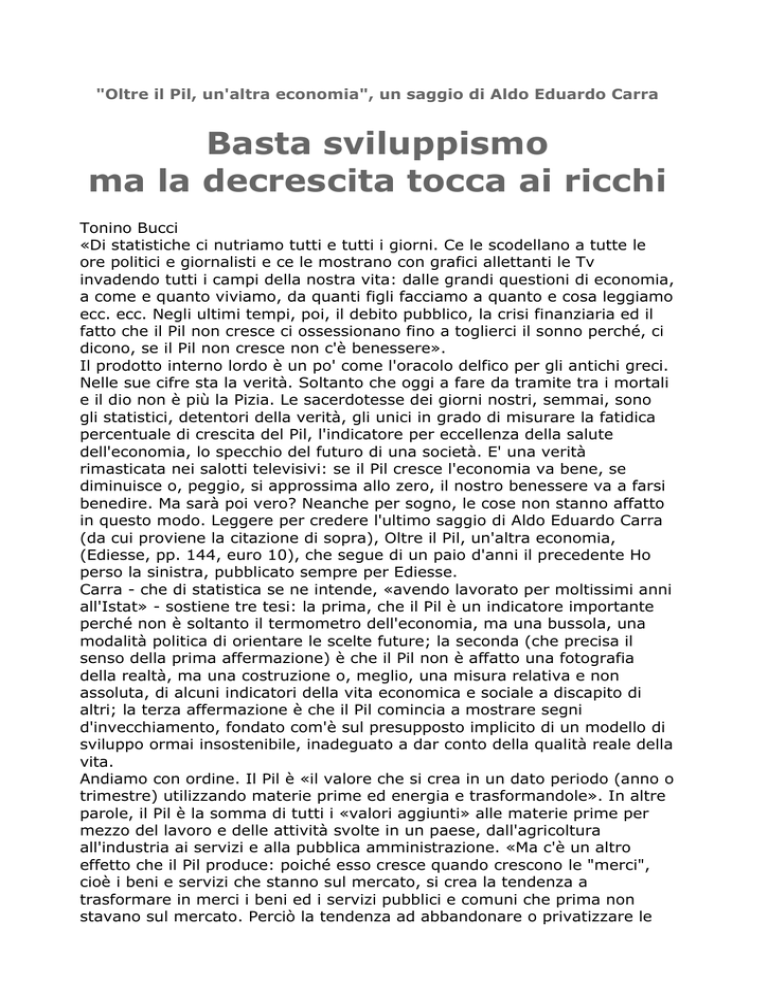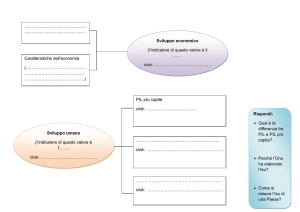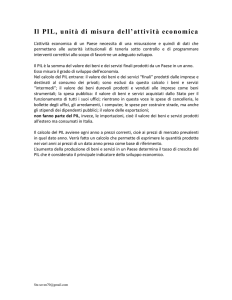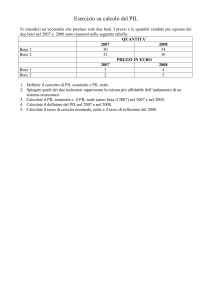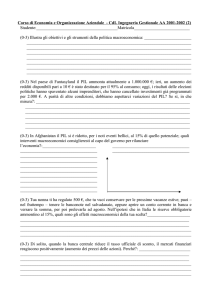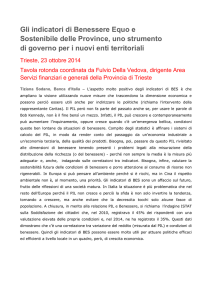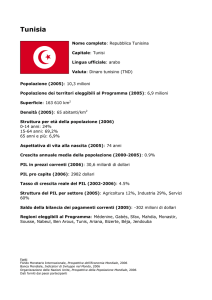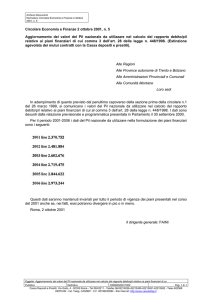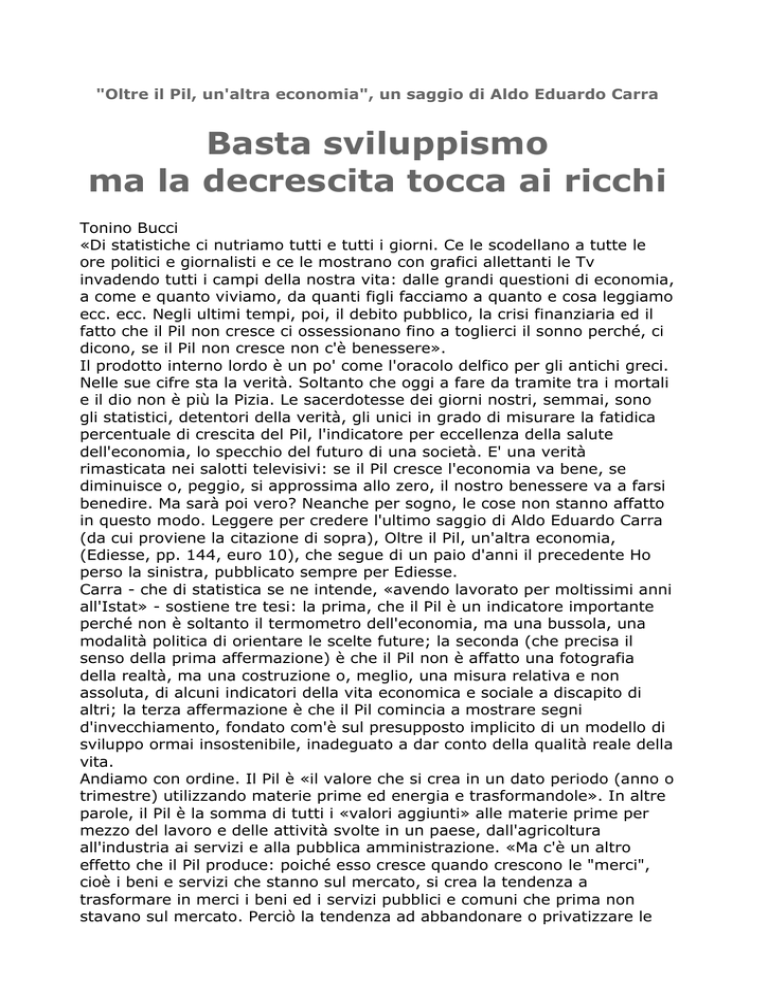
"Oltre il Pil, un'altra economia", un saggio di Aldo Eduardo Carra
Basta sviluppismo
ma la decrescita tocca ai ricchi
Tonino Bucci
«Di statistiche ci nutriamo tutti e tutti i giorni. Ce le scodellano a tutte le
ore politici e giornalisti e ce le mostrano con grafici allettanti le Tv
invadendo tutti i campi della nostra vita: dalle grandi questioni di economia,
a come e quanto viviamo, da quanti figli facciamo a quanto e cosa leggiamo
ecc. ecc. Negli ultimi tempi, poi, il debito pubblico, la crisi finanziaria ed il
fatto che il Pil non cresce ci ossessionano fino a toglierci il sonno perché, ci
dicono, se il Pil non cresce non c'è benessere».
Il prodotto interno lordo è un po' come l'oracolo delfico per gli antichi greci.
Nelle sue cifre sta la verità. Soltanto che oggi a fare da tramite tra i mortali
e il dio non è più la Pizia. Le sacerdotesse dei giorni nostri, semmai, sono
gli statistici, detentori della verità, gli unici in grado di misurare la fatidica
percentuale di crescita del Pil, l'indicatore per eccellenza della salute
dell'economia, lo specchio del futuro di una società. E' una verità
rimasticata nei salotti televisivi: se il Pil cresce l'economia va bene, se
diminuisce o, peggio, si approssima allo zero, il nostro benessere va a farsi
benedire. Ma sarà poi vero? Neanche per sogno, le cose non stanno affatto
in questo modo. Leggere per credere l'ultimo saggio di Aldo Eduardo Carra
(da cui proviene la citazione di sopra), Oltre il Pil, un'altra economia,
(Ediesse, pp. 144, euro 10), che segue di un paio d'anni il precedente Ho
perso la sinistra, pubblicato sempre per Ediesse.
Carra - che di statistica se ne intende, «avendo lavorato per moltissimi anni
all'Istat» - sostiene tre tesi: la prima, che il Pil è un indicatore importante
perché non è soltanto il termometro dell'economia, ma una bussola, una
modalità politica di orientare le scelte future; la seconda (che precisa il
senso della prima affermazione) è che il Pil non è affatto una fotografia
della realtà, ma una costruzione o, meglio, una misura relativa e non
assoluta, di alcuni indicatori della vita economica e sociale a discapito di
altri; la terza affermazione è che il Pil comincia a mostrare segni
d'invecchiamento, fondato com'è sul presupposto implicito di un modello di
sviluppo ormai insostenibile, inadeguato a dar conto della qualità reale della
vita.
Andiamo con ordine. Il Pil è «il valore che si crea in un dato periodo (anno o
trimestre) utilizzando materie prime ed energia e trasformandole». In altre
parole, il Pil è la somma di tutti i «valori aggiunti» alle materie prime per
mezzo del lavoro e delle attività svolte in un paese, dall'agricoltura
all'industria ai servizi e alla pubblica amministrazione. «Ma c'è un altro
effetto che il Pil produce: poiché esso cresce quando crescono le "merci",
cioè i beni e servizi che stanno sul mercato, si crea la tendenza a
trasformare in merci i beni ed i servizi pubblici e comuni che prima non
stavano sul mercato. Perciò la tendenza ad abbandonare o privatizzare le
attività sociali, di cura, quelle dedicate alla persona ed alla solidarietà è
anche una precisa conseguenza di un modello di società orientato solo alla
crescita di cui il Pil è stato e continua ad essere termometro e bussola».
Parliamo quindi di un indicatore che misura il valore aggiunto incorporato
nelle merci e lascia però al di fuori tutto ciò che non può essere merce,
quella parte di produzione di servizi che incidono sulla qualità della nostra
vita. «Occorrono nuovi indicatori per misurare meglio come stiamo». Ma
come si fa a misurare la qualità del lavoro, del tempo libero, dei trasporti
pubblici nelle città, dell'aria che si respira, delle acque del mare, della
salute, della cultura? Per stare al caso italiano, il 27% del valore aggiunto
deriva da agricoltura e industria, mentre il 29 per cento proviene
dall'intermediazione finanziaria e dalle attività immobiliari. E' interessante
anche osservare, a margine, che il reddito prodotto si distribuisce in parti
ineguali tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e capitale. Al primo va il
43 per cento del Pil (nel 1970 era il 46%), agli altri redditi il rimanente.
Infine, salari e profitti finiscono in consumi e in risparmi che a loro volta
vengono investiti. «Insomma il Pil resta ancora uno strumento utile per
spiegare la crescita dell'occupazione, la sostenibilità delle finanze pubbliche,
il futuro dei sistemi pensionistici». Ma non ci è di nessun aiuto se volessimo
misurare quei valori d'uso che non sono merci (valori di scambio) e che non
si collocano sul mercato. Il Pil, per intenderci, non misura i servizi offerti
dagli asili nido, dagli ospedali, dalle attività culturali, né tantomeno è in
grado di fornirci una misura della vivibilità delle città, dell'aria che
respiriamo, dell'acqua che beviamo dai rubinetti. Il Pil - ricorda Carra - è
nato quando l'obiettivo principale della società era la crescita economica negli Usa, non a caso, in piena crisi del '29 - impensabile quindi che possa
funzionare alla perfezione in una società, come quella contemporanea, alle
prese con problemi d'altro genere - la disuguaglianza, il disastro
ambientale, la globalizzazione, lo squilibrio nell'accesso ai saperi, solo per
citarne alcuni. In tutte le società avanzate, oggi, il potenziale di crescita
delle economie si sta strutturalmente abbassando, cioè non è più possibile,
stando ai parametri misurati dal Pil, portare il tasso di crescita ai livelli
dell'età aurea del dopoguerra. L'Italia degli anni Sessanta cresceva a ritmi
del 5 per cento, oggi è grasso che cola se si avvicina all'uno per cento. «Ma
d'altra parte se tutti vivessero come i francesi ci vorrebbero tre pianeti e se
vivessero come gli americani ce ne vorrebbero sei... E allora? O la terra è
troppo piccola (ma non si può allargare) o la popolazione è troppo grande
(ma al massimo si può rallentarne la crescita), o... o si cambia modello di
vita». Che la soluzione sia quella che già da tempo indicano i teorici della
decrescita à la Latouche? Sì e no. Che ci si debba dare una calmata forse è
inevitabile, che si debbano moderare i consumi pure. Ma dove sta scritto
che di questo obiettivo dobbiamo farcene carico tutti e tutti allo stesso
modo? «Vogliamo dire a chi soffre la fame di moderare i consumi? E allora
questa volta nella storia tocca ai ricchi fare i sacrifici o meglio le
scelte necessarie. Tocca ai ricchi e dovranno farsene una ragione perché la
possibilità di continuare a reperire risorse si concentra
nelle aree povere del mondo e tra quei popoli che hanno come unica fonte
di reddito le risorse della Terra». Ed è, tra l'altro, proprio in queste aree -
aggiunge Carra - che stanno nascendo movimenti di protesta a difesa «di
quello che resta della Terra» - una sorta di nuovo ecologismo dei poveri,
come è stato definito.
E' tempo di pensare a nuovi indicatori della qualità di vita che non siano
semplicemente la produzione di merci, a una qualche idea di economia
fondata sul controllo di cosa e come si produce. Già ora si fanno avanti
ipotesi di nuovi indicatori del benessere. «Bene, ma chi deciderà quali
saranno e come metterli insieme? E quale idea di benessere essi
rifletteranno? Possiamo lasciare questo compito a tecnici, statistici o
economisti che siano, visto che decidere come misurare il nostro futuro
significa anche decidere come vogliamo che esso sia»? Sta a noi, società
avanzate, modificare modello economico e stili di vita. «Sviluppo economico
sostenibile non significa crescita zero, ma ristrutturazione dei sistemi
produttivi per creare più
benessere (e quindi anche lavoro) mentre contemporaneamente si
riduce l'impatto sull'ambiente. Perché si stimolano investimenti in
apparecchiature ambientali e servizi e perché un uso ambientale più
efficiente genera una maggiore efficienza nel sistema economico e lo rende
più competitivo». Sarà una forzatura, forse no, ma sembra di risentire le
parole del Berlinguer del famoso discorso sull'austerità.
29/01/2011