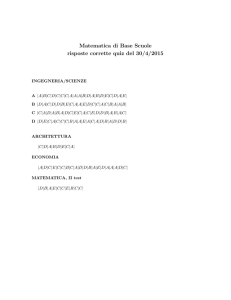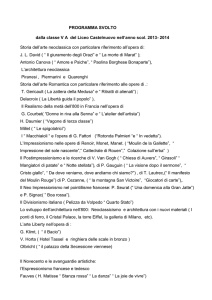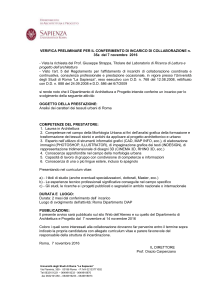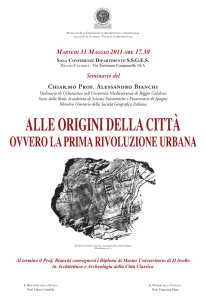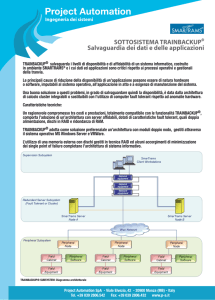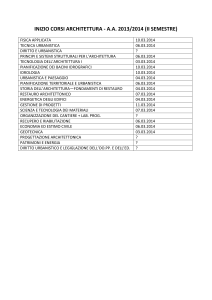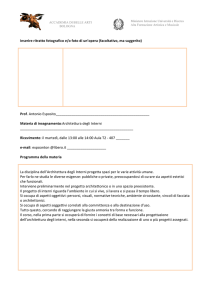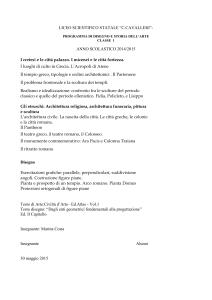5
EDITORIALE
Renato Nicolini
Poiché il tema è libero, vorrei partire da una citazione da Napoli Angelica Babele, diario del primo degli anni che
ho vissuto a Napoli come assessore all’Identità di Bassolino, il 1995.
“Le immondizie di Napoli, persino le immondizie, quello che da tutti viene indicato come un ritardo incivile,
come una piaga che affligge la città e la respinge in una posizione molto vicina all’invivibilità, hanno allora
folgorato la mia immaginazione. C’è un gruppo di cassonetti lungo il fianco della chiesa di S. Angelo a Nilo che
mi ha affascinato in modo particolare. Molto del suo fascino dipende dal contrasto, dal sapere che dentro la
chiesa, separato dal mucchio di immondizie soltanto da un muro, c’è uno dei capolavori di Donatello, scolpito per
il monumento funebre al cardinal Brancaccio. Ma la sua bellezza – uso questo termine con perversa
consapevolezza – è intrinseca al suo essere immondizia in modo assieme monumentale e mobile. (…) Se
qualcosa dell’immondizia si trasmette al monumento, bisognerà riconoscere che reciprocamente qualcosa del
monumento si trasmette all’immondizia. Sembra che uno spirito agisca sulle mani che compongono ogni giorno,
secondo una logica rigorosamente novecentesca cioè anonima, il grande mucchio. Verso sera i cassonetti non
sono più in grado di contenere altro, già debordano. Ed ecco che gli ultimi depositi vedono accatastarsi in modo
ordinato non già sacchetti ma scatole di cartone, contenitori per pasta, o per confezioni di pannolini, o per
biancheria intima, con la scritta rivolta verso lo spettatore. Tra l’una e le due della notte viene il camion della
Nettezza Urbana e porta via questa effimera architettura del rifiuto, questo spreco rituale di creatività. E la
costruzione collettiva ricomincia il giorno successivo, mobile, mutevole, mai identica a sé stessa. A volte un
vento informale sembra squassare il monumento, ed anziché ordinate piramidi di contenitori di cartone assistiamo
al trionfo del sacchetto di plastica e dei suoi colori. Ecco la trash art!”, ho pensato.“
Quello che è accaduto nel 2008 ed è ritornato nel 2010 sfugge però a ogni possibile estetica. Di fronte ai
marciapiedi invasi dalla spazzatura, ai topi ed ai gabbiani che se ne nutrono, al disastro ambientale l’unico
sentimento che si può provare è la vergogna, lo Scuorno, come s’intitola il bel libro di Francesco Durante. Ma
sono proprio i cittadini di Napoli a doverlo provare? Quando le stesse cose ritornano a distanza di due anni, è
sulle cause che hanno provocato questi effetti clamorosi che bisogna interrogarsi. Come l’existenzminimum ,
l’alloggio razionale dell’architettura moderna, è passato per la cucina di Francoforte; così l’urbanistica degli anni
2000 deve forse passare per l’immondizia di Napoli. Il ciclo di smaltimento dei rifiuti s’impone in Campania (ma
anche in Sicilia o a Roma, minacciate di una sorte simile) come centro della progettazione della città. Mentre la
cucina di Francoforte era il trionfo della meccanica applicata ai percorsi umani al suo interno (mi viene in mente
la celebre sequenza di Charlot travolto dagli ingranaggi in Tempi Moderni), il ciclo di smaltimento dei rifiuti è
refrattario all’automatismo. E’ una questione – se è giusto dire così – culturale. Lo è in particolare nella sua prima
fase, da cui dipende l’andamento di tutte le altre, la preparazione nella propria casa dei sacchetti dei rifiuti.
Aiutarci anche visivamente, nell’organizzazione della cucina, a separare immediatamente vetro, carta, plastica,
etc. dai rifiuti alimentari, organici, umidi. E poi, subito dopo? Bisogna ripensare l’attacco al suolo ed il sottosuolo
degli edifici (compito particolarmente difficile per una città porosa, sorta sopra le stesse cavità da cui sono stati
estratti i materiali con cui è stata costruita, come Napoli). In molte città francesi, oltre alle cantine e ai garage, i
piani sotto il livello del suolo degli edifici ospitano i cassonetti per la differenziata. Mentre cantine e garage
hanno il loro prezzo di mercato, i cassonetti non potrebbero averlo… Forse è il momento di fare una riflessione
su quanto è successo in Italia dopo il 1965 e la rinuncia a una legge urbanistica che colpisse alla radice la rendita
fondiaria: abbiamo esagerato nella direzione opposta, nella privatizzazione, assieme ai suoli, dei servizi e della
concezione stessa dell’abitazione… Negli spazi privati bisogna sicuramente essere “padroni in casa propria”, ma
senza regole il concetto stesso di abitazione (poeticamente abita l’uomo, diceva Heidegger appoggiandosi a Rilke
e ad Holderlin) si dissolve…
La questione più impegnativa è però la fase successiva. Le discariche non possono essere buchi in cui
semplicemente sversare i rifiuti; sono delle officine, dove deve essere possibile ispezionarli, separarli
ulteriormente… Senza discariche di questo tipo, da cui il rifiuto umido esce nettamente distinto dal rifiuto secco,
gli inceneritori – che non sono che macchine incapaci di miracoli - non funzioneranno mai…
Con i miracoli all’antica italiana, con gli uomini della provvidenza, ci siamo trastullati abbastanza. Il territorio
non è una risorsa rinnovabile. Dall’idea della disponibilità illimitata di terra, siamo passati alla sua scarsità. C’è
una bella poesia di Holderlin, particolarmente cara ad Aldo Rossi, in cui l’essenza dell’architettura è identificata
nei muri della casa d’inverno, sottoposti alla pioggia ed alle intemperie, quando il paesaggio è spoglio della
bellezza dei fiori e della vegetazione. La lezione che ci viene dalla tragedia di Napoli ci ripropone la necessità di
6
un progetto urbano essenziale. Che sappia staccarsi dai brand e dalle griffe alla moda, dalla subordinazione del
suo carattere alle esigenze della comunicazione, e riproporre la propria (indeformabile) specificità.
Mi viene in mente Pino Daniele. Napul’è ‘na carta sporca… Il secondo verso spiega il primo: cca nessuno se ne
importa… La soggettività della nostra esperienza di vita non va confusa con l’individualismo, soggettività
significa interesse per l’altro da sé, in particolare quell’ “altro da sé” per eccellenza che è la città.
7
ARCHITETTURA. MACCHINA DALL’INFINITA RESISTENZA
Carmine Piscopo
1. “Fine” è un monema ambiguo. Vuol dire simultaneamente, da una parte, “cesura” o “conclusione”, che
sono connotazioni della morte, e, dall’altra, “proiezione in avanti”, “intenzione”, che sono connotazioni
dell’esistenza, come meglio di tutti asserisce Husserl1. Non è un caso che il lemma in latino, e in italiano, sia
contemporaneamente sostantivo maschile e femminile, come il doppio volto di Giano, che da una parte
simboleggia la pace, dall’altra la guerra.
“Fine”, in senso femminile, cioè “conclusione”, è facile a usarsi, ma è difficile a decrittarsi. Chi può dire
infatti dove risieda, dove inizi, dove e come funzioni, dove termini la “fine”? Si veda quali questioni siano oggi
accese sulla questione in ambito bioetico. Si veda quali prospettive siano oggi indotte nel campo delle scienze
dalle “proposizioni” (in senso wittgensteiniano) della “fine”. Ogni volta che si varca la “fine”, implicitamente o
esplicitamente, si fa riferimento alla (ri)nascita di altro, perché nello stesso processo temporale viaggiano
differenti flussi, per cui la temporalità, che è “tempiterna”, è sempre implementata da tensioni temporali che
danno dignità ideale a una realtà materiale2.
“Fine”, declinato al maschile, è aspetto correlato e complementare al lemma usato al femminile. Esso evoca
processi ideali indirizzati verso il dover essere. Sotto questo aspetto, esso è registrato come télos. Per Platone, le
idee sono fini e veicolano fini. Per Aristotele, i fini sono le leve ovvero le cause del tutto, compresa la “causa
finale”. Dopo Platone e Aristotele, la questione dei “fini” sarà il filo rosso del pensiero teleologico. E se tale
questione resta aperta, di “fine” si può e si deve oggi parlare per quanto attiene i modi interpretativi dei termini e
dei concetti. Il discorso è squisitamente formale e si costituisce su fondamenti epistemologici e sulla retorica del
pensiero. È su tale terreno che appare legittimo discutere di “fine dell’architettura”.
2.Nei tracciati della “fine”, comunemente, l’architettura è agita come un personaggio visto di spalle che si
allontana malinconicamente per ritirarsi nell’ombra, nel già accaduto, nell’incomponibilità con l’attualità, per
lasciare dietro di sé l’evidenza del vuoto e semi di nostalgia. Nei tracciati di queste immagini, l’architettura è
andata via per sempre mille volte e altrettante mille è tornata, per potersi offrire in ultimo allo strazio dell’addio.
Un addio per pestilenze, per guerre, per distruzioni, per carestie, per catastrofi, per declino di vitalità delle
comunità, che ha visto avanzare le sabbie, le boscaglie, il deserto. Come accade oggi in Italia, dove il deserto
avanza, dove le foreste aumentano in estensione, dove nuove isole si formano nei mari, dove fenomeni carsici e
di erosione delle coste trascinano le darsene con il loro canto nelle profondità del mare, insieme con un
patrimonio di opere costruite dall’uomo. Dalle straordinarie prove della fabbrilità umana alle immagini sempre
più vicine di un pianeta in cambiamento: una prova di nichilismo generoso di sé sia nel bene che nel male. Un
disastro certamente più splendido della scenografica fine delle civiltà minoica a Creta, dell’abbattimento della
sontuosa Babilonia in Mesopotamia, del genocidio dei precolombiani di America.
3. Simultaneamente, dunque, sulla soglia della fine, ma anche sulla soglia del ritorno? “Sic rerum summa
novatur”3, recita Lucrezio, in tema di eterno ritorno. Maree anonime, deregulation compositive, pratiche usa e
getta, assoldamento e assoggettamento dell’architettura a indirizzi eterodiretti, utopie vissute come già realtà,
orizzonti di attesa che parlano della fine delle masse e del silenzio del tempo. Le città vengono affondando,
perdendo memoria all’interno di un processo di cantierizzazione massiccio, senza bordi, senza direzione in favore
di processi di disgregazione e di reticolarizzazione collassanti, esplosivi, aggressivi nei confronti di potenzialità
plurali, lasciando crescere nel loro seno manifestazioni e organizzazioni (quelle che nel Texas sono comunemente
chiamate “padelle di sabbia”) di disinfestazione di germi vitali, di disseminazione del deserto. L’addio
dell’architettura è un fatto antico.
Discontinuità incantatrici, proiezioni del tempo, desideri come già memorie. È forse questo il fascino segreto
che avvolge oggi l’architettura: l’idea stessa della sua fine, come un immenso edificio che crolla dopo aver
sedotto se stesso. Fine dell’estetica per l’estetica, dell’architettura per l’architettura. E’ l’avvento delle tecnologie
dolci, la defibrillazione del corpo estenuato da segni vuoti e tenuto in vita da organi artificiali dolcemente avvolti
da pellicole nomadi, metamorfosi del vento.
Come in un paesaggio presunto, per certi versi congetturale, l’immagine della città della storia convive con
quella della sparizione di ogni forma critica ed estetica, nell’irradiarsi di una neutralità senza oggetto. Così il
nuovo non è mai completamente nuovo, ma si costruisce in una sovrapposizione di trame come una griglia
1
E. Husserl, La crisi delle scienze europee, Il Saggiatore, Milano, 1961, p. 234 sgg
R. Panikkar, La porta stretta della conoscenza. Sensi, ragione e fede, a cura di M. Carrara Pavan, Rizzoli, Milano 2005, p. 115 sgg.
3
Lucrezio, De rerum natura, II, 75.
2
8
luminescente adorna di una lontananza spettrale, analogamente fluida, leggera e trasparente. In questo gioco di
simulazioni, di seduzioni, di sorprese infinite, nel loro continuo apparire e scomparire, il potere dei segni sembra
quello di cancellare l’immagine del mondo4. Nella loro crudele bellezza, questi segni favoriscono la più rapida
diffusione di linguaggi tecnici, fanno sembrare la progettazione un gioco elementare, esaltano, come una
seduzione sovrana, la freccia del tempo. È in questo spazio, dalla bianchezza quasi profilattica, che l‘“uomo
riconquisterà la sensazione naturale di essere nuovamente in vita”5.
È in questi termini, che i teorici dello Star System oggi promettono il benessere, la restituzione della nostra
stessa vita, la riconciliazione con un mondo tenuto in vita dalle immagini di un racconto in stile quasi monista.
Ma, come è noto, l’idea stessa di fine, si nutre della nostalgia, del ricordo di qualcosa che racchiude ancora una
presenza. Tre prevalenti “ismi” di architettura, afferma Eisenman, concernono egualmente la nostalgia, un
malessere connesso alla memoria [letteralmente, dolore del ritorno]: il modernismo, che è nostalgia del futuro; il
postmodernismo, che è nostalgia del passato; il contestualismo, che è nostalgia del presente6. Così l’idea della
fine lavora su un duplice testo: segnico e narrativo, ponendosi, insieme, come opera e accesso all’opera, in una
proiezione di se stessa sul grande schermo della città. Immagini di un mondo in dissolvenza, che accomuna
l’architettura all’idea di una mutazione sempre più vicina nel procedere verso un disegno globale7.
È qui che l’architettura sembra agita da un sogno infranto, come la nostalgia di un’assenza, in un gioco
continuo di oscillazioni tra perdite di memoria e improvvise apparizioni. In questo continuo oscillare,
l’architettura si dispone come l’immagine di un reale ritrovato, in un gioco di regole cinico che, per poter
funzionare, deve mostrare i segni di una realtà squisitamente cinica. È l’immagine più inquietante del Moïse
sauvé che Saint-Amant descrive nel suo poema d’acqua; è il luogo profondo che si presenta agli occhi del popolo
ebreo durante il passaggio del Mar Rosso: paesaggio materno, inquietante più per la sua familiarità che per la sua
estraneità, ricordo dell’Eden e, insieme, anticipazione della Terra Promessa. Mondo familiare, ma più colorato,
del quale il tempo non ha potuto appannare la freschezza originaria8.
E seppure le politiche amministrative delle nostre città fondano la loro speranza di rinnovamento su tali
seduzioni vissute già come realtà, di questi racconti, oggi, l’architettura tiene conto solo in parte.
Nata dalla cooperazione di molti saperi, nel tempo, l’architettura ha imparato a mostrare la sua stessa morte.
La sua stessa fine. Profondamente iconoclastica, al gioco delle immagini che il nostro tempo costruisce, essa da
sempre oppone il farsi e il disfarsi dei linguaggi, rendendosi libera di illuminare il loro fragile destino, il loro
riformularsi dentro universi formali più profondi, fatti di figure e di dialettiche necessarie ed irrisolte, i cui
fondamenti si rivelano sulla sabbia piuttosto che sull’argilla. Nel suo rinviare a figure più profonde, essa
ricompone il gioco delle immagini nelle immagini di una ragione che sempre si interroga sulla realtà e si fa
creatrice di mondi9. Giacché, la sorpresa infinita, che è lo scopo dell’arte, nasce da una disposizione “sempre
risorgente”, contro cui tutta l’aspettativa del mondo non può prevalere. Levatrice di scelte, essa da sempre mostra
ora il nascere, ora l’invecchiare, ora il morire dei giochi, in un disegno in cui ciò che cade su ciò che resta risale
continuamente verso significati più ampi, costringendo il linguaggio corrente a misurarsi con la sua provenienza e
le sue ragioni. In questo differire, che si muove come un’onda nel fiume della storia ed evoca nello svolgersi del
tempo la tradizione del presente, nuovi significati risalgono un linguaggio comune per trascenderlo verso nuove
costruzioni significanti; nuove individualità disvelano, nella parzialità, la contingenza del singolo punto di vista.
E’ il gioco delle infinite significazioni che abitano il progetto entro un linguaggio comune, come un differente
limite della storia che trasforma la memoria in immaginazione. In questo risalire di linguaggi, ogni replica
diviene nuova rivisitazione analogica, figura che porta in filigrana la traccia di un cambiamento. È questa, la vita
delle figure10.
"È qui che ha veramente luogo l'impresa” scrive Merleau-Ponty “e che il silenzio sembra infranto. […] La
sedimentazione della cultura, che dà ai nostri gesti e alle nostre parole un fondo comune inutile a dirsi, ha
richiesto in un primo tempo che essa fosse completata da quei gesti e da quelle stesse parole, e basta un po' di
stanchezza per interrompere questa comunicazione più profonda. Qui non possiamo più […] invocare la nostra
appartenenza a uno stesso mondo, perché è questa appartenenza che è in questione e di cui appunto si tratta di
dare conto. […] Occorre che essa insegni il suo significato, sia a chi parla, sia a chi ascolta, non basta che indichi
un significato già noto ad entrambi, occorre che lo faccia essere. […] occorre che a un certo punto io sia
sorpreso, disorientato, e che ci ritroviamo non più in ciò che abbiamo di simile ma in ciò che abbiamo di
4
J. Baudrillard, Della seduzione, SE Editrice, Milano, 1997, p. 99.
T. Ito, L’architettura evanescente, Kappa, Roma, 2003, p. 55.
6
P. Eisenman, Three Texts for Venice, in Cities of Artificial Excavation. The Work of Peter Eisenman 1978-1988, New York 1989, p. 47.
7
cfr. R. Koolhaas, La città generica, 1995, in "Domus" n. 697, Milano, 1997.
8
G. Genette, Figure, Einaudi, Torino, 1966, p. 13.
9
cfr. S. Veca, Modi della ragione, in A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Einaudi, Torino, 1979.
10
cfr. F. Spirito, Il ritorno della figura, in C. Piscopo, Architettura. Il gioco della figura, Cuen, Napoli, 2008.
5
9
differente. Ciò presuppone una trasformazione di me stesso come dell'altro: occorre che le nostre differenze non
siano più come delle qualità opache, occorre che siano divenute”11.
È questa dunque la sfida che pone oggi l’architettura nel ciclo della messa in scena di uno scambio
impossibile12: costruire, dentro l’architettura, un’altra architettura, come una costruzione diversamente logica in
grado di incidere sullo scheletro della storia. Trasformare il quadro delle conoscenze, come una luce limpida fatta
di elaborazioni, di ricerche e di immaginazioni differenti, di cui i nostri pensieri e le nostre parole si sono nutrite
nel tempo restituendoci l’inizio e la fine di un processo, in un nuovo disegno dentro cui tornare a esperire
l’immagine della realtà indagata. Ripercorrere alla rovescia il tempo degli storici e lo spazio dei geografi per
ritrovare l’immagine di una realtà diversamente fondata, finalmente sottratta ad un proprio fine originario, come
un principio attraverso cui spiegare il rapporto degli uomini con il mondo. Così il valore di un metodo sta nella
sua attitudine a scoprire, sotto ogni silenzio, un interrogativo sepolto13.
Se le opere sono differenti, e i cammini separati, scrive Octavio Paz, che cosa abbiamo allora in comune?
“Non un’estetica, ma una ricerca”. Non una scuola poetica, ma un lignaggio in cui si racchiude una diversità.
Perché, sostiene Octavio Paz, la modernità non è una dottrina, “ è l’oggi e il più antico passato, è il domani e
l’inizio del mondo. Ha mille anni e sta per nascere […] È il puro presente, che appena dissotterrato scuote la
polvere dei secoli si invola e scompare […] Inseguiamo la modernità nelle sue incessanti metamorfosi […] Ogni
incontro è una fuga […] un passero che è ovunque e in nessun luogo, trasformandosi in un pugno di sillabe. […]
Allora […] appare l’”altro” tempo, quello vero, quello che cerchiamo senza saperlo”14.
È questa la mirabile utopia che propone la letteratura, il cui senso non è dietro di noi, ma dinanzi a noi, come
una riserva di forme in attesa, l’imminenza di una rivelazione che ognuno deve produrre per sé. Similmente,
l’architettura pone il problema di fondare i nostri progetti dentro il reale, isolando, dentro un universo di forme,
un altro e soggettivo universo fondato in senso personale, ma potenzialmente orientato in senso collettivo15.
Giacchè, come afferma Salvatore Veca, esistono più immagini della ragione (e più architetti hanno costruito
questa città), il che pone l’obbligo di indicare un confine, una ragione possibile del nostro agire, precisando,
come nel gioco delle ipotesi del Parmenide, ogni volta che lo si fa, perché lo si fa. Perché una linea nel campo
dell’architettura è un’esperienza che si precisa nel tempo. È parte di una costruzione più grande, i cui fondamenti
si rivelano dentro un mondo di forme per aprirsi a nuove, continue evoluzioni. È qui che l’architettura si dispone
come una “macchina dall’infinita resistenza”, la cui verità è nel gioco delle sue figure, come un’impalcatura che
si costruisce su frantumi di castelli preesistenti, dove ciò che conta è la realtà del discorso16.
Ogni grande opera, scrive infatti André Chastel, contiene alcune “descrizioni involontarie”, che mirabilmente
Delacroix già definiva un “testo figurativo”. Questo tradimento dell’immagine è anche il modo in cui l’opera si
affida al mondo, il suo fragile destino, il suo prolungarsi in un nuovo universo di idées e di rêveries. Ma esso è
anche il modo in cui oggi l’architettura si apre, come l’opera al mondo, all’immensità del suo discorso. Dai suoi
contatti col reale, all’istituzione dei codici della rappresentazione, alla costruzione di enunciati informali o
formali, fino a un nuovo confronto con la realtà nella varietà delle strade che essa inaugura. “Da testo a testo”,
scrive Cesare Segre, “il nostro vivere, il nostro immaginare”17.
Così il valore di un’opera fonda sul suo segreto e diviene nel suo farsi spiegazione. Muta seguendo un
principio di continuità e si trasmette per risonanze ed echi nel respiro delle generazioni. Acquista coscienza
storica. Ma sempre attinge a quella sfera universale e costante dell’immaginario collettivo, come un processo che
nutre forze originarie e modella culture. Perché l’architettura è per sua natura osmosi di saperi differenti, che
includono il prossimo e il remoto, la gravità e il mito. Di certo mutano le tecniche, gli strumenti, le dimensioni,
ma ciò che non muta è il potere dei segni e la loro capacità di ripensarsi in rapporto al profondo e
all’elementare18.
Intelligenza del mondo, essa “si propone nel suo intreccio inseparabile di opere e pensieri, fatti e immagini,
oggetti e idee; vive nella cosa ma anche oltre la cosa; interferisce con la politica e il destino degli uomini, ma è
irriducibile ad essi: è costruzione di mondi materiali […] e insieme creazione di sovramondi legati al reale; è
sistema di manufatti e di concetti, di utensili e di figure. In questo rapporto singolare tra mondo delle cose e
mondo immaginato, sta dunque l’architettura, la sua scienza e il suo problema; e potremmo di nuovo
11
Merleau-Ponty, La prosa del mondo, 1969, Editori Riuniti, Roma, 1984, pp. 143-144.
Sull’argomento, cfr. J. Baudrillard, Lo scambio impossibile, Asterios, Trieste 2000; A. Cuomo, La fine senza fine dell’architettura, in
“Bloom” n. 6, Napoli, 2010.
13
G. Genette, op. cit.
14
O. Paz, Che cos’è la modernità?, in “Casabella” n. 664, Milano, 1999, pp. 48-49.
15
D. Vitale, Architettura Idee e materiali, in A. Rossi, L. Meda, D. Vitale, Architettura/Idea, Milano, 1981, p. 40
16
cfr. C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 1960.
17
C. Segre, Avviamento all’analisi strutturale, Einaudi, Torino 2000, p. 174.
18
D. Vitale, Introduzione, in R. Moneo, La solitudine degli edifici e altri scritti, Allemandi, Torino, 1999, pp. 11-12.
12
10
comprenderla appieno soltanto se, come dice Michelangelo, al calore del giorno guardiamo in noi, e sappiamo
infine distinguere, dentro tutto ciò che c’era sembrato realtà, l’unico reale possibile: ciò che è inventato”19.
È questa, dunque, la sfida delle figure20: costruire dentro l’architettura un’altra architettura e un altro processo
per comprenderli, come un’elaborata impalcatura, un castello provvisorio in cui l’architettura contempla se stessa
in un mondo creato da sé. Ciò può avvenire nella misura in cui ogni cosa cessa di essere se stessa per aprirsi a un
mondo di rapporti difficili e oscuri nelle profondità della materia.
Di questo disegno potente, che tiene insieme astratto e concreto, è pienamente avvertito il mondo antico, per il
quale le orme lasciate dagli uccelli lungo le rive sabbiose dei fiumi sono diventate, nel tempo, caratteri e figure di
alfabeto. È in questo spazio di primi rudimenti, fatto di rigore e di immaginazione, che gli artisti, afferma
Burckhardt, hanno imparato nel tempio a compiere “i primi passi verso il sublime, a separare l’elemento casuale
dalla forma, per scoprire tipi e, infine, inizi di ideali”21.
Queste forme, scrive Vitale, non possono essere linearmente spiegate, si intrecciano, ma non si identificano
con la questione del tipo, ossia, di una forma edilizia che ricorre e si ripete, si precisa nel tempo e si lega a un uso,
sino a divenire la rappresentazione concreta di un modo di vita e di una società. Piuttosto, esse rappresentano “un
tramite per andare al di là, per scoprire la realtà profonda e interiore delle cose. […] Solo passando attraverso le
figure in cui le cose si sono inverate è possibile avvicinarsi all’architettura”22. Così, “ogni figura”, scrive Genette,
“è traducibile e porta la sua traduzione in trasparenza, come una filigrana o un palinsesto sotto il suo testo
visibile”23 .
In questa trama è dunque la coscienza di figura, come un atto di ricezione e di pensiero, dove l’essere della
figura sta nell’avere una figura, ossia una forma. Cifratura simbolica del mondo, le figure abitano l’architettura
come il suo testo visibile nel loro rendere manifesto un orizzonte di latenza, immateriale radice di ogni
fondamento.
Ma ciò presuppone un’idea di sostanziale alterità dell’architettura rispetto alla vita degli uomini: un’idea
alternativa a quella che, con la modernità, pensava di legare linearmente le scelte dell’architettura a quelle
dell’organizzazione sociale e del progresso24. Una prospettiva, questa, che ha molte sue basi nella concezione
moderna del pensiero architettonico, i cui confini possono essere ancora indagati. Nella critica al razionalismo
scientista e nelle tematiche tese a incarnare di fronte alla modernità il neorazionalismo, come uso di un
razionalismo più complesso, che unisce campi di forze generati nell’immaginazione dall’associazione di
immagini; nel richiamo all’architettura civile e nella nostalgica evocazione del soggetto individuale, come homo
civilis che anticipa il soggetto collettivo ed opera nella volontà collettiva della storia. E ancora, nelle tematiche
incentrate sul richiamo all’idea di città come forma visibile della storia e concrezione di architetture, in cui
confluiscono forme senza nome, realismo visivo e immaginazione materiale del luogo.
Se la storia non è più una realtà certa, ma un divenire in cui si cela la ragione profonda di ogni agire,
l’ideazione implica e risolve, nella propria formulazione, un disegno razionale, di cui l’architettura rintraccia e
rivela una legge dinamica. Così l’architettura torna ad essere pura ideazione, che risolve nella propria
formulazione una diversa rappresentazione della realtà25.
Di questa ricostruzione, che tiene insieme realtà e immaginazione, come un reale disegno biografico che si
apre al mondo e si converte in mondo, l’architettura diviene allora l’unico autore. Ma più, e forse
inavvertitamente, come qualcosa che appare prima e nonostante la volontà collettiva della storia, essa ridefinisce,
al termine del processo, il suo stesso soggetto: l’architetto. Non più il poeta umanista, alla ricerca della sua casa
nella casa collettiva della città, egli si costruisce in una riflessione che si dà come un principio senza fine,
attraverso cui l’identità suggerisce l’alterità. Come la struttura di una sovraimpressione senza fondo, che si dà enabîme. Non diversamente dalla vita delle figure, la cui traccia si rivela in un’apertura senza fine.
Nell’ordine della ricerca, come nell’ordine della creazione, è forse giunta l’ora di quella esplorazione
auspicata da Valéry26, di sottoporre ad indagine quel campo di forme che si riconosce nel gioco della figura e
delle sue metamorfosi. Un’esplorazione, questa, che può esser fatta anche a tentoni, ma non è detto che un giorno
non possa essere sistematicamente praticata. Per saggiare quanto la “fine dell’architettura” sia inizio e
ricominciamento, infine, apertura senza fine27. Per provare quanto anche ciò che chiamiamo arbitrio possieda una
propria struttura.
19
D. Vitale, Architettura Idee e materiali, op. cit., p. 44.
cfr. A. Chastel, Favole Forme Figure, Einaudi, Torino, 1986.
21
J. Burckhardt, Sullo studio della storia. Lezioni e Conferenze 1868-1873, Einaudi, Torino 1998, p. 223.
22
D. Vitale, Introduzione, op. cit., pagg. 11-12.
23
G. Genette, Figure, op. cit., pag. 192.
24
D. Vitale, Introduzione, op. cit., p. 12.
25
C. G. Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, Einaudi, Torino, 1951; 1997, p. 87.
26
cfr. P. Valéry, Sul cimitero marino, in Paul Valéry. Il cimitero marino (1945), Mondatori, Milano, 1995.
27
P. Eisenman, Re:Working Eisenman, Academy Editions, New York, 1992, p. 55.
20
11
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA - CITTA’ STORICA
Gaetana Laezza
Le città sono un immenso laboratorio sperimentale,
teatro dei fallimenti e dei successi dell’edilizia
e dell’architettura urbana
Jane Jacobs1
Non sempre il rapporto tra l’antico e il nuovo è considerato una realtà positiva, ma è necessario che
l’architetto abbia la consapevolezza di ascoltare le preesistenze e sappia in che modo poter intervenire sulle
testimonianze di epoche passate. Il problema non dipende tanto dalla scelta del linguaggio adoperato ma dalla
capacità del progettista di sapersi misurare con il contesto, conoscere la natura, i luoghi in cui si interviene e i
significati del tessuto storico. Ancora oggi l’accostamento tra edilizia moderna e antica suscita molti interrogativi,
in particolare nel nostro paese dove coesistono due realtà molto diverse: l’immagine della città stratificata, che
presenta un forte legame con il passato, e l‘immagine della città nuova e della sua periferia che segna una frattura
considerata da molti quasi insanabile.
Il dibattito sul tema del rapporto tra antico e nuovo è sempre attuale proprio per la presenza di due correnti di
pensiero completamente contrapposte, quella degli architetti-conservatori e quella degli architetti-innovatori, che
si contrastano anche sulla questione della conservazione o meno della città consolidata. Da un lato c’è quindi chi
considera il centro antico come un monumento da tutelare ad ogni costo e, dall’altro, chi, invece, vorrebbe
costruirvi delle nuove architetture tali da rendere più moderni i centri storici attraverso l’inserimento di nuovi
edifici, di nuove funzioni.
Tra i grandi protagonisti della storia del recupero dei centri storici ricordiamo Pierluigi Cervellati, che negli
anni settanta detto la linea degli interventi e che durante un’intervista di Giovanni De Pascalis sottolinea che il
“centro storico non è una parte della città, è una città che dobbiamo salvaguardare e restaurare”.
Anche Benevolo offre la sua interpretazione su questo dibattito: la “salvaguardia delle città antiche finisce per
confondersi perfettamente col problema dell organizzazione moderna delle città. Non c è niente di più moderno
dell eredità antica delle città italiane. Le città contemporanee sono se mai troppo poco moderne per accettare e
prolungare una lezione così impegnativa”. Benevolo di fatto con questa affermazione oltre a voler aprire le città
storiche alla modernità, intende questa prima di tutto in una dimensione urbanistica da declinarsi poi sul piano
edilizio. Lo stesso fa l’architetto Paolo Portoghesi che afferma come il problema relativo al “rapporto tra antico e
nuovo” non possa essere “risolto con apodittiche proibizioni o licenze stabilite in assoluto”. Portoghesi osserva
come l Italia, già a partire dagli anni cinquanta con architetti come Albini, il gruppo dei B.B.P.R., Scarpa,
Gardella, Michelucci abbia dimostrato come il nuovo possa perfettamente integrarsi con l’antico, prevedendo
anche la possibilità di accostamenti spesso coraggiosi.
Del resto, nella stessa Carta redatta dai CIAM veniva esaminato il problema della relazione tra il centro
storico e la nuova espansione edilizia, all’articolo 66: Se gli interessi della città sono compromessi dal permanere
di alcune presenze insigni, bisognerà cercare una soluzione che sia in grado di conciliare i due opposti punti dì
vista; qualora ci si trovi di fronte a costruzioni ripetute in numerosi esemplari, alcuni saranno conservati come
documentazione e altri saranno demoliti; e in altri casi si potrà isolare la parte che costituisce un ricordo o ha
un reale valore, mentre il resto sarà utilmente modificato.
Lo stesso Paolo Portoghesi, nel catalogo della Prima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia del 1980, intitolata La presenza del passato, da lui stesso curata, affermerà che «La presenza del passato
non è né solo ironica né puramente voluttuaria. Chiusa nel ghetto della città antica, la memoria è diventata
inoperante, è diventata un fattore di separazione e di privilegio. La memoria può aiutarci ad uscire dall'impotenza,
a sostituire all‘atto magico, con cui ci eravamo illusi di esorcizzare il passato e di costruire un mondo nuovo,
l‘atto lucido e razionale della riappropriazione del frutto proibito».2
Anche Rogers affronta questo argomento affermando che: «il problema non è di proibire ma di sapere agire, in
ogni modo anche se qualcuno può avere il compito di un‘attività tutoria, il nostro, di architetti, deve rappresentare
una delle componenti dialettiche per stabilire l‘equilibrio dell‘esistenza: noi dobbiamo mettere l‘accento sul
costruire. […] In ogni caso noi dobbiamo avere il coraggio di imprimere il senso della nostra epoca e tanto più
saremo capaci di essere moderni, tanto meglio ci saremo collegati con la tradizione e le nostre opere si
1
Dalla quarta di copertina di Jacobs J., Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Edizioni di
Comunità, Torino, 2000.
P. Portoghesi, La fine del proibizionismo, in La presenza del passato, Prima mostra internazionale di Architettura, Edizioni
La Biennale Venezia, 1980.
2
12
armonizzeranno con le preesistenze ambientali. E‘ evidente che modernità non si identifica sempre con ciò che è
cronologicamente contemporaneo, ma solo con azioni qualificate: proprio dal giudizio della qualità si può
desumere un‘opinione più generale alla soluzione del problema in causa [...] Fare non è un diritto degli artisti, è il
loro dovere verso la società di cui fanno parte. Ognuno deve sapere che le sue azioni non possono essere isolate
dall‘attività corale e perciò un artista vero, non solo non ha paura dei limiti, ma può agire soltanto in colleganza
con quei limiti». 3
Di qui, sono ormai 40 anni, che l’Italia ha cercato di aprirsi verso un fenomeno di riqualificazione della città
esistente, non tralasciando mai i piani di salvaguardia e di valorizzazione dei centri storici. Il centro storico è
sempre stato considerato come un patrimonio da preservare in una città esistente ancora marginalizzata. Ma
conservare le città, ovvero i loro centri storici non significa esclusivamente salvare i monumenti isolandoli dal
contesto e dall’inserimento del nuovo, bensì far sì che il nuovo si adatti al preesistente e si integri con l’intero
tessuto edilizio antico.
In realtà, ancora oggi, per alcuni è considerato quasi blasfemo inserire un nuovo edificio nel tessuto antico,
suscitando accesi dibattiti sulla effettiva necessità di tutelare nel senso più stretto i contesti urbani passati.
In ambito italiano un ruolo fondamentale spetta allo storico Roberto Pane che sullo studio degli interventi di
ricostruzione delle città storiche, sottolinea come la soluzione al problema dell’inserimento dell’edilizia
contemporanea non va cercata nella mediazione, nel compromesso ma nella “… coscienza dell‘insieme
architettonico che ha innumerevoli vie per affermarsi”.
La città deve essere considerata un sistema nel quale, non solo si stabiliscono relazioni, ma come per un
organismo in continua evoluzione, vi sia vita per le stesse pietre, le loro forme, tra le quali si deve collocare
l’architettura contemporanea. Di recente anche Prestinenza Puglisi è intervenuto nel merito considerando come
sia sbagliato vedere i centri storici quali entità esclusivamente da conservare, in un errore che porta alla
separazione tra l’antico e il moderno. Eppure molti teorici dell’architettura sostengono l’impossibilità di
effettuare interventi nella città storica a causa di una troppo mutata visione dell’architettura contemporanea.
Naturalmente il dialogo con il preesistente non può che avvenire in forma dialogica, senza necessariamente
effettuare interventi eccessivi, quali ad esempio Beaubourg a Parigi. E’ il caso di Barcellona, considerata oggi
una città che ha conosciuto forse le più profonde e radicali trasformazioni le quali, fondate sull’inserimento di
molti edifici contemporanei nel tessuto storico non ha perduto, ma anzi ha valorizzato i suoi caratteri tradizionali.
E’ indicativo in tal senso che pure un architetto tra i più innovativi, Jean Nouvel, abbia affermato in
un’intervista che per lui è più interessante e stimolante progettare nei luoghi storici, dove è fortemente evidente la
relazione con la storia, dal momento che solo in questi contesti si evidenzia la modernità dell’architettura
consistente proprio nella capacità di interpretare l’ambiente al contorno.
Esempi eccellenti di inserimento di architettura contemporanea nei centri storici delle città consolidate
possono considerarsi l’intervento di Meier a Roma per l’Ara Pacis e la Haas Haus di Hans Hollein a Vienna.
Nel primo progetto infatti è l’Ara Pacis a sembrare voler essere in dialogo con l’architettura contemporanea
attraverso il principio di compresenza tra l’arte antica e quella attuale utilizzato dal progettista, non solo sul piano
dell’accostamento fisico quanto anche su quello del valore simbolico determinato dalla forma e dai materiali.
L’altro progetto realizzato da Hans Hollein, la Haas Haus, nel cuore di Vienna, di fronte alla cattedrale di
Santo Stefano pure esprime brillantemente il legame tra l’architettura contemporanea e la città storica
valorizzando l’area occupata precedentemente dalla vecchia sede Haas e mettendo in luce i quattro angoli del
castrum romano attraverso un attento studio dell'attacco a terra e delle relazioni con gli edifici circostanti.
Due esempi questi, del tutto dissimili, eppure dimostrativi di come il linguaggio contemporaneo
dell’architettura possa offrire parola allo stesso passato.
BIBLIOGRAFIA
Baudrillard J. e Nouvel J., Architettura e nulla. Oggetti singolari, traduzione e cura di Renata Volpi, Mondadori-Electa,
Milano, 2003.
Benevolo L., Una città con tanti “centri”, in “Italia Nostra”, 2006, 416.
Bettinelli R., Il centro antico come monumento, in “Italia Nostra”, 2006, 416.
Brandi C., Teoria del restauro, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1963, Einaudi, Torino 1977.
Jacobs J., Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Edizioni di Comunità, Torino, 2000.
Mumford L., La cultura della città, Edizioni di Comunità, Torino, 199.
Portoghesi P., Riuso dell architettura, editoriale, in “Materia”, 2006, 49.
3
E. N. Rogers, Verifica culturale dell’azione urbanistica in Difesa e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, in
“Casabella- continuità”, n. 217, 1957.
13
L’ARCHITETTURA DEL NEGATIVO
Alberto Cuomo
Il fascino di queste lotte sta nel fatto che
chi le guarda deve anche combatterle.
F. Nietzsche
(Nascita della tragedia)
“Un piccolo si e un grande no”1, in questo slogan si sintetizza forse l’atteggiamento delle Avanguardie e del
cosiddetto Movimento Moderno, rivolti a stringere piccoli patti con i poteri economici e politici onde svolgere le
proprie attività artistiche e costruttive, per attivare in esse una critica nei loro confronti e valori sociali alternativi
al loro dominio. Un atteggiamento che viene in definitiva ancora propugnato da quanti, avversi al comodo adattarsi dell’architettura attuale al mercato globale ed al consumismo di massa, evocano per essa l’impegno a svolgere una critica della realtà data.
Invero, già in un saggio del 1969, Julia Kristeva mostrava come, nell’arte, quale suo carattere specifico, più
che rivolto al mondo esterno, l’atteggiamento negativo, di critica, fosse agito verso lo stesso linguaggio utilizzato:
“La négativité du signifié poétique se distingue aussi de la négation comme opération interne au jugement… La
poésie énonce la simultanéité (chronologique et spatiale) du possibile avec l’impossible, du réel et du fictif”2. I riferimenti di tale affermazione sono, come è manifestato nello stesso scritto dalla studiosa franco-bulgara, da un
lato, le analisi critiche del formalismo russo, lungo la linea tracciata da Roman Jakobson, secondo cui la poesia
esplicherebbe una determinata “funzione” estetico-creativa, mediante procedimenti sovversivi interni agli ordini
convenzionali del linguaggio utilizzati, di per sé stessa alternativa al reale dato, e, dall’altro, con la mediazione di
Freud, le riflessioni che da Nietzsche attraversano il “pensiero negativo”, l’idea cioè di un principio vuoto, mai
determinato o nominato nelle narrazioni, che lo manifestano solo nel loro non detto, movente affabulatorio di interpretazioni e ri-creazioni in cui si dispone l’annullarsi dello stesso soggetto, autore o interprete, si direbbe in un
ritorno a Schopenhauer, nella “ascesi” proposta dal pensiero orientale3.
La Kristeva manifesta, sin dall’esordio del suo saggio, il rinvio a Jakobson e, a sfuggire ogni possibile addebito di idealismo, ricusa la distinzione tra “prosa” e “poesia” per parlare, con il linguista, di una “fonction poétique”
del linguaggio data dalla compresenza nel testo poetico di “affirmation et négation” in cui riconoscere la “duplicità dell’Apollineo e del Dionisiaco”, proposta da Nietzsche nella Nascita della tragedia4, e segna la distinzione tra
la “nègation-Aufhebung” hegeliana e la “denegazione” poetica, attraverso l’analisi freudiana del negare, inteso
processo che manifesta di una separazione tra la “intelligence” e la “zone rebelle” dell’inconscio5, per rivelare infine nella poesia, secondo un concetto espressamente buddista, il perdersi del soggetto tra i segni, la nozione di
un “subjet zérologique”, di una soggettività cioè che, pur non potendosi pensare che “à travers le signe…ne dipende d’aucun signe”6.
Sarebbe plausibile affacciare, in questi riferimenti, così come sono esposti, possibili critiche al presunto rifiuto
del logocentrismo espresso dalla Kristeva e da tutta un’area negativista della cultura francese, che finisce invece
per conquistare nuovi territori all’idealismo. Si potrebbe così muovere, ad esempio, qualche dubbio sullo “spostamento”, attuato dalla analisi “formalista”, del piano dei reali rapporti produttivi che presiedono al testo in quello “sublimato”, ideologico, del linguaggio, della “productivité dite texte”, ovvero sulla lettura linguistica di Freud
che eleva la psicoanalisi a religiosità, nel continuo riferimento al verbo7, o, ancora, una critica alla lettura del pensiero negativo nei termini dell’ascetismo orientale che, annullando il soggetto, ne fa il precipitato di una nientità
originaria, in una nuova spiritualizzazione8. Tuttavia, oltre le possibili confutazioni all’eventuale idealismo della
1
La frase, di Grosz, è analizzata da Manfredo Tafuri in “Les Bijoux indiscrets”, in Five Architects, Roma, 1976, che mostra come in Gropius, e nello stesso Grosz, si capovolga in “un grande si e un piccolo no”, secondo quanto accade oggi alle cosiddette archistar.
2
J. Kristeva, Σηµειωτιχή Recherche pour une sémanalyse, Paris, 1969, il saggio Poesie et negati vité, p. 254.
3
Ibidem, p. 246 e segg.
4
Ibidem, p. 249.
5
Sul tema della “denegazione” cfr. S. Freud, Die verneinung, tradotto in «Nuova Corrente» n. 61-62, 1973 (ora il testo è in Opere, vol. decimo, trad. it. di E. Fachinelli Torino 1978, p. 197) e la lettura che ne da Jean Hyppolite in J. Lacan, Ecrits, trad. it. di G. Contri, Torino,
1974, p. 884, alla quale la Kristeva fa riferimento, da quanto dice in op. cit. nota 28, citando altresì il commento dello stesso Lacan svolto
alle pp. 316-398 .
6
J. Kristeva, op. cit. p. 274.
7
Cfr. Franco Rella, Leggere Freud. Intorno alla verneinung (de negatione), nel numero di «Nuova Corrente» citato, con riferimenti proprio alla Kristeva, alle pp. 249-253.
8
Su questo tema ha scritto Massimo Cacciari in Pensiero negativo e razionalizzazione, Padova, 1977, nel saggio dal medesimo titolo (già
apparso nel 1973 come introduzione al Nietzsche di Fink) dove è analizzato il pensiero di Schopenhauer con i suoi riferimenti a quello orientale ed è messo in luce come l’aspirazione al Nirvana sia un tentativo di realizzare una nuova “paradossale sintesi”.
14
Kristeva, freudianamente “negato”, appare abbastanza efficace l’identificazione del poetico quale luogo della
“simultaneité” tra reale e fittizio, vero e falso in un concetto riconducibile alla formula logica della tautologia
trattata da Wittgenstein9, che ritaglia un luogo di attività negativa all’arte interposto tra la negatività hegeliana e
l’idealizzazione del negativo dei romantici.
Proprio nel saggio della Kristeva trova posto una citazione da Hegel: “il negativo è dunque l’intera contrapposizione che si riposa su di sé come contrapposizione, la differenza assoluta non riferentesi ad altro. Come contrapposizione esso esclude da sé l’identità, ma con ciò esclude se stesso, perché ogni riferimento a sé si determinerebbe come quella identità che esso esclude”10. Il termine hegeliano che designa il negativo è Aufhebung, e deriva dal verbo Aufheben, che significa non tanto negare, quanto sollevare, raccogliere, custodire, sospendere, annullare, nel senso che il negare, ovvero il continuo negarsi storico dell’Assoluto nelle cose, custodisce il negato,
l’Identico, lo sospende, lo solleva, lo differisce, e se per Hegel “positivo e negativo sono lo stesso”11, ciò è non
perché sia possibile una contemporaneità tra identità e negazione, quanto perché, nel divaricamento tra l’Identico
ed il suo negarsi, l’impossibile identità del negativo si manifesta esclusivamente nella negatività medesima (così
come l’Assoluto, positivo, è identico solo a sé) e, quindi, come negazione della negazione, come aspirazione al
ricongiungimento ed al ritorno in sé dell’Ideale. Mentre cioè la negatività su cui riflette la Kristeva è intesa come
intimamente compresa in ogni affermare, tale da svolgersi in tutti gli istanti finiti del tempo, della parola, come è
particolarmente evidente in quella poetica e, per l’“abitare poetico”, in quelli dell’esserci, della vita,
dell’esistenza, in una temporalità, si direbbe, estatica, la negazione hegeliana percorre invece una temporalità lineare di tipo aristotelico dove, nel “progresso” tra il prima ed il poi, l’Ideale “cade” nel tempo negandosi per riprendersi attraverso la negazione della negazione e identificarsi oltre il tempo. Vale a dire che se l’Assoluto, per
“comprendersi” deve differirsi nel tempo, negarsi, ac-cadere nelle cose, essendo per Hegel la negazione propriamente “tempo”12, la negazione della negazione attraverso cui esso ritorna all’identità con sé non è che negazione
del tempo, intemporalità, tempo posto oltre ogni tempo, ogni vissuto, ogni parola13.
Si dipartono di qui, in un diverso concetto temporale, i due versanti del negare, e, se si vuole, del criticare che
Vittorio Gregotti ritiene essere necessità propria all’architettura: quello che intende il negare come modalità progressiva e, pertanto, secondo quanto ha mostrato Theodor Adorno, ad esempio per Richard Wagner, del tutto integrato al procedere storico che pure critica e, in fine, rivolto ad una spiritualizzazione del reale, da condurre al
termine del tempo nell’Ideale, e quello che interpreta la negazione non indirizzata verso alcun fine, connaturata
ad ogni proposizione che, superominicamente, si apre, istante per istante, a nuove creatività, nella ipostatizzazione ideale del Nulla, dell’Assenza. E si pongono quindi lungo tali versanti le due possibili posizioni
dell’architettura, comunque portatrici di una metafisica, una ideologia, quella che tenta ancora di manifestare un
progetto, politico, sociale, in cui assumere nel tempo le cose, e quella che muove il progettare su una scacchiera
di istanti isolati, si direbbe perduti ad ogni temporalità, le cui forme riassumano insieme il mondo e la contestazione ad esso. Due posizioni che già in passato hanno investito gli atteggiamenti artistici, regola e caso, razionalismo e organicismo, e che ponevano, da un lato, la “condensazione”, nel linguaggio, nella parola, nella misura,
delle determinazioni materiali, sino a spostare l’ordine della prassi nell’ordine della lettera e, dall’altro, nella volontà di adesione alle cose, il continuo “spostamento” delle specificità linguistiche verso la vita concreta sino alla
negazione di ogni specificità, essendo sovente tali modalità rapprese in uno stesso movimento, uno stesso autore,
una stessa opera14. Sebbene il dualismo appaia fittizio, essendo entrambe le posizioni fondate su analoghi moventi
ideologici, esso è stato spesso ulteriormente avvalorato dagli analisti, così come è accaduto ad esempio negli anni
9
Le oscillazioni del dire tra “tautologia” e “contraddizione” sono illustrate in L. Wittgenstein, Tractatus Logico philosophicus, trad. it. di
A.G. Conte, Torino, 1964, alle prop. 4.46 e segg. e prop 6.1 e segg. laddove “i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mondo”
(prop. 5.6). Lo studio del pensiero di Wittgenstein come pensiero negativo è affrontato in M. Cacciari, Krisis, Milano, 1976, pp. 84-98. Il
manifestarsi della tautologia nelle esperienze artistiche contemporanee “concettuali” (cui può riferirsi l’architettura di Eisenmann) è stato
analizzato da Leo Aloisio e Filiberto Menna in Analisi delle proposizioni concettuali, Roma, 1975.
10
La frase citata dalla Kristeva è in G.W. Hegel, Scienza della logica, trad. it. di A. Moni rivista da C. Cesa, Bari, 1968 p. 486.
11
Ibidem.
12
“La negatività che si riferisce come punto allo spazio e vi svolge le sue determinazioni come linea e superficie, è nella sfera
dell’esteriorità altresì per sé, e pone colà dentro le sue determinazioni, ma insieme in modo conforme alla sfera dell’esteriorità, e vi appare
indifferentemente verso la giustapposizione immobile. La negatività posta così è il tempo”. G.W. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, trad. it. di B. Croce 1907/1963, Bari, 1967, p. 217.
13
E’ Martin Heidegger, in Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, Milano, 1970, pp. 511 e segg. a mettere in luce come lo spirito hegeliano
viva insieme nel tempo e fuori del tempo.
14
Emblematica del sovrapporsi di vita e linguaggio nell’arte la vicenda del Surrealismo, la rottura Breton-Bataille, il difficile rapporto posto da Breton tra arte, come azione del rimosso, e realtà, ovvero il proletariato, come rimosso sociale, ovvero lo spostamento del reale, operato da Bataille, tutto all’interno del linguaggio come “esperienza limite”, continuo debordare nella “impossibilità dell’esperienza” dove,
in una “opposizione eccessiva”, un “soverchio di negatività”, si sostituisce alla dialettica la continua trasgressione interna al linguaggio.
Per questo tema cfr. AAVV, Studi sul Surrealismo, Roma, 1977, ovvero M. Perniola, La trasgressione del surrealismo, ivi, e la bibliografia acclusa di Mariarosaria De Rosa ed Arcangela Cascavilla.
15
settanta, prodromici alle attuali divisioni tra gli architetti, allorchè i due schieramenti, quello italiano propositore
di un rifondato rapporto tra architettura e “forma” urbana, critico del laissez faire che caratterizzava la crescita
della città, con le sue dinamiche economiche e sociali (della realtà), e quello anglosassone intenzionato a rompere
gli ordini linguistici del progetto, ogni assetto formale dell’architettura, della città, del linguaggio costruttivo,
rappresentato in Italia dai cosiddetti “radical”, furono identificati sotto la semplicistica etichetta della Presenza/Assenza15, l’egida dell’Essere e quella del Nulla, del Positivo e del Negativo, che individuava l’uno dalla parte
della dialettica e l’altro dalla parte dell’analitico, essendo invece entrambi caratterizzati dalla volontà trasformatrice e, insieme, dall’angosciosa coscienza di un annullamento, ovvero intesi a muovere nella storia le “analisi” o
nelle analisi la storia16. E’ indicativo infatti, ad indicare il sovrapporsi ideologico dei due atteggiamenti, che, in
quelle esperienze, quanti tentavano, nella ripetizione delle parole trascorse, di ristabilire una relazione tra architettura e reale, definizioni costruttive e cose, onde offrire il progetto ad una realtà riformata, come ora vorrebbe
Gregotti, finivano con il manifestare una inattuale purezza, un nobile e distaccato attraversamento dei vari dialetti
dell’architettura lungo la storia a reperirne l’origine muta, e, già proprio nel rinvio al passato, la decadente nostalgia di un tempo posto oltre ogni recherche e, quindi, oltre ogni storia (come è nell’opera di Aldo Rossi), mentre
all’inverso, i “radical”, ponendosi all’interno di una interpretazione dell’arte e dell’architettura come modo per
introdursi immediatamente e direttamente tra le cose, sporcarsi con esse, perdere la mediazione della specificità
del progetto nell’affermazione di una continuità tra vita ed opera e di un suo effettuale risvolto pragmatico, politico, nel proporre la riappropriazione del “corpo” territoriale nel tempo effimero del magico gesto dell’arte finivano in effetti per affermare una elezione aristocratica, sacrale, dell’artista, dell’architetto, depositario di un potere
divino attraverso cui consacrare all’artistico la stessa quotidianeità, leggibile oggi in termini superlativi negli architetti della globalizzaziome.
A partire dalle considerazioni della Kristeva, leggendo cioè come le due apparentemente opposte esperienze
dell’architettura si muovessero (e si muovono) in un’area della riflessione compresa tra il posthegelismo marxiano ed il pensiero dopo-Nietzsche, che interpreta l’arte quale parte della realtà ed insieme, seguendo Simmel, “esistenza separata”17, emerge per entrambe, pur nella diversa relazione con il linguaggio, nella cui logica l’una assume il reale, o con la realtà, in cui l’altra annega ogni specifico ordine linguistico, la vocazione a porre una finalistica istanza progressiva, rivolta la prima ad una assoluta ragione, la seconda ad un assoluto niente. Se però, appare logico che quanti pongono la negazione, o con Gregotti la critica, del reale dato, sia pure appartandosi, come
accadeva agli architetti della “tendenza”, nell’universo separato del linguaggio costruttivo, finiscano per rivolgersi ad una istanza assoluta, cedere all’ideologia, è del tutto contradditorio, ed in definitiva esito di una inconsapevolezza, per chi muove un negare vuoto, ovvero una pretesa pura creatività, elevare altari al nulla e cedere alle
più frivole lusinghe del mercato, come fu per i “radical”, i blasfemi architetti pop inglesi e come è per le odierne
archistar.
E’ invece, oltre le volontà degli epigoni18, che fanno del negativo ancora un logos, a potersi leggere la “insopprimibile istanza tragica del negatives denken”, mostrando come il negativo, pure “fattore determinante dei processi di integrazione e razionalizzazione…non si sostiene che nel contesto di forme che sopportano radicalmente
la crisi del sistema dialettico come crisi di ogni possibile rifondazione sintetica del discorso ideologico” non conferendo cioè alla “disperazione alcun significato nichilista” ma tentando di agirla e praticarla “logicamente, teoricamente… produttiva di nuovi ordini” in una “irrisolvibile costitutiva contraddizione tra essi e il permanere della
crisi” che riveli “la impossibilità di risolvere in senso sintetico la crisi del sistema classico-dialettico”19. Michel
Foucault ha lucidamente messo in luce, a partire da Nietzsche, o meglio, dal Kant che Nietzsche cita, la compresenza di nuovi ordini alla Critica, riferendosi alla lettura privilegiata del linguaggio poetico dove, tra Sade e Ba15
La definizione dei due modelli interpretativi dell’arte contemporanea è di Renato Barilli in Tra presenza e assenza, Milano, 1974, dove
viene affermata anche la loro intersezione e compresenza quali “due varianti sovraculturali conseguenti come ipotesi subordinate ad una
unica ipotesi di fondo” (p.11). Lo “schema” è ripreso malamente per l’architettura, irrigidito cioè in una opposizione tra la Presenza, come
privilegiamento del “momento dialettico” ,e l’Assenza, come “creazione di una totalità in vitro” in F. Irace, Assenza-presenza due modelli
per l’architettura in «Op.Cit.» n. 37, 1975.
16
La effettualità (anche dialettica) del pensiero negativo (se si vuole, analitico) è messa in luce da Massimo Cacciari, a proposito di Max
Weber, in Krisis, op. cit. Altri studiosi hanno rilevato la complementarità di analiticità e dialettica nel pensiero dell’assenza come è in N.
de Feo, Analitica e dialettica in Nietzsche, Bari 1965. All’inverso la compresenza di analiticità e dialettica nel pensiero della presenza è
stata posta in evidenza in numerosi scritti di Enzo Paci sulla rivista «Aut Aut», ovvero nel saggio Tempo e relazione, Bari 1965, dove è affrontato il tema della “positività” e “negatività” in autori del tutto contrastanti come Wittgenstein e Dewey.
17
G. Simmel, Arte e civiltà, trad. it. di L. Perucchi, Milano, 1976, ovvero i saggi dal titolo L’ansa del vaso e Metafisica della morte.
18
Il divario tra la razionalità formale della “seria apocalisse viennese” e la lucida follia della scuola di Francoforte si colma nel convergere
di entrambe in una visione idealistica, come ha mostrato Massimo Cacciari in Metropolis, Roma, 1973, a proposito del “ritorno” nostalgico
di Simmel, o Giangiorgio Pasqualotto ne L’estetica francofortese: morte per utopia, «Il Verri» dic. 1976, a proposito della contraddizione
di Adorno e Marcuse tra l’affermazione di una incapacità dell’arte ad intervenire nel mondo e l’utopia del trasferirsi della sua istanza negativa nel sociale.
19
M. Cacciari, Krisis, op. cit., pp.7-8.
16
taille è dato assistere al gioco tra il limite e la trasgressione. “Questa filosofia dell’affermazione non positiva, vale
a dire della prova del limite – scrive Foucault – è quella, io credo, che Blanchot ha definito con il principio di
contestazione. Non si tratta qui di una negazione generalizzata, ma di una affermazione che non afferma niente:
in piena rottura di transitività. La contestazione non è lo sforzo del pensiero per negare delle esistenze o dei valori, è il gesto che riconduce ognuna di queste esistenze ed ognuno di questi valori ai propri limiti e quindi al Limite
in cui si compie la decisione ontologica: contestare è andare fin nel cuore vuoto dove l’essere raggiunge il suo
limite e dove il limite definisce l’essere”20. E tuttavia, posto oltre la critica progressiva, quella in definitiva perorata da Gregotti, questo stesso negare intrinseco al discorso, forse proprio perchè sembra non occupare alcuno
spazio, “nessun discorso già pronunciato” per essere “gioco istantaneo del limite e della trasgressione”, oscillando tra critica ed ontologia21 rischia di finire con l’offrire il suo affermativo consenso, pur fuori dalla sintesi dialettica, allo status quo delle cose, del mondo. Estremamente calzante, a questo proposito, appare, proprio per
l’architettura, la differenza tra Loos e Wittgenstein nella lettura offerta da Massimo Cacciari, dove si manifesta
l’inanità del pensiero negativo, nella interpretazione loosiana, ad intraprendere nuove scalate ad una falsa comprensione, pur nella critica, del reale, il tentativo cioè, nel “disgusto” del filosofo-logico viennese, di fare del nihilismus una formula del costruire, uno stile da trasferire all’urbano e al reale22.
Più in generale, Dino Formaggio ha mostrato, nell’arte, i modi in cui l’attività negativa si tramuta in un agire
presieduto da una sorta di assoluto istinto di morte23, offrendo al nulla una costituzione ontologica, risvolto ideale
dell’essere. Questo studioso definisce infatti l’atteggiamento che oppone al “nulla metodologico” un “nulla ontologico” come “nichilismo incompiuto” e lo rileva proprio in certe forme dell’avanguardia, del suo “nichilismo
anarchico”, del tutto conservativo. Egli scrive infatti nel 1973, con sorprendente preveggenza: “spesso è questa
inadeguata coscienza dell’arte, e del rivoltiamo confuso e velleitaristico che implica che certe forme di pretesa
avanguardia finiscono per consegnarsi ad un destino di retroguardia anche oggi. La confusione dei concetti, ed il
velleitarismo del nuovo a tutti i costi, fino a diventare solo fumo negli occhi, sono, in forma consapevole o meno,
un modo di affiancare i movimenti della conservazione e della reazione. Confusione e velleitarismo sono sempre
dalla parte dell’oscurantismo, anche quando ad agitarli è qualcosa che si chiama avanguardia. In tal senso queste
forme di avanguardia sono un gettarsi avanti fantomatico, che nei tempi medi e lunghi finisce per guadagnare in
retroguardia, per confondersi con la coda e persino con il codinismo”24. Proseguendo nella sua analisi Dino Formaggio giungerà ad un concetto dell’arte, e del nulla di cui si fa portatrice, come proiezione, progetto di “possibilità” inattuali, in una storica “possibilità di progetto”, negando ogni costituzione oggettuale, generatrice di norme
di organizzazione formale, se non come manifestazione della propria corruzione e del proprio farsi. Un carattere
‘informale’ dell’opera, strettamente legato ai meccanismi produttivi dell’uomo (nei termini estesi che vanno dalla
corporeità al linguaggio a quelli più astratti dell’universo meccanico, o, diremmo oggi, informatico) ed insieme,
alla negazione di una loro rigida definizione, che in un altro scritto definisce, con il Pareyson, quale “formatività”, un formare cioè sempre aperto ad ulteriori definizioni, in una interpretazione della morte dell’arte non come
sua fine definitiva, ma come fine della forma e di ipostatiche norme, sì che essa invada la vita stessa, concludendosi in una esteticità diffusa25.
E’ indubbio come, negli stessi anni in cui Dino Formaggio scrive nei termini esposti, l’architettura che sembra
meglio interpretare la compresenza di progetto e negazione, una formatività cioè aperta che, interrotta la forma,
mostri i modi del suo possibile farsi e delle diverse possibilità formali del fare, come invito a rompere ogni dominio costituito, sia quella di provenienza “organica”, sebbene Reyer Banham riveli, proprio nell’esperienza che
maggiormente tenta di frammentare forma e tradizione nel manifesto gioco dei materiali, nel “brutalismo” di cui
era stato profeta, ancora una propensione all’ordine, all’equilibrio ed all’armonia formale26. Oltre anche il “brutalismo” però, permane in quegli anni l’aspirazione a formalizzare l’informe, a fare della dissonanza la regola, particolarmente nell’architettura connessa alla cultura ebraica, che trova nelle “invarianti” dell’antisimmetrico proposte da Bruno Zevi, la nuova Bibbia del progetto, tanto più che lo stesso Zevi mostra come sia del tutto interno
al pensiero ebraico, ovvero ad una religione, il senso dello spazio-non spazio che egli perora27. E del resto, più
20
M. Foucault, Scritti letterari, trad. it. di C. Milanese, Milano, 1971, p. 60
“Il gioco istantaneo del limite e della trasgressione potrebbe essere forse, ai nostri giorni, la prova essenziale di un pensiero dell’origine
al quale Nietzsche ci ha votato sin dall’inizio della sua opera. Un pensiero che sarebbe, in assoluto e nello stesso tempo,una Critica ed una
Ontologia, un pensiero che penserebbe la finitezza e l’essere”, ibidem. p. 61.
22
M. Cacciari F. Amendolagine, Oikos da Loos a Wittgenstein, Roma, 1975.
23
Dino Formaggio, in Arte, Milano, 1973, a p. 64 analizza l’esaltazione dei sentimenti di morte nell’arte romantica.
24
Ibidem, p. 64-65.
25
D. Formaggio, L’idea di artisticità, Milano, 1962, particolarmente alla Sezione prima, § 18, p. 155 e segg.
26
Reyer Banham, scrive in The Newbrutalism, London 1966: “I Johnson, i Johansen e i Rudolph della scena americana furono più veloci
di me nel comprendere che i brutalisti erano in realtà i loro alleati, e non i miei; impegnati come erano nell’ultimo ritorno alla tradizione
classica e non a quella tecnologica”.
27
B. Zevi, Il linguaggio moderno dell’architettura, Torino, 1973, che aveva appunto come sottotitolo Guida al Codice anticlassico.
21
17
che nei ludici esperimenti dell’architettura anglosassone sostenuta da Banham, è un architetto di fede ebraica, cui
si ispirerà Gehry, a sua volta ebreo, John Johansen 28, dopo essere stato, allievo di Gropius ed esaltatore di Mies,
esponente dell’international style, a meglio rappresentare l’ideologia che interpreta la frammentazione della forma come luogo critico di ogni reale dato ed apertura messianica ad un principio mai raggiunto. Infatti proprio i
progetti dell’architetto americano mettono in luce la possibilità di un processo “formativo” aperto per l’attività
costruttiva, dove i singoli oggetti, le singole “parti” perdono, nel loro frammentismo, come accade alla coeva
pop-art americana di Rauchemberg, la loro rigida strutturazione, per essere, per così dire, reinventate, esse stesse
luogo di reinvenzione, nel loro senso simbolico e funzionale, attraverso l’assemblaggio di volta in volta costituito. I riferimenti di Zevi come quelli di Johansen sono esplicitamente nelle dissimmetrie wrightiane, ed è però nella volontà di irrigidire, l’uno in una normativa, quella delle sette invarianti, l’altro in un procedimento metodologico, la fluidità dell’architettura organica a riproporre una ideologia, forse già propria a Wright, alla sua aspirazione ad un antistile a sua volta stile, da trasferire al mondo, alla città (Broadacre) come al deserto, dove il concetto del superamento infinito di ogni definizione stabile, connesso alle “invarianti”, denuncia la possibilità di
una idealizzazione del negativo che comunque confluisce in un formalismo29. E difatti l’architettura di Johansen,
posta la “nuova frontiera”, irraggiungibile west mai superato, nella emancipazione delle periferie urbane dal degrado fisico e sociale, intende tale emancipazione come dovere, Sollen, da espletare nel senso della integrazione
del periferico in una “forma” urbana comprensiva, sintetica, di ogni difformità, un nuovo paradiso.
Se però i tentativi di Zevi, come in fondo quelli della Kristeva30, di normare l’azione negativa all’interno del
linguaggio, lasciano intravedere la formulazione di nuovi ordini ideali, resta comunque chiaro che per essi
l’azione critica, negativa, si pone nel limite stesso della parola come azione intrinseca ai procedimenti del dire, ed
anzi come modalità interna ai dispositivi del linguaggio, laddove, proprio a proposito dell’architettura, chi, come
Renato De Fusco analizza, negli stessi anni, i caratteri linguistici del costruire, il suo essere testo materiale autotrasgressivo, mostra anche la sua impossibilità, legato com’è a necessità concrete, di essere pratica altra, “materialisticamente” negativa del reale cui si offre31. Vale a dire che, proprio chi, come De Fusco, maggiormente analizza per l’architettura la sua disposizione ad essere un linguaggio costituito con cui dire le cose, sembra ritenere
impossibile l’esercizio di una critica alla realtà, quella che vorrebbe Gregotti, dall’interno di una pratica fortemente vincolata dalle esigenze, economiche, sociali, d’uso, della realtà stessa, per cui, ancora una volta emerge
come la negazione dei dati reali che determinano l’architettura possa esercitarsi o solo all’interno del linguaggio
costruttivo, come contestazione alle sue convenzioni formali, poco incidente sul reale se non per tempi forse lunghi, o nell’uscita dallo specifico linguistico, come è per gli architetti pop anglosassoni o i ‘radical’ italiani rivolti
alla irruzione diretta nelle cose.
La possibilità dell’architettura ad essere altero costruire, pratica “altra”, è data di solito nell’esempio
dell’unica opera di Wittgenstein, o di quelle di Mies, e tuttavia, a manifestare l’eventualità del fare architettonico
quale attività negativa sono alcune esperienze degli stessi anni settanta: quelle dei Five Architects, e più in particolare di John Heiduk e Peter Eisenmann. Così, mentre il primo nei suoi giochi “intertestuali” ci mostra, già
nell’inutile rincorrersi dei lessici, a tentare, con nominazioni reciproche, di conchiudere la realtà, l’abitare cioè,
del tutto sfuggente invece ai segni costruttivi, sì che questi si manifestano, non solo oppositivi, quanto persino
avulsi dal mondo, il secondo, nei suoi progetti, esibisce le difficoltà della medesima logica costruttiva, di cui manifesta le continue infrazioni, a catturarsi in un ordine definitivo che deponga testimonialmente su se stesso. Facendo reagire tra loro logiche desunte dall’esperienza pittorica o letteraria con le logiche riferibili al costruire 32,
Hejduk manifesta infatti l’esclusiva possibilità dei segni di rinviare a se stessi, estranei come sono alla realtà esterna, o, al più, ad una stratificazione di idiomi, desunti da diverse regioni linguistiche che, sovrapposte lungo la
storia, si ripercorrono e si riflettono in una circolare teoria di separate definizioni. Così, se per lui la parete può
28
A proposito del riferimento di Gehry a Johansen cfr. A. Saggio, Frank o Gehry, architetture residuali, Torino, 1997.
Cfr. il mio scritto sulle invarianti in «L’architettura cronache e storia», n. 241, novembre 1975
30
L’insistenza, qui, sulle analisi della Kristeva si deve al fatto che questa studiosa sintetizza gli studi di una vasta area della critica formale, da Jakobson a Tynjanov a Sklvskij a Mukarowski sino alla “Nouvelle critique” francese, applicata all’arte contemporanea cui guarda
anche Bruno Zevi.
31
La questione del testo come produzione materiale è affrontata in AAVV. La materialità del testo, Verona 1976, in particolare il saggio
di Adrea Calzolari su Diderot. Renato De Fusco in Avanguardia e sperimentalismo nella storia dell’architettura moderna, Milano, 1975,
dopo aver definito l’Avanguardia, nei termini di Poggioli, con i concetti di “attivismo, antagonismo, nichilismo” (p.65) o in quelli di Enzensberger con le nozioni di “improvvisazione, caso…vuotezza…azione pura” riconosce nella sola “architettura disegnata… il fenomeno
più peculiare dell’avanguardia” (p. 88) affermando che “per l’architettura vera e propria, ossia per gli edifici effettivamente realizzati non
si può parlare di avanguardia…è lecito invece parlare di sperimentalismo” (p. 94) dove “lo sperimentalismo tende ad un fine preciso” e
“l’avanguardia non può rinunciare a un certo grado di gratuità”. Ne consegue l’impossibilità dell’architettura costruita ad essere priva di
“scopi…antagonista e nichilista” mentre l’avanguardia è mossa solo in un “discorso su l’architettura priva di significanti, ossia di tangibili
esempi di edifici portatori delle istanze di questa o quella poetica” (p. 96).
32
Vedi La Diamond House, versioni A,B,C e l’opera di Mondrian Foxtrot o i progetti “I testimoni silenziosi”, “Il cimitero per le ceneri del
pensiero” per le Biennali del 1975/79 dove sono evocati Dante, Céline, Proust, Robbe-Grillet, Melville, ecc.
29
18
inscenare la simbiosi con la pagina (House 16) a mostrare la tautologia che vige nel continuo rispecchiarsi dei
linguaggi, Eisenmann lascia apparire negli stessi “sistemi di relazione” costruttivi, “il lineare, il planare il volumetrico”33, nelle loro asettiche “reazioni”, l’oscillazione tra vero e falso che rende contradditoria la enunciazione
di significati e sensi che comprendano le cose. Così è per travi e pilastri (il lineare) intrecciati in un reticolo privo
di necessità strutturali (House I e II) che manifestano il convenzionalismo della stessa struttura statica moltiplicata in raddoppi di travi, vere (o false?), e per pilastri dichiaratamente falsi che, sospesi dal terreno, si assimilano a
quelli veri inducendo a confondere il vero ed il falso. E ancora, per i piani orizzontali (il planare) che si interrompono ad escludere ogni possibilità di solaio e per i piani verticali che si aprono negli infiniti modi di essere di una
apertura nella parete sino a rendere la parete stessa vuota apertura. O ancora per gli slittamenti e le rotazioni (il
volumetrico, House II, II, III, IV) di volumi regolari a negare ogni finitezza formale, ogni compiutezza
dell’oggetto, onde definire spazi che si compenetrano contradditori, chiusi all’esterno ed aperti all’interno fino a
fingere spazialità dove ci sono solo vuoti, ascensioni nel nulla, inutili camminamenti tra una inutile selva di reperti edili. Ma per quanto queste architetture nella loro “estraniata solitudine”, nel “laconico stupore”34, si ritraggano da ogni ideologica coesione tra segni e cose e, persino, come annota Manfredo Tafuri, dalla sintesi rappresentata dalla forma35, in esse si agita ancora il fantasma di una metafisica istanza originaria che lega i linguaggi
diversi (Hejduk) o che promuove la ricreativa generatività del linguaggio (Eisenmann). Lo stesso concetto di “inconscio collettivo” utilizzato da Eisenmann, manifestando le sue “strutture” negli “integrali sintattici” del
Chomsky citato dall’architetto, si conforma come un fondo categoriale, a-priori, informatore delle definizioni36 ed
agente dell’immaginario, una ragion pura che innesta i dispositivi del dire e che si riflette in uno spirituale Principio. Del resto lo spiritualismo appare essere del tutto esplicito in un altro architetto americano, pure intriso del
trascendentalismo pionieristico, a sua volta ebreo che, formulando spazi e forme diversi da quelli proposti da Eisenmann, e tuttavia rivolti ad un analogo nulla, è stato sovente assimilato inopportunamente dalla critica all’Aldo
Rossi amato dai Five, Louis Kahn
In realtà la differenza tra Kahn e Rossi si manifesta proprio in un diverso modo di interpretare il negativo, inteso, nel primo, attraverso l’impossibile circoscrizione di spazi rivolti di fatto all’attesa messianica di un principio
spirituale posto, così come in Eisenmann, oltre le definizioni, e, nel secondo, come azione interna al linguaggio
rivolta all’insorgenza di forme originarie, non tanto intese recinti d’attesa del divino (come pure era per
l’ispiratore di Rossi, Saverio Muratori) quanto fantasmi dell’inconscio costruttivo o, anche, di un proprio personale abitare. Così, ad esempio, il gusto materico delle tessiture in Kahn, il rincorrersi degli spazi attraverso vuote
occhiaie che dilatano il tempo oltre lo sguardo, il suo presente, l’imprigionarsi della luce (Sinagoga di Huvra) ed
il suo improvviso liberarsi (Salk Institute, Monumento ai martiri ebrei), denotano la volontà di convogliare il
molteplice in una forma comprensiva di ogni singolarità37, dove, all’inverso, l’estrazione da ogni particolare delle
somiglianze e delle analogie, imparentate da Rossi nella freddezza bianca degli intonaci, tende al rinvio di ogni
figura ai suoi diversi significati e, insieme, a nessun significato, sintetica solo di sé nella espulsione di ogni varietà38. Accade cioè che mentre Kahn, profondamente americano39, pure nella presentificazione eidetica degli elementi che concorrono alla configurazione architettonica, le materie, gli spazi gerarchizzati40, aspira comunque ad
una Presenza, vagheggiata oltre il quotidiano, cui rimanda la Forma, celebrativa di una intemporale Istituzione e
33
Sulle architetture e la teoria compositiva di Eisenmann negli anni settanta cfr. i suoi scritti per «Casabella» n. 345/1970, n. 359-60/1972
e n. 386/1974 ed il testo di Mario Gandelsonas per il numero 374/1973 della medesima rivista.
34
K. Frampton, Five architects, in «Lotus» n. 9/1975.
35
A proposito di Eisenmann Manfredo Tafuri, in “Les bijoux indiscrets”, op. cit., pp. 16/18, scrive: “L’abitare in tale concezione non realizza il linguaggio. Anzi l’abitare è qui sfida ai limiti che il linguaggio si impone ed impone all’esistere. La forma si impone come sfida e
ostacolo da superare. L’uomo che pretende di vivere la forma è condannato a una doppia alienazione, dalla quale è possibile sfuggire solo
aggredendo la forma, accettandone la sfida”. E, a proposito di Hjduk: “la poetica dell’oggetto viene così evocata e subito distrutta. Ciò che
conta è l’esposizione lucida e perversa dell’inutilità del gioco intrapreso”
36
I riferimenti di Eisenmann a Chomsky sono ricorrenti nei suoi scritti, ed è il concetto chomskyano di “struttura profonda”, come “struttura astratta sottostante che determina l’interpretazione semantica della frase”, avente “carattere universale” (v. N. Chomsky, Saggi linguistici vol. III, La filosofia del linguaggio, trad. it. di A De Palma, Torino, 1969, pp. 272-273) che lascia emergere, nell’aspirazione a rintracciare una garanzia di verità alle definizioni, il carattere ideologico delle sue analisi e di quelle dell’architetto.
37
Louis Kahn interpreta la forma quale luogo dell’Istituzione, comprensiva della varietà del singolare, manifestando il proprio carattere
americano riferibile al trascendentalismo dei Thoreau, degli Emerson ed al kantismo di Coleridge che scopre agli “io” individuali il fondo
comune di un “Io” agglutinante le varie singolarità: “Io celebro me stesso, io canto me stesso / e ciò che io presumo devi tu presumere /
perché ogni attimo che mi appartiene è come appartenesse a te”. W. Whitman, Foglie d’erba, trad. it. di E. Giachino, Torino, 1965, p. 42.
38
Cfr. Ezio Bonfanti su Rossi in Autonomia dell’architettura, in «Controspazio» n. 1, 1969.
39
Manfredo Tafuri apre il suo saggio sui Five, op. cit. nel riferimento a Kahn ed al suo essere profondamente americano.
40
E’ Louis Kahn ad illustrare il proprio progetto per il Salk Institute mediante la concisa nominazione dei suoi materiali messi in parentesi,
quasi in una volontà a manifestarne l’epoché: “malta, cristallo, pietra, acqua”. Cfr. «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 142, 1969. Sulla fenomenologia in Kahn ha scriito Christian Norberg-Schulz, Idea e immagine, Roma 1980, mentre sulle gerarchie spaziali ed i riferimenti alla storia si veda Vincent Scully, Louis Kahn, trad. it. di E. A. Cotta e A. Barcolli, Milano 1963, ripreso da Manfredo Tafuri in «Comunità», n. 2, 1964 e da Francesco D’Amato in «Controspazio» n. 1, 1977.
19
rappresentativa dell’eterno, Rossi, invece, contraendo i vari sensi ed i vari significati in un unico segno, per così
dire primario, se rischia a sua volta di cadere nello spiritualismo, nel possibile intendere tale primarietà figura di
un termine metafisico, aspira a rendere nella forma tutto l’inventario delle altre forme analoghe che attraversano
la storia, reperite mediante una verticale recherche, anche autobiografica, onde invitare ad una analisi che, per
quanto interna all’autonomia del costruire, per dirla con Anceschi, sia testimone di una eteronoma, storica, impossibilità dell’architettura a dire ciò che le è estraneo41. Se proprio vuole trovarsi una cifra comune ai due architetti può dirsi che, sia pure in termini diversi, nelle loro opere aleggi un analogo senso di morte, data la museificazione comune, attuata attraverso il progetto, dell’architettura passata42. Ma anche qui se l’immaginario kahniano, utilizzando la “mémoire” come “creativité” tende a prolungare l’esalazione dell’architettura negli infiniti respiri vuoti che si aprono nei suoi monumentalizzati sudari, nell’opera rossiana, “al di là del principio di piacere”
in cui si pongono le fredde forme che neppure i colori riscaldano, è lo stesso bacio che congiunge in un analogo
segno “sensi” diversi, a manifestare, per la costruzione, un inappellabile rigor mortis43.
Ed è qui che si apre forse una ulteriore modalità del negare, nel senso che, se la critica al reale proposta da
Gregotti, ovvero ai domini del nostro mondo sempre più aperto quanto costrittivo, appare esercitabile solo
dall’interno del linguaggio architettonico come azione contestativa dei modi linguistici medesimi, e se tale tipo di
contestazione rischia di cadere nella ideologica ipostasi di un principio – pieno o vuoto poco importa – di fatto alieno alle concrete determinazioni sottoposte a contestazione, rimane forse come possibilità dell’architettura ad
essere critica, di sé e del reale che in essa comunque si manifesta e rappresenta, la sua volontaria improduttività,
una ineffettualità che sia effettuale in quanto a contraddizioni, una architettura cioè che spinga il suo limite oltre
ogni spazialità, ogni costruibilità, ogni economia, ogni funzionalità, ogni sempre addomesticabile e sintetizzabile
negazione, ovvero una architettura dell’inutilità che veda l’architetto ritrarsi persino dal suo fare, riaffermato in
una altera presenza, quel modo d’essere cioè, altresì ricorrente nella storia, del progetto come puro disegno o pura
parola critica. Una esperienza, quella del “disegno di architettura”, ricorrente nelle fasi di flesso della storia, che
non intende il disegno come metalinguaggio, lavoro critico sul progetto o esso stesso proiezione verso realtà nuove, aspettativa di tempi migliori, quanto pratica autoesaustiva, priva di ogni rappresentazione, e calata nella storia
di una attuale impossibilità di parola, ovvero parola che testimoni del proprio silenzio. Bisogna cioè distinguere,
in questa pratica ‘cara’ agli architetti, tra l’assimilazione del disegno ad una sorta di architettura virtuale, che dilazioni il nientificarsi del progetto, il nulla, nelle proprie rappresentazioni esaltandolo in una idealità, ed un disegnare che, a dispetto di ogni virtualità si agisce realisticamente come storica possibile pratica propria ad un progettare vuoto. Il riferimento obbligato è allora a coloro che praticano nel disegno, nella azione della matita sul foglio, l’architettura quale costruttività incostruibile, gli architetti come Piranesi, Leonidov o, negli anni settanta,
Scolari, Grumbach, forse Purini, o alcuni architetti attuali d’oriente, che, pur rinviando nei loro disegni ad un
progetto, si attardano nella pastosità dei colori, nei giochi cromatici che riflettono solo se stessi. Proprio Scolari e
Purini44 hanno definito il disegno come materiale lavoro, “dietro il proprio tavolo” di fronte alla lastra o al foglio
– ma ciò vale a maggior ragione nella intransitività del computer – per cui, mentre il tempo del disegnare,
dell’incidere, del guardare, si rapprende sul piano a negare altri tempi che non il presente, il disegno stesso si pone pratica altra, affermandosi e negandosi quale progetto, nel suo rinviare all’architettura, al costruire, e attestandosi insieme nella eliminazione di ogni edificabilità, perché il tempo, l’abitare, viva e si fissi solo negli inchiostri
e nei colori.
Ed anche qui potrebbe rivelarsi un idealismo, addirittura il riferimento platonico dell’Alberti e degli architetti
rinascimentali, sebbene la stessa critica che rilevi le contraddizioni ideologiche del progetto e del suo negarsi non
può non riconoscere che il suo negare l’architettura non può non aprire alla introiezione, nei suoi modi specifici,
dell’opera, per cui, se appare opportuno che la critica propriamente detta analizzi la caduta del negativo dell’arte
e dell’architettura in ideologia, ciò non può condurre ad ipotizzare per essa alcun luogo critico assoluto sostituti-
41
Nella ristampa del 1976 di Autonomia ed eteronomia dell’arte, Milano, 1976, Luciano Anceschi, nelle “Intenzioni” introduttive, si chiede se “l’autonomia possa ancora trovare… qualche forma attiva di significato nella realtà” diversa da quella ipotizzata nel ’36, anno della
prima edizione, riaffermando, successivamente, “la continua dialettica tra il principio dell’autonomia del campo estetico e quello
dell’eteronomia” (p. 225).
42
Si è detto del riferimento alla storia in Kahn, per Rossi cfr. A. Rossi, Architettura per i musei, in Scritti scelti sull’architettura e la città,
Milano 1975.
43
L’indugiare nel sogno e nella récherche autobiografica di Rossi rende legittimo il ricorso alla psicoanalisi, ovvero la lettura nei testi architettonici rossiani della coazione a ripetere le forme ed il loro passato, che induce a pensare al desiderio di ricostruire un luogo mitico originario in cui la volontà al piacere (del testo) sia già congiunta con l’istinto di distruzione, l’affermare al negare, palese anche nella teorizzazione di una scientificità dell’architettura che, mostrando i tratti poetici, finisce con il professare una antiscientificità, così come è per
ogni ragione che si sostiene su più profonde affezioni irrazionali.
44
Per Massimo Scolari si veda in particolare il catalogo della mostra Disegni per UNA architettura, tenuta a Milano alla Compagnia del
Disegno nel 1976, e per Franco Purini il catalogo della mostra delle stampe, Pareti. Sette incisioni, alla Galleria Romero a Roma con la lettura critica di Francesco Moschini, Note sul progetto grafico di Franco Purini, Roma, 1977.
20
vo dell’arte, come pure accadde negli anni settanta 45, foriero a sua volta di visioni ideologiche. Vale a dire che
una critica la quale voglia sfuggire a sua volta il ruolo di essere “metalinguaggio in base al quale illuminare distorsioni, mistificazioni, errori” rispetto a principi ideologicamente affermati come veri, non può che essere essa
stessa “progetto effettuale di crisi, messa a nudo di contraddizioni determinate” senza cioè “dispiegare l’oggetto,
risolverlo e chiuderlo in una interpretazione vera, ma renderlo formulabile nella sua reale e determinata complessità… proprio come oggetto contradditorio”46, fino a rendersi anzi “cosciente dell’artificiosità delle proprie operazioni” e “rivelare la strumentalità delle proprie attribuzioni di senso”47, le proprie affezioni, la propria ideologia,
in una parola esemplare che, mostrando le proprie evoluzioni, saggi il proprio limite sospendendo il giudizio a restare in silenzio perché ancora si possa costruire, parlare… tacere.
45
Lungo questa linea della critica come negazione dell’arte Giorgio Pasqualotto, op. cit.
M. Cacciari, Krisis, op. cit. e la lettura che ne offre Franco Rella in «Aut Aut» n. 159-160.
47
M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, Bari, 1968, p. 264.
46
21
THIS IS TOMORROW Vs THIS WAS TOMORROW
Sulla fine delle logiche del secondo novecento Koolhaas dichiara, in un'intervista di Lynne Cooke (critica d’arte ed Art curatrice del Dia
Foundation, New York, dal 1991) al Fairmont Olympic Hotel, Seattle, 2004 sul senso della mostra “The Art and the 60s: This Was
Tomorrow”1, la fine dei sistemi generativi del POP made in UK. Alle domande di Lynne Cooke, Koolhaas risponde con sagacia e cinismo.
E’ da sottolineare che la mostra POP patrocinata da Banham era intitolata THIS IS TOMORROW (questo è domani inteso ora è domani)
mentre la mostra alla TATE cui si riferisce Koolhaas è intitolata THIS WAS TOMORROW (questo era domani inteso ora era ieri) in un
duello di tempi che adducono a scenari differenti. Di qui il titolo THIS IS TOMORROW Vs THIS WAS TOMORROW con cui
l’intervista, che ho personalmente tradotto, è riportata nella mia tesi di Dottorato sull’attività didattica e culturale della Architectural
Association di Londra.
Raffaele Nappo
L. C.: Se vedessimo il punto centrale di Richard Seifert o ogni altra essenza degli edifici medi degli anni 60 è
ancora oggi riscontrabile una linea Vittoriana o Edwardiana. Nonostante tutte le discussioni sui radicali
cambiamenti delle strade o delle nuove urbanizzazioni di Londra, sembra che queste aree medie diffuse siano
legate da qualcosa che fondamentalmente non sia cambiato nel tempo.
R. K.: Questo è un punto interessante poiché in Europa cambiare su larga scala mostra delle resistenze. A
Londra, per esempio, ti meraviglieresti osservando le “accumulazioni delle trasformazioni” ed il modo poco
intelligente di cambiare. Ho sempre sentito delle motivazioni del tipo l’Inghilterra non ha acute ambizioni
teoriche perché il sentimentalismo lì ha un' interessante non abilità ad implementare cose su un livello teorico. Se
tu vedessi la Kelling House di Denys Lasdun, vedresti quanto è sensazionale proprio per questa ragione. Mai
pretendere che l’intero contesto debba essere cancellato ed il British solitamente proponeva proprio questi tipi di
interventi. Nel frattempo ogni persona in Europa stava provando a cancellare ogni cosa, perdendo il punto della
creazione di questa eloquente interferenza tra il vecchio ed il nuovo.
L. C.: Ma pensi che tali edifici siano compromessi inevitabilmente con questi tipi di interventi?
R. K.: Ironicamente si, perchè in questo modo molti di essi sono stati costruiti per un pubblico vantaggio e noi
ora tendiamo a pensare che essi siano compromessi semplicemente perché non erano unici ed erano carenti di
firme. La cosa era generata in uno spirito di benevolenza e, guardando al nostro impoverimento, ci rendiamo
conto che abbiamo bisogno delle icone per iniziare a prestare attenzione.
L. C.: Così noi ora parliamo di Patrick Hodgkinson, in particolare del Brunswick Centre housing project, che
non era il peggiore per molti significati?
R. K.: No, noi possiamo, sicuramente, alzare tali prodotti di qualità ma allo stesso tempo ci rammarichiamo per
le nostre aspettative che inizialmente sono state troppo alte e afflitte dall’estetica e dalla richiesta dei materiali.
Alcune volte ci troviamo in difficoltà. Se guardassimo Alexandra Road Estate potremmo vedere la pretesa di
erte tessiture che potrebbero essere epurate.
L. C.: Quest'implicazione degli aspetti estetici è qualcosa che ricopre e che può essere aggiunta, sottratta o
integrata dall’inizio?
R. K.: Essenzialmente si e questi di solito sono immediatamente e direttamente connessi tra architettura e
un'ideologia di eguaglianza. Oggi questi concetti estetici sono difficili da capire. Questa connessione è
largamente ed inconsciamente abbandonata e perfino il nostro cuore è piuttosto rassegnato e siamo eccitati per
l’eccezionale e per i giocosi capolavori. Per me questa situazione cancella una questione non solo evidente qui in
Inghilterra, ma specie quando transito dalla Berlino ovest alla Est o quando viaggio a Mosca, cioè il livello di
lusso ed eccesso nei quali noi indulgiamo ora è diventato molto appartenente in quelle zone di un passato
egualitario.
L. C.: E’ questo un prodotto tipico dell' architettura che ha dominato dal 1990? Edifici generati dai privati come
opposti al settore pubblico?
R. K.: La produzione architettonica connessa al profitto ha cambiato le città ma non l'intero contesto urbano.
L. C.: Vorresti dire che gli interventi privati erano isolati ed autonomi piuttosto che integrati?
R. K.: Si. Una personale conseguenza del movimento del profitto è rappresentata più che dal cambiamento delle
città dalle realizzazioni prodotte in disaccordo con ogni affermato programma o ambizione urbana. Molti degli
1
Si tratta di un'esibizione che rompe il campo d’azione della Tate Britain attraverso un percorso mix della fine dell’arte,
architettura e fotografia. Art and the 60s: This was Tomorrow looks at new forms of art that emerged in Britain between
1956 and 1968. 30 June - 26 September 2004.
22
edifici del 1960 erano realmente goffi e sgraziati ma seppur loro avessero poca virtù estetica o qualità, avevano
un senso di essere deliberati nonostante il loro legame con un piano o una giuda.
L. C.: Come per la Piccadilly Plaza di Manchester o il Bull Ring in Birmingham, molte città inglesi hanno il
loro centro, il loro cuore ridisegnato. Questi esempi sono identificabili o distinguibili tra gli altri? Tu pensi che
questo sia importante?
R. K.: Le persone sono convinte che la bellezza, per esempio ,della Piccadilly Plaza di Covell & Matthews, sia
riscontrabile ai loro sensi nell'aspetto programmatico di città come Londra o Manchester. Io sono sempre più
meravigliato della semplicità della produzione di tale architettura. Per contrasto oggi è quasi oscena tale
riproposizione. Ironicamente l'identità è diventata un'obbligazione. Noi siamo in un invidiato grande momento
nel senso che, sebbene probabilmente non esplicitiamo un condono delle virtù capitalistiche, contribuiamo al
taglio dell’identità spesso al costo dell’autenticità che facilmente coesiste con la più naife architettura dei nostri
immediati predecessori.
L. C.: Vuoi dire che la progettazione delle case pubbliche non è più possibile?
R. K.: Non c’è più possibilità o nessuno ci crede più.
L. C.: Tu hai parlato a lungo di Cedric Price e della sua importanza ed hai anche discusso sull’ideologia o
teoria che non ha realmente giocato un grande ruolo in Inghilterra. Dato che lui non ha costruito quasi nulla,
come spieghi questa apparente contraddizione?
R. K.: Io penso che Cedric Price ha fatto incredibili cose. Lui era un ideologo ma non un teorico. In genere io
sono molto scettico sul fatto che qualcuno possa essere teorico dell’architettura perché realmente non ci sono
teorie. Ci sono precedenti direzioni e movimenti che generano forme ed è molto importante separare questo dalla
teoria. La cosa più interessante di Price per me è che mentre lui era, in un certo modo, un architetto nostalgico e
conservativo il suo più radicale ed innovativo contributo era l'implacabile e senza fine questione della richiesta e
pretesa dell’architettura e degli architetti. Lui era uno scettico che torturava una disciplina conservativa. Cosi nel
1960 il suo fascino era duplice: su un braccio c’era la misura della sincerità e serietà degli sforzi e su un altro la
spietatezza della messa in discussione di tale sforzo da parte di persone come Price. Presumibilmente c’è
un’interna connessione tra i due e lui poteva solo essere spietato poiché il periodo produceva difficili e
competitive forme.
L. C.: Ci sono curiose anomalie in questa situazione. Per esempio, non solo la storia dell’architettura di
Nikolaus Pevsner ma anche Peter e Alison Smithson provarono a preservare i paesaggi urbani del XVIII secolo
di Bath e l'Arco di Euston a Londra. Quindi c’è sia la posizione conservativa che la più avanguardista
appartenente ad un forte senso della storia attribuito in un ruolo o ad una posizione nel presente ma quasi
nessuno propose una tabula rasa.
R. K.: L'intera pubblicazione della tabula rasa è realmente interessante poiché credo che un senso della storia è
radicato in architettura probabilmente in modo più tacito che in ogni altra professione. Ad esempio l’avanguardia
in architettura è conosciuta molto di più rispetto alle avanguardie artistiche da parte degli studenti di architettura.
Il nostro fondamentale materiale genetico è antico ed io non sono sorpreso e non lo definirei come una forma di
conservatorismo poiché questi elementi, come la Euston Arch ,sarebbero una pubblicazione per la conservazione.
Non posso immaginare un architetto singolo al momento che propone di liberarsi dal senso storico, eccetto, forse,
solo per gli interessi dello sviluppo commerciale. Il mito della tabula rasa ha avuto un' interessante vita in
architettura basti pensare che era proposto nel 1920 come una poetica nozione letterale. Poi dopo la seconda
guerra mondiale il mondo si è capovolto, iniziando il più serio crimine che un architetto potesse mai commettere.
Esso era una forma di propaganda usata per gli architetti per produrre le loro ragioni più vivamente e
presumibilmente anche per avanzare nella loro carriera ma poi divenne la propaganda dei non architetti contro gli
architetti.
L. C.: Il caso più estremo potrebbe essere Le Corbusier?
R. K.: Non ho mai creduto che ci fosse un serio sforzo di Le Corbusier di essere un antistorico, egli è per lo più
un mito che ha spostato l’architettura come un'impensabile forma di peccato originale.
L. C.: Vuoi dire che non intendeva eseguire i suoi programmi? non era intenzionato a radere al suolo una
grande parte di Parigi?
R. K.: No. Io sono sicuro che lui scelse la più bella parte di Parigi semplicemente per dimostrare il suo punto di
vista. Bisognerebbe ricordare che dopo la seconda guerra mondiale c’erano molte situazioni in cui si era
riconfigurata la tabula rasa. Penso che qualcuno dovrebbe scrivere realmente una seria storia della tabula rasa e
cosi potremmo scoprire alcune incredibili discrepanze comparate con la storia ufficiale. Per esempio sono
totalmente convinto che un progetto come il Robin Hood Gardens di Peter e Alison Smithson era in ogni suo
senso concettualizzato e coesistente con tutto il contesto.
L. C.: In un modo differente Richard Hamilton e R. Banham sembrano essere un’altra chiave della figura di
questa era. Per quanto riguarda questi punti, forgiando una nuova alleanza tra l’evidente moderno e la storia,
23
Banham, nel testo Theory e Design in the First Machine Age, essenzialmente riscrisse la storia del primo
novecento con il futurismo e regole formative e allo stesso tempo stava scrivendo sull’innovativo design
automobilistico e sui nuovi oggetti industriali.
R. K.: Credo che il cosiddetto purismo, di cui gli architetti sono spesso accusati, sia una proiezione, quasi una
speranza. L'architettura è un tropo strano per esser associata con l'eliminazione sia all’interno che all’esterno del
proprio dominio del purismo e dell’intolleranza e, al di fuori di ogni sorta di ambiguità, è considerata
incongruente. Per il mondo esterno la consistenza dell’architettura è un dato di fatto da cui si devia a proprio
rischio e pericolo.
L. C.: Nel 1960 c’era un grande contrasto tra l’Inghilterra e l’America, dove la nozione di tabula rasa era
polemicamente invocata per gli artisti che vanno da Barnett Newman a Tony Smith e Donald Judd. Quando tu
scrivesti Delirious New York in New York all'inizio del 1970 sentivi che stavi scrivendo in un ambiente con
nozione di rivalità?
R. K.: Questa probabilmente sembra una sottile differenza ma è importante e Delirious in New York è stato
scritto come una polemica contro la prima composizione e firme del post-modernismo in architettura piuttosto
che come un argomento contro la modernità. Questo è definitivamente un libro tra Europa e America infatti è
dissacratorio con la mentalità europea che mi guidava ma allo stesso tempo usavo “una forma di America” contro
il Post modern americano. Cosi, in questo senso,esso aveva una doppia agenda. La mia ambizione, con Delirious
New York, era di identificare e porre chiaramente un altro modernismo. Noi Europei siamo responsabili e pratici
di idee Suprematiste, Dadaiste, Surrealiste, ma conosciamo ben poco del mondo delle sperimentazioni che di
fatto occupa il parallelo negli U.S.A. tra le guerre del modernismo americano. Le identificazioni di particolari
forme di Modernismo, negli USA, sono state glorificate con lo storicismo ed il post modernismo. Se
osservassimo il 1970 ci accorgeremmo che c’erano momenti in cui i nostri uffici, insieme a pochi altri, realmente
sembravamo isolati nella ricerca e nel mantenimento delle istanze del Modernismo.
L. C.: Perché lasciasti l’Inghilterra per gli USA? Eri insoddisfatto per quello che era successo in architettura in
Inghilterra?
R. K.: Se ora guardassi indietro a quando ero studente potrei rispondere positivamente sul puritanesimo,
guardando le immagini dell’Inghilterra del 1960. Successivamente il puritano aspetto dell’architettura mi
sconvolse e da qui la ragione per cui lasciai l’Europa ed i motivi furono la frustrazione dell’imposizione delle
limitazioni sull'architettura e sul senso dell’interesse della città storica con veemenza lanciata da persone come
Aldo Rossi, i quali era soliti a discreditare i nuovi sviluppi dell’architettura.
L. C.: Hai lasciato l’Inghilterra nel 1972 dopo che Banham era rientrato, con molte persone a suo seguito,
dagli ambienti americani degli anni 60. Cedric Price non era tra questi e lui non costruì quasi nulla. Tu pensi
che il suo contributo sarebbe stato differente se avesse lavorato in America o lui dipendeva dai sui confronti?
R. K.: Questa è veramente un’interessante questione. Lui partecipò a competizioni internazionali per esempio
alla realizzazione della Villette a Parigi. Se la mia memoria è corretta, io penso che lui propose anche un progetto
per la realizzazione di un quartiere in Florida. Viaggiava regolarmente in America ed in altri continenti che erano
considerati come avamposti delle discussioni di Londra. Erano incantevoli le sue risposte ed io non sono sicuro
che qualcuno conoscesse realmente il loro significato e forse in qualche modo lui rappresenta le nostre colpevoli
coscienze.
L. C.: Sull’inesplorata direzione?
R. K.: Si, infatti se considerassimo la nuova biblioteca di Seattle, forse in un patetico modo e provassimo ad
essere Cedric Price, potremmo notare la piegatura e le sfaccettature di questo edificio piuttosto vicine in termini
diagrammatici e meccanici a quelle dell’Aviary di Price per il London Zoo.
L. C.: Meraviglioso se tu potessi tracciare un altro riferimento architettonico ispirato al Fun Palace di Price,
essendo un edificio non gerarchico delineato da una buona cultura in cui le persone costantemente riposizionano
elementi in ordine a differenti forme artistiche giunti come un gioco, tutto ciò è tipico nel Center Pompidou nel
suo concepimento originalmente o nel tuo progetto per la Los Angeles County Museum of Art?
R. K.: Io non conosco una singola persona che non creda che il Pompidou sia derivato da qualche connessione
con il Fun Palace. Il LACMA non è libero per tutti e rappresenta più un tentativo di accordo con il museo
enciclopedico in generale. Il Pompidou invece è essenzialmente un edificio loft su parecchi livelli. Con la
proposta LACMA io tentai di esplorare quale potesse essere teoricamente il grandissimo potenziale di un museo
enciclopedico che mostrasse il suo sviluppo parallelamente allo scorrere del tempo. Esso offre una panoramica
delle varie linee del tempo. In un comune museo storico, il soggetto è la gerarchizzazione degli spazi periodi e le
categorie sono poste nel giusto posto infatti hanno sezioni o padiglioni. L’assenza di tali gerarchie ha condotto
LACMA ad esser progettata su un solo piano ed è stata presentata come un griglia storica nella quale ogni cosa
può essere posizionata in modo da poter vedere lo sviluppo delle culture nel tempo e dare risalto alle differenze.
L. C.: Ma il suo cuore è posto all’interno di una neutrale intelaiatura?
24
R. K.: Penso che il modulo non è stato neutrale forse lo era solo nella prima proposta. Dovevamo presentarlo il
12 settembre 2001 ma dopo l'11 settembre la presentazione è stata rinviata e nel frattempo lo abbiamo modificato
drasticamente.
L. C.: Quali sono stati i paradigmi che vi allontanarono dalla neutralità?
R. K.: In qualche modo dopo l’11 settembre abbiamo sentito la neutralità troppo fredda. Le ragioni
nell’architettura sono delicate perché i progetti sono presentati come ragioni o come ragionamento, anche se sono
semplicemente azioni intuitive o adattamenti alle contingenze.
L. C.: Tu pensi che l‘idea del Fun Palace non sia più fattibile in questo momento?
R.K.: Io penso che potrebbe essere cosi e forse la mostra al TATE MODERN evidenzia il grado nel quale non sia
più possibile. Lo spazio vuoto del TATE potrebbe essere visto come il Fun Palace, ed esso risulterebbe moto
eccitante se potesse essere applicata l’idea di Price ma esso è diventato un rigido programmato spazio museale
[…]. Sebbene non ci siano più multi discipline attive oggi esso sembra troppo rigido per esporre le scoperte che
poi sono state fatte.
L. C.: L’altra idea di Cedric Price su cui desidero chiederti riguarda la sua nozione di magnete come
distinzione dal icona comunicata, costruita ed integrata in un contesto. Magnete implica un certo grado di
coesione piuttosto di esclusione come un comunicato firmato?
R. K.: Bisogna pensare che Price era fortunato in qualche modo, più del suo lavoro e più delle sue dichiarazioni,
erano interessanti le idee della necessità della firma in architettura, come successivamente poi è emerso. Essa è la
più corrosiva idea del tradizionalismo accademico. In questo momento ciò crea un incredibile pressione perché
essa è inevitabile. Non c’è modo di superarlo con la sola astuzia, forse può essere ignorata con più o meno sforzo.
L. C.: C’è un implicita rivendicazione nella mostra ‘Art & the 60s’ basata sulle differenze tra 1960 e il 1990 che
sono stati momenti straordinari nella cultura Britannica.
R. K.: Il 1990 era emozionante per lo più per l’internazionalismo della nazione ma non ha alcun intima relazione
con il 1960. La cosa speciale del 1960 nel UK è individuabile nella capacità delle persone di essere
simultaneamente parrocchiali, creative e innovative e di solito questi tre fattori sono separati. C’erano bizzarre
fiabe, molti miopi ed intensi appariscenti sodalizi con affascinanti campi di scoperta. Penso che la principale
differenza tra il 1960 e il 1990 stia nell’ultimo parrocchiale momento usato quasi come “un arnese”. Quando io
andai all’Architectural Association nel 1968 c’era una stanza da pranzo con posate e camino e questa era
un'incredibile scena perché il più moribondo elemento della cultura inglese stava per esser usato come proposta
contro l’avanguardia. C’era una mutuale rassicurazione ed interdipendenza per le istanze dell’avanguardia in cui,
nel suo sfondo, noi identifichiamo l’ultimo spasmo di una particolare cultura che non poteva perdere. Penso che
c’era un gradito piacere in esso. Questo tipo di regola-gioco è quasi assente ora perché, essenzialmente oggi, non
si può più avere il lusso dello sfondo e contemporaneamente del primo piano poiché ogni cosa è diventata primo
piano.
L. C.: Cosi anche al Courtauld Istitute of Art, poi trasferito al Robert Adam house, le separazioni dei ruoli tra la
docenza destinata alla grande scala cerimoniale e gli studenti-disegnatori destinati all’utilizzo del retro scala ,
era collassato. Tutti mangiavano insieme nella piccola caffetteria di cattivo gusto che poi è stata valorosamente
gestita da una sola donna. Anche se pieno di contraddizioni il Courtauld è stato effettivamente molto produttivo.
R. K.: Probabilmente si può rintracciare l'appiattimento di una certa cultura con la modernizzazione dei bar
dagli interni Minimalisti.
L. C.: Questo ci porta indietro all’idea che lei ha recentemente affermato e oggi noi richiediamo sempre più
adattamenti lussuosi. Questa azione mira all'improvvisazione?
R. K.: L’improvvisazione è una bella parola poiché essa connette Banham e Price ma non possiamo più far
fronte a questo.
26
UNA BIENNALE SENZA UTOPIA
Maurizio Cecchetti
Il primo indizio inquietante di questa dodicesima
Biennale d’architettura veneziana è venuto qualche
giorno prima dell’apertura della mostra, quando la
giuria internazionale ha reso noto di aver attribuito il
Leone d’oro alla carriera a Rem Koolhaas, ovvero
all’architetto olandese che oggi esprime più di tutti il
logos del supercapitalismo mondiale, l’architetto che
in un saggio ho definito il capofila del "realismo collaborazionista". Il realismo collaborazionista è il
principio etico delle archistar, che per lasciare il loro
segno sulle città globalizzate sono pronte a scendere
a patti con qualunque realtà politica o con quei sistemi che, pur nati sotto l’influenza occidentale, praticano oggi un’etica contraria a quella che l’Occidente ha messo a punto faticosamente nei secoli e
che ha al suo centro il bene comune e il bene della
persona (non genericamente della “gente”). Si può
dire che questo supercapitalismo metta in atto su
scala mondiale una visione del mondo che fa
all’uomo ciò che il comunismo ha fatto alle società
sovietizzate con la retorica e con le seduzioni estetiche del gigantismo architettonico: lo rende servo di
interessi che sono quelli di una oligarchia (economica e politica: oggi, infatti, il principio “produttivo”
diventa elemento discriminante dell’etica pubblica).
Koolhaas crede, in sostanza, che nel mondo globalizzato non ha alcun senso mettere in atto un atteggiamento di astensione o di rifiuto verso realtà
che, pur esibendo un sistema di valori in contrasto
col principio di libertà nelle sue molteplici dimensioni, sono soggetti dominanti sulla scena mondiale.
Sarà casuale che il mercato più florido delle archistar oggi sia in Cina e nei Paesi arabi? E com’è
accaduto che nello spazio di vent’anni l’Occidente,
che un tempo ha combattuto i mondi liberticidi, è
disponibile ogni giorno al compromesso pur di salvaguardare i propri interessi economici? È questo il
progresso portato dalla globalizzazione? Sia chiaro,
l’economico è stato il termine di paragone fra mondo libero e mondo totalitario fin dall’epoca che ha
visto cadere i regimi coloniali, ma da quando la Cina
ha scelto l’economia di mercato pur rimanendo sul
piano politico un paese comunista, tutto si è complicato, perché questo ibrido economico-politico ha costretto l’Occidente a venire a patti con chi in passato
avrebbe condannato senza mezzi termini (se non altro è perché c’è sempre qualcuno pronto a prendere
il posto di chi rifiuta il compromesso: questa è la
cattiva coscienza del “realismo collaborazionista”).
Aver chiamato alla direzione della Biennale la
giapponese Kazuyo Sejima, fresca di premio Pritzker (il Nobel dell’architettura), avrebbe potuto es-
sere un segno del ritorno all’architettura dopo la Biennale del 2008 curata da Aaron Betsky con uno spirito che il presidente Paolo Baratta definisce di “gioioso pessimismo”, insistendo ripetutamente sul termine gioioso, mentre è sul pessimismo che i conti
non tornano, perché bisognerebbe dire che quella di
Betsky è stata una Biennale di “gioioso nichilismo”,
cioè un’edizione dove si faceva piazza pulita
dell’architettura. In un’epoca dove tutto è immagine
e lo statuto disciplinare dell’architettura è sempre
più vago (per questo gli architetti invadono il campo
delle arti visive) Sejima prometteva maggior rispetto
dell’arte di costruire. Può essere che gli architetti
parlino meglio con lo spazio di quanto non facciano
con le parole. È forse per questo che all’Arsenale, in
apertura di mostra, c’è un video di Wim Wenders
che celebra una delle architetture più note di Sejima,
quella del Rolex Learning Center di Losanna, e che
in una delle prime sale del Palazzo delle Esposizioni
ai Giardini un’enorme plastico mostra il progetto di
Sejima & Associates per l’Art House dell’isola di
Inujima: scelta di cattivo gusto che un direttore dia
tanto spazio alla propria opera? Per carità, se Le
Corbusier avesse diretto una Biennale d’architettura
e avesse esposto il plastico e i disegni per l’Unità
d’abitazione di Marsiglia quanti oooh di meraviglia
e di adorazione avrebbe suscitato…
Ma appunto, stiamo parlando di valori infinitamente diversi sulla scala graduata del genio, per
quanto si possa o si voglia criticare l’opera di Le
Corbusier (come accadde nella sala di Tom Sachs).
In Le Corbusier l’utopia aveva la concretezza
consentita dai calcoli della ragione e da un mondo
plasmato dalla tecnologia, un sogno dell’immaginazione diventato realtà; in Sejima il realismo
gioca di fantasia, ma resta tale: celebrazione della
lingua dominante. E infatti questa Biennale è
l’espressione, un po’ più architettonica, ma sempre
“estetica”, della lingua dominante (compresi certi
pauperismi etnici, pur interessanti, come il WorkPlace di Mumbai Architects, che allestisce uno spazio di carpenteria suggerendo il ritorno al “lavoro”
nell’architettura).
Quasi un secolo fa Henri Focillon, scrivendo di Hokusai, cercava di mettere in luce cosa distingue l’arte
occidentale da quella giapponese: l’Occidente lotta
contro la materia usando la materia stessa, “i suoi
trionfi sono bagnati di sudore”, mentre il Giappone
“si limita: riduce lo spazio, scaccia la notte, semplifica e affina il suo sapere”. Di questo c’è ben poco
nella Biennale di Sejima: il grottesco si tocca quando, di fronte all’opera “leggera”, ragnatela di essen-
Padiglione del Bahrain
Amateur Architecture Studio, “Decay of a Dome”
27
ze colorate presentata da Andrés Jaque Arquitectos
(che vuole raffigurare con un intreccio visivo le conflittualità che si creano in una casa dove vivono cinque persone a Madrid), qualcuno commenta: «ah, sì,
questo è molto giapponese». Naturalmente, ti viene
da pensare che lo spettatore alluda al gusto per la
leggerezza con cui il direttore della Biennale ha
scelto di esporre quel progetto spagnolo, ma poi ti
rendi conto che per trovare qualcosa di giapponese
in questa mostra lo devi cercare fuori dal Giappone
(anche le macrostrutture di Toyo Ito, uno dei più interessanti architetti nipponici, sposano il gigantismo
- la bigness - vestendolo di un’estetica fitomorfica).
La domanda che dovrebbe farsi chi organizza una
Biennale di architettura è questa: come sfuggire
all’incudine e al martello di una mostra pensata allineandosi allo spirito estetico-ludico della Biennale
d’arte, quasi dovesse riempire il vuoto dell’anno di
passaggio da un’edizione all’altra; superando,
d’altra parte, i limiti impliciti che si manifestano
quando si vuole “mostrare” l’architettura con plastici, video o disegni, cioè con rappresentazioni di
qualcosa che si può comprendere e valutare pienamente soltanto quando si entra nello spazio costruito? Si dovrebbe tentare una strada nuova a cominciare dalla scelta del direttore: basta con gli architetti, i quali, sentendosi tecnici pieni di cultura, mostrano la tipica prosopopea da primo della classe: si
affidi la Biennale a una persona di cultura con formazione interdisciplinare, e gli si dia carta bianca
nella scelta di due o tre collaboratori esperti nei diversi campi del sapere: antropologia, architettura,
urbanistica, cinema, letteratura, comunicazioni di
massa... Si crei, insomma, un team-laboratorio dove
ciascuno è chiamato a collaborare a un progetto
d’insieme, senza ambizioni particolaristiche e consorterie culturali, con la volontà di esprimere una
visione dell’architettura molteplice e concreta, sociale e immaginativa, utopica e realistica, visiva e
musicale (si ricordi, per esempio, la collaborazione
fra Xenakis e Le Corbusier). Forse solo pensando
l’architettura come mosaico antropologico, come
forma dell’abitare, si può approdare a uno sguardo
rinnovato del suo stesso futuro.
28
L’ARCHITETTURA DELL’ESATTEZZA.
LA NEUE NATIONALGALERIE DI BERLINO DI MIES VAN DER ROHE*
Renato Capozzi
Il presente scritto, redatto nell’ambito di una ricerca MURST-PRIN 2000 – poi approfondito nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Composizione
Architettonica presso lo IUAV1 – e per l’occasione
parzialmente integrato, intende proporre, a partire
dall’analisi di un opera paradigmatica quale è la
Neue National Galerie di Mies van der Rohe, una
riflessione più ampia sul portato teorico e conoscitivo della ricerca di questo Maestro inarrivabile
dell’architettura.
L'analisi, quale procedura opposta alla mera descrizione e basata sul principio di discretizzazione
del tutto architettonico in parti descrivibili, si sviluppa secondo tre momenti metodologicamente correlati: l’ideazione o se si vuole la riflessione sul tema e sul senso del manufatto; la costruzione come
passaggio ineludibile e verifica dell’architettura; la
composizione come dis-velamento delle tecniche e
delle procedure sintattiche che presiedono alla costituzione dell’opera. L’ipotesi di fondo che è sottesa ai
ragionamenti di seguito esposti, afferma che questi
tre momenti – proposti in analogia con la triade vitruviana da Salvatore Bisogni – si pongono come
dispositivo analitico-conoscitivo delle opere di architettura. Un dispositivo che può essere applicato in
una generalità di casi dove però sia esposto con
chiarezza, qui al limite della didascaliticità, una ‘opzione razionale’ sulla disciplina che ne consenta e ne
persegua l’intelligibilità delle scelte ‘consistenti’,
per mettere in opera ed in scæna ‘forme necessarie’
e non gratuite.
Mies è un architetto ‘elementarista’2 che riduce la
complessità d’ogni tema a pochi elementi che si emancipano dalla loro individualità astratto geometrica per nominarsi e identificarsi come atti della costruzione. Tali elementi non sono ulteriormente elidibili al pari dei numeri primi nella edificazione
dell’impalcato della Matematica. La ricerca della
semplicità dell’espressione formale e dell’esattezza
della costruzione garantisce la riconoscibilità e la
condivisione dei valori universali contenuti nell’architettura.
1
R. Capozzi, Il tema dell’Aula nelle architetture di Mies
van der Rohe, tesi di Dottorato di Ricerca in
Composizione Architettonica (relatore A. Dal Fabbro,
controleralore G. Polesello, tutor M. Landsberger) XVI
Ciclo, Università IUAV, Venezia, 2004.
2
Cfr. L. Hilberseimer, Architettura a Berlino negli anni
Venti, a cura di G. Grassi, Franco Angeli, Milano, 1979.
Ideazione
Nel 1962 la municipalità di Berlino affida a Mies
van der Rohe l’incarico di redigere un progetto per
la costruzione di una Galleria del XX secolo (poi
Neue Nationalgalerie) da costruirsi in un’area devastata dai bombardamenti dell’ultima guerra, e dove
collocare, sulla base di un piano urbanistico redatto
da Scharoun, una serie di edifici rappresentativi della città e dell’intera Germania dell’Ovest: il Museo
suddetto, la nuova Biblioteca di Stato, la nuova Filarmonica. Il piano di Sharoun propone per questo
particolare luogo della città una disposizione di oggetti legati da relazioni di natura topologica in cui il
vuoto realizza e manifesta il sistema di rapporti a
distanza e determina la collocatio delle architetture.
L’incarico dell’edificio più ‘aulico’ è conferito a
Mies “senza limiti di spesa”. Nel Museo di Berlino,
come in tutti i suoi edifici civili, dal Teatro di Mannheim alla Biblioteca dell’IIT, Mies produce una
profonda erosione/riformulazione del tema dell’edificio pubblico, della sua ragione essenziale, al pari
di quanto era stato esperito da parte degli architetti
illuministi. L’innovazione tematica o re-invenzone
avviene nel senso di in-venire, cioè di trovare nella
“cosa” una nuova ipotesi sia di spazio sia di museo
ribaltando completamente i modi con i quali tale
manufatto era stato concepito dalla cultura ottocentesca ovvero come manufatto che custodiva ma al
tempo stesso celava il sapere (in quanto arte) e la
cultura. Viene completamente rivoluzionata l’organizzazione convenzionale del Museo con il sistema
atrio, quadrerie e successioni di sale come codificato
negli schemi combinatori di Durand dei quali non fu
immune lo stesso Schinkel nell’Altes di Berlino.
Sono superate anche le contemporanee ricerche di
Le Corbusier o di Wright sul museo-percorso puntando invece a ricomprendere e a rinnovare l’idea di
luogo della ‘memoria e della riconoscenza pubblica’
ricercato da Boullée. Tale scelta ideativa e di senso
diviene subito scelta architettonica: l’Aula, il grande
spazio rappresentativo unitario, un grande riparo
collettivo. Vi è un‘ipotesi di spazio mai raggiunto
nell’architettura sino ad allora, vi è l’ordine costruttivo-compositivo, vi è il tetto, vi sono le pareti opache o trasparenti: tutti questi elementi non si sovrappongono mai, le parti dell’edificio si discretizzano,
si passa – per dirla con Le Corbusier – dal Plan Paralysé al Plan Libre. Come ricorda Frampton: “Analogamente a Viollet le Duc, Mies considerava il
“grande spazio” come la testimonianza definitiva del
29
livello raggiunto da una data civiltà”3. Lavorando
sulla ‘sala continua’, sull’eidos di ‘spazio universale’ Mies mira a costruire un’Aula o Halle (i due termini hanno la stessa radice etimologica) che è per
eccellenza l’espressione di un luogo collettivo e per
questo caratterizza con un unico tipo l’edificio pubblico. La Neue Nationalgalerie, l’ultima opera realizzata da Mies, esemplifica una ricerca ostinata durata alcuna decenni sui fondamenti dell’architettura
come arte. E’ la sua opera più discussa, la più amata
e odiata al tempo stesso, rappresenta il suo “canto
del cigno”, nonché la summa del suo modo di intendere l’architettura. Le ‘Architetture ad Aula’4 vogliono costruire un grande interno: un ambiente continuo a luce unica, in cui è possibile contenere un
grande numero di persone e diverse attività essenzialmente di tipo rappresentativo reificando in tal
modo l’idea stessa della collettività. Vi è una relativa
indifferenza distributiva rispetto ai vari usi previsti,
l’elemento distintivo è l’Aula, pur essendo differenti
i modi e le forme che la realizzano. Il carattere specifico di questi edifici è la loro grande apertura, che
rende possibile osservare e denunciare le attività
umane e civili che vi si svolgono senza il tramite di
segni architettonici o di parti aggiunte. La scelta sintetica dell’Aula non impedisce però a tali manufatti
di affermare la loro ragione costitutiva, bensì consente come in questo caso, un notevole avanzamento
nella precisazione del tema assunto. Il carattere appropriato e l’individualità tematica è realizzata attraverso le adeguate soluzioni costruttive in stretto
rapporto con le procedure compositive adottate5. In
questi manufatti si combinano i due archetipi del
muro (témenos) e del portico (il riparo) costitutivi
dell’edificio pubblico6, ma anche due modi compositivi fondamentali: quello che lavora sull’ unità e
sul volume (stereotomico) e quello che discretezza il
continuum architettonico attraverso gli elementi della costruzione (tettonico). In un saggio7 di alcuni
anni fa Ignasi de Solà-Morales, richiamando alcune
tematiche suprematiste o minimaliste, afferma che:
“l’architettura di Mies è ‘autoreferenziale’, spiega se
stessa e fa della sua presenza l’atto primordiale della
sua significazione. Parlare di contesto nell’opera di
Mies risulta inadeguato, le sue opere non commen3
K. Frampton, Tettonica e architettura, Skira, Milano,
1999.
4
Si veda L. Hilberseimer, Hallenbauten. Edifici ad Aula,
a cura di L. Lanini e A. Maglio, introduzione di S.
Bisogni, Clean, Napoli, 1998.
5 A. Monestiroli, Le forme e il Tempo, introduzione a L.
Hilberseimer, Mies van der Rohe, Clup, Milano, 1984.
6 C. Martì Aris, Il portico ed il muro come elementi
dell'edificio pubblico, in (a cura di) R. Neri, P. Vigano, La
modernità del classico, Marsilio, Venezia, 2000.
7
I. de Solà-Morales, Mies van der Rohe e il grado zero, in
“Lotus”, n. 81, 1994.
tano un luogo, non si relazionano ad esso, ma al limite lo determinano. L’architettura di Mies nella sua
autoreferenzialità, nel voler rappresentare l’aspetto
artistico come significato in sé (Malévič e Ad Reinhardt) non vuole ricordare niente al di fuori di essa,
non vuole essere monumento, ma espressione esatta
del proprio tempo”. Il grado zero di Mies, il beinahe
nichts (quasi niente) delle sue architetture manifesta
lo sforzo di pervenire attraverso l’architettura, le sue
semplici ma antichissime regole, e non con sistemi
‘eteronomi’, alla definizione del manufatto. L’edificio pubblico per la sua evidenza logico-costruttivosintattica si impone al contesto e in special modo
alla natura, non come sfida né come mimesi ma come parte di un tutto. Le architetture civili di Mies
non si adattano né si mimetizzano nel contesto, ma
si costruiscono come oggetti autonomi che stabiliscono relazioni topologiche a distanza, non commentano un luogo, un tessuto, ma lo determinano
riformulandone i caratteri e le relazioni d’ordine8.
Le Aule di Mies, in altri termini, vogliono selezionare una parte speciale della “stanza smisurata” della
Natura riproducendo nel finito l’idea di infinito (apeiron) di ‘spazio universale’, cioè di uno spazio adimensionale o per meglio dire multiscalare quasi
privo di massa, completamente aperto ed attraversato dalla natura o dai contesti urbani in cui questi edifici si collocano realizzando sub specie architetturae
quella “vertigine del vuoto” tanto presente nelle
composizioni di Malévič.
Costruzione
Mies viene spesso considerato come ‘l’architetto
della tecnica’ o della tecnologia, riducendo così
l’enorme portata del suo contributo alla costruzione
del complessivo progetto stilistico del Movimento
Moderno. “L’architettura è chiarezza costruttiva
portata alla sua espressione esatta”, questa celebre
definizione dell’arte del costruire (baukunst) proposta da Mies van der Rohe contiene - come osserva
Antonio Monestiroli9 - “i due poli della questione, e
cioè la costruzione come fatto tecnico e l’architettura come fatto rappresentativo”. Secondo Mies
infatti “L’architettura nasce quando si supera il
problema tecnico”, in ciò probabilmente sta la fondamentale distinzione tra ingegneria ed architettura.
Quando gli elementi della costruzione, superato il
problema costruttivo di cui sono il risultato, si pongono tra loro in rapporto, ovvero ‘in composizione’,
con l’obiettivo - attraverso il principio del decoro di rappresentare le loro identità in rapporto al tutto,
allora c’è architettura. L’architettura in qualche mo8 I.
9
de Solà-Morales, op. cit.
A. Monestiroli, Intervento, in Bau-Kunst-Bau, a cura di
C. Scortecci, C. Zucchi, Clean, Napoli, 1994.
30
do rappresenta - attraverso gli elementi - l’atto costruttivo, e non coincide strettamente con esso.
A Berlino l’aula è poggiata su un podio realizzato
attraverso una maglia omnicomprensiva (7,20x7,20)
di pilastri in cemento armato con solaio in soletta
strutturale. La copertura consiste in una piastra nervata di 180 cm di spessore (1/36 della luce libera)
strutturata su 18 moduli x 18 moduli e misura 64,80
x 64,80 metri. Il modulo base dell’intera costruzione
sia in pianta che in alzato è di 1,20 x 1,20 metri. La
copertura in acciaio Krupp montata a piè d’opera per
parti compiute pre-assemblate e sollevata da otto
martinetti idraulici fino alla quota di 8,40 metri, pesa
circa 1280 tonnellate. Queste cifre danno conto
dell’importanza e dell’eccezionalità di quest’opera,
tenendo presente anche che a tutt’oggi non è stata
costruita una copertura con tale luce libera e con
simili condizioni d’appoggio. L’enorme piastra poggia su soli otto pilastri disposti secondo la sequenza
5-8-5 che risulta essere l’ottima per avere momento
flettente minimo e deformata minima al centro della
piastra e coincide anche con rapporti aurei sia in
pianta che in alzato, verificando una corrispondenza
tra gli aspetti compositivi e proporzionali e quelli
statico costruttivi. I pilastri cruciformi sono leggermente rastremati verso l’alto per alloggiare le cerniere sferiche che li collegano alla lastra di copertura. Il fronte della copertura è ritmato dalle teste delle
travi che ribadiscono il modulo organizzativo. E’ da
notare che la struttura dell’aula risulta chiaramente
leggibile anche a livello inferiore ove, anche se non
denunciata esplicitamente, è centrata e indipendente
rispetto ai moduli dei pilastri che sorreggono il piano del podio.
Il rapporto con la Tecnica o per meglio dire con
le forme tecniche - per la prima volta si trova
un’estetica adeguata e rigorosa, “vera” (“il bello è la
luce del vero” – Sant’Agostino) e non banalmente
analogica delle tecniche e dei nuovi materiali contemporanei, in un’opera che spinge la struttura alle
sue estreme possibilità come lo erano state in differenti condizioni il Pantheon o la cupola del Brunelleschi, in una ipotesi di finitezza, di perentorietà delle forme tecniche e non di una loro serialità e assemblabilità meccanica. La tecnica non è un fine ma
un mezzo per ottenere le forme architettoniche.
Composizione
La fabbrica ‘sintetizza e contiene’ tutte le architetture di Mies, tutti i suoi modi di comporre. La
perfezione logica degli edifici costruiti da Mies, la
loro apparente banalità cela un lavoro paziente su
pochi ma essenziali elementi che di volta in volta
sono messi ‘a contrasto’ a partire da regole e relazioni d’ordine chiaramente espresse. La volontà di
misurare e misurarsi con la natura naturata si tradu-
ce in leggi, regole, moduli, misure, in elementi, piani, sostegni di cui Mies si serve per portare alla perfezione - come direbbe Boullée - i suoi edifici10. I
progetti e le opere che Mies produsse dopo la sua
partenza per gli Stati Uniti modificano e raffinano
non poco le tecniche compositive da lui utilizzate in
Europa. Si passa dal reticolo discreto dei sostegni
disposti su maglie ordinate, dai piani-parete, e dal
tetto-lastra, ad un’ipotesi conformativa ancor più
radicale: i sostegni sono espulsi all’esterno, la copertura diviene un piano continuo potenzialmente infinito, l’edificio così è completamente aperto all’esterno o meglio contiene una sezione “particolare” della
Natura.
Le primissime soluzioni per il Museo di cui si conservano pochi disegni ed un plastico, configurano
due versioni principali: la prima riguarda un’aula
quadrata coperta da una piastra nervata in cemento
armato precompresso di 20 moduli x 20 moduli (XX
secolo?) sostenuta da un colossale pilastro centrale a
sezione variabile; la seconda ripropone per così dire
una trance del teatro di Mannheim sempre riferendosi però ad un quadrato sorretto da quattro pilastri
che attraverso due telai paralleli con travi reticolari
sostengono la copertura cassettonata.
Rapidamente queste due iniziali ipotesi sono
scartate e Mies ritorna (com’era suo solito) alle soluzioni sperimentate nelle Bacardi e nel museo
Schäfer, riuscendo in definitiva a sintetizzarle mirabilmente. Del primo riprende il basamento-crèpidoma nel quale alloggiare le collezioni permanenti del
museo e del secondo la struttura a sezione costante
in acciaio, forse il materiale più idoneo a rappresentare l’era tecnica.
L’edificio risulta determinato dalla giustapposizione di due parti distinte: lo spalto concepito come
un volume compatto di tipo stereotomico e l’Aula a
sua volta composta di parti ed elementi distinti quali
la copertura, i pilastri con la loro ripetizione controllat e la parete vetrata che conferma però nella sua
partizione l’assetto tettonico generale. Il podio rivestito in granito di altezza variabile, data l’acclività
del sito, misura circa 105 x 110 metri e consta di due
quadrati traslati e sfalsati in corrispondenza delle
scale d’accesso con l’aggiunta di un rettangolo 80 x
20 che contiene un patio per le sculture.
Osservando la pianta del piano posto a quota –
4,00 metri dal calpestio dell’aula e collegato ad essa
per mezzo di due scale simmetriche in acciaio, si
rileva, a meno dell’ala degli uffici, una perfetta
simmetria di impianto, organizzato sul modulo di
m. 7,20 x 7,20 con pilastri quadrati e scandito da una
10
Alla inaugurazione della Neue Nationalgalerie un
radicale berlinese, come è riportato da Zevi, affermò:
“E’ un edificio che rende furiosi perché si è costretti ad
ammetterne la perfezione”.
31
sequenza di spazi ben definiti. Sembra quasi di ritrovare l’assetto tipologico di una domus con la successione vestibolo - atrio tetrastilo - peristilio, ma,
superato l’atrio quadrangolare, si incontra una sala
ipostila 4 moduli x 11 moduli che nelle prime versioni doveva essere liberamente attraversata da pareti disposte in vario modo e distaccate dai pilastri che
erano lasciati in vista. Questa sala ipostila, come
anticipato, si apre su di un patio destinato all’esposizione protetta delle sculture. Ritornano in mente il
progetto per la Casa a tre corti, ma anche e soprattutto quello per il Museo per una piccola città. Nelle
parti più interne o nelle pareti controterra vengono
sistemati gli uffici, i servizi igienici, i locali tecnici e
a sinistra trova posto una rampa per il carico e lo
scarico delle opere. Il trattamento degli spazi è assolutamente neutro: le pareti sono dipinte di bianco al
fine di far emergere le opere esposte, che riguardano
le avanguardie artistiche del Novecento, con una
specifica sezione sull’espressionismo tedesco. A
questa densità distributiva, necessaria al funzionamento del museo, fa riscontro al piano superiore,
che poi è il piano di ingresso, una quasi totale assenza di partiture e di segmentazioni: vi è un podio nobilissimo in granito sardo, basse pareti in legno, du
alti monoliti in marmo nero ed una grande e ‘severa’
copertura d’acciaio sostenuta da otto pilastri. Verrebbe quasi la voglia di non aggiungere altro a tale
perentorietà e assolutezza. Siamo per così dire al
quadrato nero (l’aula) su fondo bianco (lo spalto) di
Malévič.
A cosa serve, cosa vuole significare questo enorme vuoto? Che cosa si vuole rappresentare attraverso questo prodigio tecnico? Premesso che l’utilizzo pratico di tale spazio è abbastanza evidente
nell’essere destinato a atrio di ingresso e sede di mostre temporanee, di cui la più famosa fu quella inaugurale dedicata a Mondrian, questo spazio diafano a
cosa vuole alludere?
Per rispondere a questi interrogativi è forse necessario analizzare la successione delle differenti
condizioni spaziali che ‘avvengono’ sul podio. Si
passa da uno spazio sollevato dal suolo ma completamente aperto ad uno spazio coperto ma aperto ben
definito dalla parete vetrata e dai pilastri che lasciano significativamente liberi gli angoli, fino a ritrovarsi in uno spazio coperto da questa enorme piastra
fluttuante, a rigore uno ‘spazio confinato’, chiuso
dalla parete vetrata, ma a ben vedere completamente
proiettato all’esterno, un esterno che è quasi più
concettuale che reale. E’ l’esterno della Philharmonie o della Biblioteca di Scharoun, di quel luogo
urbano specifico, ma è anche l’esterno del ‘tutto natura’11, dello spazio infinito cosmico della natura del
11
Cfr. S. Bisogni, Considerazioni sull’Arte e la Scienza
del costruire, in “Restauro”, n. 139, 1997.
quale questo è una parte speciale, solo una porzione
‘attrezzata per la vita’, che però riesce a dar conto
del tutto e delle sue leggi: nel patio la natura è circoscritta, sul podio-tempio diviene totalizzante. Questo
spazio continuo, ‘spazio universale’, rappresenta
non solo la natura ma anche il ‘luogo delle Muse’
come accadeva nel Museo di Boullée.
La forza di quest’opera sta proprio nell’essere
sintetica di una ricerca che è quella del moderno in
architettura, e al contempo di denunciare il riferimento ai temi della classicità, della sala ipostila, del
tempio e della casa romana, o alle architetture di
Schinkel che di queste sono una prima sintesi. Un
rapporto con la storia che non è affatto nostalgico
ma sempre legato alla necessità di esprimere la modernità, l’architettura del proprio tempo, una “nuova
e antichissima bellezza”. La storia ancora una volta
è il ‘carattere letterario dell’architettura’, la storia è
il terreno delle scelte, essa diviene un repertorio, un
‘deposito di umane fatiche’ da cui attingere selettivamente. Come afferma Mies: “Ogni epoca ha una
sua grandezza”.
L’immensa copertura è un tutt’uno, è una concrezione (anche se fatta con travi d’acciaio) che non
può crescere, è come nel Pantheon, un monolito. Il
sistema proporzionale apparentemente forzato che
Mies impone a quest’architettura con l’obiettivo di
ricercare le forme necessarie vuole ribadire la non
arbitrarietà delle scelte compositive: anche nel fare
un “semplice quadrato” ci si deve porre il problema
dei rapporti armonici, delle relazioni tra le parti, del
controllo trasmissibile e verificabile dello spazio12.
In ciò sta probabilmente la grandezza di
quest’opera nell’essere assoluta e raffinata, nelle
relazioni con i mondi formali e culturali che invoca
e nell’essere pur così concreta, così mondana, così
costruita con arte.
12
Mies, in tal senso, esprime questo concetto con estrema
chiarezza: “Credo che l’architettura non ha niente a che
vedere con la creazione di forme inedite, né con il gusto
personale; l’architettura per me è un’arte oggettiva che
nasce dallo spirito del tempo”.
32
DILLER SCOFIDIO E RENFRO, UN MODO NUOVO DI FARE ARCHITETTURA
Francesca Buonincontri
Lo studio Diller Scofidio + Renfro Architects
propone un modo nuovo di fare architettura finalizzato alla trasformazione dell’utente in soggetto cosciente del farsi e dell’uso dell’architettura e basato
sulla sperimentazione artistica nelle discipline più
diverse ovvero sull’utilizzo delle più moderne tecnologie comunicative.
Le diverse discipline cui si ispirano vanno dalle
arti visive, al teatro, la letteratura e la meccanica,
mentre le tecnologie di comunicazione utilizzate sono video, immagini in movimento su grandi schermi, monitor, microchip.
La metodologia progettuale dello studio Diller è
basata sulla riproposta del ruolo politico e sociale
delle arti, in primo luogo dell’architettura, resa più
popolare e comprensibile a tutti, ed è alla continua
ricerca di punti di vista innovativi e originali sull’uso della città contemporanea.
Gli interventi realizzati da questo studio stanno
modificando le città americane e soprattutto New
York. Qui l’attuazione del masterplan per il parco
sopraelevato sulla High Line, costato circa 65 milioni di dollari, ha trasformato uno spazio dismesso in
spazio verde, attirando, con enorme successo, oltre
20.000 visitatori al giorno. A sua volta il progetto di
ristrutturazione del Lincoln Center for the Performing Art, di cui la parte maggiore consiste nel recupero e ampliamento della Jullian School, in collaborazione con FxFowle Architects, inaugurato a
febbraio del 2009, si è rivelato un interessante intervento di riconfigurazione di una architettura che era
ritenuta ostile alla città.
Lo studio Diller Scofidio + Renfro Architects è
considerato attualmente tra i più innovativi di New
York sia per la capacità di operare in un ampio ambito, che va dagli edifici ai masterplan urbani, dalle
installazioni e performance, al teatro multimediale,
dai media elettronici alle pubblicazioni, sia per l'intento dichiarato di voler realizzare un’architettura
democratica e rispettosa delle proprie radici, capace
di modificare non solo gli edifici ma l’anima stessa
della città e di disegnare il nuovo aspetto dell’America.
La filosofia progettuale alla base dei lavori degli
architetti dello studio ha come obiettivo principale
dunque la trasformazione del’'identità dei luoghi
d’intervento, o, più precisamente come dice la stessa
Diller, si propone “di far riemergere ciò che è stato
rimosso nei decenni scorsi”.
Nel caso dell’Institute of Contemporary Art di
Boston (ICA), edificato nel 2006, la nuova struttura,
modificando fortemente l’immagine degradata del
settore meridionale del porto di Boston, crea un importante punto aggregazione dell’intera città.
Il nuovo ICA, protendendosi a sbalzo sulla baia,
realizza infatti 6 mila metri quadrati di spazi espositivi, per spettacoli pubblici, per attività culturali e
per accessi al lungomare della baia di Boston, in
perfetta sintonia con l’esposizione di opere d’arte
contemporanea e in stretta relazione con il paesaggio
e con l'acqua.
L’ICA é descritto dai progettisti come una macchina che raccoglie vedute del mondo esterno e che,
incorniciandole in forme diverse, le trasforma in
arte. Combinando l’architettura con elementi di altre
arti visuali, l’istituto museale si pone il duplice obiettivo di creare uno spazio contemplativo in cui
confrontarsi con l’arte contemporanea, ma anche, di
svolgere la funzione di edificio pubblico con un forte ruolo sociale. Nella relazione di progetto Elisabeth Diller, polacca di origine e docente alla Princeton University, una dei tre componenti con Ricardo
Scofidio e Charles Renfro dello studio Diller Scofidio + Renfro Architects spiega che l’edificio “pubblico è sviluppato dalla terra; l’edificio intimo, dal
cielo in giù”. Qui infatti sono collocati gli spazi espositivi, formati da gallerie modulabili e flessibili,
con pareti vetrate, illuminate da lucernari adattabili
ed espansibili che permettono alla luce naturale di
giungere filtrata dappertutto.
La ‘lunga galleria’, essa stessa spettacolare spazio espositivo, è un lungo corridoio sospeso che
pende dal soffitto delle gallerie e che termina sul
lato nord con un muro di vetro formato da lenti verticali microscopiche riflettenti diverse visioni
dell’Oceano Pacifico, secondo il punto di vista perpendicolarmente frontale o da un angolo.
Uno sfondo vetrato sull’acqua fa da fondale al
palcoscenico del teatro-mediateca di 325 posti, circondato da muri di vetro che possono essere parzialmente o totalmente oscurati. La struttura all’esterno è completamente ripartita da fasce verticali
in cui si alternano vetro trasparente, vetro traslucido
e metallo, quasi a voler formare una pelle continua
che annulli le distinzioni tra muri, porte e finestre.
Nel masterplan per il parco sopraelevato sulla
High Line, a New York, che trasforma la linea ferroviaria sopraelevata sul West Village, a Manhattan,
in passeggiata urbana, lo spirito ecologista e il riuso
delle infrastrutture generano un design urbano alternativo, dove non è il verde ad essere utilizzato per
nascondere una speculazione costruttiva ma è l’architettura a trasformarsi in struttura visibile, quale
dichiarato supporto innaturale per il verde.
33
Partendo dallo stato d’abbandono della zona gli
architetti realizzano quasi due chilometri e mezzo di
parco pensile che, seguendo l’Hudson e perimetrando un intero quartiere, collega il centro di Manhattan al Meanparking Districe. L’operazione è il risultato dell’unione tra architettura e agricoltura, in cui
la natura, servendosi dell’infrastruttura urbana, trasforma i binari ferroviari dismessi in una rotaia vegetale, utilizza gli spazi sottostanti in spazi urbani, e
modifica le regole e le proporzioni tra l’uomo e la
natura, tra il pedone e le piante. Si concretizza così
uno spazio, originato dalla spontaneità e dal caso, in
cui è possibile la contemporanea coesistenza di una
natura selvatica e di un giardino coltivato, la riservatezza dello spazio privato e la socialità del luogo
pubblico. Lungo la strada numerose e differenti aree
di sosta per i pedoni mostrano l’alternanza di essenze vegetali e superfici pavimentate formate da moduli longitudinali in calcestruzzo, appositamente
disegnate per permettere al verde di infiltrarsi, mentre le sedute poggiano su ruote poste sulla vecchia
strada e le zone più boscose sono state pavimentate
in legno.
Lo studio è stato anche incaricato della ristrutturazione del Lincoln Center for the Performing Art,
tra i più importanti centri culturali al mondo, sede di
importantissime istituzioni quali il Metropolitan Opera, la New York Philharmonic, la School of American Ballet, tutte collocate fra la 65th Street e la
Broadway. Il centro culturale voluto nel 1962 da
John Rockefeller III fu progettato dai maggiori architetti del tempo, Marcel Breuer, Alvar Aalto, Philip Johnson, Eero Saarinen e gli architetti del DS+R
per niente intimiditi dal complesso, ma anzi giudicandolo la parte peggiore di una certa architettura
degli anni ‘50 e ‘60, si sono proposti di cambiare
“da cima a fondo le forme e i contenuti del Lincoln
Center”, giungendo addirittura a dire, secondo le
dichiarazioni della Diller, che “più che un edificio è
l'anima di New York che stiamo cambiando”. Giudicandola l’architettura del Lincoln una architettura
elitaria, lo studio Diller Scofidio + Renfro interviene
quindi con una ristrutturazione radicale, ritenendo
giunto “il tempo di riaprire alla strada e alla gente
sia l’arte che l'architettura” al fine di offrire anche
“un contributo all’apertura democratica della società... Noi decostruiamo a pezzi il Lincoln per rimontarlo in forme più felici e divertenti. L’anima di New
York aveva un urgente bisogno di una profonda analisi per riportare in luce ciò che è stato rimosso”.
La Juilliard School rientra invece in un più ampio progetto che comprende la riprogettazione
dell’Alice Tully Hall, la ristrutturazione dell’ingresso del New York State Theater e la progettazione
di alcuni spazi pubblici e del Hypar Pavillion
Restaurant. Gli architetti intervengono modernizzando gli spazi esistenti della Juilliard School, or-
mai insufficienti, costruendo nuove strutture, visibilmente e volutamente estranee al preesistente, ma,
soprattutto, dando una nuova identità alla scuola.
Elizabeth Diller illustrando il piano di sostituzione dei muri bianchi con il vetro lo ha definito
come uno “spogliarello architettonico” ed ha aggiunto che gli interventi soddisfano le “potenzialità
non realizzate del centro”, dal momento che la scuola è stata trasformata e aperta alla città e tutte le attività didattiche e le sale prove sono visibili dai passanti. Lo spazio aggiuntivo non è stato posto, per
ragioni strutturali, sopra l’edificio, ma è diventato un
volume di tre piani a sbalzo sulla piazza lungo Broadway creando al di sotto una serie di spazi pubblici.
Se si pensa che il Lincon Center ha rappresentato per i suoi fondatori il luogo dove riunire tutte le
forme artistiche della società, e, se come scrive Fuksas, “La New York Philharmonic, la Metropolitan
Opera o l’American Ballet sono state viste e appartengono a quando il sogno americano riusciva a interpretare anche cultura e arte”, il progetto di Diller
e Scofidio, pur con qualche perplessità, può essere
letto come il tentativo di voler continuare a concentrare nella città i momenti migliori dell’arte e
dell’espressione umana, con l’obiettivo ulteriore di
catturare una generazione di clienti che hanno largamente ignorato queste istituzioni perché ritenute
troppo elitarie.
In questo punto di vista, i nuovi progetti possono
quindi considerarsi “risposte indirette ai massicci
spostamenti demografici, prima al centro, e poi a
Brooklyn, che hanno modificato la mappa culturale
della città” e, diremmo, la mappa sociale di New
York.
34
CATALIZZATORI SOCIALI E URBANI: UN NUOVO CONCETTO DI STAZIONE FERROVIARIA.
Nello Luca Magliulo
Quando nel 1839 venne inaugurato il primo tratto
ferroviario della penisola italiana, che univa Portici
e Napoli con circa sette chilometri di binari, erano
passati solo quattordici anni dall’inaugurazione della
Stockton and Darlington Railway1 e poco più dall’invenzione della locomotiva a vapore. In quel
momento i treni erano considerati sistemi di trasporto per le merci e solo più tardi, durante il ‘900, si
trasformeranno in un mezzo di trasporto pubblico.
Le stesse stazioni ferroviarie, vista la grande utilità, erano collocate sempre in luoghi strategici per i
collegamenti commerciali, ovvero all’interno della
città e vicine agli altri luoghi di commercio. In altri
casi sarà proprio intorno ad esse che la città si “allargherà” nel tempo. E’ ovvio che la presenza di un
sistema di collegamento così forte sia un elemento
importantissimo all’interno dell’impianto urbano,
ma è anche vero che visivamente, nell’immaginario
collettivo, il quartiere che si sviluppa attorno ad una
stazione ferroviaria è sempre stato visto come un
luogo di basso livello sociale e le stesse stazioni
come posti poco sicuri. Tutto questo a causa della
“monofunzionalità” di queste strutture che esaurivano la loro utilità nel semplice ruolo di luogo di partenza o di arrivo. Ancora oggi, leggendo il “Regolamento Circolazione Treni”, delle Ferrovie dello
Stato italiane, il termine “stazione” è così definito al
punto 4: “Diconsi stazioni le località di servizio
normalmente delimitate da segnali di protezione,
utilizzate per regolare la circolazione treni, munite
di impianti atti ad effettuarvi le precedenze fra treni
nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci
fra treni in senso opposto”. Leggendo la stessa definizione all’interno del vocabolario Treccani: “Fermata, sosta in un luogo, o, con significato più ampio, cessazione di un movimento. In partic.: a. Fermata, stazionamento di veicoli, nel corso di uno
stesso viaggio o nell’intervallo fra un viaggio e
quello successivo”. E’ evidente quindi come oggi,
guardando in cosa si stanno trasformando le stazioni
ferroviarie, ci si rende conto che andrebbe riformulata la definizione delle stesse.
Da un punto di vista architettonico il loro ‘stile
stazioni’ non è cambiato molto nei decenni. Solo sul
finire dell’800, le stazioni più importanti furono caratterizzate da uno studio e da una valenza architettonica che ancora oggi è visibile e riconoscibile
1
Il primo tratto di ferrovia pubblica nel mondo fu il Stockton
and Darlington Railway inaugurato in Inghilterra nel 1825, dove per la prima volta si presentò l’invenzione della locomotiva a
vapore.
dall’uso di una forte simmetria, dalla presenza di colonne di ghisa e da coperture di ferro e vetro caratteristiche di una forte monumentalità. Nel corso degli
anni, sia da un punto di vista stilistico che concettuale, l’idea di stazione ferroviaria è stata superata oltremodo perché è stato intuito il loro grande potenziale di essere, non solo di luogo di “collegamento”
o di “sosta”, ma anche di “catalizzatore” urbano e
sociale delle città stesse. Oggi i “terminal” ferroviari
sono considerati come delle sorte di portali di ingresso alla città e hanno perso il loro ruolo unico di
luogo dei trasporti diventando dei veri e propri spazi
di vita sociale.
Nel 1991 è partito in Italia il progetto della TAV
(treni ad lata velocità) con l’obiettivo di realizzare
stazioni che potessero accogliere la nuova linea ferroviaria nelle maggiori città quali Napoli, Roma,
Bologna, Firenze e Torino. Si è trattato di un’occasione importantissima per il rinnovo dei trasporti su
strada ferrata della penisola. Per questo motivo sono
stati banditi una serie di concorsi internazionali che
hanno dato la possibilità ad architetti di fama mondiale di poter intervenire. In tutti i bandi di concorso
le richieste sono state più o meno comuni, partendo
dal concetto di riqualificazione o risistemazione urbana e dall’idea di realizzare nuove strutture che potessero essere in grado di rispecchiare le attuali esigenze in termini di “terminal” ferroviario.
E’ il caso della stazione di collegamento della
TAV di Napoli collocata ad Afragola. Il concorso,
vinto dall’architetto Zaha Hadid, è un’occasione per
la riqualificazione e la valorizzazione di una grande
zona di espansione del napoletano. Infatti, l’intervento si colloca al centro di un nuovo parco naturalistico ed è concepito come una sorta di passerella
che collegherà le due aree del parco dove sorgeranno laboratori e centri di sperimentazione agricola.
La stessa stazione, concepita come una galleria di
vetro con struttura completamente metallica e vetrate a filo, ospiterà gli accessi ai treni al piano terra,
mentre al piano superiore sarà realizzato un centro
commerciale contenete diversi servizi. Agli estremi
(ad est e ad ovest della passerella) sono stati collocati i due accessi alla struttura, al fine di far confluire
gli utenti che, attraversando l’intera area commerciale, si convoglieranno nel nodo centrale, ovvero nella
sala passeggeri. Quest’ultima è stata concepita come
un grande atrio, che trova una connessione visiva
con il contesto circostante (il parco) attraverso un
sistema di ampie vetrate. Uno degli elementi che
maggiormente segnalano questo nuovo modo di
35
concepire la stazione ferroviaria è rappresentato
proprio dalla presenza dei servizi (negozi, bar, luoghi di divertimento) che fanno comprendere come
tali luoghi siano anche occasioni di svago, e non solo per viaggiatori, grazie anche al rapporto che la
stazione stessa instaura con il territorio circostante.
Questo oggetto architettonico non è trattato singolarmente e fine a se stesso ma fa parte di una sistemazione territoriale più ampia.
Nel caso del progetto della stazione Tiburtina di
Roma, il tema della ricucitura urbana è molto forte.
Il bando proponeva la progettazione di un elemento
che fosse in grado di ricucire una spaccatura urbana
creatasi tra i due quartieri di Nomentano e Pietralata,
separati proprio dal passaggio della rete ferroviaria.
Inoltre si richiedeva la realizzazione di un sistema
che oltre alla funzione di scambio e di trasporto potesse ospitare funzioni commerciali, direzionali, ricettive e culturali, per un totale di 48.000 metri quadrati. In poche parole si chiedeva di dar vita ad una
nuova “centralità” urbana. Il progetto vincitore, di
Paolo Desideri, risolve queste richieste attraverso un
grande contenitore che passa al di sopra dei binari e
che ospita al suo interno dei grandi volumi sospesi e
trasparenti che conterranno al loro interno un grande
numero di servizi. Il nuovo impianto mette in evidenza il tema di una forte assialità tra i due quartieri
esistenti risolvendo il collegamento fra questi ultimi
attraverso un ponte che li riconnette. Gli stessi sistemi di piazze discendenti in prossimità dei due
quartieri sono dei veri e propri portali verso la città,
donando ad essa, in un punto sprovvisto, una serie di
servizi inseriti nella maglia urbana.
Stesso scopo di riqualificazione è stato perseguito
con il progetto per la nuova stazione di Porta Susa a
Torino. Il concorso, vinto dal gruppo francese AREP con gli architetti Jean-Marie Duthilleul ed Etienne Tricaud, metteva in evidenza la necessità di
intervenire all’interno del centro storico della città
attraverso un’operazione delicata di ricucitura e riqualificazione e che allo stesso tempo potesse diventare un’icona del “viaggio”. Il progetto vincitore
propone un nuovo edificio – simbolo dell’idea del
movimento, del “viaggio”, quasi ad attestare con
forza e vigore la presenza del sistema ferroviario
all’interno della città storica. Una galleria di acciaio
e vetro lunga circa 385 metri che si conclude in una
grande torre che le fa da quinta urbana. L’intera galleria asseconda l’andamento in quota del terreno attraverso una serie di aperture per l’accesso degli utenti dalla strada. Elemento portante del progetto è
la luce che, attraversando le grandi vetrate, sottolinea la continuità con la città stessa attraverso la trasparenza. Poiché l’intero elemento segue gli assi
viari preesistenti esso si innesta di fatto all’interno
della maglia urbana storica diventando un attraversamento fruito non solo dai “viaggiatori” ma anche
da tutti gli altri cittadini. Come si può comprendere,
si tratta di interventi che mirano ad una plurifunzionalità della stazione stessa, che non può essere più
intesa solo come il luogo di arrivo e di partenza dei
treni, ma che assume un ruolo urbano, architettonico
e sociale all’interno del contesto della città.
Su questa stessa linea si muove anche il progetto
di Arata Isozaki per la nuova stazione dell’alta velocità di Bologna. Anche in questo caso il progetto si
propone come obiettivo quello di ricostituire la rottura della maglia urbana generata dai binari. L’intero
oggetto architettonico è un enorme parallelepipedo
bianco che gira intorno a tre elementi fondamentali:
una piastra, un tubo ed un’isola. La piastra è il ponte
di passaggio centrale, organizzata su due livelli, la
cui complessità di vuoti e pieni, che giunge fino in
copertura, vuole richiamare la complessità del centro
storico bolognese. I vuoti in copertura scendono attraversando i due livelli e portando la luce
all’interno della stazione. Il tubo è l’elemento di collegamento tra la piastra e l’isola ed è una sorta di
ponte intermodale che, attraverso una serie di scale e
percorsi mobili, permette l’attraversamento di tutta
la parte commerciale interna. L’isola, infine, è
l’edificio collocato in prossimità della nuova sede
comunale, ed è il cuore energetico di tutta la stazione in quanto ospiterà la centrale termica che produrrà energia pulita per alimentare l’intera struttura. Si
tratta di un intervento che riesce a coprire molti aspetti differenti in quanto è allo stesso tempo un “catalizzatore” sociale ed urbano, un sistema energetico
a zero impatto ambientale oltre ad un perfetto inserimento nel contesto circostante.
A Reggio Emilia non è stato da meno Santiago
Calatrava con il progetto di risistemazione urbanistica comprendente anche il progetto della stazione
TAV. La sua proposta verrà realizzata in un’area
dove sono già presenti molti attrattori urbani come
l’Ente Fiera, lo stadio e il più grande distretto produttivo della città. Si tratta di un intervento che ben
si inserisce nel territorio frammentato di Mancasale.
La stazione presentata da Santiago Calatrava, come
un sistema in forte movimento, è caratterizzata da
una ossatura bianca che porta la struttura all’esterno
rendendola leggibile. Il progetto si sviluppa attraverso la ripetizione di un modulo di lunghezza pari a
25,40 metri che, in successione, genera tredici portali in acciaio differenti. Il ripetersi di questo sistema
per tutta la struttura sviluppa un impianto di circa
480 metri che, letto a distanza, da l’idea di una successione di onde in movimento per richiamare l’idea
del moto. Il sistema di copertura, solo sopra le banchine ed i treni, diventa un elemento vetrato per
permettere alla luce di entrare ed è sorretto da una
struttura mista in acciaio-calcestruzzo con una trave
a “cassoncino” longitudinale che trova appoggio ogni 25 m su due supporti in calcestruzzo. Al di sotto
36
del livello delle banchine sono collocati i locali della
stazione vera e propria, un unico contenitore che
racchiude i vari servizi previsti: la stazione per
l’utenza con le tutte le attività commerciali, il sistema di interscambio con la linea regionale e una vasta
area adibita a magazzini, depositi e servizi vari. La
pianta dell’intero complesso si sviluppa, quindi,
lungo il tracciato dei binari su due livelli differenti:
il primo livello è all’altezza delle banchine, ossia
all’altezza del piano di percorrenza dei treni; il livello inferiore è quello di accesso alla stazione e che
rappresenta il cuore pulsante di tutto l’impianto. La
differenza di quota fra i due livelli viene risolta mediante l’uso di scale e gruppi meccanizzati che trovano posto lungo i corridoi laterali, compresi tra il
viadotto dei treni e la parte inferiore della copertura,
con quattro scale mobili per lato e due ascensori panoramici predisposti nel punto centrale della stazione. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad
una necessità di ricucitura urbana e fusione fra strutture preesistenti, anche se in un contesto molto più
libero rispetto a quello storico di Bologna.
Diversa è la situazione della stazione di Firenze
progettata da Norman Foster in collaborazione con
la società di ingegneria Arup. Anche in questo caso,
tutto il progetto gira intorno al modo in cui la luce
attraversa la copertura in vetro per illuminare tutto
l’interno della stazione fino ad arrivare ai binari.
L’impianto si presenta con una forma semplice che
però diventa complessa nella sua strutturazione: una
copertura di vetro a forma di vela che non è trattata
come un elemento unico ma formata da tanti pezzi
come un puzzle dove ogni singolo elemento è, a sua
volta, una piccola vela al vento. Il tutto sorretto da
strutture leggere in acciaio e un box sotterraneo che
accoglierà la fermata dei treni. L’intera stazione si
sviluppa quindi su tre livelli: il primo piano a quota
dei binari, il secondo per tutti i servizi e le numerose
attrezzature commerciali ed il terzo per la terrazza,
dalla quale sarà possibile veder arrivare e partire i
treni. A Firenze, questa stazione sarà la prima realizzata dopo ottanta anni dalla vecchia stazione di
Santa Maria Novella, progettata dal Michelucci.
Appare chiaro come questi interventi rappresentino un nuovo modo di pensare i terminal ferroviari
ma essi sono anche frutto di una nuova immagine
della società moderna che, in un’ottica di globalizzazione, si riconosce sempre più nel collettivo e
sempre meno nel singolo, in continua ricerca di attrazioni e spettacolarizzazioni. Di conseguenza, non
solo le stazioni ferroviarie, ma molte architetture attuali hanno sempre maggiormente un ruolo di coinvolgimento della collettività molto più profonda di
quella del passato con il compito di ricreare spazi e
luoghi che siano in grado di ampliare la possibilità
di socializzare e che possano, ove possibile, recuperare quelle situazioni urbane che per anni si sono identificate con un’immagine di negatività.
37
TRA DECOSTRUZIONE E MEDITERRANEITÀ.
UNA CASA A PATIO A CONDOFURI MARINA (RC)
Claudio Roseti
Questo breve saggio riguarda la casa realizzata a
Condofuri (RC) da Giovanni Laganà e costituisce di
fatto il prosieguo della presentazione che, congiuntamente a quella del libro Asfalti dello stesso G. Laganà, il 27/6/2007 ha dato luogo a uno degli “Incontri in Biblioteca”, presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, organizzati dallo scrivente, Direttore della
Biblioteca stessa, e dal Presidente della Commissione Cultura Prof. Franco Zagari.
L’invenzione architettonica che avvalora questo
edificio, una casa unifamiliare a patio di dimensioni
contenute, consiste nell’utilizzazione “trasgressiva”
di una componente che, di fatto, esiste nell’architettura storica ma con tutt’altro ruolo1 .
Il progettista ha infatti composto le facciate principali della casa incrementando le finestre reali, necessarie all’illuminazione e l’aerazione e commisurate agli ambienti in cui si aprono, con una serie di
finestre “in falso”, riquadri ciechi di dimensioni, in
linea di massima, uguali alle varie aperture (che in
totale vengono pressoché raddoppiate) a formare
una composizione variegata e complessa dove il
gioco mutevole delle ombre assume trame e spartiti
di apprezzabile qualità architettonica.
Prima di valutare gli aspetti specificamente compositivi e plastici dell’insieme vorrei fare delle considerazioni sugli aspetti concettuali che collocano
tale progetto nell’ambito della decostruzione derridiana2 in ordine ad una lettura e una valutazione personale degli esiti progettuali rileggibili in chiave decostruzionista.
In questo edificio di linguaggio moderno, dove è
tuttavia riconoscibile il modulo storico della facciata, il gioco complesso delle bucature e degli scavi
decostruisce la tripartizione classica basamento/corpo/coronamento destabilizzando al tempo stesso la composizione specifica del fronte; questo assume un aspetto astratto di vago sapore neoplastico
il cui agente si basa, in prima istanza, sulla defun1
Le finestre cieche erano usate per regolarizzare i prospetti , ma se ne trovano anche di recente, vedi il fronte
della postmoderna Fiera di Francoforte progettata a metà
degli anni ’80 da Osvald Mathias Ungers.
2
Sia pure non programmatica: giacché “la decostruzione
ha luogo, è un evento che non aspetta la deliberazione, la
coscienza o l’organizzazione del soggetto, né della modernità. Si decostruisce” Derrida J. in Roseti C., La decostruzione e il decostruttivismo. Pensiero e forma
dell’architettura, Roma, Gangemi, 1997, cap. 1, par. 1 p.
19.
zionalizzazione delle finestre (che corrisponde in tal
modo al dettato delle famose invarianti derridiane3)
il cui ruolo diviene principalmente formale secondo
un obiettivo puramente architettonico che riporta
quindi, ancora una volta, all’obiettivo derridiano di
una “architettura come tale”, della ricerca dell’essenza dell’architettura.
In tale operazione si può riscontrare un parallelo
con Peter Eisenman, il maggiore architetto della decostruzione che, nella desemantizzazione dei pilastri
esuberanti delle prime Houses autodestituentisi dal
ruolo e dalle significazioni funzionali e strutturali, a
fronte dell’impoverimento semantico a livello percettivo superficiale, acquisiscono una ridondanza
sintattica propria del livello concettuale profondo.
L’analogia con l’operazione svolta da G. Laganà
appare evidente: la riconoscibilità, non sempre palese, delle finestre e delle pseudofinestre, ne revoca in
dubbio l’effettivo ruolo, per cui ne risulta una desemantizzazione, ovvero una perdita di significanza
con una caduta del livello percettivo semantico a favore della ridondanza sintattica in tal modo acquisita, il cui livello concettuale profondo costituisce la
principale qualità architettonica dell’edificio.
Delle diciassette aperture (totali o parziali) del
fronte principale otto sono vere (sette finestre e una
porta) altre nove sono scavi di identica dimensione e
di profondità variabile per i quali si deve rilevare
anche l’inversione, operazione frequente nella decostruzione, del relativo ruolo plastico; infatti il famoso corbuseriano “gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce” qui avviene all’inverso, non vi sono volumi, vi sono dei vuoti e dei semivuoti, ma il grado
di luci ed ombre continuamente variato non è per
questo meno apprezzabile rivestendosi anzi di una
notevole originalità, dove il “bassorilievo”, decorazione tipica dell’architettura classica, diviene invece
strumento d’espressione di un’architettura genuinamente contemporanea, mediterranea o internazionale
che sia.
La profondità degli scavi nella parete prodotti dalle finestre fittizie variano da nove a quindici centimetri, con differenze assolutamente non trascurabili
perché, al variare della luce e delle sue angolazioni,
l’allungamento o la contrazione dell’ombra diventa
notevole creando effetti diversi che rendono il fronte
sempre mutante nelle molteplici e continue vibrazioni chiaroscurali.
Piante, prospetto e sezioni
3
Roseti C., op.cit., cap. 2, par. 3, p. 43.
38
E qui si ritrova la fondamentale tematica decostruzionista della dialettica presenza/assenza cui Derrida
contrappone, al rapporto assolutistico ed esclusivista
delle opposizioni dialettiche quello della differenza e
della traccia, quale rapporto ibridato e variabile dove la differenza è nell’alternanza pieno/vuoto in cui
la presenza è data dalla semplice finestra forata e
con infissi mentre le sue tracce murate derivano
dall’assenza dell’infisso sostituito dal semplice tamponamento su cui la traccia delle bucature (variabile
in profondità) qualifica il testo architettonico complessivo.
Analizzando da vicino la geometria che regola la
composizione si può osservare come il progettista
mantenga il controllo dell’assai variata e un po’ spericolata ridondanza contenendo entro il numero di
sei le giaciture orizzontali dei riquadri sia forati che
scavati, mentre raggiungono il totale di undici gli
sfalsamenti verticali, secondo una composizione libera ma che, dovendo tenere conto degli aspetti funzionali ed utilitari per quel che riguarda le finestre
vere, punta sul sistema degli scavi per controllare la
morfologia complessiva risultante.
Un attento equilibrio ponderale è poi ricavato entro il rapporto vuoto/pieno già a partire dalla facciata
complessiva che è stata alleggerita di un piano per
un quarto della superficie del fronte che fa posto ad
una terrazza aprendo l’edificio verso la strada.
La terrazza comunica col patio che caratterizza tipologicamente l’alloggio il quale poi si conclude
con un ulteriore vuoto verso l’interno. Niente da dire
sulla facciata laterale che prosegue con gli stessi
principi accrescendo ulteriormente il gioco complessivo di luci ed ombre.
Il tutto entro una tonalità che, per avere saputo ottenere apprezzabili risultati agendo con sobrietà e
discrezione su pochi elementi, si può definire certamente minimalista ma, al tempo stesso, per il genere
di materiali e l’assetto complessivo, quest’architettura non può collocarsi entro il less is more
miesiano e nemmeno ascriversi al contemporaneo
neominimalismo (v. l’architettura giapponese), e
può forse quindi trovare una sua definizione nella
più lata e plurivoca mediterraneità che gli è già stata
attribuita in altre sedi critiche. Fermo restando naturalmente la lettura decostruzionista che permane tale
secondo il principio enunciato nella nota 2.
Scorcio del fronte strada; in primo piano il
vuoto della loggia.
portunità di ridefinire il proprio statuto, ripensando la
questione dei bisogni dell’essere umano, e ripensando
la stessa bellezza come un peculiare bisogno.
Jean Luc Nancy
Le Muse
Diabasis 2006
Nancy mostra in questo libro come l’arte apra
all’infinito il mondo della significazione: colore, ritmo,
profumo, pesantezza, profondità, spessore... Per
liberare questa molteplicità nell’unità egli sostiene che
occorre saper mettere fine a una certa idea di arte
romantica con la maiuscola. Ci sono le arti e, con esse,
i sensi (un tema classico di Nancy), il senso dei sensi, e
la tecnica, di cui l’arte non è che la traduzione. Questo
e gli altri temi (la nascita hegeliana delle arti – Nancy
passa in rassegna l’estetica in Kant, Schelling ed Hegel
fino a Wittgenstein e Deleuze – l’idea di soglia, la
pittura primitiva, le vestigia dell’arte e la lotta fra arti,
l’opera d’arte come dono) concorrono ad affermare che
è proprio con le arti che il senso del mondo e la nostra
idea di esso sono rimessi in gioco.
Ludwig Mies van der Rohe
Gli scritti e le parole
A cura di V. Pizzigone, Einaudi 2010
Gli scritti di Ludwig Mies van der Rohe sono apparsi
fin dal 1947 in antologie critiche, ma questa raccolta
riporta la totalità pressoché esaustiva dei suoi scritti e
dei suoi interventi, quale finora non era mai stata
pubblicata né in Italia né all'estero. La sproporzione fra
i pochi scritti di Mies e i molti studi di cui sono stati
oggetto conferma che il suo noto aforisma “less is
more” non vale solo per le sue architetture. Celebre per
la bellezza dei suoi edifici con struttura a telaio, per la
monumentalità delle sale prive di sostegni interni e per
l’eleganza degli arredi, la personalità di Mies emerge
da questa raccolta attraverso la forza e la chiarezza
comunicativa delle sue parole. A fianco di testi già noti,
questo volume propone un gran numero di scritti inediti
o mai tradotti in italiano che mostrano in una nuova
complessità l'insieme della sua produzione teorica.
Ettore Rocca
Estetica e architettura
Il Mulino 2008
Da Kant a Derrida, da Schopenhauer a Heidegger, da
Nietzsche a Ricoeur e a Vattimo, il volume presenta
una serie di testi fondamentali per comprendere il
rapporto tra l’estetica moderna e l’architettura. Nel
percorso che l’architettura ha compiuto dalla nascita
dell’estetica nel Settecento fino ai giorni nostri emerge
come essa, inizialmente esclusa dalle “belle arti”, e
considerata gradino più basso tra le arti nella prima
metà dell'Ottocento, assuma nel Novecento una nuova
centralità per la riflessione estetica. Se da un lato
l’architettura rischia così di diventare l’arte suprema
dell’estetizzazione della quotidianità, e l’architetto
l’erede della volgarizzazione del mito moderno del
genio, dall’altro essa offre oggi all’estetica l’op-
Alfonso Gatto
Scritti di architettura
A cura di G. Lupo con un saggio di O. Scelza, Aragno
2010
Gran parte degli interessi architettonici di Alfonso
Gatto matura a Milano, nella prima metà degli anni
Trenta, a contatto con Edoardo Persico e gli altri
intellettuali radunati intorno alla rivista «Casabella».
Oltre la metà dei quarantuno capitoli di cui si compone
questo libro, viene pubblicata sul mensile milanese,
all’interno della rubrica “Cronaca dell’architettura”, tra
il gennaio del 1936 e il novembre del 1937. Tutti gli
altri contributi escono su quotidiani, riviste o
pubblicazioni monografiche e coprono un arco
cronologico di quattro decenni, dal 1935 al 1976.
Attraverso questi scritti, che svariano dalla “città
radiosa” di Le Corbusier alla Usonia democratica di
Frank Lloyd Wright, dal concetto di architettura
integrata di Walter Gropius ai principi
principi di razionalità di
Giuseppe Pagano Pogatshing ed Ernesto N. Rogers,
Gatto non solo partecipa alle polemiche tra stile
funzionale e stile mediterraneo, mostrando peraltro una
straordinaria competenza in materia di urbanistica, ma
giunge ad affermare con fondatezza metodologica quei
legami ideali fra letteratura e utopia, che ispirano tutta
la sua produzione poetica, a proposito della quale
Oreste Macrì avrebbe usato la formula di «ermetismo
attecchito nel paese di Campanella».