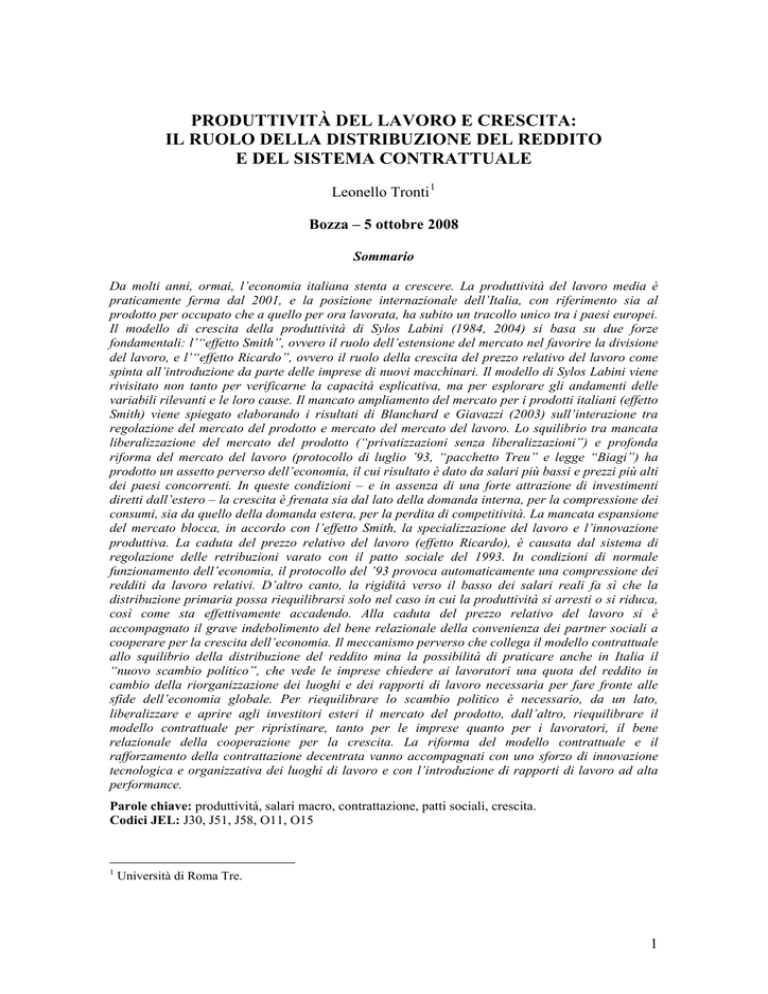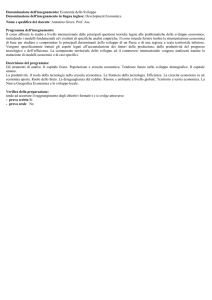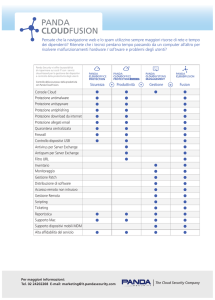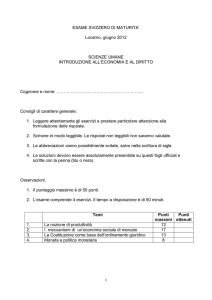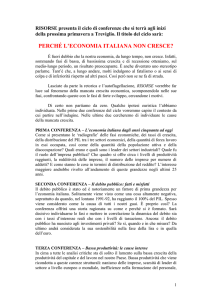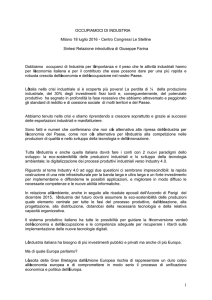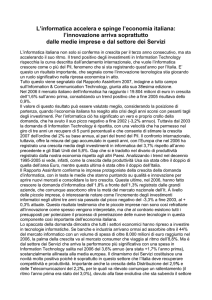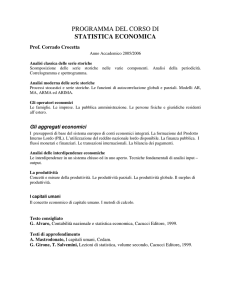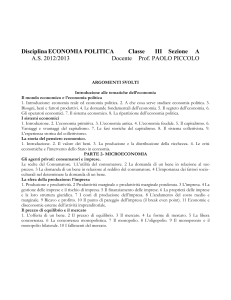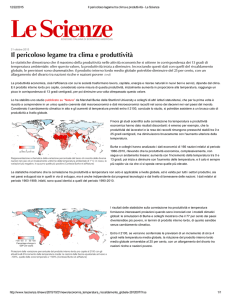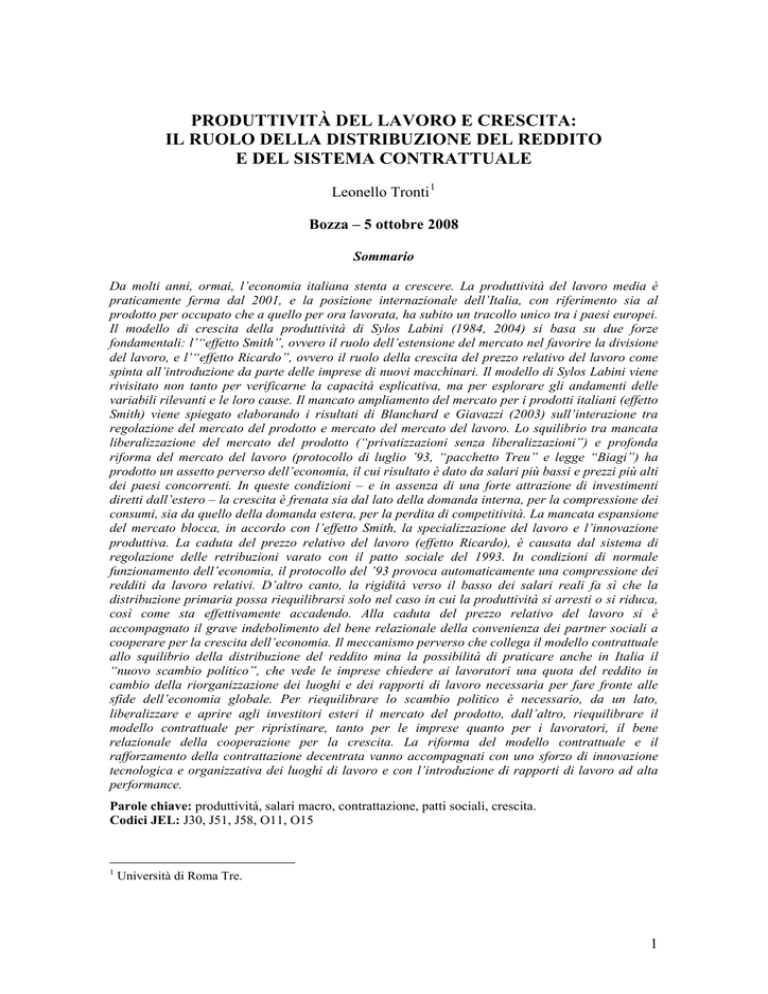
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E CRESCITA:
IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO
E DEL SISTEMA CONTRATTUALE
Leonello Tronti 1
Bozza – 5 ottobre 2008
Sommario
Da molti anni, ormai, l’economia italiana stenta a crescere. La produttività del lavoro media è
praticamente ferma dal 2001, e la posizione internazionale dell’Italia, con riferimento sia al
prodotto per occupato che a quello per ora lavorata, ha subito un tracollo unico tra i paesi europei.
Il modello di crescita della produttività di Sylos Labini (1984, 2004) si basa su due forze
fondamentali: l’“effetto Smith”, ovvero il ruolo dell’estensione del mercato nel favorire la divisione
del lavoro, e l’“effetto Ricardo”, ovvero il ruolo della crescita del prezzo relativo del lavoro come
spinta all’introduzione da parte delle imprese di nuovi macchinari. Il modello di Sylos Labini viene
rivisitato non tanto per verificarne la capacità esplicativa, ma per esplorare gli andamenti delle
variabili rilevanti e le loro cause. Il mancato ampliamento del mercato per i prodotti italiani (effetto
Smith) viene spiegato elaborando i risultati di Blanchard e Giavazzi (2003) sull’interazione tra
regolazione del mercato del prodotto e mercato del mercato del lavoro. Lo squilibrio tra mancata
liberalizzazione del mercato del prodotto (“privatizzazioni senza liberalizzazioni”) e profonda
riforma del mercato del lavoro (protocollo di luglio ’93, “pacchetto Treu” e legge “Biagi”) ha
prodotto un assetto perverso dell’economia, il cui risultato è dato da salari più bassi e prezzi più alti
dei paesi concorrenti. In queste condizioni – e in assenza di una forte attrazione di investimenti
diretti dall’estero – la crescita è frenata sia dal lato della domanda interna, per la compressione dei
consumi, sia da quello della domanda estera, per la perdita di competitività. La mancata espansione
del mercato blocca, in accordo con l’effetto Smith, la specializzazione del lavoro e l’innovazione
produttiva. La caduta del prezzo relativo del lavoro (effetto Ricardo), è causata dal sistema di
regolazione delle retribuzioni varato con il patto sociale del 1993. In condizioni di normale
funzionamento dell’economia, il protocollo del ’93 provoca automaticamente una compressione dei
redditi da lavoro relativi. D’altro canto, la rigidità verso il basso dei salari reali fa sì che la
distribuzione primaria possa riequilibrarsi solo nel caso in cui la produttività si arresti o si riduca,
così come sta effettivamente accadendo. Alla caduta del prezzo relativo del lavoro si è
accompagnato il grave indebolimento del bene relazionale della convenienza dei partner sociali a
cooperare per la crescita dell’economia. Il meccanismo perverso che collega il modello contrattuale
allo squilibrio della distribuzione del reddito mina la possibilità di praticare anche in Italia il
“nuovo scambio politico”, che vede le imprese chiedere ai lavoratori una quota del reddito in
cambio della riorganizzazione dei luoghi e dei rapporti di lavoro necessaria per fare fronte alle
sfide dell’economia globale. Per riequilibrare lo scambio politico è necessario, da un lato,
liberalizzare e aprire agli investitori esteri il mercato del prodotto, dall’altro, riequilibrare il
modello contrattuale per ripristinare, tanto per le imprese quanto per i lavoratori, il bene
relazionale della cooperazione per la crescita. La riforma del modello contrattuale e il
rafforzamento della contrattazione decentrata vanno accompagnati con uno sforzo di innovazione
tecnologica e organizzativa dei luoghi di lavoro e con l’introduzione di rapporti di lavoro ad alta
performance.
Parole chiave: produttività, salari macro, contrattazione, patti sociali, crescita.
Codici JEL: J30, J51, J58, O11, O15
1
Università di Roma Tre.
1
1. La questione: crescita lenta, produttività, impoverimento
Da molti anni, ormai, l’economia italiana stenta a crescere. Dopo il 1995 il tasso di
crescita medio annuo del prodotto lordo italiano è stato dell’1,5 per cento. Si tratta di un
valore modesto, significativamente inferiore a quello dell’Unione Europea a 15 (2,3 per
cento) e a quelli di Francia (2,2 per cento), Regno Unito (2,8 per cento), Stati Uniti (3,2
per cento), Spagna e Grecia (entrambi 3,8 per cento). Se la crescita italiana è stata
superiore a quella giapponese e pari a quella tedesca e svizzera, anche l’aumento
dell’occupazione è stato nettamente maggiore.
Protraendosi nel tempo, le difficoltà di crescita dell’Italia hanno prodotto effetti di
notevole impoverimento relativo. Nel 1995 gli italiani disponevano di un reddito per
abitante al di sopra della media europea, maggiore di quello del Regno Unito e prossimo
a quello di paesi tradizionalmente prosperi come la Francia o la Svezia. Oggi, dopo più
di un decennio di crescita lenta, si trovano otto punti sotto la media europea e 17 punti
sotto il Regno Unito. La cattiva performance italiana (-13,5 punti percentuali rispetto
alla media europea) risalta in modo ancor più netto se si confronta con i molto più
contenuti ridimensionamenti di Germania, Francia e Portogallo, e con i miglioramenti
delle posizioni relative di Regno Unito, Spagna e Grecia (11, 12 e 15 punti
rispettivamente) (figura 1).
Figura 1 - Pil pro capite relativo – Differenze tra 2006 e 1995 (Differenze tra numeri
indice in base media Ue15=100)
50.0
40.4 40.8
40.0
30.0
20.0
16.0
14.7 15.1 15.5
8.3
10.0
8.8
11.7
10.5 10.6 10.8
4.7
0.0
1.5
1.8
2.8
0.0
-0.3 -0.2
-4.2
-7.9
-10.0
-13.5
-2.9
-6.3
-12.1
IE
SI
NO
R
SK
G
HU
K
ES
U
FI
PL
NL
CZ
BG
SE
US
15
DK
BE
EU
PT
AT
FR
JP
DE
IT
CH
-20.0
Fonte: Eurostat.
Poiché nel periodo l’occupazione è cresciuta in misura notevole (del 15,2 per cento,
ovvero di 3,3 milioni di occupati) e più della popolazione, con un significativo aumento
del tasso di occupazione, la ragione del declino relativo dell’economia italiana non può
che essere ascritta alla bassa crescita della produttività. È qui che si è spezzato il circolo
virtuoso alla base del precedente successo italiano. Se dopo la Seconda guerra mondiale
la produttività cresce in Italia sempre un po’ più della media europea, consentendo al
Paese di guadagnare lentamente ma continuamente terreno, migliorando
2
progressivamente il tenore di vita sino a raggiungere livelli paragonabili ai maggiori
paesi europei, intorno alla metà degli anni ’70 la tendenza si arresta. La posizione
italiana cessa di migliorare per poi subire, dagli anni ’90, un arretramento senza
precedenti nella storia repubblicana, unico tra i paesi europei.
In termini di prodotto per occupato, nel 1995 la produttività degli italiani presentava più
di 14 punti percentuali di vantaggio rispetto al valore medio dell’Unione. Oggi quel
vantaggio è perduto. Tengono ancora agganciata l’Italia alla media europea gli orari di
lavoro che, data la bassa diffusione del lavoro a tempo parziale, risultano in media più
lunghi 2 : il valore di quanto produce in un anno un italiano risulta ancora non inferiore al
valore medio dell’Unione soltanto perché gli italiani sono impegnati più spesso con
contratti a tempo pieno 3 . Se, però, consideriamo la produttività oraria (che ovviamente è
un indicatore migliore, perché misura la potenza produttiva del lavoro
indipendentemente dalla sua durata), questa magra consolazione viene meno. Nel 1995
la posizione italiana sopravanza di cinque punti la media europea; nel 2006, dopo un
tracollo di 15 punti (figura 2), non ne supera il 90 per cento. La gravità della caduta
risalta a fronte della sua singolarità: l’Italia si ridimensiona pesantemente, mentre gli
altri grandi paesi europei mantengono o migliorano la loro posizione.
Figura 2 - Pil per ora lavorata relativo – Differenze tra 2006 e 1995 (Differenze tra
numeri indice in base media Ue15=100)
50.0
45.2
40.0
30.0
24.5
18.5
20.0
16.6
10.0
0.7
1.3
1.7
12.9
5.3
4.4
0
10
8.4
7.6
11.2 11.2
2.5
0.0
-2
-2.7 -2.2
-4.2
-1.2
-1
-0.8
-10.0
-14.8
O
IE
N
SK
LT
LU
R
K
K
U
H
G
U
C
L
US
JP
N
SE
FR
E
FI
15
D
EU
PT
AT
E
B
CH
K
D
RO
EU
IT
ES
-20.0
Fonte: Eurostat.
Questa pessima performance si colloca nel quadro dell’urto congiunto di tre grandi
sfide, comuni a tutti i paesi dell’area dell’euro: la diffusione delle nuove tecnologie,
l’affacciarsi ai mercati globali di concorrenti nuovi e agguerriti e, infine, l’adozione
della moneta unica e la fine con essa della possibilità di guadagnare competitività
2
Si vedano Tronti, 2005a; Istat, 2006a.
Bisogna peraltro ricordare che il nostro tasso di occupazione, ovvero la proporzione di persone in età di
lavoro sulla popolazione nella stessa fascia d’età, è ancora significativamente inferiore alla media
europea, e dunque il numero relativamente elevato di ore lavorate l’anno dagli occupati si applica a una
popolazione comparativamente piccola, e non è indice di un impegno lavorativo della popolazione
particolarmente elevato.
3
3
attraverso la svalutazione della moneta nazionale. Tutte e tre le sfide hanno richiesto
alle economie europee – e ancor più all’economia italiana, legata all’esportazione di
beni tradizionali e storicamente caratterizzata da tassi di inflazione più elevati – di
varare riforme strutturali profonde, intelligenti e tempestive. Ma le riforme in Italia sono
state attuate solo parzialmente e con grandi difficoltà, soprattutto sul piano del
consenso. Le misure su cui si è trovato l’accordo non sono state sufficientemente
profonde né coordinate da una visione strategica d’insieme, così che non hanno dato i
frutti sperati 4 . La difficoltà delle misure richieste va compresa anche alla luce delle
grandi trasformazioni che hanno comunque attraversato il sistema economico e il
mercato del lavoro.
Tra queste si segnala il lento e progressivo esaurirsi dell’esodo agricolo e il venir meno
dei benefici effetti di un processo di sostituzione di posti di lavoro nel settore primario,
a bassa produttività, con altri assai più produttivi nell’industria e nei servizi (Istat,
2008a). Poi la cosiddetta “terziarizzazione dell’economia” ovvero l’aumento, assoluto e
relativo, dell’occupazione nei servizi (generalmente a produttività stagnante) a scapito
della manifattura (a produttività crescente) – quest’ultima spiazzata o delocalizzata
verso paesi con costi molto inferiori (la cosiddetta “deindustrializzazione”).
Questi processi di trasformazione strutturale del sistema produttivo si sono intrecciati
con il forte aumento dell’offerta di lavoratori immigrati e con una riforma dei rapporti di
lavoro che ha creato molte posizioni flessibili e temporanee, spesso in occupazioni poco
qualificate, poco remunerate e a bassa produttività. Peraltro, la flessibilizzazione,
quando non la precarizzazione del lavoro si sono addensate al margine
dell’occupazione, sulle leve in ingresso nel mercato, contenendone la remunerazione e
spesso sottovalorizzandone il capitale umano 5 .
Infine, tra le cause delle difficoltà economiche strutturali dell’economia italiana non
vanno dimenticati il peso del debito pubblico, gli squilibri finanziari ereditati dagli anni
’80, aggravati dalla mancata crescita, e il venir meno del ruolo trainante delle imprese
pubbliche nell’area strategica degli investimenti in tecnologia e innovazione. In
particolare, alle varie fasi del processo di privatizzazione e di ridimensionamento del
ruolo economico dello Stato si è accompagnata nelle grandi imprese private una lunga
stagione di “cattivi padroni” e finanzieri d’assalto 6 , più impegnati ad acquisire,
spezzettare e rivendere con grandi plusvalenze le imprese che a innovarle e
riorganizzarle per tenere testa al mercato globale.
Queste grandi trasformazioni, che peraltro hanno interessato in varia misura anche altre
economie avanzate, hanno certamente influito con forza maggiore sui ritardi di
aggiustamento dell’economia italiana al nuovo clima tecnologico e globale. Perché?
Si vedano Gallino (2003, 2006), Sylos Labini (2004), Boeri et al. (2005), Saltari e Travaglini (2006),
Daveri (2006). Per un’acuta analisi teorica dei problemi di riforma del sistema economica, condotta con il
sussidio di un modello teorico di equilibrio generale, rimando a Blanchard e Giavazzi (2003), i cui
risultati vengono discussi più avanti nel par. 4.
5
Si veda, tra i numerosi altri, il ricco e documentato volume a cura di Contini e Trivellato (2006).
6
Si vedano, ad esempio, Mucchetti, 2003; Gallino, 2005.
4
4
2. Il modello di Sylos Labini
Per analizzare le cause della stagnazione e dell’impoverimento relativo dell’economia
italiana, il lavoro adotta come schema interpretativo di base il modello di crescita della
produttività del lavoro proposto da Sylos Labini (1984, 2004). Il paper procede quindi a
una rivisitazione del modello mirata non tanto a verificarne di nuovo la capacità
esplicativa, che viene data per scontata, quanto ad esplorare le cause sottostanti gli
andamenti delle variabili che, in accordo con le linee analitiche proposte dal modello,
bloccano la crescita della produttività in Italia.
Il modello di Sylos Labini si basa essenzialmente su due forze economiche
fondamentali. La prima è quella dell’“effetto Smith”, ovvero della capacità della
dimensione del mercato di sostenere economicamente la divisione e la specializzazione
del lavoro: due processi che ancora oggi possiamo considerare come forma
fondamentale dell’innovazione, sia di processo che di prodotto. Sylos ci ricorda che, per
Smith, l’aumento delle capacità produttive del lavoro dipende dalla divisione del lavoro,
che a sua volta dipende dall’estensione del mercato.
In termini altrettanto semplici, Sylos (2004) nota che le innovazioni si possono dividere
in “grandi invenzioni” (degli scienziati) e “piccole invenzioni” (dei lavoratori e,
aggiungo io, degli imprenditori), e che queste ultime sono endogene e più importanti
delle prime per la crescita economica, in quanto quelle accadono più raramente, e
spesso richiedono un rilevante adattamento dei sistemi produttivi e delle modalità di
consumo; mentre le piccole invenzioni sono più frequenti e non richiedono grandi
adattamenti, ma piccoli aggiustamenti continui, nei sistemi produttivi come nei
consumi.
Questa visione è confermata dalla moderna teoria dell’impresa 7 , che riconosce che
qualunque processo produttivo, oltre al prodotto cui è finalizzato, genera nel suo operare
concreto un complesso di informazioni (spesso microinformazioni) sulla sua stessa
funzionalità, che costituiscono una vera e propria risorsa economica aggiuntiva, ma
possono essere raccolte e utilizzate solo da chi è direttamente implicato in esso. Questa
realtà, ovviamente, è sempre esistita; ma, con l’elevazione dei livelli di conoscenza
della manodopera e con la flessibilità senza precedenti dei sistemi produttivi basati in
misura sostanziale sull’informatica e la telematica, ha assunto rilevanza strategica per
l’innovazione e la competitività dell’impresa. In altri termini, i sistemi produttivi
avanzati offrono più di quelli tradizionali, a chi sa avvalersene, la possibilità di
utilizzare le “piccole innovazioni” per il miglioramento continuo di processi e prodotti.
Ma, come per il passato, la sostenibilità economica della divisione del lavoro alla base
di questi processi dipende dall’estensione del mercato.
La seconda forza trainante la crescita della produttività nel modello di Sylos Labini è
quella dell’“effetto Ricardo”. Questo è basato sul ruolo della crescita del prezzo relativo
del lavoro come fattore di spinta all’introduzione da parte delle imprese di nuovi
macchinari, nuove tecnologie e nuove forme di organizzazione. Per Ricardo, la
produttività cresce come effetto di un risparmio diretto del coefficiente di lavoro, a sua
volta determinato da un aumento del costo relativo del lavoro, ossia da un aumento dei
salari rispetto al prezzo delle macchine. Su questo punto si può dire che Ricardo
7
Ad esempio Roberts, 2004.
5
fornisca un importante approfondimento dell’analisi di Smith sul legame tra alti salari e
prosperità economica: le retribuzioni reali debbono crescere, non solo perché esse sono
il principale sostegno ai consumi delle famiglie, ma perché sono anche il fondamentale
elemento di pungolo alle imprese sul terreno dell’innovazione tecnologica e
organizzativa 8 . Ricardo inaugura così un lungo filone della teoria della crescita
economica che si sviluppa annoverando autori di orientamento diversissimo, che da
Marx, Marhall e Keynes giunge in Italia, ai nostri giorni, sino a Sylos Labini, Tarantelli
e Roncaglia.
Una volta introdotti gli effetti fondamentali, vediamo dunque in concreto il modello di
Sylos.
(1)
& − p& ma )−n + d(ul&c − p& ) + eI&−t .
π& = b{
Y& + c(w
3 {
142
4 43
4 1424
EffettoSmith
EffettoRicardo
QuotaLavoro
Investimenti
La formalizzazione, che ordina le variabili per importanza da sinistra verso destra, pone
la crescita della produttività del lavoro in dipendenza dalla crescita del pil (effetto
Smith), dalla differenza tra la crescita del tasso di salario e quella dei prezzi dei
macchinari (effetto Ricardo), con un lieve ritardo temporale, e da altre due variabili. La
prima è data dalla differenza tra la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto
(ulc) e quella dei prezzi, la seconda evidenzia (con un maggior ritardo rispetto all’effetto
Ricardo) il ruolo della crescita degli investimenti.
È utile soffermarsi sulla penultima grandezza (differenza tra costo del lavoro per unità
di prodotto e prezzi) perché essa regola l’evoluzione della distribuzione primaria del
reddito. Possiamo infatti notare che la quota del lavoro nel redito (SL) è definita nel
modo seguente:
(2)
SL =
( N d + Ni ) ⋅ w N ⋅ w
=
= ulc ⋅ p −1 ,
Y⋅p
Y⋅p
dove Nd è l’occupazione dipendente, Ni quella indipendente, w il costo del lavoro
unitario, Y il prodotto, p i prezzi e N l’occupazione totale. Possiamo quindi esprimere la
quota del lavoro come rapporto tra il costo del lavoro per unità di prodotto e i prezzi.
In termini di variazioni abbiamo:
(3)
S& L = ul&c + p& −1 + (ul&c ⋅ p& −1 ) ,
da cui, con l’assunzione di trascurabilità del termine di interazione, ricaviamo la
condizione di stabilità:
(4)
S& L ≈ 0 ⇔ ul&c ≈ p& ,
S&L ≤ 0 ⇔ ul&c ≤ p& ,
che segnala che la quota del lavoro nel reddito sarà stabile se la variazione del costo del
lavoro per unità di prodotto è pari a quella dei prezzi; mentre, se la variazione è
inferiore (superiore) a quella dei prezzi, la quota diminuisce (cresce).
8
A favore degli alti salari militano anche le ragioni di ordine microeconomico enunciate dalla teoria dei
salari di efficienza (ad es., Shapiro e Stiglitz, 1984).
6
3. L’effetto Smith rivisitato
Come abbiamo notato, le economie dell’euro sono chiamate a riorganizzarsi per
fronteggiare le sfide delle nuove tecnologie, dei nuovi concorrenti globali e della
moneta unica; e la strategia comune per assicurare la crescita è quella di rendere più
competitivi sia il mercato del prodotto sia quello del lavoro, essendo la regolazione
dell’offerta di moneta ormai esogena. Blanchard e Giavazzi (2003), con l’ausilio di un
modello di equilibrio generale a due mercati, illustrano la sequenza degli elementi
rilevanti di questa strategia comune (Figura 3).
Figura 3 – Aggiustamento strutturale delle economie dell’euro ed “effetto Smith”
Mercato del prodotto
Mercato del lavoro
Liberalizzazione del
mercato del prodotto
Flessibilizzazione del
mercato del lavoro
Contenimento dei prezzi
Moderazione salariale
Competitività
internazionale
Crescita del potere
d'acquisto
Innovazione
Produttività
Effetto Smith
Domanda estera
Crescita
Domanda interna
Fonte: elaborazione su Blanchard-Giavazzi (2003)
Anzitutto la liberalizzazione del mercato del prodotto deve riuscire a ottenere un
aumento della pressione concorrenziale tale da contenere i prezzi, stimolare
l’innovazione e favorire la crescita della produttività. Contenimento dei prezzi,
innovazione e produttività, a loro volta, consentono all’economia di mantenere la
propria posizione competitiva, almeno nei confronti dei concorrenti tradizionali (i
partner nell’area dell’euro). Parallelamente, nel mercato del lavoro, le riforme devono
moderare la crescita del costo del lavoro e dei salari. Ma la moderazione non deve
essere portata al punto da diventare controproducente: il contemporaneo contenimento
dei prezzi deve infatti assicurare comunque la crescita del potere d’acquisto delle
retribuzioni e, per questa via, della domanda interna. Se il mercato del lavoro è troppo
liberalizzato rispetto a quello del prodotto, i salari perdono potere d’acquisto e i
consumi interni ristagnano; se è troppo liberalizzato il mercato del prodotto rispetto a
quello del lavoro, i salari sono troppo elevati, le imprese non fanno profitti e sono spinte
a trasferirsi altrove o falliscono, cresce la disoccupazione. Solo l’equilibrio tra i due
mercati assicura che l’economia, trainata dalla domanda estera (per il canale della
moderazione dei prezzi) e da quella interna (per quello dell’aumento del potere
d’acquisto dei salari), cresca stabilmente.
Invece per un paese che, come l’Italia, abbia messo in atto una significativa riforma del
mercato del lavoro prima di avere adeguatamente riformato il mercato del prodotto e,
quindi, senza un’adeguata pressione concorrenziale su prezzi e margini, le conseguenze
sono senz’altro perverse: da un lato il declino della quota del lavoro nel reddito
7
(impoverimento relativo dei dipendenti e delle loro famiglie), dall’altro prezzi elevati –
con la duplice conseguenza negativa di una perdita di competitività internazionale (pur
in presenza di profitti significativi) e di un rallentamento dei consumi 9 . In un contesto di
inasprimento della concorrenza internazionale, i prezzi elevati si traducono in un freno
alla crescita dal lato delle esportazioni, mentre il rallentamento dei consumi frena la
crescita sul mercato interno.
Figura 4 - Accumulazione delle rendite nell’economia italiana prima e dopo il
1993. Anni 1980-2003 (Valori assoluti a prezzi costanti 2000 in migliaia di euro e
incidenze percentuali sul pil)
12,0
120.000
10,0
100.000
Migliaia di euro 2000
8,0
80.000
Incidenza delle rendite sul pil
(scala di ds.)
6,0
60.000
4,0
40.000
Rendite a prezzi costanti 2000
(scala di sin.)
2,0
20.000
-
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Istat, conti nazionali
In un sistema economico gravato da numerosi segmenti strutturalmente protetti dalla
concorrenza (interna e/o internazionale), la moderazione salariale non accompagnata da
una (almeno) altrettanto stringente pressione su prezzi e margini consente l’accumulo di
rendite ingenti. Nell’insieme dell’economia, dopo il 1993 l’incidenza delle rendite da
oligopolio sul valore aggiunto cresce al ritmo medio di 0,4 punti percentuali l’anno,
assicurando alle imprese beneficiarie un flusso di risorse che, ai prezzi del 2000,
approssima nel periodo 2000-2007 l’importo medio di 108 miliardi di euro l’anno 10
(Figura 4).
9
L’effetto recessivo sulla domanda interna può essere accentuato, in un paese con problemi di finanza
pubblica come il nostro, da misure di taglio della domanda delle pubbliche amministrazioni, quando le
corrispondenti riduzioni delle imposte non si trasformino né in consumi, né in investimenti interni.
10
Sulla base della letteratura internazionale (si veda in particolare Griffith-Harisson, 2004), considero qui
come proxy delle rendite da oligopolio i profitti eccedenti il “normale” tasso di redditività di un mercato
di concorrenza. La procedura di stima proposta da Griffith e Harisson si basa sul mark-up del valore
aggiunto rispetto alla somma del costo del lavoro e del capitale. In particolare, gli autori stimano il costo
del capitale come costo d’uso dello stock di capitale, che assumono pari a una proporzione costante (10
per cento). Con questo metodo, il loro studio stima che il settore privato non agricolo dell’economia
italiana risulti gravato dalle rendite più elevate tra tutti i paesi considerati (14 paesi UE più gli Stati
Uniti): tra il 1985 e il 2000 il valore del mark-up è di 1,4 contro 1,26 della media. L’indicatore per l’Italia
mostra anche l’incremento più forte e raggiunge a fine periodo il valore di 1,5.
8
Figura 5 - Livello delle rendite nei settori dell’economia italiana prima e dopo il
1993. Anni 1980-2003 (Incidenze percentuali sul valore aggiunto; totale al netto del
settore della pubblica amministrazione, difesa e assicurazioni sociali)
40,0
Constructions
30,0
Manufacturing, energy, gas and water
20,0
Trade, repair, hotels and restaurants,
transport and communication
10,0
Total (excluding public administration)
0,0
Health, education and other social
and personal services
Banking, finance and business
services
Agriculture, forestry and fishing
-10,0
-20,0
-30,0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Fonte: Tronti, 2006
Le rendite si accumulano nei servizi alle imprese e nei servizi sociali e personali, nella
produzione di energia elettrica, gas e acqua, nel comparto agricolo (dove, non a caso, si
va esaurendo l’esodo occupazionale iniziato negli anni ’30 del Novecento) (Figura 5).
Incrementi minori, ma comunque significativamente superiori alla media si registrano
nell’estrazione di minerali non energetici e nelle attività di trasporto e comunicazione.
All’opposto (non senza un legame con quanto appena osservato), significative cadute
dei precedenti livelli di redditività interessano molte attività della manifattura (pelli e
cuoio, carta, stampa ed editoria, fabbricazione di combustibili, macchine e apparecchi
meccanici, mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere), le costruzioni, la pesca.
Ma le cadute più gravi si concentrano in alcune delle più rilevanti attività manifatturiere
esposte alla concorrenza internazionale – estrazione di minerali energetici, alimentari,
bevande e tabacchi, prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, macchine
elettriche ed elettroniche.
La vistosa e diseguale crescita delle rendite dopo il 1993 rivela che le politiche di
privatizzazione delle imprese pubbliche non solo non hanno accresciuto la competitività
L’indicatore, tuttavia, sovrastima le rendite italiane perché non tiene conto del reddito da lavoro degli
indipendenti, in Italia particolarmente numerosi. Se si considera questo aspetto, il costo del lavoro
aumenta e le rendite si riducono. Io utilizzo, quindi, un indicatore leggermente diverso, dato dalla
formula:
rendite = valore aggiunto – ((costo del lavoro + reddito da lavoro degli indipendenti) +
+ costo d’uso del capitale).
Inoltre stimo il costo d’uso del capitale, corretto per il reddito da lavoro degli indipendenti, al 7,5 per
cento dello stock di capitale ai prezzi di sostituzione. Il costo del capitale così calcolato supera, in media,
di circa 3,5 punti percentuali il valore degli ammortamenti. Nel settore privato non agricolo, nel periodo
1985-2000 (considerato da Griffith e Harisson), la mia stima delle rendite equivale a un mark-up di 1,2, e
il valore dell’anno finale è pari a 1,23. Il dato è meglio confrontabile con quello degli altri paesi che,
comunque, dovrebbe essere anch’esso corretto al ribasso per il reddito da lavoro degli indipendenti
(comunque assai minore).
9
dei settori protetti ma anzi, paradossalmente, l’hanno significativamente ridotta. Di
conseguenza le attività manifatturiere, esposte alla concorrenza, sono state ancor più
schiacciate tra l’incudine della competizione di prezzo sui mercati internazionali e il
martello dell’aumento di prezzi e tariffe sul mercato interno, replicando in modo
drammatico un antico e perverso copione del sistema economico italiano.
Figura 6 - Prezzi al consumo in Italia e nei paesi dell’area dell’euro. Anni 19962007 (Numeri indice in base 1996=100)
130,0
4,5
125,0
Differenza (scala ds.)
2,5
115,0
Italia
Differenze in p.p.
Numeri indice 1996=100
3,5
120,0
1,5
110,0
Area Euro
0,5
105,0
100,0
-0,5
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: Eurostat
Figura 7 – Retribuzioni reali per occupato in Italia e nei maggiori paesi europei.
Periodo 1995-2006 (Numeri indice 1995=100; deflazionate con il deflatore dei
consumi privati)
140
135
Grecia
130
125
Regno Unito
120
Portogallo
115
110
Germania
Francia
105
Italia
100
Spagna
95
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: Eurostat
10
L’asimmetria nello “scambio politico” 11 tra i partner sociali, che ha consentito
un’incisiva riforma del modello contrattuale e delle forme di lavoro (protocollo del ’93,
“pacchetto Treu”, legge “Biagi”) a fronte di una politica di privatizzazioni che non si
sono coniugate con effettive liberalizzazioni, o con altre forme di regolazione del
mercato del prodotto capaci di esercitare una forte pressione competitiva su prezzi e
margini, ha dunque prodotto un assetto del sistema economico strutturalmente
squilibrato, il cui risultato in estrema sintesi è costituito da prezzi più alti (figura 6; i
prezzi all’esportazione presentano un differenziale anche maggiore rispetto ai paesi
euro) e salari più bassi (figura 7) della media dei paesi concorrenti.
Inoltre, la sottrazione dell’offerta di moneta alla regolazione nazionale e il suo governo
comunitario avendo a target l’inflazione media europea hanno potuto cullare per periodi
anche prolungati le imprese più legate ai mercati locali nell’illusione di poter accrescere
i profitti praticando aumenti di prezzo maggiori del costo del lavoro e di quelli degli
altri mercati, senza rischiare i rigori di una conseguente politica monetaria restrittiva.
Ma il mercato opera molto presto la sua vendetta: con un’inflazione più alta della media
europea e salari più bassi, le esportazioni nette subiscono un tracollo e la domanda
interna si ferma. È questo il caso in cui è venuta a trovarsi dal 1997 in poi l’economia
italiana (figura 8).
Figura 8 – Esportazioni nette dell’economia italiana e consumi delle famiglie. Anni
1980-2007 (Esportazioni nette in valore assoluto a prezzi 2000 in migliaia di euro;
medie mobili a 5 termini dei tassi annui di variazione % dei consumi delle famiglie)
4,25
50.000
3,75
40.000
Esportazioni nette
30.000
3,25
20.000
2,75
10.000
2,25
1,75
-
1,25
-10.000
0,75
-20.000
Consumi delle famiglie (scala di ds.)
0,25
-30.000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Istat, conti nazionali
11
Traggo questo concetto da Ezio Tarantelli, che a proposito di patti sociali che comportassero una
riduzione del benessere dei lavoratori e delle famiglie parlava, anzi, di “scambio politico masochistico”
(cfr. Tarantelli, 1995).
11
Figura 9 - Il caso italiano: asimmetria di regolazione tra mercato del prodotto e
mercato del lavoro ed “effetto Smith”
Mercato del prodotto
Mercato del lavoro
Liberalizzazione del
mercato del prodotto
Flessibilizzazione del
mercato del lavoro
Contenimento dei prezzi
Moderazione salariale
Competitività
internazionale
Crescita del potere
d'acquisto
Innovazione
Produttività
Effetto Smith
Domanda estera
Crescita
Domanda interna
Fonte: elaborazione su Blanchard-Giavazzi (2003)
L’apparente stato di salute delle imprese, consentito dalla diffusione delle rendite, non è
sostenibile: la stagnazione del mercato per i prodotti italiani, all’interno come all’estero,
blocca l’effetto Smith, la specializzazione del lavoro e l’innovazione produttiva (figura
9).
4. L’effetto Ricardo rivisitato
4.1. Il Protocollo del ’93 e la caduta del prezzo relativo del lavoro
Le cause della caduta del prezzo relativo del lavoro (effetto Ricardo) possono essere
meglio comprese se le si colloca nella prospettiva dell’esperienza storica italiana di
regolazione della dinamica salariale. A questo fine, è indispensabile assumere come
punto di partenza gli esperimenti di politica dei redditi degli anni ’80, finalizzati al
rientro di un tasso di inflazione che aveva superato i 20 punti percentuali l’anno,
attraverso la fissazione concertata, tra governo e parti sociali, di un target di inflazione
annuale. In coerenza con il comune obiettivo, il Governo doveva determinare la
manovra dei prezzi amministrati e delle tariffe, le imprese le politiche di prezzo di beni
e servizi, i sindacati l’evoluzione degli scatti della cosiddetta “scala mobile” (il
meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni tabellari all’inflazione) e la
banca centrale l’offerta di moneta.
Tali esperimenti possono essere ben sintetizzati dalla proposta di Ezio Tarantelli, che ne
fu il propugnatore più attivo e tenace, fino al sacrificio della vita stessa. La proposta di
Tarantelli può essere sintetizzata nei seguenti quattro capisaldi 12 .
1. L’ipotesi di politica dei prezzi concertata identifica, in primo luogo, la stabilità dei
prezzi come un bene pubblico, non producibile da un unico agente ma frutto, invece,
da un lato del comportamento cooperativo (e concertato) dei grandi attori dell’arena
della relazioni industriali (governo e partner sociali) e della banca centrale,
dall’altro, delle aspettative dei singoli agenti.
12
Tarantelli, 1995.
12
2. La proposta considera la stabilità delle quote distributive dei salari e dei profitti nel
reddito (la cosiddetta “legge di Bowley”) come regola aurea della politica dei
redditi perché, in parità di altre condizioni, è questa la condizione che assicura la
massima crescita salariale (e, quindi, la massima crescita della domanda interna)
compatibile con l’assenza di pressioni sul saggio di profitto e, quindi, sui prezzi
interni. Si tratta di un punto cruciale. L’ipotesi comporta come corollario che i salari
reali (di fatto) crescano nella stessa misura della produttività del lavoro: questo non
per un implicito (quanto insostenibile) giudizio morale sul fatto che i lavoratori
siano i “veri” autori della crescita della produttività, ma per evidenti considerazioni
di carattere macroeconomico, legate alla crescita dell’economia e all’equilibrio nei
consumi.
3. Il terzo aspetto, in cui si concentra forse il contributo più rilevante di Tarantelli
all’analisi macroeconomica del rapporto tra salari e prezzi, è quello della cosiddetta
politica salariale d’anticipo. L’unica possibilità di spezzare la spirale perversa
prezzi-salari-prezzi consiste nell’interrompere la trasmissione al presente
dell’inflazione passata (quale era assicurata all’epoca, in Italia, dall’istituto della
“scala mobile” – e in molti altri paesi industriali da altri, consimili meccanismi di
adeguamento automatico delle retribuzioni all’inflazione pregressa). La catena viene
spezzata programmando in anticipo incrementi retributivi in linea con l’inflazione
attesa, invece di recuperare nel periodo corrente il potere d’acquisto perduto in
passato. Una clausola di salvaguardia pone in capo alle imprese l’onere di coprire ex
post i salari da un eventuale scostamento tra inflazione attesa e inflazione effettiva.
4. Infine, la scelta di governare il movimento dei prezzi attraverso il raffreddamento
della scala mobile e il suo allineamento con gli obiettivi di aumento delle
retribuzioni di base concertati e coerenti con i comportamenti degli altri attori
(governo, imprese e banca centrale), in un regime di reciproca sorveglianza e di
fattiva collaborazione tra i partner sociali e il governo, viene proposta in alternativa
alla ricetta monetarista di una violenta restrizione dell’offerta di moneta da parte
della banca centrale perché paretianamente preferibile, in quanto priva delle
conseguenze sociali negative (fallimenti, disoccupazione) che si accompagnano ad
un arresto dell’attività economica dal lato monetario.
La figura 10, che presenta le dinamiche parallele dell’inflazione e delle retribuzioni di
fatto, evidenzia le diverse fasi della storia della riforma del meccanismo di negoziazione
delle retribuzioni in Italia dal 1970 ad oggi. Il grafico mostra gli effetti esplosivi su
prezzi e salari dei due shock petroliferi del 1973-74 e del 1979-80 e consente di
apprezzare la fase di raffreddamento in cui ebbero un ruolo rilevante gli esperimenti di
politica dei prezzi concertata varati per iniziativa di Tarantelli negli anni 1983-84 (il
“lodo Scotti” e il “decreto di San Valentino”) e il successivo referendum abrogativo dei
punti di scala mobile “congelati” a causa del decreto. Il referendum, preceduto
dall’assassinio di Tarantelli, nonostante il clima di forte tensione sociale vide la netta
affermazione della linea della predeterminazione.
Ad esso seguì, nel 1986, una parziale e inefficace riforma della scala mobile e quindi,
nel 1991, la disdetta da parte datoriale dell’accordo interconfederale su quell’istituto. La
scala mobile venne quindi abolita con l’accordo trilaterale di luglio 1992, in cambio del
riconoscimento da parte del governo Amato della salvaguardia del potere d’acquisto
13
delle retribuzioni come obiettivo fondamentale della politica economica e della
promessa della predisposizione, a breve termine, di un nuovo meccanismo concertato di
determinazione della dinamica salariale. Questo venne effettivamente varato l’anno
successivo, sotto il governo Ciampi, attraverso il patto sociale sancito dal Protocollo di
luglio 1993.
Figura 10 - Inflazione e retribuzioni di fatto: gli accordi del 1982-84, il referendum
sulla scala mobile e gli accordi di luglio 1992 e 1993. Anni 1970-2007 (Tassi annui di
variazione percentuale)
25,0
Prezzi al consumo (f.o.i.)
Referendum abrogativo
5,0
Decreto di s. Valentino
Primo shock petrolifero
10,0
Lodo Scotti
Secondo shock petrolifero
15,0
Protocollo di Luglio
Disdetta della scala mobile
Retribuzione lorda per equivalente t.p.
20,0
0,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
Fonte: Istat, Prezzi al consumo e Conti nazionali
Ricordiamo brevemente che il Protocollo prevede due livelli di contrattazione salariale
separati e non sovrapponibili. Alla contrattazione nazionale di settore (primo livello),
articolata in un quadriennio normativo e due bienni economici, è demandato il compito
di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni di base. Gli incrementi dei
minimi salariali contrattuali, fissati ogni due anni, devono essere coerenti con il tasso di
inflazione programmata (politica salariale d’anticipo); in caso di scostamento tra questo
e l’inflazione effettiva, è prevista la possibilità di un recupero nel secondo biennio
economico (meccanismo di salvaguardia). Alla contrattazione decentrata (secondo
livello), articolata su scala aziendale o territoriale, è affidato invece il ruolo di regolare
con accordi quadriennali la crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni sulla base
dei risultati di produttività, redditività e qualità realizzati nell’impresa o nel territorio di
applicazione dell’accordo.
La figura 11 presenta, per i bienni contrattuali dal 1982-83 al 2008-2009, i tassi medi di
variazione dell’inflazione programmata e di quella effettiva e, sull’asse di destra, la loro
differenza espressa in rapporto percentuale all’inflazione effettiva (con dati di inflazione
2008 e 2009 previsti al 3,6 e al 2,9 per cento). Il grafico evidenzia in modo netto che, ad
eccezione del biennio 1996-97, durante l’intero periodo di progressivo abbattimento del
tasso di inflazione dal 16 a meno del 3 per cento l’anno (1982-2000), lo scarto tra i due
tassi di inflazione (effettiva e programmata) è stato sempre positivo (con l’inflazione
effettiva superiore a quella programmata) e piuttosto stabile attorno al valore del 10 per
cento circa del tasso di inflazione effettiva.
14
Figura 11 – Inflazione programmata, inflazione effettiva e differenza in rapporto
all’inflazione effettiva. Bienni 1982-83 – 2008-09 (Tassi di variazione percentuale
medi per biennio negoziale)
16,0
60,0
Differenza/inflaz.effettiva %
Inflazione effettiva
50,0
Inflazione programmata
12,0
40,0
10,0
30,0
8,0
20,0
6,0
10,0
4,0
0,0
2,0
-10,0
0,0
Differenze in %
Inflazione programmata ed effeettiva
14,0
-20,0
1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09
Fonte: Istat, Prezzi al consumo e Presidenza del Consiglio, DPEF
Invece, dal biennio 2001-02 in poi, quando l’inflazione effettiva era ormai sotto il
valore del 3 per cento, lo scarto ha assunto valori di importo maggiore, e nel 2008-09
con larga probabilità supererà il 50 per cento di un’inflazione effettiva tornata
comunque sopra la soglia psicologica del 3 per cento. La dimensione dello scarto
comporta indubbiamente problemi per la credibilità del tasso di inflazione programmata
come obiettivo comune dei tre firmatari del Protocollo del ’93.
Figura 12 – Prezzo relativo del lavoro. Anni 1981-2006 (Differenze tra i tassi di
variazione annui del reddito da lavoro dipendente per equivalente e tempo pieno e il
deflatore degli investimenti fissi lordi; medie mobili di 3 termini)
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fonte: Istat, Conti nazionali
15
Per spiegare la caduta del prezzo relativo del lavoro (alla base dell’effetto Ricardo) che
vediamo illustrata nella figura 12, sottopongo a verifica l’ipotesi che l’architettura
negoziale del Protocollo renda improbabile l’invarianza della distribuzione primaria del
reddito – che costituiva, invece, un pilastro fondamentale del disegno di politica dei
redditi di Tarantelli (punto 2 più sopra) – e all’opposto, in condizioni di normale
funzionamento dell’economia, favorisca automaticamente l’aumento della quota del
capitale.
Per mettere alla prova l’ipotesi analizzo in dettaglio il meccanismo previsto dal
Protocollo ’93 attraverso una formalizzazione matematica (cfr. Tronti, 2008). Sia w il
salario di fatto, ND l’occupazione dipendente, Q il reddito reale totale e p i prezzi; la
quota del lavoro, o quota del lavoro dipendente nel reddito (SL), può essere definita nel
modo seguente:
(5)
S L = w ⋅ N D ⋅ Q −1 ⋅ p −1 ,
da cui, moltiplicando e dividendo per l’occupazione totale NT, e sostituendo la
produttività del lavoro π al reddito per occupato, abbiamo:
(5.1)
S L = w ⋅ nD ⋅ π −1 ⋅ p −1 ,
dove nD indica l’incidenza dell’occupazione dipendente sul totale.
Dalla 5.1 si ricava agevolmente la nota condizione di crescita salariale che assicura
l’invarianza della quota del lavoro:
(6)
S& L ≈ 0 ⇔ w& ≈ p& + π& − n& D .
La formula (6) 13 , in cui il punto soprascritto indica variazioni percentuali, chiarisce che
la legge di Bowley si verifica solo se la crescita del salario reale eguaglia la variazione
della produttività del lavoro, al netto della variazione dell’incidenza dell’occupazione
dipendente sul totale. Ma, nel disegno del Protocollo ’93, la retribuzione reale può
rispettare la legge di Bowley solo nel caso in cui la retribuzione di secondo livello
cresca rispettando alcuni vincoli assai stringenti. Vediamo perché.
Sia w1 il tasso di salario di primo e w2 quello di secondo livello; la crescita della
retribuzione di fatto sarà:
(7)
w& = αw& 1 + (1 − α ) w& 2
con 0 ≤ α ≤ 1 ,
dove α è l’incidenza del salario di primo livello sul salario totale.
Ipotizzando che questa componente retributiva si muova con l’inflazione ( p& ), per
effetto del tasso di inflazione programmato (tip) e dei periodici recuperi degli scarti tra
13
Nel lato destro dell’equazione riferita alla crescita delle retribuzioni è omesso il termine di interazione
delle tre variabili, di entità generalmente trascurabile.
16
tip e inflazione effettiva, possiamo derivare la crescita di w2 che soddisfa l’invarianza
della distribuzione primaria:
(8)
w& − αw& 1
S& L = 0 ⇔ w& 1 = p& e w& 2 =
≈ p& + βπ&
1−α
con β =
1
>1.
1−α
Come si vede immediatamente, si tratta di una condizione che richiede 14 che la
retribuzione decentrata cresca non solo tenendo il passo con l’inflazione, ma anche
aumentando il proprio potere d’acquisto secondo il tasso di crescita della produttività
del lavoro moltiplicato per un fattore β maggiore di uno e tanto più grande quanto
minore è l’incidenza della retribuzione di secondo livello sul totale. Nell’insieme
dell’economia italiana, sulla base delle differenze di livello tra retribuzioni di fatto e
retribuzioni contrattuali, si può ipotizzare che β abbia un valore medio elevato, vicino a
6,5 – che conferma la scarsa diffusione della contrattazione di secondo livello (si veda
la tabella 2 più avanti).
Dunque l’impianto del Protocollo ’93, poiché prevede che le retribuzioni tabellari
fissate dai contratti nazionali di categoria restino ancorate per sempre al loro potere
d’acquisto del 1993, per mantenere inalterata la distribuzione primaria del reddito
richiede anche alla contrattazione decentrata di farsi carico di un ruolo economico di
grande importanza, che consiste: a) nell’assicurare la tenuta del proprio potere
d’acquisto e, b), nell’eguagliare la crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni di
fatto (comprensiva di primo e secondo livello) a quella della produttività del lavoro. In
altri termini, la retribuzione di secondo livello deve non solo crescere in misura
notevolmente superiore ai guadagni di produttività del lavoro (in modo da adeguare a
questi l’intera retribuzione reale), ma deve crescere comunque nella misura necessaria a
preservare il proprio potere d’acquisto anche quando la produttività del lavoro ristagna.
Inoltre, nel caso in cui venga rispettata l’invarianza distributiva, l’incidenza della
retribuzione decentrata sulla retribuzione di fatto dovrebbe tendenzialmente crescere nel
tempo sino a diventare la principale voce retributiva, dato che l’unica situazione in cui
essa può ridursi è quando la produttività del lavoro registra una caduta tale che,
moltiplicata per il fattore β, raggiunge valori superiori a quello della crescita dei prezzi.
Dunque, il Protocollo di luglio ’93 affida la possibilità di assicurare la stabilità nel
tempo delle quote distributive a due condizioni:
a) la diffusione a tutte le imprese della contrattazione decentrata (nella variante
aziendale o territoriale) e quindi la disponibilità per tutti i dipendenti di una voce
retributiva flessibile, aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare stabilita dalla
contrattazione di categoria;
b) la crescita del salario di secondo livello in misura tale da eguagliare la dinamica
della retribuzione di fatto (comprensiva di primo e secondo livello retributivo) alla
somma dell’inflazione e della variazione produttività del lavoro.
Nel sistema produttivo italiano, caratterizzato da un gran numero di piccole e
piccolissime imprese che è difficile coprire con contratti integrativi, le due condizioni
14
La formula non tiene conto della variazione dell’incidenza dell’occupazione dipendente sul totale, che
si assume costante nel breve periodo.
17
appaiono improbabili 15 . A verifica della robustezza di questa conclusione si consideri
che, anche nei paesi anglosassoni nei quali la contrattazione decentrata è la forma
contrattuale prevalente o addirittura esclusiva, la quota di lavoratori coperta da
contrattazione collettiva non eccede mai il 40-45 per cento del totale.
Per questo, per analizzare più approfonditamente le relazioni tra la dinamica della
produttività del lavoro e la distribuzione primaria del reddito secondo l’architettura
negoziale del Protocollo ’93, conviene realisticamente rilasciare il vincolo della legge di
Bowley. Possiamo quindi introdurre nel modello la variabile w& 2* , che indica la misura
teorica di crescita della retribuzione di secondo livello che, date le altre variabili,
assicurerebbe la condizione di invarianza analizzata nella (8). A livello aggregato, il
rapporto tra l’effettiva crescita della retribuzione decentrata e w& 2* , espresso dal
parametro γ, sintetizza pertanto sia l’entità della diffusione della contrattazione
decentrata (prima condizione), sia quanto questa contratti crescite salariali prossime al
livello che assicura l’invarianza della distribuzione primaria del reddito (seconda
condizione):
(9)
γ=
w& 2
w& 2*
con 0 ≤ γ .
Il parametro γ raggiunge l’unità solo se tutti i dipendenti hanno accesso alla
contrattazione di secondo livello e gli incrementi retributivi fissati dai contratti
decentrati sono tali da soddisfare l’invarianza secondo l’equazione (8).
Sulla base della crescita della produttività del lavoro e del valore di γ, possiamo quindi
ricavare le condizioni di variazione della distribuzione del reddito:
(10)
{
S& L < 0 ⇔ π& > 0, γ < 1
S& L = 0 ⇔ π& > 0, γ = 1
S& L > 0 ⇔ π& < 0, π& < (α − 1) p& .
Il legame tra crescita della produttività e movimento della quota del lavoro evidenziato
dalla relazione (10) stabilisce una relazione causale opposta a quella implicitamente
indicata dal modello di Sylos Labini. Quello ipotizza che le grandezze che fanno
muovere la quota (costo del lavoro per unità di prodotto e prezzi) contribuiscano a
determinare la crescita della produttività del lavoro, mentre il modello contrattuale
italiano stabilisce un nesso opposto, stabilito a livello istituzionale, secondo il quale è la
crescita della produttività (insieme alla distanza della crescita salariale di fatto dalla
legge di Bowley) a determinare i movimenti della quota del lavoro. Anche la natura
della relazione è opposta. Nel modello di Sylos la relazione tra quota e produttività è
lineare e diretta (se cresce o diminuisce la quota del lavoro, cresce o diminuisce la
produttività), nel modello negoziale del Protocollo del 1993 la relazione è inversa (se
cresce o diminuisce la produttività, diminuisce o cresce la quota del lavoro). Anche
l’intensità dei due effetti è diversa, dato che il legame istituzionale tra crescita della
15
Peraltro, anche tra le imprese medie e grandi si presentano notevoli differenze per settore e territorio
con riferimento alla sindacalizzazione e alla presenza di contrattazione decentrata.
18
produttività e movimento della quota del lavoro è certamente più forte del legame
economico che agisce nella direzione opposta.
Il contenuto delle relazioni indicate dalla (10) è sintetizzato a parole nella tabella 1.
Tabella 1 - Effetto combinato dei due livelli negoziali sulla quota del lavoro nel reddito
Casi
Possibili
Caso 1:
Normale
Contrattazione
nazionale
(1° livello)
Preserva il potere
d’acquisto delle
retribuzioni di
base
Produttività
del lavoro
Cresce
Caso 2:
Poco
probabile
Preserva il potere
d’acquisto delle
retribuzioni di
base
Cresce
Caso 3:
Perverso
Preserva il potere
d’acquisto delle
retribuzioni di
base
Diminuisce
Contrattazione
decentrata
(2° livello)
Non è disponibile a tutti
i dipendenti e/o non
assicura la crescita delle
retribuzioni reali di fatto
in linea con i guadagni
di produttività
Quota del
lavoro nel
reddito
⇒ Si riduce
È disponibile a tutti i
dipendenti e assicura la
crescita delle
retribuzioni reali di fatto
in linea con i guadagni
di produttività
⇒ Rimane
Si ferma
⇒ Cresce
stabile
Nelle condizioni di normale funzionamento dell’economia, nelle quali la produttività
del lavoro ha un andamento positivo, la quota del lavoro nel reddito si riduce,
comprimendo il prezzo relativo del lavoro e rallentando ulteriormente la crescita della
produttività. L’unica situazione tale da assicurare la costanza della quota del lavoro
(situazione che non esercita un effetto depressivo sulla crescita della produttività) è che
la produttività cresca e, al tempo stesso, il parametro γ sia pari a 1: un caso poco
probabile, affidato alle due condizioni (a) e (b).
Ma l’esito davvero perverso del modello negoziale varato con il Protocollo del 1993 è
che il bias a favore della quota del capitale si riequilibra solo quando la produttività del
lavoro diminuisce e la retribuzione di secondo livello si contrae, mentre l’adeguamento
ai prezzi di quella di primo livello assicura che la variazione della retribuzione lorda sia
comunque maggiore della differenza tra il tasso di inflazione e la variazione (negativa)
della produttività. In questo caso, secondo il modello di Sylos Labini, la crescita della
quota del lavoro dovrebbe controbilanciare, almeno in parte, la caduta della produttività.
Data però la larga prevalenza dell’effetto istituzionale (meccanico) su quello economico
(di comportamento), nel normale funzionamento dell’economia il Protocollo comprime
automaticamente la quota del lavoro dipendente e, paradossalmente, affida il
ristabilimento delle relatività distributive a una situazione di grave crisi dell’economia
(a una caduta della produttività del lavoro, ovvero a un fenomeno che, se si esclude
19
l’attuale fase di crisi, tra il 1970 e il 1996, si è verificato soltanto tre volte 16 ). Siamo
quindi al cospetto di un meccanismo istituzionale perverso, di un gioco a somma
negativa che dissipa quello che è probabilmente il bene relazionale fondamentale
dell’economia, costituito dall’incentivazione dell’impegno comune dei partner sociali
per la crescita della produttività e dell’economia stessa17 .
4.2. Crisi della contrattazione decentrata e crisi della produttività
L’analisi formale sviluppata nel paragrafo precedente ci fornisce una robusta chiave
interpretativa per esaminare in concreto le dinamiche retributive conseguenti al varo del
Protocollo ’93. Per fare ciò, sulla base dei cicli della produttività del lavoro si possono
dividere i 13 anni compresi tra il 1993 e il 2006 in tre periodi diversi.
Tabella 2 - Retribuzioni nominali e reali, produttività del lavoro e distribuzione
primaria del reddito. Totale economia. Anni 1993-2006 (Tassi di variazione
percentuale medi annui; per i coefficienti, valori assoluti; per la quota del lavoro
dipendente, differenze medie annue)
Periodi
Retribuzioni contrattuali nominali
Retribuzioni di fatto nominali
Retribuzioni di fatto reali (prezzi al
cons., Foi)
Costo del lavoro reale (product
wage)
Coefficiente α*
Coefficiente β**
Coefficiente γ***
Spazi economici price-neutral non
distribuiti alle retribuzioni
Quota del lavoro dipendente nel
valore aggiunto
Produttività del lavoro
1993-1995
2,4
3,5
-1,0
1996-2000
2,8
3,2
0,9
2001-2006
3,5
3,7
1,3
1993-2006
3,0
3,5
0,7
0,0
-0,5
0,4
0,0
0,89
9,0
0,4
3,1
0,87
7,7
0,7
1,2
0,84
6,4
1,3
-0,4
0,86
7,4
0,6
0,9
-1,2
-0,4
0,4
-0,2
3,1
0,8
0,1
1,0
Fonti: Istat, Retribuzioni contrattuali, Conti nazionali, Prezzi al consumo
*
Incidenza della retribuzione di primo livello sulla retribuzione di fatto.
**
Moltiplicatore dei guadagni di produttività applicato dalla retribuzione di secondo livello.
*** Distanza della dinamica retributiva dalla dinamica necessaria a garantire l’invarianza della
distribuzione primaria (il valore 1 indica una distanza nulla).
Il primo (1993-1995), di avvio e prima applicazione del nuovo sistema, è caratterizzato
da una sospensione sia dei contratti della pubblica amministrazione sia, inizialmente
(già dal 1992), della contrattazione decentrata. In questa fase la produttività per ora
lavorata cresce in misura notevole, del 3,1 per cento l’anno, in concomitanza con la più
grave crisi occupazionale della storia della Repubblica, mentre il potere d’acquisto delle
retribuzioni di fatto segna il passo (tabella 2). Il valore del coefficiente γ (calcolato
assumendo la differenza tra retribuzioni lorde dei conti nazionali e retribuzioni
16
Nel 1975 (-1,3 per cento ), nel 1982 (-0,3 per cento ) e nel 1992 (-0,1 per cento ).
Con il termine “bene relazionale” intendo, in termini sintetici, “quell’assetto relazionale che consente a
ciascun individuo di valorizzare il proprio capitale umano potenziale” (Fondazione Giacomo Brodolini,
1997) e quindi consente alle imprese e all’economia di conseguire più elevati livelli di produttività (si
veda più avanti, al par. 7).
17
20
contrattuali annue in valore assoluto come proxy della retribuzione di secondo livello)
nella media del triennio è pari a 0,4: in altri termini, la contrattazione distribuisce ai
salari il 40 per cento delle risorse che potrebbero essere distribuite senza spostare le
quote distributive. È in questa fase, che corrisponde al primo caso della tabella 1, che si
opera un netto shift della distribuzione primaria del reddito a favore dei profitti. La
quota del lavoro dipendente, già in calo dal 1978, si riduce ancora di circa tre punti e
mezzo: la relazione istituzionale tra quota del lavoro e produttività prevale largamente
su quella economica.
La seconda fase (1996-2000) è invece caratterizzata da un rallentamento della
produttività del lavoro fino al valore dello 0,8 per cento medio annuo. Il periodo vede la
piena applicazione del Protocollo, come pure la ripresa (e anzi un certo sviluppo) della
contrattazione decentrata, mentre si riavvia la contrattazione nel pubblico impiego. La
contrattazione nazionale stabilisce incrementi pro capite che, nel tentativo di recuperare
le precedenti perdite di potere d’acquisto, superano l’inflazione in media di mezzo
punto l’anno (figura 13) 18 . L’occupazione torna a crescere, ma le retribuzioni di fatto
crescono ancora in misura inferiore all’ipotesi di stabilità della distribuzione primaria e
la quota del lavoro continua pertanto, seppure molto più lentamente, a contrarsi. Questa
fase può essere considerata un’approssimazione al secondo caso illustrato dalla tabella
1, dato che il coefficiente γ ha un valore medio più vicino all’unità (0,7). Nonostante la
durata quinquennale, si tratta di un periodo caratterizzato da una straordinaria attività
negoziale, sospinta dalla necessità di recuperare almeno in parte il potere d’acquisto
perduto. Si conferma la relazione dinamica inversa tra quota dei salari e produttività.
Nell’ultima fase (2001-2006) l’inflazione programmata perde per lunghi anni il suo
ruolo di obiettivo comune a tutti e tre gli attori del sistema delle relazioni industriali, per
trasformarsi, in sostanza, in un tetto imposto unilateralmente dal Governo alla crescita
delle retribuzioni. La produttività oraria del lavoro ristagna intorno al valore medio
dello 0,1 per cento l’anno, con una caduta dell’1,5 per cento nel 2003. A fronte di
un’inflazione in linea con i valori del secondo periodo, la crescita delle retribuzioni di
primo livello accelera oltre l’inflazione programmata (e anche dell’inflazione effettiva;
figura 13), e l’accelerazione si trasmette alle retribuzioni di fatto. Così, le imprese
distribuiscono ai salari poco meno di mezzo punto l’anno più di quanto sarebbe
consentito dalla regola di invarianza (γ va a 1,3) e la quota del lavoro dipendente torna a
salire, al ritmo di quattro decimi di punto l’anno. La ripresa però, date le altre condizioni
dell’economia, non è sufficiente a generare un’accelerazione della produttività. Siamo
dunque nella situazione del terzo caso della tabella 1: la stagnazione della produttività
del lavoro a fronte della rigidità verso il basso delle retribuzioni reali opera un
paradossale riequilibrio della distribuzione primaria, che però non è sufficiente a
riavviare la crescita della produttività: le retribuzioni puniscono le imprese per non
avere utilizzato i profitti al fine di migliorare la produttività del lavoro.
18
Nel periodo, retribuzioni e costo del lavoro seguono dinamiche diverse perché quest’ultimo è soggetto
all’abolizione del contributo obbligatorio al SSN e di altri oneri minori, in conseguenza dell’introduzione
dell’Irap. La stima dell’effettivo impatto di queste misure sul costo del lavoro è ancora incerta, ma
comunque inferiore alla riduzione registrata dal reddito da lavoro dipendente stimato nell’ambito dei conti
nazionali (l’aliquota di fatto a carico dell’impresa sulla retribuzione lorda si riduce, nel 1998, di quasi sei
punti percentuali). Il costo del lavoro sostenuto dalle imprese subisce comunque un’ulteriore riduzione
per il quasi contemporaneo varo del “pacchetto Treu” che, grazie all’introduzione di forme contrattuali
flessibili, opera un significativo abbattimento dei costi di adeguamento della manodopera al ciclo e degli
stessi costi salariali al margine.
21
Figura 13 - Retribuzioni contrattuali, inflazione programmata e inflazione effettiva
(Numeri indice in base 1992=100)
160
150
140
Prezzi al consumo (Foi)
130
Inflazione programmata
120
Retribuzioni contrattuali
110
100
90
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonti: Istat, Retribuzioni contrattuali, Prezzi al consumo, Presidenza del Consiglio.
In definitiva, sulla base dei primi 13 anni di applicazione del Protocollo ’93, è possibile
concludere che, senza nulla togliere agli indiscutibili meriti nel governo dell’inflazione
e nello stimolo dell’occupazione, esso non è riuscito a favorire lo sviluppo della
contrattazione decentrata (che anzi, dopo un breve periodo di fioritura è venuta
chiudendo progressivamente i propri spazi) e nemmeno ad assicurare quella
flessibilizzazione dei salari che pure ne costituiva l’obiettivo primario. All’opposto, il
Protocollo ha favorito la compressione automatica della quota del lavoro nel reddito, e
questa, dimostrandosi nel lungo periodo più potente l’effetto economico (modello
Sylos) di quello istituzionale (modello contrattuale), ha depresso la crescita della
produttività del lavoro e dell’economia.
La figura 14 fornisce qualche dettaglio in più sui divari settoriali e territoriali nella
distribuzione alle retribuzioni reali dei guadagni di produttività del lavoro, tracciando
una mappa dell’accumulazione delle rendite oligopolistiche che è stata consentita dalla
combinazione della moderazione salariale, delle privatizzazioni e della mancata
regolazione della concorrenza (par. 3).
I guadagni di produttività non distribuiti si concentrano in agricoltura e, in misura
diversa, nei servizi market oriented (intermediazione monetaria e finanziaria,
commercio, altri servizi professionali e alle imprese), ovvero in attività protette o poco
esposte alla concorrenza internazionale; mentre nell’industria in senso stretto e nelle
costruzioni i margini non distribuiti dopo il 1993 sono molto inferiori. Notevole è poi il
caso dell’intermediazione monetaria, che mostra un governo delle retribuzioni
significativamente più favorevole alle imprese rispetto al periodo 1980-1992; mentre le
costruzioni presentano un andamento anticiclico rispetto agli altri settori (retribuzioni
molto fuori target nel periodo 1993-2000 e, all’opposto, alti margini non distribuiti nel
2001-2006).
22
Figura 14 - Produttività del lavoro non distribuita alle retribuzioni. Anni 19802006 (A) e medie 2000-2004 (B) (Tassi di variazione percentuale medi annui)
A) Per settore
4.0
3.0
2.0
1.0
-
- 1.0
- 2.0
- 3.0
1980-1992
1993-2000
2001-2006
1993-2006
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio, riparaz., alberghi e rist., trasporti e com.
Intermediazione mon. e fin.; attività immob. ed imprendit.
Altre attività di servizi
TOTALE
B) Per ripartizione
8,0
7,0
Valore aggiunto per ula
Retribuzioni lorde per ula
Produttività non distribuita
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Nordovest
Nordest
Centro
Mezzogiorno
Italia
-1,0
Fonte: Istat, Conti nazionali, elaborazioni dell’autore
Con riferimento all’aspetto territoriale, i guadagni non distribuiti si concentrano
nell’Italia Centrale, dove si riscontra una presenza relativamente elevata di attività di
servizio e agricole. La stessa combinazione, con un maggior peso però dell’agricoltura e
guadagni non distribuiti meno elevati, si rileva nel Mezzogiorno. Nel Nordest, la quota
di produttività trattenuta a beneficio del capitale è di poco superiore alla media
nazionale. Nel Nordovest invece, dove si concentrano le grandi imprese industriali e più
diffuse sono sia la sindacalizzazione, sia la contrattazione decentrata, le retribuzioni
crescono in termini reali al punto da assorbire una parte del valore aggiunto eccedente i
guadagni di produttività del lavoro.
5. Quota del lavoro e crescita economica: il “nuovo scambio politico”
Dal punto di vista delle relazioni industriali, la chiave di lettura della crisi di produttività
dell’economia italiana va dunque ricercata nel processo di distribuzione primaria del
reddito. La moderazione salariale ha avuto effetti anche più rilevanti in termini di
23
raffreddamento della dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto (clup), che è
stata frenata non solo dal lato dei salari, ma anche da ripetute manovre di contenimento
degli oneri sociali.
Figura 15. Prezzi, costo del lavoro per unità di prodotto e quota del lavoro prima e
dopo il 1993. Anni 1980-2007 (Per deflatore del v.a. e clup, numeri indice in base
1980=100; v.a. al costo dei fattori; quota del lavoro corretta per gli indipendenti)
450,0
88,0
400,0
Deflatore del v.a.
(scala di sinistra)
86,0
350,0
84,0
Clup
(scala di sin.)
300,0
82,0
250,0
80,0
200,0
78,0
Quota del lavoro nel prodotto netto
(scala di destra)
150,0
76,0
74,0
100,0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fonte: Istat, Conti nazionali ed elaborazioni dell’autore
La figura 15 pone a confronto la dinamica dei prezzi, misurata attraverso il deflatore del
valore aggiunto, con la parallela crescita del clup. Come abbiamo mostrato formalmente
nel paragrafo 2, la differenza tra queste due grandezze determina la dinamica della
quota del lavoro nel reddito, che costituisce la terza variabile rilevante per la crescita
della produttività del modello di Sylos Labini. Dopo il 1993, alla sensibile
decelerazione dei prezzi fanno riscontro un rallentamento ancor più rilevante del clup e,
conseguentemente, il ricordato declino della quota del lavoro. Dopo il 2001, a fronte
dell’andamento negativo della produttività, la quota del lavoro mostra una nuova
crescita che, come abbiamo visto, non è altro che la contropartita (altrettanto perversa)
dell’aumento automatico della quota del capitale quando la produttività del lavoro
aumenta.
Da molti anni però, la quota del lavoro dipendente si riduce e, all’inverso, cresce quella
del capitale nella maggioranza dei paesi avanzati. Dunque, l’Italia non fa eccezione
(Zenezini, 2004; Tronti, 2005b). Secondo il nuovo Productivity Datbase dell’Ocse, tra il
1992 e il 2006 la quota del capitale è cresciuta di otto punti percentuali in Spagna, di sei
nell’area dell’euro, di cinque in Giappone, di quattro in Germania. Io avanzo l’ipotesi
che l’aumento della quota del capitale vada considerato come parte di un ‘nuovo
scambio politico’ tra dipendenti e imprese: uno scambio nel quale la maggior
remunerazione del capitale è una sorta di contributo straordinario che i dipendenti, in
questa fase dello sviluppo capitalistico, pagano alle imprese per consentire loro di
riorganizzarsi e sostenere l’urto combinato delle nuove tecnologie e dei nuovi
concorrenti sul mercato globale. I termini del nuovo scambio politico sono caratterizzati
24
da profonde specificità nazionali. Alcuni paesi (Irlanda, Finlandia, Norvegia, Ungheria),
nei quali l’aumento ha assunto proporzioni spettacolari (oltre 10 punti), hanno goduto di
una crescita economica superiore agli altri. Altri, dove la quota del capitale è cresciuta,
ma di poco (Francia, Olanda e Stati Uniti), hanno goduto di performance di lungo
periodo variamente positive. Così è stato, però, anche per Regno Unito, Danimarca,
Belgio, Polonia, Grecia, dove la distribuzione primaria del reddito è rimasta
sostanzialmente immutata.
Nel caso italiano, tra il 1992 e il 2001 la quota del capitale è cresciuta, secondo l’Ocse,
di più di 11 punti, per poi tornare a cadere di circa due punti dal 2002 in poi, a fronte
dell’andamento negativo della produttività del lavoro. Ma la divergenza italiana non sta
tanto nell’entità dell’aumento della quota del capitale, quanto nella sua inefficacia ai fini
della crescita. Nel sistema economico italiano, in accordo con il modello di Sylos
Labini, un aumento della quota del capitale non porta con sé alcuna accelerazione, bensì
un rallentamento della crescita. La figura 16 evidenzia che nell’economia italiana esiste
una relazione positiva di lungo periodo, statisticamente significativa e di entità
superiore alle attese, tra il livello della quota del lavoro dipendente nel reddito e il tasso
medio di crescita successivo. Sulla base della relazione individuata, per portare il tasso
di crescita dell’economia italiana al 3 per cento annuo, la quota del lavoro dipendente
nel reddito dovrebbe essere più di sei punti percentuali più elevata del suo livello
attuale.
Il risultato concreto del “nuovo scambio politico” per i diversi paesi si può, quindi,
valutare rapportando il tasso di crescita del prodotto lordo all’aumento della quota del
capitale (figura 17). Per tutti e 15 i paesi considerati, la reattività della crescita
economica alla quota del capitale tra il 1992 e il 2005 risulta positiva, e per nove di essi
è superiore al valore di un mezzo. Ciò, ovviamente, non prova che sia stata la
redistribuzione primaria a causare la crescita, ma segnala che le due cose si sono
verificate assieme.
Figura 16 – Relazione tra livello della quota del lavoro dipendente nel reddito
nell’anno t e crescita media del pil nel triennio t_t+2 – Anni 1971-2007 (Tassi medi
annui di crescita e punti percentuali)
6
1972
Tasso di crescita del pil nel triennio successivo
5
vPIL t,t+2 = - 10,387 + 0,2599QL t
1978
2
R corr. = 0,4327
1976
1971
1977
4
1974
1987
1986
1988
1973
1979
1984
3
1985
2
2006
2000
1995
1994
1
2005
1980
1993
1997
1975
1983
1989
1999
1998
1982
1990
1996
2004
2001
1992
1981
1991
2002
2003
0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
Quota del lavoro dipendente
Fonte: Istat, Conti nazionali.
25
Figura 17 - Elasticità della crescita del pil all'aumento della quota del capitale –
Anni 1992-2005 (Valori percentuali)
3.50
3.31
3.00
2.50
2.00
1.43
1.50
1.34
0.97
1.00
0.86
0.85
0.82
0.71
0.50
0.50
0.39
0.36
0.35
0.33
0.29
0.26
0.15
Ita
ly
ay
y
Ja
pa
n
N
or
w
an
y
H
un
ga
r
G
er
m
ea
Fi
nl
an
d
ar
Sp
ai
n
Eu
ro
Ire
la
nd
la
nd
s
Fr
an
ce
N
et
he
r
Sw
ed
en
St
at
es
Be
lg
iu
m
U
ni
te
d
U
ni
te
d
D
en
m
ar
k
Ki
ng
do
m
0.00
Fonte: Oecd, Eurostat
Il risultato migliore è quello della Danimarca, dove a ogni punto di (un modestissimo)
aumento dei profitti hanno corrisposto più di tre punti di crescita; mentre Irlanda,
Olanda, Francia, Svezia, Stati Uniti, Belgio e Regno Unito si collocano, nell’ordine,
nell’intervallo tra 0,7 e 1,4 punti. L’Italia, come è ovvio attendersi sulla base di quanto
abbiamo sin qui notato, presenta il risultato largamente peggiore: per ogni punto di
aumento della quota del capitale il pil è infatti cresciuto soltanto di 1,5 decimi di punto.
In Italia, dunque, il lungo periodo di moderazione salariale che ha seguito il varo del
Protocollo del ’93 non è bastato ad assicurare che le imprese si riorganizzassero e si
rafforzassero rispetto agli shock delle nuove tecnologie, dei nuovi concorrenti e della
moneta unica. Nella logica del “nuovo scambio politico”, fintanto che la produttività del
lavoro ha avuto un’evoluzione positiva, il modello contrattuale ha reso implicito e
automatico l’aumento della quota del capitale nel reddito, eliminando la possibilità per
la parte sindacale e per quella pubblica di chiedere alle imprese una contropartita in
termini di investimenti, potenziamento del lavoro, riorganizzazione del sistema
produttivo e crescita economica. Quanto era peraltro previsto dalla stessa seconda parte
del Protocollo del ‘93 19 . In altri termini, il meccanismo perverso che collega il modello
contrattuale allo squilibrio della distribuzione del reddito ha minato alla base la
possibilità stessa di praticare anche in Italia il “nuovo scambio politico” in atto da
tempo tra i partner sociali di molte economie avanzate e di utilizzare la moderazione
salariale per attrezzare il sistema economico alla crescita nel nuovo contesto
competitivo.
6. Incentivi per le imprese e per i dipendenti: investimenti, effort
Oltre alla caduta del prezzo relativo del lavoro e allo shift nella distribuzione primaria
del reddito il modello contrattuale ha causato il venir meno degli incentivi alla crescita
della produttività, sia per le imprese che per i lavoratori: una condizione che possiamo
19
Sugli effetti perversi della mancata applicazione della seconda parte del Protocollo, si veda la posizione
largamente premonitrice dello stesso Ciampi (1996).
26
definire di dissipazione del bene relazionale fondamentale costituito dalla convenienza
economica per i partner sociali a cooperare per la crescita dell’economia.
Rivolgendo anzitutto l’attenzione alla parte datoriale, per valutare sinteticamente
l’alterazione delle convenienze è sufficiente notare che, nel nuovo contesto distributivo,
la reattività dei profitti alla produttività è, paradossalmente, cresciuta troppo. Se tra il
1980 e il 1992 occorreva un guadagno di produttività di più di 10 punti per consentire
un solo punto di aumento del saggio di profitto, tra il 1993 e il 2006 è bastato, in media,
poco più di un punto (si veda la fig. 21 più avanti). Ma la ben maggiore profittabilità
non si è tradotta in un proporzionale aumento degli investimenti.
Dopo essere caduti (tra gli anni ’80 e i primi anni ’90) dal 28 al 21 per cento del
prodotto interno lordo, a partire dal 1995 gli investimenti hanno messo a segno una
ripresa (figura 18). Ma questa, che li ha riportati nel 2007 sopra il 24 per cento del pil,
non si può che valutare come insufficiente rispetto alle potenzialità e alle necessità di
crescita dell’economia: mentre nel 1992 essi equivalevano al 76 per cento dei profitti
lordi, nel 2007, nonostante gli sviluppi dei mercati dei capitali, le privatizzazioni e le
riforme del mercato del lavoro, essi erano solo al 68 per cento; e così la crescita del
rapporto capitale-lavoro, che nel periodo 1981-1994 era del 3,4 per cento l’anno, nel
1995-2006 è caduta all’1,2 per cento.
Figura 18 - Investimenti fissi lordi. Rapporti caratteristici. Anni 1980-2007
(Incidenze percentuali)
29,0
110,0
28,0
104,0
27,0
98,0
26,0
92,0
25,0
86,0
80,0
24,0
23,0
In rapporto al prodotto
lordo (scala di sinistra)
74,0
In rapporto ai profitti lordi
(scala di destra)
22,0
68,0
21,0
62,0
56,0
20,0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fonte: Istat, Conti nazionali, elaborazioni dell’autore.
Il motivo di questa insufficienza non è difficile da comprendere. L’abbattimento del
prezzo relativo del lavoro ha reso preferibile per gli imprenditori fare scelte di
espansione occupazionale piuttosto che di ammodernamento tecnologico e
organizzativo. Questo comportamento non è inatteso. Anzi, i dati mostrano l’esistenza
di una forte relazione di lungo periodo tra quota del lavoro e rapporto investimentiprofitti, una relazione che apparentemente può apparire paradossale (figura 19), ma che
invece è perfettamente coerente con l’analisi di Ricardo e il modello di Sylos Labini. Al
calare della quota del lavoro nel reddito, che si accompagna a un deprezzamento
27
relativo del lavoro, le imprese riducono la proporzione degli investimenti rispetto ai
profitti, il processo di aumento dei servizi di capitale a disposizione del lavoro rallenta,
e con esso rallenta la produttività.
Figura 19 - Relazione tra la quota del lavoro nel reddito e il rapporto tra
investimenti e profitti – Anni 1971-2006 (Valori percentuali)
120.0
86.00
110.0
84.00
100.0
ln Ifl = −15,124 + 4,4527 ln S L + ε
R 2 = 0,7205
82.00
90.0
80.00
80.0
78.00
70.0
Investimenti f.l./profitti lordi
Quota del lavoro (scala di destra)
76.00
60.0
50.0
74.00
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
Fonte: Istat, Conti nazionali ed elaborazioni dell’autore
In particolare, nel regime salariale frutto del Protocollo ‘93, gli investimenti sono stati
inferiori a quanto i profitti avrebbero consentito 20 , e soprattutto sono stati espansivi,
generando più occupazione e meno produttività che negli anni ’80. Questo esito, ne va
dato pienamente atto agli imprenditori, era proprio ciò che, fino al Consiglio Europeo di
Lisbona del 2000, chiedevano loro i policy-makers, tanto europei che nazionali, con
parole d’ordine quali “aumentare il contenuto occupazionale della crescita”, o “jobs,
jobs and more jobs”. Per le imprese, impegnate ad accrescere l’occupazione
avvalendosi dei nuovi strumenti contrattuali e della nuova convenienza economica del
lavoro, impegnarsi anche sul fronte della produttività è stato meno necessario, dato che
erano possibili ritorni interessanti anche con attività relativamente poco produttive. Ma
il rallentamento della produttività è diventato impoverimento relativo e arresto della
crescita: da un problema di jobless growth si è passati ad uno di growthless employment.
È poi facile, spostando l’attenzione al lato del lavoro, constatare che il
malfunzionamento del Protocollo (insieme con la diffusione delle forme di lavoro
flessibili alle coorti in entrata nell’occupazione), nel corso del tempo sono venuti
erodendo anche i premi con i quali il normale funzionamento dell’economia remunera
l’impegno dei lavoratori per l’aumento della produttività. La figura 20 evidenzia la
parallela, progressiva caduta della produttività del lavoro e dell’elasticità apparente
della remunerazione del lavoro dipendente alla variazione della produttività. Se negli
anni ’80 per ogni punto di aumento della produttività del lavoro le retribuzioni lorde
reali crescono, in media, di 0,9 punti, nel periodo successivo al 1993, data la
20
Gli investimenti italiani, almeno in parte, sono migrati all’estero, attratti da un’attesa di profitti anche
maggiori.
28
divaricazione tra la dinamica retributiva e quella della produttività, l’elasticità media
crolla a un quinto di punto. Per i dipendenti, impegnarsi a “fare produttività” non
conviene più. Anzi, l’unico modo per riequilibrare la distribuzione del reddito a favore
dei salari è quello di frenare la crescita della produttività! La produttività del lavoro
cade da un tasso di crescita medio annuo dell’1,7 per cento nel periodo 1980-1992
all’1,0 per cento nel 1993-2005, con un valore dello 0,1 per cento nel periodo finale
2001-2007.
Figura 20 - Elasticità apparente delle retribuzioni lorde alla produttività del
lavoro. Anni 1980-1992 e 1993-2007 (Tassi di variazione percentuale medi annui)
2,00
1,68
1,45
1,50
0,98
1,00
0,86
0,50
0,20
0,21
0,00
-0,50
Labour productivity
Real wage
-0,65
-0,70
Wage-productivity elasticity
-1,00
-1,25
-1,50
A) 1980-92
B) 1993-2007
B-A
Fonte: Istat, Conti nazionali
Non c’è quindi da stupirsi se la spinta propulsiva dell’economia si è progressivamente
esaurita fino ad arrestarsi del tutto: i guadagni di produttività alla base della crescita
economica sono il risultato di costose e impegnative innovazioni tecnologiche e
organizzative nei luoghi di lavoro che, nel contesto distributivo del Protocollo, nessuno
– né imprese, né sindacato, né dipendenti – ha un chiaro incentivo a realizzare. Ed è
proprio questo sistema premiale perverso che bisogna ribaltare per riequilibrare lo
scambio politico e ricostituire il bene relazionale fondamentale della convenienza per i
partner sociali a cooperare per la crescita.
7. Il deterioramento strutturale
La mancata riforma del mercato del prodotto, pur a fronte di un mercato del lavoro
ampiamente flessibilizzato, segnala che l’economia italiana è lontana dall’aver portato a
termine l’aggiustamento strutturale necessario a fronteggiare le sfide
dell’internazionalizzazione, delle nuove tecnologie e della moneta unica. Alcuni
indicatori macroeconomici ne segnalano il grave stato di sofferenza (figura 21). Dopo il
1993 si evidenzia anzitutto un significativo aumento dell’elasticità della redditività
rispetto sia alla produttività del lavoro che all’occupazione; le imprese possono
29
conseguire rilevanti aumenti dei profitti senza doversi preoccupare di ottenere
consistenti guadagni di produttività, limitandosi ad accrescere l’occupazione 21 .
Figura 21 - Relazioni tra produttività, investimenti, occupazione e redditività
prima e dopo il 1993. Periodi 1980-93 e 1994-2006 (Rapporti tra tassi di variazione;
redditività misurata come rapporto tra profitti lordi e somma di investimenti lordi e
redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente a prezzi costanti; occupazione
misurata in termini di occupati interni)
5.00
4.00
3.00
Tradeoff produttività-occupazione
2.00
1.00
0.00
-1.00
Accelerazione dei profitti
rispetto alla produttività
e all'occupazione
-2.00
Elasticità profitti/produttività
-3.00
Elasticità profitti/occupazione
Elasticità produttività/investimenti
Indebolimento del legame
investimenti-produttività
Elasticità produttività/occupazione
-4.00
A) 1980-93
B) 1994-2006
Differenze B-A
Fonte: Istat, Conti nazionali ed elaborazioni dell’autore
D’altro canto si segnalano due snodi critici fondamentali per la performance
macroeconomica, entrambi legati alla produttività del lavoro. Il più evidente consiste
nel pesante tradeoff tra crescita dell’occupazione e crescita della produttività; un
tradeoff – occorre sottolinearlo con forza – tuttaltro che inevitabile, che non si è
presentato nel caso di altre economie europee pur caratterizzate da una crescita
occupazionale significativa, come quella irlandese, finlandese o greca. L’esistenza di un
tradeoff produttività-occupazione è un risultato riscontrato da diversi autori,
generalmente con riferimento ai confronti internazionali di lungo periodo tra l’economia
degli Stati Uniti e le economie europee. Blanchard (2004), ad esempio, sostiene che in
Europa, nei decenni passati, la presenza di retribuzioni minime elevate impediva alle
imprese di occupare i lavoratori a produttività più bassa, con la conseguenza di
accrescere la produttività media attraverso un processo di selezione della manodopera e
Il decoupling tra produttività e redditività nei risultati delle imprese è robustamente documentato
dall’Istat, che individua ne1 2005 l’esistenza di circa 1 milione e 600 mila imprese italiane (il 45 per
cento del totale, più di 3,8 milioni di dipendenti, all’incirca un terzo del settore privato extra-agricolo) che
presentano tassi di redditività superiori alla media del loro settore, ma con livelli di produttività del lavoro
inferiori alla media (Istat, 2008b). Si tratta di imprese con un’elevata integrazione verticale (approssimata
dal rapporto tra valore aggiunto e fatturato); mentre l’intensità di spese per servizi è molto bassa, come
modesti sono pure gli investimenti, la remunerazione del fattore lavoro e le spese per formazione. La
dimensione occupazionale è molto contenuta e l’indice di competitività piuttosto basso. Queste imprese si
concentrano al Centro del paese, e operano nei settori della manifattura a medio-bassa tecnologia e dei
servizi sia tradizionali, che di mercato e tecnologici ad alto contenuto di conoscenza. Si tratta in larga
parte di figure imprenditoriali relativamente nuove, che occupano spazi che si sono ampliati a causa della
trasformazione strutturale del sistema economico, dove la mancanza di concorrenti o di una regolazione
efficace consentono la creazione di posizioni di rendita a danno del resto dell’economia.
21
30
al costo di più bassi tassi di occupazione e di una crescita molto contenuta dei posti di
lavoro (la cosiddetta jobless growth) 22 . In una prospettiva ricardiana, la moderazione
salariale rende via via sostenibili occupazioni a produttività marginale decrescente. Se la
moderazione è di entità tale (o è accompagnata da politiche fiscali tali) da rendere
queste attività sufficientemente redditizie, come nel caso italiano indica l’aumento
simultaneo dell’elasticità della redditività all’occupazione e alla produttività, una parte
significativa della creazione di occupazione si rivolge in questa direzione, con la
conseguenza di deprimere la dinamica della produttività media per un effetto di
composizione 23 .
Peraltro, la produttività media non rallenta solo quando aumenta il peso delle
occupazioni a produttività bassa, ma anche quando aumenta il peso di quelle a
produttività stagnante o declinante. Il tradeoff tra occupazione e produttività si inquadra,
infatti, anche nella visione della dinamica economica propria del modello di unbalanced
growth di Baumol (1967): in presenza di una pressione uniforme della domanda per i
settori a produttività crescente (agricoltura e manifattura) e per le attività a produttività
stagnante (servizi), l’aumento dell’occupazione in queste ultime non può che essere più
consistente, con sensibili effetti sulla dinamica aggregata della produttività, tanto più
forti quanto maggiore è l’espansione occupazionale. Soltanto lo sviluppo delle
tecnologie, l’innovazione dei prodotti e delle forme organizzative, l’accumulazione del
capitale umano e dei beni relazionali – in altri termini, la trasformazione e
l’ammodernamento strutturale delle imprese, che allontanano dall’origine la frontiera
delle possibilità produttive – possono modificare la geografia delle attività dinamiche, e
allentare il vincolo alla crescita24 .
Il secondo snodo critico a livello macroeconomico evidenziato dalla figura 21 è
costituito dall’indebolirsi degli effetti degli investimenti sulla produttività: dopo il 1993
l’elasticità apparente della produttività agli investimenti subisce un continuo declino. Se
negli anni 1980-93 per ogni punto percentuale di crescita degli investimenti fissi lordi la
produttività cresceva di 1,2 punti, tra il 1994 e il 2006 l’elasticità si riduce mediamente
di più di un terzo, passando al valore di 0,7; e segue, inoltre, un profilo decrescente tra il
primo e il secondo sottoperiodo (1994-97: 1,0; 1998-2006: 0,5). Questo risultato,
insieme con le evidenze già discusse, conferma il carattere espansivo ma segnala anche
il deterioramento qualitativo degli investimenti, che negli anni più recenti sono stati
Sull’evidenza del tradeoff nel confronto tra Europa e USA, si veda anche Sestini e Tronti (2002). Ma
la rilevanza degli effetti ricardiani in un’economia con capitale umano (e capitale fisico) non omogenei,
in opposizione alla vulgata della “legge di Okun”, era già stata sottolineata da De Cecco (1972) e da
Tarantelli (1970, 1974), con particolare riferimento al caso dell’economia italiana degli anni ’50 e ‘60.
Oggi, con l’ampliamento del tasso di occupazione, sembra ripresentarsi una situazione analoga.
23
Uno studio dell’Istat (2004c) mostra che il declino della produttività subito dal settore privato non
agricolo tra il 1998 e il 2001, anche una volta corretto per l’aumento delle posizioni lavorative part-time,
è, in realtà, un effetto di composizione dovuto alla crescita dell’occupazione nei segmenti a produttività
bassa o stagnante dell’apparato produttivo. In assenza della modifica del mix occupazionale, la dinamica
della produttività, seppure molto modesta, sarebbe stata positiva. Dopo il 2001, invece, gli effetti di
composizione risultano blandamente positivi, mentre il tasso di variazione netto (within) della produttività
delle imprese diventa negativo (cfr. Istat, 2006).
24
Su questo aspetto, e in particolare sulle potenzialità aperte dallo sviluppo dei servizi e da una loro
stretta integrazione con l’industria nella direzione di una ripresa della dinamica della produttività
aggregata, si vedano Oulton (2001) e Sestini e Tronti (cit.).
22
31
indirizzati alla creazione di posti di lavoro a produttività bassa o stagnante, con il
risultato di un impatto meno che unitario dell’occupazione sul reddito.
Al declino dell’efficacia degli investimenti in termini di produttività si collega, poi, il
recente andamento della total factor productivity nell’economia italiana (cfr. Istat,
2007). L’indicatore, per quanto comunemente utilizzato e raccomandato dalle istituzioni
internazionali (ad es. Oecd, 2001), è fortemente problematico, non solo per la
molteplicità e vaghezza di significati che vorrebbe rivestire (progresso tecnico,
cooperazione sociale, capitale sociale, imprenditorialità ecc.) 25 , ma anche per la scelta
metodologica, ormai universalmente accettata, di utilizzare nella sua costruzione le
quote distributive come proxy delle elasticità del prodotto ai fattori. Come è noto, si
tratta di un’approssimazione che, anche accettando il paradigma neoclassico, vale però
soltanto in regime di concorrenza sia nel mercato del prodotto sia in quello del lavoro.
Ora l’economia italiana, come queste pagine argomentano ampiamente, è gravata da
vaste zone protette dalla concorrenza, dove si accumulano rendite ingenti che
remunerano il capitale oltre il suo effettivo contributo alla crescita; mentre, all’opposto,
la remunerazione del lavoro è frenata da assetti istituzionali che sono il frutto di intese
concertative centralizzate, lontane dal funzionamento di un mercato del lavoro di
concorrenza 26 . L’indicatore può pertanto essere usato a titolo meramente indicativo, di
impreciso segnale macroeconomico dell’efficacia della combinazione dei fattori, ma
nella coscienza dell’infondatezza di qualunque tentativo di utilizzare l’indicatore stesso
o altri indicatori ad esso collegati per valutare il merito del contributo dei singoli fattori
alla crescita. Con queste forti cautele, è comunque utile notare che tra il 1996 e il 2006
il contributo della tfp alla crescita del valore aggiunto è stato, nella media
dell’economia, nullo. In particolare, nel periodo più recente (2001-06) è stato
mediamente negativo (-0,5 per cento l’anno), con cadute significative nel credito e nelle
attività di servizio alle imprese (-2,1 per cento), nei servizi pubblici, sociali e personali
(-1,5 per cento), nell’agricoltura (-0,8 per cento).
In presenza di un andamento degli investimenti lordi insufficiente rispetto al potenziale
ma non negativo, questo risultato potrebbe indicare un deterioramento dei beni
relazionali nelle imprese e nel sistema di relazioni industriali, intendendo con questo
termine l’assetto relazionale che consente la valorizzazione del capitale umano
potenziale degli individui (Fondazione Giacomo Brodolini, 1997) 27 . Oltre che dalla sua
intensità e dai servizi di capitale che ha a disposizione, la capacità produttiva che il
capitale umano raggiunge dipende in modo cruciale dalla qualità delle relazioni
interpersonali (individuali e collettive), negli ambienti di lavoro e altrove: diverse
culture, sistemi di valori e di incentivo, istituzioni e rapporti fiduciari determinano nelle
unità oggetto dell’analisi economica differenze nella capacità di applicare, promuovere
25
La sua definizione da parte di Abramovitz (1956) come “la misura della nostra ignoranza” resta ancora
la più appropriata.
26
Ne è testimone la moderazione salariale che ha caratterizzato un lungo periodo in cui quasi due terzi
del Paese si è trovato in pieno impiego.
27
Il concetto di beni relazionali viene qui proposto in termini più ristretti di quanto comunemente
avvenga nella letteratura sul tema del rapporto tra relazionalità e razionalità (si veda, ad esempio, il
volume curato da Sacco e Zamagni, 2002). In particolare, l’accezione qui accolta è direttamente mirata
agli esiti delle relazioni interpersonali non mediate dal mercato sui processi produttivi e distributivi.
Questo approccio, definito approfonditamente nel lavoro della Fondazione Brodolini citato nel testo,
prende spunto in larga misura dal fondamentale lavoro di Putnam (1993) sullo sviluppo economico di
lunghissimo periodo nelle regioni italiane.
32
e valorizzare le conoscenze e le abilità produttive. Sotto questo profilo, la produzione e
il consumo di beni relazionali caratteristici di ciascuna unità di analisi costituiscono un
aspetto fondamentale del suo potenziale di sviluppo. Sono infatti i beni relazionali a
consentire una rapida, economica e ampia trasmissione delle informazioni e delle
conoscenze, come anche a mantenere elevati i livelli di reputazione e di fiducia delle e
nelle unità economiche o ancora ad assicurare i necessari incentivi all’impegno
personale nell’utilizzo delle proprie competenze a favore del risultato collettivo. Di
conseguenza, un insieme di unità caratterizzato da una sufficiente produzione di beni
relazionali è in grado di allocare e interconnettere il capitale umano (e, quindi, di gestire
conoscenze e competenze) in modo più produttivo, equo ed efficiente, e perciò stesso di
generare processi di crescita autopropulsivi. Mentre all’opposto, in un contesto povero
di beni relazionali, la semplice creazione di capitale umano potenziale attraverso la
disseminazione di conoscenze non è sufficiente ad assicurare la sua trasformazione in
capitale umano effettivo, e quindi a generare le spinte necessarie allo sviluppo.
Nel caso del passaggio alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(che innovano fortemente la relazionalità dei soggetti economici e quindi richiedono
anche l’innovazione della configurazione organizzativa delle imprese) poi, oltre al
tradizionale problema della carenza di beni relazionali in alcuni contesti territoriali, ci
troviamo di fronte al problema nuovo di gestire un vero e proprio “salto relazionale” (o
salto culturale nella relazionalità): il patrimonio relazionale tradizionale (modelli
organizzativi, gerarchie, canali di informazione e comunicazione, sistemi di incentivo,
livelli di responsabilità e di fiducia) viene “spiazzato” dalle innovazioni relazionali che
caratterizzano l’ICT e i mezzi di comunicazione di massa. Al sistema produttivo (e al
sistema delle relazioni industriali) si richiede di riorganizzarsi, a partire dalle unità
elementari (i luoghi di lavoro o workplaces), in modo da utilizzare al meglio le
potenzialità relazionali offerte dalle nuove tecnologie grazie all’introduzione di modelli
organizzativi innovativi finalizzati alla creazione di rapporti di lavoro high trust-high
performance (Marsden, 1996).
La letteratura scientifica sull’argomento28 segnala infatti, in modo sempre più
convergente e convincente, che l’andamento della produttività dei luoghi di lavoro
deriva in modo significativo e complementare da tre diversi fattori: le nuove tecnologie,
i disegni organizzativi e le nuove pratiche di lavoro ad alta performance. I tre fattori
sono tra loro collegati da una ricca rete di interazioni, al punto che l’effetto dei
cambiamenti introdotti in uno risulta significativo solo in presenza di contemporanei
adattamenti anche negli altri. In altri termini, le nuove tecnologie possono dare i risultati
sperati solo se la loro introduzione viene accompagnata da una parallela trasformazione
organizzativa dell’impresa e da una riorganizzazione dei rapporti di lavoro. La
trasformazione organizzativa e i nuovi rapporti di lavoro devono essere tali da
28
Tra gli ormai numerosissimi contributi, si segnalano quelli di Ichniowski (2000), Caroli-Van Reenen
(2001), Bauer (2003), Brynjolfsson-Hitt (2003), Roberts (2004), Black-Lynch (2004), Jensen-Vinding
(2006) e la ricca produzione di B.-Å. Lundvall sulla learning economy e le learning organizations. Tra gli
studi italiani rimando a Tronti (1997, 2003), Leoni-Cristini-Mazzoni-Labory (2000), Bugamelli-Pagano
P. (2001), Trento-Warglien (2001), Cainelli-Fabbri-Pini (2001), Colombo-Delmastro (2002), CristiniGay-Labory-Leoni (2003), Pini (2004), Leoni (2006), Colombo-Delmastro-Rabbiosi (2007), Leoni
(2008). Infine, segnalo alcuni importanti lavori di carattere istituzionale: U.S. Department of Labor
(1994), European Commission (1997), U.K. Department of Trade and Industry (2006), Ministero del
lavoro finlandese (2007), Alasoini (2008).
33
incentivare i lavoratori a sfruttare appieno le potenzialità di comunicazione,
informazione, accumulazione e trasmissione della conoscenza, e innovazione delle
nuove tecnologie. In caso contrario queste sono poco e male utilizzate, e si dimostrano
insufficienti a promuovere il decollo della produttività.
L’aggiustamento strutturale delle imprese richiede che esse si trasformino in learning
organisations: imprese capaci di apprendere dal proprio stesso operato – e anzi di
riservare all’apprendimento (organizzativo e produttivo) nel corso del normale
svolgimento del lavoro l’attenzione e lo spazio necessari a innestare nel seno stesso
della quotidiana attività nel luogo di lavoro un clima di miglioramento continuo di
prodotti e processi. Sotto questo profilo, le imprese non possono limitarsi a promuovere
l’accumulazione delle competenze dei dipendenti, ma debbono assicurare la creazione
di nuovi beni relazionali, ovvero di incentivi ai rapporti interpersonali di cooperazione e
scambio mirati alla massimizzazione dell’apprendimento, della capacità di innovare e
della disponibilità all’innovazione dei lavoratori stessi29 . All’opposto, il venir meno del
bene relazionale fondamentale dell’economia, costituito dal premio della cooperazione
sociale per la crescita, costituisce un risultato evidentemente perverso, che erode le basi
di reciproca fiducia tra lavoratori e imprese necessarie per un’effettiva partnership
sociale.
6. Per la produttività e la crescita. Scambio politico e patto sociale
L’analisi delle cause dell’arresto della produttività dell’economia italiana, condotta sulla
base delle dinamiche delle variabili chiamate in causa dal modello di Sylos Labini, ci ha
consentito di comporre un quadro ampio e dettagliato dei problemi dell’economia
italiana e di intravedere il cammino necessario per risolverli. L’Italia ha perduto molto
terreno rispetto ai partner internazionali e si è impoverita al punto che oggi la ripresa
della produttività e il ritorno alla crescita, a tassi superiori a quelli dell’Unione Europea,
sono diventati una priorità generale, di portata storica. La “questione produttività” è
oggi il problema economico, e ha incalcolabili ricadute di natura politica e sociale. Solo
risolvendolo il Paese potrà tornare a condividere il livello di vita dei grandi paesi
europei, abbattere il debito pubblico a dimensioni accettabili, portare a compimento il
disegno del sistema di welfare, avviare una nuova fase di benessere e sicurezza sociale
per tutti. Purtroppo però, nonostante la sua gravità e persistenza, la questione
produttività non è ancora accettata e affrontata liberamente dal sistema delle relazioni
industriali per il rilievo che essa realmente ha. Valga per tutti l’esempio della trattativa
minimalista e priva di visione strategica tra Confindustria e sindacato confederale sul
rinnovamento del modello contrattuale. Questa situazione di soffocante occultamento ha
spinto alcuni economisti a lanciare (e non pochi altri a sottoscrivere) il manifesto Per un
29
Tra i beni relazionali adeguati al nuovo contesto tecnologico e all’obiettivo di costruire rapporti di
lavoro high trust-high performance, si segnalano: la riduzione delle gerarchie (secondo il modello
organizzativo della produzione snella), l’organizzazione dell’impresa per processi anziché per funzioni
(con una chiara indicazione della responsabilità per tutti i processi), l’accumulazione e la condivisione
della conoscenza nella pratica di lavoro quotidiana, l’informazione e la comunicazione bidirezionale, il
lavoro di squadra, con autonomia, accountability e problem-solving affidati alla squadra stessa, la
valutazione regolare della performance, la rotazione delle mansioni, i suggerimenti dal basso ecc.
34
nuovo patto sociale per la produttività e la crescita 30 . L’ipotesi alla base del manifesto
è che si debba presentare al Paese e alle parti sociali un grande obiettivo comune – la
ripresa della produttività e della crescita – e chiedere a queste di dar vita a una social
partnership semplice ed efficiente per il conseguimento di quell’obiettivo. Il documento
si colloca nell’ambito della ricerca delle misure di livello micro per migliorare la
performance produttiva delle imprese. Ma a livello macro la ripresa della crescita può
essere raggiunta solo attraverso il riequilibrio dello scambio politico perverso che
ancora blocca il sistema economico. I nuovi termini dello scambio debbono prevedere
l’accettazione da parte delle imprese (e dei lavoratori in esse impegnati) di misure di
effettiva liberalizzazione del mercato del prodotto, contro la disponibilità da parte del
sindacato ad assecondare l’innovazione per la riorganizzazione dei luoghi e dei rapporti
di lavoro, con i necessari investimenti da parte dell’impresa in cambiamenti tecnologici
e organizzativi. I frutti della riorganizzazione devono consentire un rallentamento dei
prezzi sotto la media dell’area euro e una crescita retributiva reale e diffusa, in linea con
la crescita della produttività del lavoro, preservando il bene relazionale della stabilità
della distribuzione primaria del reddito. Le retribuzioni reali debbono crescere perché,
oltre ad essere un costo per le imprese, esse sono non solo la principale componente dei
consumi delle famiglie, ma anche un fondamentale elemento di pungolo alle imprese sul
terreno dell’innovazione tecnologica e organizzativa. I partner sociali e il governo
devono assumere, implicitamente o esplicitamente, l’obiettivo della stabilità della
distribuzione primaria del reddito quale stimolo fondamentale alla cooperazione sociale
per la crescita: la distribuzione primaria del reddito non può essere affidata a un
meccanismo automatico, a un gioco a somma negativa che individua la normalità di
funzionamento nell’aumento della quota del capitale e l’unica possibilità di riequilibrio
nella caduta della produttività del lavoro.
L’ accumulazione delle rendite e la debolezza del rapporto tra profitti e investimenti
indicano che il livello della quota del capitale è, in Italia, eccessivo rispetto al “normale
funzionamento dell’economia” (cfr. Zenezini, 2004). Nelle attuali condizioni strutturali
dell’economia italiana, per ottenere un tasso di crescita superiore a quello europeo e
recuperare il posizionamento internazionale perduto, occorrerebbe un sostanziale
incremento della quota del lavoro, pari più di sei punti di pil. L’entità di questo recupero
è talmente elevata da renderlo impraticabile sotto il profilo sociale. L’esame delle
dinamiche dal 1993 ad oggi suggerisce però che ogni movimento delle quote
distributive va inquadrato in un processo di scambio politico equo e benefico per
l’intera collettività nazionale – uno scambio che veda il Governo e la parte datoriale
impegnati nella riqualificazione e nella riorganizzazione dei luoghi di lavoro e nel
contenimento dei prezzi, con il sostegno e l’attiva partecipazione del sindacato.
Questi obiettivi, è inutile nasconderlo, incontrano grandi resistenze. Anzitutto da parte
degli imprenditori che preferiscono accontentarsi degli utili presenti piuttosto che
investire risorse, ridurre e affinare le prerogative manageriali sull’organizzazione e
concedere autonomia, iniziativa e responsabilità ai lavoratori per impiantare modelli
organizzativi innovativi. E quindi, in particolare, da parte delle imprese protette dalla
concorrenza, che non vogliono rinunciare alle barriere di cui oggi godono e accettare i
30
Il manifesto, redatto da Nicola Acocella dell’Università di Roma “La Sapienza”, da Riccardo Leoni
dell’Università di Bergamo e da me nell’autunno del 2006, ed è consultabile sul sito
http://www.pattosociale.altervista.org/.
35
rischi della competizione aperta. Ma forti resistenze provengono anche dalla parte
sindacale che, nonostante la crisi della produttività, ha notevoli difficoltà ad entrare in
una logica di corresponsabilizzazione nella riorganizzazione dei luoghi di lavoro; come
pure a smantellare i privilegi di cui spesso godono i lavoratori nelle imprese protette. Il
caso dell’Alitalia è sotto gli occhi di tutti 31 .
Dal canto suo il governo, oltre a perseguire la liberalizzazione del mercato del prodotto
e l’abbattimento delle rendite oligopolistiche, deve assicurare la ricostituzione del bene
relazionale del premio alla cooperazione sociale per la crescita, stimolare la
riorganizzazione delle imprese e introdurre gli stessi cambiamenti organizzativi nella
pubblica amministrazione 32 . I conservatori diranno che la finanza pubblica è talmente in
difficoltà che l’Italia non può permettersi un programma di riforma del genere; ma si
sbagliano. Il cambiamento di rotta, ormai ineludibile, ha bisogno, in realtà, di risorse più
politiche che finanziarie. C’è anzitutto la necessità di una revisione degli obiettivi della
politica economica e di una funzionalizzazione degli strumenti che già esistono al
riequilibrio dello scambio politico. Non c’è bisogno di risorse aggiuntive, ma di
finalizzare con coerenza e determinazione al disegno dell’efficienza delle imprese e del
mercato del prodotto l’azione e le rilevanti risorse delle politiche industriali e formative
già operanti: dall’Autorità antitrust a Mister prezzi, da Italia lavoro al Dipartimento per
lo sviluppo, dagli Enti bilaterali ai Fondi interprofessionali, dall’Isfol ai fondi per la
Formazione continua, ecc.
Il nuovo modello contrattuale deve servire a lanciare una nuova fase di contrattazione
decentrata, dedicata allo sviluppo e all’incentivazione della produttività e della crescita
attraverso la reingegnerizzazione dei luoghi di lavoro e l’introduzione di rapporti di
lavoro ad alta performance, secondo linee definite nel quadro di un patto sociale ispirato
agli strumenti di potenziamento del lavoro propri delle imprese innovative. L’accordo
nazionale, di carattere generale, deve prevedere il disegno delle linee di rinnovamento.
Gli incentivi e i programmi di sostegno alle imprese (consulenza, formazione, assistenza
tecnica, sgravi contributivi) devono essere condizionati al fatto che venga sottoscritto
localmente, tra impresa e rappresentanze sindacali, un contratto in linea con il
protocollo nazionale. In altre parole, a livello centrale imprenditori, sindacati e governo
devono accordarsi sui principi, sugli strumenti e sulle risorse; mentre le singole imprese
e le rappresentanze aziendali, le categorie o le realtà territoriali devono accordarsi su
concreti programmi di riorganizzazione; e quindi devono poter accedere alle risorse
necessarie ad abbattere i costi della riorganizzazione e compensare le perdite derivanti
dalla durata della fase di entrata a regime dei miglioramenti.
L’esecutivo e le parti sociali, attraverso il Protocollo welfare varato dal governo
precedente, la trattativa tra confederazioni sindacali e Confindustria sulla riforma del
modello contrattuale, la conferma degli sgravi fiscali su straordinari e premi di risultato
e il varo di un’impegnativa campagna di riorganizzazione del settore pubblico da parte
del governo attuale, hanno lanciato alcuni segnali nella giusta direzione. Il principale,
per quanto ancora molto timido, è quello della necessità di tornare alle imprese, senza
31
Il problema delle resistenze imprenditoriali e sindacali nei settori protetti è giustamente richiamato
come fondamentale per il successo dell’aggiustamento strutturale dal citato lavoro di Blanchard e
Giavazzi (2003).
32
Qualche passo in quest’ultima direzione è stato fatto, con vigore. Ma non altrettanto può dirsi per le
altre direzioni, forse ancor più rilevanti.
36
colpevolizzazioni per il passato, ma con la certezza di dire addio all’idea palesemente
errata che le condizioni dello sviluppo si creino soltanto nel mercato del lavoro esterno,
fuori dei cancelli della fabbrica e delle porte dell’ufficio, e che l’impresa sia una scatola
nera che dà il meglio se lasciata a se stessa. Con le misure di incentivazione del salario
di risultato e con i punti ormai acquisiti di riforma del modello contrattuale, governo e
parti sociali segnalano (seppure senza parlare esplicitamente di riorganizzazione dei
luoghi di lavoro) di voler intraprendere una nuova fase negoziale, di estensione della
contrattazione decentrata.
Questi segnali non devono però far dimenticare che nell’azione di governo, come anche
nell’autonoma iniziativa delle parti sociali e dell’opposizione, non c’è ancora alcuna
seria presa di posizione né sulla necessità di porre termine alla crisi della produttività
riequilibrando lo scambio politico attraverso un rapporto virtuoso tra prezzi e salari, tra
mercato del lavoro e mercato del prodotto; né sul problema della riorganizzazione delle
imprese per potenziare il lavoro e la produttività. Il tema della reingegnerizzazione dei
luoghi di lavoro resta ancora implicito, inespresso e imbarazzante, mentre quello della
necessità di colpire le rendite e aprire alla concorrenza le aree protette, dopo i deboli
tentativi del precedente governo e il generoso ma limitato tentativo della Robin tax sulle
imprese petrolifere, è caduto anch’esso sotto silenzio. Infine, il parziale accordo tra
Confindustria e confederazioni sindacali sul nuovo modello contrattuale si presenta
ancora pervaso da una nefasta logica microeconomica e minimalista, in cui la
dimensione collettiva è vista solo nella richiesta all’erario di finanziare senza
contropartite gli sgravi per lo straordinario e i premi di risultato.
È giunto il momento che la cultura e l’opinione pubblica si ridestino dal loro torpore
mediatico e la politica e le parti sociali abbiano chiaro che bisogna fare di più: la
questione produttività è talmente grave che non è possibile uscirne soltanto con vaghi
riferimenti ai danni provocati dal “mercatismo” o dalla “mancanza di etica” della
finanza, con sommari rimedi finanziari alla crisi finanziaria internazionale e silenziose
misure di politica economica, di incentivazione fiscale/contributiva di comportamenti
più o meno virtuosi 33 . C’è bisogno di un grande sforzo comune, esplicito e prolungato
nella qualità dell’economia reale, di un salto della coscienza collettiva, di mobilitare
energie nuove e nuovi modi di lavorare, di risvegliare nel Paese così come nelle imprese
e nei luoghi di lavoro, lo spirito di appartenenza, di comunità, di soddisfare il bisogno di
cambiamento e di futuro. La mobilitazione, come è stato negli episodi cruciali della
storia del nostro sviluppo economico e sociale – dalla Ricostruzione al rientro
dell’inflazione a due cifre, sino all’aggancio all’euro – può avvenire soltanto attraverso
la sottoscrizione di un nuovo patto sociale, di uno scambio politico equo e lungimirante,
a somma positiva, capace di tornare a traguardare l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile
e condiviso, di varare un modo nuovo di lavorare e di crescere insieme che possa essere
compreso e fatto proprio da tutti.
33
L’incentivazione degli straordinari può forse aumentare il prodotto per occupato, certo non quello (ben
più importante) per ora lavorata.
37
Riferimenti bibliografici
Abramovitz, M. 1956, Resource and output trends in the United States since 1870, “American
Economic Review”, 46(2).
Acocella N., Leoni R. (eds.) 2006, “Social Pacts, Employment and Growth. A Reappraisal of
Ezio Tarantelli’s Thought”, Physika-Verlag, Heidelberg-New York.
Acocella N., Leoni R., Tronti L. 2006, Per un nuovo Patto Sociale sulla produttività e la
crescita, sul sito http://www.pattosociale.altervista.org/.
Alasoini T. 2008, The Finnish Workplace Development Programme TYKES in a Nutshell,
PowerPoint presentation.
Antonioli D., Delsoldato L., Mazzanti M., Pini P. 2007, “Dinamiche innovative, relazioni
industriali, performance nelle imprese manifatturiere”, Franco Angeli, Milano.
Bauer T.K. 2003, Flexible Workplace Practices and Labour Productivity, “IZA Discussion
Papers”, n. 700, Bonn.
Baumol W.J. 1967, Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis,
“American Economic Review”, Vol. 57, June.
Black S., Lynch L. 2004, What’s driving the new economy? The benefits of workplace
innovation, “Economic Journal”, no. 114.
Blanchard O. 2004, The economic future of Europe, “NBER Working Papers”, no. w10310.
Blanchard O., Giavazzi F. 2003, Macroeconomic effects of regulation and deregulation in
goods and labour markets, “Quarterly Journal of Economics”, no. 118 (3).
Boeri T., Faini R., Ichino A., Pisauro G., Scarpa C. (a cura di) 2005, “Oltre il declino”, il
Mulino, Bologna.
Brynjolfsson E., Hitt L.M. 2003, Computing Productivity: Firm-Level Evidence, in “Review of
Economics and Statistics”, November, v. 85, iss. 4.
Bugamelli M., Pagano P. 2001, Barriers to Investment in ICT, “Temi di Discussione”, Banca
d’Italia, n. 420.
Cainelli G., Fabbri R., Pini P. (a cura di) 2001, “Partecipazione all’impresa e flessibilità
retributiva in sistemi locali. Teorie, metodologie, risultati” Franco Angeli, Milano.
Caroli E., Van Reenen J. 2001, Skill-Biased Organizational Change? Evidence from a Panel of
British and French Establishments, in “The Quarterly Journal of Economics”, CXVI,
Issue 4.
Christensen J.L., Lundvall B.-Å. (eds.) 2004, “Product Innovation, Interactive Learning and
Economic Performance”, Elsevier, Amsterdam.
Ciampi C.A. 1996, “Un metodo per governare”, il Mulino, Bologna.
Ciocca P. 2006, ‘Doing good’. Ezio Tarantelli’s Approach to Political Economy, in: Acocella
N., Leoni R. (eds.), “Social Pacts, Employment and Growth. A Reappraisal of Ezio
Tarantelli’s Thought”, Physika-Verlag, Heidelberg-New York.
Colombo, M., Delmastro, M. 2002, The Determinants of Organizational Change and Structural
Inertia: Technological and Organizational Factors, in “Journal of Economics and
Management Strategy”, no. 11.
Colombo M.G., Delmastro M., Rabbiosi L. 2007, “High performance” work practices,
decentralization, and profitability: evidence from panel data, “Industrial and Corporate
Change”, vol. 16, no. 6.
Contini B., Trivellato U. (a cura di) (2006), “Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel
mercato del lavoro italiano”, il Mulino, Bologna.
38
Cristini A., Gay A., Labory S., Leoni R.. 2003, Flat hierarchical structure, bundles of new work
practices and firm performance, in “Rivista Italiana degli Economisti”, n. 2.
Daveri F. 2006, “Innovazione cercasi. Il problema italiano”, Laterza, Roma-Bari.
De Cecco M. 1972, Una interpretazione ricardiana della forza-lavoro in Italia, “Note
economiche”, no. 1.
European Commission 1997, Partnership for a new organization of work. Green Paper,
“Bulletin of the European Union – Supplement”, no. 4.
Fondazione Giacomo Brodolini 1997, Sviluppo economico e beni relazionali, “Economia &
lavoro”, n. 1-2.
Gallino L. 2003, “La scomparsa dell’Italia industriale”, Einaudi, Torino.
Gallino L. 2005, “L’impresa irresponsabile”, Einaudi, Torino.
Gallino L. 2006, “Italia in frantumi”, Laterza, Roma-Bari.
Griffith R., Harisson R. 2004, The link between product market reform and macro-economic
performance, “European Economy Economic Papers”, no. 209, August.
Ichniowski C. (ed.) 2000, “American Workplace: Skills, Compensation, and Employee
Involvement”, Cambridge University Press, New York.
Istat 2004, Crescita dell’occupazione e rallentamento della produttività del lavoro, in: Istat,
“Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2003”, Roma, cap. IV, par. 4.3.1.
Istat 2006a, Tempi di lavoro e valorizzazione delle competenze, in: Istat, “Rapporto Annuale. La
situazione del Paese nel 2005”, Rubbettino, Soveria Mannelli, cap. IV.
Istat 2006b, Stagnazione della produttività ed effetti di composizione settoriale, in Istat,
“Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2005”, Rubbettino, Soveria Mannelli,
cap. II.
Istat 2008a, Trasformazioni strutturali dell’economia italiana e produttività del lavoro, in Istat,
“Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2007”, Rubbettino, Soveria Mannelli,
cap. II, Approfondimento.
Istat 2008b, Analisi dei profili prevalenti di imprese, in Istat, “Rapporto Annuale. La situazione
del Paese nel 2007”, Rubbettino, Soveria Mannelli, cap. II, par. 2.3.2.
Jensen M.B., Vinding A.L. 2006, High Performance Work Practices and Innovation in the
Manufacturing and Service Sectors, “ServINNo Project” (Service innovation in the
Nordic countries), http://www.cfa.au.dk/SERVINNO/Servinno.htm.
Leoni R. (a cura di) 2006, “Competenze acquisite, competenze richieste e competenze espresse.
Analisi e valutazioni economiche”, Franco Angeli, Milano.
Leoni R. (a cura di) 2008, “Economia dell’innovazione. Disegni organizzativi, pratiche
lavorative e performance d’impresa”, Franco Angeli, Milano.
Leoni R., Cristini A., Mazzoni N., Labory S. 2000, Disegni Organizzativi, Stili di Management
e Performance d’Impresa. Risultati di un’indagine in un campione di imprese
industriali, “Monografia n.1”, Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli
Studi di Bergamo.
Lorenz E., Lundvall B.-Å. (eds.) 2006, “How Europe’s economies learn”, Oxford University
Press, Oxford.
Lundvall B.-Å. (ed.) 1992, “National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation
and Interactive Learning”, Pinter Publishers, London.
Lundvall B.-Å. 2002, “Growth, Innovation and Social Cohesion: The Danish model”, Elgar
Publisher, Cheltenham.
39
Lundvall B.-Å., Archibugi, D. 2001, “The Globalizing Learning Economy”, Oxford University
Press, New York.
Lundvall B.-Å., Conceição P., Heitor M.V. Innovation 2003, “Competence Building and Social
Cohesion in Europe”, Edward Elgar, Cheltenham.
Marsden D. 1996, Employment policy implications of new management systems, “Labour”,
10:1, Spring, pp 17-61.
Ministero del lavoro finlandese 2007, “The Finnish workplace development programme
(TYKES-FWDP)”, http://www.mol.fi/mol/en/01_ministry/05_tykes/index.jsp.
Mucchetti M. 2003, “Licenziare i padroni?”, Feltrinelli, Milano.
Oecd 2001, “Measuring Productivity. Measurement of Aggregate and Industry-Level
Productivity Growth”, Oecd, Paris.
Oulton N. 2001, Must the growth rate decline? Baumol's unbalanced growth revisited, “Oxford
Economic Papers”, October, 53(4), pp 605-27.
Penrose E. 1959, “The Theory of the Growth of the Firm”, Wiley, New York (trad. it.: “La
teoria dell’espansione dell’impresa”, Franco Angeli, Milano, 1973).
Pini P. (a cura di) 2004, “Innovazione, relazioni industriali e risultati d’impresa. Un’analisi per
il sistema industriale di Reggio Emilia”, Franco Angeli, Milano.
Putnam R. 1993, “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”, Princeton
University Press, Princeton (Mass.).
Roberts J. 2004, “The Modern Firm. Organizational design for performance and growth”,
Oxford University Press, New York (trad. it., “L’impresa moderna”, il Mulino,
Bologna, 2006).
Sacco P.L., Zamagni S. 2002, Complessità relazionale e comportamento economico. Materiali
per un nuovo paradigma di razionalità, il Mulino, Bologna.
Saltari E., Travaglini G. 2006, “Le radici del declino economico. Occupazione e produttività in
Italia nell’ultimo decennio”, UTET, Torino.
Sestini R., Tronti L. 2002, Escaping the stagnancy trap. Unbalanced growth and employment in
the services, in: Balducci R., Staffolani S. (eds.), “Income distribution, growth and
employment”, Esi, Napoli.
Shapiro C., Stiglitz J. 1984, Equilibrium unemployment as a worker discipline device,
“American Economic Review”, June.
Sylos Labini P. 1984, “Le forze dello sviluppo e del declino”, Laterza, Roma-Bari.
Sylos Labini P. 2004, “Torniamo ai classici”, Laterza, Roma-Bari.
Tarantelli E. 1970, Produttività del lavoro, salari e inflazione, “Quaderni di Ricerche L.
Einaudi”, Roma, ora in Tarantelli E. 1988, “L’utopia dei deboli è la paura dei forti.
Saggi, relazioni e altri scritti accademici”, a cura di Filosa R., Rey G.M., Franco Angeli,
Milano.
Tarantelli E. 1974, “Studi di economia del lavoro”, Giuffrè, Milano.
Tarantelli E. 1995, “La forza delle idee. Scritti di economia e politica”, a cura di Chiarini B.,
Laterza, Roma-Bari.
Trento S., Warglien M. 2001, Nuove tecnologie e cambiamenti organizzativi:alcune
implicazioni per le imprese, “Temi di discussione”, Banca d’Italia, n. 428.
Tronti L. (a cura di) 1997, “Ristrutturazione industriale e struttura verticale dell’impresa”,
Franco Angeli, Milano.
Tronti L. 2003, Capitale umano e nuova economia. Riorganizzazione dei sistemi formativi e
sviluppo dei mercati delle conoscenze, “Lavori diritti mercati”, n. 1.
40
Tronti L. 2005a, Europa-Usa: modelli occupazionali a confronto, “La Rivista delle Politiche
Sociali”, n. 3.
Tronti L. 2005b, Protocollo di luglio e crescita economica: l’occasione perduta, “Rivista
internazionale di scienze sociali”, n. 2.
Tronti L. 2006, The July Protocol and Economic Growth: The Chance Missed, in: Acocella N.,
Leoni R. (eds.), “Social Pacts, Employment and Growth. A Reappraisal of Ezio
Tarantelli’s Thought”, Physika-Verlag, Heidelberg-New York.
Tronti L. 2008, Distribuzione del reddito, produttività del lavoro e crescita: il ruolo della
contrattazione decentrata, in “Rivista italiana di economia, demografia e statistica”,
vol. LXI, nn. 3-4/2007, in corso di pubblicazione.
U.K. Department of Trade and Industry 2006, “Achieving Best Practice in Your Business. High
Performance Work Practices: linking strategy and skills to performance outcomes”.
U.S. Department of Labor 1994, “Working Together for Public Services”,
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/worktogether/toc.htm.
Zenezini M. 2004, Il problema salariale in Italia, “Economia & lavoro”, n. 2.
41