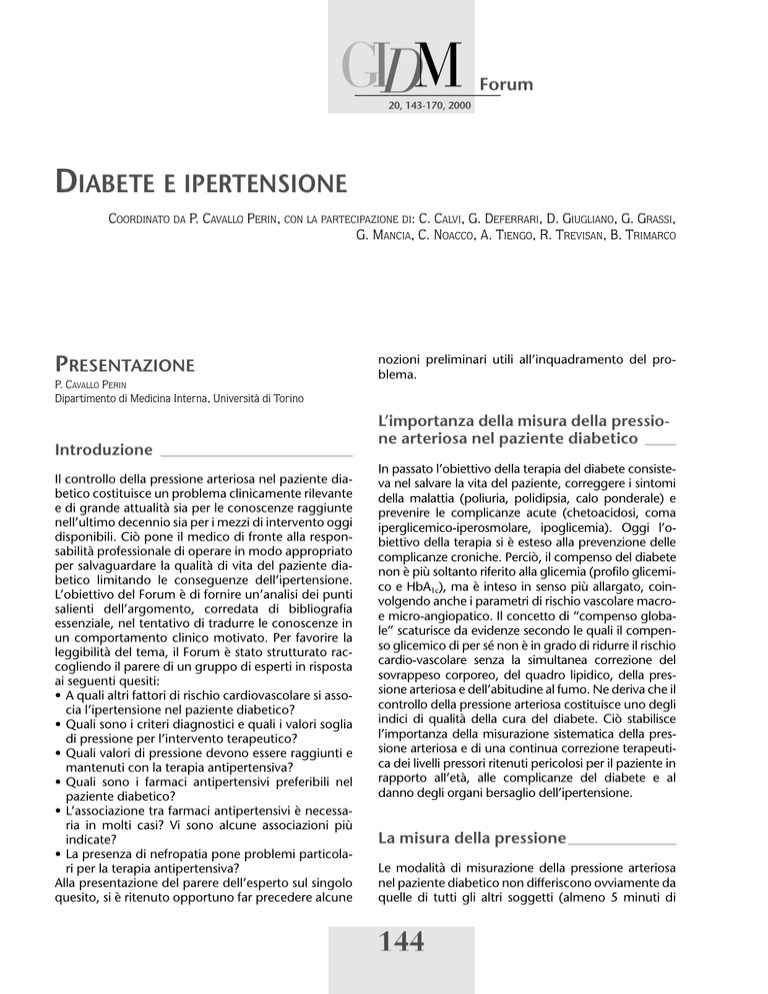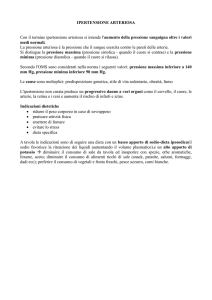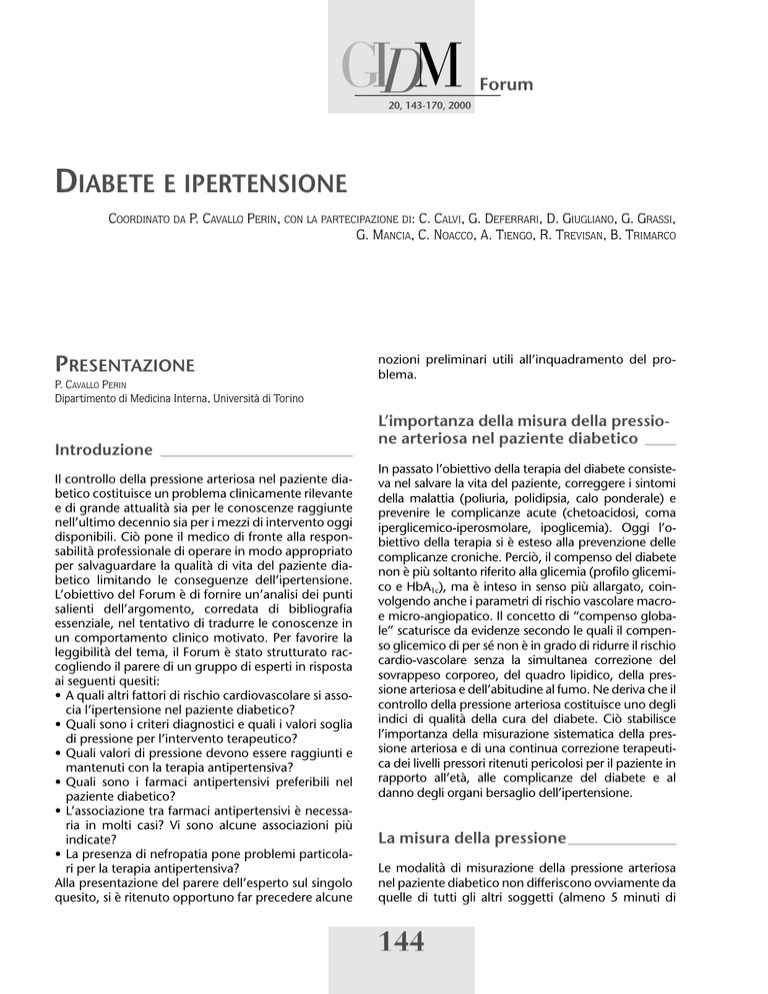
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
DIABETE E IPERTENSIONE
COORDINATO DA P. CAVALLO PERIN, CON LA PARTECIPAZIONE DI: C. CALVI, G. DEFERRARI, D. GIUGLIANO, G. GRASSI,
G. MANCIA, C. NOACCO, A. TIENGO, R. TREVISAN, B. TRIMARCO
PRESENTAZIONE
P. CAVALLO PERIN
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Torino
Introduzione
Il controllo della pressione arteriosa nel paziente diabetico costituisce un problema clinicamente rilevante
e di grande attualità sia per le conoscenze raggiunte
nell’ultimo decennio sia per i mezzi di intervento oggi
disponibili. Ciò pone il medico di fronte alla responsabilità professionale di operare in modo appropriato
per salvaguardare la qualità di vita del paziente diabetico limitando le conseguenze dell’ipertensione.
L’obiettivo del Forum è di fornire un’analisi dei punti
salienti dell’argomento, corredata di bibliografia
essenziale, nel tentativo di tradurre le conoscenze in
un comportamento clinico motivato. Per favorire la
leggibilità del tema, il Forum è stato strutturato raccogliendo il parere di un gruppo di esperti in risposta
ai seguenti quesiti:
• A quali altri fattori di rischio cardiovascolare si associa l’ipertensione nel paziente diabetico?
• Quali sono i criteri diagnostici e quali i valori soglia
di pressione per l’intervento terapeutico?
• Quali valori di pressione devono essere raggiunti e
mantenuti con la terapia antipertensiva?
• Quali sono i farmaci antipertensivi preferibili nel
paziente diabetico?
• L’associazione tra farmaci antipertensivi è necessaria in molti casi? Vi sono alcune associazioni più
indicate?
• La presenza di nefropatia pone problemi particolari per la terapia antipertensiva?
Alla presentazione del parere dell’esperto sul singolo
quesito, si è ritenuto opportuno far precedere alcune
nozioni preliminari utili all’inquadramento del problema.
L’importanza della misura della pressione arteriosa nel paziente diabetico
In passato l’obiettivo della terapia del diabete consisteva nel salvare la vita del paziente, correggere i sintomi
della malattia (poliuria, polidipsia, calo ponderale) e
prevenire le complicanze acute (chetoacidosi, coma
iperglicemico-iperosmolare, ipoglicemia). Oggi l’obiettivo della terapia si è esteso alla prevenzione delle
complicanze croniche. Perciò, il compenso del diabete
non è più soltanto riferito alla glicemia (profilo glicemico e HbA1c), ma è inteso in senso più allargato, coinvolgendo anche i parametri di rischio vascolare macroe micro-angiopatico. Il concetto di “compenso globale” scaturisce da evidenze secondo le quali il compenso glicemico di per sé non è in grado di ridurre il rischio
cardio-vascolare senza la simultanea correzione del
sovrappeso corporeo, del quadro lipidico, della pressione arteriosa e dell’abitudine al fumo. Ne deriva che il
controllo della pressione arteriosa costituisce uno degli
indici di qualità della cura del diabete. Ciò stabilisce
l’importanza della misurazione sistematica della pressione arteriosa e di una continua correzione terapeutica dei livelli pressori ritenuti pericolosi per il paziente in
rapporto all’età, alle complicanze del diabete e al
danno degli organi bersaglio dell’ipertensione.
La misura della pressione
Le modalità di misurazione della pressione arteriosa
nel paziente diabetico non differiscono ovviamente da
quelle di tutti gli altri soggetti (almeno 5 minuti di
144
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
riposo, arto superiore appoggiato, parte centrale dell’avambraccio all’altezza del cuore, misurazioni ripetute in più di 2 occasioni diverse per la diagnosi ecc.). È
tuttavia importante tenere presenti tre considerazioni:
a) la maggior parte dei pazienti con diabete di tipo 2
(60-70%) presenta sovrappeso o obesità con risultante aumento della circonferenza del braccio; b) la
macroangiopatia diabetica può determinare stenosi
arteriose a livello dei tronchi sopra-aortici su base aterosclerotica con risultanti valori di pressione arteriosa
diversi tra le due braccia; c) la neuropatia diabetica
autonomica può causare ipotensione ortostatica. Ne
deriva l’importanza: 1) di utilizzare bracciali di misura
appropriata per evitare errori di sovrastima; 2) di misurare la pressione arteriosa inizialmente su entrambe le
braccia per poter prendere in considerazione il valore
più elevato e controllarlo successivamente sullo stesso
braccio; 3) di procedere alla misurazione sia in clinoche in ortostatismo per svelare una eventuale ipotensione posturale da neuropatia autonomica. La presenza di ipotensione ortostatica assume rilevanza anche
ai fini della terapia: inizio del trattamento farmacologico, scelta appropriata dei farmaci antipertensivi,
livelli ai quali mantenere la pressione arteriosa.
L’ipertensione nelle varie forme
di diabete
A parte le forme di diabete associato a particolari condizioni o sindromi, in cui talora è presente una forma
di ipertensione secondaria, le caratteristiche cliniche
dell’ipertensione essenziale variano notevolmente tra
il diabete tipo 1 e il diabete tipo 2.
• Nel diabete tipo 1
1. L’ipertensione è assente alla diagnosi di diabete
2. Lo sviluppo di ipertensione è correlato all’insorgenza della nefropatia
3. La pressione sistolica e quella diastolica aumentano proporzionalmente
4. L’ipertensione accelera notevolmente la progressione della nefropatia
• Nel diabete tipo 2
1. L’ipertensione è di comune riscontro alla diagnosi
di diabete
2. L’ipertensione è correlata con il grado di obesità e
con l’età
3. La pressione sistolica aumenta in misura maggiore
rispetto alla pressione diastolica
4. L’ipertensione è scarsamente correlata con la presenza di nefropatia
La patogenesi dell’ipertensione
nel diabete
La patogenesi dell’associazione tra ipertensione e diabete non è ancora completamente chiarita. Si ritiene
che diversi meccanismi di alterato controllo possano
essere in misura diversa responsabili dell’elevazione
dei valori pressori e anche della difficoltà della loro
correzione terapeutica. I principali sono elencati di
seguito:
Fattori di regolazione della pressione arteriosa nel
paziente diabetico
Fattori genetici
Disfunzione endoteliale
Pool del sodio scambiabile
Catecolamine plasmatiche
Ipertono simpatico
Attività reninica plasmatica
Aldosterone plasmatico
Sensibilità barorecettoriale
Compliance arteriosa
Resistenze arteriolari
Risposta agli stimoli
pressori
Aumentata escrezione
urinaria di albumina
Adiposità addominale/
viscerale
Insulino-resistenza
Trasporto cationico
transmembrana
multifattoriali
spesso presente
di solito aumentato
normali
spesso presente
normale o bassa
normale o basso
ridotta
ridotta
aumentate
aumentata
spesso presente
aumentata nel diabete
tipo 2
presente nel diabete
tipo 2 e nel tipo 1 con
microalbuminuria
aumentato
controtrasporto
sodio-idrogeno
Come risulta dalla frammentarietà delle alterazioni
sopra elencate, non è possibile proporre un modello
unificato per illustrare la patogenesi dell’ipertensione
nel diabete. Ciò è facilmente comprensibile data l’eterogeneità fisiopatologica presente sia nel diabete
sia nell’ipertensione essenziale. Provvisoriamente, si
può ipotizzare che, in presenza di una predisposizione genetica all’ipertensione, le alterazioni metaboliche e/o emodinamiche presenti nel diabete possano
determinare l’aumentata penetranza del fenotipo
ipertensione negli individui diabetici.
145
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
Epidemiologia dell’ipertensione
nel diabete
La prevalenza dell’ipertensione è del 25% nella popolazione adulta, in cui rappresenta il fattore di rischio
cardiovascolare più comune. L’ipertensione aumenta
il rischio cardiovascolare di 2-3 volte ed è responsabile del 35% di tutti gli eventi cardiovascolari.
La prevalenza del diabete è del 4-7% per il diabete
tipo 2 e dello 0,1% per il diabete tipo 1, ma la prevalenza di entrambe le forme è in aumento. Nel diabete tipo 2 l’aterosclerosi rappresenta la prima causa di
morte e circa il 50% dei pazienti con infarto miocardico è diabetico. Il diabete tipo 2 presenta un rischio
cardiovascolare circa doppio rispetto alla popolazione non diabetica.
L’associazione tra diabete e ipertensione è molto frequente. La prevalenza dell’ipertensione è circa doppia nei diabetici rispetto alla popolazione generale:
circa il 40% dei pazienti con diabete tipo 1 e circa il
60% di quelli con diabete tipo 2 sviluppano ipertensione nel corso della malattia. Nei pazienti con ipertensione arteriosa la prevalenza del diabete risulta
aumentata rispetto ai soggetti normotesi: 6,3% vs
4,3% negli uomini e 6,4% vs 2,1% nelle donne. La
prevalenza dei soggetti affetti da diabete e ipertensione nella popolazione generale è stata stimata del
3-4% e la compresenza delle due patologie si associa
a un rischio cardiovascolare 4 volte superiore a quello dei soggetti esenti dalle due affezioni. I pazienti
diabetici con ipertensione arteriosa presentano un’incidenza (numero di nuovi eventi in un dato intervallo) di episodi cardiovascolari superiore al 4% per
anno, vale a dire un’incidenza cumulativa del 40% in
10 anni. La presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare (obesità, dislipidemia, fumo) produce un
effetto moltiplicativo sul rischio cardiovascolare. Ne
deriva l’importanza di valutare nel singolo paziente il
“rischio cardiovascolare assoluto” non solo ai fini prognostici ma soprattutto per stabilire l’intervento terapeutico più adeguato per prevenire l’insorgenza o
rallentare l’evoluzione delle complicanze.
Rischio cardiovascolare nel diabetico
iperteso
Gli studi epidemiologici dimostrano una correlazione
positiva indipendente e continua tra valori pressori ed
eventi cardiovascolari, senza evidenziare un valore
soglia al di sotto del quale venga meno il rapporto tra
valori pressori ed eventi. Inoltre, la relazione tra pres-
sione arteriosa e rischio cardiovascolare è proporzionalmente simile nella popolazione diabetica e nondiabetica: nei pazienti diabetici ogni grado di incremento pressorio si associa allo stesso incremento proporzionale del rischio dei soggetti non diabetici, ma
parte da un livello basale più elevato.
• Cardiopatia ischemica. La prevalenza della cardiopatia ischemica nel diabete tipo 2 risulta molto elevata (40-50%) e nel 50-70% dei casi ne costituisce
la causa di morte. Il rischio di infarto miocardico nel
paziente diabetico è pari al 20% nell’arco di 7 anni
e risulta del tutto sovrapponibile a quello di recidiva dell’evento nella popolazione non diabetica già
colpita da un infarto in precedenza. I dati disponibili per il diabete tipo 1 indicano un rischio relativo
di cardiopatia ischemica paragonabile a quello del
diabete tipo 2: la mortalità per eventi coronarici
raggiunge il 35% prima dei 55 anni di età in confronto al 4-8% nella popolazione non diabetica.
Anche il decorso della fase acuta e post-acuta successiva all’infarto miocardico risulta più sfavorevole, configurando una prognosi peggiore nel paziente diabetico: si registra un eccesso di mortalità del
38% negli uomini e dell’86% nelle donne, con una
mortalità totale entro il primo anno del 44% negli
uomini e del 37% nelle donne. La prevalenza dell’ischemia miocardica silente nel paziente diabetico
risulta 3 volte più elevata rispetto a quella della
popolazione generale, attestandosi su valori del 612%.
• Ictus. Il rischio di ictus nel paziente diabetico risulta doppio rispetto alla popolazione non diabetica
ed è responsabile del 15% della mortalità totale. In
presenza di diabete e ipertensione il rischio relativo
di ictus e TIA raggiunge il valore di 3-6 volte rispetto alla popolazione esente da diabete e ipertensione. Come nel soggetto non diabetico anche nel
paziente diabetico l’ictus ischemico rappresenta la
forma largamente più frequente rispetto all’ictus
emorragico. La prognosi risulta più sfavorevole nel
paziente diabetico: la sopravvivenza a 5 anni è del
20% nel paziente diabetico rispetto al 40% nel soggetto non diabetico; la frequenza delle recidive è
del 24% nei pazienti diabetici e del 7% nei soggetti non diabetici.
• Scompenso cardiaco. Nel soggetto iperteso non
diabetico il rischio relativo di sviluppare scompenso
cardiaco è pari a 4,0 nei maschi e 2,1 nelle femmine. Nel paziente diabetico il rischio è fino a 2,5
volte più elevato rispetto alla popolazione non diabetica e l’ipertensione è considerata responsabile
dello scompenso cardiaco nel 30-40% dei casi.
Nello studio UKPDS il rischio assoluto di scompen-
146
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
so cardiaco è risultato di 3 eventi/1000 pazienti/anno. A parità di livelli di pressione arteriosa, la
prevalenza di ipertrofia ventricolare sinistra risulta
doppia nei pazienti diabetici ipertesi rispetto ai
pazienti non diabetici ipertesi (72% vs 32%).
Questo dato è rilevante in quanto l’incidenza di
scompenso cardiaco aumenta di circa 8 volte in
presenza di ipertrofia ventricolare sinistra. Nella
storia naturale della cardiopatia ipertensiva del
paziente diabetico iperteso, la disfunzione diastolica compare in modo anticipato rispetto alla disfunzione sistolica; in particolare, è stato osservato che
la disfunzione diastolica è documentabile nel
paziente iperteso con alterata tolleranza al glucosio
anche in assenza di ipertrofia ventricolare sinistra.
• Arteriopatia periferica. Nell’iperteso non diabetico
il rischio relativo di arteriopatia periferica è di 2,0
negli uomini e 3,7 nelle donne. I pazienti diabetici
presentano un rischio di amputazione degli arti inferiori 10-15 volte superiore a quello dei non diabetici,
con un’incidenza annuale variabile tra 3 e 18/1000.
È stata documentata una correlazione positiva tra
pressione sistolica e arteriopatia agli arti inferiori,
particolarmente evidente nel diabetico anziano.
Ipertensione arteriosa e complicanze
microangiopatiche
Oltre all’associazione con il rischio cardiovascolare,
l’ipertensione costituisce insieme all’iperglicemia un
determinante maggiore della microangiopatia. È
stato infatti documentato che livelli pressori elevati,
anche nell’ambito della normotensione, sono in
grado di favorire l’insorgenza e/o di accelerare l’evoluzione sia della retinopatia che della nefropatia,
mentre non sembrano influenzare la neuropatia diabetica. In particolare, l’evoluzione della retinopatia e
della nefropatia è sfavorevolmente influenzata da
valori crescenti della pressione arteriosa, senza che sia
possibile individuare un valore soglia di rischio.
Accanto agli studi osservazionali, gli studi di intervento hanno documentato che la riduzione dei livelli di
pressione arteriosa risulta protettiva sull’evoluzione
del danno retinico e renale.
Terapie non farmacologiche
nell’ipertensione del diabetico
Il trattamento antipertensivo si avvale non solo di farmaci, ma anche di modificazioni dello stile di vita, le
quali devono essere realizzate in fase iniziale e mantenute successivamente durante la terapia farmacologica.
• Dieta. La correzione del sovrappeso risulta efficace
a migliorare il compenso globale del paziente diabetico. Infatti, la correzione anche parziale del
sovrappeso è in grado di ridurre l’insulino-resistenza, la pressione arteriosa, i valori glicemici e lipidemici. La riduzione dell’apporto di sodio, combinata
con la restrizione calorica, produce un effetto antipertensivo additivo. Ciò dipenderebbe dal fatto che
la riduzione del sodio riduce la reattività vascolare,
mentre il calo ponderale riduce la volemia, il ritorno
venoso, la portata cardiaca e l’ipertono simpatico. È
perciò indispensabile un’informazione continua del
paziente, richiamando nel tempo la sua attenzione
sull’importanza della riduzione dell’apporto calorico. Nel paziente con escrezione urinaria di albumina aumentata è opportuno ridurre l’apporto proteico entro 0,8-1 g/kg/die (microalbuminuria) o
< 0,8 g/kg/die (macroalbuminuria), dando la preferenza all’uso di proteine di origine vegetale. Ciò
nell’intento di ritardare la progressione verso l’insufficienza renale, sebbene non vi siano ancora
prove definitive di efficacia in proposito. La risposta
pressoria all’introito di sodio è variabile e solo il
50% dei pazienti ipertesi è “sodio-sensibile”.
Tuttavia, poiché i pazienti sodio-sensibili non sono
facilmente identificabili e una moderata restrizione
sodica (6 g/die di cloruro di sodio o 2,3 g/die di
sodio) non produce alcun danno, questa dovrebbe
essere prescritta a tutti i pazienti diabetici in cui sia
necessario ridurre la pressione arteriosa. Un eccessivo consumo di alcool si associa a un’aumentata
prevalenza di ipertensione, ma un moderato
apporto comporta un più ridotto rischio coronarico
rispetto all’astinenza totale. Sembra perciò appropriato consigliare un apporto di etanolo non superiore a 30 g/die (ad es. 200-300 mL di vino oppure
500-600 mL di birra) e invitare all’astensione totale
solo nei rari casi in cui l’effetto pressorio si mantenga anche per tali dosi. Sebbene acutamente l’assunzione di caffeina induca un aumento della pressione arteriosa, il consumo cronico di caffè non si
accompagna a un significativo aumento della pressione arteriosa. La proscrizione assoluta del consumo di caffè rappresenta pertanto un provvedimento ingiustificato, mentre l’assunzione di 2-3 tazzine
di caffè al giorno non costituisce alcun rischio nel
paziente con questa abitudine.
• Attività fisica. L’esercizio fisico moderato, regolare,
aerobico, isotonico (non anaerobico-isometrico!),
non è pericoloso e può migliorare i valori pressori,
147
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
glicemici e lipidemici. Se sono sedentari, tali
pazienti devono perciò essere incoraggiati a compiere ad esempio 3-4 km al giorno a passo di marcia oppure 40 minuti di bicicletta in pianura (o di
cyclette in casa) almeno 3 volte alla settimana. Tale
programma migliora l’efficacia della restrizione
calorica, riducendo l’insulino-resistenza e la pressione arteriosa.
• Abolizione del fumo. Sebbene il fumo di sigaretta
aumenti acutamente la pressione arteriosa, nel
tempo si sviluppa tolleranza agli effetti emodinamici della nicotina, cosicché cronicamente l’abitudine al fumo non si associa a livelli di pressione più
elevati o a una più elevata prevalenza di ipertensione. Tuttavia, il fumo è un importante fattore di
rischio cardiovascolare indipendentemente dagli
effetti sulla pressione arteriosa. Perciò tutti i
pazienti diabetici ipertesi dovrebbero essere fermamente e ripetutamente convinti a smettere di
fumare, poiché questa misura rappresenta uno
strumento efficace per ridurre il rischio cardiovascolare.
Bibliografia
American Diabetes Association: Treatment of hypertension
in diabetes (Consensus Statement). Diabetes Care 16,
1394-1401, 1993
American Diabetes Association: Standards of medical care
for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 23 (suppl
1), S32-S42, 2000
Estacio RO, Jeffers BW, Gifford N, Schrier RW: Effect of
blood pressure control on diabetic microvascular complications in patients with hypertension and type 2 diabetes.
Diabetes Care 23 (suppl. 2), B24-B64, 2000
Grossman E, Messerli FH: Diabetic and hypertensive heart
disease. Ann Intern Med 125, 304-310, 1996
Kannel WB: Vital epidemiologic clues in heart failure. J Clin
Epidemiol 53, 229-235, 2000
Mogensen CE: Microalbuminuria, blood pressure and diabetic renal disease: origin and development of ideas.
Diabetologia 42, 286-291, 1999
The sixth Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure (JNC VI). Arch Intern Med 157, 2413-2446,
1997
UK Prospective Diabetes Study Group: Tight blood pressure control and risk of macrovascular complications in type 2
diabetes (UKPDS 38). BMJ 317, 703-713, 1998
UK Prospective Diabetes Study Group: Efficacy of atenolol
and captopril in reducing the risk of macrovascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 39). BMJ 317, 713-720,
1998
A QUALI ALTRI FATTORI
DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
SI ASSOCIA L’IPERTENSIONE
NEL PAZIENTE DIABETICO?
C. NOACCO
Unità di Diabetologia, Ospedale di Udine
La ricerca epidemiologica nel campo dell’ipertensione ha riconosciuto che l’elevazione della pressione
arteriosa (PA), sia sistolica (PAS) che diastolica (PAD),
è un fattore di rischio comune e significativo di tutte
le maggiori malattie cardiovascolari: malattia coronarica ischemica, ictus, arteriopatia periferica e scompenso cardiaco.
L’ipertensione si presenta tuttavia in forma isolata in
non più del 20% dei casi, mentre è spesso associata
ad altri fattori di rischio cardiovascolare. Il diabete e la
ridotta tolleranza al glucosio, l’obesità, l’ipertrofia
ventricolare, le dislipidemie sono i principali fattori di
rischio cardiovascolare ai quali l’ipertensione è associata.
L’associazione dell’ipertensione con due o più di questi fattori di rischio si verifica con una frequenza 4
volte superiore a quanto ci si potrebbe aspettare se
l’associazione fosse casuale. Tale aumentata associazione è riconducibile, almeno nella maggior parte dei
casi, alla condizione di insulino-resistenza, genetica
e/o acquisita, e al conseguente iperinsulinismo, del
quale l’obesità, e l’obesità addominale in particolare,
è uno dei fattori causali.
Lo studio di Framhingam ha calcolato che la prevalenza della sindrome da insulino-resistenza nella
popolazione generale potrebbe essere di 22% nel
sesso maschile e di 27% in quello femminile. Inoltre,
nei soggetti ipertesi, solo il 14% degli eventi coronarici nell’uomo e il 5% nelle donne si verificano in
assenza di fattori di rischio addizionali, mentre il 40%
degli eventi nei maschi e il 68% nelle donne possono
essere attribuiti alla presenza di due o più fattori di
rischio addizionali (1).
È quindi evidente che diventa importante, in particolare nei soggetti diabetici, procedere a una stratificazione del rischio cardiovascolare e individuare quali
possano essere i fattori di rischio aggiuntivi; in altre
parole di quanto aumenti il rischio cardiovascolare
nel soggetto iperteso per il fatto che egli sia o diventi
diabetico e quali altri fattori di rischio si associno nel
diabetico all’iperglicemia, che comunque definisce e
caratterizza il diabete mellito.
148
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
Diabete e ipertensione
L’iperglicemia è nota essere di per sé un fattore di
rischio cardiovascolare. L’incidenza della malattia
coronarica è 50% più elevata nei maschi diabetici e
200% nelle donne diabetiche rispetto ai soggetti non
diabetici; nelle donne diabetiche viene inoltre a mancare la protezione da eventi cardiovascolari rappresentata dal sesso. L’impatto dell’iperglicemia sulle
sequele cardiovascolari è maggiore in termini di
rischio relativo (RR) sull’arteriopatia periferica e sullo
scompenso cardiaco, ma la malattia coronarica è in
termini assoluti la più importante e l’unica in cui viene
quasi annullata la differenza tra i sessi.
Quando al diabete si associano l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e il fumo di sigaretta, la mortalità cardiovascolare rispetto a soggetti non diabetici, ma con
gli stessi fattori di rischio, aumenta in maniera quasi
esponenziale: il MRFIT ha calcolato che il RR di un
soggetto diabetico per morte da cardiopatia ischemica è 2,3-3,2 rispetto alla popolazione non diabetica,
aggiustato per PA, colesterolo totale e numero di
sigarette fumato. Quando poi la mortalità cardiovascolare (CV), corretta per l’età, veniva calcolata in termini assoluti in base alla presenza di 1, 2 o 3 fattori di
rischio aggiuntivi, la mortalità per 10.000 in un follow-up di 12 anni raddoppiava per ogni fattore di
rischio nei diabetici (30, 58, 90 e 128 decessi per
10.000 diabetici rispettivamente) (2).
Fig. 1. Mortalità CV, corretta per l’età, per presenza di fattori di
rischio (fumo di sigaretta, colesterolo totale, PA sistolica) nei soggetti maschi sottoposti a screening per il MRFIT, con e senza diagnosi di diabete mellito alla base-line.
Yudkin recentemente ha proposto coefficienti di
rischio coronarico per decadi di età per maschi e femmine in base alla presenza o meno di diabete, ipertensione sistolica, rapporto colesterolo totale/HDL,
presenza o meno di microalbuminuria.
149
Il rischio di malattia cardiovascolare in 10 anni raddoppia, in assenza di altri fattori di rischio, sia in un maschio
sia in una donna sessantenni (da 5-10% a 10-20%) per
la sola presenza del diabete. L’associazione di ipertensione sistolica raddoppia ulteriormente sia nei maschi
che nelle femmine il rischio da 10-20% a 20-40%. Se
inoltre al diabete e all’ipertensione si associa microalbuminuria, il rischio raggiunge il 40-60% (3).
Fig. 2. Stratificazione del rischio CV a 10 anni in rapporto alla presenza di diabete mellito, alla PA sistolica, al rapporto colesterolo
totale/HDL e alla presenza di microalbuminuria in soggetti di 60
anni (modificato da Yudkin, ref. 3).
La stratificazione del rischio assume particolare
importanza per valutare il peso relativo dei vari fattori di rischio conosciuti e il NNT (Number Needed to
Treat) per evitare un evento cardiovascolare in asso-
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
luto. Infatti, supponendo in base ai maggiori trial di
intervento che la riduzione dei fattori di rischio porti
a una diminuzione di 25% degli eventi, si può prudenzialmente calcolare che, se il rischio a 10 anni è
60%, la riduzione del 25% lo porterà a 45%, con
risparmio di 15 eventi ogni 10 anni per 100 soggetti
a rischio della stessa categoria. Ne deriva che è sufficiente trattare 6,7 (100:15) soggetti con questi livelli
di rischio (NNT) per evitare in 10 anni 1 evento cardiovascolare.
Per valutare l’impatto del diabete quale fattore di
rischio cardiovascolare aggiuntivo nel soggetto iperteso è importante considerare gli studi di intervento.
L’UKPDS (4) è stato il primo studio controllato a
lungo termine a dimostrare l’effetto di una riduzione
dei valori glicemici e dell’HbA1c sugli eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus, vasculopatia periferica, morti correlate al diabete). La riduzione
dell’HbA1c dell’11% (esposizione media nel corso di
11 anni) riduce del 16% il rischio di infarto del miocardio (p=0,052), mentre non si sono rilevate differenze significative per il rischio di ictus ischemico
cerebrale. Nel sottogruppo di pazienti diabetici obesi
il trattamento con metformina, a parità di effetto sulla
glicemia e sulla HbA1c, riduceva significativamente (39%) il rischio di infarto del miocardio.
Il diabete quindi rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare indipendente e significativo, e la riduzione dei valori di HbA1c è probabilmente efficace nel
ridurre l’incidenza di eventi cardiovascolari nel diabetico, anche se sembrerebbe che altri fattori incidano
sulle complicanze macrovascolari del diabetico in
misura ancora maggiore dell’iperglicemia: infatti a una
riduzione delle complicanze microvascolari di 25% dei
soggetti in trattamento intensivo corrispondevano una
riduzione di 16% di infarto e nessuna riduzione significativa di ictus e arteriopatia periferica. L’analisi epidemiologica dei risultati dell’UKPDS dimostra infatti che
ipertensione e iperglicemia concorrono ad amplificare
il rischio CV: i pazienti con valori pressori sistolici >150
mmHg e HbA1c > 8% presentano un rischio di eventi
macrovascolari 6 volte superiore rispetto ai soggetti
con PAS < 130 mmHg e HbA1c < 6%, a dimostrazione
che più che il singolo fattore di rischio è importante
l’aggregazione dei fattori.
Nel braccio di intervento HDS (Hypertension in
Diabetes Study) dell’UKPDS i diabetici posti in trattamento ipotensivo “ottimale” (media PA 144/82
mmHg), sia con ACE-inibitori sia con beta-bloccanti,
presentavano una riduzione del rischio di malattia
macrovascolare del 34% (21% infarto, 44% ictus)
rispetto al gruppo in trattamento “non ottimale”
(media PA 154/87 mmHg) e significativamente supe-
riore a quello ottenuto con il solo migliore controllo
metabolico (5).
Anche lo studio di intervento Sys-Eur Trial conferma
l’impatto del diabete sulla mortalità CV e sugli eventi
CV: Il trattamento intensivo dell’ipertensione sistolica
(obiettivo < 150 mmHg) riduce in una popolazione di
ipertesi gli end point CV del 26%, ma nel sottogruppo di 492 soggetti ipertesi e diabetici la riduzione
della mortalità CV è stata del 55% (da 45 a 26 eventi/1000 pazienti/anno) e quella di ogni evento CV del
69%, significativamente superiore a quella dei non
diabetici (6).
Analoghi risultati sono riportati dallo studio SHEP
(Systolic Hypertension in the Eldery Programme): il
trattamento attivo (diuretico+beta-bloccante o reserpina) riduceva in 5 anni il rischio di eventi CV maggiori nei diabetici di 34%, valore doppio rispetto ai
non diabetici.
Fig. 3. Incidenza di eventi CV maggiori in 5 anni (%) nello studio
SHEP. Gli eventi includono infarto del miocardio, morte cardiaca
improvvisa, angioplastica, by-pass aorto-coronarici, aneurismi,
endoarteriectomia carotidea.
Lo studio HOT ha inoltre valutato i benefici della riduzione della PAD a vari livelli in soggetti ipertesi. Mentre
nei soggetti non diabetici nei quali la PAS veniva ridotta a circa 140 mmHg la riduzione della PAD da 90 a 85
a 80 mmHg non modificava significativamente il
rischio di eventi coronarici maggiori (10/1000
paz/anno) e di mortalità CV, nei 1501 pazienti diabetici il numero di eventi CV maggiori si riduceva significativamente da 24/1000 paz/anno (PAD < 90 mmHg)
a 18/1000 paz/anno (PAD <85 mmHg), a 12/1000
paz/anno (PAD < 80 mmHg) e la mortalità CV diminuiva da 11 eventi/1000 paz/anno a 4 eventi/1000
paz/anno se la PAD veniva mantenuta < 80 mmHg.
I dati dello studio HOT dimostrano come il diabete sia
un rischio CV aggiuntivo e la mortalità CV e gli even-
150
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
ti CV siano più che raddoppiati nei pazienti diabetici
rispetto ai non diabetici con valori di PAD in un range
considerato “normale” (8).
Fig. 4. Eventi cardiovascolari maggiori (infarto del miocardio, ictus,
morte cardiovascolare) per 1000 pazienti/anno nello studio HOT in
rapporto all’obiettivo di PA diastolica. Il gruppo dei diabetici migliora significativamente gli esiti con livelli di PA diastolica inferiori.
Recentemente Haffner ha riportato i dati dell’incidenza di infarto del miocardio in una popolazione di
maschi finlandesi non diabetici e diabetici con e
senza precedente infarto del miocardio. Nei non diabetici l’incidenza di infarto del miocardio in 7 anni è
stata di 3,5% nei soggetti senza pregresso infarto e
18,8% nei soggetti con pregresso infarto. Nei diabetici l’incidenza è stata rispettivamente di 20,2% e
45% nei gruppi senza e con pregresso infarto. Quindi
la sola presenza di diabete mellito tipo 2 rende il
rischio di infarto uguale a quello di un soggetto non
diabetico già infartuato, e la mortalità nel diabetico
infartuato risulta quasi 3 volte superiore a quella dell’infartuato non diabetico. Dato che nei soggetti con
pregresso infarto la mortalità CV è di 3-7 volte superiore alla mortalità della popolazione non infartuata,
si può calcolare che il diabete tipo 2 aumenta per un
fattore di 3-7 la mortalità CV rispetto alla popolazione non diabetica (9).
Iperinsulinemia, obesità,
insulino-resistenza
Il rischio cardiovascolare nei soggetti con ipertrigliceridemia o intolleranza ai carboidrati, quindi per definizione con glicemia a digiuno “normale”, è circa
doppio rispetto alla popolazione generale. Una
recente metanalisi che ha preso in considerazione
95.000 soggetti ha dimostrato una correlazione
151
positiva tra glicemia a digiuno, 1 ora e 2 ore dopo
carico orale di glucosio ed eventi CV senza che si sia
dimostrata una soglia di rischio: il rischio relativo di
una glicemia a digiuno di 110 mg/dL è pari a 1,33
rispetto a una glicemia a digiuno di 76 mg/dL e una
glicemia dopo carico di 140 mg/dL rappresenta un
rischio relativo di 1,56 (10). Sembra quindi che i valori di glucosio rappresentino un fattore di rischio cardiovascolare continuo, anche in un range inferiore ai
valori patologici, analogamente a quanto dimostrato
per il colesterolo totale e la PA. Ciò non sorprende
quando si pensi che l’iperglicemia si sviluppa quando
le cellule beta pancreatiche non riescono più a compensare il difetto di azione insulinica periferica, o resistenza insulinica, responsabile di molti casi di diabete
tipo 2 e che il diabete mellito viene dignosticato dopo
anni di livelli glicemici post-prandiali più o meno elevati e di iperinsulinemia “compensatoria”.
Almeno 3 studi prospettici hanno infatti posto in
relazione l’iperinsulinemia con la malattia CV.
Lo studio di Helsinki (11) ha dimostrato una correlazione positiva tra insulinemia 1 e 2 ore dopo carico
orale di glucosio e malattia coronarica anche dopo
correzione per BMI, glicemia, trigliceridemia, colesterolo totale, attività fisica, fumo e PA sistolica.
Lo studio PARIS ha dimostrato una maggiore incidenza di coronaropatia in soggetti con elevata insulinemia a digiuno, indipendente dalla tolleranza al glucosio e dalla PA (12).
Lo studio di Busselton ha dimostrato una correlazione
tra insulinemia e incidenza di coronaropatia e mortalità
cardiovascolare in soggetti di sesso maschile nella 6ª
decade di vita. La mortalità per ogni causa era correlata
positivamente all’insulinemia negli uomini nella 4ª e 5ª
decade di vita (13).
Infine, il San Antonio Heart Study ha dimostrato che
nella popolazione ispano-americana, che presenta
una prevalenza di diabete tipo 2 da 3 a 5 volte maggiore della popolazione bianca, l’insulinemia a digiuno e la risposta insulinemica al carico orale di glucosio
sono più elevate e si associano a un aumentato rischio
CV. In questi soggetti prevalgono inoltre l’obesità e la
distribuzione di tipo centrale dell’adipe, che si accompagna a maggiore insulino-resistenza.
Nello stesso studio sono stati esaminati a 7 anni dall’arruolamento i soggetti che nel corso dello studio avevano manifestato un diabete tipo 2: quelli che all’inizio
dello studio presentavano una predominante insulinoresistenza (metodo HOMA) presentavano al controllo
una PA più elevata, un colesterolo HDL più basso e una
trigliceridemia più elevata, a dimostrazione che l’insulino-resistenza di per sé è un clustering di fattori di
rischio CV e rischio CV essa stessa (14).
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
In conclusione, si può affermare che esiste evidenza
che, anche in assenza di iperglicemia o a livelli di glicemia ancora in un range considerato “normale”,
l’iperinsulinemia conseguente a insulino-resistenza
rappresenta un fattore di rischio indipendente di
malattia CV e che con il passare del tempo il manifestarsi dell’iperglicemia aumenta il rischio CV sia
direttamente sia per l’associazione di altri fattori di
rischio (obesità, ipertrigliceridemia, ipertensione) a
essa correlati.
È da notare tuttavia che il gruppo in trattamento con
ACE-inibitori presentava sia a 1 mese sia a 2 anni una
riduzione maggiore dei valori di PA sia sistolica che
diastolica rispetto al gruppo di controllo e che è noto
come anche piccole riduzioni della PA siano in grado
di produrre significative riduzioni del rischio CV.
Vi sono alcune dimostrazioni che il trattamento ipotensivo debba essere iniziato anche in soggetti diabetici microalbuminurici non ipertesi o in diabetici tipo
1, ancor prima della comparsa di MA. Studi di intervento sono in corso per valutare i vantaggi di tale
approccio.
Microalbuminuria
La microalbuminuria (MA) è un forte predittore di
nefropatia diabetica ma anche di malattia CV sia nei
diabetici tipo 1 che tipo 2. Però solo circa il 3% dei
diabetici tipo 2 va incontro a uremia mentre l’80%
muore per malattia CV.
La microalbuminuria ha una prevalenza almeno tripla
nei soggetti diabetici rispetto ai non diabetici (30% vs
5-10%) e in questi ultimi è soprattutto in relazione
all’ipertensione. Nei diabetici è correlata all’ipertensione arteriosa ma anche ad altri fattori quali l’obesità addominale, l’iperuricemia, la glicemia a digiuno e
la HbA1c. Sia il DCCT sia l’UKPDS hanno dimostrato
che il buon controllo metabolico rallenta la comparsa
della microalbuminuria (MA) e la progressione verso
la macroalbuminuria nei soggetti diabetici, confermando la relazione tra MA e controllo metabolico.
Diversi studi hanno confermato che anche nei diabetici la macroalbuminuria è un fattore fortemente predittivo di mortalità CV, con un rischio doppio rispetto
ai diabetici senza microalbuminuria (15).
Il Risk Factor Intervention Study ha dimostrato che in
un gruppo di diabetici ipertesi la mortalità è maggiore nei soggetti microalbuminurici rispetto ai non
microalbuminurici (p=0,035) e che la MA rappresenta un fattore di rischio indipendente (16).
Anche se la multifattorialità della patogenesi della MA
pone qualche problema di interpretazione dei dati
sull’effetto protettivo della riduzione della MA nei
confronti della malattia CV nei diabetici tipo 2, l’opinione prevalente è che sia il controllo metabolico sia
il controllo della PA debbano essere iniziati precocemente, che l’obiettivo pragmatico debba essere una
PA di 130/80 mmHg e che sia più importante la riduzione dei valori pressori che il mezzo utilizzato. Lo studio micro-HOPE ha recentemente dimostrato tuttavia una significativa riduzione del rischio CV (infarto
del miocardio, ictus, mortalità CV e mortalità totale)
in diabetici trattati con ACE-inibitori oltre alla terapia
ipotensiva usuale (17).
Lipidi
L’alterazione dei lipidi plasmatici tipica del diabetico
tipo 2 è caratterizzata da un aumento dei trigliceridi
plasmatici e da bassi livelli di colesterolo HDL, mentre
la prevalenza di ipercolesterolemia totale non è nei
diabetici sostanzialmente diversa da quella della
popolazione generale. Come nella popolazione generale fattori genetici possono essere causa nei diabetici di ipertrigliceridemia o di iperlipemia combinata, così anche fattori acquisiti (alcool, estrogeni, farmaci ecc.) possono amplificare il disordine lipidico
tipico del diabetico.
La fisiopatologia della iperlipemia del diabetico è
caratterizzata da un’aumentata produzione di VLDL,
prevalente nelle fasi iniziali della malattia, e da un rallentato catabolismo delle stesse. Nelle forme più
severe l’attività lipoproteinlipasica è diminuita e il
controllo dell’iperglicemia con insulina o ipoglicemizzanti orali può riportarla a valori normali nell’arco di
settimane o mesi. Sia la resistenza all’insulina che un
deficit di insulina possono essere causa di diminuzione dell’attività lipoproteinlipasica.
Nei diabetici, inoltre, sono presenti alterazioni della
composizione delle VLDL, più ricche di trigliceridi, e
un aumento delle IDL, con maggiore effetto aterogenetico per aumentata captazione delle particelle da
parte delle cellule della parete arteriosa.
I bassi livelli di colesterolo HDL possono essere dovuti sia a ridotta produzione sia ad aumentato catabolismo. La diminuita produzione sarebbe dovuta a un
diminuito catabolismo delle VLDL e alla diminuita
attività della lipasi lipoproteica. L’aumentato catabolismo è conseguente a un’aumentata attività della
lipasi epatica. Inoltre nei diabetici tipo 2 le particelle
HDL sono più ricche di trigliceridi e più povere di
colesterolo, con aumento del rapporto apo-A1/ apoA2. La glicazione delle HDL, a differenza di quanto
avviene per le LDL, ne aumenta il catabolismo.
152
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
La concentrazione assoluta di LDL nei diabetici è simile a quella dei non diabetici, ma sono state descritte
modificazioni metaboliche e di composizione delle
particelle che le rendono più piccole, più dense, glicate e ossidate, tutte modificazioni in senso aterogenetico. La glicazione delle LDL, ma anche l’associata
ipertrigliceridemia e l’insulinopenia, possono ridurre
il catabolismo delle stesse e causare un aumento
anche dei loro valori assoluti.
È evidente che tutte queste modificazioni metaboliche e strutturali espongono il diabetico a un rischio
CV aggiuntivo rispetto sia all’iperglicemia sia all’ipertensione; tuttavia non sempre è possibile valutare
quale sia il peso reale di fattori di rischio “indipendenti” e quello di fattori fortemente associati al
rischio di base. Questi fattori associati, come l’ipertrigliceridemia del diabetico, potrebbero rappresentare
più marker di rischio maggiore che fattori di rischio
aggiuntivi.
Per queste ragioni è importante considerare i risultati
degli studi di intervento disponibili, oltre agli studi
prospettici; infatti un fattore di rischio potrebbe essere un marker di malattia CV più forte in quanto
espressione di un clustering di fattori di rischio associati (ad esempio ipertrigliceridemia associata a resistenza all’insulina, obesità, ipertensione). Gli studi di
intervento ci permettono spesso di determinare il
“peso” del fattore di rischio indipendente e quello dei
fattori di rischio associati. Va tenuto presente tuttavia
che molti dei dati di intervento su soggetti diabetici
derivano da analisi post-hoc, cioè da dati raccolti in
una popolazione generale, dai quali solo successivamente sono stati isolati quelli riguardanti i soggetti
diabetici, e questo potrebbe creare problemi nella
omogeneità della selezione iniziale dei soggetti in
studio e quindi nella confrontabilità dei gruppi.
Studi di prevenzione primaria
nel diabetico
Non vi sono ancora sufficienti dati da studi di intervento di prevenzione primaria della malattia CV
in soggetti diabetici con terapia ipolipemizzante.
L’Helsinki Heart Study ha dimostrato una riduzione di
eventi coronarici in soggetti senza pregressa malattia
coronarica con gemfibrozil, in particolare in soggetti
con ipertrigliceridemia e basso colesterolo HDL. Nello
studio fu arruolato un piccolo numero di diabetici
(n=135) e l’analisi post hoc ha dimostrato una riduzione del 60% del rischio relativo di eventi coronarici,
ma il valore non risultò significativo per la scarsa
numerosità del campione (18).
Lo studio WOSCOP ha dimostrato che la riduzione
delle LDL con pravastatina riduce gli eventi coronarici nella popolazione generale, ma il sottogruppo dei
diabetici era troppo esiguo (1% del campione) per
permettere un’analisi dei dati (19).
In attesa della conclusione degli studi in corso di prevenzione primaria nei diabetici rimangono valide le
indicazioni del National Cholesterol Education Program (NCEP), che consiglia una riduzione dei livelli di
colesterolo LDL < 100 mg/dL nei soggetti con pregressa coronaropatia, < 130 mg/dL per i soggetti a
rischio, < 160 mg/dL per i soggetti a basso rischio.
L’alto rischio è definito come presenza di due o più
fattori di rischio CV: il diabete conta per un fattore di
rischio e il sesso maschile rappresenta un altro fattore
di rischio. Il panel tuttavia considera le donne diabetiche a uguale rischio degli uomini, per cui tutti i diabetici, maschi e femmine, dovrebbero avere un target di LDL < 130 mg/dL. Non solo, ma in base ai dati
di Haffner già citati, cioè della uguale incidenza di
eventi cardiovascolari nei diabetici senza pregresso
infarto e nei non diabetici con pregresso infarto, alcuni autori ritengono giustificato spostare il target di
prevenzione primaria per il soggetto diabetico a valori di LDL ≤ a 100 mg/dL.
Studi di prevenzione secondaria
nel diabetico
Lo studio 4S (Scandinavian Survival Simvastatin
Study) ha dimostrato che in soggetti con pregresso
infarto del miocardio e con trigliceridi “relativamente” normali (<220 mg/dL) la riduzione del colesterolo totale con simvastatina a livelli inferiori a 200
mg/dL porta a una riduzione di un terzo degli eventi
CV. In un sottogruppo di diabetici (n=202) la riduzione risultò ancora maggiore (-55%) e anche la mortalità fu minore nei diabetici trattati, anche se non a livelli di significatività statistica. Nel gruppo in trattamento con placebo l’incidenza di eventi cardiovascolari fu
di 2,5 volte maggiore nei diabetici, a dimostrazione
che il diabete aumenta ulteriormente il rischio CV, già
elevato nei soggetti infartuati (20).
Lo studio CARE ha rilevato che la riduzione del colesterolo LDL in soggetti con precedente coronaropatia
riduce gli eventi cardiovascolari anche in soggetti con
valori di colesterolo LDL “normali” (139 mg/dL alla
base-line) e che la riduzione è simile nei diabetici e nei
non diabetici (25% vs 23%) (21).
Recentemente sono stati pubblicati i risultati dell’effetto del trattamento con gemfibrozil in prevenzione
secondaria in soggetti con bassi livelli di colesterolo
153
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
HDL e colesterolo LDL “normale” (HDL < 40 mg/dL,
LDL < 140 mg/dL). L’aumento del colesterolo HDL del
6% e la diminuzione dei trigliceridi del 31% riduceva in
5 anni il RR del 22% nei non diabetici e del 24% nei diabetici (22).
Dai dati disponibili si può concludere che la dislipidemia, sia primitiva (ipercolesterolemia isolata) sia
secondaria (ipertrigliceridemia e basso HDL), rappresenta un ulteriore fattore di rischio CV nel soggetto
diabetico, non riducibile con il solo buon controllo
metabolico. La dimostrazione che la correzione delle
anomalie lipidiche nel diabetico ha un effetto ancora
superiore a quello che si ottiene nei soggetti non diabetici conferma la particolare aterogenicità delle particelle lipoproteiche alterate qualitativamente, oltre
che quantitativamente, nel diabetico.
Ipertrigliceridemia
Per quanto riguarda l’ipertrigliceridemia isolata nel
diabetico non vi sono prove certe che rappresenti un
fattore di rischio indipendente, come invece è dimostrato per il colesterolo LDL.
Il Paris Prospective Study ha dimostrato una correlazione tra ipertrigliceridemia e mortalità CV in un sottogruppo di soggetti con diabete mellito tipo 2 o
intolleranza ai carboidrati; inoltre è stata dimostrata
una correlazione positiva tra malattia coronarica e
VLDL e una correlazione negativa con i livelli di colesterolo HDL. Tuttavia all’analisi multivariata solo un
basso valore di colesterolo HDL era correlato alla
malattia coronarica.
Se vi sono sufficienti evidenze per considerare l’ipertrigliceridemia come un fattore di rischio CV
indipendente nel soggetto non diabetico (23), è
più difficile stabilire quanto nel diabetico essa sia
più l’espressione di un difetto metabolico di base
(insulino-resistenza) che un fattore aggiunto. Sembrerebbe che l’ipertrigliceridemia, e il basso valore
di HDL, siano dei potenti marker di rischio cardiovascolare nel diabetico, ma facciano parte di un
clustering di elementi metabolici (insulina, glucosio, lipidi, indice ponderale, obesità addominale)
che rappresentano un unico fattore di rischio principale.
Questa ipotesi ha la sua importanza concettuale e
pratica nel fatto che, se essa dovesse essere confermata, darebbe una giustificazione al fatto che non è
sufficiente la correzione di un unico fattore di rischio
(o di un marker di malattia cardiovascolare) per una
efficace prevenzione primaria e secondaria della
malattia cardiovascolare nel diabetico.
Conclusioni
Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze che
altri fattori di rischio CV presenti nel soggetto diabetico contribuiscono in varia misura all’aumentata incidenza di malattia, eventi e mortalità CV in questi
pazienti. L’iperfibrinogenemia, lo stato trombofilico
da aumentata adesività piastrinica, gli alti livelli di PAI
1, lo stress ossidativo e la disfunzione endoteliale
sono alcuni degli elementi specifici della malattia diabetica.
La riduzione dei livelli di glucosio plasmatico è sicuramente efficace nel ridurre le complicanze microvascolari del diabete, ma la relazione non è così lineare
per le complicanze macroangiopatiche, anche se i
risultati degli studi prospettici di intervento possono
sottovalutare la responsabilità dell’iperglicemia in
quanto la riduzione dei livelli di glucosio ottenuti
sono ben lungi da rappresentare una normalizzazione della glicemia.
Nei diabetici sono presenti quindi fattori di rischio
aggiuntivi non solo rispetto al rischio rappresentato
dall’ipertensione nella popolazione generale, ma
anche al rischio rappresentato dall’iperglicemia di
per sé.
Allo stato attuale dell’arte vi sono evidenze che solo
l’azione su tutti i fattori di rischio, e non solo sui marker di malattia, può ridurre l’incidenza di malattia e
mortalità CV nei diabetici, sfida questa che si apre con
il nuovo millennio.
Bibliografia
1. Kannel WB: Risk stratification in hypertension: new
insight from the Framingham Study. Am J Hypertens
13, 3S-10S, 2000
2. Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D et al:
Diabetes, other risk factors, and 12-yr cardiovascular
mortality for men screened in the Multiple Risk Factor
Intervention Trial. Diabetes Care 16, 434-444, 1993
3. Yudkin JS, Chaturvedi N: Developing risk stratification
charts for diabetic and non diabetic patients. Diabetic
Med 16 (3), 219-227, 1999
4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group:
Intensive blood-glucose control with sulphonilureas or
insulin compared with conventional treatement and
risk of complications in patients with type 2 diabetes
(UKPDS 33). Lancet 352, 837-853, 1998
5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Efficacy
of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 39). BMJ 317, 713-720, 1998
6. Tuomilehto J, Rastenyte D, Birkenhager WH et al: Effects
of calcium-channel blockade in older patients with dia-
154
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
betes and systolic hypertension. N Engl J Med 340,
677-684, 1999
7. Curb JD, Pressel SL, Cutler JA et al: Effect of diuretic
based antihypertensive treatment on cardiovascular
risk in older diabetic patients with isolated systolic
hypertension. J Am Med Ass 276, 1886-1892, 1996
8. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG et al: Effects of
intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin
in patients with hypertension: principal results of the
Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomized
trial. Lancet 351, 1755-1762, 1998
9. Haffner SM, Lethto S, Ronnemaa T et al: Mortality from
coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes
and in nondiabetic subjects with and without prior
myocardial infarction. N Engl J Med 339, 229-234,
1999
10. Coutinho M, Gersteun HC, Wang Y et al: The relationship between glucose and incident cardiovascular
events: a metaregression analysis of published data
from 20 studies of 95,783 individuals followed for 12.4
years. Diabetes Care 22, 233-240, 1999
11. Pyorala K, Savolainen E, Kaukola S et al: Plasma insulin
as coronary heart disease risk factor: Relationship to
other risk factors and predictive value during 9-year follow-up of the Helsinki policemen study population.
Acta Med Scand 701 (suppl), 38-52, 1985
12. Ducimetiere P, Eschwege E, Papoz L et al: Relationship
of plasma insulin levels to the incidence of myocardial
infarction and coronary heart disease in a middle-aged
population. Diabetologia 19, 205-210, 1980
13. Welbom TA, Wearne K: Coronary heart disease incidence and cardiovascular mortality in Busselton with reference to glucose and insulin concentrations. Diabetes
Care 2, 154-160, 1979
14. Haffner SM, Mykkanen L, Festa A et al: Insulin-resistant
prediabetic subjects have more atherogenic risk factors
than insulin-sensitive prediabetic subjects: implications
for preventing coronary heart disease during the prediabetic state. Circulation 101 (9), 975-980, 2000
15. Dinnen S: The association of MA and mortality in noninsulin-dependent diabetes mellitus. A systematic overview of the literature. Arch Int Med 157, 1413-1418, 1997
16. Agewall S, Wikstrand J, Ljungman S et al: Usefulness of
microalbuminuria in predicting cardiovascular mortality in treated hypertensive men with and without diabetes mellitus. Risk Factor Intervention Study Group.
Am J Cardiol 80 (2), 164-169, 1997
17. Heart Outcomes Prevention Study Investigators: Effects
of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the
HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 355,
253-259, 2000
18. Koskinen P, Manttari M, Manninen V et al: Coronary
heart disease incidence in NIDDM patients in Helsinki
Heart Study. Diabetes Care 15, 820-825, 1992
19. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I et al: Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia, N Engl J Med 339, 1349-1357, 1998
20. Pyorala K, Pedersen tr, Kjekshus J et al. The Scandina-
155
vian Simvastatin Survival Study (4S): Cholesterol lowering with simvastatin improves prognosis of diabetic
patients with coronary heart disease: a subgroup analysis of the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S).
Diabetes Care 20, 614-620, 1997
21. Goldberg RB, Mellies MJ, Sacks FM et al: Cardiovascular
events and their reduction with pravastatin in diabetic
and glucose intolerant myocardial infarction survivors
with average cholesterol levels. Circulation 98, 25132519, 1998
22. Rubins HB, Robins SJ, Collins D: Gemfibrozil for the
secondary prevention of CHD in men with low levels of
HDL cholesterol. Veterans Affair High Density
Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group.
N Engl J Med 341, 410-418, 1999
23. Austin MA, Hokanson JK, Edwards KL: Hypertrygliceridemia as a cardiovascular risk factor. Am J
Cardiol 81 (4A), 7B-12B, 1998
QUALI SONO I CRITERI
DIAGNOSTICI E QUALI I VALORI
SOGLIA DI PRESSIONE PER
L’INTERVENTO TERAPEUTICO?
A. TIENGO, R. TREVISAN
Divisione Malattie del Metabolismo, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Padova
La definizione di ipertensione arteriosa nel diabete
mellito non differisce da quanto stabilito nella popolazione generale.
D’altra parte i più recenti risultati di numerosi studi
prospettici sulla relazione tra livelli di pressione arteriosa e rischio di eventi vascolari hanno indotto la
comunità scientifica a fare il punto su tale problema e
a formulare nuovi e più attuali criteri di classificazione.
Le nuove linee guida hanno impostato le nuove classificazioni, partendo dal presupposto che l’ipertensione arteriosa non deve essere considerata isolatamente ma nell’ambito del rischio globale aterogeno a cui
è sottoposto il singolo paziente. Altro presupposto
della nuova classificazione dell’ipertensione è il rilievo
che i livelli di pressione arteriosa sono correlati al
rischio di patologia cardiovascolare in modo continuo senza una evidente soglia patologica e ogni definizione di ipertensione sarebbe perciò arbitraria.
In pazienti con ipertensione lieve il rischio di malattia
cardiovascolare è infatti determinato non solo dai
livelli di pressione arteriosa ma anche dalla presenza e
dall’entità di altri fattori di rischio. Le differenze di
rischio cardiovascolare assoluto tra pazienti con ipertensione sono determinate più dalla coesistenza di
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
altri fattori di rischio che dal livello di pressione
arteriosa.
L’ipertensione è comunque definita secondo le più
recenti classificazioni in differenti stadi o categorie.
Il “Joint National Committee” (JNC) negli Stati Uniti
(1) e il “WHO-ISH Guidelines Committee” (2) sono
stati concordi nel definire ipertensione arteriosa valori superiori a 140 mmHg per la pressione sistolica e 90
mmHg per la pressione diastolica nei soggetti non
sottoposti a terapia antipertensiva.
La classificazione dei livelli pressori nei soggetti adulti
sopra i 18 anni è descritta nella tabella 1.
Tale classificazione si basa su quanto proposto dalla
JNC (1), anche se si è preferito parlare di gradi di ipertensione piuttosto che di stadi che presupponevano
una necessaria progressione dei valori pressori.
Gli estensori della classificazione sottolineano che i
gradi di ipertensione si riferiscono semplicemente ai
valori attuali di PA e non alla prognosi che può essere
non sempre correlata ai valori iniziali pressori.
L’attuale classificazione non tiene conto dell’età del
paziente e quindi non definisce alcuna ipertensione
dell’anziano, ma si limita a considerare l’ipertensione
sistolica isolata. Dall’epidemiologia si è infatti chiarito
che l’ipertensione nell’anziano deve essere considerata alla stregua dell’ipertensione ritrovata nella media-
TAB. I. Classificazione dei valori
di ipertensione arteriosa
Categoria
Sistolica
(mmHg)
Diastolica
(mmHg)
Ottimale
< 120
< 80
Normale
< 130
< 85
Normale - alta
130-139
85-89
Ipertensione di grado 1 (“lieve”)
140-159
90-99
Sottogruppo “borderline”
140-149
90-94
Ipertensione di grado 2
(“moderata”)
160-179
100-109
Ipertensione di grado 3 (“grave”)
≥ 180
≥ 110
Ipertensione sistolica isolata
≥ 140
< 90
140-149
< 90
Sottogruppo “borderline”
Nel caso la pressione sistolica e quella diastolica di un paziente rientrino in categorie differenti, la classificazione va fatta in base alla categoria maggiore.
età, dal momento che il trattamento riduce comunque il rischio cardiovascolare a prescindere dall’età
del paziente.
Non si fa inoltre cenno alla ”ipertensione clinica isolata”, definita anche “da camice bianco”, situazione che
presuppone un aumento ripetuto dei valori pressori in
ambulatorio con valori pressori normali in registrazioni eseguite al di fuori di ambienti medico-sanitari.
Non è ancora noto d’altra parte se l’ipertensione clinica isolatasia un fenomeno “benigno-innocente”
oppure se si associ a un aumento del rischio cardiovascolare. Essa andrà eventualmente considerata e
valorizzata alla luce della presenza di altri fattori di
rischio vascolare come il diabete.
La diagnosi di ipertensione arteriosa deve essere fatta
dopo molteplici misurazioni ottenute in differenti
visite. Come ben definito dalle linee guida internazionali, la pressione deve essere misurata con il paziente
seduto usando uno sfigmomanometro a mercurio. Se
vengono usati altri strumenti non a mercurio, i valori
pressori ottenuti dovranno essere confrontati con
quelli ottenuti mediante sfigmomanometro.
Nei pazienti diabetici è importante misurare la pressione arteriosa anche in posizione ortostatica per evidenziare eventuali cadute pressorie (ipotensione
ortostatica) dovute alla frequente coesistenza di neuropatia autonomica.
La misurazione della pressione a domicilio con apparecchi non invasivi semiautomatici e automatici offre
vantaggi ma anche alcuni svantaggi. Pur offrendo la
possibilità di valutare i valori pressori nell’ambiente di
lavoro in diversi momenti della giornata, tali misurazioni vanno considerate con prudenza e non devono
sostituire le misurazioni ambulatoriali. I valori registrati sono peraltro di alcuni mmHg inferiori a quelli
ottenuti in ambulatorio. Non esistono ancora in letteratura risultati probanti sul valore prognostico di queste misurazioni domiciliari.
Il monitoraggio continuo della pressione arteriosa
non può essere considerato una modalità routinaria
per la diagnosi di ipertensione. Tale modalità di misurazione, che ottiene valori pressori inferiori rispetto
alle misurazioni estemporanee, va presa in considerazione soprattutto in presenza di casi con estrema
instabilità dei valori pressori, con sintomatologia di
episodi ipotensivi specie notturni e per una valutazione più approfondita dell’effetto dei singoli farmaci
utilizzati. È stato dimostrato che il danno d’organo
associato all’ipertensione correla più strettamente
con la pressione arteriosa media delle 24 ore che con
la pressione misurata in ambiente clinico.
Le definizioni di lieve, moderata e grave, usate nelle
versioni precedenti delle linee guida OMS-ISH, corri-
156
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
spondono rispettivamente al grado 1, 2 e 3 e la precedente definizione di ipertensione “borderline”
diviene un sottogruppo dell’ipertensione di grado 1.
Valori soglia di pressione arteriosa
per il trattamento
La decisione di trattare i pazienti con ipertensione arteriosa non dovrebbe basarsi solo sul livello della pressione arteriosa ma anche sulla presenza di altri fattori di
rischio o di malattie concomitanti come in particolare
il diabete, di danno d’organo, di malattie cardiovascolari o renali nonché di valutazioni specifiche riguardanti la personalità e le caratteristiche del paziente.
Ecco allora che la valutazione della soglia di valori
pressori per l’intervento terapeutico potrà variare a
seconda della stratificazione del rischio assoluto futuro di patologia cardiovascolare attribuibile al paziente. La stima del rischio è basata su età, sesso, fumo,
presenza di diabete o di ipercolesterolemia, storia di
malattia cardiovascolare precoce, presenza di danno
d’organo e storia di malattia cardiovascolare o renale
(tab. II). Il calcolo è stato fatto in base ai dati del
rischio medio di morte cardiovascolare, di ictus non
mortale o di infarto miocardico non mortale che
potrebbero comparire nell’arco di 10 anni, basandosi sui dati dello studio di Framingham.
Sono state definite quattro categorie di rischio assoluto cardiovascolare: basso, medio, alto e molto alto.
Ogni categoria è rappresentata da un intervallo di
rischio. All’interno di ciascun intervallo il rischio di
ciascun individuo sarà calcolato in funzione della gravità e del numero dei fattori di rischio presenti.
La stratificazione dei pazienti in base al loro rischio
cardiovascolare globale è utile non solo per determinare la soglia a cui iniziare il trattamento farmacologico antipertensivo ma anche per stabilire il valore di
pressione arteriosa che dovrebbe essere raggiunto
(tab. III).
Come si può osservare nella tabella II, tra i fattori che
condizionano la prognosi del paziente iperteso gioca
un ruolo estremamente negativo la presenza di diabete e di ipercolesterolemia, mentre altri fattori metabolici come la ridotta tolleranza al glucosio, l’aumento di colesterolo LDL, la riduzione di colesterolo HDL,
la presenza di microalbuminuria in corso di diabete,
TAB. II. Fattori che influenzano la prognosi del paziente iperteso
(Guidelines WHO for Management of Hypertension 1999)
Fattori di rischio cardiovascolare
Danno d’organo
Patologie associate
1. Fattori utilizzati per la quantificazione
del rischio
- Valori di pressione arteriosa sistolica
o diastolica (gradi 1-3)
- Età >55 anni: sesso maschile
- Età >65 anni: sesso femminile
- Fumo di sigaretta
- Colesterolo totale >250 mg/dL (6,5 mmol/L)
- Diabete
- Storia familiare di precoce cardiovasculopatia
- Ipertrofia ventricolare sinistra
- Proteinuria e/o modesto aumento
della creatinina (1,2-2,0 mg/dL)
- Presenza di placche aterosclerotiche
alle arterie carotidi, iliache, femorali
e aorta
- Restringimenti generalizzati o focali
delle arterie retiniche
- Malattie cerebrovascolari
• ictus ischemico
• emorragia cerebrale
• attacchi ischemici transitori
- Cardiopatie
• infarto del miocardio
• angina
• rivascolarizzazione coronarica
• scompenso cardiaco congestizio
- Nefropatia - Colesterolo HDL ridotto
2. Altri fattori che influenzano negativamente la prognosi
• nefropatia diabetica
- Colesterolo LDL aumentato
- Microalbuminuria in corso di diabete
- Ridotta tolleranza al glucosio
- Obesità
- Stile di vita sedentario
- Fibrinogeno aumentato
- Gruppo ad alto rischio socioeconomico
- Gruppo ad alto rischio etnico
- Abitanti di regioni geografiche ad alto rischio
• insufficienza renale
(creatinina >2,0 mg/dL)
- Vasculopatie
• aneurisma dissecante
• arteriopatia sintomatica
- Retinopatia ipertensiva avanzata
• emorragia o essudati
• papilledema
157
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
l’obesità, sono comunque sfavorevoli sulla storia
naturale dell’ipertensione arteriosa. Il diabete è considerato alla stregua della coesistenza di 3 o più fattori
di rischio nel condizionare il rischio cardiovascolare
indotto dai diversi gradi di ipertensione arteriosa. In
altri termini, come risulta dalla tabella III, la presenza
di diabete determina sempre e comunque un rischio
elevato o molto elevato secondario ai diversi gradi di
ipertensione arteriosa.
In presenza di ipertensione arteriosa lieve, che in
assenza di altri fattori di rischio, si accompagna a un
basso rischio aterogeno, il diabete è in grado di moltiplicare tale rischio rendendolo di grado elevato o
molto elevato.
D’altra parte è stato dimostrato che, in presenza di
valori pressori anche solo modestamente elevati, la
coesistenza di diabete moltiplica di 3-4 volte il rischio
cardiovascolare (3). È possibile che valori pressori ritenuti normali per la popolazione non diabetica siano
già in grado nella popolazione diabetica di svolgere
un ruolo favorente, a lungo termine, la compromissione cardiovascolare.
Il rischio cardiovascolare lieve secondo lo studio di
Framingham corrisponde a un’incidenza di eventi
cardiovascolari in 10 anni inferiore al 15%, il rischio
medio a un’incidenza tra il 15 e il 20%, il rischio elevato a un’incidenza del 20-30% e, infine, quello
molto elevato a più del 30% di eventi cardiovascolari
nel corso del successivo decennio.
L’entità del rischio attribuito alla popolazione diabetica-ipertesa ha modificato i valori pressori soglia per
l’intervento terapeutico. Nella popolazione generale i
numerosi studi epidemiologici randomizzati hanno
indicato la soglia di valori tensivi sistolici di 160
mmHg per l’assoluta indicazione all’intervento terapeutico. Tra 140 e 160 mmHg, che corrisponde alla
cosiddetta ipertensione lieve o “borderline”, non esiste una chiara evidenza per rendere d’obbligo il trattamento farmacologico. Solo nella popolazione diabetica si giustifica una soglia sistolica di intervento di
140 mmHg sulla base della maggiore suscettibilità
dimostrata nel diabetico al “rischio ipertensivo”.
Ciò risulta nelle raccomandazioni del “US Joint
National Committee VI Guidelines” e più recentemente nel “World Health Organization/International
Society of Hypertension Guidelines”.
Questa soglia di intervento più bassa, applicabile alla
popolazione diabetica, è dovuta alla più elevata vulnerabilità al fattore ipertensivo quando coesiste il diabete (4). Ciò è valido non solo in relazione all’incidenza di infarto del miocardio o di ictus cerebrale, ma
anche alla storia naturale della microangiopatia diabetica. Per la prevenzione primaria e secondaria della
TAB. III. Stratificazione del rischio
per quantificare la prognosi
(Guidelines WHO for Management
of Hypertension 1999)
Pressione arteriosa (mmHg)
Altri fattori di rischio
e storia clinica
Grado 1
(ipertensione
lieve)
PAS 140-159 o
PAD 90-99
Grado 2
(ipertensione
moderata)
PAS 160-179 o
PAD 100-109
Grado 3
(ipertensione
grave)
PAS ≥ 180 o
PAD ≥ 110
I Nessun altro
fattore di rischio
Rischio
basso
Rischio
medio
Rischio
elevato
II 1-2 fattori
di rischio
Rischio
medio
Rischio
medio
Rischio
molto elevato
III 3 o più fattori di
rischio o danno
d’organo o diabete
Rischio
elevato
Rischio
elevato
Rischio
molto elevato
IV Patologie
associate
Rischio
molto elevao
Rischio
molto elevato
Rischio
molto elevato
PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica
retinopatia e della nefropatia diabetica sono state
proposte soglie di intervento inferiori a 140 mmHg
che si possono identificare in 130 mmHg specie nei
pazienti con diabete di tipo 1.
La soglia diastolica per l’intervento è meno dibattuta,
anche se vi è un generale consenso favorevole a valori di 90 mmHg. Adottando questo criterio di soglia di
140/90 mmHg, ben pochi diabetici potranno essere
considerati normotesi e il 70% dei diabetici di tipo 2
dovrebbero essere sottoposti a terapia antipertensiva.
La scelta di questa soglia più bassa per l’intervento farmacologico nel diabetico è supportata dai recenti risultati di studi fondamentali di trattamento farmacologico: l’HOT Study, il CAPP Study, il Systeur Study, l’UKPDS
Study e il Micro-Hope Study, che hanno dimostrato
che, se nella popolazione diabetica si raggiungono
valori di pressione sistolica inferiori a 140 mmHg e valori di pressione diastolica inferiori a 90-85 mmHg, è possibile ridurre ulteriormente il rischio cardiovascolare,
risultato che non era possibile ottenere nella popolazione non diabetica. Un’analoga osservazione era stata
fatta per i valori di colesterolo totale e LDL, la cui soglia
di intervento terapeutico nei diabetici è stata ipotizzata
più bassa rispetto alla popolazione non diabetica.
Tale atteggiamento più aggressivo nei confronti del
158
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
diabetico-iperteso è oggi ampiamente convalidato e
deve divenire una regola per il diabetologo e per il
medico generale; proprio l’intervento terapeutico
antipertensivo più precoce e più rigido ha permesso
una significativa riduzione delle complicanze micro e
macrovascolari (5).
Bibliografia
1. Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation and Treatment of high blood pressure and
the National High Blood Pressure Education Program
Coordinating Committee (Sixth Report). Arch Intern
Med 157, 2413-2446, 1997
2. 1999 World Health Organization/International Society
of Hypertension. Guidelines for the management of
hypertension. J Hypertens 17, 151-183, 199
3. Mac Mahon S, Peto R, Cutler S, Collins R, Sorlie P,
Neaton J: Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Part 1. Prolonged differences in blood pressure:
prospective observational studies corrected for the
regression dilution bias. Lancet 335, 765-774, 1990
4. Williams B: Treating hypertension in type 2 diabetes: an
evidence base at last. Acta Diabetol 36, 504-510, 1999
5. American Diabetes Association: Clinical Practices
Recommendations 2000. Diabetes Care 23 (suppl 1),
539, 2000
QUALI VALORI DI PRESSIONE
DEVONO ESSERE RAGGIUNTI
E MANTENUTI CON LA TERAPIA
ANTIPERTENSIVA?
D. GIUGLIANO
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo, II Università di Napoli
È opinione comune e ben consolidata che il rischio
cardiovascolare nel soggetto diabetico sia molto più
elevato di quello presente nella popolazione generale. Il fatto che tre diabetici di tipo 2 su quattro soccombano per morte cardiovascolare contribuisce
alla diffusione sempre più larga di quest’evidenza. Il
declino della mortalità cardiovascolare ottenuto in
anni recenti nelle civiltà occidentali sembra non aver
interessato il soggetto diabetico, o averlo coinvolto
solo in minima parte (1). La donna diabetica rimane
ancora l’attore di questo dramma, poiché nel sesso
femminile si è avuto addirittura un aumento della
morte cardiovascolare. Le ragioni di questa discrepanza non sono state ancora chiarite, ma c’è il
159
sospetto che possa essere dipeso da un diverso
approccio nella gestione del rischio globale del
paziente diabetico.
La trama che sottende queste considerazioni, per
quanto razionale e condivisibile, non appartiene alla
nostra area geografica, essendo i dati importati da
altri Paesi di cultura occidentale, principalmente dagli
Stati Uniti d’America. Ci sono fondati motivi di ritenere che l’impatto dei vari fattori di rischio, ipertensione compresa, possa risentire delle coordinate geografiche di appartenenza della popolazione in esame. I
dati recenti dello studio dei sette Paesi dimostrano che
i popoli che gravitano nel bacino del Mediterraneo
meridionale risentono meno dei danni cardiovascolari
imputabili all’ipertensione, rispetto alle popolazioni
dell’Europa continentale o degli Stati Uniti (2).
Un altro convincimento che si sta facendo strada prepotentemente nel bagaglio culturale del medico
attento ai problemi di prevenzione cardiovascolare è
quello che il rischio di morte cardiovascolare nei
pazienti con diabete tipo 2 è molto simile a quello
espresso da pazienti non diabetici che abbiano già
manifestato un infarto del miocardio (20% di incidenza in 7 anni) (3). Per quanto condivisibile sul
piano concettuale, perché permetterebbe di considerare il soggetto diabetico sempre in stato di prevenzione secondaria, un simile convincimento eluderebbe
a priori la stratificazione del rischio globale nel paziente diabetico. Nello studio HOPE (4), per esempio, l’incidenza di eventi cardiovascolari nei 3577 diabetici
studiati era del 4,4% per anno, superiore al rischio del
3,7% per anno dimostrato dai 5720 soggetti non diabetici che già avevano sperimentato un evento.
L’analisi dei dati ha fatto però emergere che il rischio
più elevato nei diabetici era appannaggio di quelli con
malattia cardiovascolare già nota (rischio del 5,3%)
oppure di quelli con microalbuminuria (rischio del
6,4%), riducendosi il rischio al 2,2% per anno nei diabetici senza eventi noti. Questi dati, ottenuti in un’ampia popolazione di soggetti diabetici, dimostrano che
può essere fuorviante operare delle estrapolazioni
basandosi sui dati di un singolo studio. La validità della
stratificazione del rischio sembra opportuna anche nel
paziente diabetico. In tale ottica, la presenza di
microalbuminuria in un paziente diabetico di tipo 2
consentirà di considerarlo come un soggetto particolarmente degno di attenzione terapeutica.
Scopo della terapia
Lo scopo di abbassare la pressione arteriosa in ogni
paziente con ipertensione è di ridurre la mortalità e la
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
morbilità cardiovascolare. Nei pazienti con diabete vi
è anche il potenziale beneficio aggiuntivo di ridurre
l’incidenza di complicanze microvascolari (retinopatia e nefropatia). Non esiste uno studio clinico randomizzato, controllato con placebo, sull’effetto del trattamento dell’ipertensione nel paziente diabetico. Le
informazioni in nostro possesso sui benefici del trattamento antipertensivo nel paziente diabetico derivano dall’analisi di sottogruppi di pazienti inseriti in
studi più ampi di popolazione, oppure da studi di
confronto tra farmaci.
La tabella I elenca una serie di studi recentemente
conclusi. Alcuni hanno comportato il confronto con
placebo (SHEP, Syst-EUR), altri hanno confrontato
farmaci o categorie di farmaci (UKPDS, CAPPP, STOP2, ALLHAT), altri infine hanno confrontato differenti
livelli di pressione diastolica (HOT). La maggior parte
di questi studi ha comportato un’analisi cosiddetta
“post-hoc” (di sottogruppi); solo l’UKPDS prevedeva
un’analisi che concordava con lo scopo dello studio.
Lo studio HOPE non è stato uno studio d’intervento,
bensì di prevenzione farmacologica in soggetti non
ipertesi. Sia pur con le limitazioni sopraindicate, l’insieme dell’evidenza scaturita da questi studi sembra
aver convinto molti medici e società scientifiche che
il controllo più attento e, per usare un aggettivo di
moda, aggressivo della pressione arteriosa nell’iperteso diabetico dia molti più frutti in termini di prevenzione delle complicanze cardiovascolari. In concreto, ciò significa che dobbiamo trattare la pressione
arteriosa con più vigore e forza nel paziente diabeti-
TAB. I. Sommario di alcuni importanti
studi di intervento sulla pressione arteriosa
in soggetti diabetici
Follow-up
(anni)
Numerosità
Analisi
• SHEP (1996)
4,5
4732 (583)
post-hoc
• HOT (1998)
4,0
18.790 (1501)
post-hoc
• UKPDS (1998)
8,4
1148
primaria
• Syst-EUR (1999)
2,0
4695 (492)
post-hoc
• CAPPP (1999)
6,1
10.985 (572)
post-hoc
• STOP-2 (1999)
5
6614 (719)
post-hoc
• HOPE (2000)
4,5
3577
primaria
• ALLHAT (2000)
3,3
24.335 (8662)
post-hoc
Studio
co, in modo da ottenere livelli più bassi di quelli che
sono attualmente indicati come desiderabili per la
popolazione non diabetica.
Obiettivo pressorio
Sulla base delle evidenze emerse dagli studi clinici, gli
obiettivi che devono essere raggiunti con la terapia
antipertensiva nel paziente diabetico e iperteso sono
stati già indicati da alcune importanti società scientifiche nel corso dello scorso anno (1999). In particolare, l’American Diabetes Association, l’American Heart
Association e l’OMS concordano su un obiettivo pressorio di 130/85 mmHg. È molto verosimile che questi
obiettivi saranno sponsorizzati da altre società scientifiche, in un’ottica di messaggi coerenti e semplici da
suggerire al medico per migliorare il destino cardiovascolare del paziente diabetico.
È interessante la concordanza sull’obiettivo 130
mmHg per la pressione sistolica: nello studio UKPDS,
la riduzione di 10 mmHg della pressione sistolica si
associa con la riduzione del 12% di tutti gli eventi considerati, del 13% del rischio d’infarto e di ictus. Poiché
il rischio di eventi cardiovascolari si correla in modo
lineare con la pressione arteriosa, senza una soglia,
rimane ancora senza risposta la domanda: quanto in
basso possiamo spingerci? Realisticamente dovrebbe
esserci un livello di pressione oltre il quale non sarebbe
opportuno spingersi, soprattutto nelle persone anziane, ma l’evidenza dice che questo livello non è stato
ancora trovato. I dati dello studio HOT hanno avuto
una pesante influenza sull’obiettivo espresso per la
pressione diastolica: con una pressione di 144/81
mm Hg ottenuta, l’incidenza di complicanze cardiovascolari nei pazienti diabetici è risultata minore
rispetto al gruppo in cui il livello pressorio raggiunto
era un poco più alto (148/85 mmHg), con una chiara e sostanziale differenza per valori di diastolica inferiori o uguali a 80 mmHg. Esiste una stretta concordanza con i valori pressori ottenuti nel braccio intensivo dell’UKPDS, dove questo gruppo aveva un livello di pressione di 144/82 mmHg, rispetto ai 154/87
mmHg del gruppo trattato meno intensivamente.
Poiché in nessuno studio è stato possibile ottenere un
livello stabile di pressione sistolica uguale o inferiore a
130 mmHg, è lecito supporre che l’obiettivo indicato
per la sistolica rappresenti più un’estrapolazione a
posteriori, oltre che un augurio di successo dell’intervento terapeutico, piuttosto che un valore adeguatamente sperimentato. Probabilmente ha giocato
anche un ruolo l’evidenza che l’abbassamento della
pressione di polso (sistolica meno diastolica) deve
160
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
essere un obiettivo da non sottovalutare nella riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso, in
particolare l’anziano, sia esso diabetico o meno (5).
nel paziente diabetico sono più bassi di quelli desiderabili nel soggetto non diabetico: un obiettivo di 130140 mmHg per la sistolica e di 80 mmHg per la diastolica sembra realistico e deve essere perseguito”.
Controllo dell’ipertensione
vs controllo dell’iperglicemia
In tema di messaggi che circolano, è stato fatto notare peraltro che la riduzione intensiva della pressione
arteriosa nel paziente diabetico iperteso è più efficace, in termini di salute guadagnata, rispetto al trattamento intensivo della glicemia. Questa affermazione
è apparentemente razionale, trovando conferma nei
dati dello studio UKPDS; tuttavia è probabilmente
erroneo incentrare il problema in questi termini,
come a voler cercare un’eguaglianza, in termini di
beneficio per la salute cardiovascolare, tra la riduzione di una data quantità di millimetri di mercurio della
pressione e di emoglobina glicata. Rimane la constatazione che la terapia ipoglicemizzante è gravata da
molti fallimenti, superiori a quelli che si riscontrano
nell’ipertensione arteriosa, e che la soglia glicemica,
superata la quale comincia a emergere il rischio, è
probabilmente più bassa per la malattia cardiovascolare (110 mg/dL). Appare giustificata la preoccupazione che questa dicotomia di priorità d’intervento
possa far passare in secondo piano l’approccio globale al paziente diabetico che prevede un intervento sul
rischio cardiovascolare totale. Sempre nello studio
UKPDS è stato dimostrato che il rischio di ogni evento aumenta di 5-6 volte per valori di emoglobina glicata >8% e per valori di pressione sistolica >150
mmHg presenti contemporaneamente. Questo verosimilmente significa la necessità di due o tre farmaci
antipertensivi, una terapia ipolipidemizzante, e l’uso
di aspirina, aggiunti alla migliore terapia possibile per
il controllo della glicemia. Sono caldamente attesi i
commenti degli economisti sanitari circa l’efficacia, in
termini di investimenti di risorse, di questi interventi.
Allo stato attuale, abbiamo già la consapevolezza del
numero dei pazienti da trattare per evitare una complicanza in un periodo di cinque anni (tabella II).
TAB. II. Numero di pazienti da trattare
negli studi presi in esame per evitare
una complicanza in 5 anni
UKPDS
Eventi correlati al diabete
12,2
HOT
Eventi cardiovascolari maggiori
16,0
HOPE
Eventi cardiovascolari maggiori
13,5
Syst-EUR
Eventi cardiovascolari maggiori
5,6
Bibliografia
1. Gu K, Cowie CC, Harris ML. Diabetes and decline in
heart disease mortality in US adults. JAMA 281, 12911297, 1999
2. Haffner SM, Letho S, Roumlnnema A et al: Mortality from
coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes
and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 339, 229-234, 1998
3. Van den Hoogen PGW, Feskens EJM, Nagelkerke NJD et
al, for the Seven Countries Study Research Group: The
relation between blood pressure and mortality due to
coronary heart disease among men in different part of
the world. N Engl J Med 342, 1-8, 2000
4. The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)
Study Investigators: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes
mellitus: results of the HOPE study and micro-HOPE
substudy. Lancet 355, 253-259, 2000
5. Blacher J, Staessen JA, Girerd X et al: Pulse pressure not
mean pressure determines cardiovascular risk in older
hypertensive patients. Arch Intern Med 160, 10851089, 2000
QUALI SONO I FARMACI
Ridurre la pressione è efficace
La riduzione della pressione arteriosa nel paziente
diabetico è efficace nel diminuire la morbilità e la
mortalità cardiovascolare. Per quanto concerne la
domanda che ha costituito l’oggetto di questo intervento, l’autore conclude con quanto segue.
“I livelli di pressione arteriosa cui bisogna tendere
161
ANTIPERTENSIVI PREFERIBILI
NEL PAZIENTE DIABETICO?
G. MANCIA, G. GRASSI
Clinica Medica, Dipartimento di Medicina Clinica - Prevenzione e Biotecnologie Sanitarie, Università di Milano Bicocca, Ospedale San Gerardo di Monza, Milano
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
Per affrontare adeguatamente il quesito di quali farmaci devono essere usati nel paziente iperteso è
necessario trattare i seguenti aspetti del problema. È
utile ridurre la pressione arteriosa del diabetico con
pressione elevata, qualunque sia la terapia farmacologica adottata? Quali sono i valori di pressione che si
deve cercare di raggiungere? Vi sono in tal senso farmaci e strategie terapeutiche preferibili rispetto ad
altre? E infine, possono eventuali differenze o somiglianze di efficacia antipertensiva e protezione cardiovascolare tra i diversi farmaci essere stabilite con
certezza sulla base degli studi correnti, che per ovvie
ragioni tecniche sono limitati a pochi anni della vita
del paziente?
Utilità della riduzione della pressione
arteriosa nel diabetico iperteso
Non vi è alcun dubbio che nel paziente diabetico e
iperteso una riduzione della pressione arteriosa abbia
un effetto protettivo, qualunque sia il farmaco o i farmaci impiegati per ottenerla. Ciò si può evincere dai
risultati dello studio SHEP (1), nel quale pazienti diabetici e non con ipertensione sistolica isolata mostravano una chiara riduzione di mortalità cardiovascolare quando la pressione veniva ridotta con l’impiego di
un diuretico tiazidico, eventualmente associato a un
β-bloccante. Si può inoltre evincere dai risultati di altri
studi che hanno dimostrato come una altrettanto
chiara riduzione di patologia cardiovascolare si ottenesse in pazienti ipertesi sistolici o sisto-diastolici con
terapie basate sull’impiego di calcio-antagonisti (2) o
di ACE-inibitori (3). Ottenere una riduzione di pressione arteriosa nel paziente nel quale l’ipertensione si
accompagna a diabete è pertanto necessario, perché
il beneficio è in prima istanza verosimilmente legato
alla riduzione della pressione in sé. Ciò viene perseguito con misure antipertensive di carattere non farmacologico, che nel diabetico possono avere importanza particolare anche ai fini di contribuire all’attenuazione dell’elevato profilo di rischio cardiovascolare. Va però di solito anche perseguito con l’impiego
di farmaci antipertensivi, inclusi, se necessario, diuretici e β-bloccanti. Il raggiungimento di tale obiettivo
riveste una grande importanza anche perché l’entità
del beneficio nei pochi anni successivi all’inizio della
terapia è in genere correlata al rischio iniziale del
paziente ed è quindi maggiore nel paziente diabetico
che nel non diabetico. Ciò è stato messo in luce in
modo assai evidente dallo studio Syst-EUR su pazienti anziani con ipertensione sistolica che mostravano,
quando diabetici, una riduzione del rischio a seguito
della riduzione della pressione più che doppia rispetto ai non diabetici (2).
Pressione arteriosa da raggiungere
con la terapia
Poiché la pressione da raggiungere con la terapia non
può essere determinata all’inizio, i valori di sistolica e
diastolica che definiscono la massima protezione del
paziente ottenibile con i farmaci antipertensivi non è
stata stabilita con precisione. È invece ormai acquisito
che nel diabetico iperteso una drastica riduzione
della pressione arteriosa sotto i 90 mmHg di diastolica si accompagna non solo a una maggiore protezione renale (nel caso di concomitante nefropatia),
ma anche a un netto ulteriore beneficio in termini di
patologia macro e micro-vascolare (4, 5). In questo
senso è preferibile raccomandare come obiettivo
valori diastolici il più vicino possibile a 80 mmHg e
valori sistolici inferiori a 140 o anche 130 mmHg (6).
Anche una ulteriore riduzione di 3-4 mmHg di pressione diastolica andrà perseguita con tenacia, perché
nei pazienti diabetici ipertesi, e forse negli ipertesi ad
alto rischio, tale piccola differenza di valori pressori
può accompagnarsi a una cospicua differenza di
morbilità e mortalità. Ciò è particolarmente desumibile dai risultati dello studio HOT, nel quale il raggiungimento di pressione diastolica di 81 mmHg si
accompagnava, nel diabetico iperteso, a una riduzione di eventi patologici cardiovascolari del 50%
rispetto al raggiungimento di pressioni diastoliche di
85 mmHg. È anche desumibile dallo studio HOPE
(7), nel quale i pazienti diabetici mostravano una
netta riduzione di patologia cardiovascolare per piccolissime riduzioni, di pressione diastolica o sistolica,
e ciò anche quando i valori pressori di partenza
erano nettamente inferiori a 140/90 mmHg.
Diversità tra farmaci antipertensivi
Come ricordato din precedenza, tutti i farmaci con
dimostrata efficacia antipertensiva possono essere
impiegati nel paziente diabetico, considerato che l’obiettivo primario è una cospicua riduzione della pressione arteriosa. I “trial” con disegno sperimentale
controllato fino ad ora disponibili non hanno chiarito
se, rispetto ai farmaci più tradizionali come diuretici e
β-bloccanti, classi di farmaci più nuovi, se pur da anni
di largo impiego, sono più protettivi. Da un lato infatti lo studio CAPPP (3) ha mostrato una riduzione di
162
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
mortalità cardiovascolare nei pazienti diabetici trattati con ACE-inibitore rispetto a quelli trattati con terapia tradizionale. Ciò non è risultato essere vero nello
studio UKPDS (8) e nel recente studio INSIGHT (9)
nel quale il numero di eventi patologici cardiovascolari risultò non significativamente diverso in terapia
con un ace-inibitore o con un calcio-antagonista,
rispetto alla terapia β-bloccante o diuretica, rispettivamente. Dati conclusivi non sono neppure disponibili a riguardo di una eventuale differenza tra le capacità protettive di calcio-antagonisti e ACE-inibitori.
Lo studio FACET, che ha concluso a favore dei secondi, può essere infatti criticato sotto vari aspetti (10).
Inoltre l’analoga conclusione raggiunta per i diabetici ipertesi reclutati nello studio ABCD si è rivelata
essere influenzata in modo decisivo da una frequenza di complicanze notevolmente ridotta nel gruppo
in terapia con ACE-inibitori (11) e non è stata di
recente confermata dai dati calcolati per i pazienti
diabetici normotesi (12). Si deve pertanto concludere che la protezione cardiovascolare ottenibile nel
diabetico iperteso nei primi anni successivi all’inizio
della terapia antipertensiva non è sostanzialmente
diversa per i diversi farmaci.
Protezione a lungo termine
Il fatto che i trial sino ad ora eseguiti non abbiano
mostrato differenze di incidenza di eventi patologici
cardiovascolari con l’impiego di diverse classi di farmaci non consente di affermare in modo conclusivo
che tali differenze non esistano. Bisogna in primo
luogo considerare che in alcuni casi gli studi non avevano la potenza necessaria per dimostrare statisticamente eventuali differenze (8), problema verosimilmente destinato a soluzione con l’uso meta-analitico
dei dati ottenuti dai trial in corso, per un totale di oltre
30.000 pazienti diabetici (13). Vi è inoltre anche da
considerare che i trial disponibili attualmente o nel
prossimo futuro non saranno in grado di rispondere al
quesito delle eventuali differenze di protezione cardiovascolare sul lungo termine, protezione che riflette
più completamente di quella misurabile nell’arco di
pochi anni l’efficacia preventiva dei diversi interventi
terapeutici. Tale efficacia si manifesta soprattutto
attraverso la prevenzione dell’insorgenza o dell’aggravamento di altri fattori di rischio cardiovascolare associati a ipertensione e diabete nonché, e in misura forse
ancora più importante, alla prevenzione del danno
d’organo che progredisce silenziosamente per anni
prima di emergere con complicanze cliniche. Sarà
importante per la ricerca futura in questo campo otte-
nere informazioni sempre più complete sulla analoga
o diversa capacità dei diversi farmaci antipertensivi di
prevenire lesioni strutturali cardiache e rimodellamento e aterosclerosi vascolari, nonché di ottenere
dati conclusivi sul loro effetto favorevole sul profilo
glicemico, onde estendere i dati sulla prevenzione
nel diabetico iperteso a una finestra temporale più
adeguata. In questo contesto i risultati di alcuni trial
(4, 9) che dimostrano come la terapia con calcioantagonisti e ACE-inibitori si accompagni a una
minor incidenza di nuovi casi di diabete rispetto alla
terapia convenzionale, possono essere clinicamente
importanti.
Bibliografia
1. SHEP Cooperative Research Group: Prevention of stroke by hypertensive drug treatment in older persons
with isolated systolic hypertension. JAMA 265, 3255324, 1991
2. Toumilehto J, Rastenyte D, Birkenhager WH et al:
Effects of calcium-channel blockade in older patients
with diabetes and systolic hypertension: Systolic
Hypertension in Europe Trial Investigators. N Engl J
Med 340, 677-684, 1999
3. Hansson L, Lindholm LH, Niskanen L et al, for the
CAPPP Study Group. Principal results of the Captopril
Prevention Project (CAPPP). Lancet 353, 611-616,
1999
4. Hansson L., Zanchetti A, Carruthers SG, et al, for the
HOT Study Group: Effects of intensive blood pressure
lowering and low-dose aspririn in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal
Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 351, 17551762, 1998
5. UK Prospective Diabetes Study Group: Tight blood
pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. Br
Med J 317, 703-713, 1998
6. Guidelines Subcommittee. 1999 World Health Organization/International Society of Hypertension Guidelines
of the management of hypertension. J Hypertens 17,
151-83, 1999
7. The HOPE Study investigators: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with
diabetes mellitus: results of the Hope study and
MICRO-HOPE substudy. Lancet 355, 253-59, 2000
8. UK Prospective Diabetes Study Group: Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular
and microvascular complications in type 2 diabetes:
UKPDS 39. Br Med J 317, 713-20, 1998
9. Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A et al: Morbidity and
mortality in 6321 patients randomized to double blind
treatment with once-a-daily calcium channel blocker or
diuretic in the International Nifedipine GITS Study.
Lancet 2000; in pubblicazione
163
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
10. Tatti P, Pahor M, Byington RP: Outcome results of the
fosinopril versus amlodipine cardiovascular events randomised trial (FACET) in patients with hypertension
and NIDDM. Diab Care 21, 597-603, 1998
11. Estacio RO, Jeffers BW, Hiatt WR et al. The effects of
nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients with non-insulin-dependent
diabetes and hypertension. N Engl J Med 338, 645-52,
1998
12. Gress TW, Nieto FJ, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL:
Hypertension and Antihypertensive Therapy as Risk
Factors for Type 2 Diabetes Mellitus. N Engl J Med 342,
905-912, 2000
13. World Health Organization-International Society of
Hypertension Blood Pressure Lowering Treatment
Trialists’ Collaboration: Protocol for prospective collaborative overviews of major randomized trials of blood
pressure lowering treatments. J Hypertens 16, 127-137,
1998
L’ASSOCIAZIONE DEI FARMACI
È NECESSARIA IN MOLTI CASI?
VI SONO ALCUNE ASSOCIAZIONI
PIÙ INDICATE?
B. TRIMARCO
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari
e Immunologiche, Università “Federico II”, Napoli
Le linee guida per il trattamento dell’ipertensione
arteriosa emanate nel 1993 dalla Società Internazionale dell’Ipertensione e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a proposito del trattamento farmacologico dell’ipertensione arteriosa indicano due possibili strategie: la somministrazione di un’unica sostanza a dosaggio pieno o, in alternativa, l’impiego di due
sostanze a dosaggio ridotto. Questo secondo approccio trova verosimilmente la sua principale giustificazione nel tentativo di ridurre la probabilità d’insorgenza di effetti collaterali; tuttavia esistono alcune considerazioni che possono costituire ulteriori elementi di
supporto alla terapia di associazione, anche nel caso
fossero necessari dosaggi completi dei due farmaci. È
stato infatti descritto in studi comprendenti popolazioni diverse che non più del 20% dei pazienti ipertesi sottoposti a terapia antipertensiva mostra un controllo soddisfacente della pressione arteriosa, vale a
dire esibisce valori di pressione arteriosa inferiori a
quelli ritenuti patologici (1). Un’analisi più approfondita di questi dati consente di rilevare che in una percentuale non secondaria di questi pazienti il cattivo
controllo dei valori pressori sembra ascrivibile a una
scarsa compliance del paziente alla terapia, mentre in
molti altri casi esso è dovuto alla solo parziale efficacia
del trattamento instaurato. D’altra parte, per quel che
riguarda la compliance, è ben noto che l’aderenza del
paziente alla terapia si riduce progressivamente
aumentando in numero giornaliero delle compresse
da assumere (2). È evidente che, se la questione viene
posta in questi termini, essa sembra irrisolvibile in
quanto la soluzione di uno dei problemi posti porterebbe inevitabilmente a peggiorare l’altro. Tuttavia la
possibilità di avere più principi attivi in un’unica compressa può rappresentare in questo contesto il caratteristico uovo di Colombo. Peraltro questa scelta
terapeutica non è completamente scevra di rischi, se
non vengono utilizzate determinate cautele. Infatti,
è evidente che la somministrazione contemporanea
di due farmaci, con meccanismo d’azione simile
comporterà un minor vantaggio per l’effetto antipertensivo e maggiori rischi per gli effetti collaterali.
Al contrario, l’impiego simultaneo di farmaci il cui
effetto antipertensivo si realizza mediante differenti
meccanismi di azione, risulta particolarmente utile
perché consente un completo sinergismo dei due
composti. Anche in questo caso però non va considerato soltanto l’effetto di riduzione della pressione
arteriosa, ma anche quelli di prevenzione o regressione del danno d’organo.
Efficacia antipertensiva
I risultati degli studi epidemiologici e dei trial clinici
hanno evidenziato una stretta correlazione tra ipertensione arteriosa ed eventi cardio- e cerebrovascolari. A tal proposito una metanalisi (3) condotta sui
risultati di nove dei maggiori studi prospettici osservazionali comprendenti 420.000 soggetti con anamnesi negativa per patologie cardiovascolari maggiori
al momento dell’arruolamento e seguiti per un periodo medio di 10 anni mostra un’associazione continua
e indipendente tra i valori di pressione arteriosa e il
rischio di accidenti cerebrali o di cardiopatia ischemica. In particolare un aumento della pressione arteriosa diastolica di 5 o 10 mmHg è associata a un incremento del rischio cardiovascolare del 21 o del 37%
rispettivamente. Dal momento che l’obiettivo del
trattamento antipertensivo è quello di ridurre l’eccedenza di eventi cardio- e cerebrovascolari associati
alla presenza di valori pressori al di sopra della norma,
è evidente che, per raggiungere un tale obiettivo, è
necessaria una completa normalizzazione della pressione arteriosa.
A questo proposito è opportuno ricordare l’osservazione pubblicata da Menard (4) su 11.613 pazienti in
164
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
trattamento antipertensivo reclutati in Italia,
Spagna, Inghilterra e Germania. Soltanto il 37% dei
pazienti mostrava valori di pressione diastolica contenuti entro il limite fissato dal medico curante.
D’altra parte questo risultato sorprende solo parzialmente quando si considera che in studi clinici controllati il trattamento antipertensivo con un solo farmaco è risultato efficace in una percentuale di
pazienti compreso tra il 60% dei calcio-antagonisti
e il 45% dei diuretici, bloccanti del recettore α-adrenergico e inibitori dell’enzima di conversione. Né
questo risultato sembra migliorabile con la disponibilità attuale dei farmaci antagonisti recettoriali dell’angiotensina II. È evidente tuttavia la necessità di
potenziare la terapia antipertensiva così da ottenere
una reale normalizzazione dei livelli pressori. Questo
obiettivo sembra raggiungibile con l’impiego di
associazioni farmacologiche. Infatti, da una parte,
gli studi che hanno raffrontato l’effetto antipertensivo dei singoli componenti con quello della terapia di
combinazione hanno concordemente dimostrato
che quest’ultima è in grado di indurre una caduta
della pressione superiore a quella ottenibile con la
monoterapia (5); dall’altra, è noto che la percentuale dei pazienti che non mostra una riduzione della
pressione diastolica al di sotto dei 90 mmHg durante terapia antipertensiva di combinazione oscilla
intorno all’80%.
Prevenzione e regressione
del danno d’organo
La riduzione della mortalità e della morbilità collegata all’ipertensione arteriosa richiede anche un programma terapeutico volto prevalentemente a contrastare i meccanismi biologici, non dipendenti dalla
pressione arteriosa, coinvolti nella insorgenza e nella
progressione delle alterazioni strutturali cardiovascolari nei pazienti ipertesi. Ad esempio, va considerato
che gli effetti metabolici e neuro-ormonali indesiderati (iperglicemia, ipercolesterolemia, ipopotassiemia, iperuricemia, attivazione del sistema reninaangiotensina-aldosterone) indotti dai β-bloccanti e
dai diuretici possono spiegare la solo parziale efficacia di questi farmaci di prevenire lo sviluppo della
cardiopatia ischemica negli ipertesi, nonostante la
loro provata efficacia antipertensiva. Attualmente
l’associazione dei diuretici con i β-bloccanti può
essere accettata dal momento che i β-bloccanti riducono l’attivazione del sistema renina-angiotensina
indotta dalla deplezione di sale causata dai diuretici.
L’associazione dei diuretici con gli ACE-inibitori è
comunque preferibile, poiché gli ACE-inibitori non
solo annullano l’effetto negativo dei diuretici sul
sistema renina-angiotensina, ma esercitano anche
un’azione favorevole sul metabolismo glicidico e
soprattutto sul bilancio elettrolitico, contrastando
così gli effetti metabolici negativi dei diuretici.
Un’altra associazione da considerare è quella tra calcio-antagonisti e ACE-inibitori. Questa associazione
farmacologica ha il vantaggio di possedere un effetto antipertensivo sinergico mediato da una vasodilatazione periferica indotta attraverso differenti vie, e
di non interferire negativamente con il metabolismo
glicidico e lipidico.
In particolare la terapia antipertensiva di combinazione mediante l’effetto sinergico di farmaci appartenenti a queste due diverse classi sembra offrire
grandi vantaggi, rispetto alla monoterapia, nei
pazienti ipertesi con cardiopatia ischemica, in cui la
somministrazione contemporanea di ACE-inibitori e
di calcio-antagonisti appare particolarmente efficace. L’effetto antiproliferativo degli ACE-inibitori sulla
parete miocardica e vascolare, i loro effetti emodinamici, l’azione antiaterogena, la modulazione neuroormonale possono spiegare la capacità di questa
classe di farmaci di ridurre il rischio di eventi correlati alla cardiopatia ischemica. Tuttavia, sebbene ci si
possa attendere dagli ACE-inibitori, oltre a una riduzione della pressione arteriosa, un incremento del
flusso coronarico, una riduzione della pressione di
riempimento ventricolare e dell’attività simpatica,
non è stato ancora ben dimostrato un effetto antischemico di tali farmaci. Al contrario i calcio-antagonisti si sono dimostrati in grado di esercitare un’attività vasodilatatrice a livello sistemico e soprattutto
coronarico. Questo effetto, insieme a quello negativo sul consumo di ossigeno miocardico, li pone in
primo piano come farmaci per il trattamento sintomatico della cardiopatia ischemica.
ACE-inibitori e calcio-antagonisti esplicano effetti
complementari anche a livello della parete vascolare
(6): i primi, inibendo l’attività dell’ACE, bloccano la
formazione di angiotensina II e prevengono la
degradazione della bradichinina, la cui azione vasodilatante si esprime stimolando la formazione di ossido nitrico e di prostaciclina. In particolare essi sembrano in grado di correggere la disfunzione endoteliale tipica del paziente iperteso, ristabilendo una
correlazione fisiologica tra variazioni del consumo
d’ossigeno e del flusso coronarico durante attivazione simpatica (7). I calcio-antagonisti neutralizzano
l’azione vasocostrittrice di ormoni quali l’endotelina
a livello della muscolatura liscia vascolare, bloccando
l’ingresso del calcio e facilitando l’azione vasodila-
165
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
tante dell’ossido nitrico (8). Riducendo la proliferazione delle cellule muscolari lisce parietali, i calcioantagonisti esercitano inoltre un’azione vascolare
protettiva prevenendo la formazione e lo sviluppo di
placche aterosclerotiche (6). La complementarietà di
azione di ACE-inibitori e calcio-antagonisti si esplica
anche in termini di effetti nefroprotettivi. A livello
renale ACE-inibitori e calcio-antagonisti contribuiscono alla riduzione della escrezione urinaria di albumina e alla diminuzione della pressione intraglomerulare, il cui incremento è responsabile del danno
renale secondario a ipertensione arteriosa, diabete e
aterosclerosi. Ancora una volta l’effetto dei due farmaci si esplica in maniera complementare: gli ACEinibitori riducono le resistenze a livello dell’arteriola
efferente, mentre i calcio-antagonisti esercitano la
loro azione vasodilatante sia a livello dell’arteriola
afferente che di quella efferente (6).
Una considerazione a parte merita l’associazione di
ACE-inibitori e antagonisti AT1 dell'angiotensina II.
L'uso combinato di queste due classi di farmaci
potrebbe essere infatti particolarmente utile per la
prevenzione della nefropatia, ma non ha un razionale tanto forte da poter essere considerato in prima
istanza. Infatti, innanzitutto i lavori che hanno dimostrato che l’aggiunta di una di queste classi di farmaci alla terapia di pazienti già in trattamento con l’altra determina un’ulteriore riduzione della pressione
arteriosa, non consentendo di escludere che un
effetto analogo si sarebbe potuto ottenere anche
con un aumento del farmaco già in corso. In secondo luogo esiste oggi una documentata possibilità
che l’angiotensina II, che non può più legarsi ai
recettori AT1 occupati dall’antagonista, possa indurre un aumento dell’espressione dei recettori AT2,
ordinariamente poco espressi. Questi ultimi hanno
effetti emodinamici e biochimici opposti a quelli dei
recettori AT1, per cui è verosimile che l’aumento della
loro presenza possa contribuire a potenziare gli effetti del blocco del recettore AT1, spiegando così la
ragione della latenza necessaria per ottenere una
risposta completa con gli AT1 antagonisti. La somministrazione contemporanea degli ACE-inibitori, riducendo la sintesi di angiotensina II, potrebbe determinare gli effetti mediati dalla stimolazione del recettore AT2. Infine, anche l’assunto che l’aggiunta degli
ACE-inibitori alla terapia con AT1 bloccanti potrebbe
assicurare il coinvolgimento della bradichinina nella
risposta antipertensiva, non sembra del tutto corretto. È stato infatti dimostrato che la stimolazione del
recettore AT2 dell’angiotensina è in grado di stimolare l’attività dell’enzima che controlla la sintesi di chinine e quindi anche durante il trattamento con anta-
gonisti recettoriali dell’angiotensina si ha un aumento della concentrazione di bradichinina, per un
aumento della sintesi invece che per un rallentamento del catabolismo, come accade con gli ACE-inibitori. Al contrario, la somministrazione combinata di
queste due classi di farmaci potrebbe risultare utile
nel trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca che, a differenza dei pazienti ipertesi, sono caratterizzati da un elevato tono del sistema reninaangiotensina-aldosterone e presentano il tipico
“escape” del blocco dell’aldosterone da parte degli
ACE-inibitori.
Bibliografia
1. Materson BJ, Reda DJ, Cushman WC, Masie BM, Freis
ED, Kochar MS: Single-drug therapy for hypertension in
men. NEJM 328, 914-921, 1993
2. Frishman WH, Venkata S. Ram C, MacMahon FG,
Chrysant SG, Graff A, Kupiec JW, Hsu H, for the
Benazepril/Amlodipine Study Group: Comparison of
amlodipine and benazepril monotherapy to amlodipine plus benazepril in patients with systemic hypertension: a randomized, double-blind, placebo-controlled,
parallel group study. J Clin Pharmacol 35, 1060-1066,
1995
3. MacMahon S, Peto R, Cutler J et al: Blood pressure,
stroke, and coronary heart disease. Part I. Effects of
prolonged differences in blood pressure. Evidence
from nine prospective observational studies corrected
for the regression dilution bias. Lancet 335, 765-774,
1990
4. Menard J, Chatellier G: Integration of trial, meta-analysis and cohort results with treatment guidelines. J
Hypertens 14 (2), S129-S133, 1996
5. Kannel WB, Dauenberg AL, Levy D: Population implications of electrocardiographic left ventricular hypertrophy. Am J Cardiol 60, 851-931, 1987
6. Lüscher TF, Wenzel RR, Moreau P, Takase H: Vascular
protective effects of ACE inhibitors and calcium antagonists: theoretical basis for a combination therapy in
hypertension and other cardiovascular disease. Cardiovascular Drugs Ther 9, 509-523, 1995
7. Antony I, Lerebours G, Nitenberg A: Angiotensin-converting enzyme inhibition restores flow-dependent and
cold pressor test-induced dilations in coronary arteries
of hypertensive patients. Circulation 94: 3115-3122,
1996
8. Kiowski W, Luscher TF, Linder L, Buhler FR: Endothelin1 induced vasoconstriction in man: reversal by calcium
channel blockade but not by nitrovasodilators or ERDF.
Circulation 83, 469-475, 1991
166
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
LA PRESENZA DI NEFROPATIA
DIABETICA PONE PROBLEMI
PARTICOLARI PER LA TERAPIA
ANTIPERTENSIVA?
G. DEFERRARI, C. CALVI
Nefrologia e Dialisi, Di.M.I, Università di Genova, Genova
La nefropatia diabetica rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale terminale (ESRD) nei
Paesi occidentali e la sua incidenza è destinata ad
aumentare cospicuamente. Durante gli ultimi anni
più di un terzo di tutti i nuovi casi di ESRD in terapia
sostitutiva negli Stati Uniti e il 17% in Europa sono
rappresentati da pazienti diabetici (1); in Italia il 1219% dei nuovi pazienti in terapia sostitutiva è rappresentato da pazienti diabetici (2, 3). Circa la metà dei
nuovi pazienti sono affetti da diabete di tipo 2 (4). La
nefropatia diabetica non è solo causa di ESRD, ma è
frequentemente associata ad aumentata incidenza di
morbilità e mortalità cardiovascolare (5).
È stato Mogensen a definire dettagliatamente la storia naturale della nefropatia diabetica nei pazienti con
diabete tipo 1, evidenziando che circa il 30-35% dei
pazienti progrediscono verso l’ESRD (6). Inizialmente
si sviluppano ipertrofia renale e iperfiltrazione; dopo
circa 7-13 anni nel cosiddetto stadio della “nefropatia
incipiente” compare microalbuminuria e quindi
dopo circa 10-20 anni insorge la nefropatia clinica,
caratterizzata da proteinuria clinica persistente. A
questo stadio il declino del filtrato è pari a 8-10
mlL/min per anno. Nel diabete tipo 2 l’incidenza
cumulativa e il decorso nella nefropatia clinica sono
simili, con un declino del filtrato lievemente più lento
e un’incidenza cumulativa di ESRD di circa il 10% (7).
L’ipertensione è un importante fattore di rischio nella
progressione del danno renale nel diabete. I dati
emersi da numerosi studi dimostrano che l’ipertensione arteriosa si associa frequentemente al danno
renale sia nel diabete di tipo 1 che nel tipo 2 (5, 7, 8).
Una volta comparsa la microalbuminuria, la correzione dello stato ipertensivo è, in associazione al controllo glicemico, lo strumento più efficace per rallentare la progressione verso la nefropatia conclamata
sia nei pazienti con diabete tipo 1 che tipo 2 (7).
Nei pazienti con nefropatia clinica il controllo glicemico sembra non influenzare significativamente l’andamento della nefropatia, benché esso comunque
influenzi le altre sequele micro- e macroangiopatiche
della malattia diabetica; l’ipertensione diventa il fattore determinante nell’accelerare il declino del filtrato e nella progressione verso l’ESRD. Dati emersi da
167
studi longitudinali su pazienti con diabete tipo 1 e
tipo 2 dimostrano una stretta correlazione tra caduta
del filtrato e valori pressori (9, 10). Studi condotti su
pazienti con diabete tipo 1 mostrano come livelli
pressori di circa 135/85 mmHg riescano a rallentare il
declino del filtrato. Tutti i farmaci antipertensivi utilizzati, a parità di livelli pressori ottenuti, si dimostrano
efficaci. Una metanalisi di 9 studi longitudinali eseguiti su pazienti con diabete tipo 1, in trattamento
con farmaci antipertensivi appartenenti a diverse
classi, mostra il ruolo determinante della riduzione
della pressione arteriosa nel ridurre il declino del filtrato glomerulare (7) (fig. 1). Sfortunatamente esistono pochi dati in letteratura riguardanti pazienti con
diabete tipo 2 con nefropatia clinica; studi della durata di almeno 18 mesi suggeriscono che la riduzione
dei valori pressori sia, indipendentemente dal farmaco utilizzato, determinante nel ridurre il declino del
filtrato. Una metanalisi di 5 studi longitudinali disponibili conferma questa affermazione (fig. 2). I dati
recentemente pubblicati dall’UK Perspective Study
Group non dimostrano differenze significative tra
ACE-nibitore e beta-bloccante (11).
Si delinea, quindi, nei pazienti microalbuminurici e
proteinurici, la necessità di raggiungere un controllo
pressorio ottimale. Indipendentemente dalla definizione di pressione arteriosa nella popolazione generale (PA ≥ 140/90 mmHg), il paziente diabetico deve
essere trattato con terapia antipertensiva in presenza
di valori di diastolica ≥ 85 mmHg e di sistolica ≥ 130
mmHg (12, 13). Valori pressori al di sotto di questi
appena citati sono purtroppo molto difficili da ottenere e spesso in presenza di nefropatia clinica è
necessaria l’associazione di più farmaci. A questo pro-
Fig. 1. Relazione tra la pressione arteriosa media e la riduzione del
filtrato glomerulare in pazienti con diabete di tipo 1 e nefropatia
clinica [da Deferrari et al., Diabetes/Metab. Rev., 1997 (7)]
n nessuna terapia antipertensiva; lterapia convenzionale; s ACE-I ±
diuretici; tACE-I + terapia convenzionale; u β-bloccanti ± diuretici.
FG: filtrato glomerulare; PAM: pressione arteriosa media
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
Fig. 2. Relazione tra la pressione arteriosa media e la riduzione del
filtrato glomerulare in pazienti con diabete di tipo 2 e nefropatia
clinica.
lTerapia convenzionale; s ACE-I ± diuretici; u b-bloccanti ± diuretici; 6 Ca-antagonisti
FG: filtrato glomerulare; PAM: pressione arteriosa media
posito è da sottolineare l’importanza di utilizzare tutti
i farmaci a disposizione, in varie combinazioni, ma di
non accontentarsi di un controllo pressorio subottimale. I valori ottimali di pressione arteriosa sono nei
pazienti di età inferiore ai 50 anni di circa 120/70-75
mmHg e di 125-130/80-85 mmHg nei pazienti di età
superiore ai 50 anni (13, 14).
Al di là della riduzione pressoria, esiste evidenza,
ancorché dibattuta, che la terapia con alcuni farmaci
antipertensivi sia particolarmente efficace dal punto
di vista renoprotettivo; sono comunemente considerati da questo punto di vista ACE-inibitori, antagonisti dei recettori dell’angiotensina e anche calcio-antagonisti.
Sempre più numerose evidenze indicano che il sistema renina-angiotensina-aldosterone (SRAA) giochi
un ruolo importante nello sviluppo della nefropatia
diabetica, non solo a livello sistemico ma anche a
livello tissutale. Mentre il SRAA plasmatico è importante per i meccanismi acuti di regolazione, il sistema
tissutale potrebbe essere coinvolto soprattutto nei
meccanismi cronici di regolazione vascolare renale.
L’angiotensina II, i cui livelli sono circa mille volte più
alti nel rene che nel plasma, potrebbe legarsi ai recettori glomerulari e causare contrazione delle cellule
mesangiali e costrizione delle arteriole, afferente e
soprattutto efferente, determinando un’alterazione
del coefficiente di ultrafiltrazione glomerulare e della
pressione capillare glomerulare (15). Questi meccanismi potrebbero provocare proteinuria, iperplasia
delle cellule mesangiali e tubulari, aumentata produzione di matrice mesangiale e, in ultimo, glomerulosclerosi e fibrosi interstiziale (15). L’angiotensina II,
infine, influenza la crescita cellulare sia direttamente
sia attraverso l’azione di numerosi fattori di crescita e
citochine, contribuendo alla proliferazione/ipertrofia
delle cellule mesangiali, aumentata produzione di
matrice extracellulare e riduzione dell’apoptosi e in
questo modo ulteriormente allo sviluppo di glomerulosclerosi e fibrosi interstiziale (15).
Tutti questi effetti sono stati dimostrati sull’animale,
ed è interessante notare come la maggior parte di
questi siano attenuati dagli ACE-inibitori o dagli antagonisti del recettore dell’angiotensina II. I dati emersi
rendono verosimile quindi che l’inibizione farmacologica del SRAA possa giocare un ruolo importante nel
prevenire lo sviluppo e rallentare la progressione della
nefropatia diabetica (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) (16).
Il ruolo degli ACE-inibitori nella prevenzione primaria
è ancora peraltro incerto; un recente studio (17)
dimostra su un buon numero di pazienti seguiti per un
lungo periodo che la terapia con ACE-nibitori è in
grado di ridurre cospicuamente l’incidenza di microalbuminuria in pazienti normoalbuminurici normotesi
con diabete tipo 2. Uno studio simile (EUCLID) su
pazienti con diabete tipo 1 normoalbuminurici ha
dato risultati inconclusivi (18). Lo studio POND è in
fase ormai avanzata (comunicazione personale).
Nei pazienti microalbuminurici normotesi, gli ACEinibitori riducono significativamente l’incidenza di
nefropatia clinica. È interessante notare come questo
venga ottenuto indipendentemente dai valori pressori, anche se bisogna sottolineare che in quattro studi
su sei i valori pressori erano lievemente, ma significativamente, più bassi nel gruppo trattato con ACE-inibitore (7, 19). Una recente metanalisi mostra che gli
ACE-inibitori riducono circa dell’80% la progressione
da micro- a macroalbuminuria in pazienti con diabete tipo 1 (13). Tutti questi dati sembrano quindi
dimostrare uno specifico effetto degli ACE-inibitori
nel prevenire lo sviluppo di nefropatia clinica sia nei
pazienti con diabete tipo 1 che tipo 2. Pertanto questi farmaci sono da considerare la prima scelta in questo stadio del danno renale.
Nei pazienti con nefropatia clinica, come riportato in
precedenza, la riduzione della pressione arteriosa a
valori di circa 135/85 sembra avere un ruolo predominante nel rallentare il declino del filtrato glomerulare (figg. 1 e 2), anche se gli studi disponibili sono
ancora pochi, specie nel diabete di tipo 2. Nonostante le controversie sul ruolo specifico degli ACE inibitori a questo stadio, lo studio di Lewis et al. ha portato un contributo rilevante, dimostrando che nei
pazienti con diabete di tipo 1 gli ACE-inibitori riducono significativamente la necessità di terapia sostitutiva e anche la mortalità (20). Anche se nei diabetici
168
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
con nefropatia clinica gli ACE-inibitori non sembrano
essere chiaramente più efficaci di altri farmaci, sono
da considerare tuttavia farmaci di prima scelta, almeno nei pazienti con creatinina inferiore a 3 mg/dL,
non solo per la loro azione renoprotettiva, ma anche
per la loro buona tollerabilità e l’assenza di effetti
negativi sul metabolismo glico-lipidico (7, 13).
Negli ultimi anni l’introduzione degli antagonisti del
recettore dell’angiotensina II, capaci di contrastare
l’effetto periferico dell’angiotensina II sfruttando l’inibizione del SRAA a un livello diverso della cascata, ha
riscosso grande interesse. I risultati del lavoro di
Gansevoort (21), che pone a confronto ACE-inibitori
e antagonisti del recettore, sembrano suggerire un
sovrapponibile effetto antiproteinurico a parità di
valori pressori. Sono necessari quindi ulteriori lavori
clinici che valutino un possibile effetto renoprotettivo
di una più completa inibizione del SRAA; due studi,
IDNT e RENAAL, sono in fase conclusiva.
Recentemente si è sviluppato notevole interesse per il
possibile effetto renoprotettivo dei calcio-antagonisti. Questi farmaci, dilatando preferibilmente l’arteriola afferente, dovrebbero causare un aumento della
pressione intraglomerulare, a lungo termine nociva
alla funzione renale. Tuttavia la riduzione dell’ipertrofia renale, una possibile modulazione degli effetti
vasocostrittivi e proliferativi dell’angiotensina, nonché la riduzione degli effetti mitogeni dei fattori di
crescita, potrebbero giocare un ruolo importante nel
ritardare il declino del filtrato (22).
Un recente trial dell’Italian Microalbuminuric Study
Group (19) dimostra che la nifedipina ha un’efficacia
sovrapponibile a un ACE-inibitore, Lisinopril, nel
ridurre l’incidenza di nefropatia clinica in 137 pazienti con diabete tipo 1 microalbuminurici. Anche nei
pazienti con diabete tipo 2 e microalbuminuria questi farmaci esercitano un effetto renoprotettivo simile
agli ACE-inibitori (23-24). Analogo risultato è stato
ottenuto in uno studio nei diabetici tipo 2 protenurici (25).
Deve peraltro essere sottolineato che alcuni studi
suggeriscono una più elevata incidenza di eventi cardiovascolari nei pazienti con diabete tipo 2 ipertesi
trattati con calcio-antagonisti; tali dati non sono stati
tuttavia confermati da vasti trial quali lo studio HOT e
lo studio ALLHAT (13).
È infine da ricordare che un trattamento antipertensivo efficace nei pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2
non solo sembra ridurre la progressione della nefropatia, ma anche il rischio di mortalità; tale effetto è
stato in particolare dimostrato per gli ACE-inibitori
(20, 26, 27).
La Società italiana di Nefrologia e La Società Italiana
di Diabetologia hanno recentemente formulato, in
un documento congiunto, le raccomandazioni per la
prevenzione e il trattamento della nefropatia diabetica, che sono in sintonia con quanto sopra riportato
(13). L’approccio terapeutico comunque deve essere
intensivo e multifattoriale: devono essere raggiunti i
livelli ottimali di pressione arteriosa utilizzando più
farmaci antipertensivi (tra questi gli ACE-inibitori se
non controindicati) deve essere anche ottenuto un
buon controllo glicemico e la correzione della dislipidemia; non va trascurata infine l’assunzione di
antiaggreganti piastrinici (28).
Infine è interessante notare come un buon controllo
dei valori pressori e forse l’uso di ACE-inibitori riescano a prevenire e/o a rallentare l’evoluzione della retinopatia diabetica. Dallo studio EUCLID (18) nel diabete tipo 1 e dai risultati di Ravid et al. nel diabete
tipo 2 (17) emergono risultati confortanti.
Bibliografia
1. D’Amico G: Comparability of the different registries on
renal replacement therapy. Am J Kidney Dis 25, 113118, 1995
2. Marcelli D, Spotti D, Conte F et al: Prognosis in diabetic
patients on dialysis: analysis of Lombardy Registry data.
Nephrol Dial Transplant 10, 1895-1900, 1995
3. Triolo G, Salomone M, Piccoli GB, Torazza ML,
Marciello A: Diabetes mellitus is currently one of the
most frequent causes or associated causes of uremia.
Data from Piedmont Registry of dialysis and transplantation. Minerva Urol Nefrol 48, 31-36, 1996
4. Perneger TV, Brancati FL, Whelton PK, Klag MJ: Endstage renal disease attributable to diabetes mellitus.
Ann Intern med 121, 912-918, 1994
5. Viberti GC, Walker JD, Pinto J: Diabetic nephropathy. In:
Alberti KGMM, DeFronzo RA, Keen H, Zimmet P (Eds):
International Textbook of Diabetes Mellitus. John Wiley
& Sons Ltd, 1992, p. 1267-1328
6. Mogensen CE, Christensen CK, Vittinghus E: The stages
in diabetic renal disease. With enphasis on the stage of
incipient diabetic nephropathy. Diabetes 32, 64-78,
1983
7. Deferrrari G, Cheli V, Robaudo C: Treatment of diabetic
nephropathy in its early stages. Diabetes/Metab Rev
13, 51-61, 1997
8. Mangili R, Deferrari G, Di Mario U et al: Arterial hypertension and microalbuminuria in IDDM: The Italian
microalbuminuria study. Diabetologia 37, 1015-1024,
1994
9. Hasslacher C, Bostedt-Kiesel A, Kempe HP, Wahl P:
Effect of metabolic factors and blood pressure on kidney function in proteinuric type 2 (non-insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 36, 1051-1056,
1993
169
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
10. Rossing P, Hommel E, Smidt UM, Parving HH: Impact of
arterial blood pressure and albuminuria on the progression of diabetic nephropathy in IDDM patients.
Diabetes 42, 715-719, 1993
11. Uk Prospective Study Group: Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 317, 703712, 1998
12. The Sixth Report of the Joint National Committee on
prevention, detection, evaluation and treatment of
high blood pressure. Arch Intern Med 157, 2413-2446,
1997
13. Deferrari G, Cavallo Perin P, Di Paolo S, Locatelli R,
Nosadini R, Penno G, Piccoli G, Robaudo C: Linee guida
della nefropatia diabetica. Giornale Italiano di Nefrologia 17, 47-58, 2000
14. American Diabetes Association: Clinical Practice
Raccomendations 1998: Diabetic Nephropathy. Diabetes Care 21, S7-S12, 1998
15. Dubey RK, Jackson EK, Rupprecht HD, Sterzel RB:
Factors controlling growth and matrix production in
vascular smooth muscle and glomerular mesangial
cells. Curr Opin Nephrol Hypertens 6, 88-105, 1997
16. Parving HH: Renoprotection in diabetes: genetic and
non-genetic risk factors and treatment. Diabetologia
41, 745, 1998
17. Ravid M, Brosh D, Levi Z, Bar-Dayan Y, Ravid D,
Rachmani R: Use of enalapril to attenuate decline in
renal function in normotensive, normoalbuminuric
patients with type II diabetes mellitus. A randomized
controlled trial. Ann Intern Med 128, 982-988, 1998
18. The EUCLID Study Group: Randomized placebo-controlled trial of lisinopril in normotensive patients with
insulin-dependent diabetes and normoalbuminuria or
microalbuminuria. Lancet 349, 1787-1792, 1997
19. Crepaldi G, Carta Q, Deferrari G, Mangili R, Navalesi R,
Santeusiano F, Spalluto A, Vanasia A, Villa GM, Nosadini
R (The Italian Microalbuminuria Study Group in IDDM):
Effects of lisinopril and nifedipine on the progression to
overt nephropathy in IDDM patients with incipient
nephropathy and normal blood pressure. Diabetes
Care 21, 104-110, 1998
20. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD: The effect of
angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic
nephropathy. N Engl J Med 329, 1456-1462, 1993
21. Gansevoort RT, de Zeeuw D, De Jong PE: Is the antiproteinuric effect of ACE inhibition mediated by interference in the renin-angiotensin system? Kidney Intern 45,
861-867, 1994
22. Dworkin LD, Levin RI, Benstein JA et al: Effects of nifedipine and enalapril on glomerular injury in rats with
deoxycorticosterone-salt hypertension. Am J Phisiol
259, F598-F604, 1990
23. Mosconi L, Ruggenenti P, Perna A, Mecca G, Remuzzi
G: Nifendipine and enalapril improve albuminuria and
glomerular filtration rate in non-insulin dependent diabetes. Kidney Intern 49, S91-S93, 1996
24. Velussi M, Brocco E, Frigato F et al: Effects of cilazapril and amlodipine on kidney function in hyperten-
sive NIDDM patients. Diabetes 45, 216-222, 1996
25. Bakris GL, Copley JB, Vicknair N, Sadler R, Leurgans S:
Calcium channel blockers versus other antihypertensive
therapies on progression of NIDDM associated nephropathy. Kidney Intern 50, 1641-1650, 1996
26. Parving HH, Jacobsen P, Rossing K, Smidt UM, Hommel
E, Rossing P: Benefits of long-term antihypertensive
treatment on prognosis in diabetic nephropathy.
Kidney Intern 49, 1778-1782, 1996
27. Sawiki PT, Muhlhauser I, Didjurgeit U, Reimann M,
Bender R, Berger M: Mortality and morbidity in treated
hypertensive type 2 diabetic patients with micro- or
macroproteinuria. Diabetic Medicine 12, 893-898,
1995
28. Geade P, Vedel P, Parving HH, Pedersen O: Intensified
multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: the Steno type 2
randomised study. Lancet 353, 617-622, 1999
COMMENTO FINALE
P. CAVALLO PERIN
La pressione arteriosa è uno degli indici della qualità
della cura del diabete e la correzione dell’ipertensione deve essere inquadrata in un programma generale finalizzato alla riduzione del rischio macro- e
microvascolare. Il paziente diabetico con ipertensione possiede, per definizione, almeno due fattori di
rischio, appunto il diabete e l’ipertensione. Nella
maggior parte dei casi presenta però altri fattori di
rischio associati: dislipidemia, obesità, fumo ecc. La
valutazione del rischio globale nel singolo soggetto
influenza la decisione di iniziare il trattamento antipertensivo e la scelta degli strumenti più appropriati,
consentendo di collocare la correzione della pressione arteriosa in un intervento integrato sugli altri fattori di rischio modificabili. I criteri per la diagnosi di
ipertensione nel diabetico (pressione sistolica o diastolica > 140/90 mmHg) non differiscono da quelli
del soggetto non diabetico e, nell’ambito della
popolazione adulta, non differiscono nel giovane
dall’anziano. I valori di pressione utilizzati come criterio diagnostico per ipertensione non si identificano
con i valori di pressione desiderabili e il paziente diabetico costituisce un tipico esempio in cui l’intervento sulla pressione risulta talora necessario anche in
assenza di ipertensione, come nel caso della microalbuminuria. In generale, valori ≥130/85 mmHg
richiedono un intervento terapeutico non farmacologico e/o farmacologico. I valori entro i quali la
pressione arteriosa deve essere corretta con la terapia devono essere stabiliti in funzione dell’età, delle
complicanze del diabete, delle lesioni cardiovascola-
170
GIDM
Forum
20, 143-170, 2000
ri e del danno agli organi bersaglio dell’ipertensione.
Lo sforzo del medico deve essere rivolto a modificare lo stile di vita del paziente diabetico iperteso e alla
scelta oculata dei farmaci meno svantaggiosi. La
continua informazione del paziente e il monitoraggio a lungo termine delle complicanze del diabete e
delle condizioni degli organi bersaglio dell’ipertensione costituiscono l’elemento indispensabile per
garantire l’efficacia e ridurre i rischi dell’intervento
171
terapeutico. La prevenzione o la ritardata evoluzione
delle lesioni vascolari macro- e microangiopatiche si
traduce in un aumento della sopravvivenza e, fatto
ancora più rilevante, in un miglioramento della qualità di vita del paziente diabetico.
Ringrazio vivamente gli amici che hanno partecipato
al Forum per il tempo e l’impegno che hanno voluto
dedicare per mettere a disposizione di tutti la loro
preparazione ed esperienza.