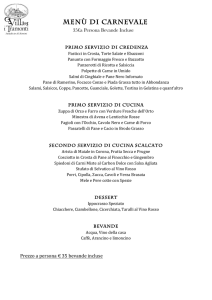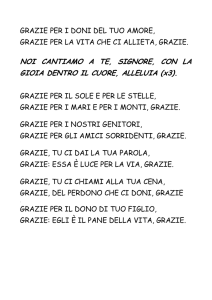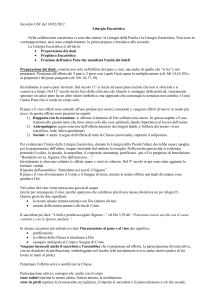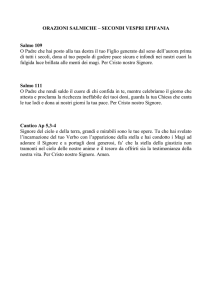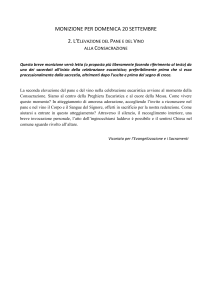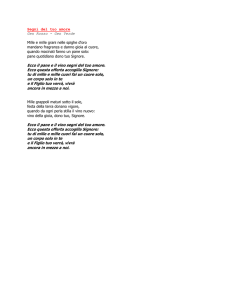IL RITO DELLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Il pane e il vino frutto del lavoro dell’uomo
GOFFREDO BOSELLI
Premessa
Sono stato inviato a riflettere con voi quest’anno sul rito della presentazione dei doni alla
luce del tema di questa Settimana Liturgica Nazionale: “Eucaristia e condivisione”. Personalmente
ritengo che sia non solo sapiente, ma direi perfino provvidenziale la scelta di sostare sul tema
“eucaristia e condivisione” nel preciso momento storico che stiamo vivendo, ovvero la crisi
economica che ormai da due anni colpisce l’occidente. Una crisi nella quale il vangelo chiama noi
cristiani a non essere come gli altri uomini e donne che attendono rassegnati che la crisi passi e tutto
torni come prima. Questo tempo di crisi economica noi cristiani siamo invece chiamati a viverlo
come tempo di krisis, in senso biblico, ossia tempo di discernimento, di decisione, di cambiamento
profondo di mentalità, comportamenti, abitudini e soprattutto di modello di vita.
Se l’eucaristia è, come noi crediamo, la fonte dell’etica cristiana, in questo mio intervento
vorrei riflettere sul rito della presentazione dei doni anzitutto come figura e paradigma dell’etica
cristiana che, in quanto etica eucaristica, è etica di comunione con Dio e di condivisione con i
fratelli e tra di loro soprattutto i più poveri che hanno
bisogno di pane come dei diritti
fondamentali. Cercheremo, in sostanza, di rispondere a una sola domanda: che visione di comunità
cristiana, di convivenza umana, dunque di società e di mondo emerge dal rito della presentazione
dei doni? Oggi è giunto il tempo nel quale nelle comunità cristiane si deve tornare a parlare, come si
è fatto al Concilio e negli anni del post-concilio, del legame tra eucaristia e solidarietà con i poveri,
del rapporto tra eucaristia ed esigenza di giustizia sociale affermando, senza paure e timori, che
l’eucaristia è una fonte di trasformazione sociale. In questa direzione, il gesto di portare all’altare i
doni è quel gesto cultuale, prima ebraico e poi cristiano, nel quale entrano in gioco simultaneamente
e mai l’uno senza l’altro, il fedele che offre, i doni posti sull’altare del Signore e i poveri con i quali
condividere i beni della creazione.
Nella prima parte di questa riflessione andremo alle radici bibliche del comando etico della
presentazione dei doni. Un comando che Gesù nei vangeli radicalizzerà e che la liturgia cristiana
farà suo integralmente. Nella seconda parte sosteremo sul rito della presentazione dei doni così
come oggi lo celebriamo, commentando in particolare le benedizioni sul pane e sul vino. In fine,
concluderemo mettendo a fuco come la presentazione dei doni sia un appello alla responsabilità
etica per l’hodie della chiesa, della società e del mondo intero.
1
Il comando etico della presentazione dei doni e la sua radicalizzazione operata da Gesù
Gli esegeti hanno sufficientemente dimostrato come nel testo molto antico di Deuteronomio
26,1-11, il gesto rituale dell’offerta delle primizie è al tempo stesso memoriale della storia di
Israele, confessione di fede nell’azione di Dio e comando etico da vivere nel presente. Insediato
nella terra di Canaan, Israele è ormai un popolo sedentario e ogni anno, terminata la mietitura, ogni
figlio di Israele deve salire al santuario per portare l’offerta delle primizie del suo raccolto e
ringraziare il Signore per i frutti della terra. Mosè così prescrive nella forma del futuro anteriore:
Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in eredità e la possederai e là ti sarai stabilito,
prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le
metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo Nome. Ti
presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: “Io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono
entrato nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi”. Il sacerdote prenderà la cesta dalle
tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al
Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un immigrato con poca
gente e vi diventò un popolo grande, forte e numeroso. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci privarono dei nostri
diritti e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò
il nostro grido, vide la privazione dei nostri diritti, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, tra grande terrore, operando segni e prodigi. Ci
condusse in questo luogo e ci diede questo paese, una terra dove scorrono latte e miele. Ed ecco, ora io
presento le primizie dei frutti della terra che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Gioirai con il levita e con l’immigrato che sarà in mezzo a te,
di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua famiglia.
Israele fa memoria del passaggio dalla condizione di misera a quella di abbondanza,
ricordandosi che quando divenne schiavo in Egitto il Signore vide il suo essere senza diritti, la
miseria e l’oppressione nelle quali si trovava e, liberando, lo ha condotto in “una terra dove
scorrono latte e miele”. Attraverso un memoriale che intreccia storia e natura, Israele riconosce che
la terra sulla quale si trova è dono di Dio e per questo deve dichiarare un fatto storico preciso: “Io
dichiaro oggi … che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi”.
Il fatto storico è riconosciuto come azione di Dio: il Signore ha realizzato la promessa fatta ai padri.
Questo riconoscimento è una vera e propria confessione di fede, “non è una rivendicazione ‘io
posseggo questa terra perché l’ho conquistata’ – ma un riconoscimento: ‘Io sono entrato nel paese
perché Dio me l’ha donato”1.
Ma il rito della presentazione delle primizie non è solo memoria del passato è anche
memoria del presente, appello alla responsabilità che Israele ha nell’oggi. Il brano del
Deuteronomio termina con il comando etico della condivisione: “Gioirai, con il levita e con
l’immigrato che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua
1 Cf. C. J.H. WRIGHT, Deuteronomio, Edizioni GBU, Roma 2009, p. 393
2
famiglia”. Ciò che hanno in comune il levita e l’immigrato è il non aver diritto a possedere la terra e
dunque vivere della generosità degli altri. Comandando di condividere con il levita e l’immigrato
significa comandare a Israele di essere con quelli che non possiedono ciò che Dio è stato con lui
quando in Egitto era senza diritti e nella miseria. Il ringraziamento nel presentare i frutti della terra
all’altare del Signore “non è quindi la gioia meschina ed egoistica del singolo che si ‘gode’ il suo
pezzo di terra, ma gratitudine di tutti e di ciascuno per un dono da condividere … con i poveri che
non hanno il diritto di appropriarsi dei frutti della terra”2. La riconoscenza manifestata verso il
Signore, attraverso l’offerta simbolica dei frutti della terra, è dunque vera solo se verificata, nel
senso di “fatta vera” nel riconoscimento del povero. Questo significa che “è nella pratica etica della
condivisione che si compie la liturgia d’Israele. Il rito è la figura simbolica della congiunzione tra
l’amore per Dio e l’amore per il prossimo in cui Israele riconoscerà presto … non solo il duplice
comandamento principale, ma il principio stesso di tutta la legge”3, il principio che nel vangelo di
Marco Gesù porterà all’estremo: “Amare Dio e amare il prossimo vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici” (cf. Mc 12,33).
Nella Bibbia, come nella storia delle religioni, portare i doni all’altare significa compiere
l’atto cultuale per antonomasia, e per questo Gesù nei vangeli vi si riferisce radicalizzando il
comando etico del culto di cui già i profeti di Israele erano fatti voce. In Matteo 5,23-24 si legge:
“Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il
tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono” (Mt
5,23-24).
Ecco come l’esegeta Jaques Dupont si immagina la scena descritta da Gesù: “Tra l’arrivare
al tempio con un’offerta … e il gesto del sacerdote di deporre l’offerta sull’altare, si è infilato il
ricordo del fratello, e il dovere che si ha nei suoi confronti ha interrotto il processo sacrificale” 4. Si
passa così dal presentare il dono all’altare al lasciarlo lì davanti all’altare. L’atto cultuale è
interrotto, la riconciliazione con il fratello viene prima perché né è la condizione sine qua non.
Giovanni Crisostomo coglie il significato dell’attimo esatto in cui il sacrificio deve essere interrotto
e mette sulla bocca di Dio queste parole:
Interrompi il mio culto, affinché la tua carità rimanga, perché anche questa è offerta e sacrificio: la
riconciliazione con il fratello. Perciò non dice di andare a riconciliarsi dopo aver portato l’offerta e prima
ancora di presentarla; ma, nel momento stesso in cui il dono è già portato davanti all’altare e il sacrificio è
2 A. BONORA, “Dalla storia e dalla natura alla professione di fede e alla celebrazione (Dt 26,1-15)”, Parola Spirito e
Vita, 25 (1992/1), pp. 27-39, p. 29
3 L.-M. CHAUVET, Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza cristiana, Elle Di Ci, TorinoLeumann 1990, p. 165.
4 J. DUPONT, « “Laisse là ton offrande, devant l’autel …” (Mt 5,23-24) », in Traditio et Progressio, Studi liturgici in
onore del prof. Adrien Nocent, G. FARNEDI (a cura di), Roma 1988, p. 207-208, pp. 205 - 214
3
già iniziato, egli manda a far pace con il fratello. Non dice, ripeto, che dobbiamo fare questo dopo aver
compiuto il sacrificio o prima di aver portato l’offerta, ma comanda di lasciarla davanti all’altare e di correre
subito via”5.
Riconosciamolo! Ci sconvolge e forse anche ci turba l’immagine di un’offerta abbandonata
lì davanti all’altare e l’offerente che se ne va a riconciliarsi con il fratello. Ma il pensiero di Gesù è
chiaro: se l’atto cultuale è il momento nel quale il credente fa memoria del primato di Dio nella sua
vita, allora questo atto cultuale è autentico e giusto solo se è anche memoria del fratello e di ciò che
egli nutre contro di lui. Altrimenti il far memoria di Dio si accompagnerebbe al dimenticarsi dei
fratelli, del male che si è fatto loro, e si diverrebbe complici dell’ingiustizia. L’atto rituale non è
abolito, ma sospeso perché ne va della verità di ciò che si celebra, ne va della giustizia
sovrabbondante. La radicalizzazione fatta da Gesù del comando etico contenuto nel gesto rituale di
presentare il dono all’altare può essere espressa in questi termini: meglio non partecipare all’atto
rituale, all’eucaristia, che parteciparvi smentendo nella prassi ciò che si celebri nel rito.
Anche Agostino, commentando nell’omelia 83 questo passo di Matteo, insiste sulla
necessità di interrompere e di rimandare l’atto cultuale pur di affermare il primato della carità.
Predica Agostino: “Dio non va in collera perché tu rimandi di porre sull’altare il tuo dono. Dio
cerca te molto più del tuo dono. Se infatti ti presentassi davanti al tuo Dio con un dono, ma covando
odio contro un tuo fratello, ti potrebbe rispondere: “Cosa porti a me tu che ti sei perduto? Offri il
tuo dono, ma tu non sei un dono a Dio (offers munus tuum et tu non es munus Dei)”6. Con queste
parole Agostino non fa altro che ricordare la verità più genuinamente cristiana dell’eucaristia, ossia
che in ciò che offriamo noi siamo offerti, a dire che nei doni che presentiamo siamo noi a essere
posti sull’altare. E ciò che siamo in verità davanti a Dio lo rivela la qualità della nostra relazione
con il fratello. Questo significa che non si può essere al tempo stesso offerente o offensore:
offerente verso Dio e offensore verso il fratello. Non si può, in definitiva, pensare di poter
presentare come dono all’altare tutta la nostra vita a Dio se questa vita noi la viviamo senza i fratelli
o contro i fratelli. Non c’è altare del Signore che non sia al tempo stesso altare del fratello, perché le
mani del povero sono l’altare di Dio.
La Didascalia apostolorum, ma prima Policarpo di Smirne e dopo anche Tertulliano ordina:
“Le vedove e gli orfani saranno per voi come un altare”7, attestando che fin dai primi secoli i
cristiani nella loro eucaristica hanno colto il rapporto essenziale tra altare e povero, facendo proprio
il comando etico della presentazione dei doni nel culto ebraico e la sua radicalizzazione compiuta
da Gesù. Non ne ripercorreremo la storia, ma sappiamo bene che i cristiani fin verso il IX secolo da
5 Commento al vangelo di Matteo 16,9.
6 Discorso 83,3,5.
7 Didascalia apostolorum IX,26,8 ; Policarpo Fil 5,1, Tertulliano Ad uxorem., 1,7.
4
casa portavano in chiesa doni in natura destinati ai poveri, da questi doni si prelevavano il pane e il
vino da porre sull’altare per l’eucaristia, a significare che offerta a Dio e offerta ai poveri
formavano un unico atto di offerta. Come non ricordare che l’apostolo Paolo comprende la colletta
per i poveri di Gerusalemme come una liturgia e in Rm 9,12 scrive: «L’adempimento di questo
servizio liturgico (diakonía tês leitourgías) non provvede solo alle necessità dei santi, ma deve
anche suscitare molte azioni di grazie a Dio». Questa visione della colletta la troviamo attestata nel
primo racconto di una riunione eucaristica (verso 150), quello di Giustino nella prima Apologia:
Coloro che vivono nell’abbondanza e vogliono donare, danno liberamente, ciascuno quel che vuole. Quello
che si raccoglie è messo nelle mani di chi presiede, ed è lui che assiste gli orfani, le vedove, coloro che sono
afflitti dalla malattia o da qualche altra cosa, coloro che sono prigionieri o gli stranieri di passaggio. In una
parola, egli soccorre tutti quelli che sono nel bisogno8.
Benché non si parli di un rito di presentazione dei doni, è essenziale costatare che la colletta
per i poveri è un atto liturgico e colui che presiede l’offerta eucaristica, vescovo o presbitero, della
comunità presiede anche l’offerta di carità in favore dei poveri. Questo spiega l’appellativo «necator
pauperum», «assassino dei poveri», con il quale nei concili della Gallia del
VI
e
VII
secolo si
definisce il presbitero che si accaparra delle offerte destinate ai bisognosi9. Il legame tra eucaristia e
condivisione con i poveri è dunque costitutivo della liturgia cristiana, per questo fin dall’inizio il
senso dell’eucaristia è esposto al rischio di essere smentito dalla stessa prassi liturgica. Questo è lo
scandalo eucaristico denunciato da Paolo ai cristiani di Corinto (1Cor 11) perché alla “tavola del
Signore” avviene una scandalosa discriminazione a danno dei più poveri della comunità con i quali
i ricchi non condividono il cibo. Il non attendere il fratello povero per celebrare con lui “la cena del
Signore” non è una semplice mancanza di cortesia, ma è segno di disprezzo nei suoi confronti, che
Paolo definisce «umiliare chi non ha niente».
Riflettere sul comando etico della presentazione dei doni, significa prendere coscienza che
l’eucaristia è la fonte dell’etica cristiana perché rende coloro che la celebrano partecipi dell’ethos di
colui che in essa opera: il Cristo che «da ricco che era si è fatto povero per voi» (2Cor 8,9). Per
questo la liturgia dei cristiani è la liturgia del Povero, ossia la liturgia che manifesta un’etica di
condivisione e di carità (la colletta per i bisognosi e presentazione dei doni) un’etica di donazione
(un corpo dato), un’etica di comunione (la frazione del pane). È dunque necessario riconoscere che
le nostre liturgie sono sempre esposte al rischio di umiliare i poveri come a Corinto, per questo
essere fedeli oggi al comando etico del culto ebraico che Gesù ha radicalizzato, significa che
dobbiamo costantemente vegliare alla qualità evangelica dello stile delle nostre liturgie, ossia alle
8 Justin, Apologie pour les chrétiens I,67,6-7, a cura di Ch. Munier, SC 507, Cerf, Paris 2006, p. 310.
9 Cf. Concilio di Orléans V (549), canoni 13, 15-16, in Les canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe siècles) I, a cura di
J. Gaudemet e B. Basdevant, SC 353, Cerf, Paris 1989, pp. 308, 310, 312; Concilio di Arles V (554), canone 6, ibid., p.
342; Concilio di Tours II (567), canoni 25-26, ibid. II, SC 354, pp. 384-388 e altri ancora.
5
parole come ai gesti, ai luoghi come agli oggetti, alle fogge degli abiti come ai materiali impiegati,
perché nella liturgia la forma è sostanza! Vegliare sulla qualità evangelica della liturgia cristiana
significa celebrare la liturgia con quello stile che il Concilio ha chiamato nobile simplicitas: «I riti
splendano per nobile semplicità» (SC 34)10. L’estetica liturgica è questione di etica evangelica.
Per questo oggi più di ieri siamo chiamati a vegliare che liturgia resti fedele allo spirito della
riforma liturgica del Vaticano II che ha cercato di declinare la nobile simplictas nelle forme e nello
stile. Non ci si lasci dunque trarre in inganno da chi mostra nostalgia di uno stile liturgico che
manifesta opulenza, fasto e ostentazione, nella vana illusione che siano queste le uniche forme
capaci di manifestare sacralità e narrare lo splendore di Dio. Un autore del XVIII secolo scriveva: «Il
lusso è prodigo, ma sempre per ostentare mai per dare»11. Al contrario, la nobile simplicitas chiesta
dal Concilio esprime la volontà di dare, di condividere, perché la semplicità della liturgia cristiana è
questione etica e, in quanto tale, questione teologica. La liturgia è infatti opus Dei, è l’agire di Dio
attraverso Cristo nello Spirito santo. Lo stile dell’agire di Gesù non è mai giunto a «umiliare chi non
ha niente», e anche la nostra liturgia non deve mai umiliare chi non ha niente.
Affermare che il rito della presentazione dei doni è figura e paradigma di un’etica
eucaristica, significa che l’assemblea liturgica cristiana deve essere il luogo dove il povero è
accolto, riconosciuto e perfino onorato. Questa accoglienza, lo ripeto, si esprime nello stile stesso
della celebrazione; uno stile semplice e tuttavia nobile, che narrando la bellezza di Dio non umilia
la povertà del povero. Parlare di una liturgia semplice non significa in nessun modo cedere a una
liturgia sciatta, trascurata e per questo inespressiva, figlia di un pauperismo certamente non
cristiano. La bellezza semplice della liturgia deve essere invece ricercata con impegno e fatica, fino
a rappresentare un punto di arrivo agognato. La semplicità è sempre un punto di arrivo e mai di
partenza, perché è la ricerca di quel nucleo puro ed essenziale che ogni cosa racchiude in sé, sia essa
un materiale, un tessuto, ma anche una parola, un gesto, un’immagine, un suono, un canto. È molto
più facile declinare la bellezza nello sfarzo, nella sontuosità, nel lusso che sono le forme mondane
di bellezza. La bellezza semplice della liturgia cristiana non è imitazione della bellezza mondana
ma riflesso della bellezza della carità di Dio, il Dio che, come canta il salmo 146, “rende giustizia
agli oppressi, dona il pane agli affamati … protegge gli stranieri … sostiene l’orfano e la vedova”.
La presentazione dei doni nel Messale di Paolo VI: figura e paradigma di un’etica eucaristica
10 Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 34.
11 Cf. G. S. Gerdil, Discours de la nature et des effets du luxe, Turin 1768.
6
Alla luce della riflessione che abbiamo fin qui fatto, commentiamo ora più da vicino il rito
della presentazione dei doni così come lo viviamo nella nostra liturgia. Vorrei cominciare evocando
quello che i Praenotanda del Messale romano dicono circa questo rito, sapendo che e i
Praenotanda sono l’autocoscienza che la Chiesa ha del significato della sua liturgia. Vi leggiamo:
“All’inizio della Liturgia eucaristica si portano all’altare i doni, che diventeranno il Corpo e il Sangue di
Cristo … È bene che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdote, o il diacono, li riceve in un luogo
opportuno e adatto e li depone sull’altare ... (n. 73). “È bene che la partecipazione dei fedeli [alla
presentazione dei doni] si manifesti con l’offerta del pane e del vino per la celebrazione dell’Eucaristia, sia di
altri doni, per la necessità della chiesa e dei poveri” (n. 140).
Ai Praenotanda poniamo tre domande: Quis praesentat? Quid praesentatur? Cui
praesentatur? Chi presenta? Cosa è presentato? A chi si presenta? Tre domande circa il soggetto,
l’oggetto e i destinatari. La prima domanda: Quis praesentat? Chi presenta? I Praenotanda sono
chiari: “È bene che i fedeli presentino il pane e il vino”. Il soggetto della presentazione dei doni
sono dunque i fedeli e se anche questo rito è compiuto materialmente solo da due o tre fedeli, lo è in
modo simbolico, perché in realtà è ciascun membro dell’assemblea chiamato a portare i doni
all’altare, quasi in obbedienza al comando di Mosè: “Nessuno si presenterà davanti al Signore a
mani vuote” (Dt 16,16). Nessun credente può presentarsi davanti all’altare con le mani vuote,
perché la vocazione dell’uomo è di far passare il mondo tra le sue mani per offrirlo a Dio. Il
soggetto della presentazione dei doni è ogni fedele perché con questo gesto egli compie quell’atto
sacerdotale al quale ogni uomo è chiamato. La teologia ortodossa, più di ogni altra, lo ha meditato.
Scrive il vescovo e teologo greco Ioannis Zizioulas: “[nelle mani dell’uomo] il mondo viene elevato
a possibilità infinite, essendo riferito a Dio e offerto a lui come ‘sua proprietà’. Questo costituisce la
base di ciò che chiamiamo il sacerdozio dell’uomo; prendendo in mano il mondo, integrandolo
creativamente e riferendolo a Dio, l’uomo libera la creazione dai suoi limiti e fa sì che essa sia in
pienezza”12. Un altro teologo ortodosso, Alexander Schmemann, ha scritto: “Homo sapiens, homo
faber, … sì, ma prima di tutto homo adorans. La prima, la fondamentale definizione dell’uomo è
che egli è il sacerdote. Egli sta al centro del mondo e lo unifica nel suo atto di benedire Dio, di
ricevere il mondo da Dio e insieme di offrirlo a Dio, e riempiendo il mondo di questa eucaristia, egli
trasforma la propria vita, quella vita che egli riceve dal mondo, in vita in Dio, in comunione. Il
mondo fu creato come la materia, il materiale di una eucaristia che tutto abbraccia, e l’uomo fu
creato come il sacerdote di questo sacramento cosmico”13.
Questi autori ci mostrano dunque come il sacerdozio dell’uomo sia un’attitudine esistenziale
che trova nella liturgia la sua piena epifania sacramentale. Ogni membro dell’assemblea che prende
12 I. ZIZIOULAS , Il creato come eucaristia, Qiqajon, Magnano 1994, p. 67.
13 A. SCHMEMANN, Il mondo come sacramento, Queriniana, Brescia 1969, p. 12.
7
parte simbolicamente alla processione compie quel cammino con il quale egli depone l’intera sua
vita sull’altare, perché porta davanti al Signore il frutto dell’incontro tra lui e la creazione, perché
anche lui, come quei doni, è parte della creazione di Dio, è frutto della natura, della storia, della
cultura e di quell’ininterrotto lavoro di umanizzazione che da quando è venuto al mondo altri hanno
compiuto su di lui e che lui stesso ha continuato. Nel pane e nel vino portati all’altre perché
diventino, attraverso l’epiclesi dello Spirito, corpo e sangue del Signore, vi è tutta la vita dell’uomo
anch’essa da trasformare, per l’opera della santificazione, in un offerta a Dio e ai fratelli, in un atto
di comunione, in un gesto di condivisione.
Ed ecco la seconda domanda: Quid praesentatur? Cos’è presentato? Oggetto della
presentazione sono il pane e il vino, e la ragione di questi doni, e non di altri, la indicano gli stessi
Praenotanda: “Nella presentazione dei doni vengono portati all’altare pane e vino con acqua, cioè
gli stessi elementi che Cristo prese tra le mani” (n. 72). Cristo prese pane e vino tra le mani e
dunque all’altare si portano il pane e il vino. Un criterio di senso questo, che se fosse osservato ci
risparmierebbe molti significati improvvisati! Ma domandiamoci: perché Gesù ha scelto proprio il
pane e il vino come le due realtà umane che meglio di tutte le altre potevano narrare il senso del
dono della sua vita fino alla morte, così da essere da quel momento il suo corpo e il suo sangue?
Cerchiamo di rispondere a questa domanda attraverso le berakot, le due benedizioni che sul
pane e sul vino il presbitero pronuncia; due formule che sono una delle novità certamente più
innovative ed espressive dell’Ordo Missae del Messale di Paolo VI .
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra
e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e
del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
“Benedetto sei tu Signore”, nella liturgia non si benedicono il pane e il vino ma si benedice
il Signore per questi doni. Ed è significativo che si benedica il Signore chiamandolo Deus universi,
Dio di tutto ciò che esiste, Dio del creato, Dio dell’universo. Se tutti i cibi, infatti, sono non solo
sostanza ma anche simbolo dell’intero, il pane lo è in modo unico, al punto che Pitagora poteva
affermare: “L’universo comincia col pane”14. Invocando il Dio dell’universo si riconosce nel pane
l’inizio nel senso del principio di sussistenza dell’uomo. Il pane è da sempre, in tutti i linguaggi e le
culture, metafora del cibo, così che per l’uomo non avere pane significa non avere cibo, ciò da cui
dipende il poter vivere o il dover morire per mancanza di cibo. Il vino, a differenza del pane, non è
principio di sussistenza per l’uomo, non è dell’ordine della necessità perché senza vino si può
vivere. Per questo il vino è simbolo della gratuità, narra l’eccesso della vita umana, è sinonimo di
14 “Parole di Pitagora, tramandate ai posteri dal saggio Diogene Laerzio”, P. Matvejević, Pane nostro, di prossima
pubblicazione presso l’editrice Garzanti.
8
festa, di gioia, pienezza di vita. Perché destinato alla gioia, il vino richiede la comunità, la
condivisione, il legame sociale. Sia il pane che il vino dicono condivisione, perché umanizzandosi
l’uomo non mangia e non beve solo, ma condivide con gli altri ciò che lo fa vivere e gioire.
Pane e vino sono portati insieme all’altare perché uniti sono il segno che la vita dell’uomo
quando è pienamente umanizzata è sempre quotidianità e festa, necessità e gratuità, fatica e gioia,
bisogno ed eccesso, sottomissione e libertà. Per questa nella benedizione si riconosce “dalla tua
bontà abbiamo ricevuto questo pane … questo vino”, si riconosce che è “de tua largitate” dalla
generosità di Dio che l’uomo riceve il pane e il vino che sono dunque suoi doni. La grande litania
del salmo 136 termina riconoscendo: “Ad ogni vivente dona il pane, perché il suo amore è per
sempre”.
Ma il pane, dono di Dio, “è frutto della terra e del lavoro dell’uomo” e il vino “frutto della
vite e del lavoro dell’uomo”. Frutto della terra anzitutto, e la Bibbia ricorda in continuazione che il
pane viene dalla creazione, dalla terra, così nel salmo 104 si ricorda: “Dalla terra trae l’uomo il suo
cibo il vino che rallegra il suo cuore … il pane che al cuore umano da forza”. Ma il pane e il vino
non li si trovano in natura, si dovrebbe dire che il grano e l’uva vengono dalla terra, per questo nella
benedizione si dice “frutto della terra … della vite e del lavoro dell'uomo”, perché il pane e il vino
sono il risultato del lavoro umano, e dunque non sono solo natura ma anche cultura. Nella storia
dell’umanità, infatti, non c’è mai stata natura senza cultura. Da quando esiste, l’uomo non è mai
stato pura animalità, anche nei confronti della terra. Per gli uomini, la terra non è mai stata terra
vergine c’è sempre stata la cultura anche nelle sue forme più rozze e primitive. Per fare il pane
l’uomo deve arare la terra, deve seminare il grano, deve mieterlo, deve batterlo, farne farina,
impastarlo con acqua e poi passarlo al fuco. Allo stesso modo, per fare il vino l’uomo deve piantare
una vigna, attenderne per anni che faccia frutto, cogliere l’uva, pigiarla e quale arte e sapienza sono
necessarie. Ecco perché il pane e il vino sono “frutto della terra … della vite e del lavoro
dell’uomo”, perché non sono materia statica ma frutto della dinamicità del lavoro dell’uomo.
Olivier Clément giunge a vedere nel lavoro un atto liturgico, quando scrive: “Grazie al lavoro che
ingloba sapere scientifico e potere tecnico l’uomo è chiamato a collaborare con Dio per la salvezza
dell’universo. È soprattutto qui che il cristiano deve essere un uomo liturgico”15.
Giungiamo così alla terza domanda: Cui praesentatur? A chi si presenta? “Lo presentiamo a
te, perché diventi per noi cibo di vita eterna” e del vino “perché diventi per noi bevanda di
salvezza” recita la benedizione. Il testo è chiaro, il pane e il vino sono presentati al Signore, posti
alla sua presenza o, nel linguaggio biblico, portarli davanti al suo volto, come ha tradotto il messale
tedesco. Tuttavia, è la benedizione stessa a dire che il Signore non è il destinatario ultimo dei doni,
15 O. CLÉMENT, Il senso della terra, Lipa, Roma 2007, p. 68
9
quando recita “lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna … bevanda di
salvezza”. Prendere sul serio quel “per noi (ex quo nobis)”, significa comprendere che destinatari
ultimi sono gli stessi fedeli che hanno portato i doni all’altare. Qui il discorso si fa molto difficile,
ma è essenziale comprendere questa dinamica per capire la novità radicale del culto cristiano
rispetto all’economia sacrificale ebraica e pagana.
Si è soliti affermare, giustamente, che la riforma liturgica conciliare ha denominato questo
primo momento della liturgia eucaristia “presentazione dei doni” e non “offertorio”, per ricordare
che l’ luogo dell’offerta è la preghiera eucaristia: “eucharistountes prospheromen” è rendendo
grazie che offriamo. Tuttavia, è stata chiamata presentazione dei doni anche per affermare che il
pane e il vino sono presentati al Signore perché su di essi egli mandi il suo Spirito a santificarli e
così diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, ed è ciò che, del resto, si dice nelle benedizioni:
“Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna (panis vitae – pane di vita) …
bevanda di salvezza (potus spiritalis – bevanda spirituale)”. In sintesi, il pane e il vino sono portati
all’altare non perché sia il Signore a nutrirsene, ma perché lui li santifichi e “diventino per noi”
pane di vita e bevanda spirituale. Così, quel pane che i fedeli hanno portato nelle loro mani
all’altare, dopo l’azione di grazie, dall’altare viene posto nelle mani dei fedeli quale corpo di Cristo,
secondo il comando dato da Gesù ai suoi discepoli “prendete e mangiatene … prendete e bevetene”.
Ma alla domanda Cui praesentatur?, a chi si presenta, non abbiamo ancora risposto
completamente, perché nei Praenotanda affermano: “È bene che la partecipazione dei fedeli [alla
presentazione dei doni] si manifesti con l’offerta del pane e del vino per la celebrazione
dell’Eucaristia, sia di altri doni, per la necessità della chiesa e dei poveri” (n. 140). Dunque la
partecipazione dei fedeli alla presentazione dei doni non si limita a portare il pane e il vino per
l’eucaristia, ma anche con il portare “altri doni per la necessità della chiesa e dei poveri”. Pertanto
anche l’intera comunità cristiana e tra essa in particolare i poveri sono i destinatari della
presentazione dei frutti della terra e del nostro lavoro. Certo, i frutti della terra e del nostro lavoro
restano incompiuti finché non raggiungono il loro pléroma, la loro pienezza di senso e significato
per l’azione dello Spirito santo. Jean Corbon ha scritto che “all’inizio dell’anafora noi arriviamo
con doni, ma con un’incompletezza, un appello – l’epiclesi è un gemito – l’attesa ansiosa della
creazione che reca l’impronta delle nostre mani ma non ancora quella della luce. Perché la luce che
trasfigura il lavoro e la creazione da esso modellata, è quella della comunione. L’eucaristia vissuta
culmina nella comunione … Spinge alla condivisione, perché se tutta la terra appartiene a Dio, il
frutto del lavoro degli uomini è per tutti i figli di Dio. La condivisione è il giubileo del lavoro”16.
Ecco, dunque, in che senso la presentazione dei doni è figura e paradigma di un’etica
16 J. CORBON, Liturgia alla sorgente, Edizioni Qiqajon, Magnano 2003, p. 244
10
eucaristica. Per questo, come il gesto rituale di presentare le primizie della terra era per ogni figlio
di Israele memoria del passato e appello alla responsabilità nel presente, allo stesso modo il rito
della presentazione dei doni è per ogni cristiano memoria dell’offerta di Cristo sulla croce e
responsabilità etica per l’hodie della chiesa, della società e del mondo intero.
Conclusione
A conclusione di questa riflessione io mi domando, e domando anche a voi: noi cristiani
siamo oggi consapevoli del rapporto che esiste tra la nostra prassi eucaristica e la prassi di carità da
offrire agli uomini e alle donne che sono nel bisogno? Sappiamo che l’eucaristia è una fonte di
trasformazione sociale?
Nella crisi economica che stiamo attraversando, noi cristiani dobbiamo compiere ogni
domenica il rito della presentazione dei doni con una rinnovata consapevolezza, ossia che
l’eucaristia è il fondamento di una speranza inaudita: la comunione di tutta l’umanità nella diversità
sociale, etnica e culturale. Facciamo in modo che questa crisi economica non passi senza avere in
qualche modo fatto nascere la consapevolezza di essere anche noi, come singoli credenti e come
comunità ecclesiali, parte di un sistema non solo economico e politico, ma anche culturale e
religioso, dunque sistema di valori e di comportamenti, di scelte e di giudizi che ormai da secoli
ininterrottamente continua ha creare nel mondo povertà e ingiustizia, più esattamente a creare
poveri e oppressi, bisognosi di pane tanto quanto di giustizia sociale e dignità umana. Interpellati
dalla situazione di milioni di uomini e donne, noi cristiani che viviamo in occidente siamo chiamati
a verificare il modo con il quale dal dopoguerra a oggi abbiamo celebrato e adorato l’eucaristia che
è nutrimentum caritatis, il nutrimento della carità (orazione dopo la comunione XII dom. dell’ord.).
Riflettendo su eucaristia e condivisione non possiamo chiudere gli occhi davanti ai dati sullo
spreco alimentare resi noti lo scorso mese: nel mondo occidentale, dal 1974 a oggi, l’aumento dello
spreco alimentare è aumentato del 50 per cento. In un paese civile come la Svezia ogni famiglia
getta in media nella spazzatura il 25 per cento del cibo che compra17. Questi dati ci dicono una
verità: quando non si condivide si finisce per sprecare, per consumare, comprovando quel che dice
il salmo 49: “L’uomo nel benessere non discerne è come gli animali che periscono”. I cristiani sono
consapevoli dello iato che ormai esiste tra la prassi sacramentale e la prassi della giustizia?
Capiamo allora che la liturgia dà alla Chiesa un compito per il mondo, un compito di cui i
17 A. CIANCIULLO , “Troppo cibo nella spazzatura. Le mosse anti-spreco delle città”, in La Repubblica del 12 luglio 2010,
p. 20.
11
cristiani, oggi forse più di ieri, sono debitori nei confronti di tutti gli uomini. In una società dove
domina il più forte, l’eucaristia è una vera e propria minaccia per il mondo. In una società dove
trionfa l’individualismo, l’eucaristia richiama il comune destino di tutta l’umanità. In una società
dove domina lo spreco, l’eucaristia è principio di condivisione. Per questo, l’eucaristia forgia una
teologia della carità, perché la carità è un mistero tanto sacramentale quanto profetico. L’eucaristia
è una realtà sociale quanto è teologica, è crogiuolo di un’etica a servizio dell’uomo.
.
12