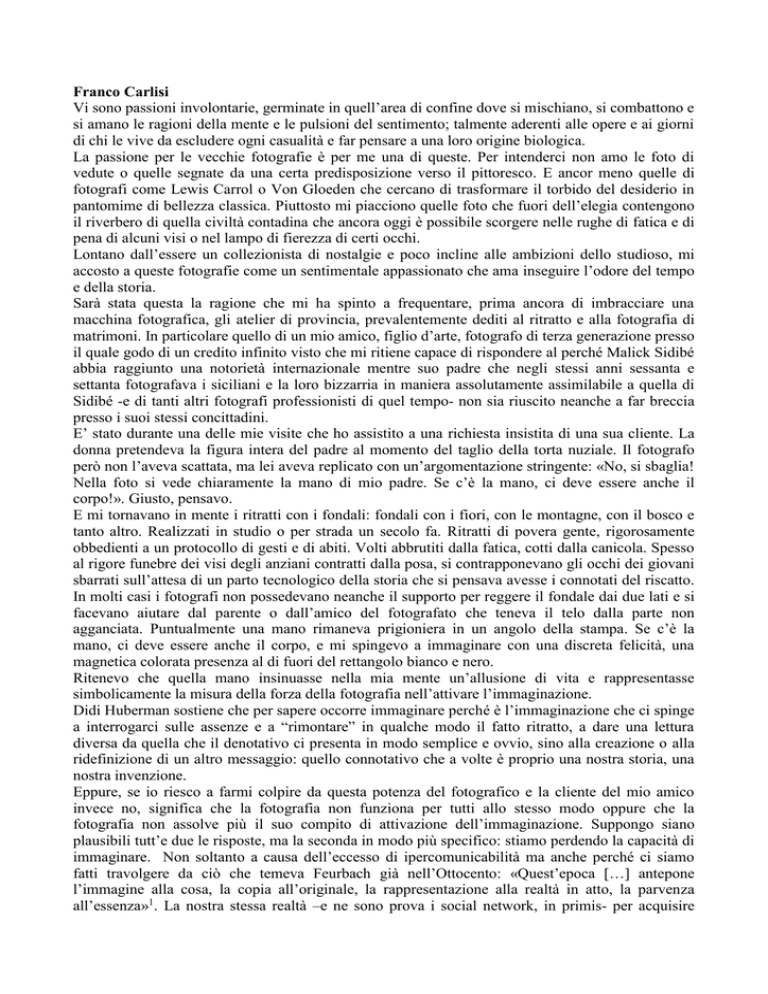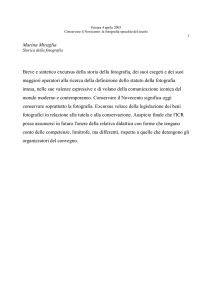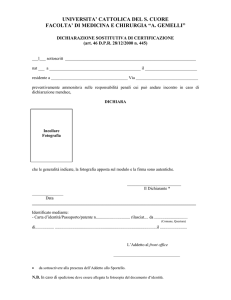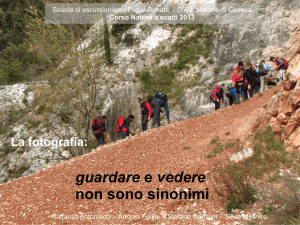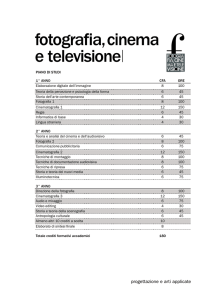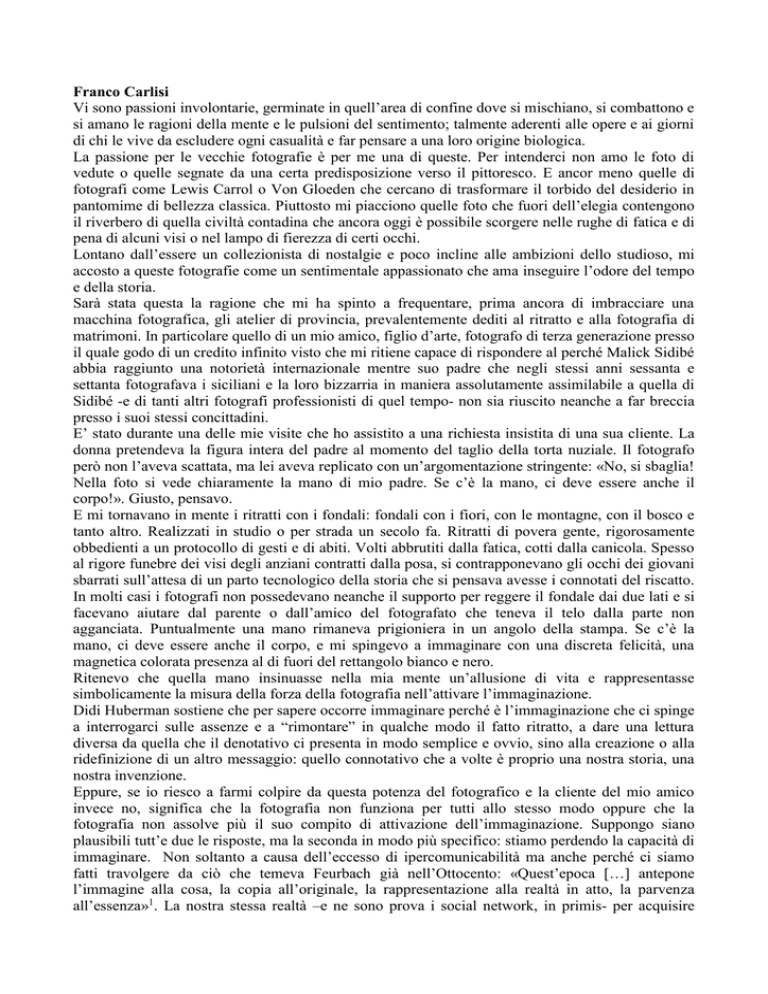
Franco Carlisi
Vi sono passioni involontarie, germinate in quell’area di confine dove si mischiano, si combattono e
si amano le ragioni della mente e le pulsioni del sentimento; talmente aderenti alle opere e ai giorni
di chi le vive da escludere ogni casualità e far pensare a una loro origine biologica.
La passione per le vecchie fotografie è per me una di queste. Per intenderci non amo le foto di
vedute o quelle segnate da una certa predisposizione verso il pittoresco. E ancor meno quelle di
fotografi come Lewis Carrol o Von Gloeden che cercano di trasformare il torbido del desiderio in
pantomime di bellezza classica. Piuttosto mi piacciono quelle foto che fuori dell’elegia contengono
il riverbero di quella civiltà contadina che ancora oggi è possibile scorgere nelle rughe di fatica e di
pena di alcuni visi o nel lampo di fierezza di certi occhi.
Lontano dall’essere un collezionista di nostalgie e poco incline alle ambizioni dello studioso, mi
accosto a queste fotografie come un sentimentale appassionato che ama inseguire l’odore del tempo
e della storia.
Sarà stata questa la ragione che mi ha spinto a frequentare, prima ancora di imbracciare una
macchina fotografica, gli atelier di provincia, prevalentemente dediti al ritratto e alla fotografia di
matrimoni. In particolare quello di un mio amico, figlio d’arte, fotografo di terza generazione presso
il quale godo di un credito infinito visto che mi ritiene capace di rispondere al perché Malick Sidibé
abbia raggiunto una notorietà internazionale mentre suo padre che negli stessi anni sessanta e
settanta fotografava i siciliani e la loro bizzarria in maniera assolutamente assimilabile a quella di
Sidibé -e di tanti altri fotografi professionisti di quel tempo- non sia riuscito neanche a far breccia
presso i suoi stessi concittadini.
E’ stato durante una delle mie visite che ho assistito a una richiesta insistita di una sua cliente. La
donna pretendeva la figura intera del padre al momento del taglio della torta nuziale. Il fotografo
però non l’aveva scattata, ma lei aveva replicato con un’argomentazione stringente: «No, si sbaglia!
Nella foto si vede chiaramente la mano di mio padre. Se c’è la mano, ci deve essere anche il
corpo!». Giusto, pensavo.
E mi tornavano in mente i ritratti con i fondali: fondali con i fiori, con le montagne, con il bosco e
tanto altro. Realizzati in studio o per strada un secolo fa. Ritratti di povera gente, rigorosamente
obbedienti a un protocollo di gesti e di abiti. Volti abbrutiti dalla fatica, cotti dalla canicola. Spesso
al rigore funebre dei visi degli anziani contratti dalla posa, si contrapponevano gli occhi dei giovani
sbarrati sull’attesa di un parto tecnologico della storia che si pensava avesse i connotati del riscatto.
In molti casi i fotografi non possedevano neanche il supporto per reggere il fondale dai due lati e si
facevano aiutare dal parente o dall’amico del fotografato che teneva il telo dalla parte non
agganciata. Puntualmente una mano rimaneva prigioniera in un angolo della stampa. Se c’è la
mano, ci deve essere anche il corpo, e mi spingevo a immaginare con una discreta felicità, una
magnetica colorata presenza al di fuori del rettangolo bianco e nero.
Ritenevo che quella mano insinuasse nella mia mente un’allusione di vita e rappresentasse
simbolicamente la misura della forza della fotografia nell’attivare l’immaginazione.
Didi Huberman sostiene che per sapere occorre immaginare perché è l’immaginazione che ci spinge
a interrogarci sulle assenze e a “rimontare” in qualche modo il fatto ritratto, a dare una lettura
diversa da quella che il denotativo ci presenta in modo semplice e ovvio, sino alla creazione o alla
ridefinizione di un altro messaggio: quello connotativo che a volte è proprio una nostra storia, una
nostra invenzione.
Eppure, se io riesco a farmi colpire da questa potenza del fotografico e la cliente del mio amico
invece no, significa che la fotografia non funziona per tutti allo stesso modo oppure che la
fotografia non assolve più il suo compito di attivazione dell’immaginazione. Suppongo siano
plausibili tutt’e due le risposte, ma la seconda in modo più specifico: stiamo perdendo la capacità di
immaginare. Non soltanto a causa dell’eccesso di ipercomunicabilità ma anche perché ci siamo
fatti travolgere da ciò che temeva Feurbach già nell’Ottocento: «Quest’epoca […] antepone
l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà in atto, la parvenza
all’essenza»1. La nostra stessa realtà –e ne sono prova i social network, in primis- per acquisire
veridicità deve essere mediata da un’immagine fino al punto che non crediamo a un evento se non
c’è una foto che ne dimostri l’effettività. E mentre prima si faceva economia, perché il rullino era
un costo, scegliendo che cosa fotografare, adesso si fotografa tutto, qualsiasi cosa e in qualsiasi
momento finendo per non “vedere” e quindi non “creare”. Perché il “vedere” ci dà la possibilità di
dare un senso al fluire informe di ciò che accade intorno a noi. Questa perdita di concretezza ci ha
spinto a credere che tutto cada sotto l’occhio del Grande fratello orwelliano, per cui il paradosso di
una fotografia documento e insieme sorgente di immaginazione arretra e si dissolve alla presenza di
uno strumento –qualunque cosa esso sia, anche un cellulare- capace di memorizzare l’intera realtà.
La realtà si è infilata nel meccanismo dell’apparecchio che tutto registra e ha saturato la nostra
immaginazione. Vilem Flusser sostiene che il fotografo deve opporsi a questa involuzione cercando
«di produrre informazioni impreviste, di estrarre, cioè, qualcosa dall’apparecchio e di mettere in
immagine ciò che non figura nel suo programma»2.
“Lottare contro l’apparecchio” come sostiene Flusser non significa, a mio parere, tirar fuori
l’imprevisto, generare uno stupore visivo che si ferma alla superficie dello spettacolo, ma piuttosto
esercitare la nostra personalissima facoltà di scelta per realizzare immagini che sentiamo
intimamente nostre. Che non siano oleografici luoghi comuni e appartengano alla nostra vita e
quindi alla nostra immaginazione.
Giovanni Verga, negli ultimi anni vissuti a Catania, scrisse in bianco e nero i capitoli mai scritti del
ciclo dei Vinti. La sua incapacità di scrivere coincide con l’interesse di quegli anni per la fotografia.
Mi voglio figurare che Verga, spinto inizialmente dal proposito scientifico di catalogazione e studio
del vero, avesse infine trovato nella fotografia quella capacità di dire in modo più immaginifico
rispetto alle parole, che queste, insomma, a un certo punto, gli siano sembrate insufficienti e che il
grande scrittore si sia smarrito di fronte alla magnifica potenzialità di aprire quegli spazi di
interrogazione -attivati dalla miccia dell’immaginazione- che proprio la fotografia innesca. E mi
voglio figurare che questa scoperta lo abbia spinto a comprendere non soltanto la grandezza del
mezzo fotografico ma anche la sua possibile insidia. Un’insidia che si presentava come una deriva
dell’immaginazione nello stagno dell’osservazione inerte, una vera e propria abdicazione del
pensiero critico a favore dell’apparecchio, dell’artificiale, tale che un giorno qualcuno avrebbe
creduto che se in una foto c’è una mano, ci deve essere il resto del corpo.
Note
1 L. Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo (Das Wesen des Christentums), trad. di F. Bazzani e D. Haibach, Fabbri, Milano 2001,
pp. 55-56.
2 Vilem Flusser, Per una filosofia della fotografia (Für eine Philosophie der Fotografie), trad. it. di C. Marazia, Bruno Mondadori
Milano 2006, pp. 110-111.