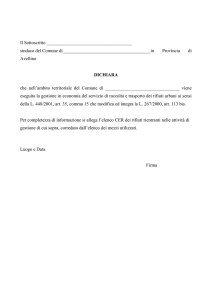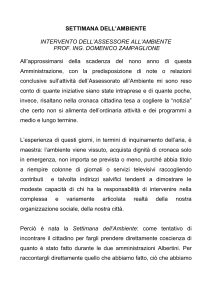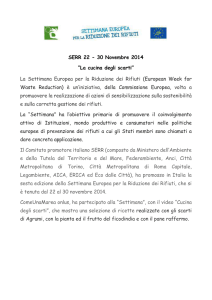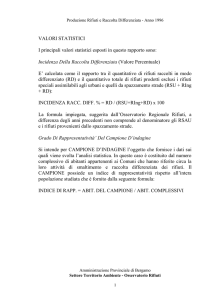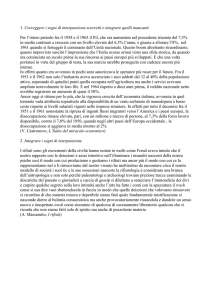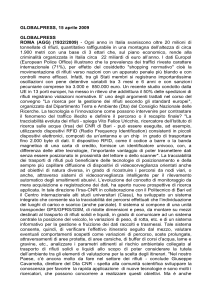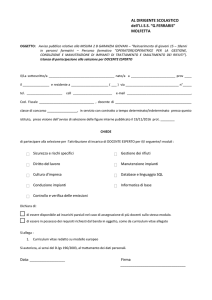Facoltà di scienze politiche, sociali e della comunicazione
Corso di laurea magistrale in
Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale
Tesi di laurea in
Antropologia dello sviluppo
Gestione dei rifiuti e studio del caso: la Casamance, Senegal
Relatore
Candidato:
Prof. ssa Marieli Ruini
Raffaele Urselli
Matr. N. 1323323
Correlatore
Prof. Paolo Palmeri
Anno accademico 2010/2011
1 per mamma, papà, Vincenzo e Grazia
2 INDICE GENERALE
Introduzione………………………………………………………………….…….…2
Premessa…………………………………………………………………….………..5
1.a La prospettiva socioantropologica………………………………………….….…5
1.b Antropologia e Africa, tra cambiamento e conflitto……………………….…,…8
Capitolo I: La configurazione sociale dei rifiuti………………………………...…24
1.1 Purezza e controllo…………………………………………………………..….28
1.2 La città e irifiuti…………………………………………………………………43
1.2.1 La città del sottosviluppo………………………………………………..….…45
1.3 Il modo di gestione dei rifiuti: riciclo e riuso……………………………….…..53
Capitolo II: Produzione, consumo e bricolage…………………………………..…58
Premessa………………………………………………………………………….…58
2.1 Produzione e alienazione………………………………………………….….…62
2.2 Consumo e sovversione..……………………………………………………..…70
2.3 L’informale, il bricolage e l’Africa………………………………………….…..84
Capitolo III: I rifiuti in Casamance: tra emergenza e retaggi primordiali….………98
3.1 Il Senegal contemporaneo…………………………………………………….…99
3.1.1 Dakar…………………………………………………………………………102
3.2 La Casamance………………………………………………………………….117
3.2.1 Il conflitto……………………………………………………………...…….118
3.3 L’indagine sui rifiuti…………………………………………………………...122
3.3.1 Gli attori……………………………………………………………………...122
3.3.2 La gestione amministrativa…………………………………………………..123
3.3.3 Dgibelor…………………………………………………………………...…124
3.3.4 Bourofaye……………………………………………………………..……..126
3.3.5
Rifiuti
e
sviluppo…………………………………………………………..…127
3.3.6 Adeane……………………………………………………………….………128
3 3.4: “Sporco e pulito”: dai Diola ai Dogon………………………………..………130
Bibliografia…………………………………………………………………...……148
Mappa geografica del Senegal……………………………………………………..153
4 INTRODUZIONE
"Soltanto buttando via posso assicurarmi che
qualcosa di me non è stato ancora buttato e forse
non è, né sarà, da buttare. […] Se questo è vero,
se
il
buttar
via
è
la prima
condizione
indispensabile per essere, perché si è ciò che non
si butta via, il primo atto fisiologico e mentale, é
il separare la parte di me che resta e la parte che
devo lasciare che discenda in un al di là senza
ritorno."
Italo Calvino
Nel racconto “La poubelle agrée” (“immondizia gradita”) Italo Calvino, antropologo
dei gesti quotidiani, descrive l’immondizia, il suo ruolo sociale, il posto che essa
occupa nella città.
Questa “poubelle” finisce per essere gradita, cara, anche perché, a dispetto del suo
contenuto, o forse proprio a causa di esso, permette di assolvere un compito di
grande valore sociale.
L’aspetto sociale infatti finisce per prevalere su quello prettamente individualefamiliare: è necessario non solo liberarsi fisicamente di una mera quantità di scarti
che impedirebbe alla vita di proseguire, ma anche di rapportarsi con quel processo di
smaltimento dei rifiuti che risulta in qualche modo consustanziale alla vita stessa, in
una sorta di tensione tra nuovo e vecchio, tra ciò che si scarta e ciò che rimane.
L’immondizia è “gradita” perché è necessario “gradire il non gradevole senza il
quale nulla di quel che ci è gradito avrebbe senso”.
L’analisi di Calvino parte dalla funzione disciplinare dei bidoni dell’immondizia nel
panorama metropolitano: essi si presentano già nel loro aspetto e colore come una
5 suppellettile ufficiale della città, annunciando quale sia la parte che nella vita di
ciascuno hanno la dimensione pubblica, i doveri civici e la costituzione della polis.
Nel momento in cui svuota la pattumiera, l’individuo si investe di un ruolo sociale, si
costituisce “primo ingranaggio d'una catena d'operazioni decisive per la convivenza
collettiva”.
Il portar fuori la spazzatura va dunque interpretato contemporaneamente sotto
l'aspetto di contratto, e sotto quello di rito: il contratto relativo al ciclo di raccolta dei
rifiuti, assurge persino al grado di rito purificatorio: i rifiuti finiscono per essere
“graditi” non più al municipio, non più al produttore di rifiuti che sente l’utilità
sociale e quasi “esistenziale” dell’operazione che sta svolgendo, ma “all’anonimo
processo economico che moltiplica i prodotti nuovi, usciti freschi di fabbrica, e i
residui logori da buttar via, e che ci lascia metter mano solo a questo recipiente da
riempire e svuotare, io e lo spazzino”. Tale sofferta presa di coscienza
dell’alienazione dell’uomo moderno, conduce poi ad una sorta di “comico
ribaltamento”, per cui sembra che siano diventati i rifiuti (o meglio, le merci-rifiuti)
il vero soggetto, e gli esseri umani i semplici esecutori materiali, “automi diligenti di
un processo eterodiretto”.
Gettare l’immondizia è invece “rito di purificazione”, poiché l’abbandono delle
scorie corporali, rappresenta il gesto con cui l’individuo conferma la necessità di
separarsi da una parte di ciò che era suo, “la spoglia o crisalide o limone spremuto
del vivere, perché ne resti la sostanza”, con cui l’individuo può identificarsi
interamente in ciò che è ed ha.
La soddisfazione che si prova nello sbarazzarsi dei rifiuti è analoga a quella della
defecazione, “del sentire le proprie viscere sgombrarsi”. Tale azione sancisce la
separazione netta tra ciò che si è e ciò che è “estraneità irriducibile”.
Quello che per Calvino è un “funerale domestico e municipale della spazzatura”,
cioè la raccolta dei rifiuti, non serve altro che a scongiurare il “funerale della
persona”, e che l’individuo produce ancora scorie, e non è esso stesso scoria.
6 I rifiuti sono insieme simbolo e rappresentazione: l’immigrante, dice Calvino, valuta
la ricchezza o la povertà dei quartieri della metropoli in base alla qualità dei loro
rifiuti, “sogna attraverso essi il destino di consumatore che lo attende”.
Se il buttar via completa o conferma l'appropriazione, “il contemplare la mole delle
bucce, dei gusci, degli imballaggi, dei contenitori di plastica riporta la soddisfazione
del consumo dei contenuti”; l’uomo che scarica tali resti, scopre invece la quantità di
beni da cui è escluso, che gli arrivano solo come residui inutilizzabili.
Calvino illustra bene il ciclo dell’esclusione, per cui lo spazzino rappresenta il primo
gradino d'una ascesa sociale che lo renderà consumatore, e a sua volta produttore di
rifiuti, mentre “altri usciti dai deserti in via di sviluppo prenderanno il suo posto a
caricare e scaricare i secchi”. Così l’immigrato che raccoglie l’immondizia sancisce
l’ingresso in un sistema che inghiotte gli uomini, e li rifà a propria immagine e
somiglianza.
Nel rito del buttar via, si cerca di chiudere il ciclo proprio del processo agricolo, in
cui
“ciò che era sepolto nella terra rinasceva. Ora l'industria moltiplica i beni più
dell'agricoltura, ma lo fa attraverso i profitti e gli investimenti: il regno
plutonico da attraversare perché avvengano le metamorfosi è la caverna del
denaro, il capitale, la Città di Dite inaccessibile a me e allo spazzino, […]
retta da un Supremo Consiglio d'Amministrazione non più plutonico ma
iperuranico, che maneggia l'astrazione dei numeri da un' altezza quanto mai
lontana dall'appiccicoso e fermentante crogiolo terrestre cui io e lo spazzino
affidiamo le nostre offerte sacrificali di barattoli vuoti, le nostre seminagioni di
cartaccia, la nostra partecipazione all'arduo disfacimento dei materiali
sintetici. Inutilmente rovesciamo, io e lo spazzino, la nostra oscura comucopia;
il riciclaggio dei residuati può essere solo una pratica accessoria, che non
modifica la sostanza del processo. Il piacere di far rinascere le cose periture
(le merci), resta privilegio del dio Capitale che monetizza l'anima delle cose, e
nel migliore dei casi, ce ne lascia in uso e consumo la spoglia mortale”1.
1
I. Calvino, La poubelle agrée, in Romanzi e racconti, vol. III, I Meridiani, Milano, 2003, p. 59-79
7 PREMESSA
1.a LA PROSPETTIVA SOCIOANTROPOLOGICA
Nell’ambito delle scienze sociali, l’antropologia viene spesso accreditata come quella
che possiede il punto di vista della totalità, la prospettiva olistica. L’indagine
intensiva su una situazione concreta di cui si serve l’antropologia, sembra
particolarmente appropriata per cogliere una realtà in tutte le sue dimensioni, e
dunque nella sua globalità.
Essa evidenzia come le molteplici logiche che si confrontano con i processi di
sviluppo non dipendano solo da attori diversi, ma mobilitano anche svariati registri
della realtà sociale da considerare simultaneamente. Pratiche e rappresentazioni sono,
infatti, sempre di ordine simbolico, politico, economico, ecc.
I processi di mutamento sociale e di sviluppo sono per definizione diacronici. Essi
mobilitano strutture intermediarie, informali, trasversali: reti, affinità, clientele,
circoli locali, professionali, familiari, ecc. Con la modernizzazione, le relazioni
impersonali, sia quelle ugualitarie che quelle gerarchiche, non scompaiono affatto.
Da questa prospettiva, una certa sociologia ed una certa antropologia diventano
indissociabili:
“I processi di cambiamento sociale e di sviluppo mettono necessariamente in
relazione norme eterogenee, culture e sottoculture eterogenee, sistemi di valori
eterogenei, configurazioni di saperi e di rappresentazioni eterogenee, sistemi
di azione eterogenei, strategie e logiche sociali eterogenee”2.
L’antropologia classica sceglieva oggetti che invece valorizzavano piuttosto la
persistenza, l’omogeneità e la coerenza. Questo confronto di elementi eterogenei,
divergenti, dissimili e contraddittori è invece al centro dell’antropologia del
2
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, Raffaello Cortina
editore, Milano, 2008, p. 28.
8 mutamento sociale e dello sviluppo. Essa è dunque un’ “antropologia del
sincretismo”, il cui carattere deve essere permanentemente dinamico.
L’antropologia dello sviluppo deve pertanto interessarsi non solo alle comunità locali
o alle popolazioni bersaglio, ma anche ai dispositivi di intervento come a tutti gli
agenti esterni.
“E’ qui che intervengono fenomeni di confronto, negoziazione, rigetto,
deviazione, adattamento, sovvertimento, lotte di potere, compromessi e
transizioni. I processi di cambiamento sociale e di sviluppo sono situati
all’interfaccia tra sociologia ed antropologia “macro” da una parte, e ad
etnografia e sociografia micro dall’altra”3.
La socioantropologia fonde quindi le tradizioni della sociologia sul campo
(scuola di Chicago) e dell’antropologia sul campo (etnografia) per tentare un’analisi
intensiva delle dinamiche di riproduzione/trasformazione di insiemi sociali di natura
diversa, tenendo conto, allo stesso tempo, dei comportamenti degli attori e dei
significati che questi attribuiscono ai loro comportamenti4.
I fatti del mutamento sociale e dello sviluppo valorizzano simultaneamente i vincoli
esterni e l’autonomia, o capacità di iniziativa (e di resistenza), degli individui e dei
gruppi locali, che de Sardan nel complesso definisce “bricolage creativo degli attori
sociali”.
Per quanto riguarda le relazioni fra l’antropologia dello sviluppo e l’antropologia
classica, esistono due possibili posizioni.
La prima consisterebbe nel voler riabilitare l’antropologia dello sviluppo in quanto
emarginata dall’antropologia accademica. A tal proposito de Sardan critica le
osservazioni di Lévi-Strauss quando distingue l’antropologia “allo stato puro”
dall’antropologia “allo stato diluito”, cioè l’antropologia dello sviluppo. In questa
prospettiva de Sardan vede nell’antropologia del cambiamento sociale e dello
sviluppo una delle possibili fonti di rinnovamento per le scienze sociali.
3
4
Ibidem.
Cfr, J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit.
9 De Sardan sostiene che i fenomeni sociali associati alle politiche, operazioni,
dispositivi, ecc, che riguardano lo sviluppo, costituiscano un campo di ricerca a sé
stante per l’antropologia e la sociologia. In questo senso queste due discipline non
possono essere distinte. “Il contesto di dominazione e disuguaglianza in cui
intervengono i processi di sviluppo mette in atto e in gioco ideologie, retoriche e
pratiche di tipo populista”5.
Tuttavia tale sviluppo si configura come l’insieme dei processi sociali indotti per
trasformare un ambiente, intrapresi da istituzioni o attori esterni a questo ambiente,
che cercano di mobilitarlo tramite tecniche, risorse e conoscenze. Esso deve essere
studiato dalla socio-antropologia puramente in quanto fenomeno sociale.
Come sostiene Marx nelle tesi su Feuerbach, il problema (dello sviluppo) è
comprendere in che modo il mondo si trasformi, piuttosto che pretendere di
trasformarlo senza darsi i mezzi per comprenderlo.
La socioantropologia in questo senso deve essere omogenea e deve trattare i suoi
oggetti in maniera trasversale. Non a caso le opinioni degli studiosi concordano nel
far risalire agli studi britannici, classificati i generale come evoluzionisti, le origini
della antropologia “socioculturale” moderna. In questo senso l’evoluzionismo non
assume un significato limitato e riduttivo, ma “è più propriamente la concezione
secondo cui la vita in ogni sua manifestazione, nonché la natura in tutti i suoi
aspetti, sono il prodotto dello sviluppo”.6
La socioantropologia è contemporaneamente un’antropologia politica, una sociologia
delle organizzazioni, dunque, un’antropologia economica che deve tenere conto dei
tanti aspetti della vita associata e della dinamica sociale.
L’approccio che De Sardan propone per interpretare lo sviluppo, meno legato alle
teorie più generali dell’evoluzionismo (anche se altrettanto interessanti), è di tipo
populista, come relazione, cioè, tra intellettuali (gruppi sociali privilegiati) e popolo
(gruppi sociali dominati); relazione mediante la quale gli intellettuali “scoprono” il
popolo, lo compiangono e si meravigliano delle sue capacità, e decidono di mettersi
al suo servizio.
5
6
Ivi, Introduz. p. IX.
P. Sibilla, Introduzione all’antropologia economica, Utet, Torino, 1996, p. 25
10 Quindi non un populismo nell’accezione del linguaggio politico contemporaneo (in
cui si evoca il comportamento demagogico di politici leader carismatici), ma un
populismo profondamente radicato al mondo dello sviluppo (che riguarda cioè i
“dannati della terra”, i disoccupati delle “Brazaville nere”, gli agricoltori esposti alle
carestie, le vittime della malnutrizione del colera o dell’aggiustamento strutturale,
ecc). Tale dinamica si manifesta con l’accoglimento della visione dei vinti, la
cronaca delle resistenze e l’inventario delle competenze di esperti e contadini locali7.
Questa prospettiva sicuramente non è esaustiva, ma è altrettanto utile per
l’interpretazione.
1.b Antropologia e Africa, tra cambiamento e conflitto
Se la sociologia e l’etnologia costituivano ancora un’unica disciplina all’epoca dei
padri fondatori di inizio secolo (Mauss e Durkheim), la ricerca sul campo in Africa si
è costituita sotto il segno della sola etnologia, e dunque in rottura rispetto alla
sociologia. “Alla sociologia le società moderne e occidentali, le città, i fenomeni di
massa; all’etnologia le società “primitive e colonizzate, i villaggi, le confraternite e
le sette”8.
Fra le due guerre mondiali la problematica evoluzionistica secondo cui le società
sono tutte proiettate sull’asse storico del progresso, viene abbandonata a favore di un
relativismo culturale che scopre la specificità irriducibile di ogni cultura e proclama
la necessità di studiare le società sul campo.
Agli inizi della colonizzazione aveva prevalso l’idea che i popoli africani fossero
“primitivi”, e dunque spinti da impulsi profondamente irrazionali. L’antropologia si è
ampiamente costituita contro quest’accezione del senso comune occidentale.
Nonostante le critiche che gli possono essere mosse, Lévy-Bruhl, afferma de Sardan,
parlando della “mentalità prelogica”, riconosceva già ai popoli primitivi una certa
“logica”, sicuramente “arcaica”e diversa dalla “vera” logica (occidentale), ma
comunque reale e degna di interesse.
7
8
Cfr, J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit.
Ivi, p. 3
11 “L’aggiornamento sulla complessità dei sistemi di pensiero africani,
sull’ampiezza delle costruzioni simboliche o cosmogoniche, ha messo
l’accento, sulla specificità dei valori delle società africane, contrapponendo
così alla razionalità tecnica ed economica occidentale una razionalità
tradizionale africana altra”9.
Ciò significava attaccare i pregiudizi etnocentrici dell’occidente. Questo
incontestabile progresso è stato tuttavia pagato con il disinteresse per le dinamiche
storiche e l’orientarsi delle ricerche verso una prospettiva statica e “tradizionalista”,
rischiando spesso di mettere da parte tanto i mutamenti storici quanto l’interazione
tra i fatti religiosi e gli altri fatti sociali (comprese le dimensioni politiche o
economiche).
A tale proposito, oggi sappiamo che l’etnia è un costrutto sociale e che
l’identità etnica è “relativa, fluttuante, parzialmente situazionale e negoziata”10. In
quanto tale essa è spesso causa di conflitti.
L’etnologia classica, nell’analizzare le società africane, spesso si è concentrata su
società, cultura ed etnia. Così le culture africane sono state implicitamente dotate di
tre grandi proprietà: sarebbero cioè omogenee, resisterebbero alla storia e
costituirebbero altrettanti universi autonomi.
Dopo la Seconda guerra mondiale, l’antropologia marxista, ha analizzato gli effetti
della “situazione coloniale”, prendendo atto dell’esistenza di un sistema di
dominazione, e tentando di reinserire le società “etnologizzate” in un contesto più
ampio. Più in generale, George Balandier intendeva “riabilitare la storia in
opposizione ai presupposti funzionalisti e strutturalisti”11.
Tale tentativo dell’antropologia marxista partiva dal presupposto che, per le teorie
della dipendenza, il “sottosviluppo dei paesi del Sud, non è più un segno della loro
arretratezza, o un’impronta del loro “tradizionalismo”12, ma il prodotto del
saccheggio storico di cui sono stati vittime per mezzo del sistema economico
9
Ivi, p. 5
Ivi, p. 6
11
Ivi, p. 8
12
Ivi, p. 10
10
12 mondiale, dell’imperialismo e della sua pretesa di imporre un modello universale
basato sui rapporti di forza e, quindi, sulle disuguaglianze.
Lévi-Strauss ha osservato che l’antropologia è il risultato di un processo
storico, che si è risolto nell’asservimento di una parte dell’umanità rispetto ad
un’altra; l’antropologia quindi, “figlia di questa era di violenza”, ha rappresentato
una situazione in cui una parte del genere umano ha trattato l’altra come oggetto13.
De Sardan stesso ha però proposto una critica che rompe con il carattere unilaterale
delle teorie della dipendenza, intendendo mettere in risalto la sistematica indifferenza
di molti intellettuali, per le relazioni di classe interne ai paesi africani e per la
responsabilità delle classi dominanti locali.
“Se il linguaggio marxista di tale critica può sembrare desueto, ne rivendico di
buon grado, ancora oggi, il contenuto nella sua essenza, che del resto, sembra
ormai scontato: non si può evitare un’analisi del ruolo delle classi dirigenti
africane e dei loro meccanismi di arricchimento”14.
Un’espressione emblematica usata nel linguaggio della critica postcoloniale, è: “al
dominio del bianco sul nero, si è sostituito quello del nero sul nero”. Come osserva
Franz Fanon, si tratta solo della “sostituzione d’una specie di uomini con un’altra
specie di uomini.”15
Si riconosce ormai frequentemente che le società locali detengono culture e saperi
ricchi e complessi. Ma subito dopo si tende a rinchiudere questi saperi e queste
culture in una visione atemporale e passatista. Per bene rendere tale concetto, de
Sardan considera, per esempio, le pratiche terapeutiche indigene e il nuovo interesse
che esse suscitano, in rapporto al fatto che spesso in esse si intravede la
sopravvivenza di tecniche e di conoscenze ancestrali.
13
C.G. Rossetti, Antropologia del dominio coloniale e sviluppo democratico, Liguori editore, Napoli,
1979, p. 35
14
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit., p.11.
15
F. Fanon, I dannati della terra, Piccola Biblioteca Einaudi, 2007, p. 3
13 “Non è forse significativo che, in linea con l’OMS si parli di ‘tradi-praticiens’
per designare i guaritori africani? Ora gli itinerari terapeutici preconizzati da
questi “medici tradizionali (a prescindere dalla loro efficacia), così come i
saperi sui quali poggiano, non hanno, in gran parte, proprio nulla di
tradizionale. Senza per questo essere occidentali, essi si sono notevolmente
evoluti a partire dal XIX secolo e dalla conquista coloniale”16.
Essi hanno inglobato e trasformato tutta una serie di elementi materiali e simbolici
legati alla medicina europea. “Non a caso si evidenzia ormai la consapevolezza che
strategie e sistemi di cura ‘tradizionali’, rivelino una profonda saggezza e siano
coerenti con le risorse ed i bisogni dei mondi locali”17.
Quella che viene considerata “tradizione”, nell’immagine collettiva può essere
imputata alla combinazione di due processi. In primo luogo, tutto ciò che, in Africa,
non rientra nel settore considerato moderno, viene automaticamente imputato alla
tradizionalità africana e rimandato ad una sorta di clichet. Tutto ciò che, in settori che
pure si dicono moderni come lo stato, l’università, i servizi tecnici, la gestione
pubblica dei rifiuti ecc, non corrisponde a quanto potremmo chiamare normalità
occidentale (economica e politica), viene parimenti imputato a sopravvivenze di tipo
culturale; un patrimonio tradizionale appunto.
“Così, fenomeni decisamente contemporanei, inediti, e in effetti originali nelle
loro attuali forme africane – come la corruzione o il nepotismo, strettamente
legati ai processi di formazione delle moderne classi dirigenti africane e alle
metamorfosi della costruzione e della degradazione dello stato postcoloniale,
possono venire spiegati in termini di strani atavismi culturali”18.
Il postcolonialismo, più che segnare una frattura o un distacco netto nei confronti del
passato,
costituisce
una
sorta
di
“ritorsione
epistemologica”
costituita
16
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit., p. 52
S. De Valeri, Politiche sanitarie globali e contesti locali, in Ruini M. (a cura di), Interpretare lo
sviluppo. Note di socioantropologia, Bulzoni Editore, Roma, 2009, pp. 159-160
18
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit., p. 53
17
14 dall’impossibilità di un suo superamento date le dinamiche neocoloniali che hanno
caratterizzato la maggior parte dei processi storici di decolonizzazione formale.
Nel periodo postcoloniale il cambiamento divenne la preoccupazione dominante.
Gran parte di ciò che era stato concepito come consuetudine fu reinterpretato come
un artefatto di un particolare periodo storico, legittimato dal fatto di essere in qualche
maniera collegato alla tradizione. L’ondata etnografica postcoloniale in Africa è
andata molto oltre la precedente tendenza a de-storicizzare. Essa ha invaso un
territorio intellettuale in cui pesava enormemente la storia dell’esperienza coloniale e
postcoloniale di ogni popolazione, nel quadro di un’economia politica in
trasformazione19.
L’assetto postcoloniale nel continente nero si è dissolto in una sorta di
transizione eterna: la critica postcoloniale, trova qui uno dei suoi argomenti
principali; se non c’è transizione non c’è progresso, ma c’è sostituzione. Tuttavia il
problema dell’Africa sembra essere esattamente l’opposto, cioè una transizione
eterna, imposta, esogena, una “dannazione”. L’idea di dannazione, è concettualizzata
da Franz Fanon come una condizione di precarietà interminabile, una transizione che
dovrebbe portare alla modernità, ma, una modernità dannata appunto, subordinata.
E’ in questa condanna che riscontriamo il fallimento dell’Africa ufficiale, che non
era altro che il progetto europeo per l’Africa.
A partire dagli anni Ottanta, soprattutto in ambito anglosassone, la rilettura di Frantz
Fanon contribuisce allo sviluppo delle teorie e degli studi postcoloniali, alla luce cioè
delle problematiche emergenti nel passaggio da una fase di decolonizzazione ad un
assetto postcoloniale.
La storia del colonialismo non finisce con la decolonizzazione, ma si
rideclina. Se da un lato si era sgretolata la stessa tripartizione del mondo che nel
secondo dopoguerra aveva sorretto i processi di decolonizzazione, dall’altro, il
riemergere delle periferie del mondo nel cuore dei centri metropolitani attraverso la
diaspora migratoria, riapriva un dibattito più interessato ad indagare le connessioni
tra colonia e metropoli, tra centro e periferia, che a rivendicarne un’astratta
separatezza.
19
S. Falk Moore, Antropologia e Africa, Raffaello Cortina editore, 2004.
15 L’idea di fondo di Fanon è che il ritorno dei conflitti etnici e tribali non sia il
riemergere di formazioni precoloniali, ma lo scontro assolutamente moderno tra chi
verrà ammesso nel nuovo ordine economico e chi ne resterà escluso.
In questo quadro, in cui si situano le guerre civili che esplodono in Africa nel
periodo
immediatamente
successivo
all’indipendenza,
il
nazionalismo
20
d’importazione europea ne riproduce il manicheismo delirante” .
Per quanto riguarda invece l’antropologia contemporanea, l’approccio è diventato
più locale e più incentrato sul “micro”. Le prospettive planetarie o continentali
vengono abbandonate, e lo sforzo di elaborazione teorica viene incentrato sulla
comprensione, almeno parziale, di fenomeni settoriali o regionali piuttosto che su
astratte teorie.
Il contributo di Balandier, che negli anni Cinquanta e Sessanta ha fatto sentire una
voce diversa da quella di Levi-Strauss e dallo strutturalismo, mettendo l’accento
sulle dinamiche sociali, sulla diacronia, sulle rotture e sulle contraddizioni, ha dato
un spinta in avanti a questa staticità disciplinare, tramite l’apertura agli studi della
Scuola di Manchester e ai risultati delle ricerche sui sincretismi interculturali.
L’innovativo indirizzo di studi proposto dall’Università di Manchester, grazie
all’impegno parallelo del Rhodes-Livingston Institute a Lusaka, in Nord Rhodesia
(oggi Repubblica dello Zambia), si basava sui contribuiti teorici e metodologici che
andavano dalla teoria scientifica della cultura di Malinowski, allo strutturalfunzionalismo di Radcliffe Brown, sino ad alla prospettiva diacronica proposta da
Evans-Pritchard.
Quest’ultimo favorì lo sviluppo di studi incentrati sul cambiamento sociale,
anche mediante l’intreccio tra la dimensione temporale e la struttura sociale.
Le innovazioni metodologiche e teoriche introdotte da tali studiosi, coinvolsero il
concetto di struttura sociale nella misura in cui si rivolgevano al tema del mutamento
socioculturale. La nuova metodologia, più adatta a tale tema, si basava su un metodo
di indagine basato sul “case study”, più adatto alla comprensione e descrizione della
20
F. Fanon, I dannati della terra, op. cit., p. 42
16 mutevole e complessa realtà socioculturale osservata in Africa, incentrandosi
soprattutto in ambienti urbani.
In tal senso, alcune delle ricerche più importanti si focalizzano su un evento
particolare, ben delimitato nel tempo e nello spazio e utilizzato come chiave di
lettura del più ampio contesto socioculturale. Inoltre, il case study poteva essere
esteso nel tempo e nello spazio, andando a configurare un’interpretazione
antropologica, processuale piuttosto che morfologica delle dinamiche socioculturali,
sino a giungere alla realizzazione di studi più complessi, articolati sulla realtà urbana
vista nel suo insieme e alla definizione di metodi di studio centrati sull’analisi delle
reti21.
Grazie a tali rinnovamenti dell’antropologia, oggi si può ormai considerare come
acquisita l’esistenza di una plurirazionalità degli attori sociali. Le scienze sociali
hanno scoperto o riscoperto la pluralità delle razionalità e, accanto alle razionalità
economiche, restituiscono un posto alle razionalità culturali e simboliche senza per
questo escludere le prime. “Le stesse società africane, rurali, urbane o ‘ruraliurbane’, sono, forse più di altre, attraversate da razionalità diverse. E’ alla loro
confluenza che occorre situarsi per comprendere i cambiamenti in corso”22.
Le logiche economiche intervengono nei rituali, così come le logiche simboliche
sottendono i comportamenti economici.
“Le strategie di linguaggio, la gerarchia dei beni simbolici, il sistema di valori
che regola le modalità di riconoscimento sociale, le procedure di
capitalizzazione del potere, le norme ostentatorie, sono altrettanti esempi di
ricorso a razionalità che non possono essere ridotte a strategie propriamente
economiche, che non eliminano le strategie economiche, ma si amalgamano
con esse, contribuendo a renderle più complesse”23.
21
D. Altobelli, L’antropologia sociale britannica e la scuola di Manchester, in, M. Ruini (a cura di),
Interpretare lo sviluppo. Note di socioantropologia, Bulzoni Editore, 2009, pp. 76-77
22
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit., p. 21
23
Ivi, p. 22
17 Le rappresentazioni occidentali dell’Africa, secondo de Sardan, hanno attraversato,
riguardo al problema della razionalità, quattro diverse fasi: dopo una prima fase che
negava agli africani ogni forma di razionalità, si sono succedute una fase che
contrapponeva le razionalità “religiose” africane alle razionalità “economiche”
occidentali. La fase successiva, scopriva nei contadini africani razionalità tecniche ed
economiche, e la fase attuale, infine, riguarda quella della multi razionalità appunto.
L’antropologia del cambiamento sociale e dello sviluppo, si situa anche nella scia di
Polany, che ha insistito sul concetto di embeddeness, ossia dell’inserimento
dell’economia nel sociale genericamente inteso. I fenomeni che rientrano
classicamente nell’economia non possono arbitrariamente essere resi autonomi e
scollegati dalle loro dimensioni sociali, politiche e simboliche.
De Sardan pone l’accento sul rifiuto di molte società tradizionali di entrare nel
mercato moderno, trovando rifugio nell’autosussistenza e nelle antiche solidarietà,
resistendo così all’influenza dello stato e dell’economia moderna (è l’ “economia
informale”, o “economia morale”).
Il modo di produzione contadino pre-coloniale, inserito in un sistema di solidarietà,
di scambi e di obbligazioni, fondato sui legami affettivi della parentela, dell’alleanza
o della residenza, offre a tutti una “rete di sicurezza”.
Esso rimane ancora oggi centrato su una logica della sussistenza e riesce a sottrarsi ai
tentativi di controllo da parte dello stato, e di inquadramento da parte delle istituzioni
dello sviluppo, promotori entrambi di una logica del profitto e dell’accumulazione.
Il sistema di produzione contadino continua ad essere una forza
predominante nel continente africano (l’espressione “modo contadino” si riferisce al
fatto che la produzione continua ad essere strutturata dalla legge di sussistenza
piuttosto che da quella del valore).
Tuttavia “combinazione di rapporti di produzione” ammette la coesistenza di svariati
rapporti di produzione e non presuppone necessariamente il persistere di un antico
modo di produzione. “E’ una combinazione, non binaria, di rapporti di produzione
eterogenei e nuovi”24. I rapporti di produzione legati al genere, per esempio,
24
Ivi, p.119
18 caratteristici del modo di produzione contadino, si combinavano, con diversi rapporti
di produzione rurali minoritari o secondari (la loro presenza o assenza non
modificava il funzionamento del modo di produzione contadino).
Tutto questo ventaglio di rapporti di produzione rurali, organizzati intorno alla
produzione contadina domestica, si combinava a sua volta con i diversi rapporti di
produzione urbani nei quali i migranti entravano provvisoriamente a far parte.
“Non solo in Africa i contadini sono tutt’altro che autonomi e capaci di
autosussistenza, ma la loro integrazione nei circuiti di scambio legati
all’economia moderna è in particolare un effetto del loro stesso operato. I
contadini non sono resistenti vittoriosi che si sottraggono all’inclusione nel
circuito dell’economia mondiale, e non sono neppure resistenti sconfitti. In
effetti, essi collaborano a questa inclusione, sia per interesse sia per necessità.
Le logiche mercantili, il perseguimento dell’utile, l’uso delle istituzioni
moderne sono loro ampiamente familiari”25.
L’economia morale ammette le contraddizioni interne e le diseguaglianze
cosmopolitiche. Infatti le norme sociali che reggevano le relazioni sociali nelle
campagne erano tutt’altre che ugualitarie.
“L’inclusione nell’economia monetaria, la mercificazione, l’integrazione nei
sistemi clientelari moderni piuttosto che in quelli tradizionali, l’intrecciarsi di
forme di produzione e di reddito rurali e urbane … tutto questo sembra ormai
essere non solo acquisito ma anche interiorizzato dalla maggioranza dei
contadini, che lo so deplori o no”26.
Riguardo al rapporto tra innovazione ed antropologia, è necessario che quest’ultima
sia attenta tanto al patrimonio tradizionale quanto ai cambiamenti.
Se la definizione di innovazione secondo Schumpeter è quella di “nuova
combinazione dei mezzi di produzione”, de Sardan la espande intendendo ogni
25
26
Ivi, p. 82
Ibidem
19 “innesto di tecniche, di saperi o di modi di organizzazione inediti (in genere nella
forma di adattamenti locali, a partire da prestiti o importazioni), su altre forme
preesistenti”27.
A tale proposito, secondo Jeremy Rifkin, la storia mostra “che ogni
applicazione tecnica presenta alcuni effetti secondari imprevedibili che sono ancora
più disastrosi della stessa assenza della nuova tecnica”28. In tutte le civiltà che
hanno preceduto l’era industriale, la tecnica aveva funzioni limitate. Era uno
strumento, non un sistema di vita.
Ciononostante i progressi tecnologici accelerano la trasformazione di una maggiore
quantità di risorse in un periodo di tempo più breve, esaurendo le riserve naturali e
creando sempre maggiore quantità di rifiuti ed un sempre maggior disordine.
Ogni innovazione avviene all’interno di un sistema sociale strutturato e non in un
aggregato di individui atomizzati. In questo senso, comprendere i fenomeni di
accettazione/rifiuto di un’innovazione, significa situare l’innovazione nel suo
contesto sociale, e cioè procedere ad un’analisi della società locale con tutti i suoi
conflitti politici, economici e simbolici, che fanno dell’innovazione una posta in
gioco. L’analisi delle innovazioni non deve dunque arrestarsi al solo fenomeno
dell’adozione, ma deve tenere anche conto delle conseguenze a lungo termine sulla
società locale, tramite la lente del conflitto.
I primi studi di antropologia africanista che abbiano sistematicamente affrontato la
realtà sociale attraverso i conflitti, sono quelli della scuola di Manchester.
L’antropologo britannico Max Gluckman, si concentrò sulla natura conflittuale della
società africane, sui problemi relativi all’ordine politico e al diritto, al controllo
sociale, alla stabilità e al mutamento nel contesto dell’amministrazione britannica
della regione della Rhodesia del Nord.
Nel corso della sua attività di studioso, il tema del conflitto sarà presentato
analiticamente:
27
28
Ivi, p. 68
J. Rifkin, Entropia. Il che fare per salvare il mondo, Interno giallo editore, Milano, 1992, p. 104
20 “[…] ho deciso di limitare il significato di ’conflitto’ a quelle opposizioni
determinate dalla struttura stessa dell’organizzazione sociale. […] Per i
disordini di superficie della vita sociale, a seconda della loro natura, possiamo
usare i termini competizione, disputa, controversia, lite, contesa, discordia,
rivalità, dissidio, ecc. Preferisco riservare il termine lotta a quegli eventi le cui
origini sono più profonde e basilari, e il termine “conflitto” per le
contraddizioni nodali del sistema, ma anche in riferimento al rapporto che
esiste tra quelle discrepanze che mettono i moto de processi che provocano
alterazioni nei ruoli sociali ma non nei modelli di tali ruoli. Preferisco usare il
termine più comune di “contraddizione” per quei rapporti che portano
inevitabilmente ad un mutamento radicale del modello di struttura”29.
Analogamente, dallo studioso venivano impiegati e problematizzati i concetti di
stratificazione, classe, tribù e tribalismo. Concetti che ebbero grande importanza
all’interno dell’intera tradizione della scuola di Manchester.
Su questa impostazione teorica, W. Turner propone una interpretazione dei conflitti,
per cui essi tendono a seguire un percorso, a ripetere una forma, a esplicitarsi
secondo modelli socialmente riconosciuti ed accettati. In Turner propone quindi un
modello basato sul concetto di “dramma sociale”, cioè di esplosioni di conflittualità
che si presentano in forma di processo ed in più fasi.
Da una parte, quanto detto, ci porta ad una constatazione empirica: tutte le società
sono attraversate da conflitti. Il conflitto è dunque un elemento insito in ogni vita
sociale.
“Tutte le società, per quanto piccole e per quanto prive di forme istituzionali di
governo, sono divise e caratterizzate da disuguaglianze. Queste divisioni e
queste disuguaglianze sono alimentate dai costumi, vale a dire dalle norme,
dalle regole morali, dalle convenzioni (potremmo anche dire dai codici
culturali)”30.
29
M. Gluckman, Potere, diritto e rituale nelle società tribali, Bollati Boringhieri, Torino, 1977 , p.141
21 I conflitti esprimono dunque degli interessi legati a posizioni sociali differenti e sono
culturalmente strutturati.
Essi, secondo la lettura funzionalista, che sembrano condannare le società alla
frantumazione o all’anarchia, contribuiscono invece alla riproduzione sociale e al
consolidarsi della coesione di una società. Tale postulato funzionalista pone diversi
problemi, visto che oggi, proprio in rapporto a quanto ci insegna il laboratorio
africano, sembra che i conflitti possano portare alla disgregazione di un insieme
sociale piuttosto che alla sua riproduzione.
L’analisi dei conflitti permette anche di mettere in risalto i mezzi per prevenirli o
risolverli. In quanto dispositivi di ricerca, i conflitti sono indicatori preziosi del
funzionamento di una società locale, per questo essi sono pertinenti al tema del
cambiamento sociale.
L’etnologia, quindi, si deve porre al livello più concreto, in seno ad una popolazione
o a più popolazioni sufficientemente vicine rispetto ad habitat, storia e cultura.
L’etnologo adotta un procedimento che è l’inverso di quello del filosofo. All’ipotesi
di un intelletto universale, egli preferisce l’osservazione empirica di intelletti
collettivi, le cui proprietà gli sono rese manifeste da innumerevoli sistemi concreti di
rappresentazioni31 .
La cautela che l’etnologo deve utilizzare quando si fanno deduzioni circa quello che
avviene nella mente di persone che appartengono ad altre culture, non è mai troppa.
Per questo la ricerca antropologica, per evitare la confusione tra l’utilizzo dei termini
“oggettivo” e “soggettivo”, usa i termini “etico” ed “emico” (presi in prestito dalla
linguistica generale) che possono approssimativamente corrispondere alle categorie
“mentale” e “comportamentale”.
Etico ed emico, sono i presupposti della teoria del “materialismo culturale”, proposta
da Marvin Harris come strategia, che, basandosi sulla premessa che la vita sociale
31
C. Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, Il saggiatore, Milano, 2008, p. 26
22 dell’uomo è una risposta ai problemi pratici dell’esistenza terrena, permette di ben
comprendere le cause delle differenze tra società e società.
Tale teoria riconosce nel materialismo storico la sua base, cioè nel porre la
produzione come la base sulla quale si sviluppa la società (la sovrastruttura). Ai
fattori di produzione Harris aggiunge quelli demografici, riprendendo le intuizioni di
Malthus.
La priorità strategica è quella di trovare un equilibrio tra riproduzione da un lato, e
produzione e consumo di energia dall’altro. “L’infrastruttura”, cioè il modo di
produzione e di riproduzione, “è la principale interfaccia tra cultura e natura, la
frontiera attraverso la quale i condizionamenti ecologici, chimici e fisici a cui
l’azione umana è soggetta, interagiscono con le principali pratiche socioculturali
volte al superamento o alla modifica di tali vincoli32”
La parola “culturale” vuole indicare la differenza tra le cause materiali dei processi
socioculturali, e quelle strettamente attinenti a fenomeni organici o inorganici (in
antitesi con i determinismi biologici)33. Per sistema socioculturale Harris intende
un’organizzazione limitata di persone, pensieri e attività che uniscono una
popolazione, una società e una cultura.
Ritornando alla distinzione tra etico ed emico, quest’ultimo termine si utilizza per
designare quelle operazioni in cui si eleva l’informatore indigeno alla condizione di
giudice ultimo dell’adeguatezza delle descrizioni e delle analisi dell’osservatore. La
prova di tale adeguatezza delle analisi emiche, sta nella loro capacità di generare
asserzioni, che l’indigeno stesso accetta come appropriate. La ricerca deve tentare di
acquisire una coscienza delle categorie e regole che bisogna conoscere per fare una
ricerca che vada in profondità34.
Le operazioni etiche si basano invece sull’elevare gli osservatori come giudici ultimi.
La prova dell’adeguatezza è data dalla capacità di generare teorie scientifiche: invece
32
M. Harris, Materialismo culturale. La lotta per una scienza della cultura, Feltrinelli, Milano, 1984
p. 65
33
Ivi, p. 12
34
Ivi, p. 41
23 di utilizzare concetti secondo la prospettiva dell’indigeno, l’osservatore è libero di
utilizzare altre categorie e regole che ha desunto dal linguaggio e dalle conoscenze
scientifiche (quelle socio antropologiche nella fattispecie).
L’intento, quindi, è di descrivere l’emica e l’etica e tentare di spiegarne una
nei termini dell’altra. Tuttavia l’oggettività resta, per Harris, “lo status
epistemologico che distingue la comunità degli osservatori dalle comunità che
vengono osservate35”.
Il punto cruciale cui arriva l’analisi del materialismo culturale, consiste nel
considerare l’esplosione demografica e il fallimento della modernizzazione nei paesi
in via di sviluppo (l’Africa, tra tutti), direttamente legati al neocolonialismo.
La crescente richiesta di manodopera a basso costo del capitalismo
internazionale, avrebbe infatti sconvolto gli equilibri del mondo intero. “La
popolazione continua a crescere, nonostante un generale declino dei livelli di vita
nelle aree a elevata densità, perché le famiglie numerose continuano ad essere
relativamente convenienti”36. Analogamente il tasso di aumento della popolazione
nei paesi sviluppati è in costante declino
Il pensiero di Harris e l’approccio cultural-materialista, sono stati largamente
ripreso dall’antropologia ecologica, che a noi interessa nella misura in cui la
questione dei rifiuti investe sia la produzione della sussistenza materiale dell’uomo
(concezione sostantivista di economia) che la relazione con l’ambiente (ecologia).
L’approccio ecologico alla cultura parte dal presupposto che se si pensa all’insieme
di una popolazione umana e del suo ambiente di vita come ad un ecosistema è
necessario supporre che quella popolazione tragga più o meno integralmente la
propria sussistenza da quell’ambiente e dunque che la distanza tra quegli uomini e il
loro cibo non superi le loro capacità di intervento sull’ambiente in cui vivono.
Questa osservazione è utile per comprendere come l’invenzione dei rifiuti urbani
allunghi a dismisura la distanza tra prodotti e consumatori.
35
36
Ivi, p. 45
Ivi, p. 122
24 Tuttavia il presupposto tecno-economico dell’antropologia ecologica secondo cui il
grado di sviluppo culturale varia in modo direttamente proporzionale rispetto
all’efficienza degli arnesi impiegati, dista in maniera rilevante dalla nostra
prospettiva di ricerca. Godelier sosteneva che esso (il presupposto tecno-economico
dell’antropologia) “riduce tutti i rapporti sociali a epifenomeni che accompagnano
dei rapporti economici ridotti essi stessi ad una tecnica di adattamento
all’ambiente”37. Ne consegue la necessità di considerare l’importanza delle categorie
culturali.
37
M. Pavanello, Sistemi umani. Profilo di antropologia economica e di ecologia culturale, Cisu,
Roma, 1992, p. 18
25 CAPITOLO I
LA CONFIGURAZIONE SOCIALE DEI RIFIUTI
La definizione della parola “rifiuto”, nel Dizionario di lingua italiana Devoto-Oli
riporta: “Esclusione o espulsione per inservibilità (in riferimento ad oggetti, con
significato affine a scarto). Quanto si getta via perché inutilizzabile o dannoso”1.
Il rifiuto si pone quindi come sintesi tra percezione individuale e percezione
collettiva: esso è costituito da cose mobili il cui detentore se ne vuole liberare
(approccio soggettivo) e la cui eliminazione regolamentata è concepita per preservare
il ben essere della comunità e per proteggere l’ambiente (approccio collettivo).
Rimanendo nel campo semantico dei rifiuti, è interessante notare che la
parola “immondizia” è il contrario di “mondezza”, cioè di nettezza d’animo e di
purezza. Il verbo “mondare” indica infatti “liberare degli elementi nocivi, impuri o
inutilizzabili”. Il verbo proviene dal Latino tardo “mundare”, derivato di “mundus”2,
che significa mondo, pulito. Da qui “immudus”, cioè sudicio, sporco. Già da un
punto di vista linguistico compare quindi il movimento di inclusione-esclusione, per
cui ciò che è pulito, è dentro perché fa parte del “mondo”, ciò che è fuori è sporco.
L’immondizia, intesa come il rifiuto-perdita di un’entità, dipende da una scelta
culturale legata al pre- e post-consumo che, il più delle volte, dipende a sua volta più
da un giudizio estetico ed economico, che non da una valutazione sostanziale. Un
rifiuto, quindi, che si pone come una entità-merce, nel corpo e nella sostanza, uscita
dal proprio ciclo vitale per scelta del detentore o perché non ulteriormente
utilizzabile.
Nel nostro sistema socio-economico i rifiuti sono sempre stati oscurati; essi
costituiscono il “dark side” del prodotto (nelle forme materiali del preconsumo e del
postconsumo), che dipende dalla relazione tra prodotto ed obsolescenza (una
relazione “stretta” nel sistema capitalista e più “larga” nelle società tradizionali e di
sussistenza).
Alla domanda “cosa rende tali i rifiuti?”, si può rispondere che è il degrado e la
corruzione della materia.
1
2
G. Devoto, G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1996, p. 1653
Ivi, p. 928
26 Tale “consumazione” può avvenire sia a causa dell’uomo che a causa di processi
naturali, come, ad esempio, il “cucinare ed il mangiare ”(evento culturale) ed il
“marcire” (evento naturale).
Lo strutturalismo ha proposto uno schema per interpretare ciò che
precedentemente appariva come un insieme di elementi simbolici, arbitrari e persino
fortuiti, trasformandoli invece negli elementi di una rappresentazione altamente
sistemica dell’ordine dell’universo culturale.
“Come al concetto di natura si contrappone quello di cultura, al prodotto
grezzo l’oggetto manufatto, o alla terra vergine quella lavorata, così all’idea
di civiltà è stata a lungo contrapposta l’idea di stato selvaggio”3.
La parola “natura” si trova, per Claude Lévi-Strauss, al centro di un’area di
significati in cui vi è l’informe, la continuità indifferenziata; mentre la cultura
implica l’istituzione di nessi e rapporti che possono essere istituiti solo se quella
continuità è stata interrotta. La questione dell’opposizione tra cultura e natura,
consiste nell’opposizione fra la legge e la regola, fra l’eredità biologica e la
tradizione culturale. Per Levi- Strauss, una tale opposizione non ha un significato
storico, ma un valore di metodo.
Nell’opera “il crudo e il cotto”, il pensatore francese si propone di mostrare
come categorie empiriche, quali crudo e cotto, fresco e putrido, bagnato e bruciato,
ecc, definibili con precisione attraverso la semplice osservazione etnografica e
assumendo ogni volta il punto di vista di una cultura particolare, possono fungere da
strumenti concettuali per far emergere certe nozioni astratte utili alla costruzione del
senso4.
Così come la parola crudo, all’interno dell’opposizione tra natura e cultura, si
manifesta nell’uso figurato del temine (per segnalare l’assenza, fra il corpo e le cose,
del normale intermediario culturale: abiti, sella, strumenti di lavoro, ecc5), così la
parola rifiuto rappresenta un processo di “consumazione”, sempre all’interno
dell’opposizione natura-cultura, in cui emerge la categoria del putrido e del bruciato,
3
M. Leiris, L’occhio dell’etnografo. Razza e altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino, 2005, p.86
Cfr., C.Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, Il saggiatore, Milano, 2008
5
C.Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, op. cit., pp. 442-443
4
27 cui corrisponde l’ulteriore contrapposizione tra “distruzione rapida” e “distruzione
lenta”. La gestione dei rifiuti si caratterizza infatti in quest’ultima dinamica: il rifiuto
prodotto dalla putrescenza naturale da una parte (distruzione lenta), e il rifiuto
bruciato (distruzione rapida) dall’altra, che è la tecnica predominante di gestione dei
rifiuti nelle società preindustriali.
La “culturalizzazione” del rifiuto presenta genericamente le stesse
caratteristiche nelle società pre-moderne (gestione domestica, impiego dei rifiuti
organici come fertilizzanti, riuso, ecc), ma subisce un enorme cambiamento con
l’avvento del modo di produzione industriale, al quale è legato un nuovo tipo di
esigenza riguardo la gestione dei rifiuti (maggiore produzione di materiali inorganici,
tempi di smaltimento allungati, accumulazione nelle città, ecc).
Se il veleno nel pensiero indigeno opera una specie di corto circuito tra natura e
cultura, nella misura in cui la prima penetra momentaneamente nella seconda, in
quanto “il veleno è incomparabilmente più potente dell’uomo”6, possiamo pensare i
“rifiuti” esattamente nella relazione inversa. Cioè la produzione di rifiuti (soprattutto
sintetici) è un’attività culturale, cioè svolta dall’uomo, che nell’era industriale è
diventata “incomparabilmente più potente” della natura.
La categoria culturale cui appartengono i rifiuti è quella del puro/impuro, o meglio, è
in base a tale categoria che noi stabiliamo cosa è sporco e cosa no, cosa è da gettare
via e cosa no; in sostanza cosa “deve essere allontanato” e cosa tenuto.
L’idea di pulizia è presente in tutte le culture, è il contenuto che varia a seconda dei
contesti socio-culturali. Se nella vita dei villaggi il rifiuto era un elemento integrato
nel modo di vita e anche disciplinato da determinati dispositivi sociali, nella vita di
città, a causa delle dinamiche di accumulazione, l’immondizia diventa soltanto “una
cosa da allontanare e dimenticare”7.
Un’inchiesta del 2008 svolta da Ndyaye8 su un campione di oltre 150 intervistati
nella città di Dakar, mostra qual è la percezione di “sporco” e “pulito”.
6
Ivi, p. 358
Cfr., L. Pinna, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, Bollati
Boringhieri, Totino, 2011
8
M. Ndyaye, La gestion des ordures a Dakar: étude du cadre global d’un systeme, de la nature et
place des acteurs intervenant dans le foncionemment du service, Universitè Gaston Berger de Saint
Louis, UFR des lettres et sciences humaines, section de sociologie, 2008, p. 71, (traduz. mia)
7
28 Il 20% ritiene sia una questione di benessere personale. Oltre il 40% ritiene riguardi
più generalmente il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Meno del 20% ritiene sia
legato alla sanità e, infine, solo quattro persone credono sia una “questione
culturale”.
Un lavoratore impiegato nella nettezza urbana, intervistato da Ndyaye sostiene che
“così come la povertà aumenta, aumenta anche lo sporco; la corsa sfrenata
alla spesa quotidiana non lascia più tempo ai poveri, sempre più numerosi, di
distinguere lo sporco dal pulito o la buona qualità da quella cattiva. Bisogna
avere mezzi e tempi per lottare contro l’insalubrità. Per combatterla davvero
bisogna agire sulla povertà”9 .
Sotto un certo livello di vita, la preoccupazione dell’individuo diviene
essenzialmente una questione politica: la sopravvivenza.
9
Ibidem
29 1.1 PUREZZA E CONTROLLO
La prova dell’esistenza di una specifica mentalità pre-moderna va desunta dal
diverso atteggiamento nei confronti della cattiva sorte. L’uomo moderno, secondo
questa tesi, segue una linea di ragionamento che risale dagli effetti alle cause
materiali, mentre i primitivi seguono un percorso che conduce dall’evento negativo
ad esseri spirituali.
Sostenere esplicitamente che il pensiero primitivo è in sé diverso, ci fa rimanere
legati a questa posizione, fino a che almeno non si riesca a dimostrare che le
utilizzazioni politiche dei pericoli naturali, rappresentano una consuetudine che noi
moderni condividiamo con i primitivi.
“Se l’origine delle usanze dell’uomo primitivo non deve essere ricercata nei
processi razionali, l’origine di certi processi razionali deve essere cercata
nelle usanze”10.
A tale proposito, Marshall Sahlins, sostiene che è il “significato”, nella fattispecie la
ricostruzione sociale della relazione tra pericolo e impurità, la proprietà specifica
dell’oggetto antropologico, in quanto la cultura è un ordine “significante” di persone
e di cose che l’antropologia deve portare a evidenza. La tradizione in oggetto è,
quindi, un insieme di significati accumulati, una sorta di “teoria collettiva e storica
che fa della percezione un concetto”11.
In “Purezza e pericolo”, Mary Douglas rivendica l’esistenza di un
comportamento razionale nei primitivi, scoprendo che i tabù non sono indecifrabili,
ma rivelano la comprensibile preoccupazione di proteggere la società da
comportamenti che potrebbero distruggerla. I primitivi affrontano politicamente il
pericolo per salvaguardare il loro patto costitutivo, mentre noi abbiamo sganciato il
pericolo dalla politica e dall’ideologia, e lo affrontiamo alla luce della scienza12 .
10
M. Sahlins, Cultura e utilità, Anabasi, Milano1994, p. 86
Ivi, p. 79
12
Cfr., M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Il Mulino,
Bologna, 2006
11
30 Il tema dell’opera della Douglas è che in ogni luogo e in ogni tempo, l’universo
viene interpretato in termini di etica e di politica. Ad esempio, ai disastri che
inquinano l’aria e la terra e avvelenano le acque, vengono generalmente attribuite
valenze politiche.
L’autrice pone a titolo esemplificativo il caso di una donna che muore; le persone
colpite dal lutto si chiedono “Perché è morta?”. Per ogni disgrazia esiste un
repertorio fisso di cause possibili, fra le quali viene scelta una spiegazione plausibile,
e un repertorio fisso di azioni che seguono obbligatoriamente la scelta.
Le comunità tendono ad essere organizzate secondo l’una o l’altra forma di
spiegazione che prevale. Un tipo di spiegazione moralistico tende a sottolineare che
la donna è morta perché ha offeso gli antenati, perché ha infranto un tabù, perché ha
peccato. L’azione conseguente a una spiegazione di questo tipo è l’espiazione, cui
corrisponde la purificazione attraverso il rito. Per evitare una sorte simile a quella
della donna morta, la comunità viene esortata a obbedire le leggi:
“Nessuna società è perfetta. Ognuna include per natura una impurità
incompatibile con le norme che proclama e che si traduce concretamente in
una certa dose di ingiustizia, d’insensibilità, di crudeltà”13.
Un modo alternativo di spiegare la cattiva sorte è attribuirla all’opera di singoli
avversari: per sopravvivere si deve essere più scaltri dei propri rivali. Le persone che
hanno ucciso la donna, non vengono affatto biasimate quando vengono scoperte,
perché anche se le morti vengono politicizzate, non destano alcuna preoccupazione
di carattere morale: ci si aspetta che tutti si comportino allo stesso modo.
In breve,
“maggiore è la solidarietà di una comunità, più prontamente i disastri naturali
verranno codificati come segni di un comportamento colpevole. Ogni morte e
gran parte delle malattie daranno l’opportunità di attribuire una colpa. Il
pericolo viene definito in modo tale da proteggere il bene pubblico, mentre
l’incidenza della colpa è un sottoprodotto di meccanismi atti a persuadere i
13
C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano, 2008, p. 331
31 membri del gruppo a contribuire al mantenimento del bene pubblico. La
contaminazione, vista da questa prospettiva, è una potente risorsa giudiziaria.
Non c’è niente che possa stare al pari con essa per convincere i membri della
comunità dei loro doveri. Un pericolo comune dà loro un pretesto, la minaccia
di una contaminazione per l’intera comunità costituisce un’arma per la
coercizione reciproca” 14.
Nell’opera “Donne granai e capitali”, Claude Meillassoux, sviluppando una critica
sulle interpretazioni classiche circa la proibizione dell’incesto, propone anch’ esso
una lettura che pone il rapporto puro/impuro come mezzo ideologico con cui si
ordina ai membri delle piccole comunità, continuamente minacciate nel loro
equilibrio interno, di reperire un partner esterno alla loro comunità d’origine
(esogamia) 15.
Proibizione dell’incesto e regole esogamiche, sono mezzi che consentono alle
comunità piccole di far fronte agli accidenti demografici cui sono soggette, e di
riprodurre le condizioni strutturali della produzione materiale e della riproduzione
sociale.
“Esso [il potere] non ha altro mezzo, per mantenersi, che quello consistente
nella produzione e nello sviluppo di un’ideologia coercitiva dell’autorità. La
religione, la malattia, i riti, il terrorismo della superstizione inflitto ai
sottoposti, ai giovani e soprattutto alle donne, vengono così a svilupparsi; i
divieti sessuali e i castighi che seguono la violazione di essi si moltiplicano e
vengono ad assumere un carattere assoluto.”16.
L’ideologia coercitiva dell’autorità di cui parla Meillassoux, per Marc Augè si
esprime attraverso gli oggetti. Le società, per istituire il potere politico o la religione,
hanno avuto bisogno degli oggetti, non solo perché essi servono a marcare e a
limitare, ma soprattutto perché la loro stessa materia è problematica: essa “si pensa si
14
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p.10
Cfr., C. Meillassoux, Donne, granai e capitali. Uno studio antropologico dell’imperialismo
contemporaneo, Zanichelli, Bologna, 1983
16
Ivi, p. 56
15
32 al limite del pensato e dell’impensato, del pensabile e dell’impensabile. Proprio
come il potere”.
L’oggetto-materia si offre in due modi: al simbolico come segno di riconoscimento,
al feticismo come un essere irriducibile. “Tra l’oggetto simbolo e l’oggetto feticcio si
crea una tensione analoga a quella che unisce e oppone pensiero dell’essere e
pensiero della cosa”.
Il punto centrale dell’oggetto è l’inerte, la materia bruta. L’impensabile e la
potenza sono dalla parte dell’inerzia bruta, della pura materialità. Se il naturale è
dunque la vita, il soprannaturale è dalla parte dell’inerte.
Da questo punto di vista sono molto importanti le rappresentazioni dei feticci
africani, tutte vicine alla materia bruta17.
“La provocazione della materia si dissolve e si risolve nell’evidenza dell’altro” 18. E’
la conclusione cui giunge Augè dopo aver dimostrato che, se non c’è simbolo che
non sia caricato di materialità e quindi dotato di un’esistenza propria, allora non c’è
neppure feticcio che non sia dotato di vita, cioè di un certo potere di relazione.
Per spiegare la differenza fra l’atteggiamento dei primitivi verso la
contaminazione e il nostro, fra la nostra civiltà e la loro, la nozione dominante era
quella secondo la quale i progressi occidentali nel campo della conoscenza, avevano
dissolto un legame che un tempo collegava ovunque morale e pericolo: per noi la
morale viene semplicemente sanzionata con la persuasione, mentre il pericolo viene
controllato dalla tecnologia; la precedente mancanza di tecnologia faceva sì che la
colpa venisse scagliata in ogni direzione.
Tuttavia, nell’epoca contemporanea, il progresso tecnologico ha superato certi limiti
(si pensi alla bomba atomica), per cui la stessa tecnologia si è trovata attaccata in
quanto fonte di pericolo.
“E’ diventato evidente che l’antico legame fra pericolo e morale non derivava dalla
scarsa conoscenza. La conoscenza è sempre scarsa. L’ambiguità è sempre in
agguato”19.
17
M. Augè, Il dio oggetto, Meltemi, Roma, 2002, p. 28
Ivi, p. 133
19
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p. 15
18
33 Da una parte si criticava, ad esempio, l’industria (incurante dei danni arrecati),
dall’altra, economisti ed esperti di probabilità divulgavano i loro calcoli sul rischio,
al fine di placare la collera generale e dimostrare che l’opinione pubblica stava
esagerando e non comprendeva quali rischi si correvano quotidianamente facendo
semplici azioni domestiche o di routine. “Il rischio divenne un settore accademico in
espansione”20.
Alla base di questa recente necessità di quesiti morali rispetto al pericolo
tecnologico, la Douglas si chiede se il comportamento contaminante sia davvero
diverso nella società tribale.
Queste opinioni sulla purezza e il pericolo, nell’era moderna sono state duramente
contestate, come conseguenza della preoccupazione di uscire dal paradigma
dominante della scelta razionale individuale. “Il pubblico” non vede certamente i
rischi allo stesso modo in cui li vedono gli esperti.
“Il divario tra l’opinione dei profani e quella degli esperti ha creato un
sottosettore completamente nuovo della psicologia del rischio, una nuova
branca di specializzati per l’educazione degli adulti, una nuova sottodisciplina
per far conoscere i rischi ed etichettarli e un’industria vera e propria per
catalogarli”21.
L’antropologia ha spesso interpretato i pericoli fisici, i pericoli per i bambini e quelli
per la natura, come armi da usare nella lotta per il dominio ideologico: da questo
presupposto parte l’analisi critica di Michel Foucault sul ”discorso”22 che impone la
sua disciplina al corpo. “Sarebbe stranamente ingenuo oggi immaginare una società
nella quale il discorso sul rischio non sia politicizzato”23.
20
Ivi, p. 13
Ivi, p. 18
22
L’analisi del discorso di Foucault intende mostrare l’ordine e la funzione che presiede alla
produzione dei discorsi, degli oggetti che questi suscitano, delle posizioni soggettive che vi si trovano
implicate. Ma soprattutto intende liberare la possibilità del discorso da tutte le istanze di controllo e di
potere che lo orientano e regolano. l’analisi del discorso non si occupa solo dei testi canonici, il cui
oggetto è esplicitamente tematizzato da un autore e acquisito nell’ambito di un sapere riconosciuto,
ma anche e soprattutto di documenti legali, repertori di casi, tabelle statistiche, regolamenti
istituzionali.
23
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p. 20
21
34 Il senso politico di tale rischio fa fulcro sulla paura e sulla confusione tra
contaminazione ed igiene:
“Il secolo Decimo Nono intravide nelle religioni primitive due caratteristiche
che le separavano in blocco dalle grandi religioni di questa terra. La prima
consisteva nel fatto che esse erano ispirate dalla paura; l’altra che erano
inestricabilmente confuse con la contaminazione e l’igiene. Riflettere sullo
sporco comporta la riflessione sul rapporto tra l’ordine e il disordine, l’essere
e il non essere, il formale e l’informale, la vita e la morte” 24.
Se le pratiche occidentali sono solidamente ancorate all’igiene, quelle “tradizionali”
sono simboliche: “noi uccidiamo i germi, i primitivi tengono lontani gli spiriti”25.
Secondo la Douglas, questa contrapposizione mostra come tra alcuni riti “primitivi”
simbolici e la nostra igiene si riscontra una somiglianza che spesso è stranamente
stretta.
L’amore per la pulizia e il rispetto per le convenzioni, sono i due elementi di cui si
compone la nostra idea di sporco. Naturalmente le norme igieniche cambiano col
mutare dello stato delle nostre conoscenze. Nelle nostre regole di pulizia non vi è
nulla che suggerisca una qualche relazione tra la sporcizia e il sacro.
“La santità e l’impurità sono così diametralmente opposte che ci sarebbe più facile
confondere la fame con la sazietà ed il sonno con la veglia26”. Eppure si ritiene che
una caratteristica della religione primitiva, sia la mancanza di una netta distinzione
tra santità e impurità.
Lo sporco è innanzitutto disordine. Non esiste qualcosa come lo sporco in assoluto:
esso prende vita nell’ottica di chi l’osserva. Poiché esso è incompatibile con l’ordine,
la sua eliminazione non è un atto negativo, ma è
“uno sforzo messo in opera per organizzare l’ambiente. Nel dare la caccia allo
sporco, tappezzare di carta, decorare, rassettare, non siamo spinti dalla paura
24
Ivi, p. 31
Ivi, p. 40
26
Ivi, p. 44
25
35 delle malattie, ma cerchiamo di riordinare in maniera positiva il nostri
ambiente, adattandolo ad un’idea. In questo nostro evitare lo sporco non c’è
paura o irrazionalità: c’è un’azione creativa, uno sforzo messo in opera per
adeguare la forma alla funzione, per unificare l’esperienza”27.
Se questo è valido per il nostro concetto di purificare, alla stessa luce dovremmo
interpretare la purificazione dei primitivi in cui le credenze nella contaminazione si
possono usare in un dibattito di rivendicazioni e di contro-rivendicazioni di una
posizione sociale. Tuttavia rispetto alle credenze nella contaminazione, notiamo che
il tipo di contatti che ritenuti dannosi, riveste anche un peso simbolico.
Alcune contaminazioni vengono usate come delle analogie per esprimere un
punto di vista generale sull’ordine sociale, di maniera che la “contaminazione di
genere”, ad esempio, rispecchia una data gerarchia sociale cui è legata la
contaminazione dei sessi. Ciò che vale anche per la contaminazione corporea.
“I due sessi possono servire come modello di collaborazione e di distinzione tra
le unità sociali. In questo modo anche i processi di ingestione
rispecchierebbero l’assorbimento politico”28.
Secondo Pierre Bourdieu, il sistema mitico-rituale svolge un ruolo equivalente a
quello assunto dal campo giuridico nelle società differenziate (stratificate). Il corpo
“socializzato”, i suoi movimenti ed i suoi spostamenti sono immediatamente investiti
di uno specifico significato sociale. La divisione delle cose e delle attività, tra
maschile e femminile, “raggiunge la sua necessità oggettiva e soggettiva inserendosi
in un sistema di opposizioni omologhe: alto-basso, sopra-sotto, davanti-indietro […]
secco-umido, duro-molle, chiaro-scuro, fuori (pubblico)-dentro (privato)”29 .
Le idee di separazione, purificazione, demarcazione, e punizione delle trasgressioni,
svolgono come funzione principale quella di sistematizzare un’esperienza di per sé
disordinata. E’ solamente esagerando la differenza tra unito e separato, sopra e sotto,
27
Ivi, p. 32
Ivi, p. 34
29
P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 15-16
28
36 maschio e femmina, con e contro, immissione/evacuazione, che si crea l’apparenza
dell’ordine. Allo stesso modo gli orifizi corporei sembrano rappresentare punti di
entrata o di uscita per le unità sociali.
Lo studio comparato delle religioni, sostiene la Douglas, è sempre stato inquinato da
quello che definisce “materialismo medico”. Secondo alcuni, tutti i riti antichi, anche
i più esotici, si fondano essenzialmente sull’igiene (basta conoscere tutte le
circostanze per giustificare la base razionale del primitivo); altri invece, pur essendo
d’accordo sul fatto che i rituali primitivi perseguono come loro oggetto l’igiene,
hanno opinioni divergenti a proposito della validità di quest’ultima: per costoro
infatti c’è un enorme abisso tra le nostre fondate concezioni igieniche e le erronee
fantasie del primitivo.
“Prima di incominciare a pensare alla contaminazione rituale ci conviene
vestire il saio e coprirci di cenere e riesaminare scrupolosamente i nostri
concetti di sporco: scomponendoli nelle loro parti dovremmo distinguere
ciascun elemento che riconosciamo come conseguenza della nostra storia
recente”30.
Vi sono due notevoli differenze tra le idee contemporanee occidentali di
contaminazione e quelle delle culture primitive. La prima è che per noi evitare lo
sporco è una questione di igiene o di estetica che non ha alcun rapporto con la nostra
religione. La seconda differenza è che la nostra concezione dello sporco è dominata
dalla conoscenza degli organismi patogeni.
La trasmissione delle malattie per via batterica fu infatti una grande scoperta
del XIX secolo. Essa provocò la rivoluzione più radicale nella storia della medicina;
ed ha trasformato a tal punto la nostra vita, che è difficile pensare allo sporco fuori
del contesto della patogenicità. Tuttavia le nostre idee di sporco non sono così
recenti: dovremmo riuscire a tornare indietro col pensiero di almeno cento anni
(prima di Pasteur) e analizzare le basi della paura dello sporco, prima che questa
fosse stata trasformata dalla batteriologia.
30
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p. 76
37 “Se potessimo astrarre la patogenicità e l’igiene dalla nostra nozione di
sporco, ci resterebbe la nostra vecchia definizione di sporcizia come di un
qualcosa fuori posto – una interpretazione molto suggestiva che implica due
condizioni: una serie di relazioni ordinate ed un neo-contravvenzione a
quest’ordine. Ma lo sporco non è mai un evento unico, isolato. Dove c’è lo
sporco c’è il sistema. Lo sporco è il sottoprodotto di una ordinazione e di una
classificazione sistematica delle cose, così come l’ordine comprende il rifiuto
di elementi estranei”31.
Questa idea dello sporco conduce direttamente nel campo del simbolismo ed anticipa
un collegamento con più ovvi sistemi simbolici di purezza.
“Può esistere della gente che confonde il sacro con l’impurità?”32.
La Douglas risponde a tale quesito, ponendo l’accento su come l’idea di influenza
per contatto sia attiva nella religione e nella società. Ma ciò non significa affermare
che il sacro sia impuro. Ogni cultura deve avere le proprie nozioni di sporcizia e di
contaminazione, quindi
“non ha alcun senso parlare di confuse mescolanze di sacro ed impuro, ma
resta valido il fatto che le religioni spesso considerano sacre cose molto
impure e respinte con orrore. Pertanto dobbiamo chiederci come mai lo
sporco, che di solito è distruttivo, talvolta divenga creativo”33.
Arrivando al tema dei rifiuti, la Douglas sostiene che l’atteggiamento che si assume
verso i rifiuti composti da “pezzi e frammenti” che sono stati respinti dall’uomo,
attraversa due stadi (all’interno di quello che l’autrice definisce “sistema distrutto e
ricostruito”): primo, tali rifiuti appaiono fuori posto, una minaccia per l’ordine e
perciò vengono considerati una causa di disturbo ed energicamente spazzati via.
In questo stadio essi possiedono una certa identità in quanto rigettati e misconosciuti
rispetto a ciò cui appartenevano (capelli, cibo o involucri). Questo è lo stadio in cui
sono pericolosi perché conservano ancora una semi-identità. Ma un lungo processo
31
Ivi, p. 77
Ivi, p. 245
33
Ivi, p. 246
32
38 di polverizzazione, di dissoluzione e di putrefazione, attende fatalmente tutte quelle
materie fisiche che sono state riconosciute come sporche e, alla fine, ogni identità
scompare, così come l’origine dei vari frammenti e dei vari pezzi: i rifiuti entrano
nella massa dell’immondizia generale.
Finché l’identità è assente, l’immondizia non è pericolosa; non si creano neppure
delle percezioni ambigue, perché essa appartiene chiaramente a un posto definito, un
cumulo di immondizie.
“La sporcizia si è creata grazie a processi mentali di differenziazione, come
sottoprodotto della creazione dell’ordine; è iniziata così da uno stadio di non
differenziazione è, attraverso tutto il processo di differenziazione, il suo ruolo è
stato quello di minacciare le distinzioni stabilite; alla fine essa ritorna al suo
vero carattere indiscriminabile”34.
In quanto categoria sensibile, l’opposizione puro/impuro beneficia di un relativismo
culturale che, attraverso il tema dell’igiene, si contrappone alla pretesa di
universalizzazione del discorso scientifico.
L’igiene è visto come un attributo di base della civiltà, a cui si oppongono le culture
indigene in particolare con le loro abitudini anti-igieniche. Il “discorso coloniale” è
infatti esplicito nel precisare le idee di isolamento e segregazione degli autoctoni.
Se consideriamo i rifiuti una questione culturale che riguarda sia l’ambiente che
l’igiene, possiamo fare riferimento alle analisi di Foucault sul potere disciplinare.
L’Igiene, come uno dei principi ordinatori di alcune tra le fondamentali istituzioni
della modernità (scuole, fabbriche, ospedali, ecc), si esplicita per mezzo di tecnologie
di regolazione della vita e di controllo biologico sulla popolazione. Un potere gestito
quindi da discipline
“creatrici di apparati di sapere e di domini molteplici di conoscenza (…) che
sosterranno un discorso che sarà quello della regola: ma non della regola
giuridica derivata dalla sovranità, bensì quello della regola naturale, cioè
34
Ivi, p. 247
39 della norma. Definiranno un codice che non sarà quello della legge, ma quello
della normalizzazione”35.
Con la società industriale, cioè, il binomio tra potere e sovranità è sostituito da quello
tra potere e disciplina. Si tratta quindi di un nuovo potere tecnologico, biopolitico,
incentrato sul controllo dei corpi, che può ritrovarsi appunto nelle scuole,
negli ospedali, nelle caserme, e via dicendo, in cui la sovranità del corpo sociale è
garantita dal potere disciplinare.
L’igiene dell’ambiente urbano, la salubrità delle costruzioni e degli spazi, la qualità
dell’aria e delle acque, sono le pratiche che rispondono ad un “imperativo della
salute”, considerato quale dovere della società, oltre che dovere di ciascuno.
Le strategie di sorveglianza sanitaria verso i pericoli epidemici, oscillano da un
modello di esclusione, di rigetto fuori dall’ambiente urbano (come nel caso del
riversamento di rifiuti fuori città, proprio in spazi già emarginati), a un modello di
inclusione.
“La disciplina opera in uno spazio vuoto, artificiale che bisogna costruire da
parte a parte. La sicurezza, invece, si baserà su alcuni dati materiali come
l’ubicazione, lo scolo delle acque, le isole, l’aria ecc. […]Al problema della
sanità è legata tutta una politica dello spazio urbano” 36.
Foucault pone la polizia come “condizione d’esistenza dell’urbanità”.
“Alcune città esistono perché c’è la polizia.[…] Nonostante tutti gli
spostamenti e le attenuazioni di senso che si sono verificate nel corso del XVIII
secolo, nel senso forte dei termini, esercitare la polizia ed urbanizzare sono la
stessa cosa”37.
35
M. Foucault, Bisogna difendere la società, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 56
M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, Corso al Collège de France. 1977-78, Feltrinelli,
Milano, 2004, pp. 235-236
37
Ivi, p. 243
36
40 In base a queste osservazioni possiamo notare che la “proibizione”, è un mezzo
necessario per costruire situazioni di ordine. Vi sono corpi “proibiti” e situazioni
particolari nelle quali un corpo è “proibito”, vale a dire sottratto al contatto perché
contaminante. E’ in questo ambito che si formano quei concetti di puro ed impuro e
di contaminazione.
La parte più consistente delle proibizioni è rivolta all’universo delle donne. Il corpo
femminile, inteso in primo luogo come corpo sessuato, è caratterizzato dall’obbligo
di attenersi ad una serie di regole di purezza atte a controllarlo38.
Ciò che rende il corpo femminile impuro è la sua qualità di corpo aperto,
sanguinante, ma di un sangue speciale: il sangue mestruale.
Tra le varie deficienze che si pongono come segno distintivo dell’universo
femminile, quella relativa al sangue mestruale, un sangue “particolare”, deprivato,
guasto, ha molto valore. La perdita del sangue mestruale renderebbe il corpo della
donna freddo, poiché il sangue e sinonimo di vita e quindi anche di calore umano.
Le vie di entrata ed uscita del corpo si pongono come punti di esposizione alle
contaminazioni, di conseguenza tutto ciò che viene emesso dal corpo è impuro
poiché ha oltrepassato i confini corporali.
Le prescrizioni adottate, si presentano come semplici regole igieniche ma, ad un
livello più profondo, esse rappresentano l’istituzione che definisce ciò che si può
accettare e ciò che è inaccettabile, manifestandosi nella forma di un ordinamento
morale collettivo. Per questo le donne, vengono escluse dalla vita comunitaria e
isolate per il periodo di durata del flusso39.
Ciò che a noi qui interessa è il fatto che tale norma igienica, che riguarda
quindi la gestione di rifiuti organici e corporali, non ha una base meramente
razionalistica o sanitario-igienica, ma appartiene ad un ordine morale complesso.
38
39
Cfr., O. Cissè, L’argent des dèchets, Karthala-Crepos, Dakar, 2007
Cfr., M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit.
41 Come nota Gilles Bibeau nella prefazione allo studio di Caprara sugli Alladian della
Costa d’Avorio40,
“si è cercato di modificare i loro modi di pensare, e non si è esitato ad imporre
loro, soprattutto col pretesto di proteggerli dalle malattie infettive, le teorie
occidentali ereditate da Pasteur. Come si poteva in effetti convincere gli
africani a costruire latrine, si dicevano gli esperti di sanità, se non avevano
fatto proprio il concetto di contaminazione fecale? (…) Le campagne di sanità
pubblica hanno quindi tentato di riformare le idee degli africani,
principalmente nel caso delle malattie infettive, e di rimodellarle nella
direzione delle teorie bio-mediche del contagio”41.
Caprara critica la separazione tra sapere e senso provocata dalla prima antropologia
medica e successivamente dalla sanità pubblica, poiché esse hanno separato
quell’unione tra pensiero empirico e pensiero analogico, tipico delle teorie africane
centrate sulle concezioni del corpo e della persona, dei rapporti sociali, della
dimensione naturale e di quella soprannaturale.
Quello che Didier Fassin definisce lo “spazio politico della sanità”, è marcato da una
rottura nella storia dei rapporti tra corpo sociale e corpo biologico. La sanità è una
costruzione culturale e merita di essere studiata come rappresentazione. Ma essa è
anche una ideologia di cui la società ne fa un uso crescente per la gestione delle
devianze. Fassin difende la tesi per cui nelle società tradizionali, le differenze di
statuto e di ricchezza non si traducono nei corpi, ma sui corpi, attraverso ferite,
mutilazioni e altre tracce. Prima la differenziazione delle condizioni e dei modi di
vita accresce le disparità socio-sanitarie operando un miglioramento selettivo dello
stato della sanità. In seguito, l'intervento dello stato nel campo della sanità pubblica,
prepara una pacificazione dei corpi che traduce una ineguaglianza sociale più
civilizzata, meno selvaggia rispetto alla violenza fatta ai corpi dei lavoratori
40
Cfr., A. Caprara, Interpretare il contagio. Una indagine storico-etnografica sulle pratiche mediche
presso gli Alladian della Costa d’Avorio, Argo, Lecce, 2001
41
Ivi, p. 12
42 dell'Ottocento, ma un'ineguaglianza inscritta nei corpi come lo testimoniano le
importanti differenze sulle aspettative di vita.42.
Caprara ha invece privilegiato nel proprio lavoro i concetti di contaminazione, di
impurità e tabù così come sono stati rielaborati da Mary Douglas. Due sono le idee
principali: da una parte il fatto che certe persone, certi oggetti, certi luoghi, e certe
situazioni possano impregnarsi di una valenza negativa e divenire potenzialmente
pericolose; dall’altra il fatto che il contatto con queste sostanze provoca debilitazione
e malattia.
Presso gli Alladian, ad esempio,
“la malattia può essere trasmessa attraverso tutte le forme di rapporti umani,
e la regola che permette spesso di interpretare tale trasmissione si basa sulle
nozioni di purezza ed impurità. Il principio di opposizione tra queste due
nozioni si esprime, in modo esplicito, nelle concezioni del corpo e dei fluidi che
esso produce. Questi ultimi sono considerati sostanze impure per eccellenza
che diventano, come tali, importanti fonti di diffusione della malattia. Di fatto,
si può considerare che esse siano cariche di contenuti negativi ed una lunga
serie di regole è destinata a prevenire il contatto con le urine, la saliva ed il
sangue mestruale”43.
Ciò che è di interesse per la ricerca è il funzionamento del dispositivo sanitario e dei
movimenti di potere che esso dispone.
Certi poteri sono esercitati a favore della struttura sociale; proteggono la società da
chi fa del male ed è contro costoro che è diretto il pericolo rappresentato dai poteri
stessi.
Il corpo è una struttura complessa: le funzioni delle sue diverse parti e le relazioni tra
esse, forniscono una gamma di simboli per altre strutture complesse.
42
Cfr., D. Fassin, L'espace politique de la santé: Essai de généalogie, Presses Universitaires de
France, Parigi, 1996
43
A. Caprara, Interpretare il contagio. Una indagine storico-etnografica sulle pratiche mediche
presso gli Alladian della Costa d’Avorio, op. cit., p. 21
43 “Noi non possiamo interpretare rituali che riguardano gli escrementi, il latte
materno, la saliva e così via, se non siamo preparati a guardare al corpo come
ad un simbolo della società e a vedere i poteri e pericoli su cui si fonda la
struttura sociale riprodotta in miniatura nel corpo umano”44.
“C’è anche una tendenza dell’osservatore ad esagerare la misura in cui le
culture primitive fanno uso magico dei resti corporei. Per varie ragioni più
note agli psicologi, ogni riferimento alla magia che riguarda gli escrementi
sembra balzare all’occhio del lettore e assorbire la sua attenzione”45.
Gli orifizi del corpo simboleggiano i punti di speciale vulnerabilità del corpo. Il
materiale che essi emettono è sostanza marginale (come sputo, sangue, latte, urina,
feci, o lacrime), che ha attraversato i confini del corpo, uscendo semplicemente
all’esterno.
44
45
Ivi, p. 186
Ivi, p. 193
44 1.2 LA CITTA’ E I RIFIUTI
I primi rifiuti con cui l’uomo si è dovuto confrontare erano le scorie del metabolismo
corporeo e forse qualche immangiabile resto alimentare. Tali rifiuti non potevano
quindi accumularsi e diventare una fonte di inquinamento, anche in relazione al
carattere nomade delle prime popolazioni.
La sedentarietà, unita alla mancanza di igiene, sarà una delle prime cause strutturali
legate all’emergere dell’esigenza di gestione dei rifiuti.
Il primo modo di vita urbano ha portato con sé l’accumularsi dei rifiuti (parliamo
sempre di deiezioni umane e animali e di pochi resti di cucina, botteghe e mercato)
lasciati marcire dove capitava. La mancanza di sistemi idrici adeguati, le strade non
lastricate usate sistematicamente come latrine e come discariche, i cimiteri che
cominciavano ad accogliere molti defunti, il percolato che si infiltrava nelle falde e
inquinava l’acqua, erano tutti fattori che compromettevano la salute umana.
Il prelievo del surplus alimentare, è alla base della nascita delle città, che
devono essere rifornite di alimenti dalle campagne, non potendoli produrre nello
spazio urbano, occupato da edifici, strade e altre opere edilizie. L’urbanesimo
provoca quindi una concentrazione di produzione e consumi, quindi di rifiuti, che
caratterizzano quella che Lorenzo Pinna definisce “la città pestilenziale”. 46
L’espandersi del modello urbano in epoca moderna, ha portato gli stati a
regolamentare e “ordinare” la gestione dei rifiuti (già nel medioevo si moltiplicavano
le disposizioni volte a disciplinare il “lancio dei rifiuti”.) I protagonisti di questa
“guerra” alla città pestilenziale si chiamavano Joseph Bazalgette e Georges Eugene
Houssemann. Il primo costruì il sistema fognario di Londra, il secondo quello di
Parigi.
Furono le prime reti di fognature moderne che permisero di fermare le
epidemie e di bonificare le grandi città che la rivoluzione industriale aveva gonfiato a
dismisura.
La produzione di opere, conoscenze e disposizioni fu tale in questo periodo, che un
chimico tedesco, Justus Von Liebig, arrivò addirittura a formulare una teoria in base
alla quale l’incapacità di impiegare le deiezioni umane come fertilizzante, era la
46
L. Pinna, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, Bollati
Boringhieri, Torino, 2011, p. 20
45 causa dell’impoverimento dei suoli coltivati (soprattutto per la perdita del fosforo) e
del crollo di intere civiltà47.
Di qui la necessità di usare i resti organici come concime, per reintegrare i nutrienti
naturali sottratti con l’agricoltura (che era stata d’altronde la tecnica prevalente in
tutte le società tradizionali di sussistenza).
Il ciclo tra città e campagna innescato dall’impiego dei rifiuti come fertilizzanti, fu
radicalmente compromesso all’inizio del Novecento, quando il chimico tedesco Fritz
Haber, mise a punto il processo per la produzione industriale dell’ammoniaca, la
base, ancora oggi, dei fertilizzanti di sintesi e di molti esplosivi.
Con la città industriale la quantità di rifiuti è aumentata e si è concentrata, rendendo
più complesso lo smaltimento. Anche la quantità di rifiuti prodotta da ogni abitante è
cresciuta, perché nel frattempo è aumentato il benessere, sono cambiati sia gli stili di
vita sia i bisogni considerati irrinunciabili, e gli oggetti per soddisfarli si sono
moltiplicati. Tutti producono rifiuti sia nella fabbricazione, come scarti industriali,
sia nella fase di consumo.
Non sono soltanto l’aumento della popolazione, l’urbanizzazione e i nuovi stili di
vita a far crescere la quantità di rifiuti. Una catena di innovazione, soprattutto nel
campo della chimica, dette vita a una serie di nuovi materiali che per comodità
etichettiamo indistintamente con il nome plastica. Sono questi i materiali a basso
costo, più resistenti, e in certi casi più igienici dei loro tradizionali concorrenti
(legno, cuoio, ceramica e tessuti animali), che rendono possibile l’usa e getta e
moltiplicano all’infinito gli imballaggi.
Questa città industriale è per Baudrillard il regno della concorrenza, di “impulsi,
desideri, incontri, stimoli, verdetti incessanti degli altri, erotizzazione continua,
informazione, sollecitazione pubblicitaria”.
Coma la concorrenza industriale si manifesta in una produzione sempre accresciuta
di beni, così la concentrazione urbana risulta in un accrescimento illimitato di bisogni
artificiali:
47
Ibidem
46 “Più preziosa ancora, forse, la città si pone alla confluenza della natura con
l’artificio. Agglomerato di esseri che racchiudono la loro storia biologica
entro i suoi limiti e la modellano con tutte le loro intenzioni di creature
pensanti,
la
città,
per
la
sua
genesi
e
la
sua
forma,
risulta
contemporaneamente dalla procreazione biologica, dall’evoluzione organica e
dalla creazione estetica. Essa è, nello stesso tempo, oggetto di natura e
soggetto di cultura; individuo e gruppo; vissuta e sognata; cosa umana per
eccellenza”48.
1.2.1 La città del sottosviluppo
La nuova tendenza urbana del XXI secolo, è stata descritta da UN-Habitat49,
l’agenzia per gli insediamenti umani, che nel suo rapporto biennale sullo stato delle
città mondiali, ha individuato una tendenza urbana all’agglomerazione in megaregioni. Le mega-città mondiali si fondono a formare ampie “mega-regioni” estese
per centinaia di chilometri scavalcando confine. Il fenomeno della cosiddetta “città
infinita”50 potrebbe dimostrarsi uno dei principali sviluppi che condizionerà il modo
di abitare e vivere la vita metropolitana. Una tendenza che ha contribuito a un
passaggio storico, quello del passaggio della metà e oltre della popolazione ad un
modo di vita urbano.
Oggi vive nelle città poco più della metà della popolazione, ma nel 2050 sarà più del
70%. Questo vuol dire che sui 9-10 miliardi di abitanti previsti per quell’epoca, fra i
6 e 7 miliardi vivranno nelle città. Solo il 14% della popolazione dei paesi più ricchi
e il 33% nei più poveri, non sarà urbana.
48
C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano, 2008, p. 108
UN-Habitat, State of the World’s Cities 2008/2009. Harmonious cities, United Nations Human
Settlements Programme, Sterling VA, Londra, 2008
49
50
UN report, World´s biggest cities emerging into mega-regions, in The Guardian, Londra, 22 marzo
2010
47 La crescita di città e mega-regioni spinge anche a forme di sprawl51 senza precedenti,
nuovi slum, squilibri insediativi e di reddito con sempre più persone che si insediano
fra quartieri satellite o dormitorio. Lo sprawl si verifica sempre più spesso nei paesi
in via di sviluppo, infatti, nel giro di poco più di mezzo secolo decine di città in
Africa, Asia e America Latina si sono moltiplicate non per 4 o 6 volte, ma per 10, 20,
fino a 44 volte.
Mentre in Cina e in pochi altri paesi asiatici, questa crescita ricalca le orme delle
vecchie città industriali del capitalismo ottocentesco europeo, con un grande afflusso
di contadini dalle campagne richiamati dal lavoro delle manifatture, in altri
continenti le cose vanno diversamente.
Quello che avviene in Africa, in America Latina, ma anche nel Sud dell’Asia, è
spesso una urbanizzazione senza industrializzazione. Il risultato di queste colossali
migrazioni sono gli slum, le baraccopoli che crescono a dismisura intorno alle città,
sui terreni più inospitali e inquinati, vicino alle discariche, alle ferrovie, nelle zone
industriali, persino nei cimiteri abbandonati o sui marciapiedi, e senza acqua potabile
o servizi igienici. Vi sono casi limite come Kinshasa, in Congo, passata in50 anni da
200 mila a quasi 10 milioni di abitanti senza una rete di fognature.
Altra tendenza rilevante è il popolamento nelle zone costiere: più del 60% della
popolazione mondiale è concentrata a meno di venti chilometri dalla costa Tra il
1950 ed il 1995 la popolazione dell’Africa Atlantica è passata da 10 milioni ad oltre
100 milioni di persone. In Senegal, ad esempio, su 700 chilometri di costa si
concentra circa la metà della popolazione (più dell’80 % a meno di 100 km dal
mare)52. Secondo Sarr53 oltre il 30% della popolazione del Senegal abita nella
regione di Dakar, sul mare, con un tasso di crescita del 3,7% (Dakar contava nel
1920 oltre 35.000 abitanti, nel 2002 oltre due milioni).
51
Lo sprawl, o dispersione urbana, è un fenomeno di rapida e disordinata crescita di un'area
metropolitana, soprattutto nelle zone periferiche.
52
Cfr., J. Bavoux, Geographie humaine des littoroux marittime, Armand Colin, Parigi, 1998
53
Cfr., C. Sarr, Les ordures ménagères dans les villes senegalais, Enda, Dakar, 2005
48 Questi dati ci aiutano a meglio inquadrare il “paradosso africano” per cui il
continente meno urbanizzato al mondo ha allo stesso tempo uno tra i più alti tassi di
urbanizzazione.
Tale fenomeno è stato il più delle volte provocato dall’economia mondiale, con
l’aiuto delle istituzioni di Bretton Woods, che ha escluso dalle campagne milioni di
persone, ha distrutto il loro modo di vita ancestrale, soppresso i loro mezzi di
sussistenza, e causato “gli ammassamenti” nelle bidonville e nelle periferie del Terzo
Mondo.
“La globalizzazione ha trasformato ciò che resta di queste società in una sorta
di popolo delle bidonville: milioni di persone che vivono ai margini della
nostra società contemporanea e moderna, che vivono degli avanzi e degli
scarti della società dei consumi”54.
Il processo di sviluppo del capitale produce profitto mantenendo una rigida bipolarità
che si esprime da una parte con l’incentivo dei consumi in città, e dall’altra col
mantenimento della sussistenza nelle aree rurali. La conseguenza di questo rapporto
costante tra città e villaggio è che quest’ultimo subisce stimoli e modelli che
provengono dalla città. In città, il modo di vita moderno, un salario e la conseguente
possibilità di acquistare beni simbolo, diventano un miraggio e il sogno da realizzare.
Nelle città l’africano subisce un bombardamento ideologico che gli propone dei
modelli di comportamento che vengono recepiti più nella forma che nel contenuto55.
Nel celebre libro “I dannati della terra”, Franz Fanon apre il primo saggio con una
descrizione della città coloniale come città spaccata in due: le zone abitate dai coloni
e dai colonizzati sono in opposizione, obbediscono al principio di esclusione
reciproca:
“La città del colono è una città di cemento, tutta di pietra a ferro. E’ una città
asfaltata, illuminata, in cui i secchi della spazzatura traboccano sempre di
54
P. Palmeri, Lezioni di antropologia dello sviluppo – parte I. l’elisse delle società tradizionali nel
tempo della globalizzazione, Nuova Cultura, Padova, 2011, p. 94
55
Ivi, p. 138
49 avanzi sconosciuti, mai visti, nemmeno sognati. I piedi del colono non si
scorgono mai, tranne forse in mare, ma non si è mai abbastanza vicini. Piedi
protetti da calzature robuste mentre le strade della loro città sono linde, lisce,
senza buche, senza ciottoli. La città del colono è una città ben pasciuta, pigra,
il suo ventre è permanentemente pieno di cose buone.[…] La città del
colonizzato, o almeno la città indigena, il quartiere negro, la medina, la
riserva, è un luogo malfamato, popolato di uomini malfamati. Vi si nasce in
qualunque posto, in qualunque modo. Vi si muore in qualunque posto, di
qualunque cosa. E’ un mondo senza interstizi, gli uomini stanno gli uni sugli
altri, le capanne le une sulle altre. La città del colonizzato è una città
affamata, affamata di pane, di carne, di scarpe, di carbone e di luce. La città
del colonizzato è una città accovacciata, una città in ginocchio, una città
piegata su se stessa. E’ una città di sporchi negri, di luridi arabi. Lo sguardo
che il colonizzato getta sulla città del colono è uno sguardo di lussuria, uno
sguardo di bramosia. Sogni di possesso”56.
L’originalità del contesto coloniale è che le realtà economiche, le disuguaglianze,
l’enorme differenza del tenore di vita, non giungono mai ad occultare le realtà
umane.
Tuttavia l’impatto che il viaggiatore ha con la città sottosviluppata è ben descritta da
Levi-Strauss a proposito delle città dell’India:
“Più che città, […] sono zone abitate; ciò che consideriamo una lebbra,
costituisce qui il fatto urbano nella sua essenza: l’agglomerato di individui il
cui scopo è di agglomerarsi a milioni, prescindendo dalle condizioni reali.
Sporcizia, disordine, promiscuità, sfioramenti; rovine, capanne, fango,
immondizie; umori, stereo, urina, pus, secrezioni; tutto quello da cui la vita
urbana sembra difenderci, tutto ciò che noi odiamo […], tutti quei prodotti
della coabitazione, qui non diventano mai un ostacolo al suo sviluppo. […] Per
ogni individuo la strada, vicolo o sentiero, è il luogo dove siede, o dorme, o
raccoglie il suo nutrimento nella vischiosa sporcizia. Lungi dal respingerlo,
56
F. Fanon, I dannati della terra, op. cit., pp. 6-7
50 essa assurge a dignità domestica, per tutto il sudore, le sozzure, i movimenti e
le azioni che essa riassume”57.
Una delle problematiche centrali nei processi di urbanizzazione, riguarda la viabilità
urbana, che è sempre successiva allo stanziamento delle popolazioni. La città si
sviluppa quindi in maniera caotica a causa dell’incapacità delle amministrazioni di
prevedere i movimenti di popolazione.
Questa dinamica ha riguardato, ed in una certa misura continua a riguardare, gli spazi
urbani protagonisti della massiccia urbanizzazione dell’Ottocento. Anche la
metropoli occidentale non era preparata al fenomeno dell’urbanizzazione massiva, si
veda Londra, Parigi ed ancor più Roma che hanno distrutto decine di vicoli e
quartieri per creare un sistema di viabilità.
Le città del Terzo Mondo crescono senza piani urbanistici: le agglomerazioni urbane
nascono in zone di basso valore, inadatte alla costruzione, come le favelas di Rio de
Janeiro che crescono su pendii, o come Il Cairo che invade il più grande cimitero
della capitale, o certe barriadas di Lima che colonizzano le discariche.
In Africa la città è un vecchio luogo, ma non bisogna dimenticare che molte delle
grandi città di oggi (Abidjan, Lagos, Luanda, Dakar), sono state fondate per
rispondere al problema dell’ “estroversione del colonizzatore”.
Le città riassumevano la divisione del lavoro, nella misura in cui includevano
numerose organizzazioni specializzate, governative, religiose, scolastiche e
commerciali58. Le città erano la parte del composito tutto sociale dello stato
coloniale.
Oggi la città africana è il luogo delle attività culturali che, per la sociologia postcoloniale si pone come spazio di sradicamento e disfunzionamento in cui domina il
paradigma ruralista, considerato come l’ultima grande espressione dell’autoctonia
africana59.
57
Ivi, p. 117
Cfr., M. Leiris, L’occhio dell’etnografo. Razza e altri scritti 1929 – 1968, Bollati Boringhieri,
Torino, 2005
59
Cfr., J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit.
58
51 Lo shock coloniale è quindi l’elemento decisivo dell’urbanismo in Africa, a causa
della sovrapposizione tra due modelli contraddittori: il modello autoctono antico ed il
modello metropolitano coloniale. Il rapporto città-campagna è carico della tensione
che si crea tra l’onnipresenza del riferimento al villaggio (in città) e l’ossessione
dell’immagine della città come serbatoio di speranze (per la campagna).
Ci sono degli “ancoraggi rurali” che sono spesso incompatibili con i bisogni
razionali del processo di urbanizzazione. E’ proprio il caso dello smaltimento dei
rifiuti in città: l’abitudine, di chi è cresciuto nei villaggi, a bruciare periodicamente
quei pochi rifiuti organici prodotti da utilizzare poi come fertilizzanti, in città diventa
una pratica malsana poiché all’interno dei cumuli di rifiuti si trova plastica (sacchetti
prevalentemente) in quantità importanti.
L’impronta igienista che il colonialismo ha dato alla città africana si è
sviluppata in base ad un principio di “segregazione spaziale”. Il termine spazio,
quando è usato nelle analisi sulle disuguaglianze sociali, e ancor più nell’ambito
della sociologia urbana,
fa riferimento alle caratteristiche fisiche e sociali dei
contesti territoriali nei quali gli individui e i gruppi vivono e sui quali,
eventualmente, si muovono. Questi contesti e le loro caratteristiche sono rilevanti
perché influiscono sulle condizioni di vita e sui destini sociali delle persone. In
questo senso la segregazione spaziale imposta dall’igienismo coloniale si manifesta
anche in una gestione dei rifiuti discriminante. Invece di operare una rottura totale
con la concezione igienista marcata dalla segregazione spaziale e sociale, le autorità
pubbliche svilupparono degli interventi che accentuarono le “ineguaglianze di
salubrità”60.
Più le città si fanno luoghi di diseguaglianza, maggiore è il rischio che gli squilibri
economici si traducano in tensione politica e sociale. C’è elevata probabilità di
disordine in questi contesti.
Bisogna di conseguenza porre attenzione alle relazioni tra città e aree rurali, non
focalizzandosi solo sul flusso di popolazioni verso le città, ma anche, ad esempio,
sulle forniture alimentari per le zone urbane. Ciò significa tentare di interpretare il
significato di quella conoscenza “portatile” nel momento in cui si separa
60
C. Sarr, Les ordures ménagères dans les villes senegalais, op. cit., p. 18, (traduz. mia)
52 dall’ambiente sociale originario, ma anche quali sono gli effetti di ritorno nei
villaggi.
Il modello che interpreta la relazione urbano-rurale in termini di continuità, è di per
se stesso incarnazione concreta del cambiamento. Infatti le condizioni delle aree
rurali cambiano di pari passo con la crescita della città.
Ciò ha favorito un’analisi diacronica approfondita delle reti sociali e delle
transizioni, come oggetti di conoscenza molto differenti dalla cultura integrale
descritta dal modello tribale (che pone le norme sociali come centro direzionale del
comportamento individuale).
L’analisi delle transizioni prodotte dal sistema delle reti, dava così al sistema sociale
e culturale dell’ Africa urbana, una dimensione temporale, sino ad allora del tutto
assente dalla narrazione incantata e romantica, propria delle società “altre”.
Karl Polany sostiene che lo sconvolgimento sociale causato dalla macchina e le
circostanze nelle quali l’uomo si trovava ora a doverla servire, avevano avuto delle
conseguenze inevitabili come, ad esempio, la “desertificazione culturale delle prime
città industriali dell’Inghilterra”, a cavallo tra Settecento e Ottocento61.
Gli slums riflettevano la mancanza di tradizione (urbana) e di autorispetto civico.
Polany riconosce nella nascita delle città industriali, e nella conseguente necessità
illimitata di alimenti e materie prime, l’elemento più potente del capitalismo
industriale. “La miseria era la natura che sopravviveva nella società, la sua sanzione
fisica era la fame”62.
La condizione di molte tribù indigene dell’Africa, era per Polany paragonabile quindi
con quella delle classi lavoratrici inglesi all’inizio dell’Ottocento. L’indigeno veniva
“trasformato in una specie umana di animale mezzo addomesticato vestito di stracci
brutti, disordinati e sporchi, che neanche il più degenerato tra gli uomini bianchi
61
Cfr., K. Polany, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974
K. Polany, La grande trasformazione, op. cit., p. 128
62
53 indosserebbe, un essere indescrivibile senza rispetto di sé o valori, un vero rifiuto
umano”63.
La causa di tale degradazione era il vuoto culturale in cui veniva sbattuta l’esistenza
dei colonizzati. Un vuoto in cui si annulla l’arte, la politica, ecc. Tale vuoto, a detta
degli economisti, dovrebbe essere riempito dall’economia ma, lo sradicamento di
popolazioni
dalle
loro
tradizioni
per
mezzo
di
cambiamenti
introdotti
prepotentemente dall’esterno, non può ricostituire rapporti immateriali.
La gestione dei rifiuti, in questo senso trova delle resistenze culturali, causate proprio
da tale vuoto culturale. Anche la nostra società protoindustriale ha dovuto affrontare
il problema dei rifiuti. “Nonostante le numerose divergenze, vi sono al fondo le stesse
situazioni tra i popoli esotici di oggi di quelle che esistevano tra noi decenni o secoli
fa”64.
I nuovi modelli di vita hanno creato nelle società nere una catastrofe culturale che è
strettamente analoga a quella di gran parte della società occidentale dei primi tempi
del capitalismo. Inoltre lo sfruttamento perpetrato dei popoli colonizzati e
l’imposizione esterna di modelli di sviluppo, ha aggravato ancor più tali problemi.
Per concludere, un approccio all’analisi dell’urbanizzazione solo in termini di
disfunzionamento e di crisi non mette in evidenza il fatto che le popolazioni delle
città africane non sono rimaste passive di fronte alle condizioni di vita sempre più
difficili. Esse hanno imparato ad “arrangiarsi”.
63
64
K. Polany, Economie primitive, arcaiche e moderne, Einaudi, Torino, 1980, p. 46
Ivi, p. 48
54 1.3 IL MODO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: RICICLO e RIUSO
Il primo sistema di smaltimento dei rifiuti organici, dopo averli abbandonati fuori
dall’abitazione, è stato molto probabilmente l’utilizzo di animali (generalmente
maiali), come l’economia contadina insegna ancora oggi.
Si arrivò a comprendere che lo sterco prodotto dagli animali da allevamento e dal
bestiame, poteva essere sparso sul terreno per concimarlo, mentre i cocci potevano
servire da riempimento nella costruzione. L’urbanizzazione fece infatti nascere e
sviluppare l’attività manifatturiera che, nell’economia dei materiali, ha introdotto
nuove categorie di rifiuti inorganici di difficile smaltimento.
E’importante sottolineare la differenza semantica tra alcuni termini che
possono generare confusione: il recupero consiste nel modificare, per migliorarlo, lo
stato fisico di un rifiuto; il reimpiego è l’uso di un materiale o di un prodotto scartato
in condizioni quasi identiche e, infine, il riciclo è una trasformazione del rifiuto in
vista del suo reinserimento in un nuovo ciclo di produzione.
Il concetto di valorizzazione consiste nell’estrazione di materia o energia, quindi
rinvia ad ottenere un guadagno economico, pratico, tecnico o simbolico, perciò,
riciclo, reimpiego e tutte le altre azioni volte ad ottenere dei materiali o energia a
partire dai rifiuti, saranno delle forme di valorizzazione. L’attribuzione di un
carattere positivo ai rifiuti, è una tradizione molto antica.
Se il soggetto dato della nostra analisi sono i rifiuti (e la loro necessaria gestione),
riciclo e riuso sono le attività culturali che essi creano. Ne risulta quindi una
contrapposizione tra le stesse: il primo è un processo attraverso il quale si mira al
recupero di materiali, con il duplice obiettivo di limitare la quantità di rifiuti e di
ottenere un risparmio di materia o di energia, reinserendo nei cicli produttivi i
materiali recuperati. I prodotti da riciclare provengono da materiali di pre-consumo
(scarti di lavorazione ecc.) e da materiali di post-consumo (rifiuti solidi urbani,
automobili in demolizione ecc.)65. Tuttavia per il riciclaggio è necessario utilizzare
nuova energia per la raccolta, il trasporto e la lavorazione dei materiali usati, e questo
aumenta il consumo di energia.
65
Treccani, Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1987
55 Con il termine “riuso” intendiamo invece il riutilizzo di oggetti o materiali per un uso
uguale o, più spesso, secondario rispetto al precedente, per lo più con l’idea di un
ulteriore sfruttamento delle possibilità residue.
La contrapposizione del termine riciclo con quello di riuso vuole evidenziare quindi
la dimensione preindustriale di quest’ultimo: l’opposizione utilizzata da Lévi-Strauss
tra natura e cultura, può essere qui utile per comprendere come il riuso sia un’azione
culturale svolta all’interno di un contesto naturale ed in armonia con esso (nelle città
africane la valorizzazione si limita ancora al reimpiego, al riuso, e soprattutto al
bricolage66), mentre il riciclo è una pratica che appartiene al sistema economicoproduttivo.
Secondo la nostra analisi il riciclo si presenta alla società industriale come
un’esigenza legata alla necessità di integrare elementi esogeni del sistema produttivo
nel contesto naturale, tramite una organizzazione artificiale.
Il riuso, caratterizzante le società tradizionali e di sussistenza, si colloca tuttavia in
una posizione di subordinazione-tensione rispetto alla modernità, caratterizzata
invece dalla produzione “schizofrenica” e dall’obsolescenza programmata.
In questo senso se riciclare significa reimpiegare i materiali per continuare a
sostenere i ritmi di consumo imposti dalla società industriale, riusare, nel senso
“tradizionale”, significa porre un freno naturale ai consumi (sfruttarne tutte le
funzionalità sino ad esaurimento), così come anche proposto dal pensiero della
decrescita.
Se il riuso richiama una circolarità naturale ed i relativi meccanismi di autoriproduzione, la non riutilizzabilità di taluni elementi della modernità penetrati nelle
società tradizionali, crea un fenomeno di disorientamento nel soggetto, provocato dal
carattere eteroclito di taluni materiali immessi nel modo di consumo, che non
rientrano nel ciclo naturale del riuso perché artificiali.
Per Jean Baudrillard il termine riciclaggio può ispirare qualche riflessione: “esso
evoca irresistibilmente il ciclo della moda: anche là ognuno deve essere sempre al
corrente e riciclarsi periodicamente. Se non lo fa, non è un vero cittadino della
società dei consumi”67.
66
O.Cissè, L’argent des déchets, Karthala-Crepos, Dakar, 2007, p. 123
J. Baudrillard, La società dei consumi, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 84
67
56 Braudillard si chiede se il riciclaggio delle conoscenze non nasconda la riconversione
accelerata e obbligata della moda, e non faccia entrare in gioco l’obsolescenza
programmata che il ciclo della produzione e della moda impone agli oggetti
materiali.
Se, quindi, da un lato il concetto di riciclo avalla l’iperconsumo (in base alla
giustificazione: “tanto poi si ricicla”), dall’altro esso si pone (riguardo alle
conoscenze) come il fenomeno della moda, cioè pone l’obbligo di riciclarsi
periodicamente, a causa di un’obsolescenza comandata, però questa volta di ordine
epistemologico.
Baudrillard estende infine questo concetto a fenomeni più vasti: la “riscoperta del
corpo” è un riciclaggio corporale, la riscoperta della natura è un riciclaggio della
natura. Ciò che viene a mancare è quindi la “presenza originale e specifica in
opposizione simbolica alla cultura”, sostituita da un modello di simulazione , “un
concentrato di segni di natura rimessi in circolazione”68.
La moderna nettezza urbana rappresenta un enorme e complesso sistema di gestione
dei rifiuti, messo in atto dai poteri pubblici occidentali. Dall’Inghilterra (del XVIII
secolo) tale sistema si diffuse in tutta Europa e, quindi, in Africa equatoriale ed
occidentale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
L’espandersi poi, negli ultimi 20 anni, di discorsi e buone intenzioni sullo sviluppo
sostenibile, ha fatto emergere la nuova posizione dell’ambientalismo nella lotta
contro l’inquinamento. Così la gestione dei rifiuti ha visto la logica delle prescrizioni
imposte dall’igiene pubblica, integrarsi con quella ambientalista: l’evacuazione dei
rifiuti risponde ad un’esigenza sia estetica che ambientale.
Se la società moderna gestisce i rifiuti in maniera disciplinare, le società
preindustriali non avevano altra scelta che essere accaniti riciclatori e non buttare via
niente. Basti pensare a chi del recupero di rifiuti ne faceva (e ne fa ancora oggi) una
attività di lavoro (Chiffonnier in Francia, Stracciaroli e Stercorari in Italia,
Boudiouman in Senegal, etc..).
68
Ibidem
57 L’avvento della rivoluzione industriale, in un primo momento aumentò a dismisura
la domanda dei materiali raccolti, per sostenere gli elevatissimi ritmi di inurbamento,
tramite un rapporto virtuoso tra città e campagna.
La fine di questo idillio ottocentesco fra città, industria ed agricoltura, con il
riutilizzo dei rifiuti, è imputabile principalmente ai progressi conseguiti nel campo
chimico e sanitario (si pensi a come l’invenzione della celluloide compromise i
molteplici impieghi di ossa e di fosforo).
C’era innanzitutto la necessità di migliorare le condizioni igieniche: la chiusura dei
pozzi neri e il collegamento con le fogne, la diffusione dei wc, le ordinanze come
quella di Eugene Poubelle69, che proibivano di gettare le immondizie per strada e
imponevano di raccoglierle in speciali bidoni, erano tutti fattori che rendevano più
complicato il tradizionale modo di recuperare e differenziare i rifiuti, tuttavia non
impedendolo completamente70.
In una prima fase quindi il progresso tecnologico sfrutta le materie prime
urbane, tendendo a chiudere il ciclo biologico con il riutilizzo di molti tipi di rifiuto.
Ma in un secondo momento, quando la domanda di una società in rapida crescita
rende queste fonti di materie prime troppo limitate e aleatorie, altre invenzioni
portano alla ribalta nuovi processi industriali o nuove fonti di approvvigionamento
(ad esempio il fosforo dei giganteschi giacimenti in Nord Africa invece che quello
tratto dalle ossa, l’azoto dell’atmosfera invece di quello nascosto nei liquami grazie
alla sintesi dell’ammoniaca etc.).
Naturalmente in questo modo, il ciclo biologico non si chiude più, e le materie prime
urbane diventano automaticamente rifiuti da allontanare e di cui disfarsi. Questa
trasformazione, avvenuta verso la fine dell’Ottocento, è stata definita “l’invenzione
dei rifiuti urbani”71.
Oggi l’economia deve tenere conto delle leggi biologiche ed energetiche, in
particolare di alcune leggi basilari della termodinamica. “Il primo principio della
termodinamica è noto nella forma sintetica – in natura nulla si crea o distrugge, ma si
trasforma. Secondo Georgescu-Roegen, tre sono le categorie che compongono il
69
Prefetto della Senna (il cui nome è a tutt’oggi utilizzato in Francia per i bidoni della spazzatura) che
prese la decisione di migliorare l’igiene di Parigi, istituendo il sistema urbano di raccolta con bidoni.
70
L. Pinna, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, op. cit., p.
116
71
Ivi, pp. 118-119
58 prodotto di questo processo: calore altamente dissipato, materia altamente dissipata e
rifiuti. Mentre le prime due categorie non presentano alcuna utilità per l’uomo, “i
rifiuti possono ancora possedere qualche valore economico-energetico72”. Ed è
proprio su queste ipotesi che nuove proposizioni diventano leggi di tendenza di una
teoria del ri-ciclare, legata al più ampio “movimento per la decrescita”, oggi
estremamente attuale.
72
G. Bottazzi, Sociologia dello sviluppo, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 218
59 CAPITOLO II
PRODUZIONE, CONSUMO E BRICOLAGE
Premessa
Nella prima sezione del Libro III de Il Capitale, Karl Marx aveva contemplato il
recupero dei materiali derivanti dalla produzione capitalista, per modificare la
“composizione organica del capitale”, e quindi il valore d’uso, ritrasformando i rifiuti
della produzione in nuovi elementi di produzione.
Per Marx solo il riciclo degli scarti industriali permette a questi di “entrare per intero
nel processo di valorizzazione, pur facendo parte solo parzialmente del processo
lavorativo”.
Il rifiuto in sé, è infatti parte del sistema di produzione e non, invece, un'appendice
periferica, come spesso viene fatto intendere. Da qui ne segue che il trattamento dei
rifiuti deve essere analizzato come un processo produttivo (anche se questa perifrasi
può sembrare una contraddizione in termini).
Come osserva Georgescu-Roegen nell’elaborazione di una teoria bioeconomica,
l’economia capitalista esclude l’irreversibilità del tempo, e, ignorando l’entropia, non
fa rientrare i rifiuti e l’inquinamento nelle funzioni produttive, sebbene questi siano
prodotti dall’attività economica.
Il punto di partenza delle analisi di Georgescu, come di sopra accennato, è costituito
dai primi due principi della termodinamica: la prima legge riguarda la conservazione
dell’energia. Essa postula che, se l’energia non può essere né creata né distrutta, può
tuttavia essere trasformata da una forma all’altra.
Se si dovesse tener conto soltanto del primo principio della termodinamica,
non vi sarebbe alcun problema e si potrebbe usare energia in continuazione senza
mai esaurirla. Ma sappiamo, grazie al secondo principio, che ogni volta che l’energia
viene trasformata da uno stato in un altro “è necessario pagare un prezzo”. Questo
prezzo è rappresentato da una perdita della quantità di energia disponibile per
eseguire in futuro qualunque tipo di lavoro. Il termine che designa questo fatto è
“entropia”.
60 Si ottiene lavoro quando l’energia si trasferisce da un livello più alto di
concentrazione ad un livello più basso. Ma il fatto più importante è che, ogni
qualvolta l’energia si trasferisce da un livello all’altro, resta disponibile una minore
quantità di energia per eseguire lavoro in un’occasione successiva.
Un aumento di entropia, quindi, implica, una diminuzione di energia
disponibile. Ogni qualvolta accade qualcosa nel mondo naturale, una certa quantità di
energia si esaurisce e non è più disponibile per produrre lavoro. Questa energia non
disponibile è ciò che generalmente si chiama inquinamento, che non è soltanto
l’insieme dei sottoprodotti dei processi produttivi, ma la somma totale di tutta
l’energia disponibile nel mondo che è stata trasformata in energia non disponibile.
I rifiuti, quindi, sono un tipo particolare di energia dissipata. Poiché, in base al primo
principio, l’energia non può essere né creata né distrutta ma solo trasformata, e
poiché in base al secondo principio la si può solo trasformare in un senso,
l’inquinamento è in sostanza un altro nome dell’entropia: rappresenta cioè una
misura dell’energia non disponibile presente in un sistema1.
La produzione economica moderna richiede, per il suo funzionamento, una sorta di
“moto discendente irreversibile”. Ciò è vero perché i materiali, nel processo
industriale, possono solo passare da uno stato di risorsa a quello di rifiuto. I rifiuti
costituiscono quindi una sorta di materializzazione necessaria di un principio di
distruzione, insito nella produzione economica.
Tale aspetto, concettualizzato da Schumpeter con l’espressione “distruzione
creatrice”, consiste nel processo di innovazione e cambiamento continuo che
caratterizza l’economia capitalista. Un cambiamento alimentato soprattutto dal
progresso tecnologico-scientifico e organizzativo, che applicato alla produzione
industriale e alla distribuzione commerciale permette alle imprese migliori di
avvantaggiarsi sulla concorrenza trovando nuove fonti di materie prime, migliorando
i processi produttivi, inventando nuovi beni e nuovi mercati, mettendo a punto nuove
tecniche di vendita. In questo continuo cambiamento quello che era nuovo diventa
rapidamente maturo, poi obsoleto e infine sostituito2.
Tale fenomeno si è diffuso in tutti i settori produttivi della società tanto che
1
2
J. Rifkin, Entropia. Il che fare per salvare il mondo, op. cit., pp. 55-58
Ivi, p. 130
61 “è sorto il sospetto che il prodotto principale dell’economia, primo nel senso
filosofico del temine, siano effettivamente i rifiuti. Forse l’economia moderna è
essenzialmente una maniera di organizzare la realtà in maniera tale da
trasformare di fatto natura e persone in rifiuti”3.
Ivan Illich osserva che le cause di questi processi involutivi siano da ricercare
rispetto agli “strumenti esosomatici” (esosomatico significa fuori, “all’esterno del
corpo”)4. Tali strumenti sono la serie di utensili che l’uomo usa per catturare,
trasformare e sfruttare l’energia disponibile (o entropia negativa) mediante i suoi
sistemi.
L’uomo costruisce utensili e macchinari per ricavare energia dall’ambiente;
costruisce case per imprigionare il calore e conservare caldo il proprio corpo;
costruisce strade e ponti e realizza nuovi sistemi per viaggiare e facilitare il trasporto
dell’energia da un luogo all’altro, inventa lingue, usanze, istituzioni economiche e
governi per meglio organizzare il trattamento e la distribuzione dell’energia5.
Tutte queste attività esosomatiche rappresentano nell’insieme gran parte della cultura
umana.
Se dovessimo riassumere in poche categorie tutte le complesse attività che vengono
svolte in una cultura, i termini “trasformazione”, “scambio” e “scarto” di energia
sarebbero indubbiamente in cima all’elenco. L’uomo è sempre attivamente
impegnato in uno o più di questi processi.
L’energia è la base della cultura umana, così come è la base della vita. Quindi in ogni
società il potere è, in definitiva, posseduto da chiunque controlli gli strumenti
esosomatici che vengono usati per trasformare, scambiare e scartare energia.
“La divisione in classi, lo sfruttamento, il privilegio e la povertà sono tutte
condizioni determinate dal modo in cui viene fissato il diagramma do flusso
energetico della società. Chi controlla gli strumenti esosomatici controllo il
3
W. Sachs, Dizionario dello sviluppo, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2004, p. 232
Cfr., I. Illich, La convivialità, Mondadori, Milano, 1974
5
Cfr., J. Rifkin, Entropia. Il che fare per salvare il mondo, op. cit.
4
62 diagramma di flusso energetico e determina la modalità di suddivisione del
lavoro nella società” 6.
L’incredibile esplosione di vita urbana, ad esempio, si è verificata in conseguenza
diretta dello spostamento globale dell’ambiente energetico nel corso dei due secoli
passati, dalle campagne verso le città. Tale fenomeno (l’inurbamento) dipende
appunto da attività esosomatiche, la più importante delle quali è costituita dal
trasporto.
A tale proposito, una delle più eloquenti intuizioni di Marx sta nell’aver individuato
il momento del trasporto e della circolazione del prodotto, come il momento della
trasformazione del prodotto stesso in merce, cioè l’inversione del valore d’uso in
valore di scambio. La distanza spaziale coperta dal prodotto sulla sua via dal luogo
di produzione al mercato, causa la perdita di identità del prodotto, quindi la propria
presenza nello spazio7. Così il prodotto diventa merce, quindi oggetto di consumo,
quindi rifiuto. Questo è il presupposto per capire il fenomeno dell’alienazione nel
modo di produzione, quindi nel consumo.
6
7
Ivi, pp. 79-80
Cfr., W. Sachs, Dizionario dello sviluppo, op. cit.
63 2.1 PRODUZIONE E ALIENAZIONE
Affrontando la questione della gestione dei rifiuti, ci sembra importante accennare al
tema del consumo. Di questo prenderemo in considerazione due aspetti: da una parte
la sua appartenenza al modo di produzione, secondo l’analisi di Marx, e dall’altra la
sua componente “sovversiva”, il bricolage.
Le società occidentali contemporanee sono spesso state definite società del consumo
di massa, intendendo con questo che gran parte della vita dei loro membri ruota
intorno all’acquisto e consumo di merci relativamente standardizzate e a larga
diffusione.
Tuttavia il consumo generalizzato sta anche diffondendosi nelle società africane, da
una parte sostenuto dalle importazioni cinesi a basso costo, e dall’altra alimentato dai
“resti” dello “sfogo” dell’economia occidentale.
L’esempio della pubblicità aggressiva delle marche di sigarette in Africa, per
compensare la contrazione dei mercati occidentali a causa delle campagne antitabacco, mostra chiaramente la logica dello “sfogo di mercato”.
Anche qui le nuove merci sono presentate come opportunità di cavalcare il
progresso, di liberarsi dalle costrizioni della vita contadina, di accedere a un più alto
livello di civiltà, sottolineando il contenuto di felicità, realizzazione e liberazione
della cultura di consumo.
Tale dinamica riguarda la società africana, soprattutto alla luce degli impressionanti
fenomeni di inurbamento che portano con sé modi di consumo urbani, favoriti
ultimamente dal massiccio arrivo di prodotti di consumo di massa cinesi, a prezzi
molto bassi.
Quella africana è una società basata sul consumo di seconda mano: gli stock
farmaceutici scaduti, le eccedenze agricole del mercato comune, gli abiti usati, i
rifiuti tossici, auto derelitte, ecc che l’Occidente riversa in Africa a titolo di aiuto,
non sono altro che i resti dell’opulenza occidentale. Essi sono “mezzi di pressione
64 materiale o simbolica a buon mercato che esibiamo con sufficienza e per cui
esigiamo riconoscenza e umiltà”8.
Vedremo tuttavia come vitalità, creatività e dinamismo saranno la reazione e la
capacità d’adattamento che la società africana mostra come via d’uscita dal
“naufragio”.
Lo strumento esosomatico, cui abbiamo accennato sopra, rimanda al significato
originario di produzione, che identificava l’atto di svelare e dare forma a qualcosa
che fino a quel momento era solo potenziale e non “realizzata”.
Nell’opera “Per la critica dell'economia politica”, Marx sostiene che tutte le epoche
della produzione abbiano certe caratteristiche comuni, certe comuni determinazioni.
“La produzione in generale è sì un’astrazione, ma un’astrazione sensata, nella
misura in cui mette effettivamente in evidenza ciò che è comune, lo fissa e ci
risparmia ripetizioni”9.
La storia mostra come l’individuo, quindi anche l’individuo produttore, si presenti
non indipendente poiché appartenente ad un tutto più grande. Tale dipendenza appare
primariamente, e naturalmente, nella famiglia attraverso il modo di produzione
domestico. Successivamente la famiglia si allarga a tribù, e quest’ultima in comunità,
attraverso lo scontro o la pacifica fusione di più tribù.
Criticando Ricardo e gli economisti che pongono al centro delle teorie classiche la
distribuzione, Marx sostiene sia la produzione l’elemento centrale, cui la stessa
distribuzione è subordinata. Per spiegare tale posizione, Marx ricorre all’esempio
della conquista, il cui tratto centrale è l’imposizione del modo di produzione:
“In tutti i casi di conquista, tre son le possibilità. Il popolo conquistatore
impone al conquistato il proprio modo di produzione (ad esempio, gli Inglesi
in Irlanda […]e in parte, in India). Oppure, il conquistatore consente la
8
9
S. Latouche, Il pianeta dei naufraghi, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p. 214
K. Marx, Per la critica dell'economia politica, Editori riuniti, Roma, 1969, p. 201
65 sopravvivenza del precedente modo di produzione e si contenta di tributi (per
esempio, i Turchi e i Romani). Oppure, c’è una reciproca influenza, da cui
nasce qualcosa di inedito, una sintesi (in parte questo è il caso delle conquiste
germaniche). In ogni caso, il modo di produzione, sia quello del popolo
conquistatore, sia quello del popolo conquistato, sia quello che risulta dalla
mescolanza di entrambi, è determinante per la nuova [forma di] distribuzione,
che si impone”10.
La produzione deve essere quindi esposta come soggetta a leggi naturali eterne ed
indipendenti dalla storia “deve, comunque, esser possibile ricavare determinazioni
comuni
e,
quindi,
annullare
tutte
le
differenze
storiche
o
risolverle
in generali leggi umane. Ad esempio, lo schiavo, il servo della gleba, il lavoratore
salariato ricevono, tutti, un certo quanto di nutrizione, che consente loro di esistere,
rispettivamente, come schiavo, servo della gleba e lavoratore salariato”11.
La dimensione storico-materialista proposta da Marx per interpretare la produzione, è
il presupposto necessario per comprendere modo e rapporti di produzione, cioè il
rapporto generale tra produzione, distribuzione, scambio e consumo.
“Nella produzione, i membri della società rendono propri ai bisogni umani i
prodotti naturali; la distribuzione determina la proporzione, in cui il singolo
può disporre di tali prodotti; lo scambio porta al singolo i particolari prodotti,
in cui egli vuol convertire la quota, che gli è stata assegnata dalla
distribuzione; nel consumo, infine, i prodotti divengono oggetto del godimento,
dell’appropriazione
individuale.
La
produzione
ricava
gli
oggetti
corrispondenti ai bisogni; la distribuzione li suddivide secondo leggi sociali; lo
scambio distribuisce il già distribuito ma, questa volta, secondo necessità
individuali; infine, nel consumo il prodotto esce da questo movimento sociale,
diviene direttamente oggetto della singola necessità e la soddisfa”12.
10
Ivi, p. 215
Ivi, p. 202
12
Ivi, p. 208
11
66 La produzione, dunque, fa la sua comparsa come punto di partenza, il consumo
come punto finale e la distribuzione e lo scambio come fase intermedia, ma sotto
duplice forma, in quanto la distribuzione è il momento determinato dalla società, lo
scambio invece dall’individuo. “Nella produzione la persona si oggettiva e, nella
persona, si soggettivizza la cosa; nella distribuzione […] la società si assume il
compito della mediazione tra produzione e consumo”13.
L’atto conclusivo del consumo, che non solo viene concepito come termine ultimo,
ma anche come scopo finale, propriamente si colloca al di fuori dell’economia,
“tranne che per la misura in cui torna ad agire sul punto di partenza, dando così un
nuovo inizio all’intero processo”14. In quanto necessità, quindi bisogno, il consumo
è, esso stesso, un momento interno dell’attività produttiva. Quest’ultima, però, è il
punto d’avvio della realizzazione e dunque anche il suo momento predominante e
l’atto da cui l’intero processo si ripropone. L’individuo produce un oggetto e
consumandolo ritorna a sé, ma come individuo produttivo, che riproduce anche se
stesso. Il consumo appare così momento della produzione.
Se “la produzione è immediatamente anche consumo”, il loro rapporto di identità
immediata si struttura in base alla reciproca dipendenza. In questo senso Marx
propone una duplice nozione di consumo-produzione: la “produzione consumatrice”
e il “consumo produttivo”. Nel primo “l’individuo, il quale nella produzione sviluppa
le proprie capacità, le dà via anche, le consuma nell’atto del produrre, esattamente
come la procreazione naturale è un consumo di forze vitali”15. Il consumo produttivo
riguarda invece il consumo degli strumenti di produzione, che vengono usati e
consumati e che, parzialmente tornano a scomporsi negli elementi generali.
“Consumo della materia prima, la quale non permane nella sua forma sensibile e
nelle sue disposizioni naturali. Lo stesso atto della produzione, dunque, è in ogni suo
momento anche un atto del consumo”16.
13
Ibidem
Ibidem
15
Ivi, p. 209
16
Ibidem
14
67 Con tale ragionamento Marx vuole dimostrare che se la produzione fornisce
nell’esteriorità la materia del consumo, è altrettanto chiaro che il consumo pone
idealmente la materia della produzione, “come immagine interna, come spinta e
come scopo”.
Il consumo fornisce le materie alla produzione in una forma ancora soggettiva.
“La produzione media il consumo, di cui costruisce il materiale-consumo, a
cui, d’altronde, mancherebbe la materia, in mancanza di produzione. Ma a sua
volta il consumo media la produzione, in quanto costruisce il soggetto per i
prodotti-soggetto, per il quale essi sono prodotti”17
La materia tuttavia non è una materia anonima e generica, ma determinata, deve
essere consumata in un modo determinato che, a sua volta, deve essere mediato dalla
produzione.
“La fame è la fame; tuttavia, una fame che venga soddisfatta da carne cotta
mangiata con coltello e forchetta, è una fame diversa da quella che vien
placata da carne cruda mangiata, servendosi di mani, unghie e denti”18.
Mediante la produzione non è solo prodotta la materia del consumo, ma anche il
modo del consumo; la produzione opera non solo sul piano oggettivo, ma anche su
quello soggettivo. In questo senso la produzione crea anche i consumatori: non
produce solo un materiale per il soggetto, ma anche un soggetto per il materiale.
Quindi, per riassumere, la produzione produce il consumo per tre ragioni principali:
in primo luogo poiché le fornisce il materiale; in secondo luogo poiché determina il
modo del consumo; infine poiché essa genera come bisogno nei consumatori quei
prodotti posti da essa stessa come materiale.
“Con la massa degli oggetti cresce quindi la sfera degli esseri estranei ai quali
l’uomo è soggetto. […] Ogni prodotto è un’esca con cui si vuole attrarre a sé
ciò che costituisce l’essenza dell’altro, il suo denaro19.”
17
18
Ivi, p. 210
Ivi, p. 211
68 L’analisi del rapporto tra produzione consumo, risulta molto utile per capire le
dinamiche di alienazione che partendo dalla produzione, riguardano anche il
consumo, quindi la produzione di rifiuti, o quello che Marx ha definito “consumo
produttivo”.
Come osserva Sahlins, se prima il consumo era un momento del processo produttivo,
di origine naturale, ora è storico (in senso storico-materialista):
“Essenzialmente quello che sta succedendo è uno spostamento del rapporto tra
produzione e consumo dallo stato di reciprocità a quello di gerarchia. Il
consumo, che ha origine in una comune interdipendenza con la produzione, è
alla fine subordinato alla produzione. […] Questa ridefinizione del rapporto
avviene con l’assegnare al consumo tutta la vaghezza di una propensione,
lasciando al contempo alla produzione tutta la definitezza dell’oggetto”20.
Marx ha messo in luce la necessità del capitalismo di produrre un sovrappiù
economico che porta ad una limitazione dei bisogni dell’operaio sfruttato, poiché tali
bisogni diventano un qualcosa che è dato e variabile in funzione ad elementi esterni
al soggetto. Il consumo appare quindi come una forma di alienazione, funzionale alle
necessità del capitalismo. Le merci sembrano soggetti autonomi (feticci), che
nascondono la loro umanità, cioè la loro provenienza dal lavoro svolto dall’uomo.
Nella quarta tesi su Feuerbach, l’autore ritiene che l’alienazione economica e
sociale non sia una forma di alienazione come quella religiosa, ma che invece sia a
fondamento di ogni altra alienazione, senza la quale la stessa alienazione religiosa
non
potrebbe
essere
teoricamente
spiegata;
perciò
solo
la
soppressione
dell’alienazione economica, cioè l’appropriazione dell’uomo pratico, sociale,
condurrà alla soppressione dell’alienazione religiosa, cioè all’appropriazione
dell’uomo teoretico.
“L’operaio diventa tanto più povero quanto maggiore è la ricchezza che
produce, quanto più la sua produzione cresce di potenza e di estensione.
19
M. Ruini, Consumo e consumi: stili di vita e rituali di massa, in. M. Ruini (a cura di)
Caleidoscopio, Bulzoni editore, Roma, 2008, pp. 263-264
20
M. Sahlins, Cultura e utilità, op. cit., p. 173
69 L’operaio diventa una merce tanto più vile quanto più grande è la quantità di
merce che produce. La valorizzazione del mondo umano cresce in rapporto
diretto con la valorizzazione del mondo delle cose. Il lavoro non produce
soltanto merci; produce se stesso e l’operaio come merce, e proprio nella
stessa proporzione in cui produce in generale le merci. Questo fatto non
esprime altro che questo:l’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del
lavoro, si contrappone ad esso come un essere estraneo, come una potenza
indipendente da colui che lo produce. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è
fissato in un oggetto, è diventato una cosa, è l’oggettivazione del lavoro. La
realizzazione del lavoro è la sua oggettivazione. Questa realizzazione del
lavoro appare nello stadio dell’economia privata come un annullamento
dell’operaio,
l’oggettivazione
appare
come
perdita
e
asservimento
dell’oggetto, l’appropriazione come estraniazione, come alienazione”21.
L’oggettivazione si presenta quindi come perdita dell’oggetto, estraniazione. Jean
Baudrillard parlava di “civiltà del gadget”, emblema della società postindustriale che
rappresenta la scomparsa
della funzione oggettiva dell’oggetto di consumo
(utensile), a vantaggio dell’ “inutilità funzionale”22.
La stessa appropriazione è alienazione: più oggetti si producono, meno se ne
possono possedere, più si diventa schiavi del prodotto. Più l’operaio lavora, più il
mondo estraneo diventa forte. L’alienazione dell’operaio nel suo prodotto significa
non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, come qualcosa che esiste all’esterno,
ma che esso “esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo”23.
“..quanto più l’operaio si appropria col proprio lavoro del mondo esterno,
della natura sensibile, tanto più egli si priva dei mezzi di sussistenza nella
seguente duplice direzione: prima di tutto, per il fatto che il mondo esterno
cessa sempre più di essere un oggetto appartenente al suo lavoro, un mezzo di
sussistenza del suo lavoro, e poi per il fatto che lo stesso mondo esterno cessa
21
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1973, pp. 72 -85
Cfr., J. Baudrillard, La società dei consumi, op. cit.
23
Ivi, p. 72
22
70 sempre più di essere un mezzo di sussistenza nel senso immediato, cioè un
mezzo per il suo sostentamento fisico”24.
L’alienazione del lavoro quindi non è finalizzata al soddisfacimento di un bisogno,
ma è soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei.
“L’uomo non costruisce solo il rapporto con l’oggetto e con l’atto della produzione,
ma anche il rapporto in cui altri uomini stanno con la sua produzione e col suo
prodotto”25. Tale affermazione ci è utile, per capire che l’alienazione non riguarda
solo l’operaio, ma l’intero processo produttivo, ivi compresi tutti i consumatori. In
questo senso il legame tra consumo e alienazione invade, tramite i mercati
globalizzati, tutti i consumatori, anche quelli delle metropoli africane.
24
25
Ivi, p. 73
Ivi, p. 82
71 2.2 CONSUMO e SOVVERSIONE
Prenderemo ora in considerazione alcune analisi teoriche sul consumo, che si
orientano principalmente in due direzioni: da una parte la tradizione marxiana, e
dall’altra quella post-moderna proposta dai Cultural Studies.
Sulla scia della teoria marxiana, la teoria del valore di scambio, le teorie critiche
della società di massa della Scuola di Francoforte, la teoria del valore-segno di
Baudrillard e della distinzione di Bourdieu, fino alla più recente figura dell’homo
consumens teorizzata da Bauman, sono tutte teorie accomunate, per quanto tra loro
molto differenti (per presupposti teorici e modelli interpretativi), dal fatto che negano
al consumo valenze creative, non gli riconoscono la capacità di produrre significati,
di creare modi d’uso alternativi a quelli previsti dal mercato26.
Simmel, ad esempio, ha concentrato la sua analisi sulle conseguenze dei processi di
industrializzazione e di urbanizzazione nella società moderna, che modificano la
natura e la forza delle relazioni sociali agendo sull’individuo e sul rapporto dialettico
che quest’ultimo intrattiene con le strutture sociali. L’individuo metropolitano, nello
specifico, all’interno di questa dinamica accresce la sua abilità nel prendere distanza
dagli oggetti e dalle persone con cui entra in contatto.
Il rapporto superficiale ed impersonale che quindi il consumatore di città crea
con gli oggetti, è una caratteristica della società industriale. Simmel ha saputo
individuare le conseguenze della comparsa della “metropolizzazione del sociale”, cui
appartiene quel senso di estraneità determinato dalla ripetitività della produzione
industriale in serie e della facilità di sostituzione che caratterizza i processi di
compravendita dei beni. In questo senso l’ “oggettivazione” di cui parla Simmel non
si discosta molto dall’alienazione di cui parlava Marx.
Così come Marx aveva rilevato l’alienazione dal proprio lavoro per il salariato, così
Simmel rileva l’alienazione del soggetto verso gli oggetti di consumo.
L’impersonalità della produzione industriale e la facilità di compravendita, si trova
26
Cfr., V. Codeluppi, Manuale di sociologia dei consumi, Carocci, Roma, 2006
72 all’origine del sentimento di estraneità che il soggetto metropolitano vive nei
confronti degli oggetti di cui fa esperienza, sempre più numerosi e facilmente
sostituibili, con i quali non può che sviluppare un rapporto meramente superficiale,
che gli consente di passare da un bene all’altro con grande disinvoltura; tale carattere
“esterno”, “esogeno”,”impersonale” è anche stato soggetto d’analisi della scuola di
Francoforte (Marcuse nell’opera “L’uomo a una dimensione” sviluppa una critica
pessimista della società moderna, alla cui totalità l’individuo si arrende. In questo
modello di vita l’individuo cede al bisogno primordiale di produrre e consumare; la
sua unica dimensione si riduce alla sfera del consumo).
Nell’opera “La società dei consumi”, per Jean Baudrillard “
il consumo […] è un’istituzione di classe: non solo c’è di fronte agli oggetti
una disuguaglianza in senso economico [rispetto al potere d’acquisto], ma più
in profondità c’è una discriminazione radicale nel senso in cui solo certi
accedono ad una logica autonoma, razionale, degli elementi dell’ambiente
(uso funzionale, organizzazione estetica, realizzazione culturale)”27.
Baudrillard analizza il problema dei consumi da una prospettiva semiologia: esso si
pone come un linguaggio che fa capo ad un sistema di comunicazione governato dal
codice della differenziazione sociale. “E’ un pensiero magico che regola il consumo,
è una mentalità miracolosa che regola la vita quotidiana; come la mentalità
primitiva viene considerata fondata sulla credenza nell’onnipotenza dei pensieri, qui
c’è la credenza nell’onnipresenza dei segni. L’opulenza non è che l’accumulazione
dei segni della felicità”28.
Se nella società industriale il lavoro è subordinato alle esigenze di
produzione, nella società dei consumi il piacere, inteso come godimento, è
subordinato al consumo. La dipendenza di questo piacere-godimento dal consumo,
che Baudrillard chiama “sistema dei bisogni”, causa la frantumazione del soggetto.
“L’abbondanza quotidiana “appare come un miracolo nella misura in cui appare
27
28
J. Baudrillard, La società dei consumi, op. cit., p. 70
Ivi, p. 25
73 non come prodotta, strappata e conquistata al termine di uno sforzo storico e
sociale, ma come dispensata da parte di un’istanza mitologica benefica di cui siamo
legittimi eredi: la tecnica, il progresso, ecc”29
Il sistema dei bisogni coinvolge anche l’universo strumentale di cui l’uomo dispone,
depotenziando le categorie dell’uso e rendendo l’uomo asservito alla tecnologia ed
alla sua presunta e apparente efficienza:
“Lo strumento veramente razionale risponde a tre esigenze: genera efficienza
senza degradare l’autonomia personale, non produce né schiavi né padroni,
estende il raggio d’azione personale. L’uomo ha bisogno di un attrezzo con cui
lavorare, non di un’attrezzatura che lavori al suo posto. Ha bisogno di una
tecnologia che esalti l’energia e l’immaginazione personali, non di una
tecnologia che lo asservisca e lo programmi. L’industrializzazione
programmatica ci ha progressivamente privato di tali strumenti”30.
La sovraefficienza di certi strumenti può alterare il rapporto tra ciò che uno ha
bisogno di fare da sé e ciò che può attingere direttamente dall’industria. In questo
senso la produzione dà luogo al “monopolio radicale”.
Con questa espressione Ivan Illich intende “un tipo di dominio di un prodotto”
specifico che restringe le possibilità di scelta di un consumatore.
“L’uomo che va a piedi e prende erbe medicinali non è l’uomo che corre a
centosessanta sull’autostrada e prende antibiotici; ma tanto l’uno quanto
l’altro non possono fare tutto da sé e dipendono da ciò che gli fornisce il loro
ambiente naturale e culturale. Lo strumento e quindi la fornitura di oggetti e
servizi variano da una civiltà all’altra. L’uomo non vive solo di beni e servizi,
ma della libertà di modellare gli oggetti che gli stanno attorno, di conformarli
al suo gusto e alle sue necessità, di servirsene con gli altri e per gli altri”31.
29
Ivi, p. 27
I. Illich, La convivialità, op. cit., pp. 30–31
31
Ibidem
30
74 Poiché i bisogni sono prodotti come elementi di un sistema e non come una relazione
tra un individuo ed un oggetto, per capire il consumo occorre dunque non tanto
considerare perché una persona desidera o compra un determinato oggetto, ma quali
significati la cultura di consumo ha iscritto in quell’oggetto in relazione all’intero
“sistema degli oggetti”. Per spiegare tale concetto Baudrillard ricorre al culto del
cargo in Melanesia.
Durante la Seconda guerra mondiale molti aerei statunitensi sorvolavano le
isole del Pacifico. Gli aborigeni che vivevano come primitivi in quell’area del
mondo, divinizzarono quegli aerei e ne realizzarono alcuni esemplari fatti di giunchi
e paglia, da adorare. I beni di consumo si propongono in questo senso, come una
potenza carpita, e non come prodotti del lavoro. I culti del cargo riflettono la
speranza, e il cibo inesauribile che il “Gran Giorno” porterà con sé, causerà un
radicale cambiamento di rapporto fra bianchi e neri, fra razze diverse fino
all’inversione, generando una nuova società32.
In senso più radicale, i consumatori non consumano specifici oggetti per rispondere a
bisogni concreti, ma consumano segni che sono parte di un sistema culturale che
sostituisce un ordine sociale di valori e classificazioni al mondo dei bisogni e dei
piaceri. Altrettanto radicalmente Baudrillard arriva alla conclusione che nel
capitalismo avanzato non solo la produzione, ma anche il consumo sono disciplinati
e razionalizzati per favorire la riproduzione della struttura economica.
Una delle contraddizioni della crescita è che produce al tempo stesso beni e
bisogni, ma non li produce allo stesso ritmo. Ne deriva quella che Baudrillard chiama
“pauperizzazione psicologica”, uno stato, cioè, di insoddisfazione generalizzata che
definisce la società della crescita come il contrario di una società dell’abbondanza,
perché basata sullo spreco: esso può indurre a parlare di società della pattumiera:
“Dimmi cosa butti e ti dirò che sei.[…] Ma la statistica del detrito non è interessante
in se stessa, essa non è che un dato ridondante del volume dei beni offerti e della sua
profusione”33. Lo spreco quindi non è che il residuo di quel che era stato prodotto per
essere consumato e che invece non è stato consumato. Esso deriva dal non rispetto
32
Cfr., E. Chiavarelli, Il mito del Cargo, in M. Ruini (a cura di), Interpretare lo sviluppo. Note di
socioantropologia, Bulzoni Editore, Roma, 2009
33
Ivi, p. 44
75 della “legge morale interna dell’oggetto” che sarebbe il suo valore d’uso. “E’ lo
spreco, quindi, […] ad essere lo schema psicologico, sociologico ed economico
direttivo dell’abbondanza”34.
Tutte le società hanno sempre sprecato, dilapidato, speso e consumato al di là dello
stretto necessario, per la semplice ragione che è nel consumo di un’eccedenza, di un
surplus, che l’individuo, come la società, si sentono non semplicemente esistere ma
anche vivere. Tale consumo può giungere sino alla “consumazione”, alla distruzione,
che assume una specificità sociale, come nel Potlach35 dei Kwakiutl è la distruzione
competitiva che caratterizza l’organizzazione sociale36.
L’uso degli oggetti non conduce che alla loro lenta perdita. Il valore creato è molto
più intenso nella sua perdita violenta. Per questa ragione la distruzione resta
l’alternativa fondamentale alla produzione, il consumo non è che un termine che
funge da intermediario tra questi due estremi. “Vi è una tendenza profonda nel
consumo a superarsi, a trasfigurarsi nella distruzione. E’ la che esso assume il suo
senso”37. Il consumo rappresenta così uno spazio di collocazione gerarchica, dove
esso funge da indicatore di status sociale, “oggi come ieri, codice riconosciuto e
accettato di un sistema identitario che vive di segni distintivi e differenziati”38
A partire dagli anni Ottanta del Novecento, antropologia e sociologia hanno iniziato
a studiare il fenomeno del consumo attraverso i modi concreti in cui le merci
vengono consumate nella vita ordinaria, a volte integrando e altre opponendosi alla
tradizione marxiana.
L’analisi di Marx infatti non spiega (direttamente), fermo restando il
presupposto della subordinazione del consumo al processo produttivo, cosa avviene
alle merci quando vengono sottratte temporaneamente o per sempre dalla sfera dello
34
Ivi, p. 48
Il Potlach è una cerimonia che si svolge tra alcune tribù di Nativi Americani della costa
nordoccidentale del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada. Essa assume la forma di una cerimonia
rituale, in cui vengono ostentate pratiche distruttive di beni considerati di prestigio.
36
J. Baudrillard, La società dei consumi, op. cit., p. 45
37
Ivi, p. 50
38
M. Ruini, Consumo e consumi: stili di vita e rituali di massa, in Ruini M. (a cura di),
Caleidoscopio, op. cit., p. 260
35
76 scambio. Non spiega cioè come si sviluppa successivamente il rapporto tra merci e
consumatore, specificatamente nell’ottica dell’appropriazione (fisica e simbolica) e
della “sovversione”.
Studi contemporanei sul consumo affrontano in modo problematico le nozioni di
standardizzazione e di massificazione e considerano tale fenomeno come una pratica
relativamente autonoma dalla produzione e distribuzione delle merci. Lungi dal
sostenere che il consumo sia espressione di piena libertà soggettiva, come tendono a
fare le analisi di stampo neoliberista, per ottenere un’immagine più equilibrata del
consumo occorre evitare di ricondurlo semplicemente ai processi produttivi.
I primi approcci hanno messo a fuoco le dinamiche di distinzione e appartenenza
sociale di cui i consumi sono espressione, sottolineando che, in quanto parte della
cultura materiale, anche le merci più standardizzate entrano in quel gioco
classificatorio mediante il quale gusti e disgusti, alleanze e antagonismi, gerarchie e
analogie vengono riprodotti. Emergeva cioè la capacità dei consumatori di utilizzare
le merci seguendo logiche distintive, con lo scopo di segnalare il proprio peculiare
posto nel mondo.
Karen
Tranberg
Hansen,
ad
esempio,
ha
analizzato
il
mercato
dell’abbigliamento di seconda mano importato dall’occidente, che è diventato un
bene popolare tra le classi delle aree urbane e rurali in Zambia. L’attrazione per gli
abiti usati ha a che fare soprattutto con l’imitazione della moda occidentale; riguarda
i valori individuali e di gruppo riferiti alle pratiche di abbigliamento, che si ispirano,
ma non sempre si allineano, alle norme locali sulle etichette sociali e il decoro
sessuale.
Oltre a soddisfare bisogni essenziali, l’abbigliamento, nuovo e usato, costituisce una
pratica in cui le identità sociali vengono costruite e contestate. Perciò l’abito e
l’abbigliarsi sono sia un fine in sé che un mezzo attraverso il quale si può esprimere
un certo potenziale liberatorio, ma che può causare anche ansia, dal momento che gli
abiti non sono indossati passivamente, ma richiedono la collaborazione attiva degli
individui.
77 Il sistema emergente della moda è in continuo sviluppo, e il suo significato
dipende dai contesti specifici in cui è creato. Basandosi su una ricerca di tipo
antropologico condotta in Zambia negli anni ’90 e su recenti lavori sulle pratiche
d’abbigliamento dei giovani a Lusaka, Hansen mostra come i giovani consumatori
utilizzino l’abbigliamento di seconda mano occidentale per costruire nuove mode e
nuovi stili. Esempio sono le figure dei sapeurs congolesi che costruiscono “un sé
interamente sociale”39, mediante l’appropriazione di abiti griffati occidentali.
Se da un lato tali trasformazioni sono influenzate dalle culture globali della moda
giovanile,
dall’altro
esse
si
collocano
all’interno
dell’universo
locale
dell’abbigliamento, che è a sua volta legato alle percezioni del corpo e della
sessualità, distinte per i generi e le generazioni, e alimentate dai quotidiani imperativi
economici e dal potere relativo dello stato40.
L’antropologia nell’area dei “Cultural Studies”, in particolare, ha studiato i fenomeni
di appropriazione simbolica e de-mercificazione. Le ricerche condotte da questa area
di studi mostra che nonostante un’industria culturale e un sistema pubblicitario che
indubbiamente suggeriscono stili di vita preconfezionati, le pratiche di consumo si
configurano
essenzialmente
come
azioni
orientate
all’espressione
e
al
consolidamento di legami sociali specifici. Anche le merci più standardizzate hanno
in effetti bisogno di essere inserite in contesti d’uso che spesso ne determinano il
senso e i significati.
Nonostante la nostra analisi differisca da quelle che considerano il consumo come
une fenomeno autonomo, alcune intuizioni relative alle pratiche di (ri)appropriazione
e personalizzazione, ci sembrano essere utili ai fini della nostra analisi. Se infatti da
un lato abbiamo trattato il consumo come un fenomeno di omologazione (soprattutto
in relazione alla società occidentale), dall’altro dobbiamo rilevarne uno
apparentemente opposto, che è quello della sovversione, cioè “una sorta di spazio
39
J. Friedman, La quotidianità del sistema globale, Mondadori, Milano, 2005, p. 99
Cfr., K.T Hansen, Salaula: The World of Secondhand Clothing and Zambia, The University of
Chicago Press books, Chicago, 2000
40
78 catacretico in cui il consumatore si appropria di significati altri per riscrivere in essi
i segni della propria traccia”41.
Il consumatore descritto da Michel de Certeau è l’uomo ordinario, che, attraverso un
uso imprevedibile dei prodotti che gli vengono imposti dal sistema economico
dominante, gioca con l’ordine sociale che lo sovrasta. Si tratta di una forma di
consumo produttivo, di appropriazione creativa e al limite sovversiva. De Certau
sostiene che il consumo sia una forma di produzione del valore, contrapposta
naturalmente al sistema di produzione delle merci42. Il consumatore interpreta le
merci in maniera personale, secondo la logica dell’arrangiarsi e del “Bricolage”.
L’antropologo inglese Daniel Miller43 ha rilevato il ruolo attivo del consumatore e la
sua capacità di appropriarsi della cultura materiale in modi a volte sovversivi.
Enfatizzando i mondi di significato che gli attori sociali sono capaci di creare
mediante gli oggetti di consumo, inclusi quelli di massa, la tradizione antropologica
nel suo complesso si è opposta quindi all’idea, formulata dalla tradizione critica,
soprattutto dalla Scuola di Fancoforte, che il consumo si configuri come l’antitesi
della cultura intesa come espressione più alta dell’essere umano.
I consumatori si comportano come bricoleurs, trovando il modo di utilizzare le merci
e i loro significati in modi personali, a volte sovversivi, muovendosi negli interstizi
lasciati a loro disposizione dalla cultura di consumo di massa. Miller considera il
consumo come un processo relativamente autonomo e plurale di autocostruzione
culturale: non vi è un solo modo appropriato di consumare, e i diversi modi di
consumare rispondono alla diversità delle reti sociali locali, che mantengono le
proprie differenze opponendosi ai meccanismi di produzione e distribuzione globali.
Per la sua natura poliforme, sottolinea pertanto Miller, il consumo può essere visto
41
M. Mellino, La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei
postcolonial studies, Meltemi, Roma, 2005, p. 78
42
V. Codeluppi, Manuale di sociologia dei cosumi, op. cit., p. 87
43
Ivi, p. 176
79 come il tentativo degli attori sociali di “distillare la propria umanità” negando la
logica della mercificazione44.
Persino nell’era del consumo di massa la cultura materiale è infatti un processo che
implica, in termini che Miller trae dalla teoria hegeliana dell’oggettivazione, un
movimento duale di esternalizzazione prima e di internalizzazione poi. In tale ottica
il consumo viene considerato come “una forma di riassorbimento o appropriazione,
ossia come il modo in cui un soggetto assimila la propria cultura e la usa per
sviluppare sé stesso come attore sociale”45. Il consumo si configura dunque come
una pratica ambivalente, non totalmente determinata ma neanche pienamente libera:
una pratica sociale attraverso la quale i soggetti usano, modulano e modificano
numerosi stimoli culturali, influenze commerciali e oggetti materiali. Studi di
carattere etnografico hanno dimostrato in effetti che il consumo non è né un atto
puramente determinato dalla natura di massa delle merci o dal sistema promozionale,
né un atto puramente razionale e strumentale che si basa sul calcolo autointeressato.
Si tratta piuttosto di un atto creativo che può produrre qualcosa di autentico anche se
si fonda su codici creati da industrie fortemente razionalizzate, un atto intimamente
distintivo che serve per segnare e rinsaldare le relazioni sociali, riprodurre differenze
e gerarchie.
Infine, Miller sostiene che attraverso le pratiche di consumo il bene può divenire
inalienabile e con esso anche i soggetti e le relazioni tra essi. Si tratta di un processo
di appropriazione o ri-contestualizzazione, che si esplica nell’uso che egli fa delle
merci e attraverso cui ha la possibilità di personalizzarle, di trasformarle in beni dal
significato personale. Ci serviamo di merci che dobbiamo de-mercificare affinché
esse abbiano un senso per noi, traducendo i significati e gli usi degli oggetti pensati
dal
sistema
di
produzione
e
proposti
dal
sistema
di
promozione
e
commercializzazione.
44
45
Ibidem
Ivi, p. 181
80 In controtendenza con quanto esposto di sopra, vale la pena accennare alla recente
tendenza del “consumo critico”, in cui produzione e consumo non sembrano separati,
ma si presentano come due questioni politiche: la controparte dei lavoratori sfruttati è
costituita infatti dai consumatori che incontrano difficoltà a trovare prodotti genuini.
La diffusione di merci di massa su scala globale non soltanto ha fatto avanzare la
logica di mercato, ma ha anche reso più scoperti gli effetti del mercato stesso,
mettendo in luce questioni etiche e politiche, come le disuguaglianze tra i
consumatori, la necessità di politiche redistributive o le conseguenze di lungo
termine sull’ambiente delle attuali procedure economiche.
L’analisi del rapporto tra consumo e produzione è utile per capire come nel modo di
produzione delle società tradizionali, il consumo non fosse alienato, ma incorporato
nel sociale, come tutta l’economia.
Se Marx ha analizzato l’alienazione nel processo produttivo, e quindi in quello di
consumo, della società capitalista, Karl Polany si è interessato su come nelle società
arcaiche l’incorporazione dell’economia nel sociale rigetti quel rapporto di
alienazione.
Tuttavia Marx, attraverso l’analisi dei modi di produzione antico, asiatico e feudale,
ha tentato un’analisi della legge generale dello sviluppo storico e del legame
reciproco dei diversi modi di produzione che si sono storicamente succeduti.
Secondo questa analisi la società antica era il naturale all’interno del sociale. La
semplicità
dell’organizzazione
produttiva,
concepita
come
la
chiave
dell’immutabilità della società arcaica, non solo era una condizione non alienata in
confronto alla società borghese, ma soprattutto “mancava delle differenziazioni
strutturali che danno alla società borghese il suo “movimento dialettico”: la
separazione dai mezzi di produzione dai produttori, dei produttori dai prodotti,
della produzione dai bisogni dei produttori, e degli individui dalla collettività”46.
46
M. Sahlins, Cultura e utilità, op. cit., pp. 60-61
81 La relativa stabilità della società più antica era connessa a una produzione
orientata ai valori d’uso, a un’economia in cui l’uomo è l’oggetto della produzione, e
la produzione l’obiettivo dell’uomo47.
Una produzione quindi di sussistenza, laddove con questa espressione intendiamo
una forma di organizzazione economica in cui i nuclei familiari (economie
domestiche contadine ma anche signorili) producono soprattutto per il proprio
fabbisogno (ciò comporta la coincidenza tra comunità di produzione e comunità di
consumo).
L'economia
di
sussistenza
si
contrappone
all'economia
di
mercato capitalistica delle società industriali, dove beni e servizi vengono invece
distribuiti attraverso il mercato.
“La ‘logica della sussistenza’ funziona come una specie di anello di
congiunzione fra diversi modi di azione economica entro cui si ripartiscono le
pratiche contadine individuali, da una parte, e il sistema dei vincoli ai quali
tutti sono sottoposti dall’altra”48.
Le regole della logica di sussistenza sono così definite dai rapporti di produzione (i
vincoli strutturali), dai sistemi normativi locali (i cosiddetti vincoli culturali) e dai
rapporti di forza sociali (i vincoli che potremmo chiamare politici).
Tale logica deve essere sganciata da specifici modi o rapporti di produzione,
ma deve essere piuttosto trasversale e operare all’interno di svariati rapporti di
produzione, poiché presenta un carattere più dinamico che intende valorizzare la
razionalità soggiacente a tutto un complesso di modi di azione economica. Essa può
dunque combinarsi con altre logiche di azione economica, come pure con logiche di
azione non economica, all’interno di svariati rapporti di produzione.
Riprendendo il concetto di produzione, Polany sostiene che essa è
“..un’interazione tra l’uomo e la natura; se questo processo deve essere
organizzato attraverso un meccanismo autoregolato di baratto e scambio,
allora l’uomo e la natura devono essere condotti nella sua orbita; essi devono
47
48
Ibidem
J.P.O. De Sardan, Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento sociale, op. cit., p. 124
82 essere soggetti all’offerta e alla domanda, essere cioè trattati come beni, come
merci prodotte per la vendita”49.
Nel libro “La grande trasformazione”50, l’autore ungherese sostiene che se da un lato
la Rivoluzione industriale del XVIII secolo comportò un miracoloso miglioramento
degli strumenti di produzione, dall’altro ciò fu accompagnato da un catastrofico
sconvolgimento delle vite della gente comune. Tale sconvolgimento fu causato dal
fallimento della filosofia liberale, che consiste principalmente nel non aver compreso
la portata del cambiamento; “bruciato da una fede emotiva nella spontaneità,
l’atteggiamento del senso comune verso il cambiamento fu abbandonato a favore di
una mistica prontezza ad accettare le conseguenze sociali del miglioramento
economico, qualunque esse potessero essere”51
Il ritmo del cambiamento non è meno importante della stessa direzione del
cambiamento, sostiene Polany, “ma mentre quest’ultimo non dipende dalla nostra
volontà, il ritmo al quale permettiamo che il cambiamento abbia luogo può
dipendere da noi”52. L’effettività del cambiamento consisterà quindi nel confronto
tra ritmo del cambiamento e ritmo di adattamento.
L’elemento principale di questo cambiamento, della “grande trasformazione”,
è quindi l’autonomizzazione dell’economia e dei mercati autoregolati rispetto alla
società. Se prima infatti l’economico era incorporato nel sociale (“embedded”), oggi
il rapporto tra uomo e produzione ha un carattere esogeno ed impersonale: l’uomo
non è più l’oggetto della produzione. Ciò accade perché il nuovo credo materialista
sostiene che tutti i problemi possano essere risolti per mezzo di una quantità
illimitata di beni materiali. Di conseguenza, le leggi alla base di questo nuovo credo,
portarono alla rinuncia della solidarietà in nome della massima felicità per il maggior
numero di persone.
Analizzando il modo di produzione delle economie di sussistenza , Polany rintraccia
ed analizza le caratteristiche dell’economia incorporata nel sociale, in cui
l’alienazione non si realizzava, se non per rapporti di forza generati dal modo di
produzione domestico (come vedremo più avanti con Meillassoux).
49
K. Polany, La grande trasformazione, op. cit., p. 176
Cfr., K. Polany, La grande trasformazione, op. cit.
51
Ivi, p. 45
52
Ivi, p. 50
50
83 Il In linea con l’antropologia di Malinowski e Firth, Sahlins ha ben spiegato
l’assenza di alienazione nelle società arcaiche:
“il lavoro tribale non è un lavoro alienato. Non è alienato né dai mezzi di
produzione né dai prodotti … non è alienato dall’uomo stesso, vale a dire
scindibile dal suo essere sociale e scambiabile in quanto unità di una forzalavoro spersonalizzata. Un uomo lavora e produce nella sua capacità di
persona sociale in quanto marito e padre, fratello e compagno di lignaggio,
membro di un clan o di un villaggio. Il lavoro non viene esaurito a prescindere
da queste esistenze e in base a una differente esistenza: “lavoratore” non è di
per sé configurazione sociale e lavoro non è una categoria reale dell’economia
tribale. In altri termini, il lavoro è realizzato dalle forme non economiche nel
senso convenzionale che appartengono piuttosto all’organizzazione generale
della società”53.
Tuttavia Claude Meillassoux ha colto la funzione essenziale del modo di produzione
domestico, nel processo riproduttivo del capitale stesso: egli ha mostrato come anche
all’interno del modo di produzione domestico e di sussistenza, persistano dei rapporti
di forza in seno alla produzione ed alla divisione del lavoro.
L’antropologo francese ha analizzato in particolare la relazione tra matrimonio,
parentela e proprietà in ambito precapitalista e capitalista, descrivendo in maniera
singolare la relazione tra produzione e riproduzione economica, e il modo in cui gli
anziani controllavano il lavoro dei giovani attraverso il fattore economico e
parentale.
Il suo lavoro ha rappresentato la prima importante tappa del processo di
elaborazione
teorica
marxista
sulle
economie
precapitaliste,
svincolata
dall’interpretazione dogmatica dei testi marxiani rispetto al concetto di classe.
Tentando di definire un modello di economia non capitalista, caratterizzato da leggi
proprie e nel quale fosse possibile spiegare l’assenza di rapporti di sfruttamento tra
classi differenziate, Meillassoux propone l’idea del modo di produzione lignatico,
definito cioè in base alla struttura della società fondata sui lignaggi. Si tratta di
53
M. Godelier, Sulle società precapitalistiche, Feltrinelli, Milano, 1976, Introduzione
84 un’economia di autosussistenza in cui la produzione è indirizzata all’autoconsumo.
Qui l’organizzazione dei rapporti sociali di produzione segue il principio gerarchico
della subordinazione dei giovani agli anziani, e il controllo che questi ultimi
esercitano mediante il controllo per l’accesso alle donne54.
Se il rapporto di forza, la gerarchia, si manifesta microscopicamente nel modo di
produzione domestico, a livello internazionale esso si esprime tramite la dipendenza
economica.
Spiegando l’imperialismo in quanto processo inerente allo sviluppo del capitalismo,
Meillassoux, tramite il pensiero di Lenin e Rosa Luxemburg, spiega che l’espansione
del capitalismo in Africa, occidentale soprattutto, è legato alla ricerca di nuovi
mercati, una sorta di “sfogo della produzione” (cui abbiamo accennato in principio),
di un’economia capitalista presa nelle contraddizioni di una crescita ineguale. Tale
sfogo è reso possibile grazie al gigantesco sviluppo del modo di produzione
industriale e del mercato mondiale.
A tal proposito, Polany sostiene che tale sfogo è sistemico, e avviene poiché
la tecnologia delle nuove macchine rende solo se si produce in grandi quantità, se lo
“sfogo” dei prodotti è ragionevolmente assicurato e, infine, se la materia prima è
costantemente garantita. Questo sistema implica un cambiamento nelle motivazioni
da parte dei membri della società: al motivo della sussistenza deve essere sostituito
quello del guadagno55.
Lo sfogo di produzione per Meillassoux dimostra che la politica coloniale in Africa
trae vantaggio dall’organizzazione delle capacità produttive dell’economia domestica
(invece di basarsi su rapporti di classe come in occidente).
54
Cfr., C. Meillassoux, Donne, granai e capitali. Uno studio antropologico dell’imperialismo
contemporaneo, op. cit.
55
K. Polany, La grande trasformazione, op. cit., p. 61
85 2.3 L’INFORMALE, IL BRICOLAGE e L’AFRICA
L’autonomizzazione dell’economia ha creato un rapporto impersonale col consumo,
quindi con i rifiuti, ovunque tale modello di economia si diffonda.
Per quanto riguarda l’Africa, i fenomeni di consumo assumono più una natura
cerimoniale e simbolica rispetto alle pratiche di acquisto ed uso dei beni. Accanto ad
azioni di consumo meramente strumentali, spiegabili mediante il ricorso al valore
d’uso delle merci, operano logiche posizionali: i beni vengono desiderati e usati per
la loro capacità di rendere visibile una data posizione sociale. Si tratta dell’
”incorporazione” di cui parla Polany, che nel continente africano sopravvive ancora
in quello che oggi, in maniera controversa, viene definito il “settore informale”, cioè
quella parte di economia non regolamentata da leggi o contratti.
Nelle economie arcaiche e primitive i mezzi di sussistenza erano garantiti come un
diritto morale derivante dall’appartenenza a una comunità umana. Si tratta del diritto
a ricevere terra, lavoro e prodotto in periodi normali e, in periodi di emergenza, il
sostegno di amici e governanti.
A differenza di reciprocità e redistribuzione (i modelli di integrazione economica),
caratteristici delle società arcaiche e primitive, lo scambio di mercato non si basa su
nessuna relazione sociale sottostante: il modello della reciprocità si fonda su status,
parentela e gerarchia, mentre quello della redistribuzione si fonda sull’ affiliazione
politica o religiosa. Secondo Polany la struttura istituzionale del capitalismo
industriale del laissez faire ha separato l’economia dalla società e dallo stato,
trasformando il lavoro, la terra e le risorse naturali in merci.
“La creatività istituzionale dell’uomo è venuta meno soltanto perché si è
lasciato che il mercato stritolasse il materiale umano riducendolo alla piatta
uniformità di un paesaggio di detriti selenici”56.
Lo scopo di Polany era quello di accrescere la libertà di adattamento creativo
dell’uomo
56
per
aumentare
le
possibilità
di
sopravvivenza,
riconsiderando
K. Polany, Economie primitive, arcaiche e moderne, op. cit., p. 70
86 integralmente il problema dei mezzi materiali di sussistenza dell’uomo. In questo
senso la solidarietà si trova alla base delle relazioni sociali, di cui la fiducia
rappresenta una sorta di garanzia dovuta alla pressione sociale esercitata in caso di
non rispetto degli accordi conclusi.
La stessa proprietà, nelle società primitive, non si riferisce ad un oggetto nella sua
interezza, come ad esempio ad un appezzamento di terra, ma soltanto a ciascuno dei
suoi usi (come vedremo nella seconda parte, riguardo al modo di produzione Diola).
La terra non poteva essere venduta, ma trasferita nel tempo, e tale trasferimento era
oggetto a condizionamenti e limitato nel tempo.
“Tradizionalmente terra e lavoro non sono separate: il lavoro costituisce parte
della vita, la terra rimane parte della natura, e vita e natura formano un
insieme articolato”57.
Vale la pena però notare come il trasferimento del solo uso abbia un senso più
specificatamente economico che non il trasferimento della proprietà. Nello scambio
della proprietà intervenivano i meccanismi di prestigio, mentre nella cessione
dell’uso prevale l’elemento utilitario58.
La tesi di Polany è che solo un approccio sostanziale del concetto di “economico”
(cioè in cui l’uomo dipende dalla natura e dai suoi simili per sopravvivere) possa
fornire i concetti di cui le scienze sociali hanno bisogno per analizzare i tipi di
economia che intervengono nel processo di soddisfazione dei bisogni naturali.
Polany si oppose con veemenza ad una sociologia economica volta ad attribuire alle
economie arcaiche e primitive i concetti di una teoria economica valida soltanto per
il sistema di mercato. E’ proprio questa la ragione per cui gli economisti sono
combattuti nel trovare una definizione universale rispetto al settore informale: le loro
analisi trattano l’informale come se si trattasse di economia, quando in realtà si tratta
di una forma di società (incorporata all’economia).
Tale settore esercita una mediazione nel tessuto socio-culturale, tra valori culturali
tradizionali e esigenze dello sviluppo e della crescita. Questo significa anche che la
57
58
K. Polany, La grande trasformazione, op. cit., p. 228
Cfr., K. Polany, Economie primitive, arcaiche e moderne, op. cit.
87 sua attività risponde agli obblighi di solidarietà, ed è proprio in tali contesti solidali
che il surplus accumulato è ricondotto. Esso è orientato alla minimizzazione dei
rischi e alla presa a carico dei valori sociali e culturali in quanto costituisce una
presa di coscienza delle popolazioni a proposito delle questioni poste dal problema
dell’esodo rurale divenuto sempre meno gestibile dai poteri pubblici.
“Le difficoltà connesse alla concettualizzazione dell’economia informale si
sommano a quelle legate alla sua interpretazione: fin dagli anni sessanta del
secolo scorso, periodo in cui, per la prima volta, è stato utilizzato tale termine,
l’informalità è apparsa come un fenomeno sociale ed economico di non
semplice interpretazione, soprattutto quando si è provato ad affrontarlo
utilizzando strumenti analitici propri di un’unica disciplina”59.
Il termine è stato utilizzato, per la prima volta, in due studi promossi
dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in Ghana e in Kenya, spinta dal
fatto che la grande crescita economica dei paesi industrializzati (ed, in parte, il
processo di sviluppo economico di alcuni paesi industrialmente più deboli) negli anni
Settanta, era bruscamente rallentata. Da allora, il paradigma produttivo dominante, su
cui erano stati costruiti quegli alti tassi di crescita, si è dovuto confrontare con un
contesto economico e sociale non più prevedibile.
Economisti, giuristi e sociologi hanno interpretato tale settore informale in maniera
differente, spesso con forzature finalizzate alla coerenza della disciplina. Se all’inizio
fu usato per indicare le attività su piccola scala impiegate soprattutto per integrare le
economie di sussistenza in vista delle nuove migrazioni nelle metropoli dei paesi in
via di sviluppo, la nozione si è poi ampliata con lo sviluppo di piccole attività e
mestieri che erano al margine dell’economia ufficiale.
Sinteticamente, le caratteristiche di tale settore sono costituite dalla produzione su
scala ridotta e da materiali e manodopera locali spesso legate allo sfruttamento
familiare, quindi dall’assenza di meccanismi concorrenziali di mercato. Essendo
59
M. Diatta, Dynamique de formalization du secteur informal senegalais, Universitè Gaston Berger
de Saint Louis, Saint Louis, 2007, p. 35, (traduz. mia)
88 dominato dal terziario organizzato in piccole e micro imprese (soprattutto nel
commerciale), un elemento fondamentale è costituito dall’adattamento tecnologico
della manodopera, o meglio, dal “bricolage” o “arte d’arrangiarsi”.
L’informale sfugge al controllo razionale economico a causa della repulsione dello
stesso per discipline come la statistica; dal punto di vista giuridico esso è infatti
spesso sinonimo di illegalità.
I primi studi sull’economia informale propongono le ricostruzioni dei cicli di vita e
delle strategie di sopravvivenza di particolari gruppi sociali, sottolineando gli aspetti
dinamici, come la creatività, propri degli uomini e delle donne che sopravvivono
nell’informalità. Si trattava di studi empirici che frequentemente descrivevano
transazioni economiche regolate non dal mercato, ma dalla reciprocità (il modello di
integrazione economica proposto da Polanyi) e che avvenivano in situazioni di totale
esclusione dai processi di sviluppo economico. Questi elementi empirici hanno
favorito lo sconfinamento in discipline non economiche per cercare d’interpretare
meglio il fenomeno.
La scuola strutturalista in particolare ha concentrato l’attenzione su specifiche
attività, quali quelle volte alla sussistenza, evidenziando la capacità di arrangiarsi
delle persone che svolgevano tali attività e l’importanza dei rapporti di reciprocità
per garantire il buon esito delle transazioni economiche. In questo senso l’informale
è essenzialmente visto come alternativa, apparendo più come una manifestazione di
contro-cultura e di rifiuto dello sviluppo economico imposto fino ad allora. Fra i
maggiori esponenti di questa corrente si ritrovano Alain Caillé e Serge Latouche.
L’idea di ricercare forme alternative di economia (e di società) nell’ambito
dell’informalità, nasce dal dibattito sulla questione se considerare o meno l’economia
informale un segmento sfruttato dalla (o, più semplicemente, funzionale alla)
economia di mercato. In tale dibattito assumono un peso rilevante le argomentazioni
sostenute da Serge Latouche, creatore dell’immagine di successo dei “naufraghi dello
sviluppo” e fra i principali assertori del fatto che l’economia informale possa
rappresentare un modello di economia alternativo a quello capitalista.
89 Quello che infatti si definisce “il fallimento dell’Africa ufficiale” (cioè del progetto
modernizzatore europeo) consiste essenzialmente nel rifiuto delle società indigene di
assorbire le nuove istituzioni economiche. Ciò che resta quindi è un modo di
sopravvivenza “informale” che si esprime con le trame del bricolage.
Le forme più sorprendenti della sintesi della modernità inaccessibile e della
tradizione perduta, si trovano in quelle bidonvilles nelle quali gli esclusi si inventano
una nuova cultura con il suo immaginario (il profetismo), la sua struttura sociale
(rapporti neo-clanici), la sua economia (l’informale).
Latouche individua quattro stadi di economia informale: i traffici, il subappalto,
l’economia popolare e l’arte di arrangiarsi domestica e neo-classica. I traffici
comprendono tutto l’import-export praticato ai margini della legalità. Se il
subappalto non ufficiale mostra la sua natura dura e cruda, l’economia popolare è
costituita da un vivaio di piccoli imprenditori dai piedi nudi che si arrangia come
può. Infine l’ultimo stadio consiste nei modi escogitati dai naufraghi dello sviluppo
per produrre e riprodurre la loro vita servendosi delle strategie relazionali. La città
popolare reinventata dagli esclusi è un luogo di agricoltura e allevamento urbani,
oltre che un centro di produzione e di scambio di beni artigianali60.
Con l’informale non siamo più in un’economia, ma in un’altra società. L’economico
non gode di una propria autonomia, giacché è dissolto, incastrato nel sociale, in
particolare nelle complesse reti che strutturano le periferie.
Latouche sostiene che ai margini di un’Africa derelitta ci sua un’ “altra Africa”,
magari non in perfetta salute, ma assolutamente viva, creativa e dinamica. L’Africa
dei “naufraghi dello sviluppo”, degli esiliati dell’economia mondiale e degli esclusi
dal senso dominante. Qui il bricolage si interpone tra dono e mercato, tra culti
sincretici e mondializzazione dell’economia.
60
S. Latouche, Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana, Edizioni Dedalo, Bari, 2009, p.
103
90 Un’informale quindi, che si pone come una vasta impresa di recupero degli scarti
della grande società. Tuttavia, tali scarti sono riciclati per via della loro abbondanza e
del loro costo zero; la produzione industriale è utilizzata perché c’è. Essa non
costituisce affatto un elemento indispensabile del dispositivo perché questo è sociale
e non tecnico. Gli scarti mancanti possono essere sostituiti da una produzione
equivalente.
La società informale mira all’effettivo, non all’efficienza. Mira a un risultato
soddisfacente
in
condizioni
accettabili;
non
al
risultato
più
efficiente
indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. Si è ragionevoli senza essere
necessariamente razionali (vedremo la dote della“phronesis” più avanti). Le scelte
non sono effettuate in base a un calcolo cifrato sui soli elementi quantificabili, ma a
una ponderazione soggettiva delle molte dimensioni del problema61.
La “società vernacolare” di Latouche si basa su quello che si definisce capitale
sociale, cioè l’appartenenza ad organizzazioni e la rete di conoscenze sociali.
Gli attori di questa società sopravvivono all’esclusione perché hanno prodotto un
modello di società basata non sui rapporti economici, ma sul valore delle relazioni
sociali e sulla logica del dono.
Una società che pur non essendo completamente affrancata dal mercato, non
subisce la logica mercantile, cioè la ricerca del profitto che nel pensiero di Marx si
basa sull’inversione del rapporto di scambio Merce-Denaro-Merce (cioè la vendita
del surplus per soddisfare bisogni), nel rapporto Denaro-Merce-Denaro, cioè sulla
ricerca del guadagno dalla compravendita. La detenzione di prodotti fisici senza
portata strumentale non ha alcun senso oltre una certa soglia. L’accumulazione di
attrezzature destinate alla produzione di altri beni ha un senso, quella delle merci no.
L’approccio degli africani alla tecnica è concepito non come una categoria,ma come
un’azione che fa parte di un rituale (scolpire,tagliare, ecc). Non c’è una
61
S. Latouche, Il pianeta dei naufraghi, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 126
91 automizzazione della tecnica, per la stessa ragione per cui l’economia è incorporata
(nella socialità).
Un aspetto molto importante, cui abbiamo già spesso accennato, che si intreccia
continuamente col settore informale, è costituito dall’adattamento tecnologico della
manodopera a ciò che si ha a disposizione: il bricolage.
Tale termine risulta molto importante anche grazie all’impiego proposto da LéviStrauss: esso è più una scienza primaria anziché primitiva, in cui chi esegue un
lavoro utilizza strumenti di fortuna, che non sono quelli tecnicamente adeguati,
utilizzati dall’uomo del mestiere:
“Il bricoleur esegue un gran numero di compiti differenziati, ma diversamente
dall’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie prime ed arnesi,
concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto: il
suo universo strumentale è chiuso; per lui la regola del gioco consiste
nell’adattarsi all’equipaggiamento di cui dispone, cioè ad un insieme via via
finito di arnesi e materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di
questo insieme non è in rapporto col progetto del momento, né d’altronde con
nessun progetto particolare, ma è il risultato contingente di tutte le occasioni
che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di conservarlo
con i residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti. L’insieme dei mezzi del
bricoleur non è quindi definibile in base ad un progetto: esso si definisce
solamente in base alla sua strumentalità”62
Ai fini della nostra analisi, informale e bricolage, sono in Africa Occidentale gli
spazi ove maggiormente si concentra la gestione dei rifiuti, vista la quasi assenza di
una gestione pubblica.
La posizione di Latouche è che se fosse vero che la crescita produce
meccanicamente il benessere, oggi tutti vivremmo in un paradiso. Invece tale crescita
vertiginosa si basa sul prelievo di fonti energetiche fossili, risorse non rinnovabili,
rifiuti ed inquinamento. Tale “totalitarismo produttivista” ha generato una crescita
che
62
supera
l’impronta
ecologica
sostenibile,
corrispondente
cioè
ad
un
C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio,op. cit., p. 30
92 sovraconsumo, cioè un livello di produzione che supera il livello che permetta il
soddisfacimento dei bisogni ragionevoli di tutti.
Criticando il concetto di sviluppo, concetto “etnocentrico ed etnocida, che si è
imposto tramite la seduzione combinata con la violenza della colonizzazione e
dell’imperialismo attraverso un vero e proprio stupro dell’immaginario”, Latouche
include in esso il paradigma della sostenibilità che “con la crisi economica è
divenuto il cuore di un New deal ecologico che permette il rilancio di un capitalismo
rifondato, etico e responsabile, drogato con gli ormoni dell’ecobusiness”63.
La “società dei consumi”64 descritta da Latouche, si basa su tre pilastri: la pubblicità
(che crea l’instancabile desiderio di consumare), il credito (che ne fornisce i mezzi) e
l’obsolescenza programmata, che assicura il rinnovamento obbligato della
domanda65.
“La società cosiddetta sviluppata si basa sulla produzione massiccia di
decadenza, cioè su una perdita di valore e un degrado generalizzato sia delle
merci, che l’accelerazione dell’usa e getta trasforma in rifiuti, sia degli
uomini, esclusi e licenziati dopo l’uso”66.
Un degrado materiale quindi cui corrisponde la derelizione dell’uomo: gli esclusi, i
licenziati, gli emarginati, i disoccupati, senza tetto barboni ed altri “rifiuti” umani.
Su questa scia Latouche propone una società della Decrescita, che così come si
impegna nel riciclaggio dei materiali, deve anche interessarsi alla riabilitazione degli
esclusi e dei falliti. “Se il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto, il miglior
fallito è quello che la società non genera”67.
La prospettiva di Latouche vede l’Africa come il luogo dove poter rinnovare
una promessa di sostenibilità che le precedenti rivoluzioni industriali hanno fallito
fondata sulla sostenibilità della produzione e sul settore informale. L’Africa perché,
63
S. Latouche, Come si esce dalla società dei consumi, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 49
Ibidem
65
Cfr., S. Latouche, Come si esce dalla società dei consumi, op. cit.
66
Ivi, p. 69
67
Ivi, p. 70
64
93 nonostante il degrado, essa costituisce il modello de-occidentalizzato e deindustrializzato, dove ancora riecheggiano le logiche comunitarie.
Nel proporre il continente nero come laboratorio del postsviluppo, Latouche mette
l’accento su quello che definisce “il regno dei debrouillards: gente sveglia, che se la
sa cavare, attori dell’economia sotterranea, che reinventa utensili d’ogni tipo con
rottami e rifiuti”68. L’arrangiarsi è un’arte con cui già da tempo il Terzo Mondo, e in
particolare l’Africa nera, reagisce al fallimento dello sviluppo. Una realtà multiforme
che va dal traffico di droga alle strategie domestiche di sopravvivenza.
Analizzando la società neo-clanica o vernacolare di Grand Yoff (su sui nella seconda
parte ci soffermeremo anche noi), un sobborgo di Dakar, Latouche mostra come
attraverso l’autoproduzione, centomila persone riescano a tenere un buon tenore di
vita senza cerare moneta, ma grazie alla densità delle reti sociali (neoclaniche
appunto).
“Lo stato di esclusione a cui la grande società condanna le masse delle periferie
africane distrugge e nega qualsiasi significato visibile alla loro esistenza”69. I
“naufraghi dello sviluppo” grazie al talento nell’arte di arrangiarsi, riescono a
condurre una vita a margine, reinventando il legame sociale.
Presso i Serer e i Wolof del Senegal, le reti urbane sono calcate sul sistema di
lignaggio. Ogni individuo partecipa a varie di queste reti. Questa autoorganizzazione permette di affrontare i mille problemi della vita quotidiane in una
bidonville o in un quartiere popolare, dallo smaltimento dei rifiuti domestici e dal
funzionamento delle fogne fino alla sepoltura dei morti passando per i collegamenti
clandestini di acqua e elettricità70.
L’incorporazione dell’economico nel sociale si ritrova nella organizzazione della
produzione, nella utilizzazione delle risorse e nel modo di approvvigionamento.
68
S. Latouche, Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana, op. cit., p. 30
Ivi, p. 44
70
S. Latouche, Il pianeta dei naufraghi, op. cit., p. 113
69
94 Il denaro (“xalis” in lingua wolof) è onnipresente nella realtà e nell’immaginario di
questo mondo informale, ma il,suo significato come il suo uso sono radicalmente
diversi rispetto al nostro. Nella grande società il denaro, equivalente generale, è un
astrazione:è la moneta. Nelle periferie popolari africane, invece il denaro è concreto
e tangibile, assume forme arcaiche che denotano un rango71.
Al di là di tutta l’ingegnosità dei collegati (gli attori di questo mondo informale fatto
di reti), è chiaro che la società vernacolare non vive in autarchia, non riuscendo a
produrre tutto ciò di cui ha bisogno. In primis il cibo che nelle periferie urbane è
prodotto solo parzialmente sul posto.
Nel quartiere di Pikine, a est di Dakar, la metà delle necessità sono coperte dalla
produzione locale contadina e artigianale, il resto è diviso equamente tra settore
capitalista e importazione. A ogni modo, non tutti i beni posso essere prodotti in
loco: gli abiti usasti, gli strumenti radio elettronici e molti materiali devono essere
importati, come pure la benzina, i medicinali occidentali e l’ educazione
internazionale. Una gran parte non trascurabile di tali importazioni obbedisce ancora
alla logica del dono e delle reti.
Eppure, la popolazione di Grand Yoff vive a margine dell’economia ufficiale come
vive a margine dello Stato.
Sul piano urbanistico tale quartiere rappresenta bene le nicchie urbane periferiche
dell’informale, nei paesi del Sud. Non si tratta di bidonville in senso stretto ma di un
habitat popolare auto-costruito su parcelle occupate (concessioni), dotato di un certo
confort, rispondente a norme urbanistiche equivalenti a quelle dei quartieri
circostanti. La vera bidonville, raffazzonata e “bricolata”esiste a Dakar come in molti
paesi del Sud, ma si trova piuttosto sparsa nelle maglie del tessuto urbano72.
71
72
Ibidem
Ivi, pp. 170-171
95 La lezione dell’ “altra Africa” nella costruzione di un’alternativa al delirio tecnoeconomico consiste nel dimostrare la sua capacità di sopravvivenza attraverso le
strategie relazionali fondate sullo spirito del dono73.
“Senza scalpore e senza proclami, gli informali di Grand Yoff mettono in
campo il principio di sussidiarietà del lavoro e della produzione. In altre
parole, il livello locale deve essere privilegiato in nome del sociale nella più
ampia misura ragionevole”74.
Di fronte alla evidenza dei successi di certi “imprenditori a piedi scalzi” si
riconoscerà il trionfo del bricolage. Tuttavia si vedrà sempre in questo informale
un’economia precaria, fatta di espedienti in mancanza di meglio.
Sul piano tecno-economico la produzione, la distribuzione e il consumo sono quasi
integralmente incastrati in questa nuova socialità neo-clanica. Il bricolage e l’arte di
arrangiarsi possono spingersi fino ad un’endogenesi tecnologica.
“In tale contesto si è ingegnosi senza essere ingegneri,intraprendenti senza
essere imprenditori, industriosi senza essere industriali. Irriducibile, nelle sue
logiche, nei comportamenti e nelle forme di organizzazione al capitalismo
tradizionale e alla società tecnologica, la nebulosa informale dimostra
un’estrema efficacia nel riciclare gli scarti della modernità e nell’accogliere le
sfide sollevate da un stato di esclusione”75.
Un altro elemento che Latouche contrappone alla razionalità occidentale è la
ragionevolezza, che non è altro che la phronesis aristotelica (prudenza). Essa
concerne in primo luogo la sfera delle azioni utili alla conservazione della società.
L’uomo prudente possiede tale capacità pratica ed è perciò capace di deliberare
correttamente su ciò che è buono e vantaggioso per lui, tenendo conto della
complessità della situazione e della pluralità dei mondi.
73
Ivi, p. 51
S. Latouche, Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana, op. cit., p. 51
75
Ivi, p. 99
74
96 La phronesis infine non è la ricerca del successo a tutti i costi, né pura tecnica. La
ricerca del bene è sempre tenuta in considerazione ed è qui che, secondo Latouche,
l’Africa è in grado di offrire la sua assistenza tecnica76.
Questa organizzazione basata sulla capacità di arrangiarsi, sul bricolage appunto,
degli esclusi della modernità, costituisce un esempio di costruzione di società
autonoma e sostenibile in condizioni infinitamente più precarie di quelle in cui si
troverebbero le società della decrescita del nord, senza dover nulla o quasi alle élites
intellettuali e politiche del continente.
La capacità di sopravvivere, di costruire una vita completa ben al di fuori
della società mondiale di mercato, si basa su tre “arrangiamenti”: il livello
dell’immaginario, con la proliferazione di culti sincretici e di sette (comprese le
confraternite e le loro sudditanze), il livello tecno-economico, con un ingegnosa e
intraprendente attività di riutilizzo e, soprattutto, il livello sociale, con l’invenzione
di un legame “neo-clanico”77.
Questa società dei naufraghi che si costruisce ai margini dell’economia mondiale e
del sistema politico nazional-statale è in una certa misura una “società contro lo
stato” così come è una “società contro l’economia”.
Rispetto alla gestione dei rifiuti, se da un lato abbiamo visto che essa è assorbita nel
sociale, dall’altro il bricolage, in quanto tecnica di adattamento, permette un ciclo del
riuso e di reimpiego dei materiali che, oltre a combattere l’obsolescenza e la scarsa
qualità del mondo delle cose di cui dispone, funge da deterrente per gli scarti che
l’Occidente gli riversa addosso sotto forma di aiuto.
Tuttavia se sino ad ora abbiamo considerato bricolage, capacità di adattamento tecno
economico, strategie di sopravvivenza, ecc, come capacità di affrancamento dalle
trame del dominio economico occidentale, riteniamo opportuno muovere una critica
a tale approccio che si oppone alle teorie del “consumo sovversivo” esposte
76
77
Ivi, p. 85
Ivi, pp. 58–59
97 precedentemente, e che considera l’ ”adattamento” subordinato ad un rapporto di
“subordinazione materiale”.
La scuola di Birmingham, nell’area dei Cultural Studies, ha indagato su quale sia il
ruolo esercitato dall’individuo che consuma all’interno della cultura di massa. Come
abbiamo visto, secondo la prospettiva adottata da questa scuola, il consumatore non è
più un soggetto passivo, ma attivo e costruttore di senso (rispetto ai prodotti che
consuma). Esso è un soggetto creativo, che rielabora i propri fini attraverso una
vasta gamma di pratiche quotidiane.
L’impostazione teorica della Scuola di Birmingham, trova fondamento nel
concetto di egemonia culturale di Gramsci, secondo cui la cultura popolare è in grado
di esercitare un ruolo paragonabile a quello della cultura delle classi dominanti ed è
addirittura in grado di lottare efficacemente con quest’ultima per il controllo
dell’egemonia culturale.
Ciò che però a noi qui interessa è la critica radicale mossa alla “tattica” del
bricolage.
Il punto di partenza è l’analisi portata avanti da Lévi-Strauss sul “pensiero
selvaggio”, nella misura in cui quest’ultimo “scompone e ricompone insiemi d’eventi
servendosene per costruire delle strutture”. Il modus operandi del bricoleur
“è inizialmente retrospettivo: egli deve rivolgersi verso un insieme già
costituito di utensili e di materiali, farne o rifarne l’inventario, e infine,
soprattutto, impegnare con esso una sorta di dialogo per inventare, prima di
sceglierne una, tutte le risposte che l’insieme può offrire al problema che gli
viene posto. Egli interroga tutti quegli oggetti eterocliti che costituiscono il suo
tesoro, per comprendere ciò che ognuno di essi potrebbe “significare”,
contribuendo così alla definizione di un insieme da realizzare che alla fine,
però, non differirà dall’insieme strumentale se non per la disposizione interna
delle parti”78.
Un bricolage, quindi, che si oppone per contrasto all’uso occidentale del termine (in
cui esso è un’attività di hobby o divertimento, saltuaria ed occasionale),
78
C. Lévi- Strauss, Il pensiero selvaggio, op. cit., p. 31
98 caratterizzato da un armamentario di fortuna, ridotto e di seconda mano, obbligato ad
arrangiarsi non con ciò che può scegliere, ma con ciò che gli viene “concesso” in via
subordinata dall’parco strumentale dominante.
Per Gramsci la cultura subalterna è tale proprio in quanto manca di coscienza di
classe; è cultura di classi che non sono ancora coscienti di sé. Infatti Gramsci mette
in rilievo come essa sia eterogenea, come in essa conviva l’influenza della classe
dominante, detriti di cultura e civiltà precedenti, insieme a suggestioni che
provengono dalla condizioni della classe oppressa. L’attenzione del pensatore sardo è
puntata sull’egemonia, ma non nel modo aristocratico di chi vede soltanto la cultura
egemone e trascura la cultura delle classi subalterne.
Ciò riconduce al concetto di bricolage proposto da Levi-Strauss, nella misura in cui il
modo di procedere culturale delle classi subalterne è quello del bricolage:
“l’assumere elementi della cultura dominante per rielaborarli, connetterli in modo
diverso sino a far loro assumere diverso ed anche opposto significato, restando
tuttavia sul terreno indicato dalla cultura egemone”79.
Non produzione autonoma, fondazione di nuovi temi e di nuove forme di cultura, ma
rielaborazione non omogenea; né critica e consapevole dei temi e dei materiali offerti
dalla classe dominante. Secondo Gruppi è questa l’interpretazione esatta dell’analisi
che Gramsci ci da dell’attività di bricolage in seno alla cultura popolare.
79
L. Gruppi, Il concetto di egemonia in Gramsci, Ed. Riuniti, Roma, 1972, p. 114
99 CAPITOLO III
I RIFIUTI IN CASAMANCE: TRA EMERGENZA E RETAGGI
PRIMORDIALI
Lo studio di caso da me considerato, si riferisce ad una esperienza di ricerca svolta
nella regione della Casamance, nel sud del Senegal. L’indagine si concentra sulla
gestione dei rifiuti nella suddetta regione, rivolgendosi agli attori che in essa
intervengono: attori formali appartenenti ad apparati burocratico-amministrativi,
attori informali ed attori dello sviluppo.
Ci siamo rivolti a “testimoni chiave”, relativamente al ruolo che essi giocano
nell’ambito della ricerca empirica:
“si tratta di persone che offrono utili conoscenze di carattere generale sulla
situazione locale in cui si realizza lo studio. Spesso possono aiutare il
ricercatore nell’ottenimento della cooperazione, di altri soggetti, individuando
o contattando intervistati”1.
Un’altra classe di intervistati cui ci siamo rivolti è quella del “testimone
privilegiato”, una persona che cioè dà informazioni “specialistiche”, cioè
direttamente rilevanti per gli obiettivi dello studio, scelta sulla base della sua
posizione strategica nella comunità, gruppo o istituzione oggetto di studio2.
Grazie all’osservazione partecipante, infine, abbiamo potuto constatare quali siano le
pratiche di gestione, sia domestiche che pubbliche, quale è la composizione
approssimativa dei rifiuti in base ai quartieri, e altre particolarità che concernono
questa pratica.
Tuttavia, in via preliminare, sarà utile presentare un quadro socio-politico
introduttivo sul Senegal, seguito da un focus sulla emblematica e paradigmatica
condizione della capitale Dakar.
1
G. Gianturco, L’intervista qualitativa. Dal discorso al testo scritto, Guerini scientifica, Milano,
2005, pp.69-70
2
Ibidem
100 3.1 IL SENEGAL CONTEMPORANEO
Momar Coumba Diop, nel libro “La construction de l’ètat au Senegal”
3
( La
costruzione dello stato in Senegal) analizza in maniera molto efficace quello che
definisce il “modello islamo-wolof”, un modello di dominazione socio-culturale
incardinato sulla figura del Maraboutto (nell'Africa sub-sahariana, un Marabutto è un
personaggio religioso cui si attribuisce la santità, e, di conseguenza, molteplici
poteri).
Nelle confraternite del Senegal, i marabutti si sono dati un'elaborata organizzazione
gerarchica. Per esempio, il marabutto di rango più elevato della confraternita
dei Muridi4, è considerato un vero califfo e dispone di estesi poteri, ma gode anche di
un prestigio di santo vivente e di una venerazione che peraltro poco si concilia con
l'islam ortodosso. Le procedure di tale modello composto da sincretismi etnicoreligiosi investono l’organizzazione sociale e politica, i modi di appropriazione come
le forme di dominazione ed ineguaglianza introdotte
sin dai tempi dello Stato
Coloniale.
Il modello islamo-wolof è altresì centrale nella costruzione dello stato post-coloniale,
e da tale centralità ne deriva anche la molteplicità e complessità di relazioni tra stato
e confraternite.
Da un punto di vista ideologico, Diop sostiene che il processo di costruzione
dello stato senegalese abbia risentito, e continui a risentirne, dell’ “Egemonia Wolof”
manifestata attraverso la produzione narrativa (si pensi alla lingua Wolof come
lingua urbana egemonica) e le pratiche sociali costruite negli spazi pubblici.
All’inizio degli anni Ottanta, sotto la neopresidenza del successore di Senghor,
Abdou Diouf, si assiste ad esempio ad una appropriazione identitaria degli spazi
avvenuta in maniera esclusiva, aggressiva e discriminatoria. Tale sistema ideologico
sarebbe lo stesso protagonista della costruzione della democrazia liberale senegalese
e della relativa stabilità e semi-democrazia che ne deriva.
3
Cfr., M. Coumba Diop, D. Gruise O’Brien, M. Diouf, La construction de l’ètat au Senegal,
Karthala, Parigi, 2002
4
I Muridi appartengono all’ordine islamico-sufi. Il sistema delle confraternite sufi è particolarmente
sviluppato in Senegal, dove gran parte della popolazione musulmana appartiene a tre confraternite; tra
queste, quella dei Muridi riunisce circa un terzo dei senegalesi, principalmente di etnia wolof.
101 Storicamente per quanto riguarda invece il contributo islamico al modello, le
confraternite Sufi si sono prestate alle forze coloniali per assicurare certe missioni
(esazione tasse, ecc) in cambio del riconoscimento politico. A tale proposito l’istituto
dello “ndigel” rappresentava, maggiormente sino alla fine degli anni Ottanta, la
prescrizione per i devoti a votare per un candidato sostenuto dai capi spirituali, dai
Marabutti appunto. Una sorta di mediazione tra colonialismo e popolo. Figura chiave
in queste relazioni prescrittive è anche quella del Talibe: lo studente islamico
seguace del Marabutto e ad esso fedele, poiché crede più in esso che nel governo.
Nel binomio protezione-ossessione gli uomini di religione offrono ad i discepoli
soprattutto protezione contro lo stato (tale legittimità sociologia trovò durante la
presidenza di Senghor i suoi migliori giorni grazie al “contratto clientelista”).
Le problematiche nelle relazioni tra stato e società africane eterogenee vanno
quindi interpretate radicalmente alla luce della mancata “legittimità sociologica” che
si trova alla base dello stato, sostiene Diop. Tale vuoto è stato riempito dalle
confraternite sufi grazie alla fiducia che i discepoli hanno riposto nella loro guida
spirituale, titolare del “contratto” con lo stato. L’incompatibilità tra gli interessi dei
due poteri, cioè tra progetto modernizzatore della democrazia liberale e
mantenimento conservatore della tradizione islamica, trova convergenza nel progetto
di restare al potere e mantenere l’egemonia. E’ tuttavia inevitabile una sorta di
distorsione dei meccanismi di identificazione etnica: per ben spiegarne la
stratificazione e le rispettive caratteristiche professionali ed attitudinali, Diop cita una
testimonianza di un suo informatore: “Chi è un Peul? Un nomade che porta al
pascolo le vacche. Se questi vende le sue vacche diventa un Toucouleur. Se poi si
serve dei soldi per andare in città a vendere tessuti, questi diviene Wolof”5 .
“La struttura fondamentale del contratto sociale senegalese è mantenuta, soprattutto
nel campo della produzione economica, dalla sottomissione sociale e dall’arroganza
politica” 6dice Diop. Tale contratto ha visto la sua base materiale erodersi
parallelamente al declino dell’economia dell’arachide (dal punto di vista economico
il monopolio industriale senegalese è concentrato sulla coltivazione dell’arachide, di
5
M. Coumba Diop, D. Gruise O’Brien, M. Diouf, La construction de l’ètat au Senegal, op. cit., p.
138 (traduz. mia)
6
Ivi, p. 11 (traduz. mia)
102 cui gli Wolof sono specialisti), che un tempo era il settore trainante dell’intera
economia nazionale, sostituita progressivamente da una diaspora internazionale di
piccoli commercianti.
Subito dopo l’indipendenza i marabutti riuscirono a conservare il loro status quo
grazie alla spalla prestata all’ideologia sviluppista, unita ad una incessante
esaltazione del lavoro. All’inizio degli anni Sessanta i marabutti controllavano la
quasi totalità di produzione di arachidi, grazie all’ideologia cooperativista sviluppata
da Senghor come modello d’accesso al socialismo e, tuttavia, all’interno del quale
non mancarono di svilupparsi massivamente corruzione e clientelismo. Ne seguì
stagnazione economica ed una riduzione sensibile della partecipazione dello stato a
tale economia, grazie anche alla “polverizzazione delle pretese socialiste”7 sotto la
presidenza Diouf.
Lo spropositato arricchimento dei Marabutti (in cambio del sostegno
elettorale al mondo della politica), quindi, insieme all’uscita progressiva dei
mauritani dall’economia dell’arachide , hanno favorito la disgiunzione del patto
politico-religioso. Questa mutazione, nota Diop, si è accompagnata all’interno delle
dinamiche metropolitane ad una degradazione ambientale, quindi sociale, educativa e
sanitaria che è sfociata nei moti di fine anni Ottanta. Nella prima metà degli anni
Ottanta l’applicazione delle riforme di aggiustamento strutturale imposte dal
Washington Consensus provocarono inoltre instabilità sociale, tecnocrazia e
dissidenza. Il 1988 fu un anno caldo a causa della crisi economica e sociale e dei
movimenti di protesta portati avanti con vigore da studenti e lavoratori (il fenomeno
del Set setal di cui parleremo più avanti si inserisce in questo quadro d’instabilità
generalizzata).
Tornando alla crisi dell’arachide, la serie di siccità che si alternarono tra la
fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta causarono una
diminuzione della superficie di terra coltivabile che spinse le popolazioni rurali verso
le città. L’urbanesimo in questione provocò una reazione violenta dei poteri pubblici
al fenomeno causato dalla crisi dell’arachide (il prezzo inoltre scese del 25% a causa
del mancato sostegno finanziario francese a tali prodotti) che si manifestò nell’
7
Ivi, p. 58 (traduz. mia)
103 “ideologia dell’esclusione” e degli “ingombramenti umani”8. Nella metà dei primi
anni Novanta si ultimò quindi il processo di privatizzazione massiccia e
liberalizzazioni in luogo al disimpegno dello stato dai mercati nazionali in forte crisi
finanziaria dopo la svalutazione del Franco CFA nel ’94.
Tuttavia la leadership regionale pretesa dal Senegal in Africa Occidentale è legata al
sostegno finanziario, contropartita di una dipendenza politica ed economica. Il ruolo
politico giocato dal Senegal in quest’area risulta perciò paradossale rispetto alle sue
potenzialità economiche e alla classificazione dei paesi secondo gli indicatori di
sviluppo utilizzati da certe istituzioni internazionali. La facilità di accesso ai
finanziamenti esterni spiega l’ampliarsi del sostegno politico esterno di cui il
governo di Dakar beneficia.
3.1.1 Dakar
La città di Dakar ha un tasso di urbanizzazione del 96,55%, ma presenta delle
disparità nella ripartizione della sua popolazione. Infatti, il dipartimento di Pikine,
che è il più popolato, contiene oltre il 50% della popolazione dell’intera regione di
Dakar. La capitale, conta oltre due milioni di abitanti, complessivamente il 54% della
popolazione dell’intero Senegal.
Tra il 30 ed il 40% della superficie urbanizzata di Dakar è avvenuta in maniera
illegale; a tale pratica corrisponde una speculare mancanza di servizi di base: la
degradazione del sistema di sanità pubblica, ad esempio, rinforza dei meccanismi
inegualitari.
Tale è l’eredità che l’impronta igienista del colonialismo ha lasciato alla città
africana, che si è quindi sviluppata in base ad un principio di “segregazione
spaziale”. Così tale segregazione imposta dall’igienismo coloniale si manifesta anche
in una gestione dei rifiuti discriminante. Invece di operare una rottura totale con tale
configurazione, le autorità pubbliche senegalesi hanno sviluppato delle politiche che
accentuano le “ineguaglianze di salubrità”9.
8
9
Cfr., M. Coumba Diop, D. Gruise O’Brien, M. Diouf, La construction de l’ètat au Senegal, op. cit.
C. Sarr, Les ordures ménagères dans les villes senegalais, Enda, Dakar, 2005, p. 18 (traduz. mia)
104 Per ben comprendere quindi il ruolo paradigmatico che la città di Dakar svolge come
“centro di diffusione del potere”, è utile riassumere il calvario della gestione dei
rifiuti a livello nazionale.
Essa può essere suddivisa in due modalità organizzative: quella informale e quella
formale (istituzionalizzata). L’organizzazione formale è divisa tra stato e partner non
istituzionali: il primo è rappresentato dai ministeri (ambiente, salute e territorio),
dalle collettività locali e dalle varie agenzie. Lo stato si presenta più come un
promotore e facilitatore che come un partecipante diretto. Il ministero dell’ambiente
esercita il controllo di conformità delle politiche ambientali. La Direzione nazionale
d’igiene attua le politiche sanitarie ed applica le disposizioni del codice d’igiene. Le
agenzie, che godono di autonomia finanziaria ed amministrativa, hanno il compito di
armonizzare e di concertare le disposizioni, oltre che di assistere le collettività locali.
I secondi sono rappresentati da gestori privati e dagli “operatori dello sviluppo”,
come le ONG. L’organizzazione informale è invece suddivisa tra popolazione ed
attori informali: la prima è composta da cittadini e comitati di quartiere, i secondi
sono rappresentati dai raccoglitori a domicilio con carri a traino e da quelli che in
lingua Wolof si chiamano “Boudiouman” (parola composta da “boudiuou” che in
Wolof indica l’atto di immergere le mani in un qualsiasi materiale), cioè chi vive di
rifiuti (chi vive nelle discariche alla ricerca di materiali ed oggetti riutilizzabili e
quindi rivendibili).
Momar
Coumba
Diop
nota
come
l’impennata
inarrestabile
della
disoccupazione, soprattutto giovanile, a partire dalla crisi finanziaria innescata dalla
svalutazione del Franco CFA, ha favorito in particolar modo il settore informale,
unica via per soddisfare i bisogni elementari. Il carattere che più si distingue
all’interno della società civile senegalese di fronte alla montante disoccupazione è il
“se débrouiller”, l’arte di cavarsela e di sbrigarsela da soli. “Per la maggior parte dei
giovani, “sbrigarsela” significa anche prendere coscienza, in maniera traumatica,
delle scelte e delle ambizioni dello stato post-coloniale”10.
In Senegal è indubbiamente il settore informale che produce più rifiuti, ed è
all’interno dello stesso che le attività di recupero si attuano. La sua espansione
10
M. Coumba Diop, D. Gruise O’Brien, M. Diouf, La construction de l’ètat au Senegal, op. cit., p.
127 (traduz. mia)
105 sviluppa un modo di consumo che favorisce l’accumulazione rapida dei rifiuti negli
spazi urbani. Un modo di consumo che si basa sulla parcellizzazione ed
atomizzazione dei prodotti: tutto è scomponibile e vendibile per unità, pena la
produzione di contenitori ed imballaggi in quantità smisurata (il sistema della
raccolta a traino delle immondizie, che possiamo definire una attività informale, è
una delle principali responsabili dell’agglomerazione anarchica dei rifiuti in vari
punti della città11. Abbiamo rilevato infatti, specificamente nella città di Ziguinchor,
anche se il fenomeno è riscontrabile in tutto il Senegal, l’accumulazione sistematica
di rifiuti in piena città, con la frequenza di almeno due depositi selvaggi per
quartiere. L’accumulazione è favorita sia dalle attività di raccolta a domicilio per
mezzo di traini animali (per chi si può permettere di pagare il servizio), sia dal
deposito occasionale delle singole famiglie.
Tuttavia l’economia informale della valorizzazione dei rifiuti solidi genera
impiego ed è potenzialmente vantaggiosa per il sistema della raccolta, del trasporto e
del riversamento in discarica dei rifiuti. Il giro d’affari che concerne il trasporto dei
rifiuti in discarica raggiunge l’ordine delle decine di milioni di franchi all’anno.
Secondo Mafadiou Diatta il 45% degli attori del settore informale hanno un’età
compresa tra i 30 ed i 44 anni. Oltre il 30% tra i 45 ed i 60anni. I settori d’attività
sono ripartiti come segue: il 45% è impiegato nel settore dell’abbigliamento, il 25%
in quello dell’alimentazione ed il 20% ferramenta12. Il potenziale di queste economie
risulta quindi poco valorizzato dalle autorità centrali, incaricate della gestione dei
rifiuti solidi urbani.
Di tale questione si è interessato nello specifico Oumar Cissé: il suo libro “L’argent
dés déchets” offre una interessante analisi sull'economia informale in Senegal, e in
particolare sulla questione del recupero dei rifiuti solidi. Esso fornisce, come risultato
di ricerca sul campo condotta presso la discarica di Mbeubeuss e altri siti a Dakar, un
attento studio degli agenti coinvolti in queste attività: collezionisti, commercianti,
grossisti, recuperatori e artigiani. L'autore prende in esame gli investimenti e il
reddito di coloro che sono coinvolti nel recupero dei rifiuti. Il libro evidenzia anche il
11
Cfr., A. G. Onibokun, A. J. Kumuyi, La gouvernance et la gestion des dechets en Afrique , in La
gestion des dechets urbains. Des solutions pour l’Afrique, Crdi-Karthala, Dakar, 2002
12
Cfr., M. Diatta, Dynamique de formalization du secteur informal senegalais, Universitè Gaston
Berger de Saint Louis, Saint Louis, 2007
106 processo di differenziazione sul posto di lavoro tra i collettori (stanziali e itineranti),
commercianti, artigiani e collezionisti grossisti. Tale contributo è per noi rilevante
anche per la rilevanza posta dall’autore sulle questioni di sanità pubblica ma,
soprattutto, sulla percezione sociale degli attori coinvolti in questo settore.
Per quanto riguarda la gestione formale, a partire dagli anni Cinquanta, sono state
sperimentate differenti vie: dal pubblico al privato, alla loro reciproca commistione
sino alla privatizzazione totale.
Negli anni Settanta la SODAIP, una società privata, gestisce il settore sino
alla prima metà degli anni Ottanta, quando il Comune riprende la gestione.
Successivamente lo Stato appoggia e monitora le attività della subentrata SIAS
(società industriale per la gestione urbana del Senegal) che, negli anni Novanta,
avvia anche il servizio di pulizia delle strade. Le comunità urbane della città tuttavia
causeranno la sostituzione anche di questa società contestando il monopolio che
questa aveva costruito. Segue un periodo in cui si alternano diverse imprese e
consorzi (come quello senegalo-canadese), e gruppi di sensibilizzazione. Il Servizio
nazionale d’igiene è anche in questi anni coinvolto, mediante l’esercizio delle
funzioni di controllo e sicurezza.
Se nel 1986 la città di Dakar produceva circa 780 tonnellate di rifiuti al
giorno, nel 2001 ne produceva più di 900. Secondo Cissè “la moltiplicazione delle
risorse di produzione di rifiuti, ha superato in molte città africane la capacità
istituzionale di gestione” 13. Verso la fine degli anni Novanta la gestione dei rifiuti è
stata caratterizzata da un dinamismo del settore privato che tuttavia si è dissolto
nell’esperienza della società romana AMA, della quale vale la pena accennare
almeno la vicenda.
Nel 2002 il Comune di Roma, per il tramite della propria azienda AMA decise,
tramite AMA International e la costituita AMA Senegal, di acquisire un appalto
venticinquennale per il recupero e smaltimento dei rifiuti di Dakar. L’iniziativa si e`
conclusa con un clamoroso “buco” che avrebbe superato i 10 milioni di euro. Nel
13
O. Cissè, L’argent des déchets, op. cit., p. 123 (traduz. mia)
107 frattempo i 1.600 dipendenti senegalesi della società sono stati licenziati; dopo un
primo periodo di operatività, peraltro con una grande massa di assunzioni di
dipendenti con mansioni manuali, ma con pochissimi mezzi tecnici (molti mezzi
meccanici risultavano arrivare “nuovi” in Senegal per capitolato dall’Italia, ma in
realtà avevano già operato per anche 20 anni sulle strade romane), la società si
avviava allo sfascio anche a causa dell’arrivo di faccendieri e strani personaggi locali
che intrecciavano affari in proprio.
In una incredibile serie di vicende venivano addirittura acquistati 25
automezzi per la raccolta dei rifiuti, del tutto inadatti alle necessità, visto che la
nettezza urbana era raccolta a mezzo di cassonetti, e questi veicoli non avevano
l’attrezzatura per scaricarli. Una parte di essi non è mai stata utilizzata; immagini
televisive hanno mostrato dipendenti AMA che, immersi sino alla vita
dall’immondizia, in una Dakar traboccante di maleodoranti rifiuti accumulati per le
strade, raccoglievano con le mani l’immondizia dai marciapiedi; tutto ciò ha portato
il governo senegalese nell’ottobre 2005 a disdettare il contratto con AMA Senegal
per gravi inadempienze contrattuali e ad iniziare una lunga trattativa poiché l’AMA
aveva assicurato il contratto con la Banca Mondiale, che minacciava quindi di
rivalersi comunque sul governo senegalese, diminuendo dell’importo assicurato gli
aiuti internazionali previsti per quel paese; il contratto è stato definitivamente
disdetto nel settembre 2006, dopo che a Dakar si è venuta a creare una situazione
catastrofica: la città è stata per un lungo periodo coperta dai rifiuti che hanno anche
favorito una epidemia di colera.
Diverse centinaia di ex dipendenti AMA sono tutt’ora senza lavoro perché
non riassorbiti dalla nuova società francese cui è stata affidata la gestione
dell’emergenza rifiuti.14
Nel 2000 viene creata l’APRODAK (“Agence pour la propretè de Dakar”), che è
per il 60% posseduta dallo stato, per il 10% dalle collettività locali e il restante 30%
tra concessionari, lavoratori e privati: essa assicura il coordinamento, il controllo e la
14
Camera dei Deputati XV Legislatura, Atti Parlamentari – 4766, Allegato B ai resoconti, Seduta del
26 Marzo, 2007
108 messa ad opera delle azioni di pulizia urbana, di raccolta, di trasporto e di
trattamento dei rifiuti solidi negli agglomerati urbani della regione di Dakar.
Per questa ragione, essa è in rapporto con i diversi organismi statali e con gli
operatori privati che intervengono in questo campo. Essa dovrebbe sensibilizzare ed
informare la popolazione, commissionare studi e ricerche in questo settore e infine
imporre sanzioni amministrative ai concessionari o trasgressori. L’APRODAK ha
poi creato il sistema delle riserve per far fronte alle frequenti difficoltà (almeno nove
imprese sono coinvolte nelle funzioni di gestione, raccolta, trasporto, valorizzazione,
ecc).
Tuttavia la frantumazione del sistema di gestione e le conseguenze socio-economiche
di quarant’anni di gestione altalenante, hanno causato una instabilità permanente. In
un articolo sul quotidiano “Le soleil”15 Boubacar Sané spiega come la
liberalizzazione del settore della gestione dei rifiuti non abbia fatto che creare una
corsa sfrenata al profitto da parte degli operatori privati coinvolti, compromettendo
una coscienziosa gestione da parte dei cittadini.
E’ utile riportare una breve analisi su un quartiere di Dakar, Yoff,(di cui abbiamo già
parlato nel secondo capitolo) situato a nord-ovest della capitale. Esso fa parte del
distretto di Almadies ed era in origine un piccolo villaggio di pescatori Lebu. Esso
gode di un’autonomia particolare, non c’è polizia del governo centrale ed ha anche il
più basso tasso di criminalità dei comuni di Dakar. Yoff è anche uno dei porti di
pesca tradizionale più importanti del Senegal. Tale attività è alla base dell’ economia
del quartiere. L’amministrazione e l’industria svolgono soltanto un ruolo secondario
nell’attività economica.
L’organizzazione socio-politica degli spazi e dell’habitat vede una
distribuzione spaziale molto precisa ed una assunzione comune delle responsabilità.
Il modo di vita del quartiere di Yoff, basato sulle “concessioni” demaniali, permette
una vita associata in cui la responsabilità degli spazi pubblici è comune.
I seguenti, sono gli elementi principali del modello abitativo locale: più concessioni
sono raggruppate in carrè (quadrati demaniali); il penc, in lingua wolof, è lo spazio
comune a tutte le concessioni dello stesso quartiere. Esso è più uno spazio di
15
B. Bachì Sanè, La gestion des dechets solides urbane, la moltiplication des intervention constitue
un handicap, Le Soleil, Dakar, 26 ottobre 2007
109 discussione e confronto, sul modello della palabre. L’eutt è lo spazio comune delle
famiglie fondatrici della concessione; il wanak è invece un disimpegno che preserva
una certa intimità all’interno delle concessioni (una sorta di cortile); esso deve essere
pulito ogni giorno. I seunes sono invece degli spazi comunitari per il deposito dei
rifiuti, che si stanno perdendo con l’espansione dei villaggi.
Il prestigio del capo della comunità (djaraaf) è, in questo senso, per quanto
riguarda la nostra analisi, legato anche alla gestione dei rifiuti: se una delle sue donne
è negligente con la pulizia del wanak, ciò influirà sulla sua aurea e sul suo carisma.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, lo spazio antistante all’abitazione è
considerato come un prolungamento del proprio spazio domestico ai fini della
collettività, la cui cura è necessaria proprio per questa ragione prioritaria.
Questo modo di vita sta venendo progressivamente rimpiazzato dal modo di vita per
appartamenti (portato con sé dall’urbanizzazione), in cui non ci si occupa più di
quello che accade intorno al proprio spazio domestico.
Barnwells nel suo studio sul cambiamento dei modelli d’abitazione a Yoff ha fatto un
paragone tra il contenuto dei rifiuti dei quartieri moderni e quelli dei villaggi
tradizionali16.
Quest’autore constata che, se si prendono in considerazione solo i rifiuti di
plastica, essi costituiscono più o meno la stessa quantità. Questo paragone serve a
farci ben comprendere che, all’interno delle dinamiche del modo di consumo, un
aumento dei consumi (così come macroscopicamente un aumento del PIL) non
implica necessariamente un miglioramento della qualità della vita. Anzi, spesso un
modo di consumo sfrenato è indice di un abbassamento della qualità della vita,
quando la composizione di questi consumi è costituita da elementi non sani.
Le analisi di Barnwells sul contenuto dei rifiuti nei quartieri più poveri rispetto a
quelli più ricchi, mostra che, per quanto riguarda i rifiuti composti da sabbia
contaminata e sporcizia varia in stato polveroso, nei quartieri più poveri essi sono
oltre il 50%, mentre nei quartieri più agiati essi sono sotto il 30%. Da questi due dati
16
Cfr., A. Barnwells, Les implications des changements du modele d’habitation sur la gestion des
dechets solide a Yoff, Enda-Rup, Senegal, 1998
110 emerge quello che Barnwells definisce il contrasto tra terra e mattone: cioè il
modello d’abitazione tradizionale in sabbia produce più scorie di quello basato sul
mattone.
Un dato più eloquente mostra invece la capacità dei quartieri poveri di
smaltire escrementi, sia umani che animali: oltre il 50% dei rifiuti nei quartieri
moderni è costituito da escrementi e resti alimentari, mentre nei quartieri poveri essi
sono poco più del 30% (la ragione è l’impiego degli stessi per la trasformazioni in
concimi o come mangime per allevamenti di maiali).
Ultimo dato interessante è la produzione di rifiuti in plastica: in entrambi i tipi di
quartieri la quantità di plastica si aggira intorno al 5%. Essa mostra qui in maniera
evidente il suo potere di penetrazione “interclassista” e di diffusione trasversale nelle
classi sociali.
Se in Africa il quadro globale dei rifiuti risulta abbastanza omogeneo (si stima che
solo il 30% dei rifiuti solidi prodotti nelle zone urbane sia gestito), sotto il profilo
delle politiche pubbliche la problematica è una questione di priorità politica: “la
gestione dei rifiuti nelle città africane sembra una questione tecnica, finanziaria ed
organizzativa che comporta una dimensione culturale nascosta, in quanto costituisce
uno strumento di potere”17.
In Senegal, la gestione dei rifiuti beneficia di un quadro più o meno
istituzionalizzato provvisto di codici e leggi (ambientali e d’igiene).
La Legge 2001-01/ 15 Gennaio definisce il rifiuto come “ tutte le sostanze solide,
liquide, gassose o residue di un processo di produzione e trasformazione o utilizzo di
tutte le altre sostanze destinate ad essere eliminate”. Il Decreto 96-1134/27,
Dicembre 1996, contiene la delega dello stato alle collettività locali della gestione dei
rifiuti. Esso riguarda le cosiddette “competenze trasferite”. Il “Piano nazionale
d’azione per l’ambiente” (PNAE) adottato nel 1997, ed il “Piano nazionale di
sviluppo sanitario” del 1998, oltre alla creazione del Codice d’Igiene con Legge 8371 del 5 Luglio 1983 (anche se se ne contesta l’efficacia in mancanza dei decreti
attuativi), contengono le norme giuridiche di riferimento per la gestione dei rifiuti.
17
O. Cissè, L’argent des dèchets, op. cit., p. 36 (traduz. mia)
111 Nelle discariche, i rifiuti non sono trattati, ma solo depositati. Non si creano quindi
né gli strati impermeabili per contenere le infiltrazioni di percolato, né vengono
eseguite semplici operazioni come la copertura dei mucchi con terra per evitare le
tempeste olfattive provocate dalla dispersione dei bio-gas e dai processi di
putrefazione.
Alla periferia di Dakar, avvolta in un fumo acre, sorge una grande piattaforma di
rifiuti, sedimentati da oltre 40 anni, la discarica di Mbeubeuss. Qui lavorano e
vivono, in condizioni limite, circa 2000 persone, tra le quali numerosi bambini,
impegnati in svariate attività di recupero. C’è un’umanità in fermento: chi trasforma
vecchi stracci in tovaglie e camicie; chi taglia bottigliette di vetro creando bicchieri;
chi riassembla arti, teste e busti di bambola per poi rivenderle; chi seziona
bombolette spray dando vita a giocattoli di latta. C’è anche una piccola moschea con
pareti di latta arrugginita, un emporio e un punto di ristoro. Gruppi di bambini
rovistano tra i rifiuti in cerca di materiale da recuperare e rivendere. I rifiuti si
decontestualizzano dando vita a un mondo a sé, composto da un’estetica tutta sua.
Mbeubeuss riceve in media ogni giorno 3500 persone (33% tra recuperatori,
commercianti e altri acquirenti di materiali di recupero). Il giro d’affari della
discarica conta quasi 13 milioni di franchi CFA. I prodotti che arrivano sono
composti da quasi il 45% di materiali fine (sabbia e ceneri) e dal 20% di
materiale putrescibile. Si tratta di una produzione di oltre 475 000 tonnellate
all'anno di rifiuti (la produzione di rifiuti solidi urbani a Dakar è passata da 350.000
tonnellate nel 1986 a quasi 600.000 nel 2001).
Se nel 1986 quelli organici rappresentavano quasi la metà della totalità dei rifiuti
presenti in discarica, nel 2010 la metà degli stessi è composta da sabbie e ceneri
(plastica e scarti industriali sono raddoppiati rispetto al 1986).
Il sito di Mbeumbeuss, nel comune di Malika, a 20 km da Dakar, sino agli anni
Sessanta era un lago salato, secco e perlopiù in prossimità di una falda acquifera. La
superficie si estende per più di 60 ettari per un totale volumetrico di 3,5 milioni di
metri cubi.
La discarica fu inaugurata nel 1968, e da allora non ha mai smesso di funzionare,
tuttavia senza procedure di controllo, gestione e trattamento (c’è solo compattazione
112 e combustione).18 Ai margini sorgono le baracche in cui si vende tutto ciò che è
raccolto e recuperato all’interno della discarica dai “boudiouman”.
I Boudiouman sono sia sedentari (quelli che si stanziano subito fuori dalla
discarica per rivendere il recuperato), sia itineranti (coloro che vanno in città per
vendere a grossisti o compratori privati). I guadagni possono variare dai 50.000 ai
100.000 Franchi CFA per i raccoglitori, mentre i guadagni si moltiplicano per i
grossisti. i criteri di vendita dei materiali stoccati rispondono principalmente a criteri
quantitativi. Il mestiere di “riciclatore”, chi vive di rifiuti, si è diffuso in Senegal
dopo le tuonanti politiche di aggiustamento strutturale degli anni Ottanta e la
successiva svalutazione del Franco CFA dei primi anni Novanta.
L’intera industria del riciclo si svolge esclusivamente a Dakar; qualsiasi cosa
destinata all’industria del riciclo è inviata alle fabbriche di Dakar, che sono i veri
soggetti accentratori di quel “capitalismo rampante” voluto dal Presidente Wade.
Intorno ad essa si trovano i piccoli centri di Yeumbeul e Keur Massar, che stanno
facendo fronte ad un impressionante boom demografico. Le uniche attività
riguardano il trasporto, riversamento e compattamento (non si ricopre nemmeno
periodicamente la massa decomposta con materiale inerte per limitarne almeno le
forti esalazioni). La pista per il deposito è lunga oltre due chilometri ed è composta
da ammassi di rifiuti che raggiungono anche gli otto metri d’altezza. I principali
materiali coinvolti nel processo di recupero, sono plastica varia, bottiglie, sacchi e
ferraglia. Tuttavia si osserva anche attività di recupero di resti alimentari utilizzati
dalle donne per l’allevamento dei maiali.
Le donne non operano in città a causa dell’ostilità pubblica che assimila i
recuperatori a degli emarginati. Il loro lavoro è circoscritto all’interno della discarica,
dove esse raccolgono essenzialmente resti organici.
Anche se la discarica è un luogo di competizione, assilli e violenza fisica, la donna
non è sottomessa pubblicamente, come buona norma vuole nella società senegalese.
Tuttavia la repulsione pubblica nei confronti dei mestieri coinvolti nel
recupero dei rifiuti, è esacerbata quando sono le donne a essere protagoniste. La
pressione su queste diminuisce nel momento in cui esse appartengono a gruppi etnici
minoritari in relazione ad un’opinione pubblica dominata dalla configurazione
18
Crdi-Iagu, Rapport final d’activités Projet PURE « Dakar, Ville Ciblée », Dakar, 2006-2010
113 islamo-wolof. Infatti, a Dakar è pubblicamente riconosciuto il ruolo della donna di
etnia Serer nella gestione dei rifiuti organici e della acque reflue; così come in
Casamance, nelle comunità Joola, è la donna che si occupa della gestione dei rifiuti
organici. Anche il recupero di materiali pericolosi, come il piombo delle batterie di
automobili, è essenzialmente svolto da donne, con una intensa partecipazione di
bambini. Altri materiali pericolosi sono i rifiuti biomedici che, nonostante non
vengano prodotti in quantità considerevoli, costituiscono un serio problema per la
sanità e l’ambiente pubblici, a causa della loro tossicità e del pericolo infettivo.
Il fenomeno dello sfruttamento dei bambini nella raccolta dei rifiuti, è un
fenomeno molto diffuso (come generalmente lo sfruttamento del mercato del lavoro
minorile in tutta l’Africa), che risente violentemente della rigida gerarchia in seno
alle classi di età. L’ambiente fisico e sociale in cui si collocano le attività di recupero
svolte dai bambini, sottopongono gli stessi a malattie, abusi ed altre forme di
manipolazione tanto pervasive da compromettere la loro crescita.
Altre figure coinvolte in questa economia sotterrata ed emarginata sono gli artigiani
del recupero, che lavorano direttamente il materiale selezionato “riportandolo in
vita”.
Gli attori di questa economia della sopravvivenza, come abbiamo già accennato,
vivono una emarginazione che non è esclusivamente legata all’indigenza economica
(dato che molti di questi attori riescono a guadagnare dignitosamente), ma soprattutto
a quella sociale, in virtù dell’associazione diretta che si fa tra rifiuto sociale,
indigenza e precarietà igienico-sanitaria.
I pochi casi riguardanti la gestione dei rifiuti al di fuori della regione di Dakar
vedono invece protagonisti, soprattutto privati e più di recente operatori dello
sviluppo.
Nel caso dei privati quasi sempre la gestione dei rifiuti è legata all’industria del
turismo (più avanti parleremo del caso del Club Med), la cui dinamica sociale che ne
segue è una economia dell’esclusione.
Infine, per completare questo quadro introduttivo di carattere socio-politico,
riportiamo l’esperienza del Set setal, cui accennato più volte in precedenza.
114 Il Set Setal (che in Wolof significa “pulire ed essere puliti”) è una mobilitazione di
uomini e di donne di un quartiere che si organizzano per pulire il loro spazio di vita.
La diffusione del fenomeno arriva sin dal mondo della musica, di cui il popolare
cantante Youssou Ndour fu principale esponente del rilancio di quel genere musicale
chiamato “Mbalax”, i cui testi sono pieni di riferimenti alle rappresentazioni del Set
Setal.
Esso è un sincretismo strategico in grado di gestire uno spazio aperto per le relazioni
sociali, che tenga conto della morfologia della città e dei suoi meccanismi di
produzione e riproduzione. Il doppio obiettivo è di “bonificare” nel senso fisico della
pulizia, dell’igiene e della sanità anche in senso morale, della lotta contro la
corruzione, prostituzione e delinquenza. La sua preoccupazione principale è di
gestire la città e di raccogliere rifiuti e detriti, di abbellire e dare nuovi nomi agli
spazi, segnandoli con stele e monumenti che parlano dei momenti e dei protagonisti
della storia locale. E’ un movimento popolare, perché è proprio nei quartieri
periferici e popolari che c’è la quasi assenza di raccolta dei rifiuti, ed da qui che il
movimento ha preso piede.
La spettacolarità delle statue che si appropriano dello spazio del quartiere
“rinvia ai segni eterocliti composti dai riferimenti culturali e storici”19. Esso si
configura quindi come un movimento locale che si oppone a quelli nazionali,
basandosi sul quartiere, tentando di trovare una soluzione alla degradazione
accelerata delle infrastrutture pubbliche e alla quasi totale assenza di raccolta di
rifiuti nei quartieri popolari, causata dalla incapacità del servizio pubblico (si pensi al
disastro gestionale a Dakar negli ultimi 50 anni).
Un malessere urbano, quindi, avvertito in modo particolare dai giovani, che oscilla
tra violenza, creatività e l’arte di sbrigarsela. Un fenomeno segnato dalla congiuntura
tra il disimpegno dello stato da una parte e la costruzione dell’egemonia tecnocratica
dall’altra (imposta dalle riforme di aggiustamento strutturale), che si manifesta con la
contrapposizione tra teatralizzazione del potere e teatro della strada.
19
Cfr., M. Diouf, Des cultures urbaines entre tradition et mondialization, in Le Senegal
contemporain, a cura di M. Coumba Diop, Karthala, Dakar, 2002
115 “L’investimento immaginario e le ricomposizioni identitarie che si elaborano
nell’applicazione e gestione degli spazi, disegnano contorni plurali, a volte
conflittuali, sulle nuove forme della città e nelle periferie popolari”20.
“La straordinaria furia distruttiva, in una società che vanta da sempre la Taranga
(cioè la proverbiale ospitalità e pacificità), sembra aver sorpreso gli stessi
senegalesi”21. E, come per purificarsi, i giovani si sono lanciati all’assalto dello
“sporco”, degli agglomerati di immondizia e delle acque stagnanti.
Il movimento del Set è un “investimento umano che ha la vocazione di fare pulizia
(bonificare, attenzione per l’igiene, ma soprattutto pulizia morale: contro la
corruzione, le stringenti misure di aggiustamento strutturale, ecc”). Il palcoscenico è
la strada: “si raccolgono rifiuti, si disegna e si dipinge, si procurano abbellimenti, si
producono monumenti e dediche a personaggi della storia locale, ecc; è a tutti gli
effetti un movimento di quartiere”22.
E’ evidente che qui il tema dei rifiuti assume un valore fortemente simbolico: la
sporcizia non è solo quella materiale ma, è anche, e soprattutto, quella della classe
dirigente. E’ infatti dopo le contestatissime elezioni presidenziali del 1988 in cui si
denunciarono brogli, che la violenza segnò l’irruzione dei giovani nel campo
politico.
Per ben capire cos’è il Set Setal questa dichiarazione di un giovane senegalese
all’inizio dei sommovimenti è eloquente: “Le autorità non hanno capito nulla. Non
sanno ascoltare. Fare set setal significa sbarazzarsi di tutta quell’eredità coloniale
che regola il nostro modo d’essere, di concepire le cose”23.
L’obbligo assoluto di sbrigarsela da soli e la necessità di esprimersi secondo nuovi
concetti e con un linguaggio nuovo e mediante nuovi idiomi che esprimano un rifiuto
dell’azione politica tradizionale, sono gli strumenti di cui il Set dispone. Esso si
presenta come una
20
Ivi, p. 275 (traduz. mia)
Ibidem
22
Ivi, p. 278 (traduz. mia)
23
Ibidem
21
116 “rappresentazione indigena della città. La gioventù lancia un violento calcio ai
linguaggi del potere per mezzo di una nuova produzione di idiomi di sintesi, i cui
elementi sono tratti da mondi eterogenei e distanti. Essa crea una cultura urbana
deconnessa dalle memorie coloniali e nazionaliste. Dalla violenza degli anni ’87’88 allo stile di strada del Set Setal, la gioventù esprime l’impossibile
caporalizzazione del periodo di aggiustamento strutturale”24.
La presa a carico della gestione dello spazio e della sua bonifica, come il nominare
spazi e strade, sono stati vettori della reintroduzione dei giovani in uno spazio ed in
un dibattito sulla città dai quali erano stati esclusi. A causa delle procedure
multiformi ed imprevedibili, il quartiere si sostituisce così al territorio come
ricettacolo per l’elaborazione di simboli e di un immaginario inedito. Il radicamento
succede alla transitorietà, la sedentarietà all’esodo rurale. La città comincia a
produrre la sua storia: uno spazio iniziale, un passaggio obbligato che si manifesta in
una nuova maniera di essere africani.
La produzione culturale riferita alle espressioni dell’arte di strada, al mondo
dei griot e dei tamburi come alla popolarissima lotta tradizionale senegalese crea una
nuova memoria, desiderosa di rompere con costrutti e metafore prodotte, in maniera
concorrente e complementare, per mezzo “della parola leggera ed ambigua dei griot,
le posture estetiche della scrittura lirica dei cantori della negritude ed il vigore
militante dei partigiani del nazionalismo culturale e della liberazione nazionale e
popolare”25. Essa intende volgere lo sguardo alla memoria che ha accompagnato
l’ascesa al potere della generazione dell’indipendenza; essa vuole anche render conto
di un presente frammentato, seppellito nei mucchi di spazzatura che coprono
l’orizzonte della città di Dakar,”avvolta negli odori fetidi e presa d’assalto da
migliaia di maschere che come turbini si dispiegano nel caldo umido, sopra le teste
perdute nei problemi che assillano la DQ26” 27.
I materiali sono oggetti da recuperare appartenenti al nuovo spazio urbano (plastica,
ferraglia, ecc), ma sono anche tronchi d’albero scolpiti ed eretti a stele in supporto a
24
Ivi, p. 283 (traduz. mia)
Ibidem
26
DQ è l’acronimo gergale utilizzato per indicare la spesa quotidiana (“depense quotidienne”)
27
M. Diouf, Des cultures urbaines entre tradition et mondialization, in Le Senegal contemporain, a
cura di M. Coumba Diop, op. cit., p. 295
25
117 “calebasse” (frutti svuotati ed utilizzati come recipienti) e “canarì” (una sorta di
frigorifero naturale). La liberazione dei corpi (sia in rapporto alle restrizioni
dell’Islam che a quelle coloniali e post-coloniali) e la riappropriazione degli spazi
compongono un binomio di sensualità e violenza, al cui interno tuttavia si trovano
elementi controversi: la celebrazione del corpo è anche il luogo di una violenza
inaudita che si esprime nelle forme della depigmentazione, dell’escissione e dei moti
post-elettorali e xenofobi.
Per concludere, la riflessione di Diouf non considera questa produzione
culturale come rottura rispetto alla memoria tradizionale o nazionalista, piuttosto
come una riorganizzazione e ricomposizione delle diverse eredità storiche declinate
in chiave urbana. La città è percepita come un corpo estraneo, luogo del potere e del
dispiegamento della magnificenza della classe dirigente; essa è uno spazio strutturato
in rapporto ai bisogni del controllo sociale. E’ anche luogo di una perdizione causata
dall’assenza di valori che facciano riferimento a quegli ancoraggi rurali soppiantati
da nuovi spazi di libertà individuale.
118 3.2 LA CASAMANCE
La Casamance è rimasta estranea alla logica clientelare islamo-wolof, ragion per cui
lo stato ha dovuto pagare una riduzione della sua autorità. La comunità Diola, che è
l’etnia maggioritaria in questa regione, presenta una impressionante differenza
culturale esistente tra le oltre cinquecento comunità di cui essa è composta. Linares
descrive tre diverse formazioni sociali regionali, rappresentate da tre comunità in cui
ha svolto per parecchi anni le sue ricerche. Tali comunità hanno avuto esperienze
storiche differenti: una ha adottato la religione islamica e si è dedicata alla
coltivazione commerciale, una non si è islamizzata e l’altra ha adottato vari tratti
organizzativi e religiosi dei Mande (gruppo etnico dell'Africa Occidentale,
strettamente collegato con i Fulani e i Wolof in termini di cultura ed etnicità).
Tramite le loro storie, Linares afferma che le differenze all’interno della comunità
non sono l’unica conseguenza degli effetti della penetrazione del sistema di mercato,
ma soprattutto il risultato di modi contraddittori con cui spesso i processi ideologici
hanno negoziato tra le vecchie pratiche e le nuove opportunità economiche.28
Il porto di Ziguinchor, capoluogo della regione, ha goduto in passato di una
indipendenza economica rispetto a quello di Dakar (da Ziguinchor partivano
esportazioni direttamente in Francia). Nei primi decenni del Novecento questa
autonomia economica si rifletteva su una sostanziale autonomia politica.
Gli importanti investimenti degli anni Quaranta, successivi soprattutto al secondo
conflitto mondiale, rinforzarono le autorità di Dakar che iniziarono ad esercitare il
loro controllo periferico sulla Casamance, cui seguì anche una discreta integrazione
infrastrutturale, che favorì una forte migrazione di “nordisti” (nel 1950 circa la metà
degli abitanti di Ziguinchor provenivano dalle regioni del Nord del Senegal). Qui si
colloca una delle questioni centrali del conflitto casamansese: le migrazioni
provenienti dal nord si appropriarono di una grande parte delle risorse della regione,
sino a quel momento poco sfruttate (si pensi ad esempio alla abbondante produzione
di manghi favorita dalle intense precipitazioni).
Se gli uomini furono i protagonisti delle migrazioni nordiste, in Casamance, al
contrario, furono le donne le principali protagoniste dell’esodo rurale verso la città. Il
28
S. Falk Moore, Antropologia e Africa, op. cit., p. 127
119 fenomeno fu talmente massiccio che gli uomini crearono delle associazioni regionali
che avevano lo scopo di controllare le migrazioni femminili. Alla fine degli anni
Sessanta diverse comunità presero addirittura la decisione di vietare totalmente la
partenza delle donne per contenere il pericolo che minacciava i meccanismi di
riproduzione sociale.
3.2.1 Il conflitto
Il conflitto etnico che ha segnato la storia della regione, vede le sue origini subito
dopo la Seconda guerra mondiale, quando alcuni Joola, sostenuti da un malcontento
di origine coloniale, da una retorica di esclusione e da oggettive differenze, oltre che
territoriali, anche sociali e culturali, rispetto ai gruppi etnici del Nord del Senegal, si
organizzarono: nel 1947 nacque l'MFDC (“Movement des forces democratique de la
Casamance”, Movimento delle forze democratiche della Casamance).
Leader spirituale del Movimento era l'abate Augustine Diamacoune Senghor.
L’MFDC delle origini non mirava all'indipendenza della Casamance, ma la scarsa
attenzione che il governo di Léopold Sedar Senghor prima, e di Abdou Diouf poi,
prestarono alla loro causa, fece cambiare le cose: mentre una parte del Movimento
entrò a far parte del governo, un'altra ala se ne distaccò (il Mac, Movimento
Autonomo
della
Casamance)
e
cominciò
ad
avanzare
rivendicazioni
indipendentiste. L'incarcerazione di Augustine Diamacoune Senghor e la repressione
nel sangue da parte del governo di una manifestazione pacifica nel 1982 fece
precipitare la situazione. La popolazione della zona a questo punto aderì unanime
alla causa indipendentista, e tanti di quei manifestanti entrarono nelle file
dell'MFDC. Il conflitto si radicalizzò e la frangia estrema impugnò le armi.
Nel 2000 Abdoulaye Wade fu eletto Presidente del Senegal, e fece della
soluzione del conflitto uno dei suoi cavalli di battaglia. Il primo atto concreto si ebbe
però con l'accordo di pace di Ziguinchor nel dicembre 2004. La situazione rimane
difficile da anche perché alle azioni dei ribelli spesso si affiancano azioni di
banditismo per nulla legate al movimento.
120 Foucher29 propone due interpretazioni del conflitto: la prima, culturalista, si incentra
sulle differenze culturali fondamentali tra la Casamance e il resto del Senegal, tra la
foresta e la savana, tra etnie saheliane ed etnie guineensi, tra civiltà del riso e civiltà
del miglio. Il governo centrale taccia l’MFDC di identità etnica primitiva,
contrapponendola alla multietnicità della democrazia senegalese. Sia la stampa che la
letteratura scientifica insistevano sul ruolo giocato da elementi come la sacralità degli
alberi ed i feticci, icone della cultura casamansese.
La seconda interpretazione è di carattere politico-economico: lo shock provocato
dall’incontro tra elementi della modernità da un lato (stato, mercato e
monetarizzazione) e società tradizionale dall’altro, hanno generato una serie di
tensioni sociali. Tuttavia in entrambe le letture emerge la sostanziale tensione tra
modernità e tradizione.
Altro elemento centrale nel conflitto casamansese è la sottorappresentazione
dei Joola nell’impiego pubblico (il governo di Dakar non fornisce dati sulle
rappresentanze etniche nell’impiego pubblico a tal riguardo).
L’idea di identità prende piede in Casamance fuori dal contesto rurale; è in città,
nella vita municipale di Ziguinchor che si fa largo l’idea della separazione dal
Senegal. Tale rivendicazione fu portata avanti paradossalmente da piccoli
commercianti bianchi e da meticci portoghesi che tentarono di creare un terreno
comune che andasse ben oltre le comunanze culturali, etniche e storiche, ma che si
concentrava su una rivendicazione in grado di far fronte alla concorrenza delle grosse
compagnie commerciali del Nord. E’ in tale contesto che si sviluppa “il mito delle
potenzialità non sfruttate”. Dal canto suo, la Chiesa, nel perseguire i suoi scopi di
evangelizzazione della regione tramite la costruzione di saperi ed istituzioni, ha finito
col favorire indirettamente l’alimentarsi dell’identità della Casamance centrata sulla
tradizione Diola.
Grazie alle rivendicazioni della “negritudine”del primo stato senghoriano, con
cui la cultura della Casamance si trovava in perfetta sintonia, si avviò anche un
processo di folklorizzazione e di commercializzazione della cultura tradizionale e
popolare Joola, tale da renderla un prodotto d’esportazione. Tant’è che negli anni
29
Cfr., M. Coumba Diop (a cura di), Le Senegal contemporain, op. cit.
121 Settanta la cultura Joola diventa un esempio di quello che si definiva “turismo rurale
integrato”.
Da queste macchinazioni sul concetto di identità ne è derivato il passaggio sul piano
politico verso la fine degli anni Settanta: l’associazione Casamansese “Esukolal”
inizia a pubblicare un giornale denominato “Kelumak” in cui si pubblicava tutto ciò
che riguardava la cultura Joola (maschere, danze, lingua, ecc), sino a pubblicare
articoli in cui si denuncia il lavoro domestico dei Joola per conto della borghesia
politico-burocratica. Ecco che nasce, ad esempio, il COREZI (“ Comité pour le
renouvement de Ziguinchor”, Comitato per il rinnovamento di Ziguinchor), una
associazione che lavorava sulla “Joola-izzazione” dei quadri politici locali.
Dopo il conflitto anche lo Stato ha cercato di favorire le rappresentanze Joola
nelle èlites politiche locali, tuttavia dimostrando di non voler seriamente affrontare la
questione, vista la quasi totale assenza delle stesse nei quadri nazionali.
Due dati che vale la pena citare, riguardano il tasso di scolarizzazione e l’intensità
delle migrazioni, che sono tra i più alti del Senegal (tale rilevanza si palesa se si
confrontano i dati della regione confinante di Kolda, dove invece tali dati sono al
contrario tra i più bassi. Ciò ancora a supporto della genesi metropolitana del
movimento).
Lo scoppio del conflitto nella prima metà degli anni Ottanta diede avvio a quella che
J.C. Marut30 definisce la “depoliticizzazione diabolica”, intendendo con questa
espressione diverse pratiche di dominazione culturale come ad esempio la scomparsa
dal vocabolario amministrativo della Casamance. Si inizia cioè a diffondere
l’espressione “Casamance naturelle”, che ha l’evidente fine recondito di attuare una
depoliticizzazione di fatto della regione. Se infatti nelle regioni tropicali la
pluviometria è un criterio oggettivo per differenziare i territori, in Casamance si
possono distinguere due regioni: quella di Ziguinchor, cioè della Bassa Casamance,
che possiamo definire guineense in base alle caratteristiche generali del territorio
(vegetazione, pioggia, ecc) e la regione di Kolda con caratteristiche sudanesi
caratterizzata da un clima prevalentemente secco. La depoliticizzazione della regione
si accompagna quindi ad un processo di naturalizzazione forzata della sua etnicità,
per cui il termine “naturale” viene usato come sinonimo di indigeno, autoctono.
30
Ibidem
122 Il “veleno etnico prodotto è conseguenza della febbre identitaria che segna il ritorno
dei demoni etnici”31. Violentissima fu quindi la reazione alle prime azioni di guerrilla
condotte dal braccio armato dell’MFDC (“Atika”) nei primi anni Novanta: lo stato
rispose con torture ed esecuzioni sommarie in grande numero. I ribelli usavano, dal
canto loro, le armi del sabotaggio e delle mine anti-uomo.
31
J.C. Marut, in Momar Coumba Diop (a cura di), Le Senegal contemporain, op. cit.
123 3.3 L’INDAGINE SUI RIFIUTI
L’ indagine si è concentrata nel prendere ad oggetto la questione dei rifiuti in due
contesti contrapposti, nella regione di Ziguinchor: da una parte la gestione
amministrativa e informale in città, dall’altra quella “tradizionale” nei villaggi.
La nostra analisi riguarda quei vasti strati di popolazione urbana, come ad esempio le
migrazioni tornanti, cresciuti nei villaggi secondo un modo di vita tradizionale, il cui
contatto con la città e quindi con la modernità ha creato dei fenomeni sincretici. Di
questi a noi interessano le dinamiche socio-antropologiche legate alla questione dei
rifiuti e al rapporto antropologico in senso stretto che l’uomo realizza con essi.
3.3.1 Gli attori
L’uso di rifiuti nell’agricoltura urbana è una caratteristica osservata nelle principali
città dell’Africa Occidentale.32 Gli attori coinvolti nella gestione in città dei rifiuti
sono eterogenei: dalle comunità rurali, ai funzionari del comune e dei vari uffici
ambientali e sanitari, agli attori informali (recuperatori, rivenditori, grossisti
specializzati, artigiani recuperatori, ecc).
In base all’indagine svolta tra gli attori informali, costituiti principalmente da
“carrettieri”, recuperatori e donne impegnate nella raccolta di resti alimentari da
destinare agli allevamenti di maiali (in una realtà come quella di Ziguinchor la
valorizzazione dei rifiuti non è sistematica e gestita da diversi soggetti come a Dakar
e Mbeubeuss), abbiamo rilevato che praticamente tutti sono in condizioni di estrema
povertà e completamente slegati da qualsiasi dinamica gestionale o di controllo
(pubblico): tant’è che il loro sistema di raccolta si basa essenzialmente sul prelievo
domestico dei rifiuti e sull’immediato deposito degli stessi in certi punti tra loro
convenzionati di raccolta, la maggior parte dei quali in piena città. Tutto ciò avviene
col tacito assenso e disinteressamento delle istituzioni locali, del tutto prive di
politiche in grado di far fronte ad un problema che è ancora, relativamente alla città
di Ziguinchor come a tutta la Casamance, contenuto.
32
Cfr., O. Cissè, L’argent des déchets, op. cit.
124 Da qui proviene il nostro interessamento per la questione, viste le prospettive di
urbanizzazione che riguardano l’Africa occidentale e più in generale l’Africa intera.
Cioè se già da ora la questione dei rifiuti è fuori controllo e tale anomia genera
panorami metropolitani insalubri e decadenti, le prospettive di inurbamento e di
crescita demografica nel continente fanno presagire una vera e propria catastrofe.
Ritornando agli attori coinvolti nel settore informale dei rifiuti a Ziguinchor,
per quanto riguarda i recuperatori, il loro status sociale è fortemente marginalizzato
per le stesse ragioni per cui lo sono a Dakar, cioè l’associazione che nel senso
comune viene fatta tra “scarto materiale” e “scarto sociale”. In principio avevamo
visto come la parola “immondo” descrivesse bene questa dinamica tramite un
movimento di inclusione ed esclusione, per cui mondo significa pulito, perché è
all’interno, immondo invece è sporco perché si trova all’esterno, è espulso dalla
“mondezza”. I principali oggetti recuperati in città sono bottiglie, plastica, cartoni,
sacchi, ferraglia e legno.
Un altro tipo di attore che interviene in tale panorama è quello del rivenditore, che, a
differenza di Dakar dove esso può stabilirsi sia direttamente in discarica o spostarsi
in città, vende essenzialmente in città, essendo la discarica uno spazio ancora
anonimo, e non animato da movimenti di uomini, affari e mercanzie come a
Mbeubeuss. I rivenditori in città hanno come acquirenti dagli artigiani ai nuclei
familiari, ai grossisti, alle micro-industrie, ecc.
3.3.2 La gestione amministrativa
Per quanto riguarda la gestione amministrativa, il riversamento fino a qualche anno
fa avveniva ancora in quartieri periferici, ma di città, mentre negli ultimi anni la
pratica dell’ “allontana e dimentica” ha spinto i rifiuti fuori dalla città, portando il
problema ai villaggi che si trovano lontano quanto basta, ma non troppo, dalla città.
Il crescere del peso dei rifiuti sulla città è intuibile quando si nota che ciascun
villaggio in cui ora si scarica si trova rispettivamente alle porte della città, ciascuno
in direzioni differenti (Dgibelor è a Est, Bourofaye a ovest, Boutout è a sud).
Per orientare le nostre ricerche partendo da “ciò che è stato fatto sin’ora” ci siamo
recati nell’ufficio ambientale del comune che dovrebbe svolgere funzioni esecutive
125 nella gestione dei rifiuti. Abbiamo sottoposto al responsabile un questionario di
orientamento
composto da una dozzina di domande. Tutte le domande che
chiedevano un resoconto circa progetti, politiche e iniziative riguardanti la gestione
dei rifiuti, hanno ricevuto la stessa risposta negativa, cioè la pressoché totale assenza
di politiche pubbliche.
Successivamente abbiamo incontrato l’unico partner privato protagonista della
gestione “formale” dei rifiuti (questi gestisce gli unici due camion, la raccolta, lo
svuotamento delle casse, ecc). Il signor Diouff denuncia quello che, a suo modo di
vedere, è il problema più grande rispetto all’accumulazione di rifiuti in città, cioè il
mercato. Diouff ci spiega che il Comune si è completamente smarcato dalle
responsabilità socio-sanitarie derivanti da una gestione superficiale ed insufficiente
dei rifiuti. Inoltre non esiste un piano di coordinamento tra la pre-raccolta, gestita dai
capi-quartiere, e la grande raccolta con i camion. Il parco attrezzi impiegato per
queste attività è inoltre scarsissimo: sono messe a disposizione, sempre per l’intera
città, 10 casse con volume di 5m3 e due camion del volume di 20m3. Oltre a non
visionare in nessuna maniera lo svolgimento del lavoro svolto dai partner privati, il
Comune stipula contratti di un anno, motivo per il quale non c’è la possibilità di fare
progetti di medio o lungo periodo (come la costruzione di una discarica). La
mancanza di bidoni e contenitori crea grossi problemi quando, sia con la stagione
delle piogge che con quella secca in cui spira l’Harmattan 33, i rifiuti si disperdono
per la città, complicando le già deboli procedure di raccolta.
Abbiamo svolto poi delle interviste e sopralluoghi nei villaggi limitrofi alla città,
colpiti dal fenomeno dell’ “allontana e dimentica” dei rifiuti.
3.3.3 Dgibelor
Il villaggio di Dgibelor, situato ad ovest in direzione Kap Skiring, alle porte di
Ziguinchor, è uno dei villaggi limitrofi alla città che risente maggiormente il
problema dei rifiuti. Il villaggio comprende anche un lebbrosario che ospita qualche
centinaia di ammalati. Abbiamo parlato col capo villaggio, che vive isolato dalla
comunità. Mr Diatta ci ha raccontato la vicenda che ha visto il villaggio protagonista
33
L'Harmattan è un vento secco e polveroso che soffia a nordest e ovest, dal Sahara al Golfo di
Guinea, tra Novembre e Marzo
126 di questa “lotta contro i rifiuti”: il comune aveva deciso nel 2008 di riversare i rifiuti
nel villaggio (poiché il quartiere di Goumel, in città, aveva appena vinto la battaglia
per riqualificare il quartiere e fermare l’accumulo di rifiuti) dietro richiesta del capo
villaggio del Lebbrosario di Dgibelor. Quest’ultimo aveva infatti chiesto al comune
di riempire una cava adiacente al villaggio, scavata negli anni Sessanta per la
costruzione del manto stradale, di modo da riempirla per portarla a livello del
villaggio ed estendere la superficie edificabile vista la crescente necessità di nuovi
spazi. Tale condizione di miseria e bisogno spaziale tuttavia è stata anche la causa di
forti tensioni col resto del villaggio. Diatta afferma infatti di essersi opposto alla
proposta del capo del lebbrosario: “Non vogliamo rifiuti che non sappiamo gestire e
che inoltre non produciamo. La cava che quelli del lebbrosario vogliono riempire è
per di più anche il luogo dove arrivano le migrazioni di coccodrilli in primavera”.
Un conflitto controverso, quindi, quello tra chi da una parte non vuole prendersi
carico dei rifiuti (perché né li produce né sa gestirli) e dall’altra chi nel riversamento
dei rifiuti vede la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita.
Diatta ci dice che la gestione dei rifiuti domestici presso i Joola è sempre consistita
nella trasformazione in compost per fertilizzare le risaie. Proprio rispetto a queste
ultime, Diatta denuncia delle pratiche di riversamento per cui, durante la stagione
delle piogge, si gettano i rifiuti da un ponte alle porte del villaggio che trasportarti
dai corsi d’acqua arrivano sino alle risaie.
Nella nostra indagine abbiamo notato (dal Comune di Malika nella regione di
Dakar, al lebbrosario di Dgibelor nel dipartimento di Ziguinchor ), che è spesso la
gente dei villaggi che chiede il riversamento dei rifiuti sui loro spazi per sfruttarne le
caratteristiche fisiche, organiche e volumetriche: da esso si ricava fertilizzante,
mangime per gli allevamenti di maiali, commercio del riuso, riempimento, ecc.
Come quanto appena descritto nel lebbrosario di Dgibelor, a Nord, nel quartiere di
Ndenatt, a Yoff, nella regione di Dakar, la gente riversa i rifiuti sulla spiaggia
giustificando questa azione con la lotta contro l’erosione marittima delle coste; le
popolazioni locali si sono mobilitate per costruire una diga artificiale di rifiuti, alta
127 1,5 metri (Dia El Boubacar)34. Emerge quindi una caratterizzazione del rifiuto come
elemento integrato alla natura.
C’è quindi una dinamica paradossale per cui non sempre le discariche chiudono
perché stracolme, ma perché i quartieri limitrofi hanno esigenza di allargarsi, sotto la
spinta demografica, reclamandone lo spazio.
3.3.4 Bourofaye
Il villaggio di Bourofaye si trova ad est della città; abbiamo incontrato il presidente
della Comunità Rurale che ci ha raccontato perché il villaggio aveva accettato che si
depositassero rifiuti. Il comune aveva promesso nel 2008 la costruzione di una scuola
e l’attivazione di almeno due classi, e in più un impiego per quattro giovani della
comunità. Ci fu un accordo verbale tra la comunità e la vecchia amministrazione, che
non è stato rispettato sino ad ora neanche dalla nuova amministrazione. E’ per questo
che nello scorso Aprile la comunità ha intrapreso una battaglia per bloccare il
deposito di rifiuti, visto il non rispetto degli accordi conclusi. Sono stati creati dei
comitati di sorveglianza e spesso si sono verificati degli episodi di tensione. La
discarica, denuncia il presidente della comunità, inquina i campi di riso ad essa
circostanti tramite la penetrazione di percolato nelle falde acquifere che, come se non
bastasse, in questa regione in particolare risultano mediamente molto prossime al
livello del suolo, ragion per cui lo scarico di rifiuti non può non includere anche dei
processi di trattamento degli stessi che preservino la qualità del terreno.
Il conflitto tra Bourofaye e il comune è paradigmatico per trarre
un’osservazione sul ruolo che esso assume nell’analisi socioantropologica. I conflitti
sono indicatori preziosi del funzionamento di una società locale, e per questo sono
pertinenti al tema del cambiamento sociale. Tutte le società sono attraversate da
conflitti. Se da una parte essi sono elementi insiti in ogni vita sociale, dall’altra parte,
l’analisi strutturale li rimanda a differenze di posizione. Essi esprimono dunque
degli interessi legati a posizioni sociali differenti e sono culturalmente strutturati.
34
Cfr., B. Dia El Hadj Memoire de Dea, Impact de la dynamique populaire face aux contraintes
d’amenagement du territoire dans la banlieu de Dakar: l’example de Yoff-Ndenatt, Chaire-Unesco,
New York, 2003
128 3.3.5 Rifiuti e sviluppo
Riporteremo ora l’esempio di due esperienze rilevanti nel settore dei rifiuti,
realizzate nella regione della Casamance: il contributo alla gestione di una Ong nella
città di Kolda, e quella di un’azienda privata che opera nel campo del turismo.
L’Ong Italo-senegalese “7A” lavora sulla gestione e sensibilizzazione dei rifiuti
nella città di Kolda da 15 anni. Qui il sistema di raccolta è federato, perché ogni
quartiere provvede singolarmente. Le associazioni delle donne svolgono una
funzione informativa, fabbri e falegnami procurano i carri per il trasporto, e il
comune raccoglie i rifiuti depositati in punti convenzionati con ogni quartiere. Il
servizio costa 1500 Franchi CFA al mese (poco più di due euro) e i programmi di
gestione vengono rinnovati annualmente.
Nonostante questo quadro suggerisca una gestione funzionante della città, la
realtà fisica di Kolda rimane violentemente segnata dall’invasione dei rifiuti: enorme
è ancora la negligenza e mancanza di consapevolezza ambientale.
T. Mballo, il rappresentante senegalese di questa Ong, è impegnato da trent’anni
nelle iniziative di sensibilizzazione sociale ed ambientale, specificatamente nelle
campagne per la raccolta dei rifiuti. Mballo sottolinea l’importanza del fatto che a
promuovere tale impegno deve essere la gente del posto. “APROSEN o no, è la gente
che si mobilita per raccogliere l’immondizia”, afferma Mballo, per sottolineare il
fallimento della gestione centrale dei rifiuti a Dakar e di come, di fronte a questo
fallimento istituzionale, debba essere la società civile a mobilitarsi per risolvere
problemi incalzanti. Mballo ci spiega come negli ultimi 30 anni, a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, il processo di urbanizzazione, favorito soprattutto
dalla spinta demografica innescata dalle migrazioni del Nord,
abbia posto il
problema dell’occupazione degli spazi.
Tale processo è coinciso con l’immissione nell’economia della regione di
nuovi prodotti industriali (secchi in plastica, sacchetti e buste, pentole, ecc), che
spesso provenivano dalle migrazioni del nord come anche da quelle tornanti. Infine
Mballo ci parla della questione di genere come un carattere distintivo nella
valorizzazione dei rifiuti. “E’ infatti la donna”, dice, “la specialista del settore”. E’ lei
che nel modo di vita tradizionale gestisce la casa e quindi anche la produzione, lo
129 smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti, ed è sempre lei che in base a questa
esperienza deve prendere coscienza di nuove esigenze di smaltimento portate con sé
da un modo di vita in cui la penetrazione di elementi moderni, come la plastica,
destabilizza.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti promossa dal Club-Med (che è
un’azienda francese che fornisce servizi nel campo del turismo), essa opera a Kap
Skiring, una nota località turistica sulla costa della Casamance. La presenza di un
consistente turismo dall’Europa ha favorito una privatizzazione massiccia del settore
per venire in contro alle esigenze dei turisti europei. In questo spazio opera ClubMed che, a nostro avviso, ha fatto della gestione dei rifiuti, sotto un falso quadro di
sostenibilità, un fenomeno paradigmatico, che ben rappresenta quell’economia
dell’esclusione, cui abbiamo accennato precedentemente. Esso ha realizzato un CTD,
centro di trattamento dei rifiuti, che smaltisce i rifiuti degli alberghi dell’area
convenzionati. Il centro funziona solo nei mesi in cui il flusso di turismo è intenso.
Un centro privato, quindi, che gestisce rifiuti non prodotti dalla popolazione locale, a
cui queste ultime si sono opposte quando nel 2006 fu creato, perché non furono
interpellate e non fu effettuato nessuno studio sull’impatto ambientale che tale centro
avrebbe prodotto. Quando abbiamo visitato il centro, abbiamo rilevato pratiche di
smaltimento molto “controverse”. Oltre al totale stato di abbandono di circa la metà
della superficie impegnata, la plastica viene smaltita bruciandola in quantità, in
semplici forni.
Gli operai del centro, dopo un’iniziale diffidenza, ci hanno manifestato la loro
condizione di precarietà, mancanza di protezioni e norme igienico-sanitarie, oltre che
ai bassissimi salari (intorno ai 2000 Franchi al giorno, meno di tre euro). La costante
assenza del responsabile del centro, che per’altro non fornisce né assistenza né
indicazioni agli operai, è la causa del decadimento del centro.
3.3.6 Adeane
Vale la pena riportare infine un sopralluogo che abbiamo fatto in un villaggio,
Adeane, 30 Km a est di Ziguinchor. Qui abbiamo constatato un ottimo risultato
conseguito da una piccola ONG italiana, Jamm. Premettiamo che tale Ong, non è un’
130 “impresa”, ma una semplice, e realmente non lucrativa, attività volontaristica portata
avanti da sei italiani, in cooperazione con una quindicina di ragazzi senegalesi. Tra
questi non c’è nessun rapporto formale, nessuna esigenza di “mercato” , ma
un’amicizia esemplare.
Dopo aver bonificato una superficie in foresta pari ad almeno mezzo ettaro ed
aver avviato una fattoria con animali e coltivazioni varie, che peraltro sono in parte
destinate anche al villaggio, oltre che al loro sostentamento, nel 2005 “Jamm” ha
iniziato a proporre al villaggio “le domeniche di pulizia”, coinvolgendo gli abitanti
nella raccolta dei rifiuti sparsi in ogni angolo.
Dal punto di vista domestico, alle donne è stato suggerito di risanare i cortili interni
delle abitazioni, ormai divenuti depositi interni di rifiuti, privi di cure, trasformandoli
in giardini in cui coltivare verdure ed ortaggi. Questa attività, che ripetiamo non si
basa su nessun finanziamento, tantomeno istituzionale, è consistita in periodiche
attività di sensibilizzazione pubblica che hanno sortito ottimi risultati. Il capo
villaggio ci dice che da quando i ragazzi di Jamm hanno proposto l’iniziativa al
villaggio, la qualità della vita è considerevolmente migliorata:
“la gente ora raccoglie responsabilmente i rifiuti selvaggi, lo spiazzo centrale
del villaggio è sempre pulito e l’ambiente domestico è più accogliente grazie
alla conversione dei cortili in micro giardini, che peraltro riescono a far
risparmiare somme non trascurabili”.
131 3.4 “SPORCO E PULITO”: DAI DIOLA AI DOGON
L’igiene è vista come un attributo di base della civiltà, a cui si oppongono le culture
indigene, in particolare con le loro abitudini anti-igieniche. Rispetto a questa
condizione, il discorso coloniale è esplicito nel precisare le idee di isolamento e
segregazione degli autoctoni.
Se consideriamo i rifiuti una questione culturale che riguarda sia l’ambiente che
l’igiene, riguardo quest’ultimo ci sembrano pertinenti le analisi di Foucault sul
potere disciplinare esposte nella prima parte.
La seconda parte dell’indagine ha tentato di individuare gli elementi caratterizzanti
della gestione “tradizionale” dei rifiuti nei villaggi del Mof Evvì, a pochi chilometri
da Ziguinchor. Nei villaggi l’esistenza di un modo di produzione quasi interamente
agricolo legato alla sussistenza e la difficoltà di penetrazione di elementi moderni,
non crea eccessivi problemi di produzione di rifiuti, anche se, nello specifico, il
dramma dei “sachets noir”, dei sacchetti di plastica neri, che dall’inizio degli anni
Novanta stanno inondando i paesaggi dell’Africa, è un problema pressante.
Atomizzazione e parcellizzazione dei prodotti sono le cause di questo iperconsumo
di sacchetti.
Ci siamo concentrati nell’individuare e descrivere gli elementi spaziali e
societari che intervengono nella gestione dei rifiuti. Un cenno importante meritano le
dinamiche di popolamento e le modalità normative con cui queste si realizzano,
secodo la “tradizione” Joola.
Paolo Palmeri, in uno studio sulla comunità Joola del Regno del Mof Evvi35 (regno
del “re della pioggia”: regione a Ovest di Ziguinchor che comprende una decina di
villaggi tra loro indipendenti, ma legati da un sistema endogamico), attraverso
un’indagine sul mito della fondazione del regno, ricompone ed analizza gli elementi
utili per capire le modalità di insediamento, la formazione dei villaggi e
l’occupazione delle terre.
La procedura tradizionale di presa di possesso di terre vergini, quando un
gruppo si sposta su nuovi territori, comporta le seguenti regole e prescrizioni: chi
35
Cfr., P. Palmeri, Tra i diola del Mof Evvì : cronaca di una ricerca antropologica in Senegal, Cleup,
Padova, 2008
132 scopre un territorio disabitato e incolto può appropriarsene seguendo due forme di
diritto tradizionale: il “diritto del fuoco” e il “diritto d’ascia”.
Il diritto del fuoco appartiene esclusivamente a chi ha scoperto un nuovo territorio e
consiste nel poter incendiare la boscaglia per liberare le terre e segnarne i confini. Il
fuoco può durare uno, due o più giorni a seconda dell’estensione che si vuol
delimitare. Le terre scoperte dovranno avere dei confini o dei limiti geografici che in
generale coincidono con fiumi o canali. Si tratterà perciò quasi sempre di un’isola
circondata su tutti i lati da corsi d’acqua. Al di là di questi, cessano i diritti dello
scopritore.
Il diritto d’ascia è una prerogativa che appartiene a coloro che per primi
hanno scoperto un territorio e hanno usato il diritto del fuoco. Con il diritto d’ascia si
può ripulire il terreno dalla vegetazione tagliando alberi e arbusti per procedere alla
messa a coltura. Ma mentre il diritto del fuoco non può essere ceduto e sarà sempre
riconosciuto allo scopritore, il diritto d’ascia può essere concesso anche ad altre
famiglie che intendono installarsi sul territorio.36 Perciò il diritto del fuoco istituisce
una giurisdizione su tutto il territorio scoperto, mentre il diritto d’ascia è quello che
permette di ripulire un terreno e viene applicato solo per quella porzione di territorio
che si vuole mettere a coltura riservandosi la possibilità di usare tale diritto per
estendere le coltivazioni anche su quelle porzioni di terra lasciate ancora integre.
Il Moff evvì confina con corsi d’acqua da ogni parte escluso a est. La vicinanza
dell’oceano e il flusso delle maree sono la causa dell’alto tasso salino presente
nell’acqua. L’orografia del territorio genera zone acquitrinose che sono regolarmente
inondate dal flusso delle maree. Il paesaggio si alterna tra residui di foresta
subequatoriale, palmeti, radure e risaie.
Per ben comprendere la maniera in cui i Joola vivono il loro territorio, è
necessario sottolineare che tutte le categorie fisiche del mondo e, soprattutto la natura
stessa, sono impregnate di sacralità. L’uomo è tutt’uno con Etam ed Emit (la terra e il
cielo), con i quali si crea un insieme coerente ed ordinato. “L’uomo non appartiene
ad una categoria diversa o separata da quella della natura bensì è integrato in un
tutto coerente composto da molteplici soggettività. […] Non è la quantità bensì la
36
Ivi, p. 42
133 qualità dei rapporti che l’uomo intrattiene con essa che gli permetterà di
sopravvivere e di evitare malattie, fame e carestie”37. La contrapposizione tra
soggetto (uomo) e oggetto (natura), non ha quindi senso in questo sistema di
pensiero. L’uomo può soltanto operare all’interno di questo ordine beneficiando dei
frutti della natura. Se da una parte quindi rileviamo una dimensione fisica, naturale e
spaziale interpretabile in base alla funzionalità ed utilità pratica, dall’altra ne
individuiamo una simbolica, parimenti impegnata nell’attività di rappresentazione
sociale.
“Nel pensiero Joola tutti i rapporti con la terra sono caratterizzati da una
particolare relazione che sancisce,di fronte a tutti, le prerogative e le
obbligazioni acquisite sulla terra stessa: la relazione “shil”. Il concetto di shil
sottolinea la responsabilità che un individuo o un gruppo si assume su una
parte definita di territorio: l’uomo si impegna a coltivare la terra e
reciprocamente questa è obbligata a nutrirlo”38.
La gente di questa regione, quindi, s’identifica con tutto il suo territorio e se ne sente
responsabile perché è la terra dei loro antenati, parte integrante e “mediatrice” di quel
rapporto cielo-terra-uomo-dio che concede la sopravvivenza. L’individuo può
operare e trasformare la natura solo mettendo in atto un rapporto shil, col quale si
manifesta la volontà di lavorare la terra. Quando tale rapporto cessa, la terra torna
alla comunità e chiunque può instaurare una nuova relazione shil. Nei limiti delle
disponibilità, infatti, la comunità accorderà sempre ad un suo membro il diritto di
usufruire di una parte di terra, con la responsabilità e l’obbligo di lavorarla. La terra,
infine, nel suo significato ideologico, non è mai intesa come un elemento che può
appartenere a qualcuno. Essa “appartiene a Dio, l’uomo può solo lavorarla e
cogliere i frutti del suo lavoro”39.
Il territorio è distinto in base alla sua utilizzazione a fini produttivi e rituali:
Baha soni le foreste a disposizione di tutti, non ancora intaccate da nessun rapporto
shil. Sono utilizzate per la caccia, la raccolta di frutti spontanei, essenze
37
Ivi, p. 74
Ivi, p. 74
39
Ivi, p. 75
38
134 medicamentose e legna. Chi intende instaurare un rapporto shil con una porzione di
terra della foresta, segna il terreno che si propone di trasformare e coltivare
delimitandone i bordi con una serie di frasche o annodando foglie di palma fissate ai
rami degli alberi.
Oltre all’utilizzo per fini produttivi, la foresta ha nel pensiero Joola un
significato importantissimo da un punto di vista religioso tanto che i rituali sono
legati all’esistenza di alcuni spazi di foresta. “In baha infatti sono collocati i più
importanti spiriti, quelli che esprimono il senso politico ed ideologico della
comunità”40. Gli spazi di foresta dove avvengono cerimonie, rituali, funerali e
iniziazioni sono considerate sacre e preservate da qualsiasi manomissione (non si
possono tagliare alberi, raccogliere vino e, anche se è concesso raccogliere legna, la
gente evita di entrare in questi spazi senza un motivo preciso, perché avvicinarsi
“alla casa degli spiriti” può essere pericoloso).
Ci sono poi alcune zone di foresta attribuite al “sacerdote della pioggia” che
sono preservate da qualsiasi intervento dell’uomo, incontaminate e completamente
abbandonate (sono queste le terre dove sono sepolti i “re”). In questi luoghi vivono
gli spiriti che il sacerdote invoca per far cadere la pioggia e per assicurare il
benessere della comunità. Il re è l’unico che può instaurare una relazione shil con
questi spazi, è l’unico che può prendersene cura.
“Etam”, è la terra posta tra le zone di foresta e quelle acquitrinose, che è
tradizionalmente destinata alla coltivazione del riso. Tuttavia, nei pressi dei villaggi o
delle abitazioni, etam è quello spazio in cui, durante la stagione dei lavori agricoli, si
custodiscono i bovini. Chi è in rapporto shil con lo spazio prescelto, ingaggia un
pastore al quale ogni famiglia affida il proprio bestiame che, ogni sera viene
raggruppato in questa stalla all’aria aperta dove le donne regolarmente vengono a
raccogliere il concime. Durante la stagione secca, le risaie vengono concimate
lasciando pascolare il bestiame nei campi; prima delle piogge, verso maggio, le
stoppie rimaste sono bruciate. Il bestiame e il debbio non sono gli unici sistemi di
concimazione del terreno, infatti, come appena accennato, le donne raccolgono il
letame dalle stalle, lo mescolano con foglie secche e con i rifiuti della casa, e lo
40
Ivi, p. 77
135 bruciano. Le ceneri così prodotte sono trasportate e sparse sulle risaie poco prima
dell’inizio dei lavori.
Un cenno meritano anche le tecniche di lavoro riguardanti la desalinizzazione
dell’acqua e lo strumento di lavoro delle risaie. Per modificare la composizione del
suolo e, quindi, diminuire la quantità di sale, si sfrutta il flusso delle maree. A tale
scopo, in vicinanza del bordo del canale si costruisce una diga alta un metro e mezzo
e larga altrettanto. Alla base di questa si inserisce un tronco svuotato che funge da
tubo di drenaggio. Quando c’è bassa marea si fa defluire l’acqua salmastra. Poi con
le prime piogge si lascia riempire il terreno di acqua dolce che lava il terreno del sale
depositato (tale operazione può durare sino a quattro anni). Per quando riguarda lo
strumento di lavoro delle risaie, il “gagiandu”, esso è uno dei prodotti più
significativi della cultura Diola, le cui sofisticate caratteristiche sono perfettamente
studiate ed adattate alla composizione argillosa del terreno ed alle sue esigenze.
Tecniche di irrigazione e strumenti tecnici perfezionati, consentono alla risicultura
Joola alti livelli di rendita.
La sacralità della terra e del riso risultano dal legame divino tra pioggia e
fertilità. E’ il dio della pioggia colui che opera affinché piova e i terreni siano fertili.
Il sacerdote, è una delle istituzioni centrali della vita Joola, perché è lui che,
attraverso i rituali rivolti agli spiriti dei suoi antenati, intercede presso la divinità,
assicurando la pioggia, quindi il benessere. Tale sacralità si palesa in ogni momento:
ad ogni fase di lavoro corrisponde una cerimonia di propiziazione che vede come
protagonisti gli spiriti, o quelli del sacerdote, o quelli degli antenati del lignaggio. Se
casualmente, le precipitazioni non sono state sufficienti e il pericolo della siccità
incombe, si compie il “gahul emìt”: “Letteralmente gahul emìt sta per ‘far piangere
il cielo’, ed è l’implorazione che tutte le donne del Mof Evvì fanno ad “ata emìt”,
colui che manda la pioggia”41.
Da quanto detto emerge come
la risicultura, come il ciclo agricolo in
generale, scandisca il ritmo della vita sociale. Tale attività è così inserita nel contesto
religioso per cui lo stesso lavoro nelle risaie è considerato un rito che rinsalda il
rapporto tra uomo e natura.
41
Ivi, p. 90
136 Arriviamo ora al modo di vita domestico, iniziando con l’individuare i principali tipi
di abitazione: il “gasurumal” (la tradizionale casa ad impluvium)42, i “fulumet”
costituiti da gruppi di case raccolte attorno a uno spiazzo centrale e i “sundo”, case
isolate.
La cooperazione era la principale forma di attività produttiva, di cui il
gasurumal è l’insieme delle piccole unità di produzione, poste sotto il patronato
dell’anziano del villaggio, l’ ”anafan”, figura centrale attorno a cui si imperniavano
tutte le attività economiche, politiche e sociali, tuttavia senza cadere mai nel ruolo di
accentratore del potere. Al giorno d’oggi sono quasi scomparse le famiglie
organizzate secondo le regole della tradizionale famiglia estesa che abita il
gasurumal. Essa col tempo si è trasformata in una forma di famiglia contemporanea
basata sul nucleo, conseguenza questa dei massicci fenomeni di fuga dal villaggio. I
sincretismi ed il dinamismo che oggi coinvolgono la comunità Joola di quest’area,
sono osservabili soprattutto attraverso le trasformazioni che l’istituzione familiare sta
vivendo. Il più stretto contatto con i centri urbani e le migrazioni di giovani verso
essi, riducono, in particolari periodi dell’anno, i villaggi a comunità popolate solo da
giovanissimi ed anziani. Tale fenomeno ha di conseguenza causato un parziale
abbandono delle terre coltivate (essendo i giovani la forza lavoro più importante),
anche se il fenomeno dell’importazione di riso a basso costo dai paesi asiatici ha
contribuito in maniera non trascurabile.
Se il gasurumal ospitava una unità produttiva composita, le unità di base
composte dalle famiglie nucleari, operavano in modo coordinato per procurarsi il
sostentamento, con il nuovo modello di aggregazione del vicinato, il “fulumet”,
l’aspetto economico-produttivo passa in secondo piano, sostituito da una forma di
coesione politico-ideologica fondata sul vincolo di sangue e il senso di appartenenza
al gruppo (dinamica che nel modo di vita del gasurumal era secondaria). Il fulumet
è genericamente composto da abitazioni monofamiliari che ospitano i singoli nuclei,
il “sundo”. Il passaggio dal gasurumal al fulumet implica un mutamento
nell’organizzazione produttiva. Mentre, infatti, il gasurumal era organizzato in modo
da coordinare i singoli nuclei produttivi che lo componevano, il sundo costituisce di
per sé una singola unità produttiva organizzata in base alle sole forze produttive che
137 lo compongono. Un passaggio che, anche se con qualche forzatura, potrebbe essere
definito pre-moderno, nella misura in cui si evidenzia il passaggio da una forma
economica di cooperazione (quella del gasurumal), ad una economia familiare
imperniata sul nucleo essenziale; le stesse risaie, non sono più proprietà comune, ma
delle singole unità produttive.
Il gasurumal è quindi la prima forma abitativa assunta dagli insediamenti nel
Mof Evvì. Pensata per ospitare le decine di componenti della tradizionale famiglia
estesa, essa sembra essersi ridotta nelle dimensioni col tempo, passando da enormi
case collettive alle dimensioni più recenti che ospitano si e no una dozzina di
persone. “Si potrebbe ipotizzare che il processo di frammentazione del gasurumal
diede vita a famiglie autonome che poi hanno prodotto le altre due forme abitative”43
(forse in conseguenza della crescente pressione demografica che spinse alcuni a
cercare nuovi luoghi da mettere a coltura e a formare nuovi insediamenti).
L'originalità
e
la qualità
architettonica offerte
da
questo particolare
tipo
di costruzione, si trova principalmente nella pianta architettonica circolare, con un
giardino centrale a cielo aperto. La creazione di un cortile al centro dell'edificio, ha
un triplice significato. Crea un luogo di incontro promuovendo una maggiore
coesione sociale dei membri della famiglia. Permette anche alla luce di penetrare
nel cuore della casa e, infine, fornisce una ventilazione che consente una buona
circolazione dell'aria.
Il gasurumal era una casa nella quale vivevano oltre ai genitori, anche i figli
sposati, con le loro rispettive famiglie. Tre generazioni convivevano nello stesso
spazio costituendo veri e propri segmenti di lignaggio. Inizialmente infatti esso era
composto da una grande famiglia estesa composta da un elevato numero di persone
legate da vincoli parentali, in grado di trasformare le terre per renderle produttive
attraverso una stretta cooperazione tra tutti i suoi membri. Tale unità economica di
base era guidata dall’anafan, l’anziano del villaggio. Le grandi imprese (dighe e
canali di drenaggio) utili per tutta la comunità del Mof Evvì, erano eseguite da una
forma di cooperazione che coinvolgeva le famiglie estese di più gasurumal.
La tradizionale famiglia estesa, ospitata da quest’abitazione, si basava sull’idea di
coesione sociale e politica che a sua volta si fondava sulla consapevolezza di
43
Ivi, p. 104
138 discendere da uno stesso antenato, e sul possesso comune di una porzione di
territorio da adibire a risaie. Gli elementi sociali ed economici erano dunque
strettamente interrelati (“embedded”, direbbe Polany), anche se l’aspetto
predominante era costituito dai vincoli di sangue che definivano l’appartenenza al
gruppo e di conseguenza il diritto di accedere alla terra. Qualsiasi individuo si
colloca nella società in base ai rapporti di parentela che ha instaurato con altri. I fatti
politici o economici possono rientrare nella categoria della parentela proprio perché
tengono costantemente conto del contesto parentale in cui si essi realizzano.
L’organizzazione della produzione, quindi, non può prescindere dalle relazioni di
parentela che la definiscono. Godelier44, a tal proposito, considerava la parentela non
come l’elemento determinante all’interno della società tradizionali, bensì come un
elemento dominante in riferimento alle forme dell’organizzazione materiale, alle
forme della produzione e a quelle delle rappresentazioni collettive.
L’appartenenza ad un gasurumal o ad un lignaggio non solo dava diritto
all’uso delle terre da risaia ma anche all’uso degli spazi per cacciare o raccogliere
frutta, legna, ecc. Il riconoscimento del diritto a coltivare era basato sul “diritto del
fuoco”(esclusività dell’uso della terra ai discendenti che l’avevano scoperta), “il
diritto d’ascia” (diritto a dissodare terre non ancora utilizzate) e infine “la relazione
“shil” (rapporto di possesso con la risaia, ma anche obbligo di coltivarla – così che
se qualcuno abbandonava la risaia ne perdeva il possesso e la stessa ritornava di
patrimonio comune)45.
Il gasurumal funzionava quindi come un’unità produttiva residenziale che
operava sul territorio mettendo in atto due diverse forme di cooperazione, una di
utilità collettiva tra i diversi gasurumal, e l’altra tra i membri dello stesso gasurumal,
per la manutenzione dello stesso e delle risaie. All’interno quindi delle dinamiche del
modo di vita domestico, si realizza le gestione dei rifiuti che riguarda principalmente
due insiemi di spazi: quello interno del gasurumal e quello esterno, “etam”. Riguardo
alla gestione domestica dei rifiuti prodotti nel gasurumal, è la donna ancora la
protagonista e responsabile di tale processo. E’ essa che provvede a tenere, prima di
tutto, pulito lo spazio domestico (le donne del Mof Evvì, si integrano nella vita di
villaggio, organizzandosi in associazioni di genere. Nei singoli villaggi esse
44
45
Cfr., M. Godelier, Sulle società precapitalistiche”, Feltrinelli, Milano, 1976
P. Palmeri, Tra i diola del Mof Evvì : cronaca di una ricerca antropologica in Senegal, op. cit.
139 discutono e propongono scelte, così da influire sulle decisioni da prendere. Inoltre
esse si organizzano in gruppi di aiuto reciproco per i lavori agricoli in campi
collettivi. I proventi servono per le feste annuali o per promuovere e gestire iniziative
d’interesse comune).
Il “gatounoum” è una sorta di raccoglitore di rifiuti domestici che si trova
all’interno del gasurumal che, insieme alle acque usate prodotte dal “foukhalab” (che
è lo spazio domestico per lavarsi), viene svuotato nel “ganner”, che è il luogo esterno
al gasurumal dove si gettano i rifiuti prodotti all’interno dell’abitazione; esso
coincide con quella parte di etam in cui, durante la stagione dei lavori agricoli, si
custodiscono i bovini. Da qui, periodicamente, soprattutto poco prima della stagione
delle piogge, è la donna che provvede a raccogliere tutti i rifiuti organici, scarti
alimentari e animali, a bruciarli e, con gli stessi, concimare i campi di riso (si tratta
della pratica del “fougnoulem”).
La proprietà e la responsabilità comune di etam impone, inoltre, la cura degli spazi
comuni quali strade, stalle, luoghi sacri, ecc. Il “bisse” è uno slargo sufficientemente
lontano dalla casa che era usato come bagno. Qui, periodicamente, venivano portati i
maiali che avevano la doppia funzione di nutrirsi e di “ripulire”.
L’estrema cura che la cultura diola dedica all’igiene e alla pulizia, è individuabile
anche da un punto di vista “disciplinare”, come abbiamo accennato in principio. A tal
proposito, l’esistenza di un “dispositivo disciplinare” come il feticcio del “finnir”, ha
una sua funzionalità specifica in rapporto all’osservanza di prescrizioni igieniche e
sanitarie che riguardano l’intreccio tra puro/impuro, sacro e “pulito”.
Riguardo la definizione che qui vogliamo impiegare di feticcio, l’ antropologia ci
spiega come l’analisi teologica dei colonialisti del XVI secolo fosse un errore che
sottovalutava grossolanamente la cultura dei paesi colonizzati. Ma fu proprio in
questa accezione - il grado estremamente primitivo della coscienza religiosa, in cui la
divinità non solo non è unica né personalizzata ma nemmeno costante e
sostanzialmente diversa dalle cose del mondo - che la nozione di feticismo ebbe
successo nel pensiero europeo. L’idea fu ripresa da Auguste Comte, nel suo tentativo
di periodizzare la coscienza, dalla superstizione alla scienza. Feticismo era per lui il
livello più basso del pensiero religioso. L'uomo primitivo concentrava i timori verso
140 fenomeni imprevedibili e incontrollabili della natura, e ne faceva il proprio oggetto di
culto superstizioso.
Il
pensiero etnologico per decenni ha interpretato il feticismo come
un'espressione particolare di religiosità primitiva, fondata sulla paura e
sull'ignoranza, e caratterizzata dall'incapacità di elevarsi a forme più raffinate,
spiritualizzate, di riflessione religiosa. Tuttavia, questa concezione si è rivelata ben
presto insoddisfacente e pericolosamente generica con l’accumularsi delle
conoscenze sui sistemi culturali e simbolici da cui erano tratte le esemplificazioni di
culto.
Mauss con un articolo del 1908, affermava con chiarezza che l'oggetto impiegato
come feticcio non è mai un oggetto qualsiasi: esso non viene scelto arbitrariamente,
ma la sua specifica funzione simbolica è definita dal codice magico o religioso di cui
fa parte. L'oggetto-feticcio non ha nulla di paradossale e di straordinario in sé, purché
lo si riconduca al contesto sociale e simbolico all'interno del quale assume un proprio
senso. La sua specifica funzione simbolica è definita dal codice magico o religioso di
cui fa parte. La fede nell’esistenza di uno o più principi che sopravvivono al corpo,
tipica dell’animismo, deve tener conto anche dell’azione buona o cattiva della
“natura animata di ciascun frammento isolabile”46 a seconda che si sappia o meno
propiziarselo.
La religione neroafricana ha carattere familiare e locale. E’ infatti opportuno
venerare in primo luogo gli antenati del gruppo o le potenze che popolano quella
particolare porzione di spazio che esso ha scelto come habitat.
”Il culto della terra corrisponde quindi al culto dell’anima della parcella di terreno
acquisita dall’antenato e trasmessa di generazione in generazione, in cui il patto
sacrificale concluso dall’antenato con la divinità del terreno deve essere rinnovato
ogni qualvolta si ha bisogno dei suoi servizi. Sovente l’anima della parcella di
terreno si confonde con quella dell’antenato stesso: di qui l’assenza di un confine
netto tra il culto agreste e quello dei morti”47.
Il feticcio del finnir, dal canto suo, è di origine divina (perché rappresentato dagli
spiriti), e si manifesta attraverso una “materializzazione ambientale”: esso si trova in
determinate strade, in determinati punti sacri della foresta. La sua è una funzione
46
47
M. Leiris, L’occhio dell’etnografo. Razza e altri scritti 1929 – 1968, op. cit., p. 175
Ivi, p.176
141 negativa, che prescrive ciò che non si può fare: non si possono violare norme
igieniche, soprattutto in relazione alla sacralità di certi luoghi e al rapporto tra puro e
pericoloso.
Il finnir è il responsabile della “sporcizia”, sia morale che fisica (in questo
senso è collegato ad altri feticci, come lo “yeel”, che regola le questioni di
immoralità, il “baccin” e l’ “epan”, che sono rispettivamente il feticcio per gli
uomini e quello per la donna). La natura disciplinare di tale dispositivo estende il suo
effetto anche a spazi non ufficialmente coperti dalla sua presenza: ad esempio la
donna indisposta, oltre al divieto di percorrere determinate strade e all’obbligo di
seguire determinati tragitti, non può cucinare, toccare strumenti da cucina, né sedersi
al tavolo insieme agli altri per mangiare.
Il “gauloutdo” è il percorso che la donna deve seguire durante il periodo del ciclo
mestruale. Anche per l’uomo c’è il divieto di toccare la donna durante questi giorni.
Il solo sfiorarla può essere fonte di disgrazie non solo per lui stesso, ma per l’intera
comunità. Non solo il sangue mestruale, ma la vista stessa del sangue
è
genericamente interdetta (se qualcuno si ferisce, se c’è un incidente, è vietato
guardare il sangue, salvo a chi presta soccorso).
Questa problematica del sangue va analizzata in rapporto ai concetti di
purezza e pericolo48. Possiamo però tentare di individuare il primordiale pregiudizio
legato al sangue, da un punto di vista della “riproduzione sociale” e dell’impurità,
facendo riferimento a studi antropologici che riguardano questo tema. Se la perdita di
sangue significa per la donna la perdita momentanea di fertilità, tale perdita può
pregiudicare la riproduzione della comunità.
Marcel Griaule49 nel celebre libro “Dio d’acqua”, racconta la sua esperienza,
l’iniziazione di un occidentale alle conoscenze esoteriche di una cultura africana.
Egli tenta di ricostruire l’universo di pensiero dei Dogon delle Falesie di Bandiagara
nel Mali centro-orientale, attraverso gli incontri con un anziano cacciatore di nome
Ogotemmêli, che, dopo quindici anni di presenza sul terreno da parte di Griaule e
della sua equipe, decide di rivelargli gli elementi essenziali del pensiero Dogon.
48
49
Cfr., M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit.
M. Griaule, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, Bollati Boringhieri, Torino, 2008
142 Il mito appare quindi come un sistema ordinato che riflette ogni azione
sociale e pratica, attraverso la ricostruzione della storia materiale. In quest’opera, per
la prima volta, il pensiero simbolico e la rete immensa di corrispondenze sono messi
in luce.
Ciò che a noi interessa sono le nozioni che si riferiscono alla persona. La dualità
dell’essere umano viene spiegata, da un parte, con l’importanza sociale dei gemelli e,
dall’altra, le istituzioni della circoncisione e dell’escissione, escogitate dalla società
per porre rimedio all’ambivalenza originale e per assicurare la riproduzione e la
fecondità. Essendo l’utero uno degli elementi principali coinvolti nel processo di
produzione cosmogonica, il suo “sfaldamento” che avviene nel processo di
mestruazione, può essere interpretato come una minaccia all’ordine dell’universo.
La struttura del sistema del mondo, è fisicamente rappresentata da quella del
granaio50. Esso, e “tutto ciò che sorreggeva era dunque l’immagine del sistema del
mondo nel suo nuovo ordine e il suo movimento era rappresentato dal movimento
degli organi interni”51. Al centro di tale sistema “un vaso di forma sferica
simboleggiava l’utero; e un altro vaso, più piccolo, ostruiva il primo. Esso conteneva
l’olio di Lamnea acida52, e rappresentava il feto; e, a sua volta, era ostruito da un
altro ancora più piccolo che conteneva profumo”53. Il profumo, agendo come una
“buona parola”, lottava contro il fetore creato dalla cattiva parola. E’ da notare, ai
fini del nostro ragionamento, che in tale struttura, il vaso uterino confina col vaso che
contiene profumo e che rappresenta l’igiene, tema che
nel pensiero Dogon è
affrontato nella dimensione olfattiva:
“… la parola54, a seconda della sua qualità, può penetrare nella donna
attraverso due aperture: l’orecchio e il sesso. La cattiva parola entra
attraverso l’orecchio, penetra nella gola, nel fegato e, alla fine, nell’utero. Il
cattivo odore del sesso femminile è la cattiva parola udita dall’orecchio”55.
50
Suddiviso in otto scomparti, rappresenta il “ventre” del mondo.
M. Griaule, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, op. cit., p. 71
52
La Lamnea acida è una pianta della famiglia degli anacardiacei.
53
Cfr., M. Griaule, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, op. cit.
54
La civiltà Dogon appare come la civiltà del verbo. La parola è di natura divina, ha una funzione
metafisica e sociale che si esprime mediante rapporti con gli elementi del cosmo e della persona.
55
M. Griaule, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, op. cit., p. 176
51
143 La cattiva parola rendeva dunque la donna momentaneamente inabile alla
procreazione, perché distruggeva il “germe d’acqua” pronto a ricevere l’apporto del
maschio.
“Il cieco aveva già detto che il verbo malvagio non si limitava ad investire
l’utero: ne esalava in effluvi che svolgevano un ruolo decisivo nei giochi della
generazione. La cattiva parola è un fetore. Essa agisce sulla forza dell’uomo.
Va dal naso alla gola e al fegato, e dal fegato al sesso”56.
La maniera per combattere la cattiva parola, quindi, era quella di mantenere una
buona igiene personale. Come appena accennato, nella rappresentazione simbolica
del sistema del mondo, al centro si trovava un vaso sferico che rappresentava l’utero,
sopra al a quale si trovava a sua volta, a guisa di coperchio, un vaso più piccolo, che
conteneva Lamnea acida, destinato all’igiene intima e simboleggiante il feto, come se
la fecondità, appunto, fosse naturalmente accoppiata all’igiene. Il resto del racconto
di Ogotemmêli riguardante il sistema delle regole igieniche non viene riportato
dall’autore.
La dicotomia tra immissione/espulsione, puro/impuro, mangiare/evacuare,
deglutire/defecare, ecc risulta molto significativa: “Ciò che viene mangiato […] è la
luce del sole. L’escremento è la notte. I soffi della vita sono le nuvole e il sangue è la
pioggia che cade sul mondo”57. Se da un lato ciò che “esce dal corpo”, gli
escrementi, sono essi stessi elementi essenziali nel processo cosmogonico, quindi
puri (“se il Nommo58 è l’acqua, egli produce anche il rame. Nel cielo coperto si
vedono materializzarsi i raggi di sole sopra l’orizzonte di nebbia; questi raggi,
escrementi dei geni, sono di rame e sono luce”59 ), dall’altro essi sono causa di
impurità, come nel caso del sangue mestruale (“… esso [l’incesto] fu inoltre causa
dell’apparizione del sangue mestruale che tinse le fibre. Lo stato della terra,
divenuta impura, era incompatibile col regno di Dio”60).
56
Ivi, p. 179
Ivi, p. 74
58
Nommo: entità divina e omogenea prodotta da Dio; esso è l’ “artigiano” dell’universo.
59
Cfr., M. Griaule, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, op. cit.
60
Ivi, p. 53
57
144 “Dopo che dio ebbe fatto la donna, le diede un sangue cattivo il cui flusso torna ogni
mese”61.
Tale era la condizione della donna, a causa dell’incesto primordiale che aveva
unito la madre terra col figlio sciacallo. Il flusso del sangue è prodotto dall’unione fra
il figlio e la madre, è cioè il frutto di una cosa proibita, di conseguenza un debito “di
sangue”con la terra, ragion per cui la donna deve versare “l’acqua del grembo di Dio
per la Terra”62. La questione della riproduzione biologica è palesata nelle ultime
pagine del libro: “La gravidanza è il segno che le buone parole sono entrate e non
sono state dipanate dall’utero. Essa è il segno che le cose procedono bene”63. La
dimensione della fecondità è trasversale, riguarda la donna, quindi la terra (la
battitura di semi o il dissodamento della terra generano fecondità).
Come rilevato nel Finnir, durante i giorni del ciclo la donna deve allontanarsi
dalla comunità. Il suo contatto contaminerebbe gli uomini. Durante il ciclo, essa abita
in una casa rotonda, simbolo dell’utero, dalla quale esce solo per le abluzioni
notturne. Deve inoltre seguire un itinerario stabilito che conduce soltanto alle acque
permesse. “Per questo i passi della donna che si trova in stato di impurità, privano
di ogni vita i luoghi che non dovrebbero calpestare”64. Emerge quindi, esattamente
come nel Finnir, l’elemento della segregazione spaziale, giustificata da una sorta di
radicalismo igienico di origine simbolica.
Se sino ad ora abbiamo analizzato la questione della “riproduzione”, concludiamo
con quella di “impurità”.
Il fatto che i tabù non siano indecifrabili, ma invece rivelano la comprensibile
preoccupazione di proteggere la società da comportamenti che potrebbero
distruggerla, mostra che i primitivi affrontano politicamente il pericolo per
salvaguardare il loro patto costitutivo.
61
Ivi, p. 183
Ibidem
63
Ibidem
64
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p. 184
62
145 In questo senso l’approccio “politico” al pulito è presente in molte culture dove il
pensiero scientifico non è diffuso. Esso persiste nella società e nel pensiero africano
tramite la biunivocità che lo lega alla categoria natura-cultura.
La casta indiana dei bramini Havik ritiene che la saliva sia il principale agente
di contaminazione. Se i cibi vengono distinti in cotti e crudi a seconda che siano o
meno portatori di contaminazione, è il cibo cotto che può trasmettere la
contaminazione. L’atto del mangiare è potenzialmente contaminante, ma è il modo
che determina il grado di contaminazione. La saliva è estremamente contaminante
perché tutto ciò che fuoriesce dal corpo è fonte di impurità. Per le pulizie che
seguono la defecazione si deve usare l’acqua e non la carta e si deve usare soltanto la
mano sinistra, mentre il cibo va mangiato solo con la mano destra.
Come spiega Mary Douglas in “Purezza e pericolo”, gli Yoruba (vasto gruppo etnolinguistico diffuso nell'Africa occidentale, soprattutto in Nigeria) usano la mano
sinistra per maneggiare tutto quello che non è pulito, “perché la destra si usa per
mangiare e la gente si rende conto del rischio di contaminazione che può derivare a
chi non osserva questa distinzione”.
L’approccio sociologico alla contaminazione “castale” è utile quando
consideriamo quali sono gli atteggiamenti privati degli indiani nei confronti della
defecazione. Secondo il rito indiano, toccare l’escremento significa essere
contaminato, di conseguenza i pulitori di latrine si trovano nel grado più basso della
gerarchia catastale. La contaminazione tra le caste appare come un sistema
simbolico, basato sull’immagine del corpo, il cui fine principale è l’ordine di una
gerarchia sociale.
In India la purezza delle caste è correlata con una complicata divisione del lavoro,
che è ereditaria. Il lavoro svolto da in ogni casta ha un peso simbolico: dice qualcosa
in merito alla condizione di relativa purezza della casta in questione. Certi tipi di
lavoro corrispondono alle funzioni escretorie del corpo, per esempio quello dei
lavandai, dei barbieri, degli spazzini.
“Non si può intraprendere l’analisi del simbolismo rituale se non si riconosce
che il rituale è un tentativo di creare e di mantenere una cultura particolare,
146 un particolare ordine di postulati attraverso il quale si controlla
l’esperienza”65.
Per concludere, riportiamo degli esempi in cui, come nel Finnir, il sangue mestruale
svolge una funzione dialettica tra sacro e impuro. Tuttavia la disparità con cui
vengono considerati i diversi aspetti del corpo nei rituali del mondo, mostra che in
certuni la contaminazione mestruale è temuta come un pericolo mortale; in altri non
lo è affatto. Secondo certi riti gli escrementi sono pericolosi; secondo altri non sono
che un oggetto di scherzo. Noi qui riportiamo, ovviamente, alcuni casi in cui
suddetto sangue costituisce un “pericolo”.
I Lele (gruppo etnolinguistico della Repubblica democratica del Congo)
parlano del feto come di uno “con le mandibole aperte” per addentare il cibo, e
spiegano il fatto con l’inevitabilità che il “seme interno” combatta con il “seme
esterno”.
Una donna non poteva cuocere il cibo o accendere il fuoco durante il periodo
mestruale, se non voleva che il marito cadesse ammalato; poteva preparare il cibo,
ma quando era il momento di metterlo sul fuoco doveva chiamare in aiuto un amica.
Questi erano i pericoli a cui solo gli uomini erano soggetti, ma non le altre donne o i
bambini. Una donna metteva in pericolo tutta la comunità se entrava nella foresta
quando aveva le mestruazioni. Non solo queste avrebbero fatto finir male qualsiasi
cosa lei avesse voluto fare nella foresta, ma si pensava che essa avrebbe creato delle
condizioni sfavorevoli per gli uomini: la caccia sarebbe stata difficile in seguito per
molto tempo, e i riti fatti con le piante della foresta non avrebbero avuto effetto.
L’angoscia dei Lele per i pericoli rituali prodotti dal sesso va considerata
come un ruolo effettivamente distruttivo assegnato al sesso nel loro sistema sociale,
afferma la Douglas. I loro uomini formavano una scala sociale i cui successivi stadi
venivano raggiunti mano a mano che essi acquisivano il controllo su un numero
sempre maggiore di donne.
Anche Andrea Caprara in “Interpretare il contagio”, riporta che presso gli
Alladian della Costa d’Avorio, il sangue mestruale è fonte di impurità, e tutta una
serie di regole raccomandano di non entrarvi in contatto66.
65
Ivi, p. 203
147 Françoise Heritier si interroga invece sulle ragioni delle somiglianze esistenti tra le
interdizioni che pesano sulle donne in periodo mestruale, e quelle che pesano sulla
vita quotidiana dei sovrani più sacri. La risposta va a suo avviso cercata in una
necessità logica e sintattica attestata dovunque tra i diversi ordini di rappresentazioni,
e che si esprime compiutamente in una meccanica dei fluidi e dei flussi, operante in
tutte le concezioni della persona e del rapporto tra il corpo biologico e la natura.
Il corpo femminile segnato ciclicamente nella circostanza del mestruo, ed
occasionalmente nel travaglio del parto, appare come un corpo vistosamente diverso,
corpo aperto, vulnerabile e vulnerato.
Partendo da una società del Burkina Fasu, Heritier indaga sui meccanismi che
giustificano la valenza differenziale tra i sessi, soffermandosi sui rapporti tra gli
umori del corpo nel processo della procreazione (latte, sangue, sperma, saliva
sudore), e i rapporti rimandano inevitabilmente a strutture.
“La logica binaria puro/impuro riguarda il corpo femminile, soprattutto sul
tema dell’impuro e della contaminazione, causati dal “corpo aperto”.
I’impurità del corpo sessuato è la base importante per la subordinazione
femminile”67.
Per gli Arapesh della Nuova Guinea, una donna indisposta deve evitare il villaggio,
il marito, il cibo (e anche il cucinarlo) ma anche se stessa. Non può attraversare il
villaggio, né camminare su una buona strada. Essa, per raccogliere igname, deve
percorrere determinati passaggi. Il sangue è pericoloso anche per l’uomo. Se esso è
vittima di un sortilegio, il sangue stesso può essere usato come antidoto grazie alle
sue qualità intrinseche.
I Maori considerano il sangue mestruale come una specie di essere umano mancato.
Se il sangue non fosse andato perduto sarebbe diventato una persona, e così si trova
ora nell’impossibile condizione di persona morta pur non essendo mai vissuta: a
questo proposito riferisce una diffusa credenza, secondo cui il feto morto
66
Cfr., A. Caprara, Interpretare il contagio. Una indagine storico-etnografica sulle pratiche mediche
presso gli Alladian della Costa d’Avorio, op. cit.
67
Cfr., F. Heritier, Masculin/féminin : la pensée de la différence, Odile Jacob, Parigi, 1996
148 prematuramente possiede uno spirito malevolo, pericoloso per i viventi. “Il pericolo
sta negli stati di transizione, semplicemente perché la transizione non è più uno stato
e non è ancora l’altro: è indefinibile”68.
I Nyakyusa (gruppo etnolinguistico del sud della Tanzania) non tollerano lo
sporco, ma sono profondamente sensibili alla contaminazione: essi osservano
complicate restrizioni, allo scopo di evitare ogni contatto con i rifiuti fisiologici, che
considerano estremamente pericolosi.
Il contatto con il sangue mestruale è pericoloso per l’uomo, specie se questi è un
guerriero: di qui le complesse restrizioni sul modo di cucinare il cibo per un uomo,
durante le mestruazioni della donna.
Ma, a dispetto di questa astensione normale, l’atto centrale del cerimoniale di lutto
consiste nell’accogliere positivamente l’immondizia che i Nyakyusa buttano addosso
ai parenti del morto. L’immondizia è il “sudicio della morte”, è l’impuro: “Che
venga ora, che non venga in seguito, che non ci prenda mai la follia. Vi abbiamo
dato ogni cosa, abbiamo mangiato l’immondizia sulla terra”69. La follia è associata
all’immondizia e all’azione di mangiare feci proprio in virtù di quella
contrapposizione tra dentro e fuori, mondo e immondo, sporco e pulito. Così come la
follia è al di fuori della “normalità” a causa di un “deterioramento della ragione”,
così i rifiuti rappresentano la corruzione della materia, la putrescenza.
La disparità con cui vengono considerati i diversi aspetti del corpo nei rituali
del mondo, mostra che in certuni la contaminazione mestruale è temuta come un
pericolo mortale; in altri non lo è affatto.
Secondo certi riti gli escrementi sono pericolosi; secondo altri non sono che un
oggetto di scherzo.
68
69
M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, op. cit., p.159
Ivi, p. 268
149 BIBLIOGRAFIA
Augè M. (2002): “Il dio oggetto” Meltemi, Roma
Bachì Sanè B.: “La gestion des déchets solides urbaines, la moltiplication des
intervention constitue un handicap” Articolo del 26/10/2007, Le Soleil
Badji A. S. (2007) : “Gestion des déchets et des eaux uses” Memoire de maitrise,
Universitè Gaston Berger, Saint Louis
Barnwells A. (1998): “Les implications des changements du modèle d’habitation sur
la gestion des déchets solide a Yoff” Enda-Rup, Dakar
Baudrillard J. (1976): “La società dei consumi” Il Mulino, Bologna
Bavoux J. (1998): “Géographie humaine des littoroux marittime” Armand Colin,
Parigi, 1998
Bottazzi G. (2009): “Sociologia dello sviluppo” Laterza, Roma-Bari
Bourdieu P. (2009): “Il dominio maschile” Feltrinelli, Milano
Calvino I. (2003): “ “Romanzi e racconti” vol. III, I Meridiani, Milano
Calvino I. (2010): “Le città invisibili” Mondadori, Milano
Camera dei Deputati : “Atti Parlamentari” - 4766 - XV Legislatura – Allegato B ai
resoconti - Seduta del 26 Marzo 2007
Caprara A. (2001): “Interpretare il contagio. Una indagine storico-etnografica
sulle pratiche mediche presso gli Alladian della Costa d’Avorio” Argo, Lecce
Cissè O. (2007): “L’argent des déchets” Karthala-Crepos, Dakar
Codeluppi V. (2006): “Manuale di sociologia dei consumi” Carocci, Roma
De Sardan O.J.P (2008): “Antropologia e sviluppo. Saggio sul cambiamento
sociale” Raffaello Cortina editore, Milano
Devoto G. e Oli G. C. (1995): “Il dizionario della lingua italiana” Le Monnier,
Firenze
Dia El Hadji B. (2003) : “Impact de la dynamique populaire face aux contraintes
d’aménagement du territoire dans la banlieu de Dakar: l’example de Yoff-Ndenatt”
Memoire de Dea, Chaire-Unesco, Dakar
Diatta M. (2007): “Dynamique de formalization du secteur informal senegalais”
Universitè Gaston Berger, Saint Louis
Diop Coumba M. (a cura di) (2002): “Le Senegal contemporain” Karthala, Parigi
150 Diop Coumba M., D.G. O’Brien, M. Diouff (2002): “La construction de l’ètat au
Senegal” Karthala, Parigi
Diop U. E. (1992): “Gestion des déchets urbaines: la problématique africaine”
Iagu, Dakar
Douglas M. (2006): “Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e
tabù” Il Mulino, Bologna
Falk Moore S. (2004): “Antropologia e Africa” Raffaello Cortina editore, Milano
Fanon F. (2007): “I dannati della terra” Piccola Biblioteca Einaudi, Torino
Fassin D. (1996): “L'espace politique de la santé: Essai de généalogie” Presses
Universitaires de France, Parigi
Foucault M. (2009): “Bisogna difendere la società” Feltrinelli, Milano
Foucault M. (2004): “Sicurezza, territorio, popolazione” Corso al Collège de
France-1977-78 Feltrinelli, Milano
Foucault M. (2006): “Utopie eterotopie” Rasoi, Napoli
Friedman J. (2005): “La quotidianità del sistema globale” Mondadori, Milano
Gianturco G. (2005): “L’intervista qualitativa. Dal discorso al testo scritto” Guerini
scientifica, Milano
Godelier M. (1976): “Sulle società precapitalistiche” Feltrinelli, Milano
Griaule M. (2008): “Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli” Bollati boringhieri,
Torino
Gruppi L. (1972): “Il concetto di egemonia in Gramsci” Editori Riuniti, Roma
Harris M. (1984): “Materialismo culturale. La lotta per una scienza della cultura”
Feltrinelli, Milano
Heritier F. (1996): “Masculin/féminin: la pensée de la différence” Odile
Jacob, Parigi
Illich I. (1974): “La convivialità” Mondadori, Milano
Latouche S. (2011): “Come si esce dalla società dei consumi” Bollati Boringhieri,
Torino
Latouche S. (2009): “Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana”
Edizioni Dedalo, Bari
Latouche S. (2004): “Il pianeta dei naufraghi” Bollati Boringhieri, Torino
151 Leiris M. (2005): “L’occhio dell’etnografo. Razza e altri scritti 1929 - 1968” Bollati
Boringhieri, Torino
Lévi-Strauss C. (2008): “Il crudo e il cotto” Il saggiatore, Milano
Lévi-Strauss C. (2010): “Il pensiero selvaggio” Il saggiatore, Milano
Lèvi-Strauss C. (2010): “Le origini delle buone maniere a tavola” Il saggiatore,
Milano
Lévi-Strauss C. (2008): “Tristi tropici” Il Saggiatore, Milano
Ly E. O. (1997): “La partecipation de la communatè à la gestion des déchets
solides au Senegal” Enda, Dakar
Malighetti R. (a cura di) (2007): “Oltre lo sviluppo” Meltemi, Roma
Marzocca O. (a cura di) (2005): “Lessico di biopolitica” Manifesto Libri, Roma
Marx K. (1973): “Manoscritti economico-filosofici del 1844” Einaudi, Torino
Marx K. (1969): “Per la critica dell'economia politica” Editori riuniti, Roma
Marx K. (1964): “Il capitale: libro terzo” Editori Riuniti, Roma
Mbaye N. (2008): “La gestion des ordures a Dakar: étude du cadre global d’un
système, de la nature et place des acteurs intervenant dans le foncionemment du
service” Ufr des lettres et sciences humaines, section de sociologie, Universitè
Gaston Berger, Saint Louis
Mead M. (2002): “The mountain Arapesh” Transaction Publishers, Piscataway
Meillassoux C. (1983): “Donne, granai e capitali. Uno studio antropologico
dell’imperialismo contemporaneo” Zanichelli, Bologna
Mellino M. (2005): “La critica post-coloniale. Decolonizzazione, capitalismo e
cosmopolitismo nei postcolonial studies” Meltemi, Roma
Ndeye B. L. (2005) : “Problématique de l’assainissement dans la commune
d’errondissement de Yoff: état des lieux d’un espace fragile” Memoire de maitrise,
Universitè Chiech Anta Diop, Dakar
Onibokun A. G. et Kumuyi A. J. (2002): “La gouvernance et la gestion des déchets
en Afrique” , in “La gestion des déchets urbains. Des solutions pour l’Afrique” Crdi
– Karthala, Dakar
Palmeri P. (2011): “Lezioni di antropologia dello sviluppo – Parte I. L’elisse delle
società tradizionali nel tempo della globalizzazione” Nuova Cultura, Roma
152 Palmeri P. (2008): “Tra i diola del Mof Evvì : cronaca di una ricerca antropologica
in Senegal” Cleup, Padova
Pavanello M. (1992): “Sistemi umani. Profilo di antropologia economica e di
ecologia culturale” Cisu, Roma
Pinna L. (2011): “Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata
dai rifiuti” Bollati Boringhieri, Torino
Polany K. (1974): “La grande trasformazione” Einaudi, Torino
Polany K. (1980): “Economie primitive, arcaiche e moderne” Einaudi, Torino
Rapport final d’activités, Projet PURE «Dakar, Ville Ciblée» 2006-2010 Crdi-Iagu,
Dakar
Rifkin J. (1992): “Entropia. Il che fare per salvare il mondo” Interno giallo Editore,
Milano
Rossetti C.G. (1979): “Antropologia del dominio coloniale e sviluppo democratico”
Liguori editore, Napoli
Ruini M. (a cura di) (2008): “Caleidoscopio” Bulzoni editore, Roma
Ruini M. (a cura di) (2009): “Interpretare lo sviluppo. Note di socioantropologia”
Bulzoni Editore, Roma
Sachs W. (2004): “Dizionario dello sviluppo” Edizioni Gruppo Abele, Torino
Sall O. (1999): “La gestion des déchets a Dakar: perceptions et effects
environnementaux” These de doctorat de geographie, Universitè Cheich Anta Diop,
Dakar
Sahlins M. (1994): “Cultura e utilità” Anabasi, Milano
Sambou G. (2010): “Les éleveurs de porcs recycleurs de déchets organiques à
Mbeubeuss : entre désespoir et quête d’une vie meilleure” Universitè Cheich Anta
Diop, Dakar
Sarr Cheich (2005): “Les ordures ménagères dans les villes senegalais” Enda,Dakar
Sibilla P. (1996): “Introduzione all’antropologia economica” Utet, Torino
Sy Ibrahima (2006): “Gestion de la salubritè a Rufisque. Enjeux sanitares et
pratiques urbane” These doctorale, Universitè L. Pasteur, Strasburg
Transberg Hansen K. (2000): “Salaula: The World of Secondhand Clothing and
Zambia” The University of Chicago Press books, Chicago
153 Treccani (1987): “Vocabolario della lingua italiana” Istituto della Enciclopedia
italiana, Roma
UN-Habitat (2008): “State of the World’s Cities 2008/2009. Harmonious cities”
United Nations Human Settlements Programme, Londra
UN Report: “World´s biggest cities merging into mega-regions”, Articolo del
22/03/2010, The Guardian
154 1
1. Cartina del Senegal. In rosso la Casamance
155