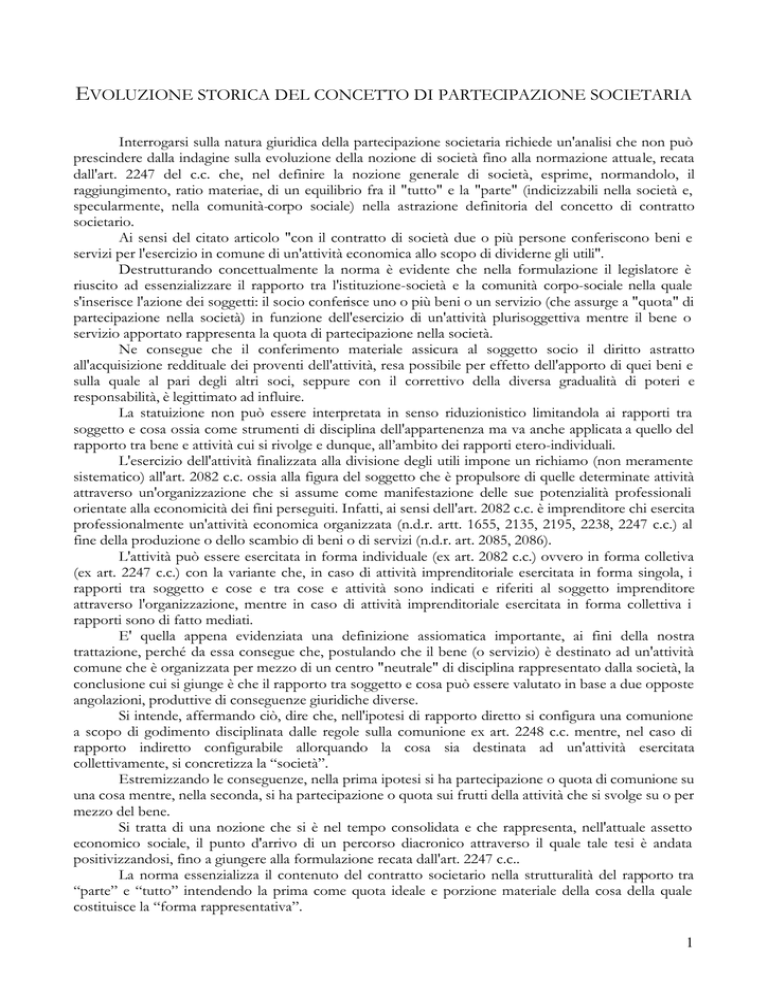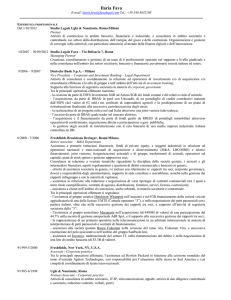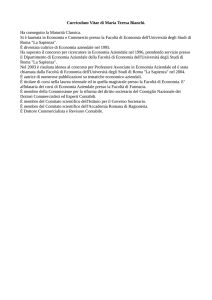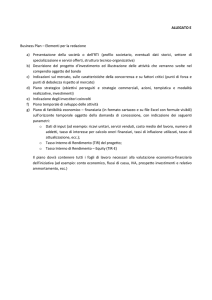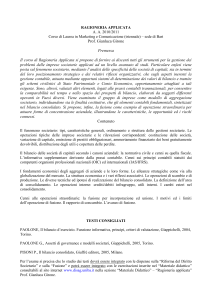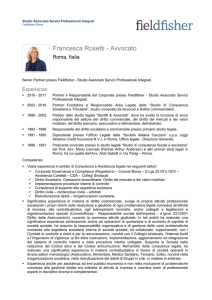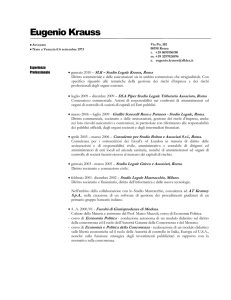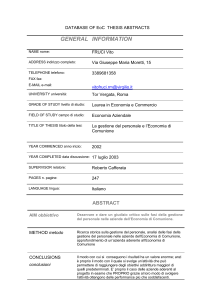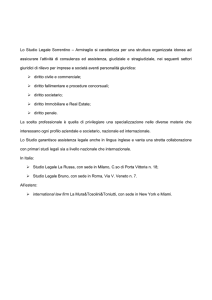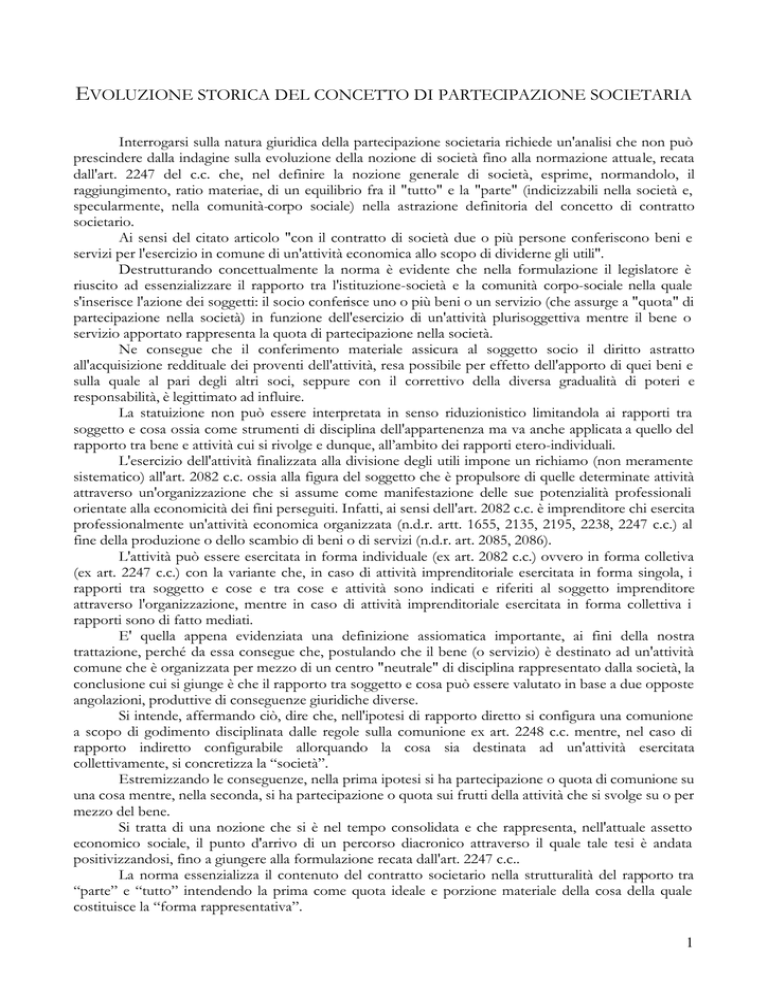
EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Interrogarsi sulla natura giuridica della partecipazione societaria richiede un'analisi che non può
prescindere dalla indagine sulla evoluzione della nozione di società fino alla normazione attuale, recata
dall'art. 2247 del c.c. che, nel definire la nozione generale di società, esprime, normandolo, il
raggiungimento, ratio materiae, di un equilibrio fra il "tutto" e la "parte" (indicizzabili nella società e,
specularmente, nella comunità-corpo sociale) nella astrazione definitoria del concetto di contratto
societario.
Ai sensi del citato articolo "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e
servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".
Destrutturando concettualmente la norma è evidente che nella formulazione il legislatore è
riuscito ad essenzializzare il rapporto tra l'istituzione-società e la comunità corpo-sociale nella quale
s'inserisce l'azione dei soggetti: il socio conferisce uno o più beni o un servizio (che assurge a "quota" di
partecipazione nella società) in funzione dell'esercizio di un'attività plurisoggettiva mentre il bene o
servizio apportato rappresenta la quota di partecipazione nella società.
Ne consegue che il conferimento materiale assicura al soggetto socio il diritto astratto
all'acquisizione reddituale dei proventi dell'attività, resa possibile per effetto dell'apporto di quei beni e
sulla quale al pari degli altri soci, seppure con il correttivo della diversa gradualità di poteri e
responsabilità, è legittimato ad influire.
La statuizione non può essere interpretata in senso riduzionistico limitandola ai rapporti tra
soggetto e cosa ossia come strumenti di disciplina dell'appartenenza ma va anche applicata a quello del
rapporto tra bene e attività cui si rivolge e dunque, all’ambito dei rapporti etero-individuali.
L'esercizio dell'attività finalizzata alla divisione degli utili impone un richiamo (non meramente
sistematico) all'art. 2082 c.c. ossia alla figura del soggetto che è propulsore di quelle determinate attività
attraverso un'organizzazione che si assume come manifestazione delle sue potenzialità professionali
orientate alla economicità dei fini perseguiti. Infatti, ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata (n.d.r. artt. 1655, 2135, 2195, 2238, 2247 c.c.) al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (n.d.r. art. 2085, 2086).
L'attività può essere esercitata in forma individuale (ex art. 2082 c.c.) ovvero in forma colletiva
(ex art. 2247 c.c.) con la variante che, in caso di attività imprenditoriale esercitata in forma singola, i
rapporti tra soggetto e cose e tra cose e attività sono indicati e riferiti al soggetto imprenditore
attraverso l'organizzazione, mentre in caso di attività imprenditoriale esercitata in forma collettiva i
rapporti sono di fatto mediati.
E' quella appena evidenziata una definizione assiomatica importante, ai fini della nostra
trattazione, perché da essa consegue che, postulando che il bene (o servizio) è destinato ad un'attività
comune che è organizzata per mezzo di un centro "neutrale" di disciplina rappresentato dalla società, la
conclusione cui si giunge è che il rapporto tra soggetto e cosa può essere valutato in base a due opposte
angolazioni, produttive di conseguenze giuridiche diverse.
Si intende, affermando ciò, dire che, nell'ipotesi di rapporto diretto si configura una comunione
a scopo di godimento disciplinata dalle regole sulla comunione ex art. 2248 c.c. mentre, nel caso di
rapporto indiretto configurabile allorquando la cosa sia destinata ad un'attività esercitata
collettivamente, si concretizza la “società”.
Estremizzando le conseguenze, nella prima ipotesi si ha partecipazione o quota di comunione su
una cosa mentre, nella seconda, si ha partecipazione o quota sui frutti della attività che si svolge su o per
mezzo del bene.
Si tratta di una nozione che si è nel tempo consolidata e che rappresenta, nell'attuale assetto
economico sociale, il punto d'arrivo di un percorso diacronico attraverso il quale tale tesi è andata
positivizzandosi, fino a giungere alla formulazione recata dall'art. 2247 c.c..
La norma essenzializza il contenuto del contratto societario nella strutturalità del rapporto tra
“parte” e “tutto” intendendo la prima come quota ideale e porzione materiale della cosa della quale
costituisce la “forma rappresentativa”.
1
Volendo lasciare spazio alla filosofia dogmatica romana l'affermazione si presta a una duplice
riflessione come postulato: mentre la parte divisa è nel contempo “parte” e “tutto” lo stesso non può
dirsi della parte indivisa.
Si è soliti infatti affermare in filosofia giuridica che l'oggetto esterno e percepibile non è un
intero, né una parte, dal momento che l'intero è un “relativo” perché viene concepito come tale solo in
funzione della parte con la quale si relativizza.
Ne deriva, seguendo il pensiero di Sesto Empirico, che “a loro volta anche le parti sono relative,
perché solo in relazione con l'intero si concepiscono come parti” ovvero che “i relativi esistono nella
nostra associazione mnemonica e la nostra associazione mnemonica è in noi” per cui “l'oggetto esterno
e percepibile non è né un intero né una parte ma un ente al quale noi assegniamo come predicato la
nostra stessa associazione mnemonica”.
La concettualizzazione è davvero audace ma perfettamente condivisibile se ci si cala nella
situazione di contesto nella quale è stata elaborata. Affermare che la "pars divisa" è nel contempo un
tutto e una parte in ragione dell'angolazione nella quale ci si pone non crea alcuna collisione ed
entrambe le affermazioni si assumono come deduzioni assiomatiche della nozione di parte come
rappresentazione neutrale riferita a cose materiali come, ad esempio, la “gens” o “l’agnatio”.
Il concetto viene in parte utilizzato dai canonisti del dodicesimo secolo i quali si riferiscono alle
strutture degli enti collettivi per sviluppare un nuovo sistema di diritto societario da estendere alla
istituzione “Chiesa”.
Il rapporto società-singoli viene sistematizzato e vengono definiti anche i rapporti tra società e
rappresentanti in funzione della prioritaria considerazione che la società non è dei singoli e che "se
qualcosa è dovuto alla società non è dovuto ai singoli né l'individuo possiede ciò che la società
possiede” viene, infatti, riconosciuta alla società la capacità di agire per mezzo dei suoi rappresentanti e
dunque l'implicita distinzione tra i diritti e doveri facenti capo alla società e quelli facenti capo ai suoi
rappresentanti.
Ma la ideologizzazione di una tale forma societaria elide i canoni della concezione cristiana della
natura sociale della comunità ecclesiale fondata sulla condivisione della proprietà comune e con un
altrettanto comune responsabilità per le obbligazioni contratte.
Il consolidamento del potere della Chiesa portò al radicarsi di una nuova definizione di ente
giuridico societario, avulso dalle impostazioni sostenute dai canonisti e da quelle romane della società
come astrazione artificiale (austalt) alle quali pure s'affianca.
La società di ispirazione ecclesiale ha come necessari elementi di identificazione un gruppo di
persone, la comunione dei beni e un "capo" con distinti diritti rispetto alla società, legittimato a svolgere
tutta quella attività che la società per proprio limite fisiologico non poteva svolgere.
Il fondamento di tale conclusione riposa nel processo osmotico che lega le volontà che
partecipano al gruppo per identificarsi con esso. Pur non concependo la società dai membri come nella
concezione romanistica i canonisti giungono alla conclusione che il gruppo non può avere una
personalità o una volontà distinta dai suoi membri.
L'impostazione dominò la concettualizzazione giuridica fino agli albori della società mercantile
medioevale ossia fino a quando non si fece sentire l'esigenza di affrancarsi dai vincoli imposti dall'etica
del mercato chiuso e si affermarono nuovi modelli organizzativi in risposta alle esigenze di dinamismo
economico imposte dalla mercatura.
In particolare emerse la necessità di trovare una nuova definizione al contratto societario, con
nuove regole di amministrazione e responsabilità, nel quale il rischio d'impresa trovasse una specifica
definizione e nella ripartizione tra stans (finanziatore) e tractator (mercante): il mercante è
illimitatamente responsabile mentre il finanziatore risponde solo nei limiti del capitale conferito.
Ma il tentativo più eloquente del mutato assetto sociale e del potere conquistato dalla nuova
classe sociale emergente fu il ribaltamento della concezione comunitaria attraverso la dissimulazione del
contratto di mutuo in contratto societario.
In altre parole qualificare come mutuo la partecipazione societaria finalizzata al riporto degli utili
conferiva liceità all’onerosità depurandola da quelle implicazioni concettuali della canonistica che
2
potevano condurre pur con ovvie forzature nell'alveo delle usure, sulle quali gravava per sempre
l'anatocismo biblico.
Attrarre le partecipazioni (commissio pecuniam) alla causa mutui significava così riconoscere
che qualunque fosse il motivo che aveva indotto le parti a soggiacere al vincolo contrattuale esse
vantavano comunque un credito alla restitutio del commissum.
La proprietà del denaro conferito (il tutto) si traduceva così nella proprietà di una quota del
capitale sociale (la parte). Viene, in altre parole, definito il rapporto tra tutto e parte attraverso la stipula
di un contratto societario in virtù del quale la proprietà del denaro conferito – che assume una precisa
funzione di mezzo di scambio - rimane al conferente sotto forma di proprietà di una quota del capitale
sociale. Una tale impostazione poteva rappresentare, nella costruzione concettuale, il giusto
compromesso tra la dissimulazione del contratto di mutuo e il peccato d'usura.
Infatti, la commissio operata nei confronti di un mercante si traduce, in realtà, in un
conferimento motivato da una causa autonoma che si oggettiva nella stipulazione del contratto
societario in virtù del quale il conferente conserva la proprietà del denaro sotto forma - attraverso lo
scambio - di proprietà di una quota del capitale sociale.
In tal modo la commissio viene assolta da ogni censura d'usura in quanto il denaro viene
utilizzato per la sua funzione principale che è quella di fungere da valore di scambio.
Il contesto giuridico pluriordinamentale che caratterizza la matrice strutturale societaria del
periodo medioevale rimane per qualche secolo
impermeabile all'evoluzione dei traffici e
alle evoluzione dei sistemi del diritto commerciale al punto che l'impronta statalista si marginalizza alle
fonti senza, tuttavia, infrangere i contenuti del diritto societario.
La statualizzazione delle fonti attraverso numerosi provvedimenti legislativi rispondevano ad
una necessità di intervento fortemente richiesto dalla classe media in rapida affermazione.
Tra la metà del sedicesimo e la fine del diciottesimo secolo le società si manifestano come
compagnie privilegiate che sono, in taluni casi, la diretta emanazione statale (come le casas portoghesi e
spagnole) e, in altri, associazioni privilegiate (è il caso delle chartered companies inglesi) alle quali si
conferiva - mediante editto o lettere patenti - uno status indipendente, dotato di personalità giuridica
fondata su statuti che codificavano i privilegi politici ed economici di cui erano dotate, in cambio
dell'obbligo di cui erano gravate di contribuire alle finanze sovrane.
Il mutato assetto sociale e i vincoli che gravavano sul riconoscimento statale non incidevano,
tuttavia, come si è detto, sulla organizzazione interna, che continuava ad essere strutturata secondo i
principi e le consuetudini proprie della mercatura medievale.
Le impostazioni storicamente compendiate ai fini dell'analisi del problema in discussione sono
censibili come antecedenti storici di rilievo per l'elaborazione dell'ideologia metodologica che ha ispirato
prime codificazioni nelle quali era evidente la soggettivazione della nozione d'impresa.
L'art. 1697 del c.c. del 1865 definiva, infatti, la società “il contratto con il quale due o più
persone convengono di mettere qualcosa in comunione, al fine di dividerne il guadagno che potrà
derivarne” e lo stesso codice di commercio del Regno d'Italia del 1865 che qualificava come
"commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale" sono una
conferma della centralità del soggetto nella prospettiva degli atti di scambio conseguenti ai rapporti
commerciali.
La costruzione personalistica viene invece oggettivata nella formulazione codicistica vigente
nella quale lo status del soggetto imprenditore viene meglio qualificato in ragione della tipologia
dell'attività svolta che costituisce espressione del regime proprietario sia con riferimento agli atti che ai
rapporti giuridici e, dunque, al regime contrattuale.
Poiché a norma dell'art. 2082 c.c., infatti, “è imprenditore chi esercita professionalmente una
attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” e, secondo il
successivo art. 2247 il quale, pur non richiamando il requisito della professionalità (ritenuto necessario
per l'esistenza dell'impresa ma non necessario per tutte le società come quelle occasionali o quelle tra
professionisti), l’esercizio in comune di un'attività economica consolida la nozione istituzionale di
società dal momento che definisce come “societario” il contratto che intercorre tra due o più persone
che conferiscono beni e servizi allo scopo di dividere gli utili derivanti dalla medesima società ne deriva
3
un'astrazione del concetto di società rispetto al contenuto oggettivo e qualificante rappresentato dalle
attività.
In questa ottica, come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 697 del
1997), anche il conferimento deve essere qualificato come immateriale (“ovvero posizione contrattuale
obiettivata, che considerata come un bene immateriale equiparabile, ai sensi dell’art. 812 c.c., ai beni
mobili materiali”) in quanto privo di essenza fisica ma espressione di astrazione del “tutto” che si
concreta in un bene altrettanto immateriale, rappresentato nel diritto ai proventi derivanti dall'attività
svolta su quei beni.
In tal senso è orientata anche la dottrina che propende per la considerazione delle partecipazioni
come conferimento immateriale di secondo grado proprio per il fatto che “la tutela assicurata dal diritto
con riferimento alle partecipazioni nei beni destinati all'esercizio dell'attività comune non concerne e
non può concernere il godimento o la disposizione dei beni (…) di primo grado, ma la probabilità della
attività cui sono destinati i beni e così anche la possibilità d'influire su detta attività, influenza che a sua
volta è strumento per la consecuzione dei redditi’’(Ascarelli).
Antonina Giordano
Funzionaria dell' Agenzia delle Entrate
Segreteria Tecnica del Comitato consultivo
per l' applicazione della norma antielusiva
4