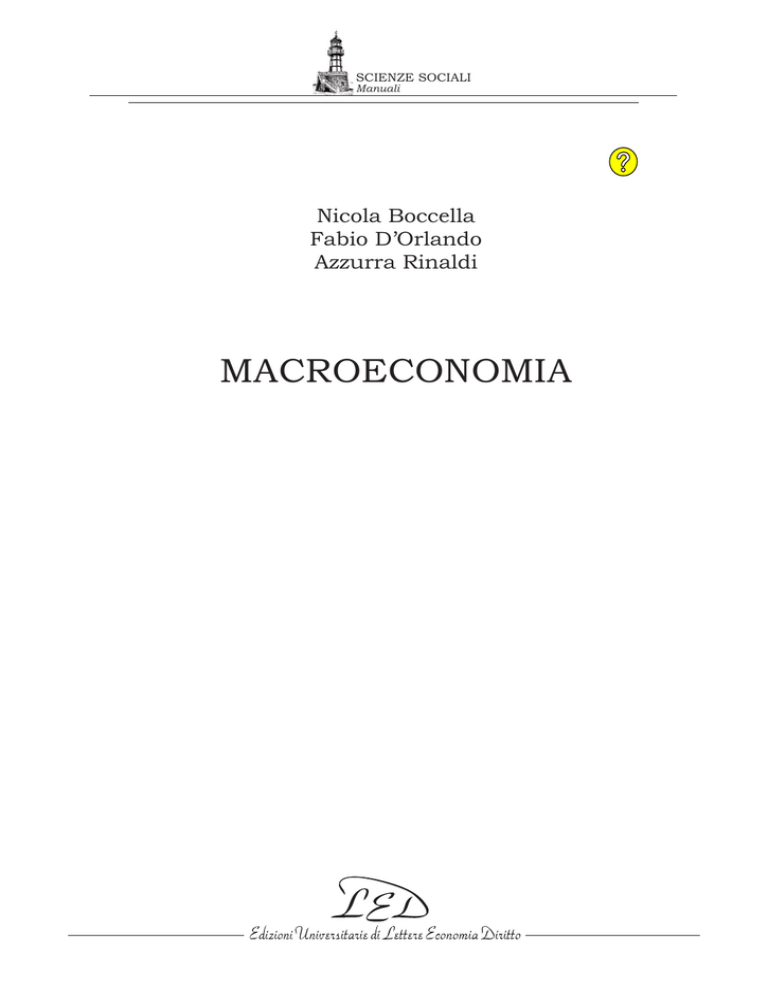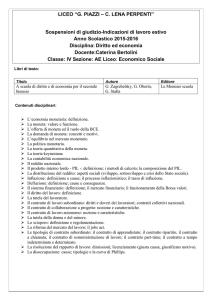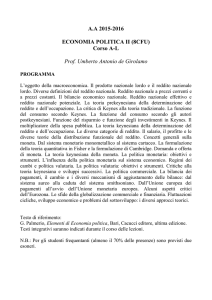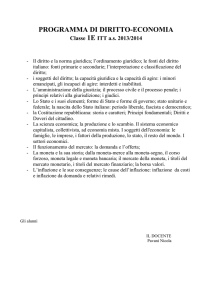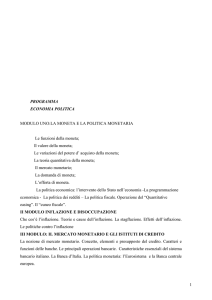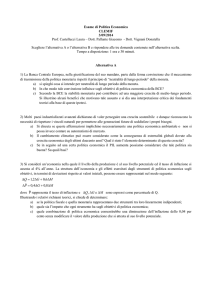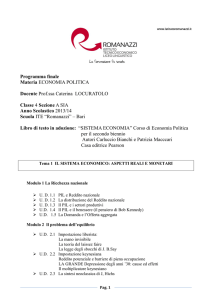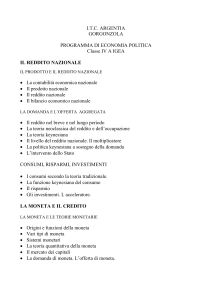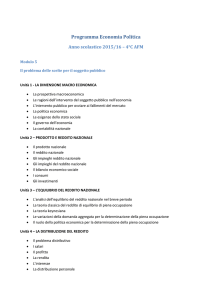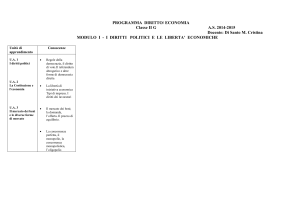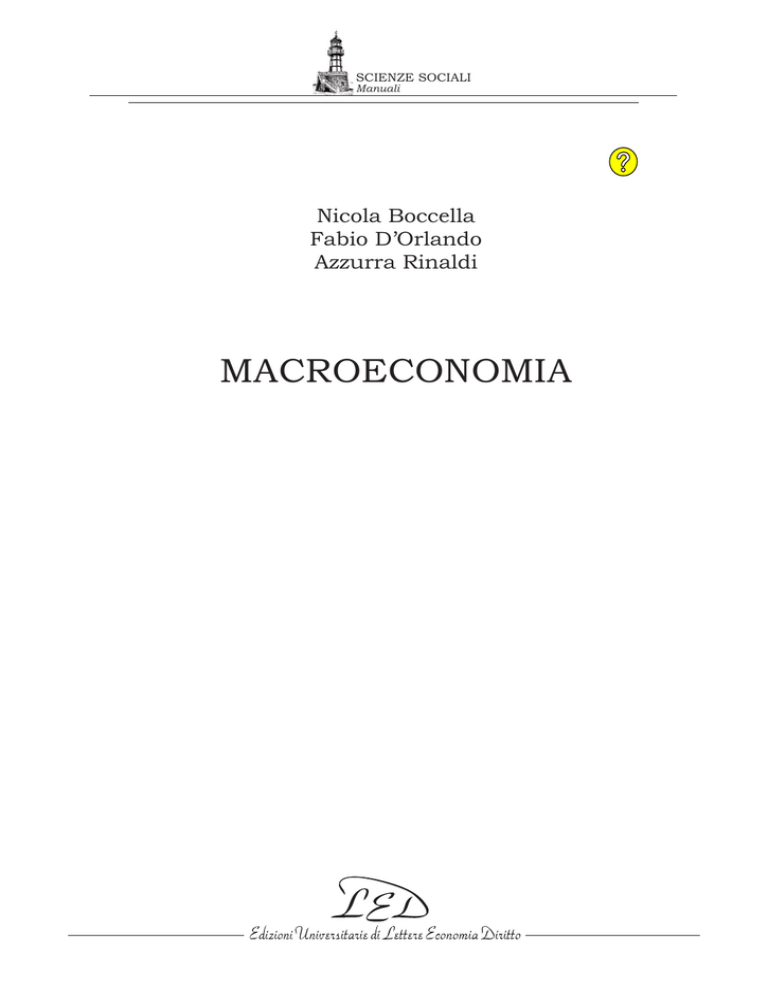
SCIENZE SOCIALI
Manuali
Nicola Boccella
Fabio D’Orlando
Azzurra Rinaldi
MACROECONOMIA
14.
LA MACROECONOMIA NEI FATTI
14.1. Alcune applicazioni
Le nozioni sinora apprese possono essere utilmente applicate per
provare a giustificare teoricamente alcuni avvenimenti che hanno
interessato le relazioni economiche internazionali negli ultimi anni.
In particolare analizzeremo, seppur in estrema sintesi, tre temi:
1. che cos’è e come si realizza un attacco speculativo;
2. le ragioni della crisi che ha interessato il Sistema Monetario Europeo nel 1992;
3. la politica monetaria attuata dalla Repubblica Popolare Cinese
negli ultimi anni.
In questa sede ci limiteremo a fornire alcuni elementi di base per interpretare i fenomeni suddetti, invitando il lettore a consultare testi
specificamente dedicati all’economia monetaria internazionale per
una trattazione più approfondita.
14.2. Gli attacchi speculativi
I mezzi finanziari che, a livello internazionale, vengono quotidianamente utilizzati dagli operatori privati per le transazioni in valuta
sono di gran lunga maggiori non solo rispetto a quelli utilizzati per
le transazioni commerciali (merci e servizi), ma anche rispetto alle
riserve di valuta possedute dalle Banche Centrali. Approssimativamente, le transazioni internazionali in titoli e valute rappresentano,
in un giorno, il 20% dell’interscambio mondiale di beni in un anno.
Questa grande disponibilità finanziaria rende particolarmente lucrativa (anche se intrinsecamente rischiosa) la speculazione contro una
valuta, tanto che in passato ha causato crisi profonde sia in Europa
sia negli altri continenti. Al di là di alcuni casi specifici, per i quali
rimandiamo al paragrafo successivo e all’ottimo libro di Paul Krugman, Il ritorno dell’economia della depressione, cerchiamo qui di
capire come (e perché) avvenga un attacco speculativo.
Per semplicità, immaginiamo che gli speculatori internazionali,
ossia soggetti e istituzioni che possiedono ingente liquidità e intendono farla fruttare, si convincano che il tasso di cambio del Paese
243
14. La macroeconomia nei fatti
La Banca Centrale
contrasta l’attacco
speculativo
244
A, attualmente in un regime di cambi fissi, è sopravvalutato, ossia
che le forze del mercato, in futuro, porteranno a un deprezzamento
del cambio, per esempio perché siamo in presenza di un crescente
deficit della bilancia dei pagamenti. Come vedremo in seguito, non
è necessario che la tendenza al deprezzamento esista realmente: è
sufficiente che gli speculatori si convincano di tale esistenza e agiscano di conseguenza. Questo ‘agire di conseguenza’ equivale a tentare di trarre il massimo profitto possibile dalla situazione. Vediamo
come.
Generalmente, gli speculatori non possiedono moneta del Paese
A, ma per speculare sul cambio del Paese A, devono procurarsela.
Quindi, si rivolgono ad istituzioni finanziarie del Paese A e richiedono un prestito. Naturalmente, per questi prestiti dovranno pagare un tasso di interesse, quello in vigore nel Paese A. Ipotizziamo
che chiedano, ad esempio, un prestito di 100 in valuta di A, offrendosi di pagare un interesse dell’1% al mese. Quindi cambieranno
questa valuta in valuta di un altro Paese, ad esempio del Paese B,
che ritengono si apprezzerà. Facendo l’ipotesi che il cambio sia alla
pari, otterranno 100 in valuta di B. Con questa valuta compreranno
titoli di B (per non lasciare denaro inutilizzato: così percepiranno
un interesse). Ipotizziamo che anche in B l’interesse sia dell’1% al
mese.
Ora, se sono in molti a compiere questa operazione (e, come
abbiamo detto all’inizio, la speculazione internazionale è in grado
di muovere quantità enormi di denaro), saranno in molti a offrire
sul mercato valuta di A domandando valuta di B. Questo creerà
tensioni sul mercato dei cambi, e la Banca Centrale di A, per scongiurare il deprezzamento, offrirà valuta di B tenuta a riserva domandando valuta nazionale. Ma se l’attacco speculativo è di dimensioni
rilevanti, la Banca Centrale finirà col terminare le proprie riserve
valutarie riducendo la capacità di richiederne altre, e sarà costretta
a lasciar deprezzare la valuta. Ipotizziamo che, come conseguenza, il
tasso di cambio, che prima era identico, diventi pari a ½: una unità
valutaria di A ne compra ½ di B o, il che è lo stesso, una unità valutaria di B ne compra 2 di A.
A questo punto, ipotizzando che sia passato un mese, il nostro
speculatore venderà i titoli di B che possiede, incassando anche l’interesse di un mese, ed otterrà 101 unità di valuta di B; convertendole in valuta di A, otterrà 202 unità di valuta di A. Si rende necessario
rimborsare il prestito (100 unità di valuta di A) e pagare l’interesse
(l’1% di 100, ossia 1). Fatto questo, rimarrà con un guadagno di
101, che potrà riconvertire nella valuta che preferisce. Effettivamente, un guadagno di queste dimensioni è elevato, ma guadagni
dell’ordine del 20-30% sono sostanzialmente normali in presenza di
attacchi speculativi (tra l’altro, il 20-30% in un mese …).
È opportuno soffermarsi su tre punti importanti:
1. Innanzitutto, la Banca Centrale di A, per contrastare l’attacco
speculativo, potrebbe essere tentata ad operare una politica mo-
14.2. Gli attacchi speculativi
netaria restrittiva, determinando un aumento del tasso di interes-
se e rendendo in questo modo dispendioso per uno speculatore
procurarsi fondi in valuta di A per effettuare la speculazione.
Un aumento del tasso di interesse potrebbe anche indurre i non
residenti a domandare una quantità maggiore di titoli di A migliorando il conto finanziario. Ma, di fronte a un attacco speculativo la cui prospettiva di guadagno è pari al 20-30% in un mese, l’incremento del tasso di interesse necessario sarebbe tanto
alto da creare seri problemi all’economia; inoltre, in presenza di
un attacco speculativo (e di un probabile deprezzamento della
valuta), è difficile convincere i non residenti ad acquistare titoli
nazionali.
2.Secondariamente, non è necessario che vi siano cause economiche effettive per attaccare una valuta: gli speculatori potrebbero
benissimo scegliere un Paese, ad esempio, in surplus di bilancia
dei pagamenti. Le risorse di cui dispongono sono tanto ingenti
da poter largamente sopravanzare la quantità di valuta internazionale che una Banca Centrale può impiegare per difendere
il cambio. Naturalmente, in genere gli speculatori attaccano valute deboli (perché l’attacco è più facile e il brusco deprezzamento più massiccio), in cerca di guadagni maggiori in tempi
minori; ma, in linea di principio, nulla impedirebbe loro, purché
concertassero il proprio attacco, di attaccare valute in perfetta
salute.
3. Infine, possiamo rilevare come non vi sia simmetria negli esiti delle politiche di contrasto ad un attacco speculativo. Spieghiamoci
meglio: una Banca Centrale non è in grado di difendere la propria valuta se l’attacco speculativo tende ad ottenere un deprezzamento, perché per farlo dovrebbe vendere valuta estera che
possiede come riserva in quantità limitata. Ma se l’attacco mira
a conseguire un apprezzamento della valuta, una Banca Centrale
non avrebbe nessun problema a contrastarlo: infatti, in questo
caso potrebbe difendersi vendendo valuta nazionale e, se vuole
(se è disposta a subirne le conseguenze in termini di inflazione),
potrà vendere quantità illimitate di valuta nazionale, poiché è la
stessa Banca Centrale a stamparla. Quindi, mentre gli speculatori
vincono sempre contro le Banche Centrali nel caso di un attacco
tendente al deprezzamento, le Banche Centrali possono vincere
(se lo vogliono) quando l’attacco mira all’apprezzamento.
Speculatori
vs Banche Centrali
14.3. La crisi dello SME
Il modello Mundell-Fleming si presta a dar conto in maniera molto
efficace di un particolare attacco speculativo, quello che nel 1992 ha
causato la crisi dello SME. Ma, prima di parlare della crisi, è opportuno spendere qualche parola su che cos’era lo SME e sugli eventi
che hanno preceduto la crisi del 1992.
245
14. La macroeconomia nei fatti
14.3.1. Lo SME e le aree valutarie ottimali
Area valutaria ottimale
L’idea che l’Europa, per diventare un’area economica sempre più
integrata, avesse bisogno di una moneta unica o, almeno in una prima fase, di un sistema di cambi fissi (come sarà, appunto, lo SME),
trovava la sua forza e la sua debolezza nella teoria delle aree valutarie
ottimali. La tesi allora (e tutt’ora) dominante tra gli economisti era
questa: gli aspetti positivi, per un Paese che partecipa ad una unione
monetaria (ossia condivide una moneta comune con altri Paesi) o ad
una unione valutaria (ossia mantiene cambi irrevocabilmente fissi con
le valute degli altri Paesi dell’area), possono superare quelli negativi se
i Paesi interessati all’evento costituiscono appunto un’area valutaria
ottimale, ossia un’area geografica all’interno della quale non è costoso
per i singoli Paesi rinunciare all’indipendenza monetaria e valutaria
(con indipendenza monetaria e valutaria si intende la possibilità di
controllare l’offerta di moneta e il tasso di cambio).
Per la teoria economica, le caratteristiche che deve avere un gruppo di Paesi per poter costituire un’area valutaria ottimale sono essenzialmente due:
1. una scarsa propensione a subire shock asimmetrici;
2. la capacità di tornare in equilibrio spontaneamente dopo aver subito uno shock.
La prima caratteristica di un’area valutaria ottimale è dunque la bassa probabilità di essere colpita da shock asimmetrici, ossia da shock
che riguardano solo alcuni Paesi dell’area, oppure da shock diversi
da zona a zona. La ratio di questa condizione risiede nella circostanza che, in generale, la rinuncia alla possibilità di attuare politiche monetarie (e/o valutarie) indipendenti da parte dei singoli Paesi
non è costosa se i Paesi possono ricorrere a una politica monetaria
comune per attenuare l’impatto degli shock; ma una politica monetaria comune non è possibile se alcuni Paesi sono colpiti da un tipo
di shock, ad esempio una recessione, mentre altri Paesi da nessuno
shock o da uno shock di segno opposto come, ad esempio, un’eccessiva inflazione.
In questo caso, infatti, alcuni Paesi vorranno mettere in atto una
politica (ad esempio, monetaria espansiva, per combattere la recessione), mentre gli altri Paesi vorranno mettere in atto la politica
opposta (ad esempio, una politica monetaria restrittiva, per evitare
di importare inflazione o per combattere l’incremento di inflazione
interna generato dalla politica espansiva del vicino). E se una politica
comune non è possibile, l’autorità che è stata incaricata di gestire
la politica monetaria dell’area (ossia la Banca Centrale dell’unione
monetaria) non saprà quale politica seguire, se espansiva come vorrebbero i Paesi in recessione, o restrittiva come vorrebbero i Paesi
con inflazione 1.
1 Nel testo abbiamo discusso di cosa accade, nel caso di unione monetaria,
quando uno shock asimmetrico colpisce un’area valutaria non ottimale. In assenza di
246
14.3. La crisi dello SME
Quali sono le caratteristiche che i diversi Paesi devono possedere
per avere minori possibilità di incorrere in shock asimmetrici (e dunque per comporre un’area valutaria ottimale)? La teoria economica ritiene che i Paesi debbano avere economie più simili possibile e
molto differenziate al loro interno (se ciascuna fosse fortemente specializzata solo in alcune produzioni, diverse da Paese a Paese, shock
settoriali avrebbero impatti diversi da Paese a Paese). Inoltre, sarebbe opportuno che i tassi di inflazione fossero simili poiché, se così
non fosse, un Paese con più alta inflazione perderebbe rapidamente
competitività, accumulerebbe passivi di bilancia dei pagamenti e
troverebbe notevoli difficoltà nel rispettare gli accordi sottoscritti:
nel caso di cambi fissi, questo costringerebbe il Paese a svalutare la
propria valuta; nel caso di moneta unica, tale rischio non esisterebbe
ma, in assenza di altri meccanismi automatici di riequilibrio, il Paese
vedrebbe progressivamente ridursi la domanda estera, cioè le esportazioni, e dunque il PIL.
Non si può naturalmente escludere che, anche in economie molto simili, si possano verificare shock asimmetrici. Questo spiega la
seconda caratteristica che un’area valutaria ottimale deve presentare:
la capacità di riassorbire spontaneamente gli shock anche senza ricorrere a politiche monetarie interventiste.
La teoria delle aree valutarie ottimali ritiene che la capacità del
sistema di riassorbire spontaneamente gli shock dipenda da due elementi:
1.la flessibilità dei prezzi (e dei salari);
2.la mobilità dei fattori.
Il primo punto è una conseguenza delle basi logiche della teoria
tradizionale: in presenza di prezzi e salari flessibili, dopo aver subito
uno shock, il sistema economico tende a convergere rapidamente
verso un nuovo equilibrio sia nel mercato interno (ad esempio, in
presenza di una recessione e della conseguente disoccupazione, la
riduzione dei salari reali indotta dalla disoccupazione porta le imprese ad assumere un maggior numero di lavoratori e ad aumentare
la produzione) sia in quello estero (la riduzione dei prezzi, causata
dall’eccesso di offerta sul mercato dei beni, porta all’aumento di
competitività nelle esportazioni e dunque ad un loro incremento,
con la conseguenza, anche per questa via, di un aumento della produzione e del PIL). Se invece prezzi e salari sono rigidi, le autorità
monetarie si troveranno costrette ad intervenire, o con politiche
espansive o con un deprezzamento del tasso di cambio, per contrastare gli effetti dello shock che il mercato non è in grado di riassorbire spontaneamente. Anche la mobilità dei fattori permette ad
un sistema di riassorbire spontaneamente uno shock: infatti, in presenza (ad esempio) di una recessione, la disoccupazione può essere
Rischio
di shock asimmetrici
Prezzi e salari flessibili
Prezzi e salari rigidi
moneta unica ma in presenza di cambi fissi, la logica è in parte diversa: se le Banche
Centrali nazionali, per reagire allo shock, seguono politiche divergenti, non potranno mantenere la parità dei tassi di cambio tra le valute.
247
14. La macroeconomia nei fatti
Il Sistema Monetario
Europeo
248
riassorbita non solo grazie alla flessibilità del salario reale, ma anche
grazie allo spostamento dei lavoratori dai settori (dai Paesi) in eccesso di offerta di lavoro ai settori (ai Paesi) in eccesso di domanda.
Un discorso molto simile riguarda l’altro fattore della produzione
mobilizzabile, ossia il capitale: anche qui la sua mobilità, ossia la
presenza di mercati finanziari sviluppati, può permettere la creazione di flussi finanziari tali da sostenere momentaneamente i settori
e/o i Paesi in difficoltà.
In un modo o nell’altro, dunque, il problema relativo all’area valutaria ottimale è quello di prevenire (o reagire adeguatamente a)
shock che dovessero colpire un sistema economico: un’area valutaria
ottimale sarà dunque quella in cui gli shock asimmetrici non si verificano e, se si verificano, sono rapidamente e spontaneamente riassorbibili; in sostanza, quella in cui i singoli Paesi possono rinunciare,
senza danni, alla possibilità di avere politiche monetarie indipendenti in quanto scarsamente necessarie.
Una volta individuate le caratteristiche che un gruppo di Paesi
deve rispettare per essere qualificato come area valutaria ottimale, rimane da valutare se i Paesi europei costituiscano o meno un’area valutaria ottimale. Inizialmente, l’idea generalmente accettata era che
i singoli Paesi europei fossero troppo diversi tra loro, e la flessibilità
dei mercati fosse così poco diffusa, da non poter essere considerati
parte di un’area valutaria ottimale. D’altro canto, alcuni autori sostengono che, sebbene l’Europa non fosse allora (e non sia tuttora)
un’area valutaria ottimale, la progressiva integrazione delle economie, degli assetti normativi e di quelli istituzionali, integrazione indotta anche dalla partecipazione al sistema di moneta unica, avrebbe
innescato un processo dinamico teso a rendere i singoli Paesi europei sempre più simili tra loro, portandoli progressivamente a costituire un’area valutaria ottimale. Prima dell’unificazione monetaria e
dell’introduzione dell’euro, nel secondo dopoguerra, l’Europa aveva
già conosciuto due esperienze di sistemi a cambi fissi: il sistema di
Bretton Woods ed il Sistema Monetario Europeo (SME).
Mentre il sistema di Bretton Woods era un sistema di cambi fissi
che comprendeva anche molti Paesi non europei, tra i quali gli Stati
Uniti e il Giappone, il Sistema Monetario Europeo, divenuto operativo
il 13 marzo del 1979, dopo il crollo del regime di Bretton Woods, era
un sistema a cambi fissi limitato ai nove Paesi europei che facevano
allora parte della Comunità Economica Europea (ma progressivamente esteso ad altri Paesi europei man mano che questi entravano a
far parte della CEE). In questo sistema i singoli Stati dichiaravano la
parità, ossia il tasso di cambio, delle loro valute con l’ECU (European
Currency Unit), una unità monetaria fittizia il cui valore era calcolato
come media del valore del paniere di valute europee che lo costituivano; poiché ciascuna valuta dichiarava esplicitamente la propria
parità con l’ECU, ciascuna valuta otteneva esplicitamente un tasso
di cambio rispetto all’ECU e, implicitamente, un rapporto di cambio
con ciascuna (altra) valuta facente parte dello SME.
14.3. La crisi dello SME
Sebbene lo SME fosse un sistema a cambi fissi, in esso erano presenti, almeno sino al 1987, ampi gradi di flessibilità.
Innanzitutto, i singoli Paesi dichiaravano la parità centrale delle
proprie valute rispetto all’ECU e si impegnavano a rispettare quella
parità, ma era consentito che le valute si svalutassero o rivalutassero
di una certa percentuale rispetto alla parità centrale. In pratica, esistevano delle bande di oscillazione attorno alla parità centrale (che
era definita ‘centrale’ proprio per questo motivo) all’interno delle
quali le quotazioni delle singole valute potevano liberamente oscillare. Solo qualora l’oscillazione avesse portato la quotazione delle
valute al di fuori della banda di oscillazione, le Banche Centrali
nazionali sarebbero dovute intervenire, acquistando la moneta che
tendeva a deprezzarsi e vendendo quella che tendeva ad apprezzarsi
per riportare il tasso di cambio all’interno della banda di oscillazione. L’ampiezza di questa banda di oscillazione è stata per un lungo
periodo di tempo diversa per alcuni Paesi (inizialmente tutti i Paesi,
ad eccezione di Italia, Spagna e Portogallo, avevano una banda di
oscillazione che permetteva uno scostamento del 2,25% in più e del
2,25% in meno rispetto alla parità centrale, mentre la lira, la peseta
spagnola e l’escudo portoghese avevano una banda di oscillazione
del 6% in più e del 6% in meno).
Un secondo elemento di flessibilità era ancora più radicale e consisteva nella possibilità di modificare la parità centrale, ossia di svalutare/rivalutare il tasso di cambio della valuta nazionale. In particolare,
se un Paese avesse manifestato sistematiche tendenze al deficit della
bilancia dei pagamenti (e dunque sistematiche tendenze al deprezzamento del cambio), sarebbe stato possibile richiedere un riallineamento delle parità centrali, ossia, in questo caso, una svalutazione
(o, viceversa, una rivalutazione in caso di sistematiche tendenze al
surplus della bilancia dei pagamenti).
14.3.2. La crisi
Della possibilità di riallineare la parità centrale (oltre che della banda di oscillazione più generosa che le era stata concessa) l’Italia si è
servita spesso. Infatti il nostro Paese, a causa del tasso di inflazione
regolarmente più alto rispetto a quello dei propri partners comunitari (ed in particolare più alto rispetto a quello della Germania,
principale Paese di destinazione delle nostre esportazioni), perdeva
sistematicamente competitività. Se i cambi sono fissi, le merci italiane, man mano che aumentano di prezzo in Italia, aumentano di prezzo anche quando vengono vendute all’estero, ossia quando vengono
esportate: trovare acquirenti diventa dunque sempre più difficile.
Poiché per lungo tempo le autorità nazionali hanno preferito una
politica economica orientata alla crescita del PIL e dell’occupazione
nel breve periodo, piuttosto che al contenimento dell’inflazione, la
perdita di competitività delle nostre esportazioni non è stata seriamente contrastata, almeno fino alla metà degli anni Ottanta, con misu249
14. La macroeconomia nei fatti
Le svalutazioni
competitive
re restrittive, ma unicamente sfruttando l’ampiezza della banda di
oscillazione e la possibilità di riallineare il cambio, ossia, in sostanza,
effettuando ripetute svalutazioni competitive: si svaluta il cambio per
recuperare la competitività che si è persa. E questa pratica non è
stata propria solo dell’Italia ma, seppur con frequenza minore, anche
di altri Paesi europei.
Tale pratica cessò nella seconda metà degli anni Ottanta, approssimativamente a partire dal 1987. In quegli anni, si affermò infatti la
convinzione che l’inflazione fosse il problema principale con cui si
dovevano confrontare le economie europee e si decise di affrontarlo
con la massima decisione possibile. In particolare, poiché la teoria
economica dell’epoca enfatizzava il legame tra inflazione e aspettative di inflazione, le autorità monetarie decisero di intervenire contro
le aspettative di inflazione per stroncare l’inflazione 2. Ma, per combattere le aspettative di inflazione, era necessario convincere i soggetti
che la politica monetaria aveva cambiato registro, ponendo la lotta
all’inflazione come obiettivo prioritario della propria azione, anche
a costo di patire un incremento della disoccupazione. Questa scelta
derivava dalla convinzione che combattere l’inflazione contrastando
le aspettative di inflazione avrebbe garantito una disinflazione più
rapida e meno dolorosa (in termini di contrazione del PIL) rispetto a
una strategia tradizionale basata su forti restrizioni monetarie.
Per combattere le aspettative di inflazione, la Banca Centrale
doveva dunque dare un segnale forte e credibile del mutamento di
strategia e del nuovo obiettivo anti-inflazionistico che si poneva. Per
farlo, si decise di non permettere più svalutazioni competitive del
tasso di cambio. E questo avvenne in Italia ma anche in molti altri
Paesi europei. Lo SME divenne un sistema a cambi fissi.
Ma poiché l’Europa non era un’area valutaria ottimale, un sistema a cambi fissi finì per accentuare tensioni che non trovavano più la
valvola di sfogo rappresentata dalla flessibilità del tasso di cambio e,
d’altro canto, non trovavano quella flessibilità dei prezzi e dei mercati che avrebbe permesso di fare a meno della flessibilità del cambio.
Così, appena il sistema si trovò ad affrontare uno shock più violento
degli altri, crollò.
Lo shock fu rappresentato dall’unificazione tedesca. Dopo il 3
ottobre del 1990, la Germania Ovest, con la riunificazione, si trovò a dover sostenere ingentissime spese. Questo forte incremento di
spesa pubblica portò ad un incremento del tasso di interesse in quel
Paese e dunque alla tendenza all’apprezzamento del marco (la valuta tedesca) e alla contestuale tendenza al deprezzamento delle altre
2 In sostanza, in previsione di un aumento futuro dei prezzi, tutti gli operatori
economici e le categorie sociali (sindacati quando trattano il rinnovo dei contratti, imprenditori quando devono rivedere i prezzi di vendita dei loro prodotti, ecc.)
avrebbero aumentato le loro richieste economiche creando così, sulla base della sola
aspettativa di inflazione, inflazione effettiva. La conclusione a cui giunsero molti economisti e politici sosteneva che fosse possibile controllare l’inflazione combattendo
le aspettative di inflazione.
250
14.3. La crisi dello SME
valute europee. Nei termini del modello Mundell-Fleming, ciò comporta uno spostamento della curva IS (della Germania) verso destra.
Nella Figura 14.1., dove abbiamo ipotizzato (come verosimile) una
situazione di perfetta mobilità dei capitali, la curva si sposta in IS1 e
l’equilibrio si colloca in B. In accordo col modello, in una situazione
di cambi fissi, l’aumento del tasso di interesse in Germania avrebbe
comportato un surplus di bilancia dei pagamenti e un tendenziale
apprezzamento del marco, al quale le Banche Centrali facenti parte
dell’accordo si sarebbero dovute opporre offrendo marchi sul mercato e domandando le valute che tendevano a deprezzarsi. Sempre
in Germania, ciò avrebbe comportato un aumento dell’offerta di
moneta, ossia uno spostamento della LM verso destra (in LM1, nella
Figura 14.1.) e un ritorno del tasso di interesse al livello originario,
ma anche un aumento degli investimenti e del reddito. L’equilibrio,
interno ed esterno, si sarebbe così collocato in corrispondenza del
punto C della Figura 14.1.
Ma la tendenza all’apprezzamento del marco era troppo forte. In
breve, le Banche Centrali si trovarono a corto di marchi (per impedire il deprezzamento, ad esempio, della lira la Banca d’Italia doveva
vendere marchi che aveva a riserva e comprare lire). E la Bundesbank, che in teoria avrebbe dovuto finanziare in maniera illimitata
la difesa del cambio (stampando marchi ed intervenendo sul mercato, vendendoli cioè direttamente o prestandoli alle altre Banche
Centrali perché esse li vendessero), nel timore che l’eccesso di offerta di moneta interna potesse far crescere a dismisura l’inflazione,
i
IS
IS 1
LM
LM1
BB
B
iB
iA = if
Apprezzamento
del marco
A
YA
C
YB
YC
Y
Figura 14.1.
251
14. La macroeconomia nei fatti
si dimostrò restia ad intervenire chiedendo un riallineamento delle
parità, ossia una rivalutazione del marco (e una svalutazione delle
altre valute).
In sostanza, i tedeschi suggerivano che il ritorno al livello del tasso di interesse internazionale avvenisse attraverso un apprezzamento
del marco che, causando una riduzione delle esportazioni nette (e
del reddito), avrebbe riportato la IS verso sinistra e non spostato la
LM verso destra (nella Figura 14.1. la IS1 torna in IS). D’altro canto,
i tedeschi ricordarono agli altri Paesi la circostanza che, fino a pochi
anni prima, ogni volta che qualcuno di loro incontrava qualsiasi piccolo problema di bilancia dei pagamenti chiedeva immediatamente
ed otteneva senza difficoltà un riallineamento; ora che il problema
era rilevante e nasceva da un evento di portata storica, la contrarietà di questi Paesi al riallineamento non era giustificata. Questi
Paesi, per contro, facevano resistenza perché temevano di perdere,
accettando la svalutazione delle proprie valute, tutta la credibilità
internazionale in chiave anti-inflazionistica che avevano guadagnato
col rigore monetario, e perdere la credibilità avrebbe significato, essi
credevano, lasciar risalire le aspettative di inflazione e, per questa
via, l’inflazione stessa.
Nel settembre del 1992, il sistema crollò. Infatti, mentre le Banche Centrali esaurivano le loro riserve in marchi, la speculazione
internazionale dimostrò la propria forza vendendo massicciamente
contro marchi le altre valute europee, nella convinzione che il sistema sarebbe crollato ed il marco si sarebbe fortemente rivalutato.
In particolare si distinse, nell’attacco contro la sterlina, il Quantum
Fund di George Soros: sulla base della percezione che il sistema non
avrebbe retto, Soros, l’amministratore del fondo, prese a prestito 15
miliardi di sterline in Gran Bretagna e con esse domandò marchi. La
mossa di Soros fu resa nota e subito seguita da altri speculatori. Ciò
che probabilmente sarebbe dovuto accadere in alcuni mesi accadde
in pochi giorni: terminate le loro riserve nel disperato tentativo di
sostenere le proprie valute, molte Banche Centrali dovettero abbandonarne la difesa (in pochi giorni la Banca d’Inghilterra acquistò 50
miliardi di sterline, anche se lo fece con operazioni ‘sterilizzate’ – si
veda il paragrafo successivo). Si tentò un riallineamento, rivalutando
il marco, ma la lira italiana e la sterlina inglese furono egualmente
costrette ad andare in libera fluttuazione, ossia a passare al regime di
cambi flessibili, mentre le altre valute, dopo ripetuti aggiustamenti al
ribasso, tornarono al regime di cambio precedente (ossia tornarono
a partecipare allo SME) molto svalutate e con bande di oscillazione
assai più ampie di prima (più o meno 15% rispetto alla parità centrale).
Rivendendo marchi contro sterline dopo la svalutazione, Soros
guadagnò in pochi giorni 2 miliardi di sterline.
252
14.3. La crisi dello SME
14.3.3. Dallo SME all’euro
La crisi dello SME rese evidente la necessità di un passaggio cruciale per il sistema valutario europeo, passaggio che proprio in quegli
anni, ed in maniera indipendente dal crollo, stava progressivamente
avvenendo nei Paesi europei: il passaggio all’Unione Economica e
Monetaria e alla moneta unica.
L’idea era che, con una moneta unica, l’Europa avrebbe potuto
sfruttare una serie di vantaggi per la propria economia:
a.i costi di transazione si sarebbero ridotti;
b.la trasparenza dei mercati sarebbe aumentata;
c. l’incertezza degli scambi sarebbe diminuita;
d.i tassi di interesse si sarebbero ridotti, grazie all’eliminazione del
rischio di cambio;
e. le politiche monetarie sarebbero diventate più rigorose rispetto a
quelle adottate da alcuni Paesi dell’area;
f.le riserve valutarie della nuova Banca Centrale sarebbero diventate enormi, pari a tre volte quelle statunitensi;
g. non ci sarebbero più stati rischi di attacchi speculativi contro le
valute dei singoli Paesi, per il semplice fatto che queste valute
non sarebbero più esistite.
D’altro canto, era noto che l’unificazione monetaria avrebbe anche
potuto comportare alcuni significativi svantaggi per le Banche Centrali nazionali, le quali:
a.avrebbero perso la possibilità di utilizzare lo strumento di politica
monetaria, delegato alla Banca Centrale Europea;
b.avrebbero perso anche lo strumento di intervento rappresentato dalle manovre sul cambio (c’è una moneta unica, il tasso di
cambio scompare tra le monete che aderiscono all’accordo e, per
quanto concerne il tasso di cambio con le valute che non aderiscono, l’autorità per l’intervento è delegata alla BCE) che, nella
forma un po’ patologica della svalutazione competitiva, era stato
frequentemente utilizzato da molti Paesi.
Creare una moneta unica in Europa sarebbe stato conveniente qualora i vantaggi avessero superato gli svantaggi. Ma, come si è visto,
ciò può accadere solo se si è in presenza di un’area valutaria ottimale.
E l’Europa, secondo molti commentatori, non era affatto (e non è
tuttora) un’area valutaria ottimale. Perché si è proceduto su questa
strada, allora? La risposta sta in due considerazioni:
1. In assenza di un’area valutaria ottimale, neppure un sistema di
cambi fissi come lo SME sarebbe stato ottimale; eppure quell’esperienza era stata compiuta ed era stata giudicata positiva da
molti Paesi fino alla crisi del 1992. La moneta unica avrebbe
comportato tutti i vantaggi dello SME, altri nuovi vantaggi (quelli indicati prima: costi di transazione, trasparenza, tassi di interesse, ecc.) e l’eliminazione di uno svantaggio importante: i Paesi
partecipanti alla moneta unica non avrebbero più subito attacchi
speculativi.
I vantaggi
ipotizzati con l’Euro
Svantaggi
dell’Unione Monetaria
253
14. La macroeconomia nei fatti
I parametri di Maastricht
2. Tuttavia, proprio la crisi dello SME aveva mostrato che l’Europa non poteva essere considerata un’area valutaria ottimale, e che
dunque alcuni Paesi non sembravano in grado di sopportare né la
moneta unica né i cambi fissi.
Questa considerazione portò ai parametri fissati per stabilire chi
avrebbe potuto far parte della nuova Unione Monetaria: i parametri
di Maastricht 3. Questi parametri avevano lo scopo dichiarato di far
partecipare solo alcuni Paesi: quelli che avevano economie sufficientemente simili e che dunque potevano costituire un’area valutaria
(più o meno) ottimale. Agli altri Paesi, quelli più deboli e meno omogenei, sarebbe stato lasciato tempo sufficiente per rinforzare le loro
economie e renderle omogenee alle altre prima di lasciarli entrare, in
un futuro più o meno prossimo, a far parte dell’UEM.
In particolare, i parametri di Maastricht furono scritti per ‘tenere dentro’ all’UEM alcuni Paesi, i più forti, ricchi e simili (Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo e, ma solo perché altrimenti
l’unione sarebbe stata troppo debole, Francia) e ‘lasciar fuori’ tutti
gli altri, i quali, peraltro, non erano neppure troppo preoccupati
dell’esclusione, rendendosi conto che la partecipazione all’UEM
avrebbe impedito loro di realizzare le politiche monetarie e del
cambio che avevano realizzato in passato, e che la caduta dello SME
aveva dimostrato essere inevitabili, pena violente crisi, per le proprie economie.
È importante rimarcare come la scelta dei parametri sia stata soprattutto politica. Infatti, per valutare correttamente se i Paesi potevano far parte dell’UEM, si sarebbe dovuto stabilire se possedevano
o meno i requisiti per appartenere ad un’area valutaria ottimale. E,
come si è visto, questi requisiti sono soprattutto microeconomici, relativi alla struttura dell’economia e alla flessibilità dei prezzi e dei
mercati. Invece, i parametri fissati implicavano essenzialmente requisiti macroeconomici, con valori privi oltretutto di qualsiasi ratio economica. In sostanza, i parametri furono scelti e fissati appositamente
perché gli unici a rispettarli fossero i Paesi che si era già deciso, a
priori, facessero parte della moneta unica.
I parametri che un Paese doveva rispettare per poter partecipare
all’UEM, e quindi alla moneta unica, erano i seguenti:
1.il tasso di inflazione non doveva superare di oltre l’1,5% la media
dei tassi di inflazione dei tre Paesi con l’inflazione più bassa;
2.il tasso di interesse a lungo termine non doveva superare di oltre
il 2% la media dei tassi di interesse dei tre Paesi più virtuosi in
termini di inflazione;
3.il tasso di cambio della valuta che desiderava aderire all’accordo
doveva aver rispettato la banda di oscillazione dello SME per almeno due anni prima dell’ingresso nella moneta unica;
4.il rapporto deficit/PIL non doveva essere superiore al 3%;
3 Nella località di Maastricht venne firmato, il 7 febbraio 1992, il trattato (appunto, di Maastricht) per la creazione dell’UEM.
254
14.3. La crisi dello SME
5.il rapporto debito/PIL non doveva essere superiore al 60% o, se lo
era, doveva essere comunque in rapida diminuzione.
Nonostante l’iniziale, diffusa convinzione che solo alcuni Paesi sarebbero riusciti a rispettare questi parametri senza imporre micidiali
strette recessive alle proprie economie e, soprattutto, che solo alcuni Paesi avrebbero avuto convenienza a far parte della moneta unica, i Paesi candidati all’esclusione si resero progressivamente conto
che restare fuori dall’UEM sarebbe stato per loro troppo rischioso.
Quindi quasi tutti intrapresero le rigide politiche di intervento necessarie per rispettare i parametri. D’altro canto, anche i Paesi più forti
evidenziarono in quegli anni difficoltà sempre maggiori nel rispettare le regole che essi stessi avevano voluto: furono infatti costretti
a politiche restrittive e persino a qualche tocco di ‘finanza creativa’,
pratica che a quel punto fu considerata lecita ed impiegata abbondantemente anche dai Paesi inizialmente candidati all’esclusione. Il
parametro più difficile da conseguire rapidamente, ossia il rapporto
debito/PIL, fu considerato di secondaria importanza, ed il 1° gennaio del 1999 l’euro divenne la moneta unica di 11 Paesi europei
(la Grecia entrerà a far parte dell’UEM solo il 1° gennaio 2001, non
essendo riuscita a rispettare entro i termini stabiliti i parametri di
Maastricht).
Fino al 1° gennaio 2002, comunque, l’euro rimase una moneta
scritturale, ossia virtuale: utilizzata nelle negoziazioni ufficiali, ma
non ancora coniata.
Due considerazioni finali.
Innanzitutto, è necessario ricordare la differenza che esiste tra i
parametri di Maastricht, il cui rispetto permette l’ingresso nell’UEM,
ed i parametri sanciti dal patto di stabilità (un protocollo del trattato
di Maastricht, firmato a Dublino nel dicembre del 1996), al cui rispetto sono tenuti i Paesi durante la loro permanenza nell’UEM, che
impone dei vincoli alla gestione della finanza pubblica; in particolare,
il patto di stabilità sancisce che i singoli Paesi dovranno non solo
cercare di ottenere un rapporto tra deficit e PIL inferiore al 3%, sotto
pena di richiami e forti sanzioni, ma soprattutto tendere al pareggio il
bilancio dello Stato, ossia portare a zero quel rapporto (almeno «in
condizioni normali»). Al patto di stabilità si è aggiunto, il 1º gennaio
2013, il cosiddetto Fiscal Compact, che impone un più rigido piano
di riduzione del rapporto debito/PIL.
Secondariamente, è importante rimarcare come l’introduzione
dell’euro sia l’elemento più visibile della rivoluzione che ha interessato l’area monetaria europea, mentre quello più importante è la
nascita (il 1° giugno 1998) della Banca Centrale Europea: una sola
istituzione monetaria incaricata di gestire la politica monetaria dei
dodici Paesi facenti parte dell’UEM. Della Banca Centrale Europea
ci siamo occupati in dettaglio nel Capitolo 5. Qui possiamo solo rimarcare la puntuale realizzazione dei problemi indicati dalla teoria
AVO nell’introduzione di una moneta unica in un’area valutaria non
ottimale.
255
19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014
19.3. La crisi europea
Area valutaria ottimale
Uscire dall’Eurozona
Riduzione del salario
orario in Germania
340
La crisi colpisce un’Europa nella quale alcuni Paesi presentano già
rilevanti segni di debolezza economica. Come abbiamo avuto modo di osservare nella sezione 14.3, i Paesi che compongono l’attuale
Eurozona non costituivano (e con ogni probabilità non costituiscono
tuttora) un’area valutaria ottimale: ciò comporta che, in presenza di
shock asimmetrici, i costi della rinuncia alla politica monetaria indipendente, e alla possibilità di gestire il tasso di cambio, rischiano di
essere notevoli.
Questi costi si erano d’altro canto già dimostrati insostenibili nel
1992, quando proprio uno shock asimmetrico aveva condotto alla
crisi del Sistema Monetario Europeo, un regimi a cambi fissi con
ogni evidenza troppo rigido per alcuni Paesi. Non c’erano dunque
molte ragioni per ritenere che un insieme di Paesi incapaci di reggere
un regime a cambi fissi fosse invece capace di sostenere un regime a
moneta unica, che è ancora più rigido. È probabile che si ritenesse
che Paesi tanto diversi in origine da non costituire un’area valutaria ottimale ex-ante fossero destinati, col tempo e con l’integrazione
commerciale e istituzionale, a diventare progressivamente più simili,
sino a costituirla ex-post.
Oppure, più semplicemente, si riteneva che se questi Paesi non
avessero realizzato le riforme necessarie a divenire tra loro simili, perché costose dal punto di vista politico (si pensi alla flessibilità dei
salari, o alla mobilità del lavoro), prima o poi sarebbero stati costretti
a realizzarle dal verificarsi di una crisi sufficientemente violenta.
Affinché tutto ciò avvenisse era però necessario che fosse impossibile, o al limite estremamente costoso, abbandonare la moneta unica,
in modo che i Paesi non avessero altra scelta se non quella di implementare le necessarie riforme. Questo è proprio ciò che dobbiamo
registrare: uscire dall’Eurozona, per i motivi che vedremo, è estremamente costoso.
In ogni caso, i Paesi europei che entrano nell’Eurozona devono
da subito confrontarsi con le loro differenze, che vanno probabilmente oltre il non costituire un’area valutaria ottimale. In particolare la Germania si trova ad adottare la moneta unica con un tasso
di cambio sopravvalutato, e dunque scopre di avere esportazioni
poco competitive; mentre alcuni altri Paesi europei devono fronteggiare un basso tasso di crescita della produttività del lavoro, anche questo un elemento che rende le esportazioni, nel tempo, poco
competitive.
La Germania si rende subito conto del problema, e vuoi per lungimiranza sindacale, vuoi per la minaccia degli imprenditori di delocalizzare le imprese nei Paesi a più bassi salari dell’Europa orientale, aumenta l’orario di lavoro a parità di salario, riducendo così il
salario orario, e dunque il costo di produzione per le imprese, che
possono ridurre i prezzi di vendita dei loro prodotti e recuperare
competitività.
19.3. La crisi europea
Viceversa molti altri Paesi, nonostante abbiano un problema di
produttività che li rende meno competitivi della Germania stessa,
invece di ridurre i salari li aumentano. Con il risultato che la Germania
conquista quote di mercato per le sue esportazioni (anche grazie alla
particolare specializzazione produttiva, in settori dove subisce poca concorrenza), mentre altri Paesi (Italia, Francia, Spagna, Grecia,
Portogallo…) perdono quote di mercato.
La via più rapida, e nel breve periodo meno dolorosa, per recuperare la competitività delle esportazioni sarebbe il deprezzamento del
tasso di cambio. Ma se il tasso di cambio non è nel controllo dei singoli Stati, perché appartengo ad un’area a moneta unica nella quale
i tassi di cambio non ci sono, vi sono poche alternative: o si riducono
i salari e per questa via i prezzi dei prodotti, cercando di continuare
così a sostenere la domanda aggregata con le esportazioni, o si deve
rinunciare a far crescere le esportazioni aumentando la domanda aggregata puntando sulle sue altre componenti (spesa pubblica, consumi, investimenti).
È proprio ciò che accade nell’Eurozona: alcuni Paesi (Grecia e
Portogallo in particolare) realizzano massicce politiche di bilancio
espansive, incrementando la componente spesa pubblica della domanda aggregata, mentre in altri (Spagna e Irlanda) si gonfia una
bolla speculativa immobiliare che incrementa la componente consumi e investimenti. Altri ancora, come l’Italia, si trovano con un debito
pubblico eccessivo e non attuano politiche finalizzate alla competitività.
In ogni caso, dal punto di vista della crescita del PIL tanto la
bolla quanto la spesa pubblica espansiva si dimostrano strumenti assai potenti, garantendo un’ottima performance economica a questi
Paesi. Così come assai efficace si dimostra la politica tedesca tesa al
recupero di competitività con la moderazione salariale, che riesce ad
ottenere un aumento della domanda aggregata grazie all’aumento
delle esportazioni. Nel primo caso però, a differenza del secondo,
la crescita del PIL è accompagnata da un rilevante incremento del
debito: di quello pubblico, usato per finanziare la spesa pubblica
espansiva realizzata in deficit, in Grecia e Portogallo; di quello privato, usato per finanziare gli acquisti immobiliari, in Spagna e Irlanda. Ma finché flussi consistenti di prestiti giungono dai Paesi core
dell’Eurozona, questo non sembra costituire un problema rilevante.
In realtà, i problemi ci sono. Il primo e più rilevante riguarda la
Grecia, che nel sostenere la massiccia spesa pubblica espansiva con
la quale riesce a far crescere la sua economia, si trova a dover fare i
conti con il Patto di Stabilità e Crescita, del quale noi ci siamo già
occupati nella sezione 14.3.3. Il Patto infatti, al fine di impedire che
la spesa in deficit dei Governi possa generare esternalità rilevanti per
gli altri Stati membri dell’Eurozona, prevede delle sanzioni nel caso
in cui il deficit di bilancio di uno Stato superi il 3% del PIL. Ma la spesa
in deficit della Grecia è così terribilmente efficace proprio perché
è largamente superiore ai limiti imposti, e il Paese la può realizzare
Aumento dei salari
Politiche economiche
in Grecia e Portogallo
Spesa in deficit in Grecia
341
19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014
Crisi finanziaria
Credit Crunch
Crisi reale
342
senza incorrere in sanzioni solo comunicando dati di bilancio contraffatti.
A parte la situazione greca, anche gli altri Paesi periferici iniziano
a evidenziare gravi squilibri, con deficit crescenti nel conto corrente della bilancia dei pagamenti, indebitamenti (pubblici e/o privati)
crescenti, tensioni inflazionistiche. Insomma, i problemi sono latenti
ma non vengono ancora esplicitamente allo scoperto.
È su questo composito e problematico scenario che impatta lo
scoppio della bolla subprime statunitense. Impatta innanzitutto come
crisi finanziaria, poi come crisi reale. Come crisi finanziaria, perché
non solo alcune banche Europee hanno acquistato i titoli risultanti dalla cartolarizzazione dei mutui subprime degli Stati Uniti, ma
in alcuni Paesi (principalmente Spagna e Irlanda) le banche si sono
fortemente esposte concedendo mutui immobiliari ai residenti, finanziando cioè la bolla speculativa di quei Paesi.
E quando scoppia la bolla negli Stati Uniti subito dopo scoppia
anche quella europea, così che le banche si trovano a subire pesanti
perdite sia sui titoli della cartolarizzazione statunitense posseduti,
sia sui prestiti concessi ai residenti. Coll’usuale risultato di crisi bancaria, timore nel concedere prestiti ad altre banche che potrebbero essere sull’orlo del fallimento, blocco del mercato interbancario,
blocco dei prestiti all’economia reale (Credit Crunch).
Le imprese si trovano così in difficoltà nell’ottenere prestiti proprio mentre arriva la crisi reale, quella scatenata dalla riduzione delle
importazioni statunitense, che sono (anche) esportazioni dell’Europa, ossia domanda per le imprese europee. Le imprese quindi vendono meno, non riescono a ripagare i prestiti che hanno contratto,
non ottengono nuovi prestiti, falliscono o comunque riducono l’occupazione, la disoccupazione aumenta, con l’aumento della disoccupazione si riduce la domanda interna e le imprese devono ridurre
ancora la produzione. E così via.
La reazione europea alla crisi è differente dalla reazione statunitense. Stavolta la Banca Centrale Europea è inizialmente molto prudente, ritenendo che il suo obiettivo sia la stabilità dei prezzi e non
il sostegno alla domanda, ed interviene con ritardo. Intervengono
invece rapidamente alcuni Governi, con politiche di spesa pubblica
espansiva, ma a questo punto la situazione precipita.
Infatti, il 10 Novembre 2009 il nuovo Governo di George Papandreou dichiara che il bilancio della Grecia è falso: il rapporto deficit/
PIL non è del 3.6%, come assicurato dal precedente Governo, ma
molto superiore.
Non sarà né facile né rapido scoprire la vera dimensione di questo deficit, ma alla fine si rivelerà essere attorno al 15% del PIL. Sui
mercati scoppia il panico. Se fino alla crisi subprime il denaro veniva
prestato con enorme facilità, nella convinzione (rivelatasi come abbiamo visto errata) che nessuno potesse fallire, e che se anche fosse
successo esistevano strumenti finanziari sofisticati che impedivano
ai fallimenti di far danni rilevanti, dopo la crisi USA tutti diventano
19.3. La crisi europea
estremamente prudenti, e per prestare a soggetti rischiosi chiedono
tassi di interesse elevatissimi. La Grecia incontra così enormi difficoltà, ed enormi costi, nel finanziarsi sul mercato. In breve il tasso di
interesse che è costretta a pagare diventa così alto che il Paese non
può sostenerlo e chiede sostegno finanziario agli altri Stati Europei e
al Fondo Monetario Internazionale.
Il sostegno viene concesso, , prima sotto forma di prestiti bilaterali a tasso agevolato, poi anche con l’intervento dei cosiddetti fondi
salva-Stati (dei quali ci occuperemo tra breve), ma che non eviterà
alla Grecia il default (fallimento) del marzo del 2012, quando il Paese
sostanzialmente cancella il 70% dei suoi debiti – senza comunque risolvere i suoi problemi, visto che il debito si ricrea dopo pochi mesi.
Tornando al 2009, l’Irlanda comincia a percepire l’ampiezza della crisi bancaria che la colpisce, dopo che l’anno prima il Governo
ha concesso garanzie “illimitate” alle proprie banche che apparivano
sull’orlo del fallimento, garanzie che si riveleranno in seguito molto
più costose di quanto inizialmente ipotizzato.
Le banche irlandesi entrano in crisi per l’aver acquistato ingenti
quantità di titoli delle cartolarizzazioni statunitensi e inglesi (anche in
Gran Bretagna si è gonfiata, ed è scoppiata, una bolla immobiliare),
titoli che poi si sono spesso rivelati carta straccia, ma anche (soprattutto) per aver finanziato con eccessiva leggerezza i mutui immobiliari dei cittadini irlandesi, divenuti anch’essi insolventi quando la
bolla irlandese scoppia assieme a quella statunitense. Per salvare le
sue banche (ossia i correntisti delle sue banche: se una banca fallisce,
chi ha denaro sui conti correnti rischia seriamente di perderlo), il
Governo irlandese taglia gran parte delle altre spese e si indebita
pesantemente sui mercati.
Un processo analogo si registra in Spagna, dove, però, la dimensione del Paese permette di ammortizzare meglio la crisi. E fenomeni minori, con un misto di coinvolgimento in bolle speculative che
scoppiano ed eccesso di indebitamento pubblico, caratterizzeranno
anche il Portogallo e la Slovenia. Il nervosismo dei mercati fa alzare
il livello medio dei tassi di interesse che devono pagare tutti i Paesi in difficoltà, Italia compresa, rendendo sempre più problematica
la gestione della finanza pubblica soprattutto per i Paesi “deboli”
accomunati dal dispregiativo acronimo di PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna), che ricorda il termine inglese “pigs”,
maiali. A lasciar intendere che sarebbe stata una gestione finanziaria
eccessivamente disinvolta a mettere questi Paesi nei guai: cosa che,
come abbiamo visto, era vera solo per alcuni Paesi, segnatamente la
Grecia e, in parte, il Portogallo.
Di fronte a questa situazione, le politiche di intervento impiegano
un po’ a stabilizzarsi, ma poi si delineano con chiarezza. Da un lato
la Banca Centrale Europea attua una politica monetaria finalmente
espansiva, anche senza giungere mai al massiccio quantitative easing
della FED. Dall’altro tanto i governi (con alcune eccezioni) quanto le
istituzioni europee virano su politiche di bilancio restrittive.
Aumento tasso interesse
debito greco
La crisi irlandese
Politiche di intervento
nell’Eurozona
343
19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014
Le riforme obbligatorie
Le cause
della crisi europea
344
Contemporaneamente, vengono organizzate operazioni di salvataggio nei confronti dei Paesi in difficoltà, prestando loro denaro a
tassi molto più bassi dei tassi di mercato. Questi prestiti sono erogati dai fondi temporanei europei di salvataggio, che hanno proprio
lo scopo di reperire denaro sul mercato, emettendo obbligazioni
garantite dai Paesi europei più “forti”, e prestarlo ai Paesi deboli a
tassi contenuti. Questi fondi sono inizialmente l’EFSF (European Financial Stability Facility, un fondo dei Paesi appartenenti all’Unione
Economica e Monetaria) e l’EFSM (European Financial Stabilization
Mechanism, un fondo dell’Unione Europea); nell’ottobre del 2012
questi fondi temporanei sono stati sostituiti da un fondo permanente, l’ESM (European Stability Mechanism). I fondi intervengono nei
salvataggi di Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro. I Paesi che
richiedono loro assistenza finanziaria devono sottoscrivere una serie
di impegni sostanzialmente volti al rigore di bilancio, al taglio della
spesa pubblica e all’introduzione di una serie di riforme, soprattutto
nel mercato del lavoro. E sempre al rigore di bilancio, con tagli ai
deficit e riduzione del debito pubblico, si impegnano tutti i Paesi
dell’Eurozona firmando il cosiddetto Fiscal Compact. La politica del
rigore, appunto.
Mentre non ci sono grossi dubbi nell’indicare in una politica monetaria espansiva una ricetta ragionevole per combattere una recessione, più controversa è la scelta di contrastarla con politiche di bilancio restrittive come le politiche del rigore, soprattutto se nel resto del
mondo, e in particolare negli Stati Uniti e in Giappone, si compiono
scelte opposte. Le politiche di contenimento della spesa infatti, come sappiamo, riducono il reddito e aggravano la recessione. Come
giustificare, quindi, questa scelta tutta europea?
Da un lato dobbiamo forse ricordare che le istituzioni statunitensi sono tendenzialmente più pragmatiche, più Keynesiane, rispetto
alle analoghe istituzioni europee, che sono tendenzialmente più neoclassiche; e che la natura della crisi, e soprattutto la struttura istituzionale sulla quale incide, sono profondamente diverse in Europa e
negli Stati Uniti. Ciò nonostante, le politiche intraprese nell’Eurozona sono apparse discutibili a più di un economista.
Per quanto concerne le implicazioni delle diverse concezioni di
politica economica possiamo rimandare all’inizio di questo capitolo, quando abbiamo rilevato come per l’impostazione neoclassica il
sistema tenderebbe spontaneamente alla piena occupazione e l’intervento pubblico nell’economia per sostenere la domanda aggregata sarebbe inutile e soprattutto dannoso, mentre per l’impostazione
Keynesiana, nonostante il recente avvicinamento alle posizioni neoclassiche, l’intervento pubblico avrebbe ancora un ruolo.
Per quanto invece concerne la differenza tra Europa e Stati Uniti, il problema cruciale risiede nelle cause ultime della crisi europea.
Secondo una impostazione largamente condivisa, anche se non unanime, la crisi europea non sarebbe una conseguenza né della crisi
subprime degli Stati Uniti, né dell’eccesso di indebitamento pubblico
19.3. La crisi europea
(o privato) di alcuni Paesi, bensì di un problema di differenziali di
produttività/competitività tra Paesi. Secondo questa impostazione
il debito sarebbe solo una conseguenza delle strategia di crescita
che i diversi Paesi hanno adottato: come abbiamo visto, infatti, per
contrastare il calo della domanda associato al calo delle esportazioni nette, calo a sua volta determinato dalla perdita di competitività,
una volta abbandonate le proprie valute e abbracciato l’euro i Paesi
deboli dell’Eurozona non hanno più potuto utilizzare lo strumento
della svalutazione del cambio.
Alcuni Paesi hanno dunque sostenuto la domanda e il reddito generando bolle, e debito privato, altre spesa pubblica espansiva, e
dunque deficit di bilancio e debito pubblico. Il debito sarebbe dunque una conseguenza di un problema, non il problema stesso. Tra
l’altro, bolle e spesa pubblica sarebbero solo una soluzione tampone
macroeconomica a un problema che è invece microeconomico, ossia la perdita di competitività. Per risolvere il problema si dovrebbe
operare alla radice. Come? Ridando competitività all’economia, ossia facendo investimenti capaci di incrementare la produttività (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo) o riducendo i prezzi delle merci esportate.
L’ultima strategia tra quelle indicate è la più rilevante, anche se
solo perché è la meno costosa, oltre ad essere la più rapida da conseguirsi, ed è fondata sul concetto di deflazione interna. L’idea di
base è che se i salari si riducono, le imprese vedono ridursi i costi di
produzione e possono ridurre i prezzi, recuperando competitività
internazionale.
Affinché questo accada, però, è cruciale che i salari si riducano,
cosa che può accadere o con politiche di liberalizzazione del mercato
del lavoro che riducano la rigidità dei salari verso il basso, o anche
lasciando fare al mercato, perché la crisi recessiva, se protratta, tende a fiaccare la resistenza dei lavoratori, e dei sindacati, forzandoli
ad accettare le riduzioni salariali pur di uscire dalla disoccupazione.
Ciò spiega la politica del rigore adottata dalle autorità europee, che
impone tagli di spesa pubblica, che tendono a portare in recessione
l’economia, e/o riforme strutturali, tipicamente liberalizzazioni del
mercato del lavoro. Tra l’altro, secondo i proponenti queste politiche non solo porterebbero ad una maggiore competitività delle
esportazioni, ma implicando un minor ruolo dello Stato nell’economia porterebbero gli imprenditori (nazionali ed esteri) ad investire nel Paese, e gli investimenti non solo rilancerebbero la domanda
aggregata, il reddito e l’occupazione nel breve periodo, ma nel più
lungo periodo accrescerebbero lo stock di capitale contribuendo alla
crescita, ossia all’aumento della produzione potenziale del Paese.
Naturalmente esiste anche un’altra impostazione, più keynesiana,
che pur riconoscendo i problemi di produttività dei Paesi periferici
interpreta la crisi principalmente dal lato della domanda e non dal
lato dell’offerta, come fa invece l’interpretazione del rigore. Secondo questa diversa impostazione si potrebbe recuperare l’equilibrio
Non è possibile per
i singoli Paesi utilizzare
lo strumento della
svalutazione del cambio
Deflazione interna
345
19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014
tra le diverse competitività dei diversi Paesi non aumentando la com-
Debiti pubblici
e divari di produttività
petitività dei Paesi “deboli”, ma riducendo quella dei Paesi “forti”.
In particolare la Germania dovrebbe (come in parte è comunque
accaduto) iniziare a far crescere i propri salari, incrementando così i
propri prezzi e riducendo la competitività delle proprie esportazioni,
e/o far crescere la spesa pubblica, incrementando la domanda aggregata, il reddito e dunque le importazioni, che altro non sono se non
le esportazioni degli altri Paesi.
I Paesi dell’Eurozona hanno comunque scelto il rigore, probabilmente preoccupati per le conseguenze sui debiti pubblici di politiche che lasciassero più spazio alla spesa pubblica espansiva. Il lettore
può valutare da solo l’efficacia di tale scelta.
Al momento in cui questo libro va in stampa la crisi europea si
è attenuata, ma assolutamente non risolta. Soprattutto, come è evidente da quanto abbiamo sin qui detto, per superare la crisi non
sarà sufficiente agire sui debiti (pubblici e privati) dei Paesi periferici
dell’Eurozona, ma bisognerà intervenire sui divari di produttività che
sono alla base di quei debiti. Rendere insomma i Paesi europei più
simili tra loro, sia come struttura produttiva sia come assetto istituzionale, avvicinandoli all’essere quell’area valutaria ottimale che sola
potrebbe permettere a Paesi diversi di condividere un’unica moneta e
un’unica politica monetaria. In assenza di queste trasformazioni strutturali il problema non potrà che ripresentarsi, sotto le attuali o sotto
diverse spoglie, e la permanenza di alcuni Paesi nella moneta unica
diventerà sempre più problematica.
Sembra dunque corretto affermare che forse sarebbe stato opportuno riflettere meglio ed essere consci dei problemi che sarebbero potuti sorgere prima di aderire alla moneta unica europea.
19.4. Si può uscire dall’Eurozona?
I costi
dell’uscita dall’Euro
346
Poiché molti economisti avanzano, oggi, seri dubbi sulla convenienza, allora, dell’ingresso nell’Eurozona di alcuni Paesi, ci si potrebbe
domandare se, di fronte alle difficoltà di rimanere nell’area euro,
non possa essere più conveniente per un Paese abbandonare l’euro e
reintrodurre la propria valuta nazionale.
Come abbiamo già accennato, l’euro è stato però costruito per
essere una scelta (quasi) irreversibile, con costi elevatissimi in caso
di uscita di un singolo Paese: poteva forse convenire non entrare
nell’Eurozona, ma una volta entrati uscirne non è affatto facile o
indolore.
In quanto segue ci occuperemo delle conseguenze economiche
dell’abbandono dell’Eurozona da parte di un Paese, valutandone dunque la fattibilità economica; trattandosi di un manuale di economia,
non ci occuperemo invece dei problemi giuridici e delle controversie
che potrebbero sorgere, ossia della fattibilità giuridica della cosa. E
non ci occuperemo neppure del caso, più complesso ma probabil-
19.4. Si può uscire dall’Eurozona?
mente meno costoso, rappresentato da un dissolvimento concordato
dell’intera Eurozona.
Vediamo dunque cosa accadrebbe se un Paese decidesse di uscire
dall’Eurozona e tornare alla precedente valuta nazionale, o introdurre una nuova valuta nazionale, al fine di recuperare l’indipendenza
della politica monetaria e di bilancio e/o la possibilità di manovrare
il tasso di cambio.
Innanzitutto, il Paese dovrebbe effettuare l’uscita a sorpresa, non
in maniera democratica (non quindi come risultato di un referendum
o di una discussione in Parlamento). Questo perché altrimenti non
appena si iniziasse a discutere anche solo della possibilità di indire
un referendum o effettuare un voto parlamentare, tutti coloro i quali
possedessero euro sui propri depositi bancari (o titoli di quel Paese
denominati in euro) li trasferirebbero immediatamente in un altro
Paese dell’UEM (o, nel caso dei titoli, li venderebbero e ne comprerebbero altri emessi da un altro Paese), uno di quelli che si presume
manterranno la moneta unica europea, al fine di evitare le perdite
derivanti dalla conversione dei depositi e dei titoli in depositi e titoli
denominati nella nuova moneta che, verosimilmente, si deprezzerà
rispetto all’euro. Ma se si verificasse questa fuga di capitali le banche
si troverebbero prive di liquidità e il Governo non riuscirebbe più a
vendere i propri titoli sul mercato: il che condurrebbe al fallimento
tanto le banche quanto il Governo. E questo molto prima che avvenga la votazione parlamentare, il referendum e il cambiamento di valuta. Quindi è necessaria una decisione a sorpresa, presa con decreto
legge di venerdì sera a mercati chiusi e banche chiuse. Ammesso
naturalmente che ci si riesca e non ci siano fughe di notizie.
Con questa decisione il Governo non solo dichiarerà la sostituzione dell’euro con una nuova valuta, restituendo potere di emissione
e autonomia di politica monetaria alla propria Banca Centrale, ma
convertirà anche depositi bancari e debito pubblico denominati in
euro in depositi bancari e debito denominati nella nuova valuta. Il
cambiamento della denominazione del debito da euro a nuova valuta
è indispensabile perché altrimenti il Paese si troverebbe con un indebitamento in valuta straniera, compirebbe cioè il cosiddetto “peccato
originale” (original sin) che tanti problemi ha creato a parecchi Paesi
in via di sviluppo, costretti ogni anno a procurarsi in tutti i modi
ingenti quantitativi di valuta straniera per pagare interessi e rimborsi
del debito. È dunque opportuna la conversione del debito nella nuova valuta. E qui iniziano i problemi veri.
Il primo problema riguarda i depositi bancari. I correntisti, infatti, si aspetteranno che la nuova valuta si deprezzi rispetto all’euro,
quindi cercheranno di recuperare dalle banche il loro denaro (ormai
convertito nella nuova valuta, se la decisione è stata presa a sorpresa) per cambiarlo in euro prima del deprezzamento. Se ci riuscissero, non solo le banche si troverebbero in grave crisi di liquidità, ma
soprattutto si avrebbe una fuga di capitali che causerebbe proprio
il deprezzamento, in questo caso ingentissimo. Per evitare che ciò
Conversione dei depositi
e dei titoli
Cambiamento della
denominazione del debito
347
19. L’evoluzione recente della Macroeconomia e la crisi 2007-2014
Blocco circolazione
dei capitali
Debiti privati
Deprezzamento
del cambio
348
accada è ragionevole ipotizzare che si decreti un blocco alla circolazione dei capitali con l’estero ma anche la chiusura delle banche per
un certo periodo di tempo, al fine di evitare che qualcuno ritiri denaro contante per portarlo fisicamente all’estero. Tutto ciò creerebbe
problemi rilevanti ma non insormontabili all’economia del Paese.
Esiste però un secondo problema che riguarda i debiti privati. Se
il solo debito pubblico è convertito nella nuova valuta, mentre non
lo è il debito privato, le imprese si troveranno indebitate in euro
ma incasseranno (a parte quelle dedite unicamente alle esportazioni) almeno in parte pagamenti nella nuova valuta. Qualora, come è
verosimile che accada, la nuova valuta finisse per deprezzarsi rispetto
all’euro, le imprese vedrebbero aumentare enormemente i propri debiti nella nuova valuta e finirebbero per dover dichiarare insolvenza.
Non sarebbe d’altro canto possibile convertire nella nuova valuta
anche i debiti privati perché altrimenti sarebbero le banche che li
hanno concessi (e che sono indebitate con altre banche dell’Eurozona in euro) a dover dichiarare insolvenza. È quindi cruciale che
la nuova valuta si deprezzi poco o per nulla nei confronti dell’euro.
È verosimile che la nuova valuta si deprezzi poco o per nulla
rispetto all’euro? Non particolarmente. Infatti l’assenza di deprezzamento richiederebbe un totale blocco della circolazione dei capitali a tempo indeterminato e una lunga chiusura delle banche, con
pressanti controlli alle frontiere per impedire le esportazioni illegali
di denaro: tutto ciò implicherebbe conseguenze assai negative per
l’economia nazionale e non permetterebbe comunque di raggiungere l’obiettivo, come testimonia il sostanziale fallimento, almeno nel
medio/lungo periodo, di blocchi analoghi imposti in alcuni Paesi
dell’America meridionale.
Inoltre, il recupero dell’indipendenza di politica monetaria sarebbe
utile anche per recuperare lo strumento del cambio: un deprezzamento del tasso di cambio, infatti, permetterebbe di incrementare
le esportazioni e, almeno nel breve periodo, di recuperare tanto la
competitività internazionale quanto il “traino” della domanda estera
per la spesa aggregata e quindi per il reddito. Insomma, il deprezzamento del cambio sembra non solo un esito scontato, ma almeno
per il breve periodo auspicabile (anche se, nel più lungo termine,
aumenterebbe il costo delle materie prime e dei prodotti importati e
finirebbe per creare forti pressioni inflazionistiche, con aumenti dei
prezzi che rischierebbero di compromettere la ritrovata competitività). Difficile quindi pensare che non si realizzi, ma se si realizzasse
creerebbe default privati a catena nell’economia nazionale.
Questo breve elenco non esaurisce i problemi che si verificherebbero, ma può essere utile per capire l’entità delle difficoltà che
si incontrerebbero: difficoltà rilevanti, con costi economici e sociali
altissimi. Il che non implica sostenere che l’abbandono dell’Eurozona sia impossibile o non convenga: vuol solo dire che avrebbe un
senso pagare questi costi altissimi solo e unicamente se i costi della
permanenza nell’Eurozona fossero ancora più alti.
SCIENZE SOCIALI
——————————————————————
Collana diretta da Nicola Boccella
MANUALI
N. Boccella - C. Imbriani - P. Morone • Analisi microeconomica e scelte pubbliche
N. Boccella - F. D’Orlando - A. Rinaldi • Macroeconomia
A. Coppola - B. Ricciardi • Fondamenti di economia aziendale
V. Feliziani - R. Imbruglia • Fondamenti di politica economica • In preparazione
G. Marotta • Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno
F. Antolini - F. Truglia • La statistica e le statistiche. Dal dato amministrativo al dato statistico.
STRUMENTI
A. Billi - N. Boccella • Strumenti per lo studio dell’economia politica
S. Pergolesi • Appunti e letture di macroeconomia keynesiana
Rinaldi - M. Siddivò • Strumenti per l’analisi dei sistemi economici comparati
Le istituzioni finanziarie nel nuovo contesto internazionale • A cura di E. Caviglia
Le ONG protagoniste della cooperazione allo sviluppo • A cura di F. Serra
Diritti umani e nuove forme di cooperazione. I rapporti euro-maghrebini • A cura di K. Scannavini
La cooperazione decentrata. L’esperienza del Comune di Roma • A cura di P. Luzzatto
Temi di criminologia • A cura di G. Marotta
E. Sapienza • La politica regionale dell’Unione Europea
A. Testi • Il commercio internazionale. Disciplina multilaterale e sviluppo economico
A. Napolitano • Le legislazione nazionale e regionale per il turismo
P. Laurano • Il viaggiatore glocale. Mobilità, globalizzazione, comunicazione
C. Spizzichino • Il mercato del lavoro tra vecchie e nuove sfide
STUDI E RICERCHE
Ch.P. Oman - G. Wignaraja • Le teorie dello sviluppo economico dal dopoguerra a oggi
La transizione dal piano al mercato in Cina • A cura di M. Siddivò
R. Pasca di Magliano • Fondi di Ricchezza Sovrana
Mutamento sociale, diritti, parità di genere • A cura di S. Petilli
G. Bechtle • Potere e soggetto. Il dibattito sul post-fordismo
G.P. Orsello • Antonio Labriola. Il pensiero del filosofo e l’impegno del politico
L’ideologia fondamentalista tra identità e differenza. Dal Maghreb all’Africa a sud del Sahara. Un profilo storico
A cura di A. Piga e I. Pizzardi
Quale futuro per l’Africa: le prospettive della Nigeria • A cura di A. Billi e R. Miranda
Tecnologie dell’informazione e comportamenti devianti • A cura di G. Marotta
Le Organizzazioni Non Governative. Risorse e modelli di organizzazione • A cura di N. Boccella e O. Tozzo
CIDEM - IPS • Comunicare la cooperazione. Una sfida difficile
CIDEM - IPS • Comunicare la cooperazione. Terzo rapporto. La stampa settimanale europea
Diritti umani e diritto allo sviluppo. La promozione dei diritti dei minori da una prospettiva di genere
A cura di N. Boccella e P. Viero
Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche • A cura di N. Boccella
G.L. Gregori • Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d’età romana
Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile
all’indirizzo web http://www.lededizioni.com, dove si possono trovare anche informazioni dettagliate sui
volumi sopra citati: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni vengono date un certo numero di
pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere ordinati on line.