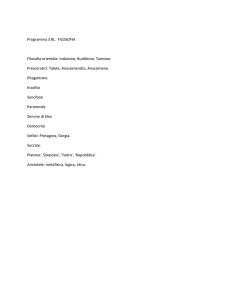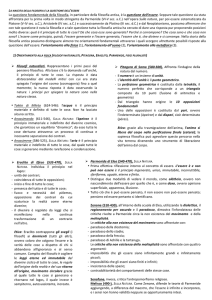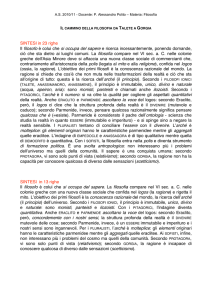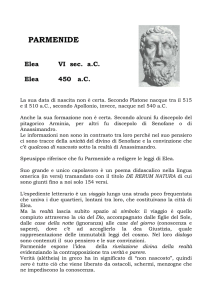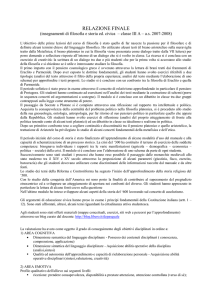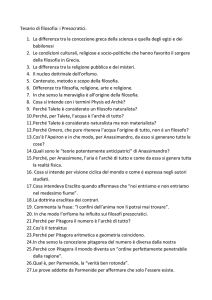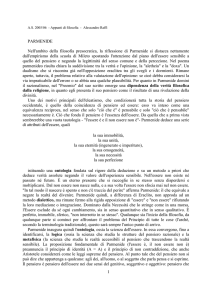Dario Zucchello
Le origini del pensiero occidentale
Casa Editrice Polaris
Faenza
1997
1
Indice
Indice .......................................................................................................................................................................1
1. La splendida storia dei presocratici..............................................................................................................3
2. Il problema delle origini...............................................................................................................................3
2.1
Aristotele e la ricostruzione delle origini della filosofia ......................................................................4
2.2
Talete e l’orizzonte della prima speculazione filosofica ......................................................................8
2.3
Anassimandro e il più antico frammento della filosofia occidentale .................................................10
3. Pitagora e il pitagorismo antico..................................................................................................................13
4. Eraclito.......................................................................................................................................................17
4.1
Il logos ...............................................................................................................................................18
4.2
La struttura del logos..........................................................................................................................20
4.3
Una nuova tavola di valori .................................................................................................................21
5. Parmenide: il poema...................................................................................................................................22
5.1
Rivelazione e Verità...........................................................................................................................24
5.2
Gli enti e l’orizzonte dell’essere ........................................................................................................25
5.3
Pensiero e essere ................................................................................................................................26
5.4
I segni dell’essere...............................................................................................................................27
5.5
Essere e apparenza .............................................................................................................................30
6. L’eleatismo.................................................................................................................................................31
6.1
La dialettica di Zenone.......................................................................................................................32
6.2
Melisso: totalità e infinità dell’essere ................................................................................................33
6.3
I nuovi segni dell’essere ....................................................................................................................34
6.4
L’essere è uno ....................................................................................................................................36
7. Dopo Parmenide: Empedocle e Anassagora ..............................................................................................36
7.1
Le radici di tutte le cose.....................................................................................................................38
7.2
Amicizia e Contesa ............................................................................................................................39
7.3
Tutto in tutto.......................................................................................................................................41
7.4
Il Nous ................................................................................................................................................42
8. Dopo Parmenide: Democrito e l’atomismo antico .....................................................................................43
8.1
Il confronto con l’eleatismo: la conoscenza .......................................................................................44
8.2
Il confronto con l’eleatismo: atomi e mondi ......................................................................................45
9. Conclusione................................................................................................................................................47
Lessico ...................................................................................................................................................................49
2
1. La splendida storia dei presocratici
<<La storia dell’antica filosofia greca, specialmente da Talete a Platone, è uno splendido racconto,
fin troppo bello per essere vero. In ogni generazione troviamo almeno una nuova filosofia, una
nuova cosmologia di sorprendente originalità e profondità. Come era possibile questo? Naturalmente, non c’è spiegazione per l’originalità e il genio. Si può cercare, tuttavia, di gettarvi un po’ di
luce. Qual era dunque il segreto degli antichi?>> 1 .
L’interrogativo del filosofo contemporaneo Karl Raimund Popper (1902-1994), che volutamente lasciamo in sospeso, può essere utilizzato come traccia del percorso da noi costruito
sui testi degli autori all’origine della nostra tradizione filosofica. Nello specifico lo studente
dovrà attendere la conclusione della ricerca per riscontrare l’indicazione popperiana e giudicarla sulla scorta della propria esperienza di lettura. Quanto possiamo senz’altro già anticipare
è la risposta che lo stesso filosofo ha proposto a un ulteriore quesito, che ci investe direttamente: a che cosa si deve il continuo rinnovato interesse degli studiosi per la filosofia dei presocratici (così sono impropriamente designati quei pensatori che precedono, nella ricostruzione aristotelica, la svolta incarnata dal filosofo ateniese)?
Popper individua due motivi che per noi si riveleranno di grande rilevanza:
1. la semplicità e la temerarietà dei loro problemi,
2. l’atteggiamento critico del pensiero occidentale, sviluppato per la prima volta dai pensatori ionici 2 .
C’è, secondo Popper, almeno un problema filosofico a cui tutti gli uomini che pensano sono interessati: quello della comprensione del mondo in cui viviamo, di noi stessi che ne siamo
parte, e della nostra conoscenza di esso. E gli interrogativi cui i presocratici tentarono di rispondere erano soprattutto questioni cosmologiche (qual è la struttura fondamentale della realtà, di che cosa sono fatte le cose ecc.), e, connessi con queste, problemi di teoria della conoscenza 3 . D’altra parte, l’impronta predominante all’interno delle scuole filosofiche greche
(anche in questo caso l’uso del termine scuola è un po’ forzato) sarebbe stata, secondo il filosofo austriaco, quella della discussione razionale, per cui le idee nuove sarebbero scaturite
quale risultato di una critica aperta delle convinzioni e teorie precedentemente formulate. Saremmo così in presenza di un fenomeno unico, strettamente legato alla libertà e creatività della filosofia greca.
Ma come si articolò quella ricerca, e in che senso possiamo parlare di discussione? Nei paragrafi seguenti ci proponiamo di illustrare soprattutto questi due punti.
2. Il problema delle origini
Le origini della filosofia rappresentano per noi un problema praticamente insolubile, dal
momento che possiamo sondarle solo in modo approssimativo e frammentario. Le lontane voci dei protagonisti sono quasi del tutto perdute anche per quanto riguarda la loro espressione
scritta, senz'altro marginale all'interno di un mondo per lo più dominato dall'oralità; gli stessi
brani tramandati, normalmente schegge sopravvissute di testi dai contorni per noi ipotetici, ci
hanno raggiunto nelle testimonianze di autori più tardi, come Platone e Aristotele o i loro scolari all'interno dell'Accademia e del Liceo (IV secolo), che ne riferivano nell'ambito di opere
di forte impegno teoretico, destinate quindi a piegare le posizioni degli antichi sapienti alla
propria logica intrinseca. In altri casi decisive sono le testimonianze di commentatori aristotelici o neoplatonici o quelle dei padri della Chiesa, certamente non intese a riprodurre con e1
) K.R. Popper Ritorno ai presocratici in Congetture e confutazioni, Bologna, 1972, p.256.
) Ibidem p.235.
3 ) Ibidem.
2
3
quilibrio l'impostazione originaria degli autori citati, coinvolti nei contesti più diversi. Possiamo così affermare, onestamente, che l'universo di pensiero che costituì la radice della nostra tradizione occidentale è per noi ampiamente indisponibile.
Eppure ci apprestiamo a tentare una ricostruzione delle linee d’articolazione di quella tradizione, muovendo proprio da quel problema, nella convinzione che un confronto è almeno
inevitabile, seppur pregiudicato, e che referenti principali, di là dai frammenti dei sapienti (filologicamente recuperati e disponibili, insieme alle relative testimonianze, nella raccolta curata nei primi anni del secolo da H. Diels e rinnovata nel 1934 da W. Kranz, da cui la sigla d'identificazione DK), rimangono Platone e Aristotele, in altri termini coloro che, nella propria
prospettiva filosofica, strutturata su peculiari categorie di pensiero, hanno retrospettivamente
aperto l'orizzonte della filosofia, fornendone anche una prima sistematica definizione e conseguente collocazione rispetto alle altre forme di sapere.
Certamente essi (particolarmente Platone) avvertirono talora il senso della distanza insuperabile tra la loro posizione culturale e quella degli antichi, in ogni caso la riflessione proposta
sul rapporto con la sapienza dei secoli VI e V a.C. è tale da tratteggiare una parabola filosofica, cui, rispettivamente, essi ritenevano d’aver contribuito in modo determinante e conclusivo.
Allo scandaglio di quei tratti, sebbene evidentemente segnati, non ci si può sottrarre se si intende avvicinare quella sapienza, semplicemente perché, a prescindere da quelle indicazioni in ogni modo da soppesare e vagliare nella collazione reciproca -, avanzeremmo a tentoni, potendo contare poi solo su frammenti ricavabili, in larga misura, proprio dalla lezione (platonica e aristotelica) cui si vorrebbe rinunciare.
2.1 Aristotele e la ricostruzione delle origini della filosofia
Platone e specialmente Aristotele, fissando l'origine di quella parabola filosofica in Talete,
hanno oltretutto istituito, di riflesso, due ordini di questioni, per noi, introduttivamente rilevanti:
i) quello relativo ai nessi tra filosofia (philosophia) e tradizioni sapienziali mediterranee e
orientali,
ii) quello riguardante i nessi tra mito (mythos) e philosophia, fondamentali per de-finire il
perimetro semantico del termine.
Sono in questa direzione esemplari i primi due capitoli del libro Alfa della Metafisica di
Aristotele 4 .
1. Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l'amore per le sensazioni: infatti, essi amano
le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e, più di tutte, amano la sensazione
della vista. In effetti, non solo ai fini dell'azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi
preferiamo il vedere, in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa
conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose.
[...]
Orbene, mentre gli altri animali vivono con immagini sensibili e con ricordi, e poco partecipano dell'esperienza, il genere umano vive, invece, anche d'arte e di ragionamenti. Negli uomini, l'esperienza deriva
dalla memoria: infatti, molti ricordi dello stesso oggetto giungono a costituire un'esperienza unica. L'esperienza, poi, sembra essere alquanto simile alla scienza e all'arte: in effetti, gli uomini acquistano scienza e arte attraverso l'esperienza. L'esperienza, infatti, come dice Polo, produce l'arte, mentre l'inesperienza
produce il puro caso. L'arte si genera quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un giudizio
generale ed unico riferibile a tutti i casi simili.
Per esempio, il giudicare che a Callia, sofferente di una determinata malattia, ha giovato un certo rimedio,
e che questo ha giovato anche a Socrate e a molti altri individui, è proprio dell'esperienza; invece il giudicare che a tutti questi individui, ridotti ad unità secondo la specie, sofferenti di una certa malattia, ha giovato un certo rimedio (per esempio ai flemmatici o ai biliosi o ai febbricitanti) è proprio dell'arte.
[...]
4)
Citiamo dalla traduzione di G. Reale, Loffredo, Napoli, 1968. Sottolineature nostre.
4
[...] noi riteniamo che il sapere e l'intendere siano propri più all'arte che all'esperienza, e giudichiamo coloro che posseggono l'arte più sapienti di coloro che posseggono la sola esperienza, in quanto siamo convinti che la sapienza, in ciascuno degli uomini, corrisponda al loro grado di conoscere. E, questo, perché i
primi sanno la causa, mentre gli altri non la sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece gli altri conoscono il perché e la causa.
Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione nelle singole arti siano più degni di onore e posseggano maggiore conoscenza e siano più sapienti dei manovali, in quanto conoscono le cause delle cose
che vengon fatte; invece i manovali agiscono, ma senza sapere ciò che fanno, così come agiscono alcuni
degli esseri inanimati, per esempio, così come il fuoco brucia: ciascuno di questi esseri inanimati agisce
per un certo impulso naturale, mentre i manovali agiscono per abitudine. Perciò consideriamo i primi come più sapienti, non perché capaci di fare, ma perché in possesso di un sapere concettuale e perché conoscono le cause.
In generale, il carattere che distingue chi sa rispetto a chi non sa, è l'essere capace di insegnare: per questo noi riteniamo che l'arte sia soprattutto scienza e non l'esperienza; infatti coloro che posseggono l'arte
sono capaci di insegnare, mentre gli empirici non ne sono capaci.
Inoltre, noi riteniamo che nessuna delle sensazioni sia sapienza: infatti, se anche le sensazioni sono, per
eccellenza, gli strumenti di conoscenza dei particolari, non ci dicono, però, il perché di nulla: non dicono,
per esempio, perché il fuoco è caldo, ma solamente segnalano il fatto che esso è caldo.
È logico, dunque, che chi per primo scoprì una qualunque arte superando le comuni conoscenze sensibili,
sia stato oggetto di ammirazione da parte degli uomini, proprio in quanto sapiente e superiore agli altri, e
non solo per l'utilità di qualcuna delle sue scoperte. Ed è anche logico che, essendo state scoperte numerose arti, le une dirette alle necessità della vita e le altre al benessere, si siano sempre giudicati più sapienti gli scopritori di queste che non gli scopritori di quelle, per la ragione che le loro conoscenze non erano
rivolte all'utile. Di qui, quando già si erano costituite tutte le arti di questo tipo, si passò alla scoperta di
quelle scienze che non sono dirette né al piacere né alle necessità della vita, e ciò avvenne dapprima in
quei luoghi in cui gli uomini erano liberi da occupazioni pratiche. Per questo le arti matematiche si costituirono per la prima volta in Egitto: infatti, là era concessa questa libertà alla casta dei sacerdoti.
Si è detto nell'Etica quale sia la differenza fra l'arte e la scienza e le altre discipline dello stesso genere. E
lo scopo per cui noi ora facciamo questo ragionamento è di mostrare che con il nome di sapienza tutti intendono la ricerca delle cause e dei principi. Ed è per questo che, come si è detto sopra, chi ha esperienza
è ritenuto più sapiente di chi possiede soltanto una qualunque conoscenza sensibile: chi ha l'arte più di chi
ha esperienza, chi dirige più del manovale e le scienze teoretiche più delle pratiche.
È evidente, dunque, che la sapienza è una scienza che riguarda certi principi e certe cause.
2.Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, dovremo esaminare di quali cause e di quali principi sia scienza la sapienza. E forse questo diventerà chiaro, se si considereranno le concezioni che abbiamo del sapiente. [...]
Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad
un'unica e medesima scienza: essa deve speculare intorno ai principi primi e alle cause: infatti, anche il
bene e il fine delle cose è una causa.
Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che
per primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine,
a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici,
in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è
per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da
un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressoché tutto ciò
che necessitava alla vita ed anche all'agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa
forma di conoscenza. È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.
[...] Essa [...] fra tutte, è la più divina e la più degna di onore. Ma una scienza può essere divina solo in
questi due sensi: a) o perché essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, b) o, anche, perché essa
ha come oggetto le cose divine. Ora, solo la sapienza possiede ambedue questi caratteri: infatti, è convinzione a tutti comune che Dio sia una causa e un principio, e, anche, che Dio, o esclusivamente o in grado
5
supremo, abbia questo tipo di scienza. Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna
sarà superiore.
D'altra parte, il possesso di questa scienza deve porci in uno stato contrario a quello in cui eravamo all'inizio delle ricerche. Infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal meravigliarsi che le cose stiano in
un determinato modo: così, ad esempio, di fronte alle marionette che si muovono da sé nelle rappresentazioni, o di fronte alle rivoluzioni del sole o alla incommensurabilità della diagonale al lato: infatti, a tutti
coloro che non hanno ancora conosciuto la causa, fa meraviglia che fra l'una e l'altro non vi sia una unità
minima di misura comune. Invece, bisogna pervenire allo stato di animo contrario, il quale è anche il migliore, secondo che dice il proverbio. E così avviene, appunto, per restare agli esempi fatti, una volta che
si sia imparato: di nulla un geometra si meraviglierebbe di più che se la diagonale fosse commensurabile
al lato.
Si è detto, dunque, quale sia la natura della scienza ricercata, e quale sia lo scopo che la nostra ricerca e
l'intera trattazione devono raggiungere.
ESERCIZIO
• Prima di procedere alla lettura del commento al testo, lo studente provi a fissare per iscritto i punti essenziali della presentazione aristotelica della “sapienza”.
• Si tenti una prima, provvisoria definizione dei termini “esperienza”, “arte”, “scienza”, “sapienza” e
“filosofia”
La filosofia, come indagine sull'intelaiatura generale della realtà, è,
secondo il pensatore greco, strutturalmente radicata nella nostra natura,
in quella brama di conoscenza (orexis tou eidenai) che ci contraddistingue
in quanto esseri umani, ed è commisurata alla nostra organizzazione sensoriale, alle nostre capacità gnoseologiche (conoscitive), che culminano nella possibilità astrattiva dell'universale, in altri termini nella focalizzazione degli aspetti ontologici comuni ai diversi enti individuali, che
ritroviamo alla base di quel sapere concettuale che contraddistingue eminentemente il sapiente.
L'impulso verso il sapere non è dunque qualcosa d'accidentale per l'uomo,
è
invece
costitutivo
del
suo
essere,
imponendo
l'esigenza
di
un’esplicazione piena e conseguente. In questo senso si deve leggere il riferimento agli animali, per la sottolineatura della peculiarità del vivere
umano, ancorato a immagini e ricordi, ma anche, e soprattutto, a esperienza
(empeiria) e arte (techne). L'esperienza si pone in continuità con la sensazione e la memoria, come conoscenza dell'individuale, l'arte ne prolunga
l'interesse pratico (come accennato nell'esempio del medico), garantendo
nel contempo un approfondimento delle mere constatazioni empiriche, verso
il perché (la ragione e il fondamento), che segna un vero scarto qualitativo.
Il piano appropriato per il dispiegamento della brama di conoscenza sarà
quindi quello della techne, in quanto scienza, sapere concettuale, che ha
come oggetto l'universale, di cui indaga le cause. Aristotele ne individua
un percorso storico di sviluppo, dalle origini tecnico-pratiche fino al
sorgere di un interesse scientifico puramente speculativo, la cui finalità
è assolutamente intrinseca, presupponendo il disimpegno da obblighi materiali (come nel caso dei sacerdoti egiziani). Tale eccellenza, denotata come sapienza, è affrontata da Aristotele attraverso un confronto con le correnti accezioni pre-filosofiche del termine, che consentono di focalizzare
l'ambito e il livello della scansione causale. Il sapere fine a se stesso e
la scienza in senso pieno implicano, così, uno scandaglio delle cause e dei
principi primi, in altre parole risalgono a quegli esclusivi fondamenti in
cui si radica la comprensione totale della realtà. Ciò rappresenta l'eccezionalità divina della sapienza, come conoscenza universale, difficile, esatta, di maggiore consistenza scientifica, quindi gerarchicamente dominante.
La philo-sophia, in quanto amore, cura della sapienza, è investigazione
delle cause e dei principi primi; la conquista del sapere aitiologico (delle cause) e archeologico (dei principi) è dunque sophia (sapienza). Investigazione e conquista (dominio epistemico, scientifico) sono le tappe lungo le quali si snoda la conoscenza, in senso lato, della realtà: la scienza
6
(episteme) delle cause e dei principi primi assicura un'apertura metafisica
e un respiro divino, in quanto il reale, nella sua globalità, dipende in
ultima analisi da quei fondamenti, e la loro determinazione garantirà da un
lato la possibilità della comprensione scientifica di quella totalità, dall'altro la possibilità della divulgazione di quella comprensione, in altri
termini due dei segni topici della sapienza secondo Aristotele.
Il compimento della ricerca aitiologica comporta la risoluzione del desiderio di conoscenza: tenendo conto delle gerarchie che Aristotele nettamente delinea tra empeiria (mera constatazione fattuale), da un lato, e techne
e episteme (sapere in senso proprio) dall'altro, e (meno chiaramente in
questo luogo) tra arte (conoscenza finalizzata a una produzione) e scienza
(in ultima analisi contemplazione, teoresi, speculazione disinteressata),
dobbiamo concludere che nell'investigazione filosofica, come appassionata
approssimazione alla sapienza, si realizza quel modo di vita (bios theoretikos, vita contemplativa) in cui giunge a piena attuazione la nostra umanità.
Ma Aristotele, sulla scorta di Socrate e Platone, segnala anche un altro
risvolto di questa strutturale aspirazione alla sapienza: essa ha come condizione originaria la meraviglia, la stupefatta apertura di fronte alla realtà, la consapevolezza del proprio non-sapere, e il conseguente sbalordito
interrogarsi sull'assetto degli enti della nostra esperienza. D'altra parte
tutto il brano è giocato sulla manifestatività del reale, sulla sua visibilità, in termini sensoriali e intellettuali. Il privilegiamento del vedere
che qui si palesa è il segno della riflessione greca che s’imprime su tutta
la nostra tradizione. Sul vedere sono ritagliati concetti come aletheia
(verità), theorein (contemplare, speculare), eidenai (conoscere), eidosidea (idea, specie), noein (pensare).
La filo-sofia nasce così (ora come in origine, sostiene Aristotele) non
genericamente da un istinto, seppur sedimentato e decantato nella natura
umana, bensì dalla cosciente riflessione, certamente vissuta emotivamente,
sui principi dell'ordine che investe i diversi livelli del reale. Ciò consente a Aristotele anche un altro decisivo coinvolgimento: il mito, il racconto a sfondo religioso centrale nella formazione della civiltà greca, a
partire dalla tradizione di Omero e Esiodo (e non solo). Esso è qui accomunato problematicamente al filosofare proprio per la registrazione stupefatta dell'incomprensibile, e per il tentativo di darne ragione: indicativamente interessante l'accostamento a interrogativi d'ordine fisico e cosmologico, per il pensatore greco evidentemente originari nella cultura filosofica. Se differente risulterà la qualità e la disciplina nella risposta,
la sua struttura e il suo linguaggio, identica è l'esigenza di fondo. Questo però non significa che per Aristotele qualsiasi indagine sia filosofica. È chiara, nella prima parte del brano, la gerarchia del sapere, da
quello motivato da urgenze immediate a quello più sottilmente legato alle
comodità del vivere, su su fino alla speculazione disinteressata, orientata
verso la totalità. Questa, nel suo compiersi, sarà propriamente philosophia, nella sua piena realizzazione, invece, sophia.
Con tale traccia Aristotele riconosce e giustifica anche le conquiste
scientifiche egiziane, pur sovraordinando teoreticamente la sapienza, da
collocarsi perciò in una stagione storica di sviluppata civiltà, quale
quella greca dei secoli VII-V: il primo filosofo sarà dunque Talete e la
filosofia sarà questione ellenica.
L'indagine storica ha lavorato a lungo intorno alle affermazioni aristoteliche, in particolare
cercando di dipanare:
• il nodo del rapporto tra mito e logos, in una direzione assai più articolata di quanto non
prospettato nei passaggi del brano (che, d'altra parte, non è l'unica occasione in cui l'autore
s’interessò del problema, come rivelano i frammenti dei dialoghi perduti),
• e quello dei rapporti della filosofia greca con le culture orientali, indirettamente accennato nel riferimento alla matematica egiziana.
7
Il quadro di cui oggi possiamo disporre è certamente più frastagliato, eppure il testo aristotelico tiene come lezione introduttiva: sia per la prossimità-differenza implicita nel primo nodo, sia per la sostanziale marginalità del secondo.
2.2 Talete e l’orizzonte della prima speculazione filosofica
Abbiamo visto in precedenza come nella tradizione stabilitasi a partire da Platone e Aristotele (quest'ultimo, a suo modo, primo storico della filosofia) l'origine della filosofia sia riportata all'ambiente greco della costa dell'Asia Minore (Ionia), e alla riflessione di Talete, vissuto
tra la fine del VII e la metà del VI secolo. Dal punto di vista naturalistico, che abbiamo rintracciato anche nei due capitoli introduttivi della Metafisica, il pensatore di Mileto (ma di famiglia forse d'ascendenze fenicie) era riconosciuto da Aristotele come fondatore della filosofia della natura, in altre parole, iniziatore di quell'indagine sui principi alla base del mondo
che noi diremmo fisico, ma che, nell'interpretazione aristotelica, esauriva l'orizzonte della realtà contemplato da Talete. Anche in questo caso vale la pena leggere la testimonianza della
Metafisica (capitolo III), per prendere coscienza dell'approccio di Aristotele agli antichi sapienti, e delle categorie coinvolte.
3. È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti, diciamo di conoscere una
cosa quando riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause vengono intese in quattro significati
diversi. In un primo senso, diciamo che causa è la sostanza e l'essenza: infatti, il perché delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma: e il primo perché è appunto una causa e un principio; in un secondo senso, diciamo che causa è la materia e il sostrato; in un terzo senso, poi, diciamo che causa è il principio del movimento; in un quarto senso, diciamo che è causa quella opposta a quest'ultima, ossia lo scopo e il bene: infatti, questo è il fine della generazione e di ogni movimento. Queste cause sono state da
noi studiate adeguatamente nella Fisica, tuttavia dobbiamo prendere in esame anche coloro che prima di
noi hanno affrontato lo studio degli esseri ed hanno filosofato intorno alla realtà. È chiaro, infatti, che
anch’essi parlano di certi principi e di certe cause. Ora, il rifarsi ad essi sarà certo di vantaggio alla presente trattazione: infatti, o troveremo qualche altro genere di causa, oppure acquisteremo più salda credenza nelle cause di cui ora si è detto.
La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che principi di tutte le cose fossero solo
quelli materiali. Infatti essi affermarono che ciò di cui tutti gli esseri sono costituiti e ciò da cui derivano
e in cui si risolvono da ultimo, è elemento ed è principio degli esseri, in quanto è una realtà che permane
identica pur nel trasmutarsi delle sue affezioni. E, per questa ragione, essi credono che nulla si generi e
che nulla si distrugga, dal momento che una tale realtà si conserva sempre. [...]
Tuttavia, questi filosofi non sono tutti d'accordo circa il numero e la specie di un tale principio. Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è l'acqua (per questo afferma anche che la terra galleggia sull'acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si genera dall'umido e vive nell'umido. Ora, ciò da
cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione da
questo fatto e dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una natura umida e l'acqua è il principio della natura delle cose umide.
Ci sono, poi, alcuni i quali credono che anche gli antichissimi che per primi hanno trattato degli Dei, molto prima della presente generazione, abbiano avuto questa stessa concezione della realtà naturale. Infatti,
posero Oceano e Teti come autori della generazione delle cose, e dissero che ciò su cui gli Dei giurano è
l'acqua, la quale da essi vien chiamata Stige. Infatti, ciò che è più antico è anche ciò che è più degno di rispetto, e ciò su cui si giura è, appunto, ciò che è più degno di rispetto. Ma che questa concezione della realtà naturale sia stata così originaria e così antica, non risulta affatto in modo chiaro; al contrario, si afferma che Talete per primo abbia professato questa dottrina intorno alla causa prima[...].
ESERCIZIO
• Individuare nel testo i passaggi essenziali per definire il rapporto tra “mito” e “filosofia”
L'impostazione dell'esposizione aristotelica è trasparente sin dalle prime righe, che si riallacciano direttamente alla riflessione sulla sapienza
8
dei capitoli precedenti: la comprensione della realtà è possibile solo attraverso la determinazione delle cause prime. Nella sua famosa catalogazione delle classi di cause (formale [che riguarda la struttura intrinseca],
materiale, efficiente e finale), Aristotele è confortato dalla lezione dei
predecessori: nessuno, di fatto, ne aveva individuato un ordine ulteriore.
La rassegna ha così la funzione di verificare la validità storica e l'efficacia comparativa della griglia adottata.
Questa operazione, come in precedenza rilevato, ha, rispetto alle nostre
esigenze di intellezione, il limite della facile manipolazione delle posizioni originarie dei filosofi evocati, evidentemente sottoposte alla distorsione delle categorie aristoteliche o a schemi in ogni caso posteriori.
In tal modo, ad esempio, tutta la ricostruzione della prima speculazione
ionica è rigorosamente condotta nell'ottica della filosofia della natura,
proiettandovi termini tecnici e concettualità propri dell'analisi di Aristotele o dell'ambiente dell'Accademia platonica in cui egli si era formato. Eppure, dalla più tarda lezione dossografica (quella, in altre parole,
che raccoglieva la tradizione delle opinioni dei vari filosofi) di Diogene
Laerzio (III secolo d.C.) noi veniamo a riconoscere in quei sapienti delle
personalità complesse, cui si attribuivano anche altre competenze (nel caso
di Talete, in ambito etico).
Ma veniamo a quanto sostenuto da Aristotele sull’argomento specifico. Egli sottolinea come, rispetto alla propria classificazione, coloro che primi filosofarono individuarono principi d'ordine materiale: Infatti essi affermano che ciò di cui tutti gli esseri sono costituiti e ciò da cui derivano originariamente e in cui si risolvono da ultimo, è elemento e è principio degli esseri, in quanto è una realtà che permane identica pur nel
trasmutarsi delle sue affezioni. Questo significa che, nell'interpretazione
aristotelica almeno, il primo grande tema filosofico, capace di problematizzare l'intero arco della realtà (non si dimentichi che l'autore parla di
impegno peri tes aletheias, intorno alla realtà, ma letteralmente intorno
alla verità, come disvelamento dell'essere) è quello del divenire, del nascere e corrompersi degli enti, del mutare delle loro proprietà (affezioni). I primi filosofi, insomma, approntarono una strategia per comprendere,
afferrare
la
complessità
della
natura
(physis),
riducendola
all’elementarità di un principio (arché). I due termini meritano una particolare considerazione, rivelandosi poi portanti nella lezione filosofica
greca.
Il termine physis (fusiς) indica da un lato l'insieme degli enti che nascono e crescono (in questo condividendo la stessa radice etimologica del
latino natura), contrapposto ai prodotti della techne (ma quest’aspetto sarà probabilmente fissato solo in epoca posteriore); dall'altro individua il
principio intrinseco di sviluppo di quegli enti, e in questo senso esso ricorrerà più frequentemente nelle pagine dei filosofi, spesso ricordate, non
a caso, come Peri physeos (Sulla natura), titolazione forse di comodo, che
sfruttava proprio l'ambiguità dell'espressione.
Il termine arché (arch) fu introdotto probabilmente proprio dai pensatori
ionici: esso designa l'origine, l'inizio, il punto di partenza di un processo, non nel senso di contributo puntuale, momentaneo e estrinseco, ma in
quello di presenza strutturale. Chiaramente il concetto tende a sovrapporsi
alla seconda accezione, quella specifica, di physis. Aristotele (che pure
gli accosta il termine stoikeion, sicuramente più tardo e in ogni modo d'uso tecnico nelle sue esposizioni) lo connota ulteriormente come ciò di cui
tutti gli esseri sono costituiti, e ciò da cui derivano originariamente e
in cui si risolvono da ultimo: il principio è allora non solo origine ma
anche fine, è caratterizzato dalla permanenza. Utilizzando ancora il proprio bagaglio lessicale, Aristotele qualifica l'arché come realtà che “giace sotto”, perdura a fondamento delle trasformazioni.
In tal modo si palesa il doppio volto del principio: dal punto di vista
ontologico (dell'essere) esso è la realtà da cui tutto scaturisce e cui ogni ente sostanzialmente si riduce; da quello logico esso svolge la funzione di condizione di intelligibilità del divenire: per questa ragione essi
credono che nulla si generi e che nulla si distrugga, dal momento che una
tale realtà [physis]si conserva sempre. I processi che investono la natura
nel suo complesso possono essere in prima istanza decifrati nella misura in
9
cui siano riconducibili a un sostrato permanente, che allontani lo spettro
del nulla, capace d’annientare qualsiasi sforzo razionale. Aristotele, interpretando e enucleando a suo modo la logica delle argomentazioni arcaiche, ne focalizza così la dimensione omogeneizzante e unificante, che rimarrà poi un tratto indelebile della nostra razionalità occidentale.
Il riferimento a Talete (iniziatore di questo tipo di filosofia) si inserisce in questo contesto: avendo, secondo l'autore, i primi filosofi avviato la propria indagine naturalistica ricercando un solo genere di causalità, quella materiale, la rassegna delle loro posizioni è inaugurata con la
scelta taletiana dell'acqua. Lo spazio modesto dedicato, nello specifico,
al capostipite segnala lo scarso spessore delle testimonianze disponibili
per Aristotele, il quale procede, a suo modo, a una ricostruzione, in assenza di citazioni autentiche. Nell'economia complessiva del discorso ciò è
in ogni caso indicativo, giacché le probabili ragioni di quella scelta sono
fatte reagire sulla tradizione mitologica, che pur si era espressa in termini superficialmente convergenti al logos taletiano, rimarcandone lo scarto. Da un lato abbiamo, infatti, un'argomentazione fondata sull'elaborazione razionale del dato empirico (l'associazione tra acqua e vita in genere),
dall'altro il quadro antropomorfico delle narrazioni religiose. Si mostrano
dunque la continuità (molto filtrata) e la differenza (qualitativa) precedentemente indicate tra mito e logos, con il chiaro riscontro aristotelico
sulla peculiarità della posizione filosofica.
La cautela di Aristotele, espressa anche in altri testi riferiti al filosofo di Mileto, è pienamente comprensibile, per la carenza d’informazioni su quella figura quasi leggendaria, oltretutto vissuta in un'epoca segnata dal primato culturale dell'oralità, che non consente alcun approfondimento organico. Gli vengono in ogni modo attribuite, dalla tradizione posteriore riflessa nelle opere aristoteliche, tre tesi:
a) l'acqua è principio (o natura) di tutte le cose,
b) il magnete ha un'anima,
c) tutto è pieno di dei.
Difficile collegarle logicamente. Il primo punto, in ogni caso controverso, è quello che rivela forse connessioni con la tradizione mitica e con l'Oriente: l'acqua è proposta, alla luce di
considerazioni analogiche probabilmente relative alla fisiologia dei viventi, come costituente
originario degli enti, che persiste come substrato, e in cui tutto in fine perisce. L'acqua in questo senso alimenterebbe il divenire, giustificando, come scaturigine di vita, sviluppo e crescita, e, sostenendo nello stesso tempo la terra (quasi legno galleggiante), si rivelerebbe ulteriormente fondamentale. La dimensione vitalistica, che torna anche in altri autori arcaici, potrebbe garantire un nesso con le altre due affermazioni, ridimensionando parzialmente lo
schema ermeneutico aristotelico: l'intrinsecità e la pervadenza della natura originaria nella totalità delle cose, la rendono animatrice, nell'accezione mitica di una divinità e in quella scientifica di un motore.
Nel caso Talete abbia effettivamente sostenuto la prima tesi, l'importanza del suo contributo sarebbe da leggersi come impulso alla generalizzazione, alla ricerca dell'universale nella
totalità: nella convinzione che solo raccogliendo il molteplice a unità, omogeneizzandone le
differenze nell'identità di un comune denominatore, sia possibile la comprensione. Con un ulteriore, indicativo sviluppo: la radice originaria (physis) mantiene un ruolo di essenza (intrinseco nucleo strutturante) rispetto ai fenomeni (che, letteralmente, appaiono); alla base della
molteplicità manifesta si cela un fondamento (una realtà stabile e portante), che la riscatta,
con la propria stabilità, dal suo trascorrere.
2.3 Anassimandro e il più antico frammento della filosofia occidentale
Anassimandro, vissuto a Mileto tra la fine del VII secolo e la metà del VI, è stato considerato, anche dalla dossografia più antica, seguace di Talete, di cui avrebbe sviluppato la ricerca
naturalistica. Per noi è il primo pensatore in qualche modo documentato dalla tradizione, che
10
ci ha conservato poche righe di un'opera Sulla natura, e, indirettamente, alcuni motivi argomentativi di grande interesse scientifico e logico. Per quanto possibile ricostruire dalle testimonianze, ci troviamo nuovamente in presenza di una personalità complessa, cui sono attribuite invenzioni scientifiche (come già accaduto per Talete), ma anche previsioni e interessi
politici. Per quanto ci riguarda da vicino, le concezioni di Anassimandro sono così riassunte
dal grande commentatore della Fisica aristotelica Simplicio (VI secolo d.C.), che ancora poteva disporre di evidenze testuali (probabilmente sulla scorta dell'allievo di Aristotele Teofrasto) 5 :
Tra quelli che pongono un unico principio mobile e illimitato, Anassimandro di Mileto, figlio di Prassiade, successore e discepolo di Talete, affermava che principio e elemento primordiale delle cose è l'illimitato [apeiron], introducendo per primo il termine di principio. E diceva che esso non era né l'acqua né un
altro dei cosiddetti elementi, ma un'altra natura infinita da cui provengono tutti quanti i cieli e i cosmi che
sono in essi. “E donde viene agli esseri la nascita, là avviene anche la loro dissoluzione secondo necessità; poiché si pagano l'un l'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo”, così
si esprime Anassimandro nel suo linguaggio poetico. Evidentemente Anassimandro, avendo osservato la
trasformazione dei quattro elementi l'uno nell'altro, non volle porre uno di essi come sostrato, ma qualcos’altro oltre questi. Secondo Anassimandro dunque la generazione non avviene per una trasformazione
del principio primordiale, ma per la separazione dei contrari ad opera dell'eterno movimento. [DK12A9]
Il brano denuncia in modo palese la propria stratificazione: muove dallo
schema interpretativo aristotelico, inserisce a conferma una probabile citazione testuale, quindi procede a giustificarne nel dettaglio le tesi con
l'intervento del commentatore.
Anassimandro avrebbe dunque contribuito al sorgere di un linguaggio tecnico della filosofia della natura, introducendo il termine arché, nell'accezione prima riscontrata. Ma l'aspetto originale e per certi versi rivoluzionario del Milesio, attraverso cui egli è assimilato, con qualche imbarazzo, nel quadro fisico di Aristotele, è quello relativo all'individuazione di tale principio: non era né l'acqua né un altro dei cosiddetti elementi [acqua, terra, aria, fuoco, nella lezione aristotelica], ma un'altra natura infinita.
L'apeiron (illimitato, infinito, indeterminato: letteralmente privo di
limiti, qualitativi e quantitativi) si impone sulla scena filosofica, marcando subito lo scarto rispetto all'orizzonte degli altri pensatori. Certamente, come nel caso di Talete, è possibile rintracciare l'eco della tradizione (il caos, a proposito del quale il poeta Esiodo, nella Teogonia, aveva
sostenuto: fu primo) o l'influenza orientale; tuttavia, più ancora che nel
caso precedente, è facile rilevare il salto qualitativo operato dal filosofo.
Anassimandro manifesta lo stesso atteggiamento logico che è stato possibile riconoscere nella presunta tesi taletiana: la ricerca del principio
comporta
la
riduzione
della
complessità
e
la
sua
comprensione
nell’omogeneità unificante di un fondamento. Nello stesso tempo, come suggerisce anche Simplicio, egli, a differenza del predecessore e dei posteriori seguaci, non si ferma, nell'individuazione, a uno degli elementi, comunemente ritenuti fondamentali nella tradizione. Anassimandro intende rimarcare la differenza tra ciò che deve (da un punto di vista ontologico e
logico, in altri termini, della realtà e del pensiero razionale) fungere da
arché e ciò che, sottoposto ai processi del divenire, non può che essere
principiato. In questo senso l'apeiron è, per sua natura, altro da tutto
ciò che cade sotto la nostra esperienza quotidiana, la sua illimitatezza
sottintende, dunque, anche una maggiore consistenza ontologica, rispetto
alle cose che passano.
D'altra parte i caratteri impliciti nella nozione di apeiron non sono
percepibili dai sensi, ma solo concepiti razionalmente: il principio non è
dato empirico, ma risultato di un'analisi radiografica dell'esperienza; ha
5)
Cito da I Presocratici. Frammenti e testimonianze, a cura di A. Pasquinelli, Einaudi, Torino, 1958. Sottolineature mie.
11
una visibilità esclusivamente intellettuale che è effetto di una riflessione argomentata sul divenire. Decisiva per quest’aspetto la testimonianza
aristotelica della Fisica:
E ben a ragione tutti considerano l'infinito come principio, poiché non è possibile né che esso esista invano, né che ad esso convenga un'altra potenza che quella di principio. Tutto, infatti, o è un principio o deriva da un principio: ma dell'infinito non vi è principio, perché altrimenti avrebbe un limite. Ed è anche
ingenerato e incorruttibile, allo stesso modo di un principio, poiché ciò che è generato ha necessariamente
anche una fine, ed ogni corruzione ha il suo termine. Per questo dicevamo che dell'infinito non vi è principio, ma che esso sembra essere il principio d’ogni altra cosa e comprendere in sé tutte le cose, e a tutte
le cose essere guida, come dicono quanti non ammettono altre cause, come la mente o l'amore, all'infuori
dell'infinito. E tale principio sembra essere il divino; ed è infatti immortale e imperituro, come dicono
Anassimandro e la maggior parte dei filosofi della natura. [...] [DK 12A15].
ESERCIZIO
• Riprodurre i passaggi essenziali dell’argomento.
• Individuare i presupposti logici per cui l’”infinito” è considerato “ben a ragione” principio.
• Sottolineare i caratteri peculiari del principio che emergono dal testo.
Gli specialisti ritengono che l'argomento possa essere ritagliato sulle
deduzioni originarie di Anassimandro, come rivelerebbero in particolare
l'attacco e la conclusione (che sembrano appoggiarsi a una lettura diretta). Si paleserebbe in tal caso un interessante motivo logico nella scelta
dell'apeiron come arché: l'infinito non può che essere principio, pena la
contraddizione. Analogamente, in quanto apeiron, non può che essere ingenerato e incorruttibile, assumendo quindi tratti d’eternità in palese tensione
con la temporalità dell'esperienza. A una diversa collocazione funzionale
osta, logicamente, la sua natura illimitata. Nell'alternativa proposta (o
principio o principiato) il ruolo logico e ontologico è dunque trasparente:
solo l'apeiron non ammette il rinvio a altra fondazione. Non ci sono, quindi, semplici considerazioni d'ordine fisico, quali emergono nella testimonianza di Simplicio, non è poi così rilevante il condizionamento del mito,
se è possibile introdurre ragioni squisitamente razionali a convincere della bontà della scelta anassimandrea.
Ma la collazione delle due testimonianze è efficace anche per evidenziarne i limiti d'analisi. Infatti, quando si passa a focalizzare come l'apeiron funga da principio, si riconosce che esso sembra [...] abbracciare tutte le cose e tutte le cose governare: in quest'azione di sostegno e orientamento (attribuita al principio anche da altri autori arcaici), in cui
l'infinito entra in gioco tanto nella sua dimensione spaziale, quanto in
quella della potenza, garanzia di stabilità e conservazione contro la minaccia del nulla, si manifesta l'irriducibilità dell'apeiron a pura causa
materiale in senso aristotelico. Del resto, le ultime righe del brano della
Fisica citato, con l'accostamento al divino, letteralmente senza morte e
senza distruzione, confermano alla physis apeiron una forza vitale e formatrice che va al di là della mera sostanzialità materiale.
Veniamo ora all’interpretazione del presunto frammento tramandatoci da
Simplicio:
E donde viene agli esseri la nascita, là avviene anche la loro dissoluzione secondo necessità; poiché si
pagano l'un l'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo.
Nella prima parte noi troviamo la contrapposizione tra gli esseri, gli
enti (ta onta), letteralmente le cose che sono, e (sempre a livello letterale) le cose da cui quelle hanno origine e in cui si corrompono secondo
necessità. Se consideriamo la conclusione della testimonianza, basata sulle
Opinioni dei fisici di Teofrasto, che parla della separazione dei contrari,
dovremmo ritenere che il donde del frammento si riferisca alle contrarietà
fisiche fondamentali, poi fissate da Aristotele in caldo-freddo, seccoumido, dalla cui combinazione scaturiscono i quattro elementi, alla base
del mondo naturale. Lo schema polare, per opposizione, era d’altro canto
caratteristico dei modelli mitici, greci e orientali: ciò che in questo ca-
12
so conta maggiormente rimarcare è il rigore con cui Anassimandro lo impone
nel proprio orizzonte, come destino che grava sugli enti e ne ritma la processione. La seconda parte del frammento esalta appunto quest'aspetto.
Al centro ritroviamo, infatti, il tema dell'ordine (taxis) che pervade le
cose che sono, che ne scandisce l'inesauribile sovrapposizione nel processo
del divenire. Anassimandro percepisce l'effetto dello scontro delle contrarietà fondamentali negli enti, il loro reciproco determinarsi e limitarsi
(si osservi nuovamente la differenza rispetto alla natura dell'apeiron) in
termini fortemente antropomorfici: ingiustizia, espiazione, pena. Proietta
così nell'universo il linguaggio umano della città, e con esso l'idea della
stretta correlazione e sequenza dei momenti dell'infrazione e della sua
compensazione, nella processualità temporale. L'esperienza apparentemente
caotica del divenire è quindi riletta attraverso il modulo della dialettica
polare (della tensione e correlazione reciproca dei contrari), che assoggetta gli enti al giogo del tempo. Anche in questo caso, allora, la trascendenza attribuita, con la documentata espressione non invecchia mai, all'infinito, intende proprio rimarcare lo scarto ontologico tra il principio
e le cose che ne derivano.
La testimonianza di Simplicio ci aiuta, inoltre, a definire il nesso cosmogonico (da cui si genera l'ordine, il kosmos) tra apeiron e contrari.
All'illimitata potenza (divina) del principio era probabilmente attribuito
un eterno movimento intrinseco, cui era da imputare il distacco, pur sempre
all'interno del seno infinito del fondamento (che abbraccia e guida tutte
le cose), delle contrarietà, le quali, nella reciproca interazione, avrebbero poi determinato gli equilibri dei singoli mondi. L'uso del plurale è
indicativo perché nell'infinito, in conseguenza di un moto eterno, si dà la
possibilità d’innumerevoli kosmoi, anche se non sono chiari i contorni della proposta di Anassimandro.
Poche parole, infine, sull'ultimo rappresentante di questa supposta “scuola di Mileto”, Anassimene, giovane contemporaneo di Anassimandro, di cui, ovviamente per la tradizione
dossografica, sarebbe stato discepolo. Egli avrebbe operato una conversione, dalle impegnative e temerarie aperture del maestro a un quadro più lineare e prossimo all'esperienza e alle
sue analogie. Abbiamo un probabile frammento, pervenutoci attraverso un repertorio del I-II
secolo d.C., basato sulle Opinioni dei fisici di Teofrasto:
Anassimene di Mileto, figlio di Euristrato, afferma che l'aria è il principio delle cose: da essa infatti tutto
proviene e di nuovo in essa tutto si dissolve:
come la nostra anima, che è aria, ci sostiene e ci governa, così il soffio e l'aria abbraccia il mondo intero
(soffio e aria sono usati come sinonimi) [...]. [DK 13B2].
Principio di tutte le cose sarebbe dunque stata l'aria, elemento sufficientemente flessibile per giustificare le più diverse manifestazioni, garantito dalla stessa sapienza mitologica greca e orientale, tradizionalmente associato alla vita e all'animazione, e, soprattutto, condizione di una
più semplice deduzione cosmogonica. L'aria di Anassimene avrebbe in ogni
caso mantenuto l'infinità propria del principio di Anassimandro, e, a suo
modo, la sua impercettibilità, fenomenizzandosi solo a seguito di processi
di condensazione e rarefazione, effetto del suo intrinseco moto originario.
Si confermava, dunque, il modulo della polarità delle contrarietà fondamentali, sullo sfondo di una physis i cui tratti materiali sfumavano nel rilievo della sua potenza animatrice.
3. Pitagora e il pitagorismo antico
Uno dei problemi più complessi per la storiografia filosofica è quello rappresentato dalla
figura di Pitagora (VI secolo) e dalla scuola (il termine in questo caso sembra giustificato) che
a lui si richiamò, dando vita a una tradizione secolare destinata poi a confluire, in parte, nel
platonismo. Problema che evidentemente già imbarazzava Aristotele, il quale, per lo più esplicito nelle attribuzioni, si riferiva a quella scuola con l’espressione i cosiddetti pitagorici,
13
rivelando così incertezze di documentazione specifica. D’altronde Pitagora, pur essendo personaggio certamente storico (lo confermano le testimonianze quasi coeve di Eraclito, Senofane e Empedocle), era circonfuso in un’aura leggendaria, probabilmente costruita sapientemente dalla scuola sin dalla fondazione. Era, dunque, estremamente difficile discernere le opinioni
del fondatore da quelle elaborate posteriormente dai discepoli, all’interno di una struttura gerarchicamente organizzata e gelosamente gestita, di cui era proverbiale la consegna della segretezza. Inoltre, a infastidire ulteriormente la ricostruzione aristotelica, c’era il compasso
d’interessi e valenze della riflessione pitagorica, solo a fatica inquadrabile nello schema del
primo libro della Metafisica, con l’eco sensibile del misticismo delle sette orfiche e le possibili incidenze orientali a complicare ancor più la scena. Non che questi elementi fossero mancati negli altri autori: anche di passaggio abbiamo segnalato l’eventualità di aperture in direzione del mito e della tradizione religiosa. Tuttavia, nel caso in questione, è indiscutibile e strutturale l’ambigua simbiosi di scientismo e esoterismo.
Pitagora, originario di Samo, isola prossima alle coste della Ionia, avrebbe partecipato al
grande fenomeno migratorio che spinse i suoi compatrioti nella nuova area di colonizzazione
greca dell’Italia meridionale (Magna Grecia), a seguito di problemi politici interni e della difficile convivenza con la potenza persiana. In particolare, si racconta di suoi viaggi e contatti
nel Vicino e Medio Oriente, di un soggiorno in Egitto, che avrebbero poi pesantemente inciso
nella definizione del suo insegnamento. Infine egli sarebbe giunto a Crotone, istituendo una
scuola dai tratti piuttosto originali: confraternita religiosa, centro di studi scientifici, riferimento d’iniziativa politica. Il successo della sua lezione avrebbe quindi segnato l’inizio della
diffusione di “appendici” in altre città, sia, in un primo tempo, nell’area italica, sia, più tardi,
nella madrepatria greca. Un successo difficile da spiegare, dato il carattere molto esclusivo
della scuola: per accedervi era previsto una sorta di tirocinio per provare le qualità degli aspiranti; i candidati ammessi alle attività didattiche erano poi suddivisi in acusmatici e matematici, in altre parole, meri uditori e veri scolari-ricercatori, destinati a partecipare degli insegnamenti più riposti, e a contribuire, a loro volta, all’indagine scientifica. Con un duplice impegno:
•la venerazione della figura del capo fondatore, cui erano riconosciute capacità taumaturgiche e origini semidivine,
•l’attribuzione alla sua lezione di conquiste teoriche posteriori.
Ovviamente, con queste premesse, tenendo conto della lunga tradizione della scuola, è tentativo disperato risalire alle dottrine pitagoriche originarie. D’altra parte sono molto scarsi i
frammenti genuini riferibili a membri della confraternita (in ogni caso già di una generazione,
almeno, posteriore al caposcuola), e poco numerose anche le testimonianze antiche. Dal confronto tra queste fonti è stato in ogni modo possibile concludere che Pitagora insegnò:
i) una nuova concezione dell’anima umana, considerata immortale, quindi divina, capace
d’incarnarsi in altre forme viventi (trasmigrazione delle anime), e, probabilmente in relazione
a essa,
ii) la pratica d’alcuni tabù superstiziosi;
che, d’altra parte,
iii) gli si devono imputare anche interessi scientifici, in particolare la dottrina dell’armonia
delle sfere, nei suoi riflessi musicali, astronomici, filosofici e etico-religiosi, come risulta anche dai cenni dossografici di Porfirio (III secolo d.C.):
Riguardo alle dottrine di Pitagora i più dicono che le scienze cosiddette matematiche le ha imparate dagli
Egiziani, dai Caldei e dai Fenici. Gli Egiziani infatti si sono occupati fin dai tempi più antichi di geometria, i Fenici dei numeri e dei calcoli, i Caldei delle ricerche celesti. Le cerimonie sacre e tutto ciò che riguarda le pratiche di vita dicono l’abbia imparato e preso dai Magi. E che queste cose siano note a un
14
numero assai grande di persone perché le ha scritte, mentre gli altri precetti di vita sono meno noti [...].
[DK 14A9].
I primi due punti furono sicuramente i più popolari nell’antichità, quelli intorno a cui fiorirono le leggende riguardanti il fondatore e la scuola. Erodoto (V secolo a.C.) [DK 14A1] e
Diogene Laerzio [DK 14A3] collegano, direttamente o indirettamente, la lezione pitagorica
sul destino dell’anima, e la connessa ritualità, alla sapienza religiosa egiziana, ai culti orfici e
ai contatti con figure taumaturgiche come Ferecide di Siro o Epimenide, a loro volta legati alla tradizione mediorientale 6 :
Anche questa dottrina (immortalità e trasmigrazione delle anime) l’hanno trovata per primi gli Egiziani, i
quali sostenevano che l’anima dell’uomo è immortale e che quando il corpo si corrompe essa entra in un
altro animale che sta nascendo in quel momento e dopo aver percorso tutti gli esseri della terra, del mare
e dell’aria rientra di nuovo nel corpo di un uomo che nasce; tale ciclo si compirebbe in 3000 anni. Vi sono dei Greci che, chi prima chi dopo, si sono serviti di questa dottrina come se ne fossero loro gli autori:
ne conosco i nomi ma non li scrivo. [...] Tuttavia gli Egiziani non portano vesti di lana nei templi, né si
fanno seppellire con esse perché non è lecito secondo le norme della loro religione. In questo concordano
con i riti cosiddetti Orfici e Bacchici, che in realtà vengono dall’Egitto, e con quelli Pitagorici. Infatti a
chi partecipa a questi riti misterici non è lecito farsi seppellire con vesti di lana. E vi è intorno a queste
cose un discorso sacro [DK 14A1].
Il dato per noi più indicativo, alla luce delle influenze posteriori, è quello riguardante i rapporti con l’orfismo.
Il termine designa il movimento religioso, ispirato a un’altra figura leggendaria, quella del
poeta tracio Orfeo, che dovrebbe risalire almeno al VI secolo a.C., anche se le testimonianze
dirette (laminette e terracotte funerarie) sono posteriori e la produzione poetica, improntata a
quelle credenze, solo tardo-ellenistica. L’orfismo, a sua volta, si riallacciava poi, riformandolo dall’interno in senso ascetico, all’orgiasmo tipico delle sette dedite al culto di Dioniso.
Centrale doveva quindi risultare il mito dello sbranamento di Dioniso-Zagreus da parte dei
Titani, dalle cui ceneri avrebbe poi visto la luce il genere umano, portando in sé, nell’oscura
malignità propria dell’involucro corporeo (i Titani erano forze telluriche) un brano di luce divina, immortale (daimon). Il riscatto di quel frammento doveva avvenire, secondo gli orfici,
attraverso una vita ascetica, con cui scontare quella colpa originaria in una serie di successive
reincarnazioni, fino alla piena espiazione, e alla conseguente liberazione dal ciclo. Il peso di
questa prospettiva escatologica sulla storia del pensiero filosofico potrebbe essere stata enorme, sia per l’accento posto sui destini dell’individuo umano, sia per il modello ciclico imposto alla vita dell’universo: presenze orfiche sono state riscontrate nel richiamo taletiano
all’animazione, nel riferimento anassimandreo a tempo e necessità (due grandi divinità orfiche), per non dire d’autori successivi come Eraclito, Parmenide e Empedocle. Purtroppo, i
contorni storici del movimento non possono essere precisati e è quindi difficile stabilire quanto abbia inciso o piuttosto ereditato da quelle lezioni filosofiche.
Nel caso del pitagorismo, per esempio, ci sono specialisti che sostengono la tesi
dell’influenza di Pitagora sull’orfismo, anche se per lo più prevale l’opinione che la scuola
abbia operato un’ulteriore riforma della precedente tradizione orfico-dionisiaca. In particolare, essa avrebbe saldato l’ascesi all’indagine naturalistica, ritenendole entrambe sicure vie di
purificazione per l’anima. È probabile che in origine Pitagora avesse proposto una concezione
apparentemente magica dell’universale simpatia e corrispondenza (alla base, vedremo, delle
stesse considerazioni matematiche), entro cui s’integrava e giustificava il ricorso alla trasmigrazione delle anime in diverse forme viventi. Ma la vera novità pitagorica rispetto
all’orfismo, forse già introdotta dal fondatore, è la convinzione che la salvezza per l’uomo
6)
Ibidem.
15
passi attraverso una vita dedicata alla filosofia (termine, si dice, utilizzato per la prima volta
proprio all’interno della scuola), una vita pitagorica (bios pythagorikos).
Sui contenuti di tale speculazione Aristotele, nel quinto capitolo del primo libro della Metafisica, ci informa come segue:
Contemporanei a questi filosofi, ed anche anteriori a questi, sono i cosiddetti Pitagorici. Essi per primi si
applicarono alle matematiche e le fecero progredire, e, nutriti delle medesime, credettero che i principi di
queste fossero principi di tutti gli esseri. E poiché nelle matematiche i numeri sono per loro natura i principi primi, appunto nei numeri essi ritenevano di vedere, più che nel fuoco, nella terra e nell’acqua, molte
somiglianze con le cose che sono e che si generano: per esempio ritenevano che una data proprietà dei
numeri fosse la giustizia, un’altra, invece, l’anima e l’intelletto, un’altra ancora il momento e il punto giusto, e similmente, in breve, per ciascuna delle altre; e inoltre, poiché vedevano che le note e gli accordi
musicali consistevano nei numeri; e, infine, poiché tutte le altre cose, in tutta la realtà, parevano a loro
che fossero fatte a immagine dei numeri e che i numeri fossero ciò che è primo in tutta quanta la realtà,
pensarono che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose, e che tutto quanto il cielo fosse
armonia e numero. E tutte le concordanze che riuscivano a mostrare fra i numeri e gli accordi musicali e i
fenomeni e le parti del cielo e l’intero ordinamento dell’universo, essi le raccoglievano e le sistemavano.
E se qualche cosa mancava, essi si ingegnavano a introdurla, in modo da rendere la loro trattazione in tutto coerente. Per esempio: siccome il numero dieci sembra essere perfetto e sembra comprendere in sé tutta la realtà dei numeri, essi affermavano che anche i corpi che si muovono nel cielo dovevano essere dieci; ma, dal momento che se ne vedono soltanto nove, allora essi ne introducevano di conseguenza un decimo: l’Antiterra.
Abbiamo trattato questi argomenti in altre opere con maggior accuratezza. Qui vi ritorniamo sopra, al fine
di vedere, anche presso questi filosofi, quali sono i principi che essi pongono, e in quale modo questi
rientrino nell’ambito delle cause di cui abbiamo detto. Anche costoro sembrano ritenere che il numero sia
principio non solo come costitutivo materiale degli esseri, ma anche come costitutivo delle proprietà e
degli stati dei medesimi. Essi pongono, poi, come elementi costitutivi del numero il pari e il dispari; di
questi, il primo è illimitato, il secondo limitato. L’Uno deriva da entrambi questi elementi, perché è, insieme, e pari e dispari. Dall’Uno, poi, procede il numero; e i numeri, come s’è detto, costituirebbero tutto
quanto l’universo.
Altri Pitagorici affermarono che i principi sono dieci, distinti in serie di contrari:
1) limite - illimite
2) dispari - pari
3) uno - molteplice
4) destro - sinistro
5) maschio - femmina
6) fermo - mosso
7) retto - curvo
8) luce - tenebra
9) buono - cattivo
10) quadrato - rettangolo.
ESERCIZIO
• Individuate i passaggi logici addotti da Aristotele per motivare la scelta pitagorica dei “numeri” come
“principi”.
Evidentemente, in questo contesto, nel tentativo di ricostruzione filosofica, esplicitamente inteso a rispettare il proprio schema eziologico, Aristotele si concentra soltanto sugli aspetti teoretici, trascurando la dimensione etico-religiosa dell’insegnamento pitagorico. La sua testimonianza, pur consapevolmente sfocata, risulta preziosa da diversi punti di vista.
Intanto, ci consente di cogliere il possibile nucleo originario della riflessione del caposcuola: lo studio dell’armonica, con la definizione matematica degli intervalli musicali, e l’adozione, per analogia, dello stesso
metodo di riduzione matematica a altri fenomeni, come quelli astrali. Il
fatto che un fenomeno fisico fosse analizzabile, e così decifrabile, attraverso numeri, rappresentati da punti estesi (aritmogeometria) e quindi da
16
considerare sorta di atomi fisici, fece probabilmente maturare la convinzione che ciò che risultava condizione d’intelligibilità dovesse essere anche principio a livello ontologico (della realtà). I numeri, insomma, non
solo improntavano certe manifestazioni (i suoni, i movimenti degli astri),
e erano applicabili, come chiavi di lettura, all’intera realtà, ma la
strutturavano concretamente (tutte le altre cose, in tutta la realtà, pareva a loro che fossero fatte a immagine dei numeri).
A questi primi dovette seguire un ulteriore passaggio, come logicamente
si può ancora arguire dalla testimonianza: i numeri (e con essi tutti gli
enti) furono, a loro volta, ridotti a principi irriducibili, il limite e
l’illimitato. La diversa qualità dei numeri, pari e dispari, probabilmente
suggerì la riduzione, che palesa ancora la logica arcaica, già in precedenza riscontrata, per cui il molteplice si fa comprensibile nell’unificazione e nell’articolazione polare. Lavorando sulle analogie matematiche, sfruttando implausibili risvolti qualitativi e assiologici (di valore), deducibili dalla dicotomia limite-illimitato (la lista di contrarietà
riportata da Aristotele), la scuola riuscì a omogeneizzare, nel numero e
nei suoi principi ultimi, l’intero universo fisico e morale, svelandone costantemente latenti correlazioni.
Inoltre l’indicazione aristotelica è rilevante perché ci fa intravedere
il procedimento scientifico pitagorico, misto d’osservazione, elaborazione
analogica e vera e propria riflessione razionale, dove la componente astratta, a priori, era rigorosamente vincolata a esigenze d’armonia,
d’equilibrio, funzionali alla prospettiva escatologica. L’universo era, infatti, oggetto di contemplazione e di riscontri perché letto, in primo luogo, come kosmos, ordine e bellezza; esso palesava una struttura divina,
nella sua compiutezza e regolarità. La contemplazione (theoria) dell’ordine
(nel macrocosmo) comportava la sua interiorizzazione, quindi una cura, una
terapia per i mali dell’anima (microcosmo): probabilmente l’impegno politico
rappresentava
l’espressione
di
quel
theorein
(incarnata
anche
dall’istituzione scolastica), nella società, il compito dell’attuazione
dell’ordine all’interno della polis.
4. Eraclito
Eraclito rappresenta uno dei grandi “bagliori” del pensiero greco, e, per molti versi, un
nuovo inizio della filosofia. Originario di Efeso, sulle coste dell’Asia Minore, non lontana da
Mileto, di famiglia aristocratica, visse tra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del
V, in uno dei periodi più tumultuosi della storia politica della regione, tra la conquista persiana e la riconquista greca, mantenendo un atteggiamento di fiero distacco polemico nei confronti del regime democratico della propria città e dei propri concittadini, che gli valse
un’insolita sottolineatura da parte di Diogene Laerzio [DK 22A1]: Era di animo disdegnoso e
superbo, quant’altri mai. La tradizione gli attribuisce un’opera scritta, di cui conserviamo
all’incirca 127 frammenti, di varia ma comunque modesta consistenza e difficilmente assemblabili, tanto che da parte di qualche studioso è stata avanzata l’ipotesi che non si tratti di brani di un testo eracliteo, piuttosto di una raccolta di sue sentenze sparse, redatta da qualche discepolo o ammiratore.
D’altra parte, se i frammenti risalgono effettivamente all’Efesio, si pone la questione del
loro stile ambiguo, enigmatico già per gli antichi, tanto da meritare all’autore l’epiteto di oscuro. È possibile, al limite, attribuire a Eraclito una forma aforistica, per brevi flash, illuminazioni compiute, ritagliata su un modello, quello della divinazione apollinea, che lo stesso
autore richiamerebbe esplicitamente, coniugandolo con un altro archetipo classico della tradizione religiosa, l’enigma. Certamente alcuni frammenti fanno pensare 7 :
La sibilla dalla bocca delirante dice cose di cui non si ride, non addolcite né da ornamenti né da profumi
[DK 22B92].
7)
Ibidem.
17
Il signore che ha l’oracolo in Delfi non dice e non nasconde, ma accenna [DK 22B93].
Son tratti in inganno gli uomini nella conoscenza delle cose visibili, simili in questo a Omero, che pure fu
il più sapiente degli Elleni. Anche lui infatti trassero in inganno dei bambini che schiacciavano i pidocchi
dicendogli: tutto quel che abbiamo visto e preso lo lasciamo, tutto quello che non abbiamo visto né preso
lo portiamo con noi [DK 22B56].
Il fatto poi che Eraclito coinvolga certi prototipi sapienziali, con la loro ambiguità e ricchezza di sfumature, potrebbe da un lato strutturalmente riferirsi ai contenuti del suo messaggio filosofico, dall’altro costituire aristocratica provocazione nei confronti dei molti, per coinvolgere l’eventuale lettore in una sfida ermeneutica (interpretativa) analoga a quella mortale
della Sfinge, nel mito di Edipo, garantendo così il proprio discorso razionale in una cornice
sacrale.
Si è detto inizialmente che l’Efesio rappresenta un nuovo inizio per la filosofia occidentale: sia nel senso che per noi è possibile trascorrerne i frammenti e ricavarne una lezione, ricorrendo solo parzialmente alle testimonianze indirette, sia nel senso, più sottile, che, attraverso
quella, si delinea un abbozzo di riflessione sullo statuto del sapere avanzato dai primi filosofi
ionici - centrale anche nei versi del poema di Parmenide -, intesa più a enucleare una struttura
che a individuare principi. Inoltre, rispetto al naturalismo ascritto, da Platone e Aristotele, a
Talete e Anassimandro, è dato rinvenire in Eraclito un orientamento sicuramente più complesso, cui non è estranea anche una probabile allusione alla propria interiorità:
Ho indagato me stesso [DK 22B101].
4.1 Il logos
Il presunto libro del filosofo di Efeso si doveva aprire, secondo una costumanza riscontrabile nei testi del periodo, con un richiamo alla novità del proprio contributo:
Questa mia dottrina [logos], benché verità eterna, gli uomini non la intendono mai, né prima di udirla né
dopo averla udita; e sebbene tutto avvenga secondo tale dottrina [logos], che è la legge del mondo, ne
sembrano inesperti quando si provano in parole e in azioni come quelle che io spiego, scomponendo ciascuna cosa secondo la sua intima natura e dicendo come è. Ma gli altri uomini sono ignari di ciò che fanno da svegli, così come non sanno ciò che fanno dormendo [DK 22B1].
La traduzione di Pasquinelli fa miracoli per conservare tutta l’ambiguità
e polivocità del greco di queste righe. In primo luogo, infatti, come già
risulta dalla Retorica aristotelica, l’apertura lascia impregiudicata
l’attribuzione dell’avverbio sempre, tra logos e anthropoi (uomini): è il
discorso-verità che è sempre, oppure sono gli uomini che sempre non [lo]
intendono? La soluzione, in questo caso, è quella di mantenerle entrambe,
sfruttando in tal modo al massimo lo spettro semantico dell’affermazione.
In secondo luogo c’è il fondamentale problema del significato di logos.
All’epoca esso aveva già un ampio ventaglio d’accezioni:
1. discorso,
2. valore,
3. argomento,
4. misura,
5. proporzione,
6. pensiero.
Nel frammento esso riveste sicuramente la prima accezione, si riferisce
all’espressione di Eraclito, eventualmente, al suo libro, ma nello stesso
tempo al suo contenuto, alla verità che essi palesano (altrimenti risulterebbe privo di senso il riferimento all’udire), la quale, a sua volta, riflette un ordine oggettivo, riscontrabile nella physis d’ogni ente. Per
questo il logos è anche struttura, proporzione, legge, universale e eterna,
cui si contrappongono le cose che invece avvengono. Eraclito ha con tale
concetto formalizzato le assunzioni ioniche sulla stabilità e indefettibilità della physis-arché, e sul processo cosmogonico (letteralmente di for-
18
mazione dell’ordine) innescato dalla sua intrinseca vitalità, avvicinandosi
alla coeva lezione pitagorica sul kosmos e sull’armonia. L’intera realtà
risulta abbracciata nell’unità (polivoca) del logos, che se, vedremo, non è
riducibile a legge astratta, è in ogni caso la struttura pervadente che dà
senso al tutto.
Un altro aspetto risalta, inoltre, in apertura: l’isolamento epistemico,
scientifico, del filosofo rispetto alle opinioni condivise tra gli altri
uomini. Anche in questo caso si rivela una tensione polare. Da un lato il
consapevole discorso del filosofo, che rivela un logos totalizzante,
dall’altro la loro incomprensione, tanto più grave in quanto anche gli altri uomini si muovono nell’ambito di quella legge universale e eterna. In
questo senso Eraclito utilizza l’accostamento ai dormienti, che ritorna anche in altri frammenti famosi:
Non capiscono, anche se ascoltano, simili ai sordi; di loro testimonia il proverbio: son presenti, ma assenti [DK 22B34].
Non bisogna agire e parlare come nel sonno [DK 22B73].
Discordano dalla verità, dalla legge del mondo ad essi in ogni momento presente, e le cose in cui si imbattono ogni giorno sembran loro estranee [DK 22B72].
I desti hanno un unico mondo comune [DK 22B89].
L’autore intende così esaltare l’aderenza al logos come adesione a ciò
che è comune e quindi sensato, contrapposta all’ottusità dell’esperienza
quotidiana vissuta inconsapevolmente, che ci convince falsamente di un mondo frammentario, discontinuo, caotico (il tema dell’estraneità). Una dicotomia che implica uno scarto gnoseologico (conoscitivo), segnalato per primo proprio da Eraclito:
Comune è il retto pensiero [DK 22B113].
Coloro che vogliono parlare con intendimento devono fondarsi su ciò che a tutti è comune, come la città
sulla legge e con maggior forza ancora. E invero tutte le leggi umane si alimentano dell’unica legge divina, poiché quella impone quanto vuole e basta per tutte le cose e avanza [DK 22B114].
Quindi si deve seguire ciò che è comune. Ma benché comune sia questa verità che io insegno, i molti vivono come se avessero un proprio pensiero per loro [DK 22B2].
Il retto pensiero è la massima virtù e la sapienza è dire e fare cose vere ascoltando e seguendo l’intima
natura delle cose [DK 22B112].
ESERCIZIO
Alla luce dei frammenti e dei commenti precedenti, argomentate una soluzione ai seguenti problemi sollevati dal testo:
• Perché il “retto pensiero” è detto “comune”?
• Perché il “retto pensiero” è la massima virtù”?
Così come nel primo frammento si rimarcava la portata universale del
logoß, qui si constata la comunanza del retto pensiero (phronesis), fondato
evidentemente su quell’universalità: anzi, è introdotto un aspetto normativo che rafforza l’interpretazione del logos come legge che dà significato
alla realtà, e nuovo valore (rispetto alla tradizione epica) allo stesso
agire e discorrere umani. Il pensare, l’intendere (noein) qualificano il
logos del filosofo, il quale è portavoce di un discorso che svela una
struttura ontologica, in teoria disponibile a tutti, investendo tutta la
realtà, di fatto suo esclusivo appannaggio a causa della miopia e ottusità
degli altri uomini. Essi non sanno né ascoltare né parlare, non capiscono,
anche se ascoltano. Per Eraclito:
Occhi e orecchi son per gli uomini cattivi testimoni, se hanno anime da barbari [DK 22B107].
Il dato immediato d’esperienza non aiuta a cogliere l’intima natura delle
cose:
L’intima natura delle cose ama nascondersi [DK 22B123].
19
Essa si palesa solo nella misura in cui quel dato venga trasceso, meditato razionalmente (il riferimento all’anima). La sintonia con la radice profonda della realtà, sulla cui base dire e far cose vere, non si raggiunge
nel contatto sensoriale con la natura stessa, ma attraverso la radiografia
logica dei suoi fenomeni, che consente di tracciarne la struttura. Chi, invece, si affida all'incerto impatto empirico non può che produrre discorsi
senza senso, balbettanti (il riferimento ai barbari).
4.2 La struttura del logos
Ma qual è in concreto il contenuto del logos di Eraclito, o, se vogliamo, qual è questa legge-struttura che racchiude tutta la realtà, costituendone la physis? Qui emerge il nesso intestino con la riflessione ionica, l’esercizio di formalizzazione della logica intrinseca alla scienza
della natura dei Milesii:
Si deve sapere che la guerra è comune, e che la giustizia è contesa, e che tutto avviene secondo contesa e necessità [DK 22B80].
Polemos (la guerra) di tutte le cose è padre e di tutte il re, e gli uni rivela dei, gli altri uomini, gli uni fa
schiavi, gli altri liberi [DK 22B53].
Anche la mistura di vino e formaggio si scompone se non si agita [DK 22B125].
Il divenire, il passare degli enti, già problematizzato alla radice da
Anassimandro, è colto (con probabile rinvio proprio al frammento tramandato
da Teofrasto) antropomorficamente come conflitto polare, duello costante,
tensione che incatena tutto, cui nulla sfugge, donde la necessità. Come il
ciceone, la bevanda cui il filosofo accenna, impiegata nell’iniziazione alle cerimonie eleusine (e quindi legata alla tradizione sacra del tempio cara a Eraclito), si dissolve se le sue componenti non sono continuamente rimescolate, così la realtà non sarebbe, senza l’eterno polemos che la domina, dicotomizzandone le sorti.
Se quindi la guerra, come il logos, è comune, essa tuttavia non ha un effetto globalmente annichilente, in quanto sottesa dall’equilibrio o dalla
ciclicità:
L’opposto in accordo e dai discordi bellissima armonia [DK 22B8].
Non capiscono come con se stesso concordi pur discordando: armonia di tensioni contrastanti come
nell’arco e nella lira [DK22B51].
La stessa cosa è il vivente e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio: questi infatti trasformandosi son quelli, e quelli a loro volta, trasformandosi, son questi [DK 22B88].
Congiungimenti: intero e non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l’uno e
dall’uno tutte le cose [DK 22B10].
In questi frammenti Eraclito sembra alludere a una duplice forma di polarità: una interna ai singoli enti (o specie), che ne determina il ciclo,
l’altra
che
investe
il
loro
reciproco
ordinamento,
improntandolo
all’equilibrio (armonia). Il risultato è, in ogni caso, inequivocabilmente
convergente con quello della filosofia dei Milesii: la molteplicità e il
suo apparente caos si fanno trasparenti nel riferimento all’uno. Lo stesso
modello polare salda, nella mutua correlazione, tutte le cose:
Non ascoltando me, ma la parola della verità [logos] è saggio riconoscere che tutto è uno [DK 22B50].
ESERCIZIO
• Tenendo conto dei precedenti, abbozzate una interpretazione del frammento, che spesso è stato
sfruttato come emblematico della posizione eraclitea.
L’universalità del logos trova riscontro nell’unicità di struttura latente, profonda, invisibile (L’armonia invisibile val più della visibile), che
Eraclito rinviene negli aspetti più diversi della realtà, da quelli fisici
20
a quelli morali, in cui la tensione si esplica nella coincidenza concreta
tra due opposti punti di vista:
La via in su e la via in giù sono un’unica identica via [DK 22B60].
Comune è il principio e la fine nel cerchio [DK 22B103],
oppure nella reversibilità dei processi:
Ciò che è freddo si riscalda, ciò che è caldo si raffredda, l’umido secca, l’asciutto si inumidisce [DK
22B126],
o ancora nella relatività dei valori:
Il mare è l’acqua più pura e più impura, per i pesci bevibile e salutare, imbevibile e mortale per gli uomini
[DK 22B61].
La malattia rende dolce e gradita la salute, la fame la sazietà, la fatica il riposo [DK 22B111].
Gli asini preferirebbero la paglia all’oro [DK 22B9].
Non si deve tuttavia credere che l’analisi del filosofo si fermi alla
formalizzazione della scienza altrui e al rilievo di una misura immanente
nella realtà: in questo caso si rischierebbe di proiettare Eraclito molto
avanti nella storia del pensiero occidentale, mentre egli si muove, con le
sue folgorazioni intuitive, nell’orizzonte della physis ionica, con le sue
affascinanti ambiguità. Così non deve sorprendere, dopo la sovrapposizione
tra il logos e la discorde armonia, l’ulteriore apertura cosmica:
Quest’ordine del mondo, che è lo stesso per tutti, non lo fece né uno degli dei né uno degli uomini, ma è
sempre stato ed è e sarà fuoco vivo in eterno, che al tempo dovuto si accende e al tempo dovuto si spegne
[DK 22B30]
Scambio reciproco di tutte le cose col fuoco e del fuoco con tutte le cose, come delle merci con l’oro e
dell’oro con le merci [DK 22B90]
Mutamenti del fuoco: dapprima mare, del mare una metà terra, l’altra soffio infuocato [DK 22B31].
Il logos comune qui si fa kosmos (il termine è qui per la prima volta ufficialmente utilizzato da un filosofo), identico per tutti gli enti, eterno, quindi si rivela physis-arché: fuoco sempre vivo, cui si riducono le
cose in un nesso d’equivalenza sostanziale, e che struttura l’ordine sulla
base della propria intrinseca misura. Il vitalismo milesio è in ogni modo
disciplinato dall’esigenza d’un effettivo equilibrio dinamico nei processi
cosmologici, interpretati come scambi di masse elementari, risultato delle
metamorfosi fenomeniche del fuoco originario.
4.3 Una nuova tavola di valori
Come in precedenza messo in evidenza, un aspetto colpisce nel materiale attribuito a Eraclito: il richiamo all’interiorità e alla consapevolezza (ho indagato me stesso), reso più consistente dalla profondità attribuita all’anima:
Per quanto cammini, ed anche percorrendo ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell’anima: tanto
profonda è la sua vera essenza [DK 22B45].
Ora possiamo aggiungere che l’originalità di tale passaggio sta nel fatto che evidentemente
per il filosofo non si dà opposizione nei due percorsi, quello dell’indagine “naturalistica” e
quello dell’interiorità, per la semplice ragione che il logos è comune. L’introspezione non ha
dunque in Eraclito alcuna connotazione intimistica, non sottintende una chiusura in se stessi,
piuttosto l’apertura alla totalità del kosmos. Anche se non mancano frammenti di sapore ambiguamente escatologico, in cui s’accenna al destino dei morti, marcando con disprezzo orfico
l’insignificanza del corpo, che potrebbero suggerire una lettura morale o religiosa del filosofo:
21
I cadaveri son da gettar via più dello sterco [DK 22B96].
Attendono gli uomini, da morti, cose che non sperano né si immaginano [DK 22B27].
Il fuoco venendo giudicherà e condannerà tutte le cose [DK 22B66].
In questo senso Eraclito abbozza anche una nuova tavola di valori, una nuova nozione di
saggezza. Essa da un lato rifiuta i modelli della tradizione, discutendone lo spessore (il caso
di Omero) o la competenza (Esiodo), dall’altro investe l’enciclopedismo dei contemporanei:
Omero è degno di esser frustato e cacciato via dalle gare e con lui Archiloco [DK 22B42].
Maestro dei più è Esiodo. Credono che fosse il sapiente, lui che non sapeva cosa fossero né il giorno né la
notte: perché in verità sono una cosa sola [DK 22B57].
Il saper molto non insegna a pensar rettamente: altrimenti lo avrebbe insegnato a Esiodo e a Pitagora, ed
anche a Senofane e a Ecateo [DK 22B40].
Pitagora è capo di ingannatori [DK 22B81].
Pitagora, figlio di Mnesarco, ha atteso agli studi più d’ogni altro uomo e raccogliendo questi scritti ne ha
fatto la propria sapienza, il saper molto, cattiva arte [DK 22B129].
La nuova saggezza è intendere come il tutto sia governato attraverso tutto, è quel retto
pensiero che vince l’estraneità del mondo e guida l’uomo a dire e fare cose vere, in sintonia
con l’intima natura delle cose. Massima virtù è dunque quella qualità razionale che consente
all’uomo di cogliere l’armonia nascosta, abitando, di conseguenza, consapevolmente, il mondo comune ai desti.
ESERCIZIO
• In conclusione, tenendo conto dei frammenti esaminati, si tenti di interpretare il fr. 123: <<l’intima natura delle cose ama nascondersi>>.
5. Parmenide: il poema
Probabilmente contemporaneo di Eraclito (quindi vissuto tra la seconda metà del VI e la
prima del V secolo), Parmenide si formò e operò (forse anche a livello politico, come abbiamo registrato anche per precedenti figure) a Elea, in Magna Grecia, nell’ambiente di diffusione del pitagorismo, cui la dossografia (Diogene Laerzio) tende a collegarlo, sebbene la tradizione lo voglia (improbabile) discepolo del poeta-filosofo Senofane di Colofone (famoso per
la sua polemica contro l’antropomorfismo delle rappresentazioni religiose e il politeismo). Le
fonti neoplatoniche, Proclo (V secolo d.C.), Simplicio, lo scettico Sesto Empirico (II secolo
d.C.) e altri ci hanno conservato circa un quarto (150 versi) del poema parmenideo Peri
physeos, garantendoci dunque la possibilità dello scontro diretto con le asperità e novità profonde dei suoi contenuti. La storia della filosofia, come avremo modo di verificare nei prossimi capitoli, non sarà più la stessa dopo l’espressione di quel pensiero.
La struttura dell’opera, che noi siamo in grado di ricostruire nei suoi tratti essenziali, e la
sua forma stilistica rappresentano un chiaro tentativo d’intrecciare la narrazione mitica e la
disamina razionale, tanto da renderle indistricabili e equivalenti: così, sui ritmi dell’esametro
della grande tradizione epica omerica e esiodea, noi parteciperemo all’emozione per un viaggio straordinario, lungo una strada che conduce alla verità, appannaggio, tuttavia, di chi si orienta con l’intelligenza, e per la comunicazione di una rivelazione, che, d’altra parte, come
esplicita l’autore, deve essere vagliata razionalmente, trovando la propria forza
nell’inattaccabilità logica. Nella veste sacrale del viaggio, di marca orfica oltre che omerica,
nel linguaggio del mythos, si esprime così la potenza di un logos inaudito 8 :
8)
Utilizzo l’edizione Parmenide Poema sulla natura, a cura di G. Reale e L. Ruggiu, Rusconi, Milano, 1991.
Sottolineature mie.
22
Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio
[vuol giungere,
mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e
[mi ebbero posto sulla via che dice molte cose,
che appartiene alla divinità e che porta per tutti i
[luoghi l’uomo che sa.
Là fui portato. Infatti, là mi portarono accorte cavalle
tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via.
L’asse dei mozzi mandava un sibilo acuto,
infiammandosi - in quanto era premuto da due
[rotanti
cerchi da una parte e dall’altra -, quando
[affrettavano il corso nell’accompagnarmi,
le fanciulle Figlie del Sole, dopo aver lasciato le case
[della Notte,
verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo.
Là è la porta dei sentieri della Notte e del Giorno,
con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra;
e la porta, eretta nell’etere, è rinchiusa da grandi
[battenti.
Di questi, Giustizia, che molto punisce, tiene le
[chiavi che aprono e chiudono.
Le fanciulle, allora, rivolgendole soavi parole,
con accortezza la persuasero, affinché, per loro, la
[sbarra del chiavistello
senza indugiare togliesse dalla porta. E questa, subito
[aprendosi,
produsse una vasta apertura dei battenti, facendo
[ruotare
nei cardini, in senso inverso, i bronzei assi
fissati con chiodi e con borchie. Di là, subito,
[attraverso la porta,
diritto per la strada maestra le fanciulle guidarono
[carro e cavalle.
E la Dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano
[la mia mano destra
prese, e incominciò a parlare così e mi disse:
<< O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici,
con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora,
rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto
[a percorrere
questo cammino - infatti esso è fuori dalla via [battuta
dagli uomini -,
ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto
[apprenda:
e il solido cuore della Verità ben rotonda
e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera
[certezza.
Eppure anche questo imparerai: come le cose che
[appaiono
bisognava che veramente fossero, essendo tutte
[in ogni senso>>. [DK 28B1]
ESERCIZIO
• Si evidenzino, di questa introduzione poetica, i tratti secondo voi più marcati dal poeta-filosofo.
23
Questo proemio, probabilmente versione integrale di quello del poema, è
dominato dal tema della odos (strada, via): l’esperienza eccezionale, che
Parmenide fa rivivere nei dettagli che ne svelano la tensione emotiva (il
desiderio), lo sforzo rivelativo (la guida divina, l’accortezza delle cavalle, lo stridore del carro), è scandita dai riferimenti al percorso del
viaggio. Quel che conta, però, non è tanto cogliere l’eco (indubitabile)
dell’epica o della mitologia orfica, in altre parole fermarsi semplicemente
all’aspetto della continuità con la tradizione sapienziale, piuttosto individuare i passaggi che nel prosieguo dell’opera manifesteranno la metamorfosi interna a quell’iconografia religiosa.
Così il proemio si apre con la sottolineatura “iniziatica” della via che
appartiene alla divinità e che porta l’uomo che sa: un sapere, come risulterà inequivocabilmente dai frammenti successivi, che non è più quello dei
misteri (in cui si usavano identiche espressioni), ma logos vincolato dalla
necessità razionale, cui si appellerà la stessa divinità nel giudizio.
L’annuncio stesso della rivelazione, con cui si chiude questo primo squarcio del poema, compimento quindi del viaggio lungo un cammino fuori dalla
via battuta dagli uomini, non si mostra atto arbitrario di una divinità
supponente, ma programma articolato secondo un piano logico, che corrisponde alla legittimità e alla giustizia evocate a garanzia del cammino.
Nell’affollamento di figure femminili, nominate e innominate, religiosamente velate, nonostante gli impliciti e espliciti ostacoli del percorso e
l’intervento persuasivo delle soavi parole delle fanciulle Figlie del Sole,
l’impatto con la Verità non è sussurrato, né affidato all’ambiguità di un
responso, ma proposto globalmente, linearmente, limpidamente. A differenza
delle Muse esiodee, la divinità parmenidea è vincolata alla rivelazione
della Verità. Le qualità richieste per accogliere tale rivelazione non sono
dunque né quelle della riservatezza assoluta, né quelle della devozione rituale, bensì quelle intellettuali che consentono di seguire l’arco del discorso presentato dalla dea.
Con questo non vogliamo negare la forte connotazione religiosa del quadro, la dimensione “ascensiva”, “solare” della rivelazione, né trascurare
proprio quell’affollamento di cui si è appena detto (Dike, Themis, Heliades,
Nuktos, Moira) e che senz’altro riflette schemi della lezione omerica, esiodea e orfica. Tuttavia, attraverso quelle figure e in quel quadro, in
altri termini, nel linguaggio del mito, si esprimono le esigenze del logos,
che molto ha appreso dal contributo dei primi filosofi.
Che cosa preannuncia, in conclusione, la divinità innominata? Da un lato
i) la manifestazione della Verità e, conseguentemente,
ii) la denuncia degli errori nelle confuse e incerte opinioni dei mortali
(uno dei passaggi in cui sembra marcato lo scarto, classico ancora nel contemporaneo Eraclito, tra umano e divino); dall’altro, in relazione a quegli
errori,
iii) la corretta interpretazione del mondo dell’esperienza (le cose che
appaiono, ta dokounta). Un punto, quest’ultimo, molto controverso, anche a
livello filologico.
5.1 Rivelazione e Verità
Orbene, io ti dirò - e tu ascolta e ricevi la mia
[parola quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare:
l’una che “è” e che non è possibile che non sia
•
è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro
[alla Verità l’altra che “non è” e che è necessario che non sia.
E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si
[apprende.
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché
[non è fattibile,
né potresti esprimerlo [DK 28B2].
...Infatti lo stesso è pensare ed essere [DK 28B3].
24
ESERCIZIO
• Soffermatevi sull’indicazione delle “due vie”, cercando di motivare l’affermazione dell’ultimo
frammento (“lo stesso è pensare ed essere”).
La rivelazione della Verità, delegata alla parola divina (mythos, nel testo greco), si affida al tema centrale della odos (cammino, via), che dal
piano “mitico” del viaggio è trasposta in quello logico del “metodo” (methodos), della via di ricerca. Preliminarmente, in modo diretto e chiaro,
la dea innominata (Verità? Giustizia? Mnemosyne? O, più semplicemente, un
concentrato del “femminino” dominante nel poema?) individua, nella direzione di un’indagine che voglia cogliere il vero nella sua totalità, due sole
possibilità, reciprocamente incompatibili, designate dalle pure forme verbali dell’affermatività o esistenza (è) e della radicale negatività (non
è). Non si concede, logicamente, altra eventualità, fissando per la prima
volta un principio fondamentale del logos, che tra due espressioni contraddittorie non è ammessa mediazione.
Ciò è rafforzato dall’impiego, a sostegno, delle formule di impossibilità
e necessità: non è possibile che non sia, e è necessario che non sia. Le
due vie, insomma, s’impongono alla ragione, come le uniche praticabili in
quanto incondizionate e assolutamente incompatibili (come positività globale e negatività): la ragione è “costretta” a riconoscerle come le alternative che, nella mutua esclusione, esauriscono ogni pensabilità. Con un ulteriore risultato “pesante” per la storia del pensiero posteriore:
l’implicita equazione tra pensabile e possibile.
Aperta logicamente l’alternativa, essa è immediatamente risolta. Qualsiasi contenuto del pensiero andrà senz’altro ascritto alla via che “è”, dal
momento che nulla può attribuirsi alla via che “non è”: ciò che non è è inconoscibile e inesprimibile, risultando, in quanto pura negatività, svuotato di ogni consistenza positiva. Soltanto due vie possono essere in assoluto proposte all’attenzione della ragione, ma una sola è quella percorribile, e che, dunque, assicura conoscibilità e esprimibilità; l’altra rimane
come una sorta di simbolo sospeso della totale indeterminatezza e carenza.
C’è poi un ulteriore elemento da valutare in questo secondo frammento del
poema: l’assenza di un soggetto esplicito alle due forme verbali “è” - “non
è”. Molte sono state le proposte di sottintesa attribuzione, ma la scelta
di Parmenide, in questo contesto, probabilmente all’avvio della trattazione
sulla Verità, può giustificarsi alla luce della logica intrinseca del discorso. Per la prima via (che “è”) sarà presto possibile ricavare un vero
soggetto, per la seconda (che “non è”) propriamente no: la loro corrispondenza è solo apparente e iniziale, e lascia immediatamente il posto alla
consapevolezza della radicale dissimmetria. L’impostazione della ricerca fa
semplicemente considerare la seconda possibilità, che si rivela in ogni modo come non fattibile.
Ma in che senso la dea usa l’espressione “è”? Il terzo frammento, con
l’esplicita equazione di pensare (noein) e essere (einai), contribuisce a
sottolineare la perfetta sovrapposizione, nel linguaggio della Verità, tra
il pensiero che svela l’essere come vera e unica possibilità, e l’essere
che non può non manifestarsi nel pensiero. Come avremo modo di rimarcare,
Parmenide in questo si orienta nell’orizzonte dischiuso dalla riflessione
sulla physis, anche se con un rigore e una consequenzialità lì non riscontrabili.
5.2 Gli enti e l’orizzonte dell’essere
Considera come cose che pur sono assenti, alla
[mente siano saldamente presenti;
infatti non potrai recidere l’essere dal suo essere
[congiunto con l’essere,
né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo,
né come raccolto insieme [DK 28B4].
Indifferente è per me
il punto da cui devo prendere le mosse; là, infatti,
25
[nuovamente dovrò fare ritorno [DK 28B5].
ESERCIZIO
• In che senso, secondo voi, le “cose assenti” sono “alla mente “saldamente presenti”?
Il quarto frammento è indicativo della direzione imboccata da Parmenide e
del suo rapporto con il pensiero ionico. Ciò che è messo in risalto è la
funzione omogeneizzante del nous (pensiero) rispetto alla discontinuità del
dato empirico: il verbo noein, da cui nous deriva, non ha valore generico,
designa piuttosto un vedere (con la mente) che penetra oltre la superficie,
l’apparenza, che dunque disvela e coglie. Mentre nel frammento precedente
si poneva l’accento sulla sua portata rivelativa rispetto all’essere, qui
se ne precisa il senso. L’essere (to eon) è infatti proposto come lo sfondo
che accoglie, stringe tutte le cose, l’unità che dà significato al molteplice delle cose presenti e assenti, lontane e vicine. Il pensiero opera
questo superamento del dato immediato dell’esperienza, compattandolo
nell’eon, che ne risulta comune denominatore.
Operazione per molti versi analoga a quella dei primi autori studiati,
con la fondamentale differenza che, in questo caso, non si riscattano le
contraddizioni del divenire inquadrandolo nella permanenza della physisarché, ma si denuncia l’assurdità della comune e quotidiana assunzione del
divenire, e la debolezza degli schemi interpretativi ionici. Il pensiero
palesa l’inattaccabile contiguità degli enti nell’essere, implicitamente
emarginando, con il nulla, il problema stesso del divenire, come generazione e corruzione. Contemporaneamente, però, sono stigmatizzate le incongruenze della tradizione ionica, nel rilievo dell’impossibilità (logica)
della dispersione e concentrazione dell’essere nel cosmo, in altri termini,
dell’insufficienza (logica) delle sue deduzioni cosmogoniche, come meglio
risulterà più avanti.
Infine, il quinto frammento sembra ribadire questo senso di compattezza e
densità dell’essere, che costituisce l’unità nella molteplicità degli enti,
risultando quindi ineludibile e sempre riconoscibile dal nous.
5.3 Pensiero e essere
È necessario il dire e il pensare che l’essere sia:
[infatti l’essere è
il nulla non è: queste cose ti esorto a considerare.
E dunque da questa prima via di ricerca ti tengo
[lontano,
ma, poi, anche da quella su cui i mortali che nulla
[sanno
vanno errando, uomini a due teste: infatti, è
l’incertezza
che nei loro petti guida una dissennata mente.
[Costoro sono trascinati,
sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini
[senza giudizio,
dai quali essere e non-essere sono considerati la
[medesima cosa
e non la medesima cosa, e perciò di tutte le cose c’è un
[cammino reversibile [DK 28B6].
Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le
[cose che non sono!
Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero,
né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su questa
[via ti forzi
a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che
[rimbomba
26
e la lingua, ma con la ragione giudica la prova
[molto discussa
che da me ti è stata fornita [DK 28B7].
ESERCIZIO
• Individuate le ragioni che possano consentire l’interpretazione del riferimento di Parmenide agli “uomini a due teste”.
Il sesto e il settimo frammento avviano il sondaggio delle implicazioni
delle tesi emerse nei passaggi precedenti, tanto nei risvolti propositivi,
quanto in quelli critici. I fr.3 e 4 avevano fatto intravedere il vero soggetto della via che “è”: l’essere, che rappresenta la dimensione comune degli enti vicini-lontani, presenti-assenti, aperta, manifestata dal pensiero
che non si lascia ingannare dalle apparenze (nous). L’attacco del nuovo testo esplicita quel ruolo, rilevando lo scarto rispetto alla via che “non
è”: per questa si propone un soggetto, il nulla, che è tale solo dal punto
di vista di un’analisi sintattica, senza avere alcuna consistenza ontologica. L’essere esprime, invece, compiutamente, proprio per quella connotazione d’unità costituente la molteplicità degli enti, la positività affermata
originariamente.
Nuovamente è esaltata la necessità, la cogenza delle tesi proposte, non
collegate all’autorità della dea, ma all’incompatibilità logica dei poli
del dilemma introdotto (è - non è). Negata la possibilità di percorrere la
via della negatività (probabilmente coinvolta per prima nell’analisi,
all’interno del poema), inconoscibile e inesprimibile, non rimane che seguire coerentemente l’altra. È appunto la coerenza che è mancata e manca ai
mortali, i quali pretendono di coniugare essere e nulla, così malamente interpretando la propria quotidiana esperienza. Se Eraclito aveva parlato di
ottusità e sonnambulismo, Parmenide registra l’erramento, la deriva, per
l’accecante contraddizione delle loro opinioni. Riferimento generico e specifico a un tempo: ai molti (ignoranti), ma anche ai filosofi ionici, che
non avevano adeguatamente evitato l’ambiguità, attribuendo la forza del
principio a un elemento a scapito degli altri, concentrando l’essere in
un’area della realtà, piuttosto che in un’altra; forse addirittura
all’Efesio, come vorrebbe qualcuno, leggendo le ultime righe del fr.6 come
motteggio del logos eracliteo.
Nel passaggio successivo, ribadita l’assurdità e quindi inaccettabilità
della contraddizione (che siano le cose che non sono), viene articolata la
scomunica della pretesa terza via inconsapevolmente avanzata dagli uomini
senza giudizio (letteralmente a due teste), sulla scorta dell’abitudine nata dalle molte esperienze. Gli uomini della contraddizione sono dunque
quelli che si affidano al dato empirico, condizionati dai meccanismi riflessi dell’abitudine, senza discernerlo razionalmente, senza leggerlo in
trasparenza con l’occhio della mente. L’errore si dissolve, non a caso,
nell’appello alla valutazione, con la ragione, degli argomenti a confutazione sostenuti dalla dea.
5.4 I segni dell’essere
Resta solo un discorso
[della via:
che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori
assai numerosi: che l’essere è ingenerato e imperituro,
infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza
[fine.
Né una volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto
[quanto,
uno, continuo. Quale origine, infatti, cercherai di
[esso?
Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere
[non ti concedo
né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né
27
[dire né pensare
che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto
a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla?
Perciò è necessario che sia per intero, o non sia
[per nulla.
E neppure dall’essere concederà la forza di una
[certezza
che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa
[ragione né il nascere
né il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo
[dalle catene,
ma saldamente lo tiene. La decisione intorno a tali
[cose sta in questo:
“è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario,
che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e
[inesprimibile, perché non del vero
è la via, e invece che l’altra è, ed è vera.
E come l’essere potrebbe esistere nel futuro? E come
[potrebbe essere nato?
Infatti, se nacque, non è; e neppure esso è, se mai
[dovrà essere in futuro.
Così la nascita si spegne e la morte rimane ignorata.
E neppure è divisibile, perché tutto intero è
[uguale;
né c’è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere.
Perciò è tutto intero continuo: l’essere, infatti, si
[stringe con l’essere.
Ma immobile, nei limiti di grandi legami
è senza principio e senza fine, poiché nascita e
[morte
sono state cacciate lontane e le respinse una vera
[certezza.
E rimanendo identico e nell’identico, in sé medesimo
[giace,
e in questo modo rimane là saldo. Infatti, Necessità
[inflessibile
lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra
[tutt’intorno,
poiché è stabilito che l’essere non sia senza
[compimento:
infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse,
[mancherebbe di tutto.
Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il
[pensiero,
perché senza l’essere nel quale è espresso,
non troverai il pensare. Infatti, nient’altro o è o sarà
all’infuori dell’essere, poiché la Sorte lo ha
[vincolato
ad essere un intero e immobile. Per esso saranno nomi
[tutte
quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che
[fossero vere:
nascere e perire, essere e non-essere,
cambiare luogo e mutare luminoso colore.
Inoltre, poiché c’è un limite estremo, esso è
[compiuto
da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera,
a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti, né
[in qualche modo più grande
28
né in qualche modo più piccolo è necessario che sia, da
[una parte o da un’altra.
Né, infatti, c’è un non-essere che gli possa impedire di
[giungere
all’uguale, né è possibile che l’essere sia dell’essere
più da una parte e meno dall’altra, perché è un
[tutto inviolabile.
Infatti, uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei
[suoi confini [DK 28B8 vv.1-49].
ESERCIZIO
• Si elenchino per iscritto i “segni” dell’”essere”.
• Tenendo conto dell’alternativa “è - non è”, si cerchi di dare ragione di essi, prima di leggere il commento.
Il lungo frammento ottavo (di cui leggeremo la conclusione più avanti),
senz’altro il brano di sapienza arcaica più consistente che ci sia stato
tramandato, mette a fuoco i caratteri del soggetto in questione nella rivelazione della dea: l’essere. Come già riscontrato, questo non avviene in
termini meramente assertivi, ma sempre in modo argomentato, a partire
dall’originario dilemma “è”-“non è”. La rigorosa conduzione logica del discorso
porta
ancora
Parmenide
a
rovesciare
il
quadro
quotidiano
dell’esperienza irriflessiva, ma anche a mettere a nudo l’insufficienza
delle teorie ioniche.
L’apertura si può ricollegare ai frammenti precedenti: cancellata, come
impercorribile, la via che “non è”, evidenziata l’inconsistenza illusoria
della via che pretenderebbe rubricare il divenire come commercio tra
l’essere e il nulla, non rimane se non la via che “è”, lungo la quale, progressivamente, si dipanano i segni (semata) che rivelano la natura
dell’essere. Essi sono ricavati con un procedimento originale, che tuttavia
potrebbe risentire di una tradizione orale, per noi perduta, di confronti
dialettici, duelli verbali tra sapienti, in cui forse maturarono le categorie che Parmenide utilizza con grande disinvoltura (essere, non-essere,
possibile, necessario). Ogni segno è il risultato della confutazione di un
aspetto della realtà che noi ci illudiamo di apprendere attraverso i sensi.
Così l’essere è ingenerato e imperituro, a dispetto della cosiddetta esperienza del nascere e morire. Perché? Parmenide rileva immediatamente il
carattere di totalità e omogeneità dell’eon, che lasciando fuori ogni possibilità alternativa, assicura compiutezza in ogni senso. L’argomento è
tuttavia articolato. Da un lato si dissolve infatti l’illusione di una temporalità dell’essere, che comporterebbe l’inammissibile coinvolgimento del
nulla: ciò che era non è più, ciò che sarà non è ancora. L’essere è, dunque, ora insieme tutto quanto: nella sua compattezza che esclude la negatività in sé, esso trascende la temporalità nell’eterno, puntuale, presente
(ora).
D’altra parte, scompare anche il problema dell’origine, che implicherebbe
nuovamente la contraddizione di un nulla generatore dell’essere. Con
un’ulteriore assurdità: come potrebbe il non-essere determinare ciò che è?
L’assoluta mancanza non può essere sufficiente come principio determinante:
ex nihilo nihil sarà la formula latina di questo fondamentale assioma della
nostra razionalità occidentale. Nell’integrità e omogeneità dell’essere si
risolve ovviamente anche l’eventualità di una generazione dall’essere, che
implicherebbe un’inaccettabile nota discriminante nella sua compattezza.
Dike (Giustizia) lo vincola logicamente, lo trattiene dalla contraddizione
annichilente. Maturata la decisione razionale per l’essere, tutto quanto
possa coinvolgere il contraddittorio deve essere azzerato, proprio per svelare a pieno la positività dell’eon, la sua verità.
Escluse la generazione e, analogamente, la corruzione, Parmenide passa a
negare un altro apparente dato d’esperienza: la divisibilità. L’essere,
nella sua omogeneità e integrità non può ammetterla, pena l’ammissione di
una lacuna, di un vuoto di realtà, che risulterebbe contraddittoria: non
c’è un più o un meno d’essere, ma l’essere è pieno di essere. Detto, evi-
29
dentemente, anche con riferimento a quei pensatori che avevano ingenuamente
delineato processi di condensazione e rarefazione della physis (Anassimene,
forse i pitagorici). Quella continuità e quella densità ontologica, unitamente alla sua totalizzante interezza, garantiscono all’essere pure
l’immobilità, che è in primo luogo logica (l’insistenza sui legami, le catene), come conseguenza della necessità e unicità della via che “è”.
Ingenerato, incorruttibile, indivisibile, immobile, “atemporale”, sotto
l’egida della ferrea Necessità (a un tempo forza divina e logica) l’essere
è dunque inviolabile, invulnerabile (nascita e morte sono state cacciate
lontane). Non soffrendo lacune è compiuto, essendo compiuto sarà rinserrato
nel limite estremo, secondo un modello squisitamente pitagorico: Parmenide
usa un’immagine potente, quella della massa di ben rotonda sfera, a segnalarne la solidità, integrità, omogeneità e equilibrio, forse per alludere
anche alla dimensione cosmica dell’essere.
Accanto a questi aspetti centrali, emerge la riflessione sul nesso realtà-pensiero, pensiero-linguaggio. Non può darsi altro oggetto del pensiero
se non l’essere, che d’altra parte in quello soltanto trova espressione. Il
linguaggio umano può significare questa sovrapposizione e essere dunque veritiero, disvelante, oppure occultare, disorientare, come accade comunemente nell’uso quotidiano: in tal caso esso si ridurrà, secondo il filosofo, a
confusione di meri nomi, senza forza significante.
5.5 Essere e apparenza
Qui pongo termine al discorso che si accompagna
[a certezza e al pensiero
intorno alla Verità; da questo punto le opinioni
[mortali
devi apprendere, ascoltando l’ordine seducente delle
[mie parole.
Infatti, essi stabilirono di dar nome a due forme
l’unità delle quali per loro non è necessaria: in
[questo essi si sono ingannati.
Le giudicarono opposte nelle loro strutture, e
[stabilirono i segni che le distinguono,
separatamente gli uni dagli altri: da un lato, posero
[l’etereo fuoco della fiamma,
che è benigno, molto leggero, a sé medesimo da ogni
[parte identico,
e rispetto all’altro, invece, non identico; dall’altro
[lato, posero anche l’altro per se stesso,
come opposto, notte oscura, di struttura densa
[e pesante.
Questo ordinamento del mondo, veritiero in tutto,
[compiutamente ti espongo,
così che nessuna convinzione dei mortali potrà
[fuorviarti [DK 28B8 vv.50-60].
Questi versi conclusivi dell’ottavo frammento fanno da spartiacque,
nell’economia del poema, così come ci è stato tramandato, tra esposizione
della Verità e opinioni sul mondo fenomenico. In questo senso svolgono una
funzione molto delicata, contribuendo sostanzialmente alla valutazione della portata della doxa (opinione) in Parmenide. Abbiamo messo in evidenza,
nel commento che precede, l’originale procedimento con cui l’autore ha “costruito” i segni indicatori dell’essere, negando i caratteri che
l’inconsapevole abitudine ci porta a attribuire al mondo. Quei segni non
sono dunque frutto dell’esperienza sensibile, che da essi, anzi, sembra
confutata, si fondano piuttosto su un’analisi a priori, puramente logica,
delle implicazioni delle due vie. L’essere così conquistato razionalmente è
in ogni caso la realtà cui accediamo attraverso il pensiero: una realtà
consistente, compatta, ben diversa da quella che ci illudiamo di scoprire
attraverso l’adesione immediata al dato sensibile. Si deve concludere che
Parmenide abbia negato spessore al mondo fenomenico, magari limitandosi a
30
proporne un’interpretazione meno assurda d’altre concorrenti, nella mesta
consapevolezza che comunque siamo condannati a vivere nell’illusione dei
sensi?
Certamente la dea avvisa il discepolo della svolta nella propria esposizione, mettendo l’accento sullo scarto tra il discorso della certezza (il
lungo processo deduttivo, a priori, della prima parte del frammento) e
l’ordine seducente delle parole che si confrontano direttamente con le opinioni mortali. In questo passaggio abbiamo, molto probabilmente, un richiamo alle righe conclusive del primo frammento, quelle che presentavano il
programma della rivelazione, accennando anche all’esigenza di apprendere
come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, essendo tutte in
ogni senso. Alla luce di quel che nel frattempo abbiamo imparato, è possibile concludere che, pur marcando la differenza tra la dimensione assoluta
dell’essere, in altri termini, della realtà colta nella sua totalità, e
quella sempre relativa e condizionata dell’apparire, Parmenide fosse convinto della possibilità di offrirne una valida interpretazione.
Come in precedenza segnalato, l’errore di fondo della filosofia ionica e
pitagorica era stato quello di non aver debitamente considerato i risvolti
della via che “è”. La dimensione ontologica dello sforzo di un Anassimandro
e, se conosciuto, dello stesso Eraclito, non poteva essere sfuggita
all’Eleate. L’appunto ripreso genericamente in questo contesto è quello relativo alla natura della polarità impiegata, di cui non era stata convenientemente rilevata la radice unitaria nell’essere, finendo così per romperne l’equilibrio, con la positività concentrata in un polo, la negatività
nell’altro. L’inganno, insomma, consisterebbe nella lacerazione, logicamente insanabile, aperta da quella tensione. A correzione di quel modello (luce-notte, probabilmente di matrice pitagorica, ma strutturalmente analogo a
quello delle cosmogonie ioniche), Parmenide evidenzierebbe come le due forme nominate siano saldate nell’essere, come la loro articolazione sia solo
funzionale alla lettura del fenomenico, mai mettendone a rischio l’unità e
integrità. Un approfondimento mirato, quindi, a ripulirlo dalle ingenuità e
incongruenze, senza metterlo radicalmente in discussione nella sua valenza
esplicativa dell’apparire.
La seconda parte dell’opera, destinata appunto alla doxa, molto più ampia
di quella dedicata alla Aletheia, una sorta di prova enciclopedica, ci è
giunta solo estremamente frammentata, tanto da renderne problematica la ricostruzione in dettaglio. Indubbiamente Parmenide vi sviluppava una grande
cosmologia, incentrata sul motivo appena accennato, “tutto è pieno di luce
e notte” (esattamente come l’essere era tutto pieno d’essere), che, riciclando elementi pitagorici (la tavola delle contrarietà), puntava, con i
propri equilibri e con la densità pervasiva delle due forme, a prolungare
sul piano fenomenico la compattezza razionalmente riconosciuta alla realtà
nella sua totalità. Intrecciando intenzione scientifica e temi e figure
della tradizione teogonica, a conferma di una tendenza all’uso combinato di
diversi registri espressivi, palese sin dal proemio.
6. L’eleatismo
Riuniamo in questo capitolo l’analisi del pensiero di due autori direttamente legati alla lezione parmenidea, l’uno, Zenone di Elea, giovane contemporaneo e, come si dice, discepolo
di Parmenide, l’altro Melisso di Samo (V secolo), che contribuì, con una certa originalità, a
mediare tra istanze ioniche (l’infinito) e esigenze logiche eleatiche. Mentre del primo ci sono
conservate solo poche righe, e le parafrasi aristoteliche e dei commentatori più tardi di Aristotele, abbiamo del secondo una decina di frammenti, anche di una certa consistenza, che consentono una più accurata ricostruzione diretta. Motivo per cui, a dispetto della maggiore dignità filosofica riconosciuta sin dall’antichità a Zenone, noi ci concentreremo prevalentemente sulla discussione dei frammenti melissiani, nella convinzione che essi implicitamente introducano anche alla lezione naturalistica di Empedocle, Anassagora e Democrito.
Un aspetto accomuna i due filosofi, per altro vissuti in aree geografiche diverse e probabilmente mai entrati in contatto diretto: la radicalizzazione delle posizioni di Parmenide, con
l’azzeramento, ben oltre le intenzioni del maestro, del mondo dell’opinione, e lo sviluppo del
31
metodo dilemmatico (cioè per dilemmi, dicotomie) avviato nel poema (in particolare nel fr.8),
nella sua intenzione dialettica, di confutazione delle possibili alternative a una tesi, al fine di
riaffermarne la validità contro l’attacco dei teorici avversari. A Zenone, per questo, fu attribuita l’invenzione della dialettica, che gli valse anche un ruolo, insieme con il maestro, amico
e, forse, amante Parmenide, in uno dei dialoghi più impegnativi di Platone (il Parmenide, appunto) per il confronto con la tradizione “eleatica”.
6.1 La dialettica di Zenone
Così Filopono, commentatore aristotelico del VI secolo, riassume la strategia dialettica 9
del discepolo di Parmenide:
Zenone di Elea infatti attaccando coloro che mettevano in ridicolo la dottrina del maestro Parmenide, secondo la quale l’essere è uno, ed intervenendo in sua difesa, cercò di dimostrare che è impossibile che
l’essere sia molteplice. Se infatti vi fosse la molteplicità, dato che essa è composta di una pluralità di unità, sarebbe necessario che vi fossero quelle molte unità di cui consta la molteplicità. Quindi se riusciremo
a dimostrare l’impossibilità che vi siano molte unità, è chiaro che ne risulterà l’impossibilità anche della
molteplicità, che è composta di unità. Se è impossibile che esista la molteplicità - essendo necessario che
esista o l’uno o la molteplicità, e questa non potendo esistere - resta come ultima possibilità che esista
l’uno.
E come dimostrò Zenone l’impossibilità di una pluralità di unità? Poiché (gli avversari di Parmenide) introducevano la molteplicità fondandosi sull’evidenza sensibile (infatti esiste il cavallo e esiste l’uomo e
ogni cosa particolare, la cui unione costituisce la molteplicità), Zenone, cercando di confutare sofisticamente questo principio dell’evidenza, disse che, se la molteplicità è costituita d’unità, esse dovevano essere unità. Riuscendo a dimostrare che queste cose è impossibile che siano unità, è chiaro che da esse non
può risultare la molteplicità, se è vero che essa consiste di unità. E Zenone lo dimostra in questo modo:
<<O Socrate, ciò che voi chiamate unità e che dite costituire la molteplicità non è solo Socrate, ma bianco, filosofo, panciuto e camuso, tanto che la stessa cosa sarà una e molti. Ora è impossibile che la stessa
cosa sia una e molti, e quindi Socrate non sarà un’unità, ed allo stesso modo neppure le altre cose che dite
costituire la molteplicità. Quindi se è necessario che l’essere sia o uno o molti, ed è stato dimostrato che i
molti non sono, poiché non vi è una pluralità di unità, è necessario che sia uno>>.
Dimostra la stessa cosa partendo dalla considerazione del continuo: supponendo che il continuo sia uno,
dato che esso è sempre divisibile, sarà sempre possibile dividere ulteriormente il prodotto della divisione;
in questo caso il continuo sarà molteplice. Ma allora la stessa cosa sarà uno e molti, il che è impossibile,
tanto che non sarà uno. Ma se nessun continuo è uno, ed è necessario che la molteplicità, se esiste, sia
composta di unità, poiché non è possibile che vi siano unità, la molteplicità non esiste.
ESERCIZIO
• Si riproduca per punti l’argomento attribuito a Zenone.
Pur trattandosi di una testimonianza indiretta (comunque documentata dalla tradizione dei commenti aristotelici), si possono subito ricavare indicazioni interessanti sul pensiero di Zenone:
• intanto l’intenzione apologetica che condiziona il suo sforzo: contro i
detrattori del maestro, il discepolo ne riafferma l’inattaccabilità della
dottrina, rilevando le assurdità teoriche nelle tesi dei contraddittori. In
questo modo si afferma un modello confutatorio (elenchico) che è esasperazione di spunti parmenidei, di cui sfrutta il procedimento per dilemmi o
alternative incompatibili,
• poi l’assenza di una vera argomentazione in positivo, di una prova analoga a quella proposta dalla dea nel poema: tutto si riduce a quella riaffermazione, evidentemente senza contributi originali espliciti.
Implicitamente, in ogni caso, qualche accentuazione tematica risalta:
9)
Cito dall’edizione I Presocratici. Frammenti e testimonianze, a cura di A. Pasquinelli, cit., pp. 254 ss. Sottolineature mie.
32
• diventa centrale il riferimento all’uno, tutto sommato secondario in
Parmenide, molto più interessato a rimarcare l’interezza, totalità, integrità;
• sembra radicalmente emarginata l’attenzione per il mondo fenomenico,
mentre sistematica è la dissoluzione dei comuni presupposti della sua interpretazione.
Zenone avrebbe dunque proceduto in questo modo. Per quanto riguarda la
tesi dell’unità dell’essere, egli avrebbe proposto il dilemma: o è uno o è
molteplice, ma non può essere molteplice, quindi è uno. L’impossibilità del
molteplice era argomentata analogamente. Perché si dia molteplicità devono
esserci unità, di cui essa si compone: dimostrata l’inconcepibilità (impossibilità) di vere unità, si concludeva con la negazione anche della molteplicità. Tale inconcepibilità era ovviamente connessa alla contraddizione
intrinseca all’unità: nel testo che abbiamo riprodotto ci si riferisce alle
unità di base del molteplice sensibile. La confutazione è tanto più sbrigativa per la fluidità stessa dell’esperienza, che porta a riconoscere aspetti sempre diversi nello stesso soggetto: che si troverebbe così ad essere
nello stesso tempo, contraddittoriamente, uno e molteplice. Tuttavia se
viene meno l’unità di base, svanisce anche la molteplicità.
Come si evince dalle ultime righe della testimonianza, certamente Zenone
presentò nel suo Sulla natura argomenti ben più sottili di questi, tratti
dall’ipotetico confronto del Parmenide platonico. Argomenti in cui adeguava
la propria confutazione alle dottrine dei maggiori oppositori, probabilmente pitagorici, mettendo l’accento in ogni modo sulle contraddizioni del
molteplice a partire proprio dalle unità che avrebbero dovuto fondarlo. Estese o inestese (si pensi ai numeri-punti pitagorici)? Se estese, quelle
unità si sarebbero rivelate solo fittizie, rinviando a un processo di divisione inarrestabile, all’infinito. Se inestese, nuovamente, esse non avrebbero potuto essere considerate consistenti, risultando pari al nulla.
Modelli argomentativi analoghi erano poi proposti per altri segni
dell’essere parmenideo, indivisibilità e immobilità, con l’applicazione
strategica della riduzione all’assurdo. Le analisi avanzate proponevano,
dunque, una costante: la rigorosa applicazione delle vie del poema del maestro. Erano quindi articolate a priori, secondo schemi fissi, inevitabilmente mirati a dimostrare come ogni deviazione dalla via che “è” risultasse
in un’insostenibile contraddizione. La paradossalità delle conclusioni parmenidee, che negavano i dati immediati dell’esperienza, era così esaltata
come peculiare della vera filosofia, contro le assurdità e le illusioni di
chi poggiava su quell’evidenza, intendendo in ogni modo, sullo sfondo della
physis, “salvare i fenomeni”, come si sarebbe detto in seguito.
6.2 Melisso: totalità e infinità dell’essere
Il Sulla natura o sull’essere di Melisso si presenta, nella ricostruzione per noi disponibile,
con queste tesi introduttive 10 :
Se niente è, che cosa se ne potrebbe dire come se fosse qualcosa di esistente?
Sempre era ciò che era e sempre sarà. Perché se fosse nato, sarebbe necessario che prima di nascere non
fosse nulla. Ma se non era nulla, dal nulla non sarebbe potuto nascere nulla in alcun modo [DK 30B1].
Ora dunque poiché non è nato è e sempre era e sempre sarà e non ha né principio né fine, ma è infinito.
Se fosse nato infatti avrebbe principio (perché avrebbe cominciato a nascere ad un momento determinato)
e fine (perché avrebbe finito di nascere ad un momento determinato); ma poiché non ha né cominciato né
terminato era sempre e sempre sarà, e non ha né principio né fine. Non è possibile infatti che sia sempre
ciò che non è tutto [DK 30B2].
Ciò che ha principio e fine non è né eterno né infinito [DK 30B4].
[...] se non fosse uno, sarebbe limitato dal confinare con altro [DK 30B5].
10)
Cito dall’edizione Pasquinelli.
33
Se fosse, com’è, infinito, dev’esser uno. Se fossero due infatti non potrebbero essere infiniti, ma uno costituirebbe un limite per l’altro [DK 30B6].
ESERCIZIO
• Si tenti una ricostruzione dell’argomentazione di Melisso sull’infinità dell’”essere”, prima della lettura del
commento.
L’originalità degli sviluppi, rispetto al poema parmenideo, dovrebbe risaltare immediatamente. Procedendo più agilmente dell’Eleate, avendone acquisite le conclusioni, Melisso punta a precisarne il pensiero su alcuni
aspetti delicati. Ribadita inizialmente l’alternativa tra le due vie e subito imboccata l’unica percorribile, a motivo dell’indicibilità del nulla,
l’autore ne ricava un dato scontato, intorno a cui però farà ruotare le argomentazioni successive: l’essere è ingenerato e incorruttibile, dal momento che l’ammissione di un processo di generazione e corruzione implicherebbe l’avallo del nulla. Banditi tali rivolgimenti, l’essere è fissato nella
sua eternità, che, a differenza della puntualità atemporale dell’ora di
Parmenide, è connotata dal sempre era e sempre sarà. Ciò tuttavia non sottintende necessariamente uno scadimento teoretico, un’incomprensione melissiana per la atemporalità dell’essere parmenideo; semmai solo l’urgenza,
avvertita dal filosofo di Samo, di rimarcarne l’assenza di limiti, anche
temporali, e l’immutabilità.
Infatti, seconda correzione rispetto al maestro, l’essere, senza principio né fine (che risulterebbero invece coinvolti nei processi banditi come
contraddittori), è apeiron: l’assoluta stabilità è così garantita abolendo
ogni termine temporale. Tuttavia, l’inciso che chiude il terzo frammento
proposto (Non è possibile infatti che sia sempre ciò che non è tutto), è
significativo di un’esigenza più generale, quella di porre l’infinità non
solo dal punto di vista temporale, ma anche da quello spaziale, in considerazione del carattere di totalità dell’essere. In quanto tutto esso non avrà nulla fuori di sé, dunque sarà infinito (come si sostiene nei successivi frammenti); non ammettendo così un prima e un poi fuori di sé, sarà eterno.
Melisso, probabilmente, articolava nella sua opera questi argomenti, secondo la scansione dilemmatica che ci è ancora parzialmente conservata in
qualche passaggio, e nelle parafrasi dei commentatori. A proposito
dell’infinità, noi possiamo ancora intravedere l’impianto logico della prova. Rilevato che ciò che ha limite temporale e quindi subisce processi di
generazione e corruzione, non può essere tutto, avendo un principio da cui
e un termine in cui, egli poteva riconoscere, a maggior ragione, l’essere
come apeiron, nella misura in cui esso esaurisce il pensabile e possibile,
rifiutando ogni finitizzazione. Per cui, Melisso, non solo coniuga infinità
temporale e spaziale (non ricavando la seconda dalla prima, come si è creduto, ma riportandole alla necessaria totalità dell’essere), ma ribadisce,
con Zenone, come segno decisivo, che l’essere è uno. Anche in questo caso,
però, a fondamento non troviamo soltanto l’infinito, come immediatamente
appare nei frammenti, ma quel carattere totalizzante, diversamente orientato rispetto a Parmenide: in altre parole, l’essere è uno sostanzialmente
perché è tutto.
Parmenide aveva chiaramente alluso al limite estremo, essenziale, nella
sua ottica, per la compiutezza e compattezza dell’essere (l’immagine della
sfera): in quanto tutto, esso era compiuto, in quanto compiuto limitato,
molto probabilmente secondo un’impronta mentale squisitamente pitagorica.
Melisso, muovendo dalla stessa scelta per l’essere come totalità e compiutezza, inferiva la sua infinitudine, per azzerare eventuali difficoltà connesse al concetto stesso di limite (avanzate, con buona probabilità, dagli
oppositori dell’Eleate), che sembrava sottintendere il riferimento a quanto
è “al di là”, “fuori”. La totalità comportava dunque l’infinità, facendo
giustizia di quei risvolti; questa, a sua volta, l’essere-uno.
6.3 I nuovi segni dell’essere
1. Così dunque è eterno e infinito e uno e tutto uguale. 2. E non può né perire né diventar più grande né
cambiare la sua natura né mutare la sua disposizione, né soffrir dolore né provar sofferenza. Che se do-
34
vesse esser soggetto a una qualunque di queste cose, non sarebbe più uno. Se infatti cambia la sua natura
è necessario che l’essere non sia uguale, ma che perisca ciò che era prima e nasca ciò che non è. Basterebbe dunque che diventasse diverso anche di un solo capello in diecimila anni perché si annientasse
completamente in tutta la durata del tempo. 3. E neppure è possibile che muti la sua disposizione, perché
non si distrugge l’ordinamento che c’era prima e non nasce quello che non c’è. Ma poiché niente si aggiunge o perisce o diventa diverso, come potrebbe mutarsi qualcuno degli esseri? Perché se qualcosa potesse diventare diverso, sarebbe già cambiata anche la sua disposizione. 4. Né soffre dolore: perché non
potrebbe essere tutto se lo soffrisse, giacché una cosa che soffre dolore non può essere sempre né ha la
stessa forza di una cosa sana. E non sarebbe neppure uguale se soffrisse, perché soffrirebbe se gli venisse
aggiunto o tolto qualcosa, e allora non sarebbe più uguale. 5. Neppure ciò che è sano potrebbe soffrire,
perché perirebbe ciò che è sano e quindi ciò che è, e ciò che non è nascerebbe. 6. E anche per il provar
sofferenza vale lo stesso ragionamento che per il soffrir dolore. 7. E neppure c’è niente di vuoto: perché il
vuoto non è nulla e quindi ciò che non è nulla non può esistere. Né si muove: infatti non ha luogo dove
spostarsi, ma è pieno. Ché se il vuoto esistesse, potrebbe spostarsi nel vuoto, ma non essendovi il vuoto
non ha dove spostarsi. 8. E non può essere né denso né sottile. Il sottile infatti non è possibile che sia pieno nella stessa misura del denso, ma il sottile è già di per se stesso più vuoto del denso. 9. Questa è la distinzione da fare tra pieno e non pieno: se una cosa fa posto a un’altra o la accoglie in sé non è piena; se
non fa posto ad un’altra né l’accoglie in sé è piena. 10. Quindi deve essere pieno se il vuoto non esiste.
Ma se è pieno non si muove [DK 30B7].
ESERCIZIO
• Si elenchino per iscritto i “segni” dell’”essere” melissiano, abbozzandone una giustificazione.
Analogamente a Parmenide, Melisso procede in questo frammento alla dissoluzione delle “illusioni” empiriche, applicando rigorosamente i principi
logici del poema, tuttavia oltre le intenzioni dell’Eleate, che pur al mondo attestato dai sensi non intendeva rinunciare del tutto.
Infinitezza, eternità e unità del primo punto sono state argomentate; il
tutto uguale segue di necessità alla totalità onnicomprensiva, la quale estingue ogni possibilità di discriminazione nell’essere, che comporterebbe
l’implicita accettazione del nulla. Gli altri segni proposti seguono sulla
falsariga: l’ammissione dei tratti tipici della quotidianità significherebbe, anche nel loro caso, il misconoscimento delle proprietà essenziali
dell’essere. Mutamento, qualitativo e quantitativo, e sofferenza sottintendono, secondo Melisso, o processi afferenti direttamente o indirettamente
alla generazione e corruzione, già banditi, o modificazioni tali da metterne in discussione l’unità, identità e uguaglianza.
Nuovamente s’intravede il nucleo logico degli argomenti, quando, in relazione al dolore, Melisso rimarca che l’essere non potrebbe essere tutto se
lo soffrisse. Nulla può, infatti, aggiungersi o alterare l’essere dal “di
fuori”, nessuna mancanza può segnarlo dall’interno: la benché minima crepa
nella sua compattezza lo condannerebbe, nella contraddizione, allo sgretolamento radicale. Posto sul piano degli esseri (presunti, come vedremo meglio più avanti) della nostra esperienza, esso si sarebbe annientato completamente in tutta la durata del tempo. Se, in quanto totalità, l’essere
non può che essere uguale a se stesso (altrimenti ci sarebbe altro a discriminarlo), e rimanere uguale, evidentemente ciò che contraddice tale
tratto essenziale va rifiutato, come incongruente rispetto alla via imboccata.
Tutta l’ultima parte del frammento, dal punto 7 in avanti, si concentra
intorno al problema del movimento. L’immobilità dell’essere è provata in
due direzioni: impossibilità di moto verso l’esterno (spostamento) e impossibilità di movimento interno. In entrambi i casi, fondamentale è
l’equazione, solo implicita in Parmenide, tra nulla e vuoto: l’affermazione
dell’infinità dell’essere era stata, in questo senso, già una garanzia. Ciò
che è nulla non può esistere, quindi non c’è il vuoto. D’altra parte,
l’essere, essendo tutto e uguale, l’abolisce in ogni dimensione, anche in
quella del sottile, che, nei precedenti ionici, avevano svolto un ruolo importante a livello cosmogonico. Melisso riconosceva il vuoto come condizione del movimento: la sua negazione toglieva spazio a un eventuale spostamento, mentre l’esplicitazione della pienezza, comportando il rifiuto di
ogni rarefazione, annullava l’altra possibilità di movimento.
35
6.4 L’essere è uno
1. Questo discorso che abbiamo fatto è la massima prova che esiste soltanto l’uno, ma ne sono prova anche queste cose che ora diciamo. 2. Se infatti esistessero molti esseri, dovrebbero essere così come io dico che è l’uno. Ché se ci fosse la terra e l’acqua e l’aria e il fuoco e il ferro e l’oro, e il vivo e il morto, e il
nero e il bianco e tutte quelle cose che gli uomini dicono essere vere, se dunque queste esistono e noi vediamo e udiamo secondo verità, ognuna di esse dovrà essere necessariamente tale quale ci è parsa la prima volta e non dovrà né cambiare né diventar diversa, ma essere sempre ognuna qual è. Ora noi diciamo
di vedere, di udire e di intendere secondo verità; 3. tuttavia ci sembra che il caldo diventi freddo e il freddo caldo e che il duro diventi molle e il molle duro e ci sembra che il vivo muoia e nasca da ciò che non
vive e che tutte queste cose mutino nella loro natura e che ciò che era non sia uguale a quel che è ora, ma
che per esempio il ferro, che è una cosa dura, si consumi stando a contatto col dito, e così l’oro e la pietra
e tutto ciò che sembra solido, e ci sembra che dall’acqua si generino terra e pietra. Da cui risulta che noi
no vediamo né conosciamo gli esseri nella loro realtà. 4. Infatti benché diciamo che gli esseri sono molti
e che hanno forme e forza eterne, ci sembra poi che tutti mutino nella loro natura e divengano diversi da
come li vediamo ogni volta. 5. E allora è chiaro che non avevamo visto giusto e che quelle cose ci sembrano a torto esser molte; perché se fossero vere non cambierebbero, ma ciascuna di esse sarebbe esattamente tale quale ci sembrava essere. Ché niente è più forte di ciò che è veramente. 6. Ma se è cambiato
allora l’essere è andato perduto ed è nato il non-essere. Così se ci fossero molti esseri, bisognerebbe che
fossero esattamente tal qual è l’uno [DK 30B8].
ESERCIZIO
• Si riproduca per punti l’argomento di Melisso.
Il testo è di grande interesse, sia per il procedimento dicotomico che
sottende (o è uno o è molteplice; ma non può essere molteplice, quindi è
uno), in linea con i precedenti modelli eleatici, sia per l’ipotesi avanzata (molteplicità di esseri), di fatto percorsa in quei decenni centrali del
V secolo da Empedocle e Anassagora. Il senso dovrebbe risultare chiaro.
L’unicità dell’essere si può provare, oltre che attraverso l’analisi della
via che “è”, con la confutazione della tesi opposta, quella che nasce
dall’esperienza sensibile, come Melisso denuncia adeguatamente. Se esistessero molti esseri, questi, per essere tali, dovrebbero manifestare le stesse proprietà essenziali attribuite all’uno, come suoi segni, a partire da
Parmenide. Il molteplice empirico, assunto a conferma (con inclusioni indicative, come i quattro elementi e le coppie polari), dimostra come, invece,
quei presunti esseri siano avvolti nella contraddizione con il nulla, essendo sottoposti a continui processi di trasformazione (con allusione forse
ai frammenti eraclitei). L’esperienza, dunque, inganna; noi c’illudiamo di
cogliere degli enti, che l’analisi logico-ontologica svela in realtà inconsistenti. Quindi l’essere è uno. Anche se l’ipotesi finale poteva costituire spunto per soluzioni alternative.
Dunque se deve essere, bisogna che sia uno; ma essendo uno bisogna che non abbia corpo. Nel caso che avesse uno spessore avrebbe delle parti e quindi non sarebbe più uno [DK 30B9].
L’ultimo frammento che commentiamo introduce un ulteriore elemento di novità, il riconoscimento dell’incorporeità dell’essere. L’argomento, proposto
con
grande
sinteticità,
collega
tale
affermazione
a
quella
dell’unicità. Il corpo implica infatti parti, per il suo spessore, quindi
non si può attribuire a ciò che è intrinsecamente uno. D’altra parte, come
hanno documentato le ricerche di questo secolo, il concetto di corpo era
associato arcaicamente alla figura, al limite, alla forma: l’essere-uno,
nella sua infinità, esclude qualsiasi configurazione, risultando quindi incorporeo anche in questo senso, che, nel contesto, è comunque diverso da
immateriale. Per tale concetto sarà necessario attendere Platone.
7. Dopo Parmenide: Empedocle e Anassagora
36
Concentriamo in questo capitolo l’esame di due pensatori che, pur essendosi formati e avendo operato in ambienti molto diversi, manifestarono convergenze nello sforzo di mediare
tra le istanze logiche nettamente definite da Parmenide e dall’eleatismo, e la tradizione della
cosiddetta filosofia della natura, di matrice ionica. Concluderemo l’argomento, nel prossimo
capitolo, con l’atomismo, dedicandogli uno spazio particolare per la sua profonda incidenza
storica.
Empedocle e Anassagora furono sostanzialmente contemporanei: nati all’inizio del V secolo, rispettivamente a Agrigento (Magna Grecia) e Clazomene (sulla costa dell’Asia Minore,
non lontano da Mileto e Efeso), risentirono probabilmente in modo durevole delle tradizioni
culturali locali, che spinsero, ad esempio, Empedocle al recupero della lezione etico-religiosa
pitagorica, facendone una sorta di sapiente, sacerdote, profeta, oltre che medico e politico.
Anassagora, dal canto suo, divenne proverbiale nell’antichità per il naturalismo che ne avrebbe caratterizzato le espressioni, molto critiche anche nei confronti delle credenze religiose
popolari: cosa che gli guadagnò, verso la fine della sua vita, nell’Atene periclea, un processo
per asebeia (approssimativamente empietà), probabilmente solo un escamotage politico per
colpire indirettamente lo stesso Pericle.
Entrambi i filosofi furono autori di opere pervenuteci solo in modo frammentario, d’altra
parte documentate nella dossografia, nelle ricostruzioni aristoteliche e nei commentari dei
chiosatori di Aristotele. Siamo quindi in grado di delineare con una certa sicurezza i tratti essenziali delle loro posizioni, anche se su alcuni dettagli, anche significativi, esistono discrepanze nelle testimonianze, con conseguenti, marcate, divergenze interpretative (specialmente
nel caso di Anassagora).
Pochi frammenti sono sufficienti per inquadrare lo sfondo teoretico da cui prende le mosse
la riflessione dei due pensatori. Empedocle nel suo poema in esametri, Sulla natura 11 :
Fanciulli: non certo solleciti sono i loro pensieri,
essi che si aspettano che nasca ciò che prima non è
o che qualcosa muoia e si distrugga del tutto [DK 31B11].
Da ciò che infatti non è è impossibile che nasca
ed è cosa irrealizzabile e non udita che l’ente si distrugga;
sempre infatti sarà là, dove uno sempre si poggi [DK 31B12].
Nel tutto nulla vi è di vuoto né di sovrabbondante [DK 31B13].
Nel tutto nulla vi è di vuoto: donde dunque qualcosa potrebbe sopraggiungere? [DK 31B14].
E Anassagora, nella sua omonima opera in prosa:
Del nascere e del perire i Greci non hanno una giusta opinione, perché nessuna cosa nasce né perisce, ma
da cose esistenti ogni cosa si compone e si separa. E così dovrebbero propriamente chiamare il nascere
comporsi, il perire separarsi [DK 59B17].
ESERCIZIO
• Ricercate gli elementi comuni ai frammenti dei due autori, cercando di individuarne il problema di fondo.
Il punto di partenza comune è l’alternativa radicale focalizzata da Parmenide, con i suoi risvolti fisicamente più pregnanti, come la negazione
del vuoto che abbiamo visto avanzata esplicitamente da Melisso. D’altra
parte la dimensione della totalità e del suo equilibrio (l’uguaglianza ele-
11)
Cito da I Presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni e altri, Laterza, Bari, 1983.
37
atica), l'invulnerabilità logica dell’essere costituiscono l’orizzonte in
cui anche Empedocle e Anassagora aprono il proprio discorso. La cui direzione è dato intravedere nell'ultima citazione: approfondendo gli spiragli
aperti da Parmenide, nella seconda parte del suo poema, nei confronti del
mondo dell’apparire debitamente reinterpretato, essi puntarono a sviluppare
i parziali risultati della filosofia della natura precedente, rileggendoli
rigorosamente alla luce delle fondamentali istanze parmenidee, in modo da
giustificare il mondo del divenire in termini più sofisticati di quelli ionici, e da resistere così alla confutazione eleatica (sostanzialmente zenoniana, nel loro caso).
Come? Pur divergendo nell’articolazione e nei dettagli, le due strategie
concordano su alcuni punti essenziali, messi in evidenza nel frammento di
Anassagora:
i) riesumare la problematica del principio e della polarità, al plurale,
per poter più efficacemente dar conto delle sfumature qualitative e
della molteplicità; evitando l’errore dei mortali, condannato, in conclusione della propria rivelazione, dalla dea parmenidea,
ii) rimarcare la consistenza ontologica della pluralità d’elementi necessari a definire il quadro della realtà fenomenica;
iii) ridurre i processi di tale realtà a passaggi solo apparenti, dietro
cui si celano enti stabili come quelli, per assurdo, ipotizzati da Melisso,
iv) attribuendo la responsabilità di tali vicende a forze eterne, ben distinte.
7.1 Le radici di tutte le cose
Così, Empedocle introdusse, per la prima volta contestualmente, i quattro elementi, ponendoli come eterne radici (rizomata) delle cose mortali:
Per prima cosa ascolta che quattro son le radici di tutte le
[cose:
Zeus splendente e Era avvivatrice e Edoneo
e Nesti, che di lacrime distilla la sorgente mortale [DK 31B6].
Ma un’altra cosa ti dirò: non vi è nascita di nessuna delle
[cose
mortali, né fine alcuna di morte funesta,
ma solo c’è mescolanza e separazione di cose mescolate,
ma il nome di nascita, per queste cose, è usato dagli
[uomini [DK 31B8].
Ma come allorché i pittori dipingono le tavolette votive,
uomini ben esperti nella loro arte grazie alla loro sapienza,
i quali, dopo aver preso con le loro mani le tinte multicolori,
armonicamente mescolandole le une in misura maggiore
[le altre in misura minore,
da esse preparano forme simili a tutte le cose,
componendo alberi, uomini, donne, fiere, uccelli e pesci
[che dimorano nell’acqua,
e divinità che vivono a lungo e massimi per il loro onore;
così non lasciare che l’inganno ti prenda la mente che
[altrimenti sia l’origine
degli esseri mortali, i quali in numero infinito sono
[diventati manifesti,
ma chiaramente questo sappi ascoltando la parola che
[viene dalla divinità [DK 31B23].
ESERCIZIO
• Qual è, secondo voi, il senso dell’esempio introdotto (dei pittori)?
38
Come riscontrato anche in Anassagora, il divenire è chiaramente riletto
come aggregazione e disgregazione delle quattro radici divine: fuoco (Zeus), aria (Era), terra (Edoneo) e acqua (Nesti). La combinazione di registri espressivi mitici e argomentativi, già segnalatasi nel poema di Parmenide, rivive in quello di Empedocle, non solo garantendo elevatezza
all’ennesima rivelazione, ma proiettando anche all’interno della disamina
razionale le proprie valenze. In tal modo, utilizzando semplicemente figure
divine, Empedocle assicura ai propri principi, da un lato, i tratti della
physis ionica, dall’altro, alla luce delle esigenze logiche precedentemente
espresse, i segni della stabilità, indefettibilità e immortalità.
Nascita e morte, come nel bozzetto del pittore, si risolvono nel rimescolamento degli elementi, quindi la contraddizione è solo illusoria, dal momento che tutto opera nell’essere. La mescolanza è solo provvisoria,
nell’ambito di un equilibrio complessivo in cui, propriamente, non si potrebbe neppure parlare di diversità, nulla aggiungendosi di nuovo, tutto
essendo eterno. Quelle che Empedocle definisce cose mortali sono, in realtà, di una consistenza diversa da quella che attribuiamo loro sulla scorta
di una superficiale constatazione empirica: ciò che veramente è in loro,
non viene mai meno. Come accidentali combinazioni di colori, esse rinviano
all’irriducibilità di qualità fondamentali.
7.2 Amicizia e Contesa
Duplice cosa dirò: talvolta l’uno si accrebbe ad un unico
[essere
da molte cose, talvolta poi di nuovo ritornarono molte
[da un unico essere.
Duplice è la genesi dei mortali, duplice è la morte:
l’una generata e distrutta dalle unioni di tutte le cose,
l’altra, prodottasi, si dissipa quando di nuovo esse si
[separano.
E queste cose continuamente mutando non cessano mai,
una volta ricongiungendosi tutte nell’uno per l’amicizia,
altra volta portate in direzioni opposte dall’inimicizia della
[Contesa.
Così come l’uno ha appreso a sorgere da più cose
così di nuovo dissolvendosi l’uno ne risultano più cose,
in tal modo esse divengono e la loro vita non è salva;
e come non cessano di mutare continuamente, così sempre
[sono immobili durante il ciclo [DK 31B17 vv.1-12].
Amici sono infatti tutti questi [elementi] delle loro parti,
lo splendore del sole, la terra e il cielo e il mare,
quante di essi negli esseri mortali errano disgiunte.
Così quante sono maggiormente disposte alla mescolanza
reciprocamente si amano rese simili ad opera di Afrodite.
Massimamente nemiche sono invece tutte quelle cose che
[più differiscono tra loro
per generazione, per mescolanza e per forme impresse,
completamente estranee ad ogni unione e il loro dolore
[nasce
dall’ordine imposto dalla Contesa, che dette loro origine [DK 31B22].
A vicenda predominano [gli elementi] nel ciclo ricorrente,
periscono l’uno nell’altro e si accrescono nella vicenda del
[loro destino.
Questi soli, appunto, sono gli elementi, ma, precipitando
[l’uno nell’altro,
nascono gli uomini e le altre stirpi di fiere,
una volta riuniti ad opera dell’amicizia in un solo cosmo,
una volta separati ciascuno per sé ad opera dell’odio della
39
[Contesa,
fino a che essi, combinati insieme in un unico tutto,
[vengono risospinti in basso.
E così, come l’uno ha appreso ormai a nascere dal mol[teplice
e il molteplice, di nuovo, dal dissolversi dell’uno,
in tal modo essi divengono e la loro vita non è salda;
e come non cessano di mutare continuamente, così
[sempre sono immobili durante il ciclo [DK 31B26].
I due frammenti sono di notevole rilevanza sia nello specifico, per fissare la posizione e l’originalità di Empedocle, sia per comprendere in generale l’approccio di questo naturalismo post-parmenideo.
Individuate quattro radici eterne, ridotto il divenire alla loro mescolanza, il filosofo di Agrigento compie il distacco dalle filosofie della
natura ioniche, estraendo dalla loro concezione della physis la dimensione
energetica e ponendola accanto al concentrato sostanziale: abbiamo così gli
elementi e le forze motrici, Amore-Odio, Amicizia-Contesa, secondo i contesti. La polarità s’estrinseca dunque non solo a livello di sostrato materiale (caldo-freddo, secco-umido) ma anche di dinamica. Con una conseguenza
immediata: nei registri mitici omerici e esiodei, trova espressione la teoria del ciclo, risultato dell’alternanza o della tensione delle due forze
psicologiche, proiettate nel cosmo come divine antagoniste.
Due risulterebbero (ma c’è disaccordo tra gli interpreti) le fasi estreme: il dominio di Amore e quello di Odio. Nel primo caso si registrerebbe
l’osmosi totale delle radici nell’uno, lo sfero (con chiara eco parmenidea); nel secondo la loro totale scissione reciproca, con conseguente concentrazione degli elementi in aree omogenee. Le fasi intermedie sarebbero, evidentemente, quelle in cui si stemperano le associazioni e dissociazioni
estreme: le fasi delle molteplici unità, diversificate qualitativamente,
cui appartiene il nostro mondo.
Questo modello, probabile rielaborazione del Polemos eracliteo, impone,
con la ripetizione, anche la stabilità e l’immutabilità globale, ritmando
la vita dell’intero (perché, certamente, ancora di vitalismo si tratta, con
tanto di sottofondo sessuale) con la concentrazione a unità, attraverso Amicizia, e la frantumazione nella pluralità, per opera di Discordia. Come
si evince dall’ultima citazione, questa alterna vicenda dell’intero è proposta ormai, con una terminologia ritagliata sui paradossi zenoniani, come
passaggio dall’uno al molteplice e viceversa, nell’immobilità (necessità
immutabile) del ciclo. Non solo: l’attività attrattiva e repulsiva, innescata dalle due eterne forze polari, è alla base anche dei processi microscopici che legano intrinsecamente ogni frammento dell’universo, giustificando la stessa possibilità di penetrazione gnoseologica della realtà:
Sapendo che vi sono effluvi di tutte le cose, quante
[nascono... [DK 31B89].
Così il dolce afferra il dolce, l’amore si slanciò verso
[l’amore
l’acido andò all’acido e l’ardente era attratto verso l’ardente [DK 31B90].
Da questi elementi tutte le cose risultano connesse e
[armonizzate
e per essi pensano, godono e soffrono [DK 31B107].
Con la terra infatti vediamo la terra, l’acqua con l’acqua,
con l’aria l’aria divina, e poi col fuoco il fuoco distruttore,
con l’amore l’amore e la contesa con la contesa funesta [DK 31B109].
La combinazione della tensione agglutinante e di quella discriminante induce nella natura una pulsione del simile verso il simile, che, nel caso
40
dell’uomo, come indica l’ultimo frammento, è a fondamento delle stesse possibilità conoscitive. Il sangue, infatti, equilibrata miscela delle quattro
radici, raccogliendo, attraverso i pori, gli effluvi che scorrono da ogni
cosa in virtù di quell’attrazione, e concentrandoli nel cuore, è in grado
di decifrarne le componenti ultime. Tutto, in fondo, è sensibilizzato in
questo fluire: l’animazione ionica è rilanciata sulla scorta di un modello
più articolato, ma sempre vincolato all’analogia dell’organismo, micro- e
macrocosmico.
Si rivela, dunque, problematico inserire, in questa prospettiva naturalistica, l’argomento religioso dell’altra grande opera di Empedocle, le Purificazioni, chiaramente ispirata alla tradizione orfica, per quel che riguarda l’idea della colpa originaria e l’esigenza d’espiazione, e a quella
pitagorica per il primato della catarsi intellettuale e per la più sofisticata concezione della trasmigrazione delle anime, in una serie di cicli di
reincarnazione, destinati, infine, a liberare il daimon (anima-demone) e a
riunirlo al divino.
7.3 Tutto in tutto
L’intenzionale sfida di Anassagora, nel suo ponderoso (e forse unico) scritto Sulla natura,
doveva essere evidente sin dall’apertura:
Insieme erano tutte le cose, illimiti per quantità e per piccolezza, perché anche il piccolo era illimite. E
stando tutte insieme, nessuna era discernibile a causa della piccolezza: su tutte predominava l’aria e
l’etere, essendo entrambi illimiti: sono infatti queste nella massa totale le più grandi per quantità e per
grandezza [DK 59B1].
In effetti del piccolo non c’è minimo ma sempre un più piccolo (è impossibile in realtà che ciò che è non
sia) - ma anche del grande c’è sempre un più grande: e per quantità è uguale al piccolo e in rapporto a se
stessa ogni cosa è e grande e piccola [DK 59B2].
L’autore scende sul terreno delle presunte contraddizioni del molteplice
empirico rilevate da Zenone, accettandone l’assurda relatività e l'infinitizzazione, con cui, a suo modo di vedere, era possibile in ogni caso convivere logicamente. La sua proposta - a dire il vero, secondo alcuni interpreti, non sempre argomentata -, esasperando il pluralismo empedocleo, faceva appunto leva sulla difficoltà zenoniana (divisibilità illimitata
dell’esteso), nella misura in cui individuava nell’infinità di eterni elementi qualitativi le uniche basi solide per rovesciare la contraddizione
del divenire, riassorbendo nel seno dell’essere ogni apparente divenire.
Riproducendo lo stesso schema dell’agrigentino, Anassagora poneva in origine una sorta di totale, infinita mescolanza di qualità, assolutamente indiscernibili nell’osmosi reciproca, fatta eccezione per il predominio di
aria e etere, elementi quantitativamente “più infiniti” degli altri. Tale
osmosi era garanzia di irriducibilità qualitativa e quantitativa: non sarebbe stato, in altre parole, possibile identificarle individualmente, né
raggiungere un minimo atomico (indivisibile):
Stando così, bisogna supporre che in tutti gli aggregati ci siano molte cose e di ogni genere e semi di tutte
le cose aventi forme d’ogni sorta e colori e sapori. [...]
Prima che queste cose si separassero, essendo tutte insieme, nessun colore era discernibile: lo proibiva la
mescolanza di tutte le cose, dell’umido e del secco, del caldo e del freddo, del luminoso e dell’oscuro, e
della terra molta che c’era e dei semi illimiti per quantità e in niente simili l’uno all’altro. Perché neppure
delle altre cose l’una è simile all’altra. Stando questo così, bisogna supporre che nel tutto ci siano tutte le
cose [DK 59B4].
[...] Sembra che Anassagora ritenga infiniti [gli omeomeri] perché accettava come vera la dottrina comune dei naturalisti, che niente nasce dal niente: per questo dice: <<Insieme erano tutte le cose>> e stabilisce che il venire all’esistenza di tale o tale genere di cose è un’alterazione, mentre altri parlano di unione
e di separazione. Altro motivo era che gli opposti si producono l’uno dall’altro e dunque vi erano contenuti in precedenza. Se infatti tutto quel che si produce deve prodursi o da ciò che è o da ciò che non è, ed
41
è impossibile che sia prodotto dal non essere (su questo punto tutti i naturalisti sono d’accordo), pensarono che di necessità era vera l’altra parte dell’alternativa, che cioè fosse prodotto da esseri e da esseri preesistenti, inattingibili, però, dai nostri sensi per la piccolezza delle masse. Pertanto essi affermano che tutto è mischiato in tutto perché vedevano che ogni cosa è prodotta da ogni cosa. Ma le cose appaiono differenti e i loro nomi cambiano in rapporto a ciò che per quantità prevale nella mistione degli illimiti: non
c’è, però, nessuna cosa che sia assolutamente tutta bianca o nera o dolce o carne o osso, ma ciò di cui ciascuna cosa contiene di più, questa appare essere la sua natura [DK 59A52].
La miscela originaria, avendo comportato una concentrazione qualitativa,
segnava ogni successivo processo di discriminazione, in cui si conservava,
alla radice, quella reciproca compenetrazione del tutto con il tutto, che
era il corrispettivo anassagoreo dell’universale simpatia pitagorica, e
della pienezza d’essere eleatica. Incrociando l’infinita divisibilità e
l’indiscernibilità qualitativa, Anassagora otteneva un effetto prospettico
in cui il punto di fuga era rappresentato, probabilmente, da quel che egli
chiamava seme (sperma).
La discussione tra gli interpreti su questo punto è ancora aperta, dal
momento che i frammenti hanno subito parafrasi da parte di Aristotele e dei
suoi commentatori, che ne hanno modificato l’impianto lessicale, introducendo termini tecnici (omeomerie, particelle qualitativamente omogenee)
difficilmente ascrivibili al filosofo di Clazomene. Tali semi, presumibilmente individuatisi dalla originaria miscela nelle prime fasi del processo
cosmogonico, dovevano conservarne la densità qualitativa, qualificandosi
per le porzioni prevalenti degli infinitesimi ingredienti. Nelle successive
vicende cosmogoniche, spettava loro la funzione di elementi base per le ulteriori aggregazioni.
Al di là di questa paradossale regressione all’infinito, che Anassagora,
a dispetto delle scomuniche zenoniane, accettava e sfruttava sapientemente
per liberare il divenire dalla contraddizione del passaggio dall’essere al
nulla, quel che colpisce in questi frammenti è la forte sottolineatura qualitativa, unica nel panorama della filosofia presofista. Solo ammettendo la
latenza di ogni qualità in ogni ente, sempre qualitativamente determinato
dalla porzione predominante dei semi infiniti in cui è incessantemente divisibile, era possibile giustificare le mutazioni continue senza contravvenire alle vie parmenidee.
7.4 Il Nous
In ogni cosa c’è parte di ogni cosa, ad eccezione dell’intelletto: ma ci sono cose nelle quali c’è anche
l’intelletto [DK 59B11]
Tutte le altre cose hanno parte a tutto, mentre l’intelletto è alcunché di illimite e di autocrate e a nessuna
cosa è mischiato, ma è solo, lui in se stesso. Se non fosse in se stesso, ma fosse mescolato a qualcos’altro,
parteciperebbe di tutte le cose, se fosse mescolato a una qualunque. Perché in ogni cosa c’è parte di ogni
cosa, come ho già detto in quel che precede: le cose commiste ad esso l’impedirebbero di modo che non
avrebbe potere su nessuna cosa come l’ha quand’è solo in se stesso. Perché è la più sottile di tutte le cose
e la più pura: ha cognizione completa di tutto e il più grande dominio e di quante cose hanno vita, quelle
maggiori e quelle minori, su tutte ha potere l’intelletto. E sull’intera rivoluzione l’intelletto ebbe potere sì
da avviarne l’inizio. E dapprima ha dato inizio a tale rivolgimento dal piccolo, poi la rivoluzione diventa
più grande e diventerà più grande. E le cose che si mescolano insieme e si separano e si dividono, tutte
l’intelletto ha conosciuto. E qualunque cosa doveva essere e qualunque fu che ora non è, e quante adesso
sono e qualunque altra sarà, tutte l’intelletto ha ordinato, anche questa rotazione, in cui si rivolgono adesso gli astri, il sole, la luna, l’aria, l’etere che si vengono separando. Proprio questa rivoluzione li ha fatti
separare e dal raro per separazione si forma il denso, dal freddo il caldo, dall’oscuro il luminoso,
dall’umido il secco. In realtà molte cose hanno parte a molte cose. Ma nessuna si separa o si divide del
tutto, l’una dall’altra, ad eccezione dell’intelletto. L’intelletto è tutto uguale, quello più grande e quello
più piccolo. Nessun’altra cosa è simile ad altra, ma ognuna è ed era le cose più appariscenti che in essa
sono in misura massima [DK 59B12]
Dopoché l’intelletto dette inizio al movimento, dal tutto che era mosso cominciavano a formarsi le cose
per separazione, e quel che l’intelletto aveva messo in movimento, tutto si divise. E la rotazione di quanto
era mosso e separato accresceva di molto il processo di separazione [DK 59B13].
42
ESERCIZIO
• Ricercate i caratteri che definiscono il “Nous” e la sua funzione nei due frammenti anassagorei.
Il contenuto cosmogonico dei frammenti è chiaro: ribadendo lo schema empedocleo e forse i modelli ionici, Anassagora delinea uno svolgimento che
ha nel tutto infinito e indifferenziato (l’apeiron anassimandreo) il suo
punto di partenza, e nella progressiva azione di un “motore” la sua forza
discriminante. Con alcuni rilevanti sviluppi: l’affermazione di un processo
aperto, irreversibile, alternativo a quello ciclico (esplicito anche nelle
scelte dei tempi verbali), e, soprattutto, la novità dell’introduzione di
una forza motrice intelligente, il nous.
Anassagora compie ogni sforzo per determinare questo nuovo principio,
mantenendolo distinto dalle qualità che potremmo definire materiali: lo
connota come apeiron e autokrates, ne rimarca l’“inseità”, per rilevare lo
scarto rispetto alla relatività delle altre cose. Ne fa, insomma, una sorta
di divinità, versione razionalizzata di quelle che popolavano le raffigurazioni teogoniche. Eppure, per precisarne la natura, l’autore non può che
ricorrere a un predicato sostanzialmente materiale come sottile, di sapore
ionico (Anassimene). Il ruolo che gli viene attribuito nei frammenti pervenutici è, appunto, rigorosamente dinamico, anche se, per analogia forse con
l’apeiron di Anassimandro (che “abbracciava” e “guidava” tutte le cose), il
movimento introdotto nella compatta miscela originaria non è estraneo a un
disegno ordinatore (come rivelerebbe l’impiego del verbo diakosmein, d’uso
omerico per designare l’organizzazione dell’esercito da parte di un comandante), sebbene le critiche di Platone e Aristotele sembrino smentire tale
interpretazione.
L’effetto cosmogonico del nous è un vortice locale, capace d’innescare la
disgregazione dell’intero originario attraverso l’emergenza delle polarità
fondamentali (da intendere sempre mescolate a tutte le altre qualità). Ai
primi svolgimenti fanno seguito i loro ulteriori effetti, in una progressiva articolazione lineare. Punto fermo di tutto il discorso anassagoreo è
comunque che tutto ciò che fu, è e sarà (a dispetto di Parmenide) era già
nell’originaria mescolanza, a scongiurare la contraddizione del divenire
dal nulla.
Un dato ulteriore può essere in conclusione segnalato a proposito dell'intelletto: pur separato per conservarne la dignità e il potere
d’indirizzo, lo si riconosce parte in alcune cose. Tenendo conto che la capacità discriminante attribuitagli è anche di carattere gnoseologico (individuare le componenti originarie della mescolanza), è possibile che tale
partecipazione fosse contemplata per assicurare agli esseri intelligenti la
possibilità di ricostruire il quadro della realtà, altrimenti affidato alle
incertezze dei sensi, condannati a cogliere solo l’aspetto fenomenico di
quanto non appare sensibilmente:
le parvenze fenomeniche, infatti, sono l’aspetto visibile delle cose non appariscenti [DK 59B21.a].
8. Dopo Parmenide: Democrito e l’atomismo antico
Con Democrito, nato a Abdera, sulla costa nord-orientale della Grecia, intorno al 460 a.C.
e probabilmente vissuto circa cent’anni, si chiude il nostro esame delle origini della filosofia
occidentale. In effetti Democrito è giovane contemporaneo degli ultimi autori studiati, Empedocle, Anassagora e Melisso; sarà anziano contemporaneo di Platone, collocandosi in tal modo a cavaliere di due secoli fondamentali per la storia del pensiero greco e chiudendone, rispetto alla svolta platonica, una pagina. D’altro canto il suo grande contributo registrerà una
significativa ripresa, a pochi decenni dalla morte, da parte di Epicuro, segnando, di conseguenza, una tradizione che giunge al XVI e XVII secolo. Per molti versi la sua figura appartiene alla stagione culturale aperta dal poema parmenideo, come quelle di Empedocle e Anassagora, ma l’originalità delle soluzioni adottate gli garantiscono una posizione particolare:
43
non a caso, pur essendo di gran lunga l’autore preplatonico più prolifico dal punto di vista letterario, la sua produzione, organizzata nell’antichità in tredici tetralogie, e disponibile fino ai
primi secoli dell’era volgare, fu in seguito boicottata dalla patristica e dalla scolastica cristiana, per il rigoroso naturalismo che la contraddistingueva, giungendoci solo molto frammentata.
Pare che Democrito maturasse il proprio “atomismo” alla scuola di Leucippo, a sua volta
forse direttamente collegato a Elea (qualcuno addirittura lo vuole discepolo di Zenone), anche
se i contorni storici del personaggio sono per noi sfuggenti.
8.1 Il confronto con l’eleatismo: la conoscenza
Nei frammenti conservati è possibile avvertire la continuità e la rivoluzionaria frattura rispetto alla lezione eleatica 12 :
L’uomo deve rendersi conto, per mezzo del presente criterio, ch’egli è [per effetto delle apparenze sensibili] tenuto lontano dalla verità [DK 68B6].
Anche questa considerazione appunto dimostra che noi non sappiamo nulla conforme a verità intorno a
nessuna cosa, ma che l’opinione è in ciascuno [una sorta di] nuova configurazione [DK 68B7].
E pertanto sarà manifesto che vi è grande difficoltà a conoscere conforme a verità come sia costituito ogni oggetto [DK 68B8].
Democrito talora rifiuta le apparenze sensibili e dice che nulla in esse ci appare conforme a verità, ma solo conforme a opinione, e che il vero negli oggetti consiste in ciò ch’essi sono atomi e vuoto. Infatti egli
dice:
Opinione il dolce, opinione l’amaro, opinione il caldo, opinione il freddo, opinione il colore; verità gli atomi e il vuoto;
vale a dire: si ritiene e si opina che esistano le qualità sensibili, ma in verità non esistono queste, sibbene
gli atomi e il vuoto. Nei Libri probativi, poi, benché avesse promesso di attribuire valore di credibilità alle sensazioni, nulladimeno si trova che egli condanna queste. Dice infatti:
Noi in realtà non conosciamo nulla che sia invariabile, ma solo aspetti mutevoli secondo la disposizione
del nostro corpo e di ciò che penetra in esso o gli resiste [DK 68B9].
ESERCIZIO
• Ricercate nei frammenti e nella testimonianza le ragioni per cui, secondo Democrito, l’uomo è tenuto
“lontano dalla verità”.
Democrito sembra condividere la preoccupazione, largamente avvertita negli autori precedenti, per l’instabilità del dato empirico: analogamente ai
seguaci di Parmenide, egli stigmatizza l’inaffidabilità dei sensi e quindi
l’opinabilità degli esiti immediati dell’esperienza. Empedocle e specialmente Anassagora avevano, a loro volta, assunto un atteggiamento guardingo
o critico, mantenendosi in ogni caso, per ragioni strategiche, all’interno
di un orizzonte qualitativo, desumibile dall’esperienza (semi e radici rappresentavano la purezza di un tratto qualitativo). Democrito, schierandosi,
sostanzialmente, per quella strategia, strappa decisamente quell’orizzonte,
come risulta evidente dall’ultima citazione (per la quale dobbiamo essere
grati, come per le altre precedenti, allo scettico Sesto Empirico, II-III
secolo d.C.), nella quale si contesta puntualmente la fondatezza delle contrarietà (caldo e freddo) su cui era stata costruita la teoria degli elementi empedoclei, insieme con le più comuni impressioni qualitative. A ciò
che è accolto per superficiale consenso, ma non garantisce la stabilità canonica dell’essere, è contrapposta la verità dei principi: atomi (letteral12)
Cito dall’edizione laterziana a cura di G.Giannantoni e altri cit.. Sottolineature mie.
44
mente: indivisibili) e vuoto. È interessante aggiungere, a completamento
della riflessione gnoseologica introdotta, un’ulteriore testimonianza:
Nei Canoni afferma che vi sono due modi di conoscenza, cioè mediante i sensi e mediante l’intelletto: e
chiama genuina la conoscenza mediante l’intelletto, riconoscendo ad essa la credibilità nel giudicare del
vero, mentre all’altra dà il nome di oscura, negandole la sicurezza nel conoscere il vero. Dice testualmente:
Vi sono due forme di conoscenza, l’una genuina e l’altra oscura; e a quella oscura appartengono tutti
quanti questi oggetti: vista, udito, odorato, gusto e tatto. L’altra forma è la genuina, e gli oggetti di questa
sono nascosti [alla conoscenza sensibile ed oscura].
Poscia, mostrando la superiorità della conoscenza genuina su quell’oscura, prosegue dicendo:
Quando la conoscenza oscura non può più spingersi ad oggetto più piccolo né col vedere né coll’udire né
coll’odorato né col gusto né con la sensazione del tatto, ma si deve indirizzar la ricerca a ciò che è ancor
più sottile, allora soccorre la conoscenza genuina, come quella che possiede appunto un organo più fine,
appropriato al pensare [DK 68B11].
ESERCIZIO
• Individuate le caratteristiche che contraddistinguono le due forme di conoscenza, secondo Democrito.
Il commento di Sesto Empirico traduce l’opposizione conoscenza oscura e
conoscenza genuina in un linguaggio che sicuramente risente del corso posteriore della storia del pensiero; sono in ogni modo chiari il senso della
distinzione, e, credo, anche la sua sfocatura riguardo alla conoscenza mediante intelletto. L’oggetto della prima è manifesto ai sensi, quello della
seconda è nascosto; la conoscenza genuina, in virtù di un organo più fine,
è in grado di cogliere ciò che è più sottile e sfugge alla ricognizione
sensibile. Dal contesto generale di queste testimonianze è evidente lo
scarto tra ciò che è manifesto agli organi di senso e ciò che invece si dischiude al pensiero: nel primo caso si pone l’accento ripetutamente sulla
dimensione qualitativa, nel secondo ci si premura di rimarcare particolarmente la latenza (analogamente a Anassagora) rispetto a ciò che qualifica
(i sensi). Tenendo conto della precedente contrapposizione tra opinione
(convenzione) e verità, si deve riscontrare dunque la consistenza solo convenzionale del dato empirico, e la direzione veritativa del disvelamento
del più sottile (gli atomi).
8.2 Il confronto con l’eleatismo: atomi e mondi
Democrito ritiene che la materia di ciò che è eterno consiste in piccole sostanze infinite di numero; e suppone che queste siano contenute in altro spazio, infinito per grandezza; e chiama lo spazio coi nomi di
<<vuoto>> e di <<niente>>, mentre dà a ciascuna delle sostanze il nome di <<ente>> e di <<solido>> e
di <<essere>>. Egli reputa che le sostanze siano così piccole da sfuggire ai nostri sensi; e che esse presentino ogni genere di figure [e forme] e differenze di grandezza. Da queste sostanze, dunque, in quanto
egli le considera come elementi, fa derivare e combinarsi per aggregazione i volumi visibili e in generale
percettibili. Esse lottano e si muovono nel vuoto, a causa della loro diseguaglianza e delle altre differenze
ricordate, e nel muoversi s’incontrano e si legano in un collegamento tale che le obbliga a venire in contatto reciproco e a restare contigue, ma non produce però con esse veramente una qualsiasi natura unica:
perché è certamente un’assurdità pensare che due o più possano mai divenire uno. Del fatto che le sostanze rimangono in contatto tra di loro per un certo tempo, egli dà la causa ai collegamenti e alle capacità di
adesione degli atomi: alcuni di questi, infatti, sono irregolari, altri uncinati, altri concavi, altri convessi,
altri differenti in innumerevoli altri modi; ed egli reputa dunque che gli atomi si tengano attaccati gli uni
agli altri e rimangano in contatto fino a quando, col sopraggiungere di qualche azione esterna, una necessità più forte non li scuota violentemente e li disperda in varie direzioni.
Ed attribuisce il nascere ed il suo contrario, il disgregarsi, non soltanto agli animali, ma anche alle piante
e ai mondi, insomma a tutti quanti gli oggetti sensibili. Se dunque il nascere è aggregazione di atomi e il
dissolversi è disgregazione, anche per Democrito il divenire non è che modificazione di stato [DK
68A37].
ESERCIZIO
• Qual è la funzione attribuita nel testo alla struttura degli atomi?
• Abbozzate una spiegazione dell’equazione proposta tra “atomo” e ”essere”, e “vuoto” e “non-essere”.
45
Questa testimonianza di Simplicio, che a sua volta cita da un’opera perduta che Aristotele aveva dedicato al suo conterraneo (Su Democrito), consente un’immediata verifica ontologica delle posizioni gnoseologiche riscontrate. Democrito avrebbe sostenuto una tesi pluralistica che individuava l’essere nei solidi (probabilmente perché indivisibili, atomi appunto),
dinamicamente correlati nel vuoto, equiparato, provocatoriamente, al niente. Nel momento in cui degli enti si rilevava, come tratto specifico, la
solidità (l’indivisibilità e pienezza), ciò in cui essi si muovevano, per
aggregarsi e disgregarsi giustificando le configurazioni percettibili e il
loro divenire, doveva necessariamente connotarsi come non-pieno: designato
il pieno come ente, il non-pieno poteva (certamente in polemica) essere definito non-ente.
Tuttavia non deve sfuggire, dietro la provocazione, la logica, sostanzialmente eleatica, della posizione attribuita a Democrito. Nonostante il
diniego
di
Empedocle
e
Anassagora,
sembrava
infatti
legittima
l’osservazione esplicita di Melisso circa la necessità del vuoto come condizione del movimento, specialmente con l’abbandono del punto di vista della mescolanza qualitativa. D’altra parte l’ammissione del vuoto andava nella direzione di un razionale recupero del mondo dell’apparire, inserendosi
in un modello esplicativo totale capace di superare le contraddizioni del
divenire, mantenendo complessivamente i segni dell’essere eleatico: compattezza, uniformità, eternità dell’atomo, omogeneità dell’universo (to pan),
in cui si risolvevano tutte le distinzioni gerarchiche di tipo qualitativo
(si leggano le ultime righe della testimonianza).
Il mondo dell’esperienza è dunque manifestazione del nascosto, come accadeva in Anassagora, con la fondamentale differenza che i caratteri di tali
infiniti solidi sono geometrici e le loro conglomerazioni puramente meccaniche.
Infiniti
atomi
in
moto
nel
vuoto
infinito,
a
motivo,
nell’interpretazione di Aristotele, dell’intrinseco squilibrio delle loro
forme e figure (ma la causa ultima del loro movimento rimane incerta nelle
testimonianze). I corpi che percepiamo risultano dalla saldatura momentanea
di tali elementi, la loro conformazione dalla struttura geometrica di quelli, le loro qualità dall’effetto di quelle strutture sui nostri organi sensoriali. Il passaggio dagli atomi alle loro aggregazioni non era legato in
Democrito, come negli immediati predecessori, all’azione di un agente esterno, ma alle necessarie, meccaniche conseguenze del casuale scontro atomico, contro l’assunto di un disegno ordinatore.
Analogamente, anche il suo [di Leucippo] discepolo Democrito di Abdera pose come principio il pieno e
il vuoto, chiamando essere il primo e l’altro non essere: essi, infatti, considerando gli atomi come materia
dei corpi, fanno derivare tutte le altre cose dalle differenze degli atomi stessi. Le differenze sono: misura,
direzione, contatto reciproco, che è quanto dire forma, posizione e ordine. Essi ritengono infatti che per
natura il simile è posto in movimento dal simile e che le cose congeneri sono portate le une verso le altre
e che ciascuna delle forme, andando a disporsi in un altro complesso, produce un altro ordinamento; di
modo che essi, partendo dall’ipotesi che i principi sono infiniti di numero, promettevano di spiegare in
modo razionale le modificazioni e le sostanze e da che cosa e come si generano i corpi; perciò essi anche
dicono che soltanto per coloro che considerano infiniti gli elementi tutto si svolge in modo conforme a
ragione [...] [DK 68A38].
Questa nuova testimonianza di Simplicio fissa efficacemente il quadro ontologico della proposta atomistica: il pieno, indivisibile proprio in virtù
di
quella
pienezza
che
riproduce,
nel
frammento,
l’indivisibilità
dell’essere parmenideo, e il vuoto (non-pieno); le differenze geometriche
degli atomi e la meccanica delle loro relazioni reciproche nel vuoto. Gli
elementi ultimi, irriducibili e impercettibili, del processo d’analisi della realtà fenomenica le assicuravano trasparenza razionale, nella misura in
cui tutto poteva prospettarsi come effetto della combinazione meccanica.
L’attrazione del simile, che in Empedocle era vincolata rigorosamente
all’orizzonte qualitativo grazie al gioco di Amicizia e Discordia sulle radici, è riformulata in termini di causalità efficiente. L’omogeneità in
precedenza segnalata comportava, nell’infinito, l’assenza di luoghi privilegiati e quindi l’infinità dei mondi: non essendoci ragione per avanzare
46
un processo cosmogonico in una regione dello spazio piuttosto che in
un’altra,
si
concludeva
con
la
contemporaneità
di
tali
processi
nell’infinito, e con la loro successione nella vicissitudine eterna degli
atomi.
(44) Le sue dottrine sono queste: principi di tutte le cose sono gli atomi e il vuoto, e tutto il resto è opinione soggettiva; vi sono infiniti mondi, i quali sono generati e corruttibili; nulla viene dal non essere,
nulla può perire e dissolversi nel non essere. E gli atomi sono infiniti sotto il rispetto della grandezza e
del numero, e si muovono nell’universo aggirandosi vorticosamente e in tal modo generano tutti i composti, fuoco, acqua, aria, terra; poiché anche questi sono dei complessi di certi particolari atomi: i quali invece non sono né scomponibili né alterabili appunto per la loro solidità. Il sole e la luna sono pure composti di tali atomi, [di quelli cioè] lisci e rotondi; e ugualmente l’anima, che è tutt’uno con l’intelletto.
Noi vediamo per effetto degli idoli che penetrano nei nostri occhi. (45) Tutto si produce conforme a necessità, poiché la causa della formazione di tutte le cose è quel movimento vorticoso che egli chiama appunto necessità. Il fine supremo della vita è la tranquillità dell’animo [euqumia], che non è la medesima
cosa del piacere, come credevano certuni che avevano frainteso, bensì quello stato in cui l’animo è calmo
ed equilibrato, non turbato da paura alcuna o da superstizioso timore degli dei o da qualsiasi altra passione. A tale stato dell’anima egli dà il nome di benessere e parecchie altre denominazioni. Le qualità sensibili sono puramente soggettive [nomw], in realtà [fusiς] esistono solo atomi e vuoto [...] [DK 68A1].
Quest’estratto dall’opera dossografica di Diogene Laerzio, che intende
sinteticamente concentrare i tratti salienti della dottrina democritea, è
sufficiente per rilevare l’articolazione e l’ampiezza della prospettiva atomistica. Essa abbraccia non solo le problematiche cosmologiche e gnoseologiche, ma, approfondendo il lavoro già compiuto da Empedocle e Anassagora, anche quelle antropologiche e etiche.
Esaltata la matrice eleatica sui generis della teoria, in questo caso,
sia con la ripresa delle proibizioni parmenidee (prime tre righe), sia nella dicotomia tra fluidità delle aggregazioni atomiche nelle vicende cosmiche, e inalterabilità degli atomi, Diogene indica tre istanze fondamentali.
i) Quella
gnoseologica,
per
cui
si
ribadisce
la
soggettività
dell’esperienza sensibile, giustificandola sulla scorta del meccanismo delle particelle: sottili pellicole atomiche, staccandosi continuamente dagli
aggregati e raggiungendo gli organi di senso predisposti a accoglierle, ne
modificano lo stato momentaneo venendo così registrate. La sensazione risulterebbe dunque da un processo di contatti e alterazioni (superficie del
corpo percepito, mezzo e superficie dell’organo), irrimediabilmente destinati a segnarne l’adeguatezza.
ii) Quella “psicologica”, che individua in un particolare tipo di atomi,
associabili alla luminosità e al calore per la loro scorrevolezza, la componente elementare dell’anima, qui esplicitamente fatta coincidere con la
facoltà conoscitiva eminente, ma probabilmente destinata, con la propria
mobilità e vivacità, a scorrere all’interno dell’involucro corporeo esterno, raccogliendo le modificazioni sensoriali e elaborandole.
iii) Quella etica, conseguente alla totale immersione dell’uomo nei destini
della
vicissitudine
cosmica:
valore
privilegiato
è
quello
dell’equilibrio, in linea con la tradizione, per certi versi, d’altra parte
perfettamente inquadrabile nella logica dei ricambi atomici, che non possono non investire anche l’anima.
Il tutto rigorosamente (e problematicamente, almeno per quanto riguarda
l’ultimo punto) inquadrato sullo sfondo della necessità meccanica, innescata dal moto vorticoso prodotto originariamente dai conflitti atomici.
9. Conclusione
Il segreto che Popper riscontrò alla radice dello splendido racconto dell’antica filosofia
greca coincide con quella che egli definisce la tradizione della discussione critica 13 , in altre
parole con quell’esercizio razionale di libera valutazione e confutazione delle teorie che avrebbe comportato la rottura con la tradizione dogmatica degli insegnamenti religiosi e teogonici. A parte il caso, sostanzialmente isolato del pitagorismo, la filosofia greca si sarebbe
13
) K.R. Popper op.cit. p.257.
47
insomma caratterizzata per l’apertura alla pluralità di dottrine, tutte miranti al perseguimento
della verità attraverso il confronto.
La nostra ricostruzione ha parzialmente confermato questo quadro. Essa, in particolare, ha
rilevato:
1. l’indiscutibile incidenza del dialogo tra filosofia e mito, e il relativo scarto strutturale,
2. il costante richiamo reciproco tra le posizioni dei maggiori pensatori,
3. la permanenza al centro del confronto di un nucleo di problemi, in primis quello del divenire (l’interesse cosmologico di cui parla il filosofo austriaco),
4. l’intreccio tra razionalità dialettica e razionalità deduttiva (nel caso dell’eleatismo).
Abbiamo poi cercato di sottolineare le permanenze dogmatiche, e soprattutto di insistere
non tanto sull’esemplarità critica della razionalità elaborata nella riflessione greca del VI-V
secolo, ma sul suo sforzo di costituirsi appunto come razionalità, attraverso la pratica della
riduzione al principio, la formalizzazione del modello della polarità, la consapevole focalizzazione della proibizione della contraddizione. In questo, a nostro avviso, risiede il contributo
maggiore di quella stagione di pensiero.
48
Lessico
Anima
Il termine psyché, reso impropriamente con anima, indicava originariamente (in Omero, ad esempio) il soffio vitale che si esalava con la morte, ma anche il fantasma che sopravviveva alla morte,
depotenziato, nell’Ade. Nell’orfismo psyché designa il demone imprigionato nel corpo per espiare
la colpa originaria. Nella riflessione filosofica arcaica l’anima è da un lato associata alla physis,
come principio generatore e motore intrinseco, dall’altro, a partire almeno da Eraclito,
all’intelligenza. Nel pitagorismo ritroviamo implicite nell’uso del termine sia le esigenze escatologiche della tradizione orfica, sia quelle intellettuali e speculative.
Apparenza
I termini doxa, ta dokounta, phainomenon possono essere resi con apparenza, distinguendone
comunque due distinte accezioni: una negativa, in cui apparenza significa sostanzialmente una
copertura, una velatura della vera realtà (si tratta di un’accezione ampiamente presente negli autori
studiati, specialmente in seno all’eleatismo); una positiva, in cui l’apparire è il manifestarsi stesso
dell’essere, come abbiamo riscontrato nella nostra interpretazione di Parmenide.
Armonia
Il termine presenta diverse valenze nella cultura greca arcaica, rivelandosi uno dei più pregnanti.
Da un punto di vista filosofico esso designa per un verso la struttura misurata della realtà (Eraclito, pitagorismo), decifrabile razionalmente; per altro l’equilibrio dell’anima, inscritto nell’ordine
del tutto e quindi vincolato alla sua contemplazione (pitagorismo).
Atomo
Il termine significa letteralmente indivisibile, e designa in Leucippo e Democrito gli elementi irriducibili della realtà, gli enti semplici, impercettibili cui devono essere, logicamente e ontologicamente, ridotti i composti. La ragione della loro indivisibilità era rintracciata nella pienezza, secondo un modello probabilmente mutuato dall’eleatismo.
Confutazione
Il termine elenchos designa, nell’ambito della riflessione filosofica arcaica, un momento del confronto dialettico tra sapienti: quello, in particolare, in cui si denuncia l’insostenibilità della tesi
dell’avversario, mostrandola in contraddizione con se stessa ovvero rilevando la contraddizione tra
le sue conclusioni e alcuni dei presupposti, impliciti o espliciti, dell’argomentazione.
Cosmo
Il termine kosmos indicava in origine ordine, e passò a significare mondo per il contributo sostanziale dei Pitagorici, che riscontravano nella realtà appunto l’impronta del numero e dell’armonia.
Anche la concezione anassagorea del Nous rafforzò probabilmente questa significazione del termine, accennando in particolare all’idea di un disegno intelligente nella natura.
Cosmogonia
Il termine, derivato da kosmos (ordine, mondo) e goné (generazione), indica la dottrina relativa al
processo di formazione di tutto ciò che esiste. A volte esso viene impiegato in contrapposizione a
cosmologia, per individuare un approccio al problema dell’origine del mondo affidato a credenze
mitico-religiose, differente quindi dall’altro, risultato di una riflessione più consapevole, vagliata
criticamente. In questo senso il significato del termine si avvicinerebbe a quello di teogonia. Nel
presente lavoro è comunque stato utilizzato nella sua accezione più generale e letterale, per denotare cioè gli sforzi attraverso cui gli antichi abbozzarono una spiegazione della scaturigine e dello
sviluppo dell’ordine riscontrato nell’esperienza.
Cosmologia
Il termine designa la dottrina che indaga la genesi e la costituzione del cosmo, e ha, nell’ambito
della riflessione greca arcaica, una valenza decisiva, dal momento che quasi tutti i problemi filosofici furono inquadrati sullo sfondo del concetto di cosmo. La ricerca sulla natura del mondo nella
49
sua totalità inglobava, infatti, la stessa meditazione sul destino dell’uomo e sul suo ruolo sociale
nella polis.
Dialettica
Il termine deriva da dia-leghein che significa dialogare ma anche (come dialegesthai) discernere,
distinguere. Esso designa in origine il procedimento discorsivo, per domande e risposte, attraverso
cui, nel confronto tra tesi in reciproca contraddizione, si afferma la verità. In particolare, nella riflessione arcaica la dialettica viene affermandosi come tecnica della confutazione nell’ambito della lezione eleatica, parmenidea prima, zenoniana e melissiana poi. Si trattava concretamente di affermare, anche in un confronto simulato (cioè in un opera scritta), la verità della propria posizione
dimostrando la contraddittorietà di quella degli avversari.
Divino
Il termine theion, utilizzato certamente anche nell’accezione tradizionale connessa
all’antropomorfismo politeistico, si trova associato, nella riflessione filosofica arcaica, al principio, in quanto fondamento della totalità (natura) e guida del processo del divenire. In questo senso
esso si collega alla vita e all’animazione.
Elemento
Il termine stoicheion, tecnico nell’ambito della ricerca aristotelica e in quella successiva (Euclide),
designava in origine la lettera o il carattere, in quanto componente della sillaba. Prendendo forse
spunto dall’analogia del nesso lettera-sillaba, il termine fu utilizzato da Aristotele nella propria ricostruzione della tradizione di pensiero presocratica per indicare il primo, intrinseco costitutivo di
un ente (soprattutto materiale: ad esempio le radici empedoclee, l’atomo democriteo).
Essere
Il termine sostantivo to on (o to eon) indica per un verso l’ente, ciò che è, per altro tutto ciò che è,
nel suo complesso, e in questo senso è contrastato dall’espressione to me on (il non essere), per altro ancora significa quanto è immutabile, imperituro e eterno nella realtà, in ciò contrastato da
ghignomenon, il divenuto e diveniente, l’instabile. Il termine in Parmenide assume in particolare il
secondo significato, designando la totalità del reale, nella quale si raccolgono i singoli enti della
nostra esperienza, a loro volta espressione, manifestazione della realtà stessa.
Intelligenza
Il termine nous indica, in Parmenide e Eraclito, la capacità umana più caratterizzante, in quanto in
grado di trascendere l’immediatezza del dato empirico, di cogliere ciò che sta al fondo
dell’esperienza. Il verbo corrispondente, noein, designava, già nei poemi omerici, il vedere, con
gli occhi della mente, al di là dell’inganno e dei mascheramenti. In questo senso l’intelligenza (o
intelletto) rappresenta la capacità di maggior rilievo in ambito gnoseologico (quella che fa conoscere di più), quella che consente la correlazione al principio e\o al reale nella sua totalità.
Logos
Il termine, che trova un’applicazione tecnica nella filosofia di Eraclito, ma un impiego diffuso anche in altri autori, risulta polivalente, designando a un tempo il pensiero (come capacità), il suo
esercizio, il discorso, e la sua espressione scritta, il suo significato. Esso possiede anche una forte
valenza ontologica, nella misura in cui viene utilizzato per designare la struttura della realtà, le
sue proporzioni.
Mito
Il termine mythos nella tradizione omerica designava parola, discorso, in alcuni contesti anche
progetto, macchinazione. Secondo alcuni studiosi, il mito condenserebbe in origine due poli per
noi nettamente distinti nella designazione: la parola, appunto, e la cosa designata. In questo rivelerebbe la sua potenza taumaturgica, la sua valenza sacrale, nel momento in cui al centro del discorso, per lo più poetico, si trovavano divinità. Successivamente, nel V-IV secolo il termine mantenne il significato di racconto intorno agli dei, agli eroi o, comunque, incentrato su episodi straordinari. In ambito filosofico, invece, assunse quello di discorso che è strutturalmente estraneo a una
strategia dimostrativa, in contrapposizione al logos, inteso come argomentazione razionale.
50
Natura
Il termine physis nei primi autori indica sostanzialmente:
1. la totalità degli enti,
2. la radice originaria, nascosta di quella totalità.
Il primo significato è quello che superficialmente più si avvicina alla nostra ordinaria accezione: è
necessario tuttavia tenere presente che le stesse titolazioni dei testi filosofici più antichi (peri
physeos) rivelano l'orizzonte onnicomprensivo del concetto associato, riferito a ogni possibile oggetto di studio, anche non immediatamente "fisico", come la morale, ad esempio.
Il secondo significato è forse quello più tecnico, legato alla stessa etimologia del termine latino
natura: la parola greca appartiene alla radice phyein = generare, indicando quindi la generazione,
il processo di costituzione e ciò che è al suo fondo, determinandolo. In questo senso il termine designa il principio intrinseco cui un ente si riduce per essere quello che è. Nei primi pensatori greci
questo ruolo era caricato di particolari valenze, riconoscendolo associato alla vita, e dunque attribuendo alla natura originaria una forza cosmogonica corrispondente a quella dei grandi miti teogonici della tradizione poetica: ragion per cui, per essa, era utilizzata l'impegnativa espressione to
theion (il divino).
Opinione
Il termine doxa, nella tradizione filosofica arcaica, designa per lo più una forma debole o addirittura illusoria di conoscenza, fondata sull’acritica ricezione del dato sensibile, di per sé insufficiente
senza un’adeguata interpretazione razionale (si pensi a Eraclito e Parmenide) o fuorviante (come
nell’eleatismo).
Principio
La parola greca arché indica, in contesti molto diversi, il punto di partenza, l'inizio, il punto di riferimento di un processo, ciò che lo guida (ad esempio in ambito politico). Individua nel lessico filosofico arcaico, con sovrapposizione semantica a physis, ciò da cui derivano originariamente e in
cui si risolvono da ultimo tutti gli esseri. È allora scaturigine delle cose, termine cui esse ritornano
dissolvendosi, fondamento costante delle loro vicende, designando ciò che è primo e persistente,
rispetto a quanto è invece dipendente e transitorio. Associato al divino per questa funzione determinante, gli furono attribuiti da Anassimandro e Anassimene (e forse dallo stesso Eraclito) anche
compiti di direzione (abbracciare e governare) nel processo cosmogonico.
Radice
Il termine rizoma, tecnico della filosofia di Empedocle, venne impiegato per designare gli elementi
fondamentali, costitutivi della realtà (acqua, terra, aria e fuoco), in quella che è considerata dagli
storici della filosofia la prima teoria degli elementi, ripresa e puntualizzata dallo stesso Aristotele.
Scienza
Il termine episteme, che, a dire il vero, non trova un’applicazione sistematica nei filosofi più antichi, indica la forma di conoscenza più forte, dominante, in virtù della propria apprensione del
principio. Contrapposto al mero opinare, esso designa il sapere che è caratterizzato da una fondazione ultimativa, capace di svelare la struttura della realtà.
Seme
Il termine sperma è un termine tecnico della filosofia di Anassagora, impiegato molto probabilmente per designare la componente elementare degli enti (infinitamente divisibile), qualitativamente connotata dalla prevalenza di porzioni dell’originaria miscela qualitativa. Ciò consentiva al
filosofo di sostenere la tesi del tutto in tutto, pur abbracciando una prospettiva in qualche misura
anticipatrice delle esigenze atomistiche.
Sensazione
Il termine aisthesis indica la percezione delle qualità degli oggetti della nostra esperienza quotidiana e la facoltà connessa. La filosofia arcaica rifletté sia sull’origine della sensazione, sia sul suo
valore, insistendo da un lato sui nessi elementari che ne sarebbero a fondamento, come l’attrazione
del simile (tra soggetto e oggetto), dall’altro sulla sua superficialità, per cui tale percezione sembrava connotarsi per l’incertezza delle affezioni (come nel caso dell’atomismo), o, comunque per
l’insufficienza del dato sensibile rispetto alle aspirazioni conoscitive.
51
Teogonia
Il termine deriva da theos (dio) e goné (generazione), e designa, sin dall’antichità, poemi
sull’origine del mondo e delle divinità. O meglio: la sapienza, espressa in quelli, riguardo al processo di produzione del mondo, interpretato come una progressiva articolazione genealogica a partire da una o più divinità. In questo senso, nel linguaggio proprio della tradizione sacerdotale, la
teogonia rappresenta la risposta mitico-simbolica alla domanda sulle scaturigini della realtà.
Dario Zucchello, 1997
52