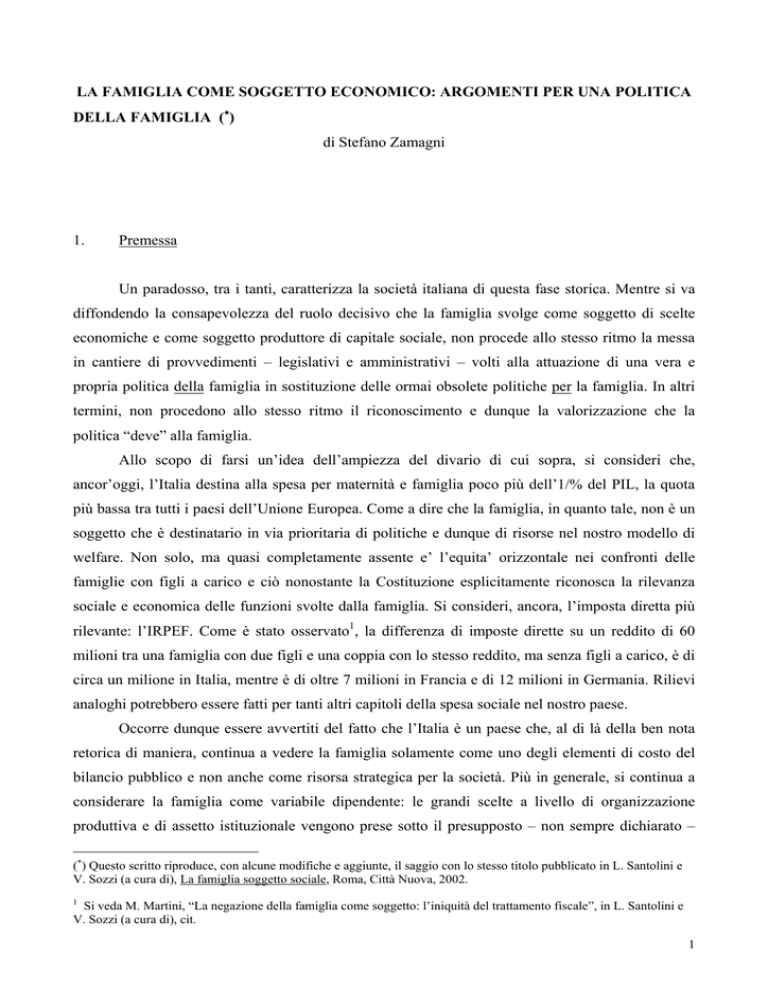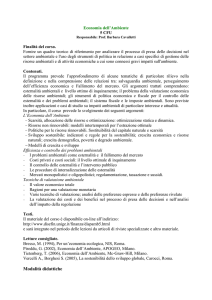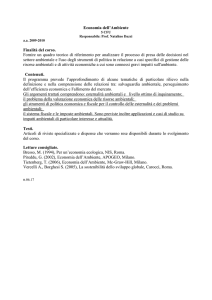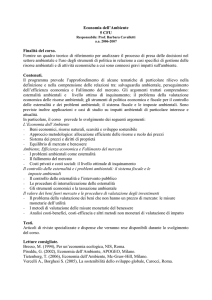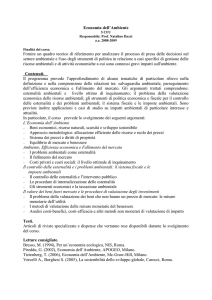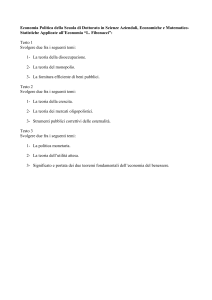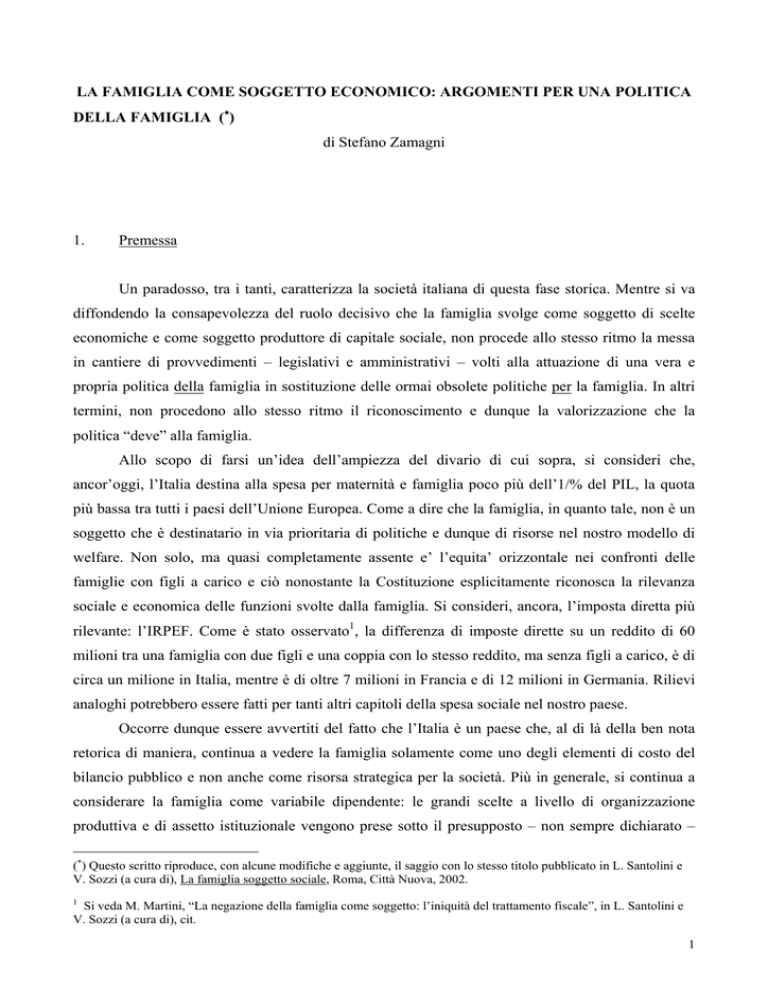
LA FAMIGLIA COME SOGGETTO ECONOMICO: ARGOMENTI PER UNA POLITICA
DELLA FAMIGLIA (∗)
di Stefano Zamagni
1.
Premessa
Un paradosso, tra i tanti, caratterizza la società italiana di questa fase storica. Mentre si va
diffondendo la consapevolezza del ruolo decisivo che la famiglia svolge come soggetto di scelte
economiche e come soggetto produttore di capitale sociale, non procede allo stesso ritmo la messa
in cantiere di provvedimenti – legislativi e amministrativi – volti alla attuazione di una vera e
propria politica della famiglia in sostituzione delle ormai obsolete politiche per la famiglia. In altri
termini, non procedono allo stesso ritmo il riconoscimento e dunque la valorizzazione che la
politica “deve” alla famiglia.
Allo scopo di farsi un’idea dell’ampiezza del divario di cui sopra, si consideri che,
ancor’oggi, l’Italia destina alla spesa per maternità e famiglia poco più dell’1/% del PIL, la quota
più bassa tra tutti i paesi dell’Unione Europea. Come a dire che la famiglia, in quanto tale, non è un
soggetto che è destinatario in via prioritaria di politiche e dunque di risorse nel nostro modello di
welfare. Non solo, ma quasi completamente assente e’ l’equita’ orizzontale nei confronti delle
famiglie con figli a carico e ciò nonostante la Costituzione esplicitamente riconosca la rilevanza
sociale e economica delle funzioni svolte dalla famiglia. Si consideri, ancora, l’imposta diretta più
rilevante: l’IRPEF. Come è stato osservato1, la differenza di imposte dirette su un reddito di 60
milioni tra una famiglia con due figli e una coppia con lo stesso reddito, ma senza figli a carico, è di
circa un milione in Italia, mentre è di oltre 7 milioni in Francia e di 12 milioni in Germania. Rilievi
analoghi potrebbero essere fatti per tanti altri capitoli della spesa sociale nel nostro paese.
Occorre dunque essere avvertiti del fatto che l’Italia è un paese che, al di là della ben nota
retorica di maniera, continua a vedere la famiglia solamente come uno degli elementi di costo del
bilancio pubblico e non anche come risorsa strategica per la società. Più in generale, si continua a
considerare la famiglia come variabile dipendente: le grandi scelte a livello di organizzazione
produttiva e di assetto istituzionale vengono prese sotto il presupposto – non sempre dichiarato –
(∗) Questo scritto riproduce, con alcune modifiche e aggiunte, il saggio con lo stesso titolo pubblicato in L. Santolini e
V. Sozzi (a cura di), La famiglia soggetto sociale, Roma, Città Nuova, 2002.
1
Si veda M. Martini, “La negazione della famiglia come soggetto: l’iniquità del trattamento fiscale”, in L. Santolini e
V. Sozzi (a cura di), cit.
1
che debba essere la famiglia ad adattarsi alle decisioni degli altri attori sociali e non viceversa.
Restando all’interno di un contesto culturale e politico del genere, non ci si deve poi meravigliare di
scoprire che la famiglia versa oggi in una crisi profonda, come le cronache puntualmente
documentano.
2.
La famiglia come soggetto generatore di esternalità positive.
Al solo scopo di farsi un’idea del ruolo importante che la famiglia assolve come produttrice
di welfare, proviamo a considerare cosa “rende” alla società la famiglia intesa quale soggetto
economico. La proposizione generale che va compresa e fatta comprendere è che la famiglia è il
primo generatore di esternalità sociali positive, cioè di effetti positivi per l’intera collettività che
però non vengono internalizzati dal meccanismo dei prezzi. Sfuggendo alle usuali rilevazioni
statistiche, tali effetti finiscono con il non esistere, dal momento che, secondo la contabilità
nazionale, esiste solo ciò che è quantificabile e misurabile con il metro monetario. Eppure, si tratta
di effetti la cui rilevanza ai fini della definizione della nozione di benessere di un paese non può
certo essere ignorata. Vediamo di illustrare, in breve, le principali fattispecie di esternalità sociali
positive generate dalla famiglia.2
Primo, la riproduzione della società. La decisione di mettere al mondo figli è bensì un fatto
privato che, tuttavia, produce conseguenze di grande momento sul piano collettivo – come sanno
tutti coloro che si occupano di transizione demografica e di equilibri economico–finanziari fra le
generazioni. Si consideri, ad esempio, il nesso tra vitalità imprenditoriale e composizione per età
della popolazione. Una società che invecchia, come è appunto la nostra, è una società che per ovvie
ragioni non è in grado di sostenere stabilmente nel tempo quel tasso di imprenditorialità che è
necessario a rendere vitale il sistema economico. Eppure, l’atteggiamento ancor’oggi diffuso è che i
costi della procreazione debbano essere sostenuti dalla famiglia proprio come se la decisione di fare
figli fosse assimilabile ad una usuale scelta di consumo.
Una seconda forma di esternalità positiva concerne l’integrazione e la redistribuzione dei
redditi da lavoro. E’ a tutti nota3 la capacità della famiglia di riequilibrare la distribuzione personale
dei redditi, la quale diventa più egualitaria quando si passa dalla distribuzione personale a quella
familiare. In questo senso, la famiglia si configura come un potente ammortizzatore sociale,
fungendo da punto di smistamento e di raccolta dei redditi dei propri membri svolgendo, in tal
2
Cfr. L. Campiglio, “La politica dei redditi, la politica fiscale e la famiglia in Italia” e C. Collicelli, “Famiglia e
politiche sociali negli anni ‘90” in AA.VV., Cittadinanza alla famiglia in Italia, Roma, Città Nuova, 1995.
2
modo, un’efficace funzione perequatrice. D’altro canto, non v’è chi non veda il nesso forte tra una
distribuzione meno ineguale dei redditi e il grado di coesione sociale presente nella società, quella
coesione sociale che oggi viene unanimemente riconosciuta come uno dei più significativi fattori di
progresso anche economico.
Una terza forma di esternalità positiva è quella che chiama in causa la flessibilizzazione
della partecipazione lavorativa dei soggetti femminili e dei giovani. Si tratta di un tema ormai
classico che è fatto oggetto di specifica attenzione nel contributo di L. Caselli , “Famiglia e lavoro”
nel volume a cura di L. Santolini e V. Sozzi (2002).
A questi casi, per così dire canonici, di esternalità positive generate dalla famiglia, penso sia
opportuno aggiungere altri tre casi, altrettanto se non più importanti dei precedenti, eppure quasi
sempre trascurati nel dibattito politico-culturale. In primo luogo, la famiglia (unitamente alle reti
sociali) è l’istituzione che più di ogni altra sostiene e tutela i soggetti deboli – dai bambini in età
prescolare agli anziani non autosufficienti; dalla cura dei disabili all’assistenza dei malati. E’
accertato che se la famiglia italiana non svolgesse quelle funzioni di tipo sia socio-assistenziale sia
socio-sanitario che da sempre essa svolge, il nostro paese non potrebbe certo occupare – date le
caratteristiche strutturali dei nostri servizi pubblici – il posto (secondo) nella graduatoria mondiale
che l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli riserva per quanto attiene gli indici di morbilità e di
mortalità. A fronte di ciò si scopre che su 100 lire di reddito redistribuito (trasferimenti) solo 21 lire
vanno in Italia a famiglie nei tre decili più poveri. (Negli USA, queste cifre sono, rispettivamente,
100$ e 37$).4
Secondariamente, la famiglia è il luogo ideal – tipico della creazione di capitale umano degli
individui. E’ noto che il capitale umano non dipende solamente dall’investimento in istruzione e
formazione da parte degli interessati (o da chi per loro) e dall’ambiente sociale, ma anche e, in certi
contesti, soprattutto dall’ambiente familiare. Le interazioni tra soggetti, per il tramite di effetti di
spillover, consentono la trasmissione reciproca di conoscenze e questo accresce, di per sé, lo stock
di capitale umano. Ebbene, per sua natura la famiglia è il luogo in cui le interazioni tra membri sono
più intense e meno soggette a fenomeni di tipo opportunistico: al suo interno avvengono
trasferimenti sistematici di conoscenze tra i componenti, trasferimenti favoriti dalla stretta vicinanza
e dai legami parentali. Ecco perché là dove la famiglia è solida più elevato, coeteris paribus, è lo
3
Cfr. G. Malerba, “Famiglia, distribuzione del reddito e politiche familiari. Parte prima”, Quaderno 27, Università
Cattolica di Milano, Aprile 2000.
4
Per un’analisi dettagliata si veda P. Roberti, “Modelli e obiettivi della politica sociale per la famiglia”, CNEL, Roma,
ott. 1998.
3
stock effettivo di abilità acquisite dagli individui e quindi più alta è la produttività media del
sistema.5
Infine, la famiglia funge da filtro tra individuo e mercato per quanto concerne le scelte di
consumo. E’ risaputo che queste ultime non sono quasi mai il frutto di processi decisionali di tipo
atomistico, ma risentono piuttosto dell’insieme di valori, delle prassi e degli stili di vita che il
singolo trae dalla famiglia di cui è parte. Ad esempio, l’edizione 2000 dell’Osservatorio
Findomestic mostra, a tutto tondo, come ancor’oggi resti prevalente in Italia il ruolo della famiglia
nella programmazione degli acquisti. Quanto a dire che è la famiglia il consumatore tipico. Quale la
rilevanza pratica di tale constatazione? Quella di suggerire che se si vogliono modificare o
trasformare gli attuali modelli di consumo – vuoi per ragioni di sostenibilità ambientale vuoi per
considerazioni di natura etica – a poco valgono le costose campagne di educazione del consumatore
– individuo, campagne che troppo spesso acquistano il vago sapore del moralismo. Molto più
efficace sarebbe agire sulla famiglia mediante l’implementazione di strategie di empowerment della
stessa.
Si pone la domanda: come è potuto accadere che durante la lunga fase della modernità si
affermasse, una concezione di famiglia incapace di riconoscerle una vera e propria soggettività
economica per quanto concerne la produzione di esternalità sociali positive? Sono dell’avviso che la
risposta vada cercata nelle caratteristiche strutturali che connotano di sé il sistema di fabbrica quale
si afferma a seguito della rivoluzione industriale. Vediamo di chiarire.6
E’ noto che con l’avvento del sistema di fabbrica si diffonde nelle società occidentali uno
stile di vita basato sulla separazione tra produzione e consumo; sulla separazione cioè tra l’uomolavoratore (portatore di forza produttiva) e l’uomo-consumatore (portatore di bisogni). Lavoro e
consumo rimandano a due principi opposti e complementari: la costrizione il primo (la disciplina di
fabbrica), la liberazione il secondo (il tempo libero). Questa separazione viene giustificata (ed
esaltata) ricorrendo alla diversa possibilità di conseguire economie di scala nei due ambiti della
produzione e del consumo: solo nel primo ambito si possono ottenere rilevanti economie di scala,
non certo nell’attività di consumo.
A sua volta, ciò consegue al fatto che la società industriale è una società che produce beni.
La macchina predomina e i ritmi della vita sono meccanicamente cadenzati. L’energia ha sostituito
la forza muscolare e dà conto degli enormi incrementi di produttività, a loro volta responsabili della
produzione di massa di beni. Energia e macchina trasformano la natura del lavoro: le abilità sono
scomposte in componenti elementari e l’artigiano della società preindustriale è sostituito dalle due
5
Per un approfondimento sul tema rinvio a P. Rossetti e P. Tanda, “Interazioni familiari e rendimenti del capitale
umano”, Univ. Di Roma, La Sapienza, Sett. 1998.
4
nuove figure del tecnico e del lavoratore semispecializzato. E’ un mondo di coordinamento e di
organizzazione in cui gli uomini sono trattati come “cose” perché è più facile coordinare cose che
uomini. Ne deriva una necessaria distinzione tra ruolo e persona. Le organizzazioni si occupano dei
requisiti dei ruoli, non delle persone. Il criterio della techné è l’efficienza e il modo di vita è
modellato sull’economico, le cui parole chiave sono massimizzazione e ottimizzazione.
Ovviamente, elementi e caratteri tradizionali permangono in tale società, ma il fatto del lavoro
ripetitivo e parcellizzato resta il connotato saliente del modo di produzione industriale. Infatti la
divisione del lavoro determina non solo i ruoli o le funzioni all’interno della fabbrica, ma nella
società in generale. L’individuo trova, nel momento in cui entra nel mondo del lavoro, professioni
già determinate e deve pertanto adattare la sua personalità alla funzione che la società gli ha
assegnato. Il taylorismo costituisce il tentativo di teorizzare questa nuova fase della organizzazione
del lavoro. Il ritmo di lavoro viene controllato dalla catena di assemblaggio e le capacità di giudizio
e l’esperienza dell’operaio vengono ridotte al minimo. Così la produzione di massa, su larga scala,
si accompagna a una totale dequalificazione e spersonalizzazione della persona del lavoratore.
Giova osservare che queste conseguenze della divisione del lavoro sulla condizione
lavorativa non dipendono dal modo in cui viene organizzato il controllo del processo produttivo, sia
questo il modo della proprietà capitalistica o quello della pianificazione centralizzata. Lo Stato
socialista può abolire bensì la proprietà privata dei mezzi di produzione, può eliminare la borghesia,
può realizzare condizioni di spinto egualitarismo per tutti, ma non può abolire la subordinazione dei
lavoratori alle ferree leggi della produzione meccanizzata. “L’ultima parola del capitalismo –
scriveva Lenin nel 1918 – il sistema di Taylor racchiude in sé… la ferocia raffinata dello
sfruttamento borghese unito a una serie di ricchissime conquiste scientifiche nell’analisi dei
movimenti meccanici del lavoro… La Repubblica sovietica deve ad ogni costo far suo tutto ciò che
vi è di prezioso nelle conquiste fatte dalla scienza e dalla tecnica in questo campo… Si deve
introdurre in Russia lo studio e l’insegnamento del sistema Taylor. “(Opere Scelte, Editori Riuniti,
Roma, 1978). Come si nota, Lenin non sfugge alla trappola che consiste nel credere di poter servirsi
del ford-taylorismo senza “disinfezione”. Invero, lo stesso Gramsci non riesce a liberarsi
completamente da questa sorta di condizionamento culturale: quando parla del fordismo, Gramsci
non manca di rilevare come esso permetta alla mente del lavoratore di tenersi libera e disponibile
per l’impegno politico.
Ebbene, il mutamento nella struttura e nell’organizzazione del lavoro che si realizza col
fordismo, si accompagna a modificazioni altrettanto radicali nella sfera dei consumi.
L’affermazione della “catena di montaggio” trova il suo correlato nella affermazione del
6
Per una trattazione più completa rinvio al mio, “Verso il superamento della concezione economicistica del turismo” in
5
consumismo. Di qui la dicotomia tipica dei “tempi moderni”: da un lato, si esaspera la perdita di
senso del lavoro (l’alienazione), dall’altro, a mò di compensazione, si rende il consumo opulento. E
il “luogo” privilegiato del consumo è appunto la famiglia, la quale diventa per ciò stesso
l’istituzione maggiormente funzionale alle esigenze di accumulazione del capitale e di espansione
del sistema.
Cosa muta in quanto precede con il passaggio alla società post-fordista? Quest’ultima da un
lato, spinge verso il superamento della separazione tra ideazione e esecuzione di lavoro, oltre che
della concezione del consumo come antidoto all’alienazione del lavoro, dall’altro fa emergere un
nuovo dilemma: o tempo o lavoro. In breve si tratta di questo. Oggi, il povero ha scarsità di
denaro e abbondanza di tempo; il ricco ha abbondanza di denaro e scarsità di tempo. Il ricco di
ieri, invece, aveva sia denaro sia tempo in abbondanza. Il fatto nuovo è dunque che l’accresciuta
produzione di beni, e soprattutto l’aumento incessante dei livelli di produttività, hanno generato
una nuova scarsità, quella del tempo di consumo. Come bene documenta e argomenta Cross 7, che
ci voglia tempo per produrre è noto da sempre; la novità, dell’attuale fase di sviluppo, è che la
scarsità di tempo ha cominciato a farsi sentire anche nell’attività di consumo: per consumare
volumi crescenti di beni e servizi ci vuole sempre più tempo. Col risultato che il tempo è diventato
denaro sia sul lavoro (il che è sempre stato vero), sia nel consumo. Ciò spiega la nascita, a getto
continuo, di nuove attività e prodotti il cui scopo è proprio quello di far risparmiare tempo nel
processo di consumo, vale a dire di elevare quello che in economia si chiama il tasso di
consumatività – un tasso questo che misura la quantità di beni e servizi che possono essere
consumati in una certa unità di tempo. Si pensi al significato ultimo degli acquisti per posta; del
fast food; dell’e-commerce, ecc.. Invero, il fatto che consumare prenda tempo è la rovina delle
società dei consumi – osserva giustamente Bauman. La società dei consumi – e non già dei
consumatori – avrebbe bisogno, infatti, che la soddisfazione del consumatore fosse istantanea, e
ciò in un duplice senso: i beni consumati dovrebbero generare soddisfazione senza presupporre
l’apprendimento di speciali capacità (l’uso del computer deve essere sempre più friendly se si
vuole che la navigazione in internet si affermi come strumento di consumo, come modo per
occupare il tempo libero); la soddisfazione raggiunta con il consumo di un dato bene o servizio
deve cessare il più in fretta possibile per far posto ad altri desideri o ad altri bisogni e perciò al
consumo di altri beni e servizi. 8
Tuttavia, se è vero che consumando più in fretta si possono accrescere i volumi di consumo
– e di conseguenza i livelli di produzione dei beni di consumo – è del pari vero che in tal modo
AA.VV., Per un turismo autenticamente umano, Rimini, Faro ed., 2001
7
G. Cross, Tempo e denaro. La nascita della cultura del consumo, Il Mulino, Bologna, 1998.
8
Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma, Laterza, 2000.
6
non aumenta il tempo libero, il tempo cioè nel quale si è “capaci” di fare scelte libere. E’ un fatto
che la realtà che sta sotto i nostri occhi è che il lavoro non viene più circondato dall’alone
messianico che gli era stato attribuito nella stagione fordista – l’uomo è lavoro, come J.Locke,
K.Marx e altri avevano teorizzato: la storia dell’umanità è storia del lavoro – ma ciò non significa
affatto che il lavoro vada diminuendo. Al contrario, esso si va estendendo, andando a riempire
sempre più il tempo di vita delle persone. Come opportunamente osserva Totaro,9 il superamento
della concezione utopica del lavoro tipica del fordismo è proceduto di pari passo con la sua
dilatazione di fatto, col risultato di far nascere un nuovo paradosso: oggi, gli individui sono più
consapevoli di ieri della necessità, poniamo, di stare più in famiglia o di dedicarsi maggiormente a
consumi culturali, ma hanno meno tempo per farlo. Di qui la frustrazione soggettiva di vedere la
propria vita assorbita dal lavoro e dal consumo. Ieri, la vita era assorbita prevalentemente dal solo
lavoro; quella del consumo veniva considerata come l’attività volta alla soddisfazione di bisogni,
più o meno necessari. (E infatti per la teoria economica, il consumo è sempre stato
concettualizzato, salvo rarissime eccezioni, come attività economica
improduttiva). Oggi, il
consumo è anche “mezzo di produzione” perché i beni “hanno bisogno” di essere consumati e se il
bisogno non è spontaneo, se di questi beni non si sente il bisogno, occorrerà che questo bisogno
sia generato, in un modo o nell’altro. E’ in ciò la differenza tra “induzione del consumo” – quella
di ieri – e “manipolazione del consumo” – quella di oggi. E’ in questo cioè la differenza tra
consumismo e iperconsumismo. In questo processo, la produzione (l’impresa) usa i consumatori
come suoi alleati da coinvolgere, in un certo senso, nel processo decisionale. Non così ieri, quando
Henry
Ford poteva dire: “I miei clienti possono scegliere il colore dell’automobile che
desiderano, purchè sia neo”. Nei termini di Baudrillard, viviamo oggi in un mondo in cui tutti gli
ambienti sono dedicati, direttamente o indirettamente, ai consumi.10
Quale il nesso di tutto ciò con la domanda che avevamo posto sopra? Per le sue
caratteristiche intrinseche la famiglia è un luogo che postula il tempo libero. Non è possibile
comprimere il tempo di un rapporto tra genitori e figli o tra moglie e marito nello stesso modo in cui
si può comprimere il tempo di un viaggio. In tal senso, si può dire che la famiglia è oggi
l’espressione più rilevante, del tempo libero come durata (nel senso di H.Bergson) che non è presa
né dal lavoro né dal consumo; del tempo libero cioè come tempo dedicato ad attività a carattere
relazionale, siano esse di produzione oppure di consumo. Ma, come si è detto, l’organizzazione
attuale della società, tende pervicacemente a ridurre il tempo libero, perché vede nel consumo
l’attività economica per eccellenza e dunque tende a ridurre lo spazio proprio della famiglia. In
9
F. Totaro, “Ansie e aspirazioni del mondo del lavoro di oggi”, Notiziario Ufficio Pastorale del Lavoro, Roma, Maggio,
2000.
10
J. Baudrillard, Simulari e impostura, Bologna, Cappelli, 1980.
7
questo senso, si può dire che la famiglia pone oggi una grande sfida: quella di trovare un assetto
organizzativo della società capace di assicurare un equilibrio soddisfacente, di alto profilo, tra
lavoro, consumo e tempo libero. Per dirla in altri termini, il modo in cui gli aumenti di produttività
legati all’impiego delle nuove tecnologie infotelematiche, vengono ripartiti tra tempo e denaro –
cioè tra avere più tempo libero e avere più denaro da destinare al consumo – è oggi la vera sfida per
le nostre società avanzate. (La sfida di ieri riguardava piuttosto i modi di riparto tra reddito da
destinare al consumo e reddito da destinare all’accumulazione del capitale). Una sfida che vede
proprio la famiglia come attore principale.
3.
Verso il superamento della dicotomia familismo-defamilizzazione
Si è detto nel paragrafo precedente che la famiglia è da sempre il più grande fornitore di
servizi di welfare. Si può ora aggiungere che tale ruolo, non solamente non mostra segni di declino,
né nei sistemi del Nord Europa né in quelli dell’Europa mediterranea, ma addirittura che esso sta
conoscendo un rilancio inimmaginabile fino a qualche anno fa, almeno per quanto concerne il care
familiare. Eppure, la famiglia, in quanto tale, non è ancora entrata, in modo adeguato, nell’analisi
dei regimi di welfare. Come opportunamente scrive Donati: “Il secolo che si è appena chiuso alle
nostre spalle ci ha lasciato in eredità una realtà tanto evidente quanto densa di ambiguità: il fatto che
le politiche familiari abbiano perduto le famiglie”11. Invero, la tendenza prevalente è ancora quella
di trattare la famiglia come variabile dipendente. Ritengo sia giunto il momento di avanzare con
forza la richiesta che la famiglia entri nel novero delle variabili indipendenti – una richiesta che
dovrebbe apparire semplicemente naturale a chi considerasse che i grandi mutamenti sociali oggi in
atto che chiamano in causa la famiglia (la riduzione della durata dei matrimoni; l’aumento del
numero dei nuclei monoparentali; la crescita del numero delle coabitazioni; la massiccia riduzione
dei tassi di fertilità; e così via) hanno effetti di rilievo sul disegno delle politiche sociali.
Cosa può favorire l’accoglimento di una simile richiesta? Certamente il superamento della
celebre distinzione, ancor’oggi in auge, tra sistemi familisti e sistemi defamilizzanti. Seguendo
Esping-Andersen 12, familista è il sistema di welfare in cui lo Stato assume che il nucleo familiare
sia il primo responsabile del benessere dei suoi membri e dunque il primo generatore del lavoro di
cura. Nei sistemi di defamilizzazione, invece, le responsabilità di cura della famiglia vengono
11
12
P. Donati, “La famiglia come soggetto sociale”, in questo Volume.
G. Esping-Andersen, I fondamenti sociali delle economie post-industriali, Bologna, Il Mulino, 2000.
8
attenuate attraverso gli interventi realizzati o dallo Stato direttamente (care pubblico) oppure per il
tramite del mercato (lavoro di cura informale, spesso costituito da prestazioni retribuite “in nero” e
non regolarizzate sotto il profilo contributivo). In altro modo, i sistemi che defamilizzano sono
quelli che tendono ad alleggerire il peso che ricade sulla famiglia con interventi sostitutivi di natura
essenzialmente pubblica e, di conseguenza, a ridurre la dipendenza del benessere dei singoli
dall’esistenza di rapporti di parentela. Ora, a prescindere dai problemi, certo non lievi, riguardanti la
misurazione del grado di familismo e di defamilizzazione presente in una certa realtà e a
prescindere dal fatto se sia vero o meno che in Europa sia in atto da qualche tempo una convergenza
tra stati sociali familistici (quelli dell’Europa del Sud) e stati sociali defamilistici (quelli dell’Europa
del Nord), il mio argomento è che la distinzione stessa abbia perso, oggi, la sua ragion d’esistere. Se
essa ha avuto un senso durante il cinquantennio post-bellico per descrivere ed interpretare la
diversità dei modelli di welfare, oggi quella distinzione non ci consentirebbe di compiere il balzo in
avanti di cui sopra si è detto, cioè a dire passare da una politica per la famiglia ad una politica della
famiglia. Vediamone le ragioni, in breve.
La più rilevante è che restando attaccati alla dicotomia familismo – defamilizzazione come
categoria esplicativa non riusciremo mai a sciogliere due autentici paradossi. Il primo è che se si
confrontano i trasferimenti alle famiglie con figli a carico nei due tipi di sistemi, si scopre che i
trasferimenti meno generosi si registrano nei sistemi più familistici. Ad esempio, gli assegni
familiari ai nuclei con due figli corrispondono al 2% del reddito medio nei paesi dell’Europa
Mediterranea e ad almeno il doppio in quelli dell'Europa del nord. Come dire che quanto maggiore
è il lavoro di cura svolto dai familiari, ovvero quanto più la famiglia produce al proprio interno
servizi di welfare, tanto meno riceve dallo Stato sussidi o trasferimenti con il che anziché essere lo
Stato sussidiario alla famiglia, è quest’ultima a sussidiare il primo. Il secondo paradosso è quello
che concerne la relazione tra tassi di attività femminili e tassi di fertilità. Come mostra EspingAndersen, nei regimi di welfare più defamilizzati (quelli della Scandinavia) si registrano livelli di
natalità tra i più alti d’Europa. Il viceversa si verifica in paesi a tradizione familista quali l’Italia, la
Spagna, il Portogallo. E’ questo un caso importante di rovesciamento storico: la correlazione fra
tassi di occupazione femminile e fecondità si è letteralmente rovesciata. Fino agli anni settanta era
nettamente negativa; oggi è diventata positiva.13 Questo significa che le politiche di impianto
familista non facilitano, né servono ad incentivare la generazione di figli.
Una seconda ragione che parla contro la dicotomia di cui si tratta è che, nelle condizioni
storiche attuali, la prospettiva del familismo non è più proponibile perché respinta dalle donne.
13
D. Blenchet e S. Pennec hanno stimato il “coefficiente di incompatibilità” tra occupazione femminile e fecondità
distinguendo situazioni diverse. Cfr. “A simple model for interpreting cross-tabulations of family size and women’s
labor force participation”, European Journal of Population, 9, 1993.
9
D’altro canto, insistere per la via della defamilizzazione non farebbe altro che accrescere il già
elevato tasso di individualismo atomistico presente nelle nostre società. In entrambi i casi si
registrerebbe una riduzione dei livelli di benessere e soprattutto uno scadimento della qualità di vita.
Vediamo di chiarire.
Come sappiamo, la società fordista è stata una società inerentemente maschilista.
L’affermazione del sistema di fabbrica, infatti, è valso a legittimare in termini socioeconomici la
superiorità dell’uomo sulla donna sia per ragioni fisiche (l’organizzazione produttiva avvantaggiava
il possessore di “muscoli”) sia perché quel sistema, separando il luogo del lavoro (la fabbrica) dal
luogo della famiglia (la casa), ha finito con il cristallizzare i ruoli di genere, servendosi spesso di
vere e proprie coperture ideologiche.
L’ingresso, ormai avvenuto, nella società post-fordista ha modificato – per le ragioni ormai
ben note – i termini del vantaggio comparato tra i due generi. Sarebbe dunque stolto, oltre che
profondamente ingiusta, mantenere in vita una organizzazione sociale che discrimina ex-ante le
condizioni effettive (e non già potenziali) di accesso all’attività lavorativa tra uomini e donne. Che
sia ingiusto è palese a tutti, quale che sia la teoria della giustizia che si intenda abbracciare. Ma è
anche stolto dal punto di vista economico, perché le politiche delle pari opportunità costituiscono
oggi il metodo più efficace per provocare un aumento sensibile della produttività media. E ciò per
due ragioni principali. In primo luogo, perché esse, facendo in modo che tutti (e non solo il 49% dei
cittadini rappresentato dalla popolazione maschile) siano soggetti attivi del mercato del lavoro,
dilatano le possibilità occupazionali attraverso un aumento della flessibilità del sistema. In secondo
luogo, perché tali politiche consentono di civilizzare la competizione, riducendo le pratiche
belligene del mercato. E’ ormai diventato chiaro che la competizione pensata all’interno di un
paradigma di genere è distruttrice perché tende a dare fiato alla competizione posizionale, cioè a
quella forma di competizione che è responsabile dei più seri guasti di cui soffrono le nostre società
attuali.
Riusciamo così a comprendere perché sia oggi controproducente puntare, nelle politiche
familiari, sulla disponibilità delle donne a restare in casa . (Si tenga presente che, con riferimento
alla coorte dei trentenni – poco più di 10 milioni in Italia – già oggi le donne in possesso di titolo di
studio universitario superano, sia in numero sia in performance accademica, gli uomini). Un
risultato curioso, ma istruttivo, è quello che emerge dalle ricerche di Gershuny e Bonke teso a
quantificare il tempo riservato dalle donne ai lavori domestici non remunerati. Nei paesi in cui gran
parte delle donne lavora fuori casa (Danimarca, Finlandia, Svezia ecc.), i lavori domestici non
remunerati occupano un numero di ore settimanali assai inferiore a quello prevalente in quei paesi
10
dove bassi sono i tassi di occupazione femminili (25 ore in Danimarca, 30 in Canada, Inghilterra e
USA; ma 45 in Italia e Spagna) 14.
Se dunque il vecchio impianto familista non è oggi più proponibile, dobbiamo allora
rassegnarci a rivedere e riformulare il modello defamilista? La mia risposta è decisamente negativa.
Una ricerca recente dell’economista americana Hochschild
15
mi aiuta ad esplicitarne le ragioni.
Rifacendosi a precedenti studi di J. Schor, secondo i quali gli americani lavorano oggi in media
l’equivalente di un mese in più all’anno rispetto a vent’anni fa, l’autrice parla di “inciampo del
tempo” per significare una nuova forma di “scelta tragica” di fronte a cui si trovano oggi le donne,
quella riguardante la scelta tra esigenze del lavoro e il tempo da dedicare alla famiglia. Dalla sua
indagine empirica, la Hochschild trae la conclusione che per un numero crescente di americani “il
posto di lavoro ha preso il posto della casa e la casa è diventata il lavoro”. Il fatto è che l’azienda sta
diventando sempre più, nell’attuale fase di sviluppo, un’istituzione totale e questo nel senso che
essa tende ad assorbire quanto più tempo dai suoi quadri e dipendenti e ciò indipendentemente da
ragioni legate all’attività produttiva. Di qui il triste circolo vizioso: quante più ore si resta in
azienda, tanto più si diventa estranei alla famiglia e alla vita di relazione; d’altro canto, quanto più
si diventa estranei alla famiglia e agli amici, tanto più ci si sente a proprio agio dentro l’azienda. E
infatti le aziende tendono, sistematicamente, ad internalizzare i luoghi della socializzazione,
realizzando ritrovi, bar, piscine, campi da gioco e così via. Vale a dire, si preferisce fingere che ci
sia lavoro sufficiente a far lavorare tutta la giornata i propri dipendenti piuttosto che riorganizzarsi e
lasciare che costoro occupino il tempo non necessario a generare valore aggiunto nella vita di
famiglia ovvero in attività di tipo relazionale come quelle che si esplicano nelle reti sociali.
All’interno di un quadro del genere, non deve fare meraviglia se accade sempre più di
frequente di constatare che le donne (negli USA così come in Europa) sempre più desiderano
lavorare e stare fuori casa. E ciò non tanto per ragioni di denaro, quanto piuttosto perché è quello
del lavoro non domestico il luogo in cui si intrecciano le relazioni, si praticano forme spurie di
solidarietà, ci si realizza sul piano della personalità. (Si badi che azienda è qui termine generico:
potrebbe essere un ufficio, una fabbrica, una clinica ospedaliera o altro ancora). Ora, non v’è chi
non veda come una tendenza del genere, se non contrastata e invertita, possa produrre lacerazioni
profonde nel tessuto sociale e rischi seri per la stessa sostenibilità del modello di sviluppo. Se si ha
motivo di credere che una autentica società di uomini e di donne non possa non fare proprio il
principio di reciprocità tra uomo e donna – quel principio che von Balthasar ha definito “il caso
paradigmatico del perenne carattere comunitario dell’uomo” – si deve essere avvertiti del fatto che
14
Se, tuttavia, si considerano solamente le donne italiane occupate, le ore di lavoro domestico non remunerato si
avvicinano a quelle danesi: 28 ore alla settimana. Cfr. J. Gershuny, Changing times: the social economics of post
industrial societies, Univ. of Bath, Giugno, 1991.
11
un approccio come quello della defamilizzazione non può rappresentare l’orizzonte all’interno del
quale ricercare una politica familiare di tipo promozionale adeguata ad affrontare le sfide delle
società dopo-moderne.
4.
Proposte qualificanti per una politica della famiglia
Se dunque l’alternativa familismo-defamilizzazione
non costituisce più un ancoraggio
solido per impostare una innovativa politica della famiglia, quali fondamenti accogliere se, da un
lato, si vogliono conservare gli aspetti di indubbia positività dei due sistemi (la famiglia come prima
responsabile del benessere materiale e immateriale dei suoi membri, per quanto concerne il sistema
familista; la possibilità per la donna di superare l’inquietante trade-off fra lavoro esterno e lavoro di
cura familiare, per quanto concerne il sistema defamilistico ) e, dall’altro, si vogliono scongiurare i
rischi di una deriva che non farebbe altro che dilatare gli spazi di infelicità gia massicciamente
presenti nelle nostre società? Non esito ad indicarne tre.
Il primo fondamento concerne l’affermazione del principio secondo cui la famiglia va vista
come variabile indipendente, vale a dire come soggetto economico che agisce in quanto tale dotato
di una sua propria autonomia e non già come mero aggregatore di preferenze individuali.
L’accoglimento di un tale principio deve avere come primo effetto quello di favorire una
riconcettualizzazione del modo usuale di concepire il funzionamento di un’economia di mercato.
Mi spiego. Nei nostri sistemi di contabilità nazionale due sono gli operatori contemplati: le imprese
e le famiglie. Le prime sono deputate allo svolgimento dell’attività produttiva: le imprese non
consumano, ma utilizzano –così si dice- i fattori produttivi per conseguire i loro scopi. Alle famiglie
spetta invece l’attività di consumo, vale a dire l’acquisto di beni e servizi prodotti dalle imprese. Le
famiglie non producono alcunché secondo la contabilità nazionale. È dunque chiara la divisione dei
ruoli: la famiglia, in quanto luogo in cui si soddisfano i bisogni, è il soggetto cui si deve la funzione
del consumo; l’impresa, in quanto luogo in cui si attua l’accumulazione del capitale, è il soggetto
che realizza la funzione di produzione.
Una volta postulato – ma non dimostrato – che all’interno della famiglia non v’è produzione
di sorta, si arriva a comprendere perché nel calcolo del reddito nazionale non vi sia posto per tutto
ciò che di produttivo la famiglia realizza. Così, per fare un esempio: il pasto preparato in famiglia
non viene contabilizzato come attività di produzione, ma come attività di consumo misurata
15
A.R. Hochschild, The time bind. When work becomes home and home becomes work, New York, 1997.
12
dall’acquisto sul mercato dei beni che servono alla preparazione del pasto stesso. Eppure, il
medesimo pasto consumato in un ristorante viene contabilizzato come attività di produzione.
Ancora: la cura di un minore svolta da un genitore entro le mura domestiche è contabilizzata come
attività di consumo; la medesima cura fornita da una “colf” entra invece nel calcolo del reddito
nazionale, come espressione di attività produttiva. E così via. 16
Qual è il punto di arrivo di quanto precede? Innanzitutto, che se la contabilità nazionale
intende mantenere il tradizionale impianto concettuale, sarebbe bene che essa evitasse di
confondere le idee chiamando famiglia un soggetto che in effetti è semplicemente un individuo.
Infatti, se si definisce il consumo come l’attività di acquisto di beni e servizi sul mercato, è evidente
che non v’è alcun bisogno di parlare di famiglia come soggetto economico. Per fare acquisti sul
mercato basta l’individuo! Ma v’è di più. Qual è il collegamento che nelle nostre società di mercato
viene istituito fra decisioni di produzione e decisioni di consumo? Il principio organizzativo è
quello, ben noto, della sovranità del consumatore: le decisioni di produzione (cosa e quanto
produrre) sono guidate, per il tramite del sistema dei prezzi, delle scelte libere dei consumatori. Alle
imprese spetterebbero solamente le decisioni di come produrre. Se dunque fosse la famiglia il
soggetto del consumo, sarebbe vero che ad essa spetterebbe la scelta e in definitiva la responsabilità
anche etica del modello di consumo prevalente. Ma, come sappiamo, le cose non stanno in questi
termini per la semplice ragione che la famiglia non è affatto sovrana sul mercato; non ha cioè il
potere di inviare messaggi vincolanti alla sfera della produzione.
Il secondo pilastro di una vera e propria politica della famiglia è quello che concerne il
capitolo dei sostegni economici. Se è vero, come si è detto, che la famiglia è, oggi, il principale
produttore di esternalità sociali positive nelle nostre società, allora il sostegno economico deve
assumere le sembianze della restituzione ovvero della compensazione e non già – come continua ad
essere – della compassione o del paternalistico assistenzialismo. Detto in altro modo: la politica
della famiglia non può essere confusa con una politica di lotta alla povertà –che pure è necessaria.
Per colpa anche di tale confusione ci ritroviamo, oggi, con un paese in cui la povertà relativa è
16
In sostanza il punto sollevato è che va superata l’idea secondo cui il lavoro è solo quello retribuito nelle forme ben
note, quello cioè che produce beni e servizi che transitano per il mercato privato. Piuttosto, il lavoro è l’insieme delle
attività necessarie alla crescita umana, ma dell’uomo inteso nella globalità delle sue dimensioni, e non solo di una di
esse. E’ stato un connotato tipico della società industriale, ormai alle nostre spalle, quello secondo cui il lavoro veniva
definito nei termini dei suoi attributi solo mercantili, in quanto produttore di merci.
Concretamente, ciò significa che oggi siamo nelle condizioni di poter aggiungere a quelle monetarizzate le attività
non monetarizzate, quelle cioè che potrebbero essere remunerate secondo il principio dello scambio di equivalenti,
possedendo un valore di scambio implicito, ma che non lo sono. Tanto è vero che, nonostante le ovvie difficoltà di
natura tecnica, alcuni paesi stanno sviluppando la cosiddetta “contabilità satellite”, con la quale si cerca, appunto, di
calcolare il lavoro non monetarizzato. Secondo il Rapporto sullo sviluppo umano, 1995, dell’UNDP, il valore della
produzione totale non monetarizzata è stimata, a livello mondiale, a 16.000 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il
70% dei 23.000 miliardi di dollari del volume delle attività monetarizzate. Non ci vuole molto a congetturare come una
parte così rilevante dell’economia non possa restare invisibile, ancora a lungo, dalle statistiche ufficiali.
13
decisamente superiore a quella di tutti i paesi dell’Unione Europea, eccetto Grecia e Portogallo.
Come risulta da una recente indagine della Fondazione De Benedetti, il tasso di povertà relativa,
calcolato sulla media 1993-96, è del 14% in Italia, mentre è del 4,2% in Danimarca, 10% in Francia,
12,1% in Spagna e in Inghilterra, 9,5% in Belgio e così via (Il tasso di povertà relativa misura la
percentuale di individui aventi un reddito familiare inferiore alla metà dei redditi della famiglia
mediana).
Nel concreto, una politica di sostegno economico basata sul concetto di soggettività della
famiglia dovrebbe intervenire in quattro ambiti specifici. Il primo concerne il credito al consumo.
La famiglia in quanto tale non è considerata, in Italia, un soggetto bancabile. Di qui le forme di
razionamento del credito cui essa va soggetta (molto spesso implicitamente) e quindi la diffusione,
soprattutto in certe aree del paese, di pratiche endemiche di usura. Occorre allora intervenire sul
sistema bancario perché vengano aperte linee di credito specificamente rivolte alla famiglia come
già avviene in paesi civilmente più avanzati del nostro e come l’Osservatorio Findomestic, ad
esempio, da tempo suggerisce di fare.
Un secondo ambito di intervento è quello che concerne la messa in opera di forme
innovative di sanità integrativa che vedano la famiglia come soggetto, ad un tempo, di domanda e di
offerta di certe tipologie di prestazioni. Si pensi alla cosiddetta ospedalizzazione domiciliare; alle
terapie riabilitative per i malati psichiatrici (in numero spaventosamente crescente); alle varie forme
di pratiche socio-sanitarie. Più in generale, l’obiettivo da perseguire in tempi rapidi è quello di dare
vita ad un vero e proprio mercato sociale dei servizi in cui – come indica C. Ranci17 - il lavoro di
cura intrapreso dai familiari, mentre viene sostenuto economicamente dallo Stato o dagli altri enti
pubblici, è al tempo stesso regolato a livello pubblico o per via di contrattualizzazione (come già
avviene in Olanda e in Francia) oppure predisponendo procedure di regolarizzazione ad hoc (come
accade in Germania).
Un terzo ambito di intervento e’ quello propriamente fiscale. E’ vera l’obiezione di chi, pur
dichiarandosi d’accordo col principio dell’equita’ orizzontale a favore delle famiglie con figli, non
lo ritiene applicabile per motivi tecnici? Oppure e’ vero che il disinteresse per l’equita’ orizzontale
e’ conseguenza di una posizione culturale di marcato individualismo, secondo cui la decisione di
generare figli appartiene alla sola sfera privata dei genitori, una sfera rispetto alla quale lo Stato non
deve interferire? Un problema di ordine pratico da risolvere con urgenza è quello concernente le
forme degli interventi di sostegno: in natura oppure in denaro (cash)? Come è noto, la letteratura in
argomento è amplissima e non v’è una posizione, per così dire, dominante a livello teorico, mentre
nella pratica è di gran lunga prevalente la forma in natura. Sono dell’avviso che se si vuole dare vita
14
ad una politica della famiglia adeguata ai nostri tempi sia giunto il momento di dare la preferenza
alla forma in denaro.
Un quarto ambito di intervento ha per oggetto quelle misure che tendono a ridurre
l’incertezza endogena oggi gravante sulle famiglie, soprattutto su quelle giovani. Da sempre, la
creazione di nuova ricchezza e il conseguente miglioramento delle condizioni di vita sono serviti a
ridurre l’incertezza di vita dei singoli e delle famiglie. La transizione già in atto verso la società
globale ci pone, invece, di fronte ad un’economia in cui la produzione di incertezza sembra
connaturata al problema economico, anzi una sorta di precondizione per l’ulteriore progresso. Il
messaggio che veicola la sindrome dell’incertezza – diventata ormai una vera e propria sociopatia,
soprattutto le giovani generazioni – è quello dll’incertezza naturale ovvero “fabbricata”, come la
chiama A. Giddens: le persone sono indotte a pensare che occorra autoinfliggersi una certa dose di
incertezza per migliorare le performance economiche. Non ci si deve allora meravigliare se,
all’interno di un simile contesto culturale, le giovani famiglie si formano in età avanzata e
soprattutto se l'attività procreativa si limita ad un solo figlio. Come venirne fuori? In pratica, si
tratta di lanciare iniziative volte ad assicurare una qualche forma di reddito permanente alla
famiglia, in sostituzione dell’ormai obsoleto concetto di lavoro permanente (il posto fisso!)
assicurato al capofamiglia, tipicamente il marito. In altri termini, nelle condizioni odierne, alla
famiglia interessa assai più la prospettiva di una sorta di reddito permanente, che non la garanzia del
posto fisso di lavoro per il cosiddetto capofamiglia.
Una misura concreta in tal senso è quella che riprende un’idea avanzata da B. Ackerman nel
suo saggio Stakeholder Society del 1999: l’idea del baby bond. Per ogni bambino che nasce lo Stato
apre un conto in cui versa una somma iniziale – variabile in relazione alle condizioni di reddito
della famiglia – alla quale faranno seguito accreditamenti successivi all’età, poniamo, dei 5, 10 e 15
anni. Genitori e parenti sono incentivati ad effettuare versamenti sul conto mediante l’adozione di
schemi di deducibilità fiscale. Conseguita la maggiore età, il giovane riceve il fondo accumulato,
comprensivo degli interessi maturati, e potrà decidere come disporne: se per finanziarsi gli studi
superiori, per dare inizio ad attività lavorative, per acquistarsi una casa in vista del matrimonio o
altro ancora. Come è agevole comprendere, è questa una proposta che tende a realizzare
congiuntamente tre obiettivi importanti: la parità, sia pure parziale, dei punti di partenza delle
persone; la responsabilizzazione dei giovani nei confronti del loro futuro; una certa garanzia di
reddito permanente per la famiglia con figli. 18 E’ chiaro, infatti, che un ben funzionamente piano di
17
C. Ranci (a cura di), L’assistenza agli anziani in Italia e in Europa. Verso la costruzione di un mercato sociale dei
servizi, milano, F. Angeli, 2000.
18
Può essere interessante ricordare che l’idea illustrata da Ackerman si rifà, mutatis mutandis, ad un celebre progetto
realizzato a Bologna già nel 1472: il Monte dei Matrimoni, un’istituzione che per secoli ha rappresentato il più valido
strumento a favore della formazione di nuove famiglie in un epoca in cui, per sposarsi, la donna doveva esibire la dote.
15
baby bond varrebbe a ridurre di molto le preoccupazioni, talvolta le angosce, dei genitori circa il
futuro dei propri figli.
5.
Flessibilità intertemporale del lavoro e famiglia
Passo, da ultimo, al terzo pilastro di una politica promozionale della famiglia, quello che ha
per oggetto la vexata quaestio della possibilità di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita
familiare. Occorre prendere consapevolezza del fatto che, oggi, il principale ostacolo alla
formazione di nuove famiglie e, all’interno di queste, alla procreazione è la percepita impossibilità
da parte di non poche coppie di sciogliere il trade-off tra avanzamenti di carriera e/o di livello
professionale nel lavoro e necessità di dedicare ai figli le attenzioni indispensabili per la loro
educazione. Se le cose stanno, come a me pare, in questi termini, la questione urgente da sffrontare
è quella di studiare tipi specifici di politiche d'uso del tempo, tenendo presente che il problema non è
tanto quello della riduzione delle ore di lavoro settimanali o mensili, quanto piuttosto quello, assai più
complesso, della regolazione della sequenza temporale del lavoro retribuito in modo da consentire, da
un lato, alla persona di aggiustare il tempo di lavoro alle proprie esigenze nelle diverse fasi del ciclo di
vita lavorativa e, dall'altro alle imprese, di ridurre i costi di riorganizzazione dei processi produttivi
conseguenti alla implementazione di nuovi modi di occupazione. In altro modo, non si tratta tanto di
procedere ad una riduzione dell'orario di lavoro, di rilanciare lo slogan degli anni ottanta: "lavorare
meno, lavorare tutti". Anzi, da un lato gli orari di fatto di lavoro si stanno allungando e, dall'altro, le
stesse discussioni a livello internazionale sugli orari di lavoro definiti per legge o tramite la
contrattazione collettiva stanno arenando. (In Italia, la divaricazione tra orario contrattuale e orario di
fatto è marcata. Dal 1980 al 1993, l'orario contrattuale medio nell'industria si è ridotto di circa 60 ore su
base annua, mentre le ore effettivamente lavorate, includendo la Cassa Integrazione Guadagni, sono
cresciute di circa 90 unità). Piuttosto, il nodo da sciogliere è l'articolazione dei tempi - di lavoro, di
formazione, di cura, di tempo libero - e la suddivisione del tempo di lavoro tra "lavoro retribuito a
prezzi di mercato" e lavoro diversamente retribuito.
In uno studio non pubblicato del 1989, il Bureau of Labor Statistics degli USA indicava che il
18,4% dei dipendenti federali e il 12,2% degli occupati nel settore privato usufruivano di schemi di
lavoro temporalmente flessibili. Schemi in base ai quali, ciascun lavoratore è sempre presente durante
intervalli fissi di tempo di due ore al mattino e al pomeriggio. Le ore restanti, necessarie a completare
l'orario contrattualmente fissato, vengono recuperate su un arco di tempo, usualmente di quattro
settimane, secondo un piano predisposto dal lavoratore. In altri paesi, quali l'Australia, l'Inghilterra e i
16
paesi Scandinavi, le imprese di più grandi dimensioni già attuano da anni forme di organizzazione del
lavoro family-friendly volte a consentire ai propri dipendenti di conciliare esigenze di lavoro e impegni
familiari. Ciò che consente a tali imprese sia di attrarre personale di talento sia di mantenere nel lungo
periodo in ambito aziendale dipendenti che altrimenti verrebbero persi. I "career breaks", introdotti per
via legislativa in Belgio nel 1985, vengono oggi offerti, su base volontaria, da non poche imprese in
molti altri paesi. Ad esempio, la Midland Bank in Inghilterra consente ai propri dipendenti di prendersi
fino a cinque anni, in tre intervalli separati con almeno un anno di servizio continuativo tra un
intervallo e l'altro, per la cura dei figli, degli anziani o per altre pressanti ragioni familiari. Agli
occupati di livello dirigenziale vien assicurato il reimpiego al medesimo grado, ma costoro devono
lavorare almeno dieci giorni all'anno per mantenersi in contatto con la banca. E così via. 19
In buona sostanza, l'idea dell'approccio del ciclo di vita alla tematica occupazionale si basa
sulla possibilità di organizzare la scelta tra tempi di lavoro, tempi “familiari” e tempo libero avendo
come riferimento l'intero arco di vita degli individui. Un numero crescente di persone è desiderosa di
abbandonare temporaneamente il luogo di lavoro per trarre vantaggio dalla opportunità di formazione
di vario tipo che le nuove tecnologie dell'informazione rendono oggi disponibili o per soddisfare
esigenze di cura familiare. Ma, a buon considerare, anche le imprese hanno il medesimo interesse: il
tasso di obsolescenza del capitale umano è oggi così elevato da imporre, di fatto, continui programmi
di retraining per tutto il personale se si vogliono vincere le sfide della concorrenza nell'era della
globalizzazione. Non solo, ma le stesse imprese hanno tutto l’interesse ad avere come dipendenti o
come collaboratori uomini e donne che si sentono realizzati a livello personale perché in grado di
declinare in maniera non più oppositiva lavoro e famiglia.
In non poche aziende vige tuttora una mistica quantitativa del lavoro, per cui un dipendente
è tanto più apprezzato quante più ore serali di straordinario svolge. E i capi devono inventarsi
sempre nuove incombenze pur di trattenere i propri dipendenti oltre l'orario contratto, oppure
escogitare astruse combinazioni di orario. De Masi racconta di una raffineria della Esso che prevede
l'inizio giornaliero del lavoro alle 7.43 e la fine alle 16.51. Sempre De Masi
20
ha svolto indagini
accurate sul telelavoro da cui emerge che i compiti che in azienda richiedono otto-dieci ore a casa si
svolgono comodamente nella metà del tempo. Come a dire che l'azienda, in quanto istituzione
totale, tende ad assorbire quanto più tempo dai suoi quadri e dipendenti e ciò indipendentemente da
ragioni legate all'attività produttiva.
19
G. Campanini, “Quali politiche della famiglia per una sostenibilità sostenibile”, La Società, 2, 2001, avanza una
proposta interessante allo scopo di coniugare i vantaggi della flessibilità del lavoro con quelli della stabilità della
famiglia. Distinguendo le fasi iniziale (fino ai 30 anni) e terminale (dai 50 ai 65 anni) della vita lavorativa da quella
centrale, si potrebbero applicare – secondo Campanini – le regole piene della flessibilità alla prima e alla terza fase,
mentre tali regole dovrebbero (almeno in parte) essere condizionate alle esigenze familiari negli anni della fase
intermedia.
20
D. De Masi, Ozio creativo, Ediesse, Roma, 1997.
17
Di qui il triste circolo vizioso: quante più ore si resta in azienda, tanto più si diventa estranei
alla famiglia e alla vita di relazione; d'altro canto, quanto più si diventa estranei alla famiglia e agli
amici, tanto più ci si sente a proprio agio dentro l'azienda. E infatti le aziende tendono,
disperatamente, ad internalizzare i luoghi della socializzazione, realizzando ritrovi, bar, piscine,
campi da gioco e così via. Vale a dire, si preferisce di fingere che ci sia lavoro sufficiente a far
lavorare tutta la giornata i propri dipendenti piuttosto che riorganizzarsi e lasciare che costoro
occupino il tempo non necessario a generare valore aggiunto nella vita di famiglia ovvero nello
svolgimento di altre attività lavorative.
In definitiva, una politica tesa a realizzare una flessibilità intertemporale del lavoro segnala una
profonda trasformazione negli stili di vita e un marcato avanzamento culturale: l'esperienza di lavoro
tiene conto, almeno in qualche misura significativa, dei bisogni personali e dei progetti di vita. E non
v'è chi non veda come una prospettiva del genere possa concretamente contribuire ad avviare a
soluzione il problema della donna e, più in generale, della famiglia. Siamo stati abituati, durante la fase
della società industriale, a declinare il concetto di libertà di scelta nei termini della scelta sul mercato
tra vari tipi di beni e servizi. La nuova frontiera della libertà, nell'era post-industriale, richiede che la
nozione di libertà di scelta venga progressivamente estesa alla scelta dei piani di vita. E' consolante
sapere che gli aumenti continui di produttività associati alle nuove tecnologie rendono - purchè lo si
persegua con intelligenza e saggezza - un obiettivo del genere concretamente realizzabile.
6.
Per concludere
La realtà di una società poliarchica dal punto di vista sia economico e sociale e sia politico e
culturale, come è ormai l'Italia, è il grande fatto da cui prendere le mosse per giungere a proposte
orientate all'azione. E' ormai acquisito che i grossi problemi della transizione in corso saranno sempre
più quelli riguardanti l'equilibrio dei poteri diffusi, specie di quelli "forti", e la loro legittimazione in
ordine a qualcosa di comune. La sfida della famiglia può dunque costituire un prezioso momento di
riflessione sulle forme storiche della Dottrina Sociale della Chiesa e, più in particolare, sulla capacità
del movimento cattolico italiano di tornare a pensare in grande, a coltivare progetti audaci. A tale
riguardo, due mi paiono le condizioni che vanno previamente soddisfatte. La prima è che mai si
dimentichi che a istituire il consenso etico tra le persone non è l'accordo (o il contratto) di per sè, bensì
la partecipazione di chi lo ha realizzato. Quanto a dire che il consenso poggia non solo sulla ragione,
ma anche sul coinvolgimento personale di chi ha preso parte al processo di deliberazione. Da questo
punto di vista si può dire che il consenso (con-sensus) è un'istituzione tipicamente comunitaria. E
18
infatti le comunità cristiane non sono solamente delle tradizioni di riflessione morale. Esse sono anche
- e direi soprattutto - delle tradizioni narrative viventi che coltivano la cultura della reciprocità. L'etica
sociale della Chiesa acquista peso e credibilità nella misura in cui essa viene radicata in esperienze
vissute, nella vita cioè di comunità che diventano laboratori di uno stile nuovo di vita; che realizzano
una pratica innovatrice di vita capace poi di modificare anche il contesto sociale e economico.
La seconda condizione è che entrambe le accezioni del termine etica - costume e dimora vengano accolte come necessarie. In effetti, il bisogno crescente di un nuovo consenso etico non
implica solo il bisogno di riscoprire delle norme di buon comportamento, di una più avanzata prassi del
vivere civile, per rendere meno conflittuale il vivere in comune. Quel che in più si richiede è che queste
regole siano rapportate ad un'ultima dimora, ad un orizzonte di senso. Solo così esse potranno essere
capaci di offrire delle motivazioni per l'agire morale e di incidere in profondità sul comportamento
delle persone.
19