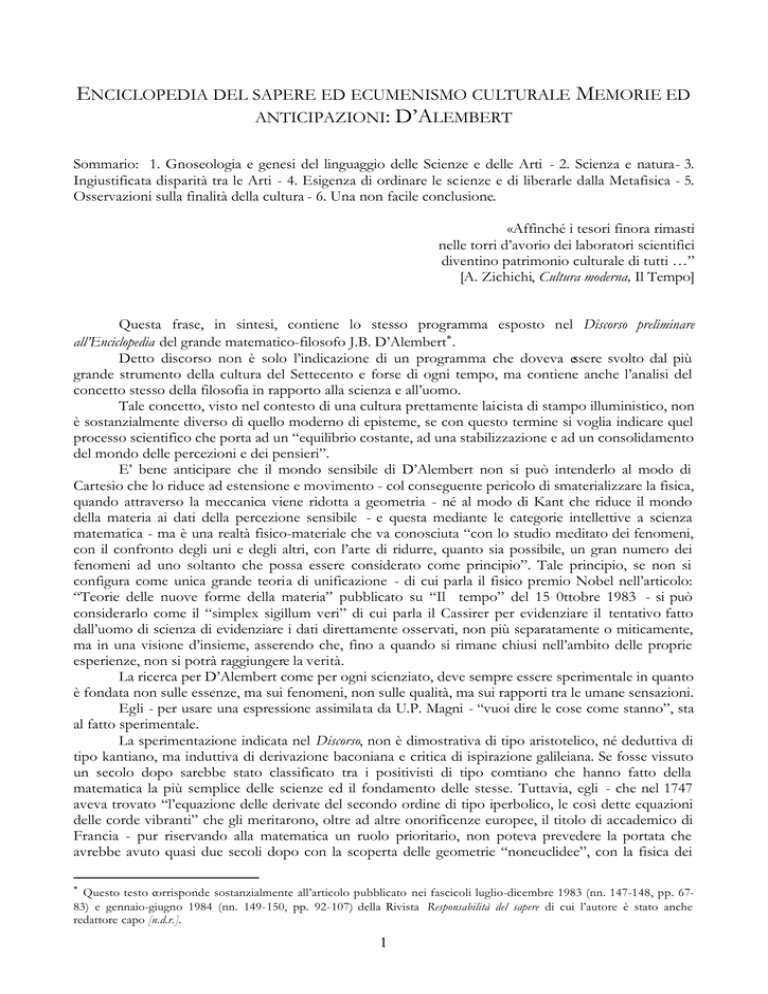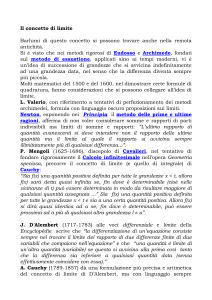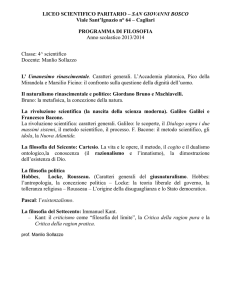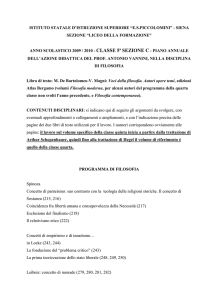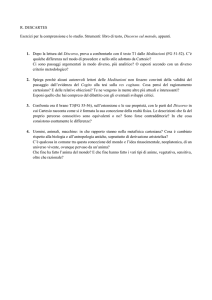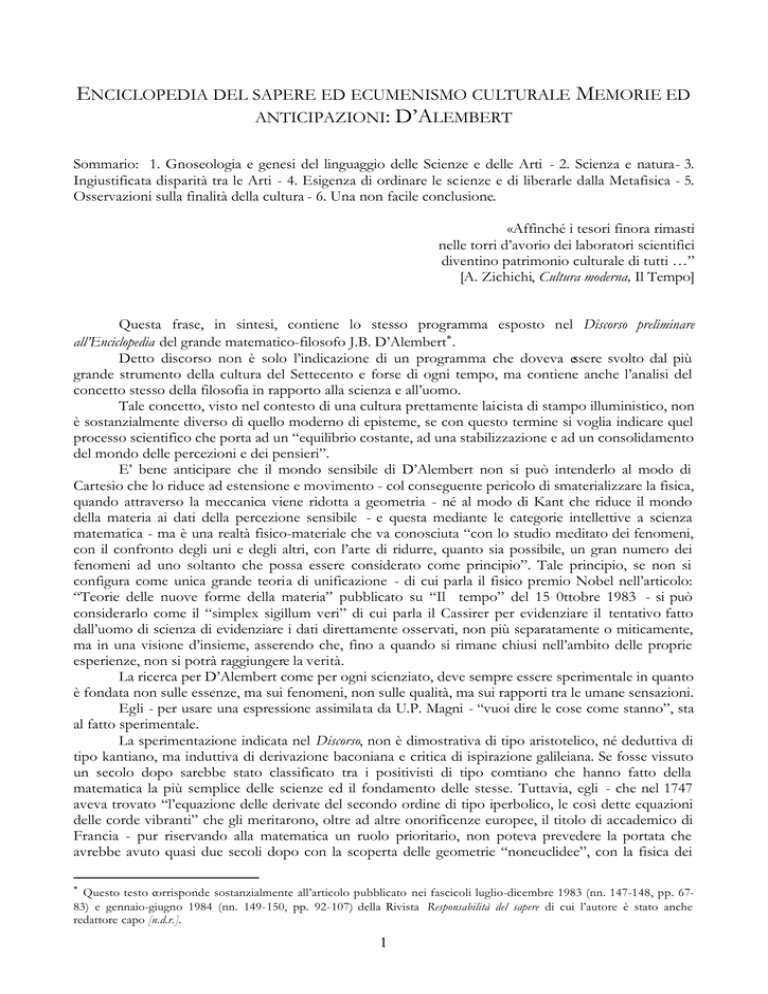
ENCICLOPEDIA DEL SAPERE ED ECUMENISMO CULTURALE MEMORIE ED
ANTICIPAZIONI: D’ALEMBERT
Sommario: 1. Gnoseologia e genesi del linguaggio delle Scienze e delle Arti - 2. Scienza e natura- 3.
Ingiustificata disparità tra le Arti - 4. Esigenza di ordinare le scienze e di liberarle dalla Metafisica - 5.
Osservazioni sulla finalità della cultura - 6. Una non facile conclusione.
«Affinché i tesori finora rimasti
nelle torri d’avorio dei laboratori scientifici
diventino patrimonio culturale di tutti …”
[A. Zichichi, Cultura moderna, Il Tempo]
Questa frase, in sintesi, contiene lo stesso programma esposto nel Discorso preliminare
all’Enciclopedia del grande matematico-filosofo J.B. D’Alembert∗ .
Detto discorso non è solo l’indicazione di un programma che doveva essere svolto dal più
grande strumento della cultura del Settecento e forse di ogni tempo, ma contiene anche l’analisi del
concetto stesso della filosofia in rapporto alla scienza e all’uomo.
Tale concetto, visto nel contesto di una cultura prettamente laicista di stampo illuministico, non
è sostanzialmente diverso di quello moderno di episteme, se con questo termine si voglia indicare quel
processo scientifico che porta ad un “equilibrio costante, ad una stabilizzazione e ad un consolidamento
del mondo delle percezioni e dei pensieri”.
E’ bene anticipare che il mondo sensibile di D’Alembert non si può intenderlo al modo di
Cartesio che lo riduce ad estensione e movimento - col conseguente pericolo di smaterializzare la fisica,
quando attraverso la meccanica viene ridotta a geometria - né al modo di Kant che riduce il mondo
della materia ai dati della percezione sensibile - e questa mediante le categorie intellettive a scienza
matematica - ma è una realtà fisico-materiale che va conosciuta “con lo studio meditato dei fenomeni,
con il confronto degli uni e degli altri, con l’arte di ridurre, quanto sia possibile, un gran numero dei
fenomeni ad uno soltanto che possa essere considerato come principio”. Tale principio, se non si
configura come unica grande teoria di unificazione - di cui parla il fisico premio Nobel nell’articolo:
“Teorie delle nuove forme della materia” pubblicato su “Il tempo” del 15 0ttobre 1983 - si può
considerarlo come il “simplex sigillum veri” di cui parla il Cassirer per evidenziare il tentativo fatto
dall’uomo di scienza di evidenziare i dati direttamente osservati, non più separatamente o miticamente,
ma in una visione d’insieme, asserendo che, fino a quando si rimane chiusi nell’ambito delle proprie
esperienze, non si potrà raggiungere la verità.
La ricerca per D’Alembert come per ogni scienziato, deve sempre essere sperimentale in quanto
è fondata non sulle essenze, ma sui fenomeni, non sulle qualità, ma sui rapporti tra le umane sensazioni.
Egli - per usare una espressione assimilata da U.P. Magni - “vuoi dire le cose come stanno”, sta
al fatto sperimentale.
La sperimentazione indicata nel Discorso, non è dimostrativa di tipo aristotelico, né deduttiva di
tipo kantiano, ma induttiva di derivazione baconiana e critica di ispirazione galileiana. Se fosse vissuto
un secolo dopo sarebbe stato classificato tra i positivisti di tipo comtiano che hanno fatto della
matematica la più semplice delle scienze ed il fondamento delle stesse. Tuttavia, egli - che nel 1747
aveva trovato “l’equazione delle derivate del secondo ordine di tipo iperbolico, le così dette equazioni
delle corde vibranti” che gli meritarono, oltre ad altre onorificenze europee, il titolo di accademico di
Francia - pur riservando alla matematica un ruolo prioritario, non poteva prevedere la portata che
avrebbe avuto quasi due secoli dopo con la scoperta delle geometrie “noneuclidee”, con la fisica dei
∗
Questo testo corrisponde sostanzialmente all’articolo pubblicato nei fascicoli luglio-dicembre 1983 (nn. 147-148, pp. 6783) e gennaio-giugno 1984 (nn. 149-150, pp. 92-107) della Rivista Responsabilità del sapere di cui l’autore è stato anche
redattore capo [n.d.r.].
1
“quanti” di Planck e con la “relatività” di Einstein; per cui sotto l’influsso della gnoseologia lockiana e
della cosmologia newtoniana, ritiene che “il primo passo che si deve fare per la ricerca, consiste
nell’esaminare la genealogia e la filiazione delle nostre conoscenze, le cause che le hanno originate e i
caratteri che li distinguono, in una parola, nel risalire alle origini e alla formazione delle nostre idee.
Tralasciamo momentaneamente l’accennato problema gnoseologico per poter esaminare più da vicino
l’ambiente culturale del Settecento in cui il pensatore è vissuto per meglio comprendere le motivazioni
che lo hanno indotto a privilegiare l’indirizzo empirista inglese piuttosto che quello razionalista di
origine francese.
L’interesse per questo documento, attraverso il quale lo studioso può risalire alla comprensione
dell’ideale della cultura dell’illuminismo europeo, scaturisce dalla elaborazione del concetto di filosofia
reso possibile nella nuova atmosfera che si era formata sotto la spinta cartesiana.
Questo famoso testo d’altra parte nulla di più ci dice di quanto era conosciuto delle scienze e
della filosofia del tempo: di Cartesio, di Bacone, di Galileo, di Newton, di Hobbes, di Locke, di Leibniz
ecc. Vi si trova in esso contenuta la gnoseologia del Condillac, il cui sensismo non si era spinto fino al
materialismo; la critica della metafisica classica; la fondazione di una morale su basi utilitaristiche di tipo
humiano; la tendenza, infine, a svalutare il passato, visto come una congerie di fatti permeati di errori ai
quali lo storico deve guardare col chiaro intento di conoscere per giudicare, di capire per condannare.
Voltaire, che è un esponente chiave della nuova interpretazione della storia, non esita a giudicare
passionalmente le varie epoche della storia ritenendo che l’epoca classica della ragione sia molto
superiore, non solo al medioevo, ma anche alla tanto vantata antichità, per intelligenza e conoscenza.
Il D’A è meno intransigente - anche se alquanto pungente verso i monarchi che mal regnarono
e tiranneggiarono i sudditi, apprezzando, invece, coloro che operarono per i bene dell’umanità e
ponendo la conoscenza storica sul piano della natura, da la netta sensazione di voler condannare i
cartesiani che mitizzano la storia; e si delinea, invece, per una impostazione scientifica di tipo vichiano.
“La cronologia e la geografia sono i due polloni e i due sostegni della scienza di cui parliamo: una, per
cosi dire, situa gli uomini nel tempo, l’altra li distribuisce nel ostro globo.
Ognuno di questi motivi costituisce il leit-faden della filosofia del Settecento francese e dei vari
dizionari enciclopedici di quel periodo.
Nulla di più, dunque, di un riassunto di quanto si conosce sul valore della cultura del tempo
attraverso la più vasta opera di filosofia, se non ci fosse un elemento nuovo rispetto alle altre
enciclopedie, che costituisce la parte certamente più significativa della grande opera: il dizionario
ragionato. Infatti il Discorso preliminare del D’Alembert è diviso in due parti. Nella prima viene esaminata
la struttura della scienza umana nello spirito del sensismo condillachiano e dell'empirismo lockiano;
nella seconda, invece, è contenuto il programma del discorso ragionato riferentesi alle scienze, alle arti
ed ai mestieri. In essa, come si vedrà in seguito, si riaffaccia il così detto problema della tecnica nello
spinto della scienza galileiana.
L’enciclopedia, come tale, non è solo uno strumento della cultura, intesa in senso antimetafisico,
ma vuole indicare all’uomo le vie più opportune per realizzare quella emancipazione della ragione che
Kant attribuirà in modo particolare all’uomo del diciottesimo secolo. Croce in proposito scrive in
“Teoria e storia della storiografia” che viene il momento in cui gli uomini imparano a pensare
rettificando le loro idee e tutta la storia passata si dipinge ai loro occhi come il mare tempestoso a chi è
sbarcato sulla terra ferma. Certamente nei nuovi tempi non ogni cosa è da lodare, anzi molto è da
biasimare... Tutti sentono, e dicono, che si è usciti non solo dalle tenebre ma dai chiarori antelucani e il
sole della ragione è alto sull’orizzonte e rischiara gli intelletti e li irradia di una luce vivissima. “Luce”,
Rischiaramento, onde il nome di età dei lumi o illuminismo che si da a quel periodo che va da Cartesio
a Kant. Tra questi due filosofi ed entro quell’arco di tempo si sono svolte, non solo le filosofie
razionaliste entro e fuori la Francia, ma anche quelle empiriste di stampo inglese, care al D’Alembert
che voleva diffonderle nel mondo della cultura europea ancora legata agli schemi della metafisica
tradizionale da cui la ragione non si era ancora svincolata per camminare più spedita sulla via della
esperienza lungo la quale è solo possibile la vera conoscenza.
2
Tale indipendenza della ragione da ogni mito e superstizione, appunto si realizza, dando
all’uomo gli strumenti più idonei per intendere, secondo il D’Alembert, la realtà senza ipotesi, come
voleva Newton nei suoi Principi matematici della filosofia naturale.
Una esatta comprensione del testo del D’Alembert, dunque richiede che si studino i due aspetti
già indicati: il significato della filosofia quale risulta dall’esame delle conoscenze umane ed il problema
della tecnica quale compare nelle indicazioni programmatiche del dizionario ragionato. I due aspetti
sono indivisibili.
Altra avvertenza opportuna da fare è che l’inquadramento di tale celebre testo non può che farsi
sotto la spinta di una storiografia storicistica, in cui cioè si cerchi di ripetere il significato di quelle opere
nel senso che essa ha reso possibile una determinata idea dell’uomo e della comunità.
Questa tendenza storicistica, d’altra parte, è quanto di meglio ha prodotto la storiografia di
questi ultimi anni in rapporto allo studio dell’età dei lumi. Dopo la critica di Croce all’antistoricismo
illuministico, si sono levate varie voci per rivendicare alla filosofia del Settecento una determinata
concezione della storia. I nomi più importanti di questo rinnovato bisogno di storicizzare quel grande
periodo sono come è noto: Dilthey, Cassirer, Meinecke, che hanno fatto vedere come già nel
Settecento, e quindi prima che comparissero sull’orizzonte le filosofie di Herder e di Hegel, si era avuto
un grande movimento storico, che aveva reso possibile un esame positivo dei fatti (sociali, politici ecc.)
contro la tendenza all’immobilità del sapere, che aveva nella matematica, secondo l’idealismo, il suo più
celebre esempio. Anche in Italia questo nuovo tipo di storiografia ha dato qualche frutto importante.
Dapprima il Luporini ed il Bobbio hanno ripetuto, sia pure con intenti diversi, le varie fasi del
processo culturale illuministico, rompendo gli schemi della storiografia crociana. A questi studiosi si
sono aggiunte le indagini ispirate al cosiddetto metodologismo che vede nell’illuminismo un
antagonismo saliente di una storiografia laica, libera da sovra strutture teologiche. Sono significative
“Les lettres sur l’àme” di Voltaire del 1738. Il Luporini riferisce che Voltaire non tralascia occasione per
far trasparire il suo disprezzo verso la religione in genere ed i ministri di culto in particolare. Su
trentasette protestanti che vivono in Inghilterra felicemente insieme solo i Quaccheri si salvano dai suoi
strali avvelenati per le loro virtù, la loro semplicità di vita, il loro spirito di uguaglianza, il loro pacifismo
e antimilitarismo e la loro capacità di iniziativa commerciale; ma quando si tratta, però, dei loro riti e
cerimonie religiose, non esita a gettarvi sopra il ridicolo. Ma Voltaire, che pure ebbe nel suo tempo tanti
ammiratori e non poco seguito, non fu l’espressione più genuina dell’illuminismo francese ed europeo.
Rousseau fu un suo critico implacabile e D’Alembert non ne condivise gli eccessi, anche se ebbe il
merito, secondo il Meinecke, di aver sentito storicamente, più che il Montesquieu, lo spirito dei popoli
nella dimensione temporale, poiché gli fu “più a cuore seguire le sorti dei suoi ideali razionali, le loro
battaglie, sconfitte, vittorie attraverso i tempi”.
Ed è questa nuova capacità della filosofia che la rende idonea ad intendere il significato delle
diverse epoche nelle quali di volta in volta debbono considerarsi concluse ed esaurite le possibilità
esistenziali dell’uomo. Certamente l’uomo dell'illuminismo è quello espresso dalla borghesia, cioè di una
classe in ascesa che rivendica quei diritti di libertà che le monarchie di quel periodo vanamente
cercavano di conculcare.
E’ evidente che ad ognuna di queste tendenze storiografiche, corrisponde un tipo di valutazione
del Discorso preliminare.
Al di la di tutte le possibili interpretazioni storicistiche e storiografìche si cercherà quanto più
possibile di rimanere aderenti al testo ed al pensiero dell’autore. Si terrà presente che il D’Alembert. sulla scia del Traité des système del Condillac, alla luce delle “Regulae philosophandi” di Newton e non
ignorando il “Discours de la methode” di Cartesio cerca una nuova logica, che non è quella del
sillogismo aristotelico, né quella del concetto scolastico, né la logica matematica cartesiana, ma quella
dei fatti, dei fenomeni della natura. Fenomeni che appaiono all’intuizione sensibile come fatti unitari,
come complessi indivisi. Per una reale spiegazione dei fenomeni, non basta la sola descrizione dei
contorni, il loro modo di svolgersi, il loro puro cos’è; ma solo in quanto un avvenimento
apparentemente semplice si scompone nei suoi elementi e lo si ricostruisce con gli stessi elementi, si
acquista la piena comprensione. Questa metodologia introdotta da Newton per la conoscenza della
3
natura viene indicata nel Discorso preliminare come valida anche per una indagine metafisica in cui il
pensiero umano incontra i suoi limiti.
1. GNOSEOLOGIA E GENESI DEL LINGUAGGIO DELLE SCIENZE E DELLE ARTI
Dare un giudizio sull’impostazione del problema gnoseologico di D’Alembert, senza tener
presente la filosofia che ha maggiormente influito sul suo pensiero, sarebbe, se non semplicistico,
quanto meno acritico.
Se il D’Alembert riconosce a Bacone il merito di aver saputo impostare in modo sistematico il
metodo della scienza sperimentale e non aveva notato che malgrado il Novum organum era rimasto sul
piano critico legato allo studio delle forme e delle essenze, secondo gli schemi logici degli aristotelici e
della scolastica decadente; aveva, però, intravisto che il fine della conoscenza scientifica (per Bacone)
era preminentemente pratico, in quanto l’accostamento alla natura per la scoperta delle leggi doveva
essere finalizzato al progresso dell’umanità e non a discussioni sterili.
Il D’Alembert ben conosce che oltre a Bacone anche Galileo e Cartesio muovono serrate
critiche al formalismo della scolastica decadente. E poiché quest’ultimo ha osservato che lo sterile
sillogismo è incapace di giustificare le premesse e non riesce a produrre nuova scienza, ricorre alla
matematica, unica che parta da principi certi e conduca a conoscenze vere. E poiché la matematica è la
scienza dell’“ordine”, egli la applica a tutte le scienze. Questo matematismo lo porterà a quell’innatismo
di tipo platonico che separerà il mondo delle cose dal mondo delle idee.
Da un simile dualismo prenderanno posizione i filosofi dell’epoca sia in senso razionalista che in
quello empirista. Il D’Alambert, sente il fascino di questa ultima filosofia e prendendo a modello il
Saggio sull’intelletto umano del Locke imposta il problema gnoseologico distinguendo le conoscenze in
dirette e riflesse, riducendo però quest’ultime a sensazioni secondo il modo indicato dal Condillac.
Le prime conoscenze sono “quelle che riceviamo immediatamente e senza alcuna operazione
della nostra volontà. Riflesse sono quelle che lo spirito acquista operando sulle dirette, unendole e
combinandole tra loro”. Le conoscenze in ordine, sono quelle che si riferiscono al soggetto e agli
oggetti esterni.
Il programma, come si è accennato, è in linea con quello lockiano; solo attraverso un
convincimento pratico è possibile dire se le sensazioni siano il prodotto di oggetti esterni. Questi
oggetti, però, esistono e “le nostre sensazioni hanno m realtà fuori di noi la causa che attribuiamo loro,
poiché l'effetto che può risultare dalla esistenza reale di questa causa non differirebbe in alcuna maniera
da quello che proviamo veramente”.
La gnoseologia del D’Alembert, direbbero gli idealisti, è una forma di realismo ingenuo, in cui
non è entrato il problema critico riguardante cioè l’analisi di quelle forme che rendono possibile il
conoscere stesso. In modo altrettanto ingenuo ammette l’esistenza di altri esseri simili al soggetto che
provano le stesse impressioni e le stesse sensazioni. Ciò che spinge il soggetto a scoprire l’esistenza degli
altri è un semplice motivo edonistico: la necessità cioè di scoprire quegli individui che non contrastino il
sentimento di piacere che prova il soggetto. Da questo istinto sorge anche il problema della
“comunicazione” resa possibile dalle idee, e quindi la nascita della società.
L’ipotesi appena accennata d'uno stretto legame tra l’origine del linguaggio e l’evoluzione della
società, non ha trovato i linguisti sempre allineati. Leibniz che aveva letto il De corpore di Hobbes, aveva
trovato interessante il rapporto tra il segno e la struttura linguistica come tramite essenziale del discorso
umano - concepì, nella “Dissertazione” del 1666, l’idea di un linguaggio universale dalla scomposizione
analitica dei concetti, asserendo che vi era una profonda relazione tra la verità e il complesso dei segni
che asseriscono la verità.
La teoria ha riecheggiato tra i linguisti moderni, e il Cassiner, facendo riferimento al Nouveaux
essais sur l’entendement humaine di Leibniz, scrive che il problema di una lingua adamitica aveva interessato
pensatori e mistici fino al XVIII secolo. “Senza il linguaggio, nessuna comunità potrebbe esistere; anzi
l’ostacolo maggiore per la convivenza di tale comunità”, si continuava a dire non senza contraddizione,
sarebbe costituito dalla diversità delle “favelle”. Il mito, le religioni, si rifiutano di considerare queste
diversità di linguaggio, come qualche cosa di necessario e di inevitabile per la comunità. L’ipotesi, poi,
4
che l’evoluzione proceda dal semplice al complesso - cui aderirebbe, come vedremo in seguito il
D’Alembert - non è sostenuta sov ente dai dati sperimentali; e la moderna linguistica sembra dar ragione
all’antropologo e linguista tedesco Franz Boas quando in La mentalità dell’uomo primitivo, porta ad
esempio il linguaggio. “Molte lingue primitive, egli scrive, sono complesse : lievi sfumature di punti di
vista vengono espresse per mezzo di forme grammaticali; e le categorie grammaticali del latino e ancor
più quelle dell’inglese moderno, appaiono rozze se paragonate con la complessità delle forme
psicologiche e logiche che le lingue primitive conoscono ma che sono ignorate dal nostro discorso”.
Sono dello stesso parere altri linguisti moderni, come il Sapir che così scrive: “Per comprendere
bene una lingua e un popolo è necessario tralasciare ogni pregiudizio ed ogni preferenza e considerare
sullo stesso piano l’inglese e l’ottomano con lo stesso distacco e disinteresse” per cui non si può parlare
di stretta connessione tra complessità ed evoluzione della lingua e sviluppo della civiltà intesa in senso
occidentale; come intenderebbe il D’Alambert. Questi infatti legato alla concezione empirista di tipo
sensista, muove dal condillachiano linguaggio d’azione inizialmente confuso e giunge attraverso i gesti
naturali al linguaggio articolato e con la parola al linguaggio artificiale quale quello matematico. Scrive
infatti il D’Alembert che “le lingue nate con le società non furono dapprima che una collezione assai
bizzarra di segni di ogni specie e i corpi naturali che cadono sotto i nostri sensi furono in conseguenza i
propri oggetti designati mediante dei nomi”. Perciò, cominciarono a ridurre i segni in parole, poiché
queste sono, per così dire, i simboli che hanno più facilmente sottomano.
Da quanto è stato appena riportato, si può notare che l’autore del Discorso, pur rimanendo legato
alla teoria signistica, abbia intravisto, senza prevederne gli sviluppi, l’importanza della teoria simbolica
che tanta fortuna ha ancora oggi tra i linguisti, i quali si dibattono sull’origine e sulla natura del
linguaggio; se questo sia un organismo e se la linguistica sia una scienza naturale o una scienza dello
spirito.
Che è come dire ciò che il D’Alembert afferma subito dopo quando scrive: “l’ordine della
generazione delle parole dovette seguire l’ordine stesso della generazione dello spirito”, da cui derivano
le varie attività pratiche e teoretiche.
Le origini delle scienze e delle arti sono legate direttamente ai bisogni dell’uomo. Ad essi si può
supplire in due modi: con opere particolari o con la collaborazione degli altri uomini. Sono sorte in
questo modo nell’ordine: l’agricoltura, la medicina e le arti di prima necessità.
Gli uomini all’inizio della storia, erano avidi di “conoscenze utili”; solo in un secondo tempo,
rivolsero la loro attenzione alla speculazione oziosa. Fanno eccezione a questa origine edonistica delle
nostre conoscenze quelle che si riferiscono a Dio, alla sopravvivenza della nostra anima e ai doveri che
legano l’uomo a Dio; ma anch’esse, poi, sono considerate il frutto delle prime idee riflesse occasionate
dalle nostre sensazioni. Così l’origine delle nostre conoscenze trova, in tal modo una duplice
spiegazione: da una parte essa è legata alle impressioni e alle capacità di rielaborarle, dall’altra si collega
direttamente ai bisogni con i quali l’uomo fa sentire la sua presenza nel mondo.
La prima applicazione pratica della conoscenza si ha nella formazione e nello sviluppo delle
scienze della natura. Anche queste scienze, avverte il D’Alembert, sono fatte dagli uomini, “in parte per
necessità e in parte per passatempo”. L’albero genealogico delle scienze descritte dal D’Alembert non
differisce dal programma scientifico dell’epoca. In ordine vengono enumerate: la fisica, la geometria,
l’agricoltura e l’algebra. Queste sono le scienze più astratte, in quanto partono dal movimento e dalla quiete
(primi elementi del corpo) e poi si sviluppano come analisi delle proprietà geometriche degli oggetti e
dei relativi strumenti di calcolo. La concezione del D’Alembert non va oltre una definizione meramente
meccanicistica di derivazione cartesiana e galileiana. A queste discipline, che il Comte più tardi
considererà nell’ordine della generalità decrescente si aggiungono quelle fisico-matematiche, come
l’astronomia e la fisica sperimentale stessa. Esse completano quello spirito positivo che è appunto negli
intenti meramente scientifici della cultura del Settecento.
Importante è notare che l’intento del D’Alembert non differisce da quello degli altri studiosi
francesi dell’epoca, come il Lamettrie e l’Holbach. E’ un programma materialistico, dunque, che
esclude qualsiasi proprietà misteriosa della natura e che non si possa ridurre negli schemi immutabili
della matematica. Probabilmente tale materialismo, oggi si potrà giudicarlo ingenuo (come l’aveva,
per altro verso, giudicato astratto il Berkeley); tuttavia il D’Alembert ha l’innegabile merito di aver
5
tracciato le linee di una indagine del mondo naturale senza precedenti e su basi direttamente
sperimentali. La preoccupazione del D’Alembert, infatti, non è quella di stabilire un rapporto tra la
natura e l’uomo al modo dei filosofi rinascimentali - i quali risolvevano il problema più sul piano storico
che su quello scientifico, essendo la storia non limitata al solo rapporto tra gli uomini, ma anche tra
questi e la natura - sibbene quella di attuare la possibilità di uno studio della proprietà del mondo che,
pur considerato oggettivo e irrefutabile sulla base della sperimentazione, per chi “sapesse abbracciarle
da un sol punto di vista, non sarebbe, se è permesso dirlo, che un fatto unico ed una unica verità”.
2. SCIENZA E NATURA
Ecco cosa dice il D’Alembert: “Non dunque con ipotesi vaghe ed arbitrarie possiamo sperar di
conoscere la natura, ma con lo studio meditato dei fenomeni, con il confronto degli uni e degli altri, con
l’arte di ridurre quanto sia possibile, un gran numero di fenomeni ad uno soltanto che possa essere
considerato come principio”.
A questo punto sorgono spontanee due considerazioni: la prima è che la metodologia della
ricerca del D’Alembert è legata al programma di Newton: “hypotheses non fingo”; la seconda è che lo
studio dei fenomeni è finalizzato alla ricerca del principio unitario della natura.
Per quanto riguarda il primo punto si dovrebbe accettare l’esplicito rifiuto in senso assoluto, di
ogni ipotesi, se a queste non avesse fatto seguire due aggettivi limitativi: vaghe e arbitrarie. Ciò può far
pensare che le ipotesi che non sono vaghe ed arbitrarie possono essere utili alla ricerca. Se si potrà
provare ciò, la metodologia da lui indicata non si discosterebbe alquanto da quella che si è configurata
da Galileo ai nostri giorni. Infatti quando affronta il problema della conoscenza, e asserisce che questa
non può che aver inizio nelle sensazioni, scrive che “in buona filosofia ogni deduzione che abbia a
fondamento fatti e verità riconosciute, è preferibile a quanto non sia appoggiato che ad “ipotesi”, sia
pure ingegnose”. E’ chiaro che qui si tratta di fatti e verità evidenti, e come tali non v’è alcun bisogno di
ipotesi e tanto meno di quelle ingegnose. Se a ciò si aggiunge che il rifiuto di cui innanzi può riferirsi,
come è più attendibile, all’uso che la scolastica decadente ha fatto di detta ipotesi, sino a farla “scadere a
finzione fisica priva di valore scientifico”, si può comprendere più chiaramente quanto egli asserisce
quando parlando delle scienze matematiche scrive che “molte di queste, fondate come sono su principi
fisici cioè su verità di esperienza o su semplici “ipotesi”, non hanno, per così dire, che una certezza di
esperienza od anche di mera supposizione”. Ciò detto è superfluo evidenziare il ruolo che il
D’Alembert ha riservato alle ipotesi per lo studio della fisica in generale e della meccanica in particolare.
Per quanto riguarda il secondo punto il D’Alembert avverte che “quanto più si riduce il numero
dei principi di una scienza, tanto maggiore estensione si dà a ciascuno di loro; poiché essendo l’oggetto
di una scienza necessariamente ordinato, i principi applicativi a questo oggetto saranno tanto più
fecondi, quanto meno saranno numerosi”. E’ appena da osservare che in base a questi criteri, Newton
ha scoperto la legge di gravita e Kant postulerà più tardi con Laplace una nuova teoria cosmologica. Ma
non basta. In base agli stessi criteri sembra che il D’Alembert abbia intuito, con la scoperta delle
«equazioni delle onde luminose”, ciò che il fisico inglese Pr. Nobel Paul Dirac tenterà circa due secoli
dopo, una saldatura tra le “teorie della relatività” e la “meccanica ondulatoria” che stanno alla base delle
rispettive unificazioni; la prima del macrocosmo e la seconda del microcosmo con la scoperta delle
equazioni “ondulatorie e relativistiche”.
L’accostamento Dirac-D’Alembert potrebbe sembrare al quanto forzato se non si fosse sorretti
da una profonda considerazione che il D’Alembert fa a proposito delle singolari proprietà della
calamità. Così egli scrive: “In mancanza di una tale conoscenza, e quindi dei lumi che sarebbero
necessari per conoscere la causa fisica delle proprietà della calamità, sarebbe indubbiamente oggetto
degno delle ricerche di un filosofo il ridurre, se possibile tutte queste proprietà ad una sola, mostrando il
legame che esse hanno tra loro. Ma quanto più una tale ricerca sarebbe utile al progresso della fisica
tanto più abbiamo ragione di temere non debba essere preclusa ai nostri sforzi. E dico il medesimo d’un
gran numero d’altri fenomeni il cui concatenamento dipende forse dal sistema generale del mondo”.
Il discorso sulla natura della conoscenza ed origine delle arti, non poteva non considerarsi
nell’indagine “dei limiti del sapere”. Ed è questa, infatti, la terza parte del discorso di prefazione
6
all’Enciclopedia. Ma sarebbe un’aspettativa deludente se, iniziando la lettura di questa ultima parte del
discorso, ci si aspettasse di trovarvi osservazioni improntate ad uno spirito critico veramente valido. I
limiti del nostro sapere, infatti, sono per il D’Alembert quegli stessi che scaturiscono dalla gnoseologia
di tipo sensitivo. I limiti del conoscere, sono cioè connaturati sia alla conoscenza dei corpi come a
quelle realtà che cadono nel dominio della matematica. Dice il D’Alembert, con una immagine efficace,
che, “l’universo potrebbe essere paragonato a certe opere sublimi ed oscure, i cui autori, con
l’abbassarsi di tanto in tanto alla portata del lettore, sembrano volerlo convincere di intendere tutto. Da
ciò si evince che la possibilità di errore segue, dunque, di pari passo la formazione del sapere, ed il
riconoscimento dei limiti di questo è connaturato, in parte, alla capacità di esprimerlo. Con una
espressione che ci sembra molto moderna, possiamo dire che il D’Alembert vede nel linguaggio una
delle “prime” cause dell’errore.
Infatti nella metodologia della ricerca - da Galileo ad oggi - lo scienziato deve fare uso della
fantasia per la formazione delle ipotesi; e talvolta detta fantasia viene condizionata dal linguaggio, il
quale secondo Linneo è connesso con la scienza senza soluzione di continuità. Pertanto l’assertore del
creazionismo - che nel classificare le piante e gli animali aveva creato una nuova terminologia avente
valore verbale e reale mai confutata neppure dallo stesso Darwin - poteva dire che “nomina si nescis,
perit et cognitio rerum”.
Inoltre lo scienziato, per la soluzione dei problemi, avanza ipotesi, elimina continui errori che
incontra necessariamente lungo il difficile cammino della ricerca, facendo così passare “un’ipotesi dal
mondo delle opinioni personali al mondo delle teorie oggettive”.
Una teoria scientifica, secondo il Popper, se è tale deve essere provata, e “per essere provata di
fatto deve essere provabile, cioè controllabile, cioè ancora falsificabile; e provare una teoria non vuol
dire altro che tentare di falsificarla, di coglierla in fallo”.
Come si vede, dall’affermazione del D’Alembert, che ravvisa nel linguaggio una delle prime
cause dell’errore nella ricerca scientifica, al Popper, che ricerca nella teoria gli eventuali errori da
eliminare per il progresso scientifico, il passo è breve. Ma ciò che il D’Alembert e l’epistemologia
moderna imputano al linguaggio, lo aveva avvertito anche Bacone.
Come è noto Bacone aveva considerato una classe particolare che egli chiamava “idola fori” che
producono facilmente convinzioni a cui non corrisponde alcuna realtà. A questo proposito il
D’Alembert consiglia di ridurre il numero degli assiomi e di servirsi di essi solo in rapporto alla loro
utilità.
Il riconoscimento dei limiti del sapere è un invito a restringere il nostro conoscere nell’ambito di
quelle scienze che si riferiscono all’uomo. E qui il D’Alembert ci mette di fronte ad un nuovo elenco di
scienze: logica, grammatica, retorica, storia e politica, ognuna delle quali è poi suddivisa in tante altre. L’elenco
risponde ad esigenze di sistematicità e non presenta in sé nessun carattere originale. Vi si sente piuttosto
la preoccupazione dell’ideale della scienza, com’era vista nell’illuminismo. I sentimenti del piacevole e
dello sgradevole presiedono anche alla formazione delle “arti” delle quali l’ideale non va, ad ogni modo,
al di là della semplice imitazione. Ideale estetico, dunque, meramente utilitaristico, che ispira la poesia, la
pittura, la scultura e via dicendo. D’altra parte è questo l’ideale propugnato dall’illuminismo e sarebbe
assurdo pretendere che il discorso preliminare del D’Alembert contenesse delle indicazioni diverse. In
definitiva, l’ideale della scienza del D’Alembert è ispirato ad un criterio di sana utilità.
Le scienze e le arti sorgono via via che i bisogni dell’uomo si fanno più necessari. Scrive, infatti,
il D’Alembert che “quanto meno i bisogni sono immediati e quanto più sono difficili da soddisfare,
tanto più le conoscenze richieste sono lente ad apparire”.
L’Uomo, per sua natura, posto di fronte alla realtà considerata nella sua complessità, esplica una
duplice attività: teoretica e pratica. La prima in funzione conoscitiva, la seconda in quella operativa. Il
D’Alembert rivolge la sua attenzione anche a questa seconda parte per evidenziare il ruolo che le arti ed
i mestieri hanno avuto, lungo il corso dei millenni, nel progresso tecnico scientifico oltre che in quello
estetico, economico sociale e culturale in genere. Sarà bene, pertanto, prima di trattare della seconda
parte del Discorso, esaminare il problema dell’arte a cui l’Autore ha riservato un ruolo non meno
importante della filosofia e che tanta parte ha avuto nella cultura del settecento.
7
Alla filosofia che si riferisce in modo particolare alla conoscenza diretta della natura, segue l’arte
che è una “specie di conoscenza riflessa consistente nelle idee che ci formiamo immaginando e
comprendendo esseri simili che sono oggetto delle nostre idee dirette”. Con questo concetto il
D’Alembert prende in esame il problema dell’arte muovendo per un verso dai filosofi che per primi
hanno trattato con competenza e sistematicità l’assunto; per l’altro tentando quella sintesi che più tardi
opererà Kant con la Critica del giudizio. Prima di Kant l’arte veniva considerata sotto un duplice aspetto:
teoretico e pratico; in entrambi i casi non aveva una realtà o valore proprio. Essa come il linguaggio
oscilla tra gli opposti poli dell’oggettivo e il soggettivo. Nel primo caso l’arte è rivolta all’imitazione che
da Platone in poi riguarda le cose e la natura fisica.
Sotto questo punto di vista l’arte è riguardata più in senso negativo che positivo, come copia
delle copie; e ciò in linea con l’atteggiamento polemico assunto da Platone nei confronti della mentalità
greca del suo tempo in cui veniva esaltata la passionalità degli uomini e ancor più degli Dei. Ciò è
evidenziato nei poemi omerici come nelle tragedie di Eschilo, di Sofocle, di Euripide oltre che nella
lirica anacreontica e pindarica.
Se da una parte la riduzione dell’arte al mondo sensibile ha portato Platone alla svalutazione
della stessa, dall’altra l’animo poetico dello stesso (Platone) ha finito per valorizzare l’irrazionalismo
delle passioni e dei sentimenti fino ad assumere le forme più elevate nel Convito e nel Fedro. In detti
dialoghi oltre che nel libro X della Repubblica Platone smentisce la sua avversione per l’arte, ritenendola
indispensabile viatico verso lo splendore della Bellezza cui è possibile giungere attraverso la natura
sensibile. Tuttavia il mondo naturale sensibile e l’irrazionale umano se considerato in se stesso, avulso
dal mondo intelligibile potrebbero configurare un regno fondato sulle passioni e sulla sensualità
corruttrici dell’individuo e della collettività. Invece l’artista che opera, come il Demiurgo, nel sensibile
avendo davanti allo spirito il mondo intelligibile delle idee, tende come Eros, figlio della Miseria e della
Ricchezza, a distaccarsi dal mondo materiale sensibile per attingere la Bellezza che è EssereBene.
L’arte così intesa non è più imitazione della natura considerata in sé staticamente, ma nel suo
divenire, come vedrà in seguito meglio Aristotele, per cui l’artista deve saper cogliere l’universale
immanente nella natura per far risultare nella produzione la copia più bella del modello. Partendo da
questo concetto si svilupperà nel corso di due millenni e particolarmente tra il XVI e il XVIII secolo
quella teoria che sarà definita della imitazione della “Bella Natura ”. Sotto questo riguardo Aristotele
poteva rispondere ad un critico dell’epoca che era bene che Zeusi ritraesse immagini di uomini così belli
che non avevano riscontro nella realtà, “perché l’artista deve migliorare il modello a cui si ispira”.
Questa teoria durerà fino al 1700 quando con La nuova Eloisa di Rousseau si passò dall’arte
mimetica a quella caratteristica, o meglio dalla mera riproduzione alla creatività.
Non più imitazione della natura, ma spontanea espressione dei sentimenti, Il romanzo - che si
svolge nell’arco di più di un decennio fino alla morte di Eloisa avvenuta nel 1745 - mette in evidenza
soprattutto i sentimenti e le idee; “sentimenti e sensazioni osservati nelle più lievi sfumature, spesso con
una stupefacente penetrazione e sottigliezza che li insegue nei più riposti meandri”. I personaggi a
cominciare da Giulia non sono in fondo che i vari aspetti della complessa personalità dello stesso
autore, per cui il romanzo in ultima analisi, non è che un esame introspettivo che mette in evidenza il
carattere dello scrittore. A giudizio di Madame d’Epinay (nel romanzo) “è sempre l’autore che parla”.
L’artista è un creatore di forme, quasi un “semidio”, scrive il Cassirer riferendo il pensiero di
Goethe, che infonde il suo spirito nella materia. Tale sentimento è fondato non più sull’elemento
oggettivo, ma soggettivo, non più legato al concetto di Bellezza, ma alla creatività che non riproduce
una realtà data, ma la scopre.
Kant nella sua “Critica del Giudizio” distingue la bellezza d’arte da una bellezza naturale. “Una
bellezza naturale è una cosa bella; la bellezza d’arte è una rappresentazione bella di una cosa”. Per
giudicare una bellezza naturale come tale non c’è bisogno d’avere prima un concetto di ciò che deve
essere un oggetto; vale a dire, non c’è bisogno di conoscere di esso la finalità materiale, la sua semplice
forma, senza conoscenza dello scopo, piace per sé stessa nel giudizio. Ma se l’oggetto è dato come un
prodotto dell’arte e come tale deve essere dichiarato bello, bisogna appoggiarsi al concetto di ciò che
deve essere.
8
Quando per esempio si dice - riferisce testualmente Kant - “è una bella donna, non si pensa
altro che questo: la natura presenta bellamente in questa forma gli esempi che essa si propone nel corpo
femminile”. Ma l’arte bella non mostra la sua preminenza soltanto in questo, ma può anche rendere
belle quelle cose che in natura sono brutte o spiacevoli. I cataclismi, le malattie, le distruzioni della
guerra e simili (il terrorismo, la droga, l’aborto e ogni violenza in genere) possono essere molto
“bellamente descritte e anche essere rappresentate nei quadri”. Sotto questo riguardo il D’Alembert ritenendo quanto aveva asserito l’abate Batteax sul vero scopo dell’arte (nel suo libro Les beaux arts
reduits a méme principe del 1747) consistente non nella mera imitazione della natura in genere, ma nella
riproduzione solo di quella bella - poteva asserire per un verso che “l’imitazione della bella natura, su
cui tanti autori hanno scritto senza saperne dare un’idea chiara, sia perché la bella Natura non si
discerne che mediante un sentimento squisito, sia anche perché si tratta di una materia in cui i limiti che
distinguono l’arbitrario dal vero non sono ancora ben fissati e lasciano un certo margine dell’opinione
dei singoli”; per l’altro verso sembra anticipare quanto asserisce Kant circa il giudizio sull’opera d’arte e
della sua produzione. Se Kant poteva dire che per rendere bello ciò che è brutto e piacevole ciò che
spiacevole è necessario il genio, il D’Alembert poteva concludere - prendendo ad esempio la musica che non è possibile sperare che un ingegno ordinario sia capace di districare o di cogliere quelle
sfumature che solo l’uomo di genio può intuire, l’uomo di gusto può sentire e l’uomo di spirito
appercepire, mentre tutte queste cose sono perdute per la moltitudine. D’altra parte continua il
D’Alembert un musicista che non dipinga altro non produce che rumore... Tuttavia uno stesso
musicista attento a dipingere ogni cosa finirebbe col presentare, in molte circostanze, dei quadri
d’armonia non fatti punto per sensi volgari”.
Come si può notare il D’Alembert, nel valutare un’opera d’arte, distingue giudizio da giudizio.
C’è un giudizio dell’uomo di genio, di gusto, di spirito e della moltitudine o del volgo. Detti giudizi
potrebbero essere ridotti a due categorie: quelle del gusto ordinario e del gusto raffinato. Per usare la
terminologia kantiana potremmo dire: giudizio personale che non vuole avere la pretesa d’avere valore
universale e un giudizio valido universale che esige il consenso altrui.
Altra osservazione non meno interessante è quella che il problema estetico così impostato sia in
D’Alembert come in Kant sposta il suo baricentro più sul soggetto che sull’oggetto, per cui non si
dovrebbe parlare tanto di bello in sé, universalmente inteso, quanto di bello relativo al soggetto secondo
il vecchio adagio: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace universalmente senza concetto,
aggiunge Kant, in quanto la bellezza senza il riferimento al sentimento del soggetto non sussiste. Per cui
un giudizio che non fosse relativamente al piacere e al dispiacere (della bellezza) indipendentemente dal
concetto, non sarebbe un giudizio di gusto. Il D’Alembert sapeva bene -anche se non poteva giungere
al concetto di una universalità soggettiva estetica di tipo kantiano, perché per quanto si era distaccato
dalla razionalistica identità bellovero, non si era ancora accostato all’irrazionalismo - che il gusto non è
necessariamente connesso ai principi logici, ma poggia sulle percezioni sensibili quali: la vista, il tatto,
l’olfatto ecc.. In tal modo il D’Alembert, seguendo l’indirizzo empirista lockiano, addita a Hume la via
che porta la ragione di fronte al tribunale del sentimento, inducendo così la natura a rinunciare alla sua
sovranità in favore della fantasia che in conseguenza diviene la facoltà fondamentale dell’anima sul
piano estetico. In conseguenza di ciò se è vero che il singolo soggetto non può farsi giudice delle cose
della natura, è anche vero che esso è “l’unico giudice possibile chiamato a dare un giudizio del proprio
stato”.
Per cui l’intelletto, per il fatto che giudica delle cose che sono fuori di sé, può errare, mentre il
sentimento che non ha contenuti da giudicare fuori di sé, non può errare. Pertanto Hume poteva
concludere che si può dare un giudizio della Bellezza in senso oggettivo in quanto essa (bellezza) non è
una cosa, ma uno stato soggettivo dentro di noi. Come si può notare il punto di arrivo di Hume sul
piano estetico diviene il punto di partenza della critica del giudizio di Kant.
Allo stesso modo, partendo dall’empirismo lockiano, Hume sviluppa la sua filosofia
dell’esperienza giungendo con rigore logico fino allo scetticismo e D’Alembert imposta il suo discorso
preliminare all’enciclopedia.
Partecipano nell’ordine alla teoria della bellezza: l’architettura, la scultura, la pittura, la poesia, la
musica che per D’Alembert scaturiscono dalla necessità dell’uomo di elevarsi dalla vita primitiva ai gradi
9
sempre più alti di civiltà che per “il filosofo altro non è che la maschera abbellita dei nostri grandi
bisogni”.
3. INGIUSTIFICATA DISPARITÀ TRA LE ARTI
E’ interessante notare come il D’Alembert, nel mentre biasima l’ingiusta disparità creata da
millenni tra le arti liberali e quelle meccaniche e l’ingiustificato pregiudizio di superiorità delle prime
sulle seconde, esalta quest’ultima al punto da esortare letterati e filosofi a prendere coscienza della
nobiltà delle arti meccaniche che hanno consentito agli scienziati di realizzare quelle invenzioni e
scoperte essenziali per elevare le condizioni sociali, economiche, culturali e nonché morali dell’umanità;
e immortalare nel contempo coloro che in virtù del lento ma continuo graduale progresso delle stesse
arti meccaniche sono riusciti a far progredire le .scienze. Purtroppo, continua il D’Alembert, la società,
nel mentre ha giustamente esaltato gli uomini di scienza che l’hanno “illuminata nel mondo, non ha
fatto altrettanto per coloro che con le mani la servono”.
“Eppure è forse proprio tra gli artigiani che si devono cercare le prove più ammirabili
dell’acutezza dello spirito, della pazienza e delle sue risorse. I nomi di questi benefattori sono quasi
sempre sconosciuti, mentre la storia dei suoi distruttori, cioè dei conquistatori a nessuno è ignota”.
Senza l’artigianato, senza il lavoro manuale, non escluso quello dei campi, non vi sarebbe cultura
e pertanto non vi sarebbe progresso tecnico, scientifico, sociale, politico, economico, morale ecc. Quali
i segni delle civiltà passate se non vi fossero documenti, frammenti di scritte, di suppellettili, di vasi e
sarcofagi istoriati e non, di ruderi di mura, di edifici, templi ed ogni altra cosa prodotti dalla mano
dell’uomo e sepolti per millenni da strati di materiali accumulatisi in seguito a cataclismi, a distruzioni
provocati da fenomeni naturali o dalla perversa volontà degli uomini avidi di possesso?
In che cosa si distinguerebbe l’uomo dagli altri esseri morfologicamente simili se non avesse
lasciato i segni della subcultura mediante opere prodotte dalle sue mani? E quale opera prodotta dalle
mani dell’uomo, per modesta che sia, non riveli la presenza della sua intelligenza o che non sia permeata
della spiritualità e della personalità di colui che l’ha prodotta? Il lavoro qualunque esso sia è opera
dell’uomo, è espressione della sua dignità, è parte integrante della sua stessa vita morale. “L’uomo infatti
quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma anche perfeziona se stesso. Apprende
molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato ad uscire da sé ed a superarsi”.
Il lavoro così inteso ingloba ogni attività umana, teoretica, intellettuale e manuale, in quanto nel
lavoro fa confluire tutto sé stesso, la sua essenza di uomo. Il lavoro in tal modo si personalizza per cui
l’opera prodotta è la espressione del proprio spirito, della propria cultura, della propria creatività. Detto
lavoro non può essere inteso come forma materiale di stampo marxiano che produce mercé e capitale a
scapito dell’operaio, ma è una forza creativa, spirituale che arricchisce e perfeziona la personalità
rendendola capace di comunicare, con i mezzi di cui dispone, il proprio mondo interiore, rivelandosi in
qualche modo artista. Si potrebbe dire con Croce che ogni uomo nasce artista. “Meglio che: poeta
nascitur, andrebbe detto: homo nascitur poeta”.
Tra l’uomo comune e il grande artista c’è solo differenza quantitativa e non qualitativa. Detto
lavoro non è solo forza che produce, con i mezzi opportuni, beni per la sussistenza e il progresso
materiale dell’uomo, ma è soprattutto una forza spirituale posta nell’animo dell’uomo per migliorare la
sua esistenza, perfezionare la sua formazione, morale e religiosa, far crescere la sua personalità.
Una simile concezione è in netta opposizione con la cultura grecoromana e in particolare con
chi riteneva, in linea con la filosofia aristotelica, che il lavoro manuale è avvilente e spregevole, da
praticarsi solo dalle classi più umili e dagli schiavi incapaci di produrre, per la stessa condizione,
alcunché di bello. Ed è proprio contro questa mentalità che reagisce il D’Alembert il quale rimprovera
filosofi e letterati che quando non avessero operato in senso negativo, poco o nulla hanno fatto per
conoscere ed esaltare il reale contributo dato dalle arti meccaniche ed artigiane al progresso delle
scienze. “D’altronde - scrive D’Alembert - se devo credere ad alcuni filosofi che il disprezzo che si
nutre per le Arti non ha trattenuto dallo studiarle, vi hanno certe macchine così complicate e le cui parti
dipendono talmente l’una dall’altra, che è ben difficile si siano potute trovare se non da un solo uomo.
10
Questo genio raro il cui nome è sepolto nell’oblio, perché sarebbe stato in degno di essere collocato
accanto al piccolo numero di spiriti creatori, che hanno aperto strade nuove nelle scienze?”.
4. ESIGENZA DI ORDINARE LE SCIENZE E DI LIBERARLE DALLA METAFISICA
La seconda parte del Discorso del D’Alembert è una prefazione al Dizionario ragionato
dell’Enciclopedia. Questo dizionario, come è noto, riguarda i vari termini di cui l’Enciclopedia si
compone, nonché la storia delle singole scienze ed arti, sorte nel corso dei tempi. Questa seconda parte
della prefazione del D’Alembert tratta vari aspetti. Vengono intanto descritti i caratteri della scienza,
sotto il profilo sistematico; vengono indicate le principali tappe storiche, attraverso cui si è formato il
progresso della filosofia, da ultimo troviamo alcune osservazioni sui caratteri della cultura.
L’esigenza di porre ordine nelle scienze era già vivo, prima che nell’illuminismo, nei primi grandi
filosofi moderni: Bacone, Galileo e Cartesio. Al primo di questi si ispira il D’Alembert nelle descrizioni
di quelle che egli chiama “albero genealogico delle scienze”. Il bisogno di un ordine è dettato dal fatto
che “ il sistema generale delle scienze e delle arti è una specie di labirinto, di cammino tortuoso, in cui lo
spirito si impegna senza troppo conoscere la via che dovrà tenere”.
La sua struttura si può paragonare al celebre esempio dell’albero di Cartesio; il tronco, i rami e le
foglie non sono che varie parti in cui si suddivide il sapere. Ricorre nel D’Alembert la stessa immagine
cartesiana: “il sistema delle nostre conoscenze è composto di differenti rami di cui parecchi hanno un
medesimo punto di riunione”.
Quale sia questo punto il D’Alembert non lo dice chiaramente. In Cartesio, invece, era ravvisato
nella metafisica. Il D’Alembert, conforme all’ideale illuministico del sapere, si preoccupa più dell’elenco
delle varie scienze, che del loro collegamento, secondo un preconcetto criterio sistematico. A Bacone è
invece ispirata la suddivisione delle scienze secondo le tre facoltà umane: memoria, ragione, immaginazione,
a cui son fatte corrispondere la storia, la filosofia e le arti. L’ordine di queste facoltà rispecchia l’ideale
illuministico secondo cui l’attività riflettente media le altre due. Il D’Alembert fa, infatti, osservare che
“l’immaginazione è una facoltà creatrice e lo spirito prima di pensare a creare incomincia a ragionare su
quanto vede e conosce. Sarebbe interessante conoscere più chiaramente le ragioni che hanno indotto il
D’Alembert a mutare l’ordine tradizionale delle facoltà dello spirito, ponendo la fantasia al terzo posto
piuttosto che al primo, ma il discorso ci prenderebbe molto spazio che per ora non c’è consentito. Ci
limitiamo solo a rilevare che nella filosofia greca la fantasia era considerata una facoltà ricettiva, atta cioè
a ricevere immagini, mentre per il D’Alembert essa è una facoltà atta a produrre immagini e perciò
creativa. Per quanto riguarda le scienze, esse sono collegate tra loro in quanto l’Enciclopedia “è una
specie di mappamondo che deve mostrare i principali paesi, la loro posizione e la reciproca dipendenza,
il cammino in linea retta che va dall’uno all’altro”.
Immagine molto efficace che tornerà anche successivamente nella descrizione dei vari aspetti
della conoscenza. Hume ad esempio, affermerà che la nostra mente è una specie di carta geografica i cui
punti non sono che altrettanti modi e tipi di sapere. Concezione naturalistica, dunque, non estranea allo
spirito materialistico dell’epoca. Ma studiare l’ordine delle scienze vuoi dire vederne anche la loro
successione storica: se non altro “per illuminarci sul modo con cui dobbiamo trasmettere queste
conoscenze ai nostri lettori”. Come si vede, la cultura non risponde solo ad una esigenza di stabilità,
essendo essa un fenomeno sociale, che implica conservazione e trasmissione.
Le tappe più importanti di questo cammino sono quelle della rinascenza e del rinnovamento
della filosofia (di fronte al formalismo scolastico) e della scienza (operata da Bacone, continuata da
Newton e dagli altri scienziati moderni).
Il progresso della filosofia e della scienza, però, non si svolge con facilità. Esso implica una
graduale liberazione dalla metafisica, che tuttavia permane nella sistematica di Cartesio e di Leibniz. Ma
a questa metafisica, che culmina nel razionalismo Wolfiano, il Locke oppone allo studio positivo dei
fatti, “una fisica sperimentale dell’anima”. Questo tipo di metafisica è definita dal D’Alembert “ ragionevole
“ ed “ utile “, in quanto gli assiomi, sono i medesimi per i filosofi e per il popolo”.
L’ideale del D’Alembert non va oltre queste esigenze sociali a cui deve essere subordinata la
cultura. Naturalmente la società del D’Alembert è aristocratica e borghese. E’, in altre parole, quella
11
stessa borghesia che aspirava con la sua cultura a creare un nuovo ordine sociale libero da tutte le
strutture economiche e politiche del medioevo.
5. OSSERVAZIONI SULLA FINALITÀ DELLA CULTURA
Le osservazioni finali del Discorso trattano le finalità della cultura in rapporto al progresso della
società. Esse sono ispirate ad un sano ottimismo e sono una risposta alle critiche del progresso della
scienza (ad esempio quella del Rousseau, ricordate esplicitamente nell’ultima pagina della prefazione) e
della conseguente esaltazione del regno della natura.
Il D’Alembert ha un senso storico del progresso della scienza e benché la fisica di Newton
rappresenti la più grande conquista moderna, non si può ritenere che essa sia definitiva. Per questo il
D’Alembert si può considerarlo, come abbiamo accennato, “nei limiti del sapere” nello spirito degli
epistemologi a noi contemporanei. “Se Newton dovesse ai giorni nostri venir distrutto da una qualsiasi
causa, ingiusta o legittima che sia, dice il D’Alembert, i numerosi settari che ora lo difendono
sosterrebbero allora senza dubbio la medesima parte che han fatto sostenere agli altri”.
Ciò che non muta, invece, è la fiducia nella filosofia intesa come strumento di illuminazione e di
liberazione dello spirito dalle strutture dommatiche. Il suo compito, dice il D’Alembert, è quello di
arrivare fino alle masse per emanciparle, non solo sul piano dell’istruzione, ma anche del sapere
scientifico. Mediante l’Enciclopedia, questo potente mezzo di diffusione e volgarizzazione della cultura,
“i tesori (per dirla con uno dei più grandi scienziati del mondo contemporaneo) rimasti nelle torri
d’avorio dei laboratori scientifici diventano patrimonio culturale di tutti”.
Pertanto la filosofia, continua il D’Alembert, “pur pensando a piacere, sembra non aver
dimenticato che è fatta principalmente per istruire. Per questa ragione il gusto dei sistemi proprio più a
lusingare che a rischiarare la ragione, è assolutamente oggi bandito dalle buone opere”.
E’ chiaro che l’Enciclopedia, oltre che a diffondere la cultura, ha il fine di promuovere il
progresso autonomo della scienza. Da qui la diffusione della filosofia - come non è mai avvenuto in altri
tempi - nei salotti, con la conseguente formazione di circoli di cultura e di associazioni culturali. In detti
salotti, gravitanti intorno ad erudite e colte dame di grande rango, convenivano scrittori, artisti,
scienziati e filosofi da ogni parte di Francia e d’Europa, creando quella che fu chiamata “l’opinione
pubblica”. Tra i più importanti meritano di essere ricordati quello di Madame Geoffrin frequentato dai
maggiori enciclopedisti quali Diderot, lo stesso D’Alembert, Marmontel ed altri; e quello di M.me du
Deffrand che annoverava tra i più assidui il divo Voltaire e il grande Montesquieu. Quest’ultimo con le
Lettres persanes aveva avviato la letteratura francese a quella satira politica che sarà il campo di battaglia
del poligrafo Voltaire. Inoltre nei trentuno libri de L’esprit des lois - ispirati alla Costituzione Inglese in
cui ravvisa l’equilibrio dei poteri - passa in rassegna, senza intenti rivoluzionari, gli usi, i costumi, le
religioni, i governi e le filosofie che influirono a formare le leggi dei vari popoli. Queste opere che - non
prive di errori per le eccessive generalizzazioni - pur osteggiate e poste all’indice dai Gesuiti, esaurirono
dal 1748 al 1750 oltre venti edizioni. Analogo successo ebbero le opere degli scrittori che con sguardo
sincero e talvolta beffardo descrissero, con schietta obiettività, gli usi, i costumi e gli abusi della società
corrotta e decadente. Tali idee innovatrici sorte da motivi libertini seicenteschi, filtrati nella cultura
illuministica attraverso i dizionari come quello “Historique et critique” di Pierre Boile e dell’analisi
attenta e minuziosa della vita aristocratica del settecento - che fornirono spunti di critica corrosiva sul
piano religioso ed eticopolitico ricorrenti negli scritti e nelle citate opere di Montesquieu - raggiunsero
con sorprendente rapidità tutti gli ambienti sociali dall’alta borghesia al popolo minuto.
Il D’Alembert avverte il pericolo di questa diffusione della cultura in lingua volgare e ne
sottolinea gli svantaggi che ne possono derivare, in quanto gli studiosi, sia essi filosofi, scienziati o
critici, per conoscere le opere non più scritte nella lingua dei dotti: la latina, dovranno ricorrere o agli
interpreti o apprendere le lingue nelle quali quelle opere sono scritte col comprensibile svantaggio del
tempestivo progresso delle scienze; senza dire che la conoscenza di una lingua comune agevolerebbe la
cooperazione tra gli stessi scienziati. Pur con questi comprensibili limiti e questi aspetti contraddittori,
davanti ali utilità della diffusione della cultura, il D’Alembert non può accettare la critica del Rousseau e
lo confuta, senza esitazione, asserendo che la cultura e in particolare “le lettere contribuiscono
12
certamente a rendere la società più amabile”. E per di più, egli aggiunge, “si dovranno forse prescrivere
le leggi, perché il loro nome serve di riparo ad alcuni delitti di cui gli autori sarebbero puniti in una
repubblica di selvaggi?”. Si tratta di una fiducia nella cultura, dunque, che è comune agli spiriti più
illuminati dell’epoca, da cui dovevano nascere le più grandi trasformazioni della società verso la fine del
secolo. Di questo spirito sono animate le conclusioni finali, le quali costituiscono una specie di mise a
point dello stato della cultura di fronte alla società dell’epoca.
6. UNA NON FACILE CONCLUSIONE
Una critica del Discorso del D’Alembert sarebbe inopportuna, in quanto essa implicherebbe un
confronto con i più importanti documenti programmatici della filosofia moderna: dal Discorso sul metodo
di Cartesio al De Dignitate et augmentis scientiarum di Bacone e molti altri. In realtà il Discorso del
D’Alembert, oltre che essere una prefazione a quella che fu detta la Bibbia dell’illuminismo, riassume
anche le principali caratteristiche della cultura della filosofia del Settecento.
Entro questi termini storici va, dunque, valutata la sua importanza e considerata la sua
originalità, le quali sono in diretto rapporto col significato storicistico che ha per noi, oggi, quel
fenomeno culturale che è appunto l’illuminismo.
Caduta l’idea di un illuminismo come epoca perfetta, isolabile dalle altre età della storia, si torna
a vedere - come dicevamo all’inizio - in quel periodo, una grande affermazione dello spirito in cui vige,
però, la consapevolezza del legame della cultura con il progresso umano. Sotto questo profilo e questo
soltanto abbiamo tentato un accostamento tra il programma tracciato nel Discorso e tutto il movimento
culturale del Settecento francese ed europeo intesi a demolire le norme che imponevano l’ossequio ad
un autoritarismo arbitrario, per affidare alla ragione il diritto di criticare le strutture sociali preesistenti e
il compito di tracciare un disegno di una nuova società in cui l’uguaglianza socioeconomica avrebbe
garantito - mediante la divisione e l’autonomia dei poteri - la libertà politicoreligiosa quali espressioni
dell’autentica dignità della persona umana.
Ove tutti questi diritti fossero stati acquisiti, l’uomo ha il dovere di migliorare le sue condizioni
individuali e perfezionare i rapporti sociali, non ignorando che nella misura in cui sa stabilire un
rapporto di equilibrio con l’ambiente umano e quello fisico riesce a conquistare spazi nuovi cui
seguiranno nuove invenzioni in campo tecnico-scientifico e apriranno nuovi orizzonti all’inappagabile
desiderio di conoscenze.
Tali conoscenze non sono da ritenersi inchiodate né al tradizionale dualismo soggetto- oggetto,
né alla distinzione operata da Kant tra mondo noumenico e mondo fenomenico, ossia tra ciò che è
conoscibile mediante le categorie intellettive e ciò che non è conoscibile, perché tagliato fuori
dall’attività del pensiero e pertanto relegato nell’oscuro mondo della cosa in sé. La ricerca scientifica
nuova, libera da condizionamenti dialettici di tipo idealistico e non più legata all’idea di una materia che
“a guisa di un mono polo magnetico attraeva a se tutte le cose”, ha individuato - col modello di
cronotopo della relatività einsteniana - nella luce il ponte tra il fenomeno ed il noumeno, tra l’esteriore e
l’interiore, tra l’onda ed il corpuscolo, tra la qualità e la quantità, tra il meccanicismo e l’organicismo, tra
il de terminismo causalistico ed il finalismo. Non più dualismo, dunque, ma dualità, non più
opposizione ma interazione, non più solo la logica del pensiero, quale supremo inappellabile tribunale,
che giudica col suo unico metro ogni cosa, ma sono le cose che rispondono alle domande con la
propria logica ed il proprio codice che la mente deve interpretare per capire la risposta. Sotto un certo
aspetto si risente quello che Bacone nella sua opera Cogitata et Visa così affermava: si può dominare la
natura solo ubbidendole, e per ubbidirle bisogna sapere cosa ordina: e la natura svela i suoi ordini solo a
chi sa interrogarla e sa “costringerla a rispondere”.
E’ come dire: il linguaggio antropologico o culturale deve interagire col linguaggio biologico che
è scritto in codice il quale deve essere interpretato se si vuole comprendere la struttura della natura. Con
la fisica teorica la ricerca scientifica nuova ha operato il salto di qualità, dando alla materia e alla
macchina una dimensione nuova, non riducibili al mero dinamismo deterministico. Con la cibernetica
poi la macchina ha superato il rigido automatismo assumendo il ruolo di autogoverno e pertanto, con
l’introduzione dell’algebra sul piano operativo, si può paragonarla ad un algoritmo.
13
Il D’Alembert, che, oltre alle altre scoperte, aveva trovato le “equazioni delle onde luminose”
che hanno dato, due secoli dopo, a Fantappiè occasione di sviluppare le teorie dei potenziali ritardati e
anticipati quali conseguenze delle leggi fondamentali dell’universo cui dette equazioni si riferiscono, non
poteva non intuire il ruolo che la matematica avrebbe avuto in futuro (anche se non ne poteva
prevedere le proporzioni) in campo operativo. Se si pensa poi che egli sapeva bene che Bacone (di cui
era ammiratore) aveva sostenuto nella Nuova Atlantide il ruolo prioritario degli scienziati in campo
sociopolitico-economico - e che nella misura in cui detti scienziati operino in stretta collaborazione
nella ripartizione dei compiti inerenti alle loro specifiche competenze, si sviluppa il progresso in ogni
campo, risolvendo in modo ottimale tutti i problemi, non esclusi quelli economici che avevano
preoccupato il Campanella ed il Moro, rispettivamente nella Città del Sole e ne L’Utopia non si
comprende perché egli non abbia auspicato una società fondata sulla cooperazione degli scienziati ed
abbia invece esortato i politici a promuovere tutte quelle iniziative atte ad incentivare la cultura.
A conclusione del suo Discorso sembra volesse rivolgere un appello alla nuova generazione
affinchè prenda coscienza di una realtà che deve mutare le strutture preesistenti. Tale generazione deve
assumersi dei compiti nuovi, chiamata come è a vivere in un mondo che deve rompere con i vecchi
organismi che hanno rallentato od ostacolato il progresso dei popoli. “Per questo la gioventù, “scrive il
D’Alembert”, che si considera di solito un giudice assai cattivo, è forse invece il migliore in questioni di
filosofia come in molte altre, quando non sia sprovveduta di lumi, poiché, tutto essendo per lui nuovo,
altro interesse non ha che quello di scegliere”. Questa generazione nuova - che si arroga il diritto di
giudicare i governi e le istituzioni passate che per millenni hanno soffocato e calpestato i diritti
elementari dell’uomo e del cittadino - deve decidere del futuro.
Se il D’Alembert avesse chiuso con questo auspicio il suo discorso preliminare, avrebbe
tracciato un programma profetico, che, a distanza di due secoli avrebbe avuto il suo coronamento nel
“Progetto Homo Solaris”. In tale progetto si auspica - nel non lontano duemila con l’elevarsi della
cultura e l’emancipazione delle coscienze dalla barbarie delle guerre, retaggio di una mentalità selvaggia di uscire, come asserisce il fisico nucleare Zichichi, “dall’equilibrio del terrore” in quanto gli armamenti
nucleari hanno raggiunto proporzioni talmente grandi che si calcola che sulla testa di ogni abitante di
questo nostro pianeta incombono tremila Kg. di tritolo che varrebbero, se esplodessero, a polverizzare
la razza umana e a rendere definitivamente inospitale qualsiasi forma di vita. Detto progetto prevede
l’unione di tutti gli scienziati del mondo a non cooperare con i guerrafondai e a indurre le potenze
imperialiste a disarmare. Ma il D’Alembert, che viveva nel secolo delle monarchie - che per quanto
teoricamente illuminate erano ancora praticamente assolutiste - con realistico senso storico, pur
diffidando delle vecchie strutture politiche e confidando nelle istaurando istituzioni democratiche,
riteneva opportuno, almeno per il momento, un rinnovamento sociale più attraverso oculate graduali
riforme che mediante rivoluzioni ritenute, ancora, malgrado le innovazioni, utopistiche; e soffocando i
naturali impulsi legati ai suoi ideali politici, auspica “repubbliche e monarchie in cui vi siano più
scienziati, più filosofi, più letterati, più poeti, più teologi” per creare mediante la diffusione della cultura
- ciò che si vorrebbe ancora oggi, nella contingente realtà - una società regolata da leggi fondate su
principi morali validi universalmente che trovino riscontro nella intimità delle singole coscienze entro
cui si promuove e si sviluppa la persona unica capace di garantire – ove siano fatte salve, oltre la
giustizia e l’equità, i diritti elementari inalienabili di ciascun uomo – l’autentico progresso civile di tutti i
popoli della terra.
Enzo Sacco
Filosofo
14
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
P. Casini D’Alembert-Diderot, La filosofia dell’Enciclopedia, Laterza, Bari, 1966.
E. Cassirer, Saggio sull’uomo, A. Armando, Roma, 1967
E. Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo, La Nuova Italia, 1976.
Costa Lovoi, Eredità del mondo La tragedia greca nella sua struttura tradizionale, Zanichelli,
Bologna, 1962.
B. Croce, Estetica, Laterza, Bari, 1950
B. Croce B., Teoria e Storia della Storiografia, Laterza, Bari, 1966.
Gaudium et Spes, 35, Documenti del Concilio Vaticano II – Edizione Paoline, 1967.
E. Kant, Critica del Giudizio, traduz. Gargiulo, Laterza, Bari 1938, pp. 163-164.
U.P. Magni, Homo Solari, Ed. Il Fuoco, 1982.
Marx, Per la critica dell’economia politica, Newton Compton Italiana 1972, Roma.
A. Pasa, D’Alembert, Discorso preliminare all’Enciclopedia, Ed. Canova 1953, Treviso.
Prampolini, Enciclopedia univ. Della Letteratura.
J. Rousseau, Giulia e la nuova Eloisa, Univ. Rizzoli, Milano 1964, p. 12.
E. Sacco, La filosofia del linguaggio in Filiasi Carcano, Responsabilità del Sapere, lugl. dic. 1982.
E. Sacco, La natura e l’uomo, in Il Fuoco, III/81, Roma.
A. Zichichi, Cultura Moderna, Il Tempo n. 148, 19-2-1983.
15