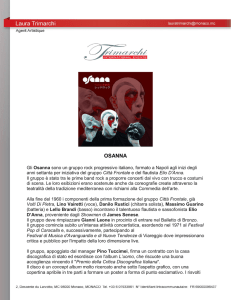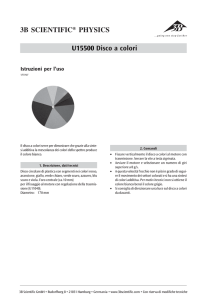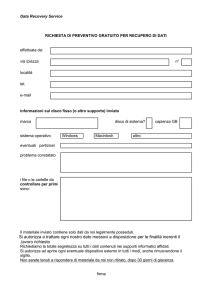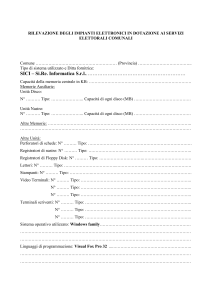digital magazine marzo 2009
N.53
Rafael Toral. Adriano Modica. Lebowski. Honeychild Coleman.
Le stagioni del cuore. Dm Stith. These Are Powers. Yoñlu.
Nicolas Vernhes. Les Fauves. Darwinsbitch. Anni Rossi. Grandmaster Flash.
Bbreaks
Lungo il continuum con
Harmonic 313, Zomby, Lukid, Actress, Hudson Mohawke
+
Sentireascoltare n.53
Turn On
3 5 . N 9002 ozram enizagam latigid
p. 6
Grandmaster Flash
7
Anni Rossi
8
Darwinsbitch
9
Lebowski
10
Les Fauves
12
These are Powers
14
Yoñlu
Rubriche
Tune In
16 Honeychild Coleman
108
Giant steps
20 DM Stith
109
Classic album
24
Nicolas Vernhes
110
Cult Cinema
114
La sera della prima
116
A night a the opera
118
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
28
Rafael Toral
32 Bbreaks
94
Le Stagioni del Cuore
Recensioni
DM Stith
David as a musician
38
Actress, Aethenor, Anni Rossi, DM Stith, Druid Perfume, Hexlove, Les Fauves
Rearview Mirror
94
Le Stagioni del Cuore
104
Eluvium, Red Red Meat, Henry Cow
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Consulenti
alla redazione:
Daniele Follero, Stefano Solventi
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo,
Alessandro Grassi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali,
Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio
Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
bbreaks
Sentireascoltare digital magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda Direttore responsabile: Antonello Comunale Provider NGI S.p.A. Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi
forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
a cura di Teresa Greco
mt
per ora si sa solo
sunnO)))),
Phil
che si esibiranno
Wandscher (Jesse
in alcuni festival
Sykes and the Sweet
estivi europei…
Hereafter, WhiskeyI Jane’s Addiction,
town), Josh Stevenson
arrivati alla loro terza
(Jackie O Motherfucker),
reunion, dopo alcune date
Ashley Webber (The Orin piccoli locali di Los Angegan, Bonnie Prince Billy),
les, riprendono l’attività live ed
Amber Webber (Black Mounhanno annunciato la loro partecitain, Lightning Dust), Matthew
pazione al festival Sasquatch che
Camirand (Black Mountain, Blood
si terrà a Quincy, Washington, dal 23
Meridian), Joshua Wells (Black Mounal 25 maggio prossimo, oltre delle date
tain, Lightning Dust), Keith Parry (Suprimaverili in compagnia dei Nine Inch
perconductor, the Gay) e Tolan McNeil
Nails.
(Caroline Mark)…
Annunciato il nuovo disco degli Yeah
Gli MGMT hanno citato in giudizio il
Yeah Yeahs, previsto per metà aprile e dal
presidente francese Nicolas Sarkozy, accutitolo It’s Blitz! La band sarà il 4 maggio ai
sandolo di aver utilizzato durante un congresso
del suo partito il loro brano Kids, senza aver chie- Magazzini Generali di Milano per l’unica data
sto il permesso; dallo staff francese fanno sape- italiana del tour…
re che non hanno chiesto la liberatoria per un È scomparso Kelly Groucutt, bassista della
Electric Light Orchestra (ELO), morfraintendimento, e si sono offerti di versare
to 63 anni per infarto a Worcester. Il
simbolicamente al gruppo un euro in
gruppo pop orchestrale del chisegno di risarcimento, richiefaith no more
tarrista Jeff Lynne aveva
sta che la band ha rifiutato.
conosciuto un largo sucSarkozy è stato tra i primi
cesso tra gli anni ’70 e
premier dell’Unione
’80. Lynne si è dediEuropea a dichiaracato in seguito alla
re di volersi battere
produzione, lavocontro il file sharing
rando con Georillegale…
ge
Harrison,
Ancora
reucreando i Travenion in vista:
ling Wilburys
dopo undici anni
(con Dylan, Harriecco i Faith No
rison, Tom Petty, e
More. La band di
Roy Orbison) e metMike Patton si era
tendo mano anche
sciolta nell’aprile 1998
all’Anthology dei Bee i membri avevano tutti
atles. Gli ELO avevano
proseguito con altri progetpubblicato l’ultimo disco nel
ti, Patton compreso, attivo con
2001, Zoom…
Tomahawk, Fantômas e Peeping
Tom. La line-up non è stata ancora comunicata e
mg
Confermati altri nomi per dell’edizione 2009
del FIB Heineken 09 che si terrà a Benicàssim
(Spagna) il 16, 17, 18 e 19 luglio 2009. Dopo i
già annunciati Franz Ferdinand, Kings of Leon,
Oasis e Paul Weller, tocca a Psychedelic Furs,
White Lies, Friendly Fires, The Bishops e
Boys Noize. Maggiori informazioni su fiberfib.
com…
Murray Perahia, Martha Argerich & Friends, Radu Lupu, Jordi Savall, Leonidas Kavakos,
András Schiff, Fazil Say, Daniel Harding, Zubin Mehta, Mikhail Pletnev, Cristian Mandeal,
Mahler Chamber Orchestra, Russian National
Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica George Enescu, Le Concert
des Nations. Sono gli ospiti della ventottesima
edizione di Bologna Festival che da marzo a
ottobre 2009 si articola nei suoi tre cicli di concerti Grandi Interpreti (27 marzo – 25 maggio), Talenti (3 aprile – 4 giugno), Il Nuovo
L’Antico (22 settembre – 29 ottobre). Il grande
repertorio classico-romantico, i compositori protagonisti del Novecento europeo, la musica contemporanea con sette prime esecuzioni di opere
scritte per Bologna Festival
dai compositori bolognesi
più significativi, la musica
barocca con Monteverdi,
Galuppi, Vivaldi, Bach e un
omaggio ad Händel nella ricorrenza dei 250 anni dalla
sua scomparsa. Maggiori informazioni su http://www.
bolognafestival.it...
Dal comunicato ufficiale
con cui la Touch and Go
spiega il momento critico che sta attraversando:
Pink Mountaintops
“It is with great sadness that
we are reporting some major changes here at Touch and
Go Records. Touch and Go will be returning to its roots
and focusing solely on being an independent record label.”
Quindi ci sarà un ritorno alle loro radici e un ridimensionamento a causa della crisi economica…
Nuovo sito rinnovato per la label Leaf (www.
theleaflabel.com/en/index.php) e nuove uscite
per il 2009, fra le quali si segnalano, oltre agli annunciati Wildbirds & Peacedrums (The Snake), Icy Demons (Miami Ice, fine aprile), A
Hawk and a Hacksaw (Délivrance, maggio),
Nancy Elizabeth (Wrought Iron, settembre),
Murcof (Océano, fine anno)…
Jagjaguwar comunica l’entrata nel suo roster
dei Dinosaur Jr. Il gruppo, con i suoi tre membri originari J Mascis, Lou Barlow e Murph, sta
al momento terminando l’album, che verrà pubblicato per l’estate prossima…
A proposito di Jagjaguwar, uscirà a maggio sull’etichetta il terzo album dei Pink
Mountaintops, dal titolo Outside Love. Titolare del progetto è Stephen McBean, veterano della scena punk-rock di Vancouver/
Victoria e componente dei Black Mountain.
Partecipano al disco, prodotto da John Congleton, Sophie Trudeau (A Silver Mt. Zion, Godspeed You! Black Emperor), Ted Bois (Destroyer),
Jesse Sykes (Jesse Sykes and the Sweet Hereafter,
News /
5
Anni Rossi
classical viola pop
GrandMaster flash
a dj saved our lives
Una cultura si conferma salda e salva solo se tiene
in conto le proprie radici. Ci sta provando l’hiphop, riscoprendo la figura del DJ dopo che successo e denaro hanno annebbiato le idee a troppa gente. Nemmeno a farlo apposta, il Colosso
Grandmaster Flash è riapparso sulle scene con
un disco affatto disprezzabile…
Lo dico a voce alta: sono fiero d’esser tornato.
Così, parafrasando James Brown, potrebbe esprimersi Grandmaster Flash alla luce di The Bridge,
disco che lo mostra in discrete condizioni di forma. Già lo sosteneva da anni, il Nostro, di non voler essere confinato a leggenda, pur conscio che la
sua Grandezza stesse in una passata rivoluzione
tecnologico-stilistica. Prima di The Message c’era
stata la Sugarhill Gang di Rapper’s Delight, ma era
disco funk all’inseguimento dei tempi. Come paragonare Rock Around The Clock a Johnny B. Goode:
imitazione di un genere contro l’elezione a stile
autonomo. Hai detto niente, fratello Joseph Saddler, che dal gennaio 2008 hai mezzo secolo. Nativo delle Barbados, crebbe nel Bronx, facendosi
notare mettendo dischi ai block parties e nei locali.
Poiché di giorno frequenta una scuola di elettronica, escogita un colpo di Genio tecnologicamente consapevole erigendo i piloni dell’hip-hop. Il
“cutting” (fondere un brano all’altro tramite similitudini ritmiche, incrementando l’impatto con
un beat-box), il “back-spinning” (intervenire con
le mani sul vinile per suonarlo) e il “phasing” (lavo6
/ Turn On
rare sulla velocità del giradischi) diventano pane
quotidiano di ogni DJ. Nel ’77 Gran Maestro si
unisce ai rapper Furious Five e la cronaca si fa
Arte: abili in rime connesse alla realtà, arrivano
a incidere tardi e nondimeno in modo epocale.
L’esordio per Sugar Hill Freedom va in classifica
e idem il seguito Birthday Party; spetta però a The
Adventures Of Grandmaster Flash On The Wheels Of
Steel cambiare nell’81 le sorti della musica. In quel
collage di graffiti sonori sta l’estetica del frammento come la conosciamo. Ricetta perfezionata un
anno dopo da The Message, scuola pura sin dal
suo “don’t push me, ‘cos I’m close to the edge”: il Gioco
comincia a raccontare la strada e la realtà spesso drammatica che ne costituiscono il grembo.
Nell’82 ecco The Message, festa d’afrocentrismo che recupera i gioielli di cui sopra - per il
resto vale il Best Of su Rhino del ‘94 - e uno dei
primi album rap concepiti come tali. Resterà il
loro unico: dopo l’inno anti-cocaina White Lines,
i rapporti si deteriorano e addio. Farà ancora dischi, Flash, tutti trascurabili e comunque problema non v’è. Il linguaggio si è intanto sviluppato,
ci sono in giro Public Enemy e Jungle Brothers
che sono figli suoi come Rolling Stones e Living
Colour lo sono di Chuck Berry. Rispetto eterno
sia dunque per uno degli Originali. La storia siamo noi, ma a farla sono in pochi.
Giancarlo Turra
La viola al centro del proprio mondo musicale,
con tutta le deviazioni e le dissonanze applicabili
a questo strumento, e un’attitudine pop e nello
stesso tempo contemporanea: queste le coordinate dell’avant pop della newcomer Anni Rossi. Dal
Minnesota via Los Angeles e infine Chicago, fresca l’anno scorso di contratto con la 4AD, arriva
ora all’esordio con Rockwell. Composizioni che
in maggioranza appartenevano al suo precedente repertorio, sofferti e spasmodici saliscendi per
viola e cantato, sono state rivisitate e arricchite
strumentalmente con il tocco di Steve Albini.
Di formazione classica, la polistrumentista è passata, nel corso degli ultimi cinque anni, dall’anarchia musicale delle prime prove su cd-r (come
Scandia, uscito sulla DIY Folktale Records nel
2004), scarni e cupi bozzetti per sola voce e viola
dove tensione e animalità la facevano da padrona, anche nel canto spasmodico, a una certa regolarizzazione e ad un arricchimento strumentale che l’ha portata, nel 2008 all’EP Afton, sempre
su 4AD, coadiuvata dal fondatore dei Big Black.
Da Afton emerge la scrittura cinematica di Anni
e la sua propensione all’improvvisazione e alla
destrutturazione delle composizioni, piccole suite
sempre sul punto di deflagrare, in un continuo
saliscendi emotivo e armonico. Caratteristiche
tutte amplificate nell’ultimo Rockwell (in recen-
sioni) dove ancora una volta riemergono alcuni
di quei pezzi che abbiamo imparato aconoscere
(Machine, Ecology, Wheelpusher) nel corso della sua
discografia; laddove in precedenza c’erano spazi vuoti tra voce e musica, ora le composizioni
tendono alla stratificazione ed al sinfonico, in un
compendio avant orchestrale (The West Coast) e in
improvvise sfuriate e saliscendi armonici, dominati dalla viola in primis (Deer Hunting Camp 17),
dall’organo in Ecology, dal clarinetto in Venice,
da violoncello, fiati e percussioni. La voce qui
funge maggiormente da strumento aggiunto,
modulando le armonie con le progressioniarmoniche strumentali.
Una controparte femminile dei Beirut o di Final
Fantasy, con in aggiunta la preponderante componente dissonante. Una Joanna Newsom meno
“normalizzata”, una Carla Bozulich (con la quale
ha suonato in tour, tra l’altro) a cui l’accomuna
l’attitudine arty e il lato selvaggio dell’esibizione
dal vivo, il Cale selvaggio e destrutturato che percuote la sua viola, le coloriture Joni Mitchell della
voce. Tra impeti neofolk di comunione con la natura e riflessioni sulla contemporaneità, a ricordarci, con Cale, che “la viola è il più triste degli
strumenti”.
Teresa Greco
Turn On /
7
Darwinsbitch
Lebowski
Immersive and Breathing Music
“The first definition of an instrument according to the
American Heritage Dictionary is “a means by which something is done; an agency.” An instrument somehow embodies a means to an end, the path relating intention and
action, whether of a mechanical or electrical source”. È
il concetto stesso di strumento, ovvero di “device” nella sua accezione tecnologica che sembra
spingere e animare le intenzioni dell’americana
Marielle V. Jakobsons. Da qui il suo interesse per
le infinite possibilità di “ambientarsi” nel contesto circostante. L’affermazione di cui sopra e
tratta dalla sua tesi di laurea in Electronic Music
e Recording Media, conseguita con tutti i crismi
del caso, al Mills College nel 2006. Titolo della
dissertazione: “Immersive Instruments and Breathing Systems”, basata su una installazione denominata Two Violins and a Theatre: A Triptych
of Resonance.
Il sunto teorico del discorso di Marielle sembra
essere quello della risonanza come agente fisico
ancorché intangibile, direttamente modificabile
dall’ambiente. Come dire che nello stesso istante,
lo stesso strumento può originare infinite modalità
per riverberare nell’ambiente, indipendentemente dalle sue modalità espressive. O per lo meno
questo par di capire, sorvolando velocemente i
suoi assunti teorici minuziosamente elencati sul
8
/ Turn On
suo sito web. Quello che però lascia propendere
maggiormente verso quella che possiamo definire
come una vera e propria poetica del suono trattato è il suo lavoro a nome Darwinsbitch di cui
in questi giorni si sentenzia il debutto sulla lunga
distanza con un lavoro pubblicato da Digitalis e
intitolato Ore. Nella descrizione della musica la
press abbandona volutamente qualunque aspetto
tecnico-teorico per abbandonarsi alla evanescente carica della suggestione. Onde per cui si parla
di “fluid forms of drones, doomy laments, and folk melodies fleshed out from a backbone of sine oscillators and
violin”.
Un approccio alla materia sonora non troppo
distante da quella del suo compagno di amorosi
affetti, Gregg Kowalsky, ma carico di un evidente
sense of apocalypseche non può che dirsi uterino.
Marielle oltre alla musica di Darwinsitch si concentra anche su altri progetti degni di nota, come
la collaborazione con la compagna di corsi Agnes
Szelag nel duo elettroacustico folk denominato
Myrmyr di cui si dovrebbe ascoltare a breve il
debutto e l’ensemble multimediale Triometrik in
cui si prodiga in quella che rimane tuttora la sua
passione primaria e prediletta: il violino.
antonello comunale
Loro sono solo al disco d’esordio ma chi vi parla,
fosse il direttore di NME, li spiattellerebbe direttamente in copertina. E non solo perchéhanno personalità da vendere, ma anche perchédimostrano
di saper conciliare un post-punk/noise teso e serissimocon una vena ironica capace di prendersi gioco di qualunque cosa respiri. A cominciare
dai diretti interessati: “Chi sono i Lebowski? Quattro
sbandati, di cui uno molto vecchio. È uncontenitore di storie
di ordinaria e deprimente demenza quotidiana,di nascita e
morte, di improbabili ultimi desideri. È un cesto di droga.
Lebowski è il suono che produceva l’uomo bionico quando
si scopava la donna bionica e concepivano un bambino
bionico di nome ST-N-N-N al modico prezzo di 1 milione
di dollari. Lebowski è Clint Eastwood che gioca con una
pistola ad acqua. Lebowski nasce, cresce,si riproduce e poi
morirete voi”.
A scanso d’equivoci, nulla a che vedere con il demenziale più gretto,bensì una curiosa metafora
dei nostri tempi. Una modernità fatta dimescolanze in cui tutto è permesso, anche di affiancare
a testisurreali e, talvolta, in forma di narrazione,
una parte musicale puntuale, meccanica, spigolosa, decisamente elettrica. C’è la leggerezza svagata del Lebowski cinematografico a indicare la
via -“la figura degli anti-eroi scanzonati e pigri” -, ma
anche un’attenzione particolare per temi che esulano il semplice intrattenimento – le follie della
modernità di Zuber Buller o l’intransigenza della
chiesa cattolica in fatto di sessualità in Church Of
Fonz! -, a dimostrazione che nulla viene lasciato
al caso nella proposta della band di Jesi: “Non ci
piace scrivere testi forzatamente viscerali o super-incazzati
(equasi sempre retorici) e così cerchiamo di dire cose “interessanti” senza pesare su chi ascolta. Diamo una scelta: se
vuoi, sorridi, sehai più tempo, magari rifletti sul testo”.
Facciamo due conti: c’è un disco uscito a dicembre dello scorso anno– in spazio recensioni praticamente perfetto; c’è un produttore come Giulio
Favero del Teatro degli Orrori a fare gli onori di
casa; c’è una provenienza geografica – le Marche - che èuna sorta di garanzia di qualità per
certo rock ruvido e “strambo”(“Nella nostra zona
ci sono tantissimi gruppi di grande personalità, comeJesus
Franco & the Drogas, Butcher Mind Collapse, Guinea
Pig,Bhava, Lleroy, oltre a formazioni che ci piacciono molto come i Dadamatto o gli Edible Woman.).
Il passo successivo è accendere lo stereo, prepararsi un White Russian e spaparanzarsi sul divano di casa, con un sorriso un po’ beota stampato
sul viso e le orecchie ben sintonizzate sulle casse.
Fabrizio Zampighi
Turn On /
9
zioni sono serie, serissime! Vi date addirittura alla sociologia, citando un filosofo
non certo da Sorrisi e Canzoni come Zygmunt Bauman. O anche questa è tutta una
messinscena?
Non avevamo intenzioni serie! se il disco ti sembra serio allora dobbiamo aver sbagliato qualcosa... Al contrario volevamo creare un contrasto
tra visioni apocalittiche e ritmi da festa africana!
vogliamo gente che danzi ridendo sulle macerie
della propria casa!
Les Fauves
La cartella stampa snocciola riferimenti
come Fela Kuti, Piazzolla e Harry Belafonte (!), però se non vi spiace tranquillizzerei i lettori denunciando un certo
sbilanciamento verso zuzzurelloni come
Robyn Hitchcock e Flaming Lips. Siete
d’accordo?
Beh se vuoi come approccio alla materia si, per
quel che riguarda il contenuto in se, noi siamo
molto meno legati agli anni sessanta e settanta di
quanto lo siano loro. Volevamo allargare un po di
piu la visuale, spostarla un po piu in là.
Ai tempi dell’esordio – con l’ep Our Dildo Can
Change Your Life (Urtovox/Shinseiki / Audioglobe, aprile 2006) - mi lasciarono sconcertato, come uno schiaffo dato ridendo. Poi non mi
sono fatto più fregare. Questi quattro sciagurati
da Sassuolo sanno il fatto loro, malgrado provino a spacciare un understatement ultra cazzone.
Giunti al secondo capitolo di una trilogia di al10
/ Turn On
bum dedicata alle “luci ed ombre del comportamento alieno”, abbiamo ritenuto opportuno intervistarli.
Cari Les Fauves, oserei dire che con
N.A.L.T. 2 Liquid Modernity il bluff sia
svelato: altro che screanzate impertinenze e perversioni dadaiste, le vostre inten-
La ricchezza schizoide dei riferimenti
stilistici, caratteristica comune a molte
band “indie” contemporanee, è più un
tentativo di smarcarsi o una conseguenza
inevitabile (buona? cattiva?) del peer-topeer che offre accessibilità e simultaneità
a qualsivoglia genere pop-rock di qualsiasi epoca?
Per quel che ci riguarda é tutte e due, cioè un tentativo di smarcarsi grazie anche al peer to peer:
Il p2p ci ha permesso di ascoltare centinaia di
dischi da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi epoca, al di la cioè di qualsiasi limite spazio/
temporale. La quantita di musica che una persona può ascoltare ora rispetto a quella che poteva
ascoltare anni fa é cresciuta moltissimo, se si unisce le potenzialità del peer to peer a delle menti
abbastanza elastiche ne deriva un gusto musicale
che può passare tranquillamente dal clavicembalo ben temperato di Bach a Johnny Cash, dai
Contortions a Giacomo Puccini, da Miles
Davis ai canti gregoriani e così via. Certo l’altro lato della medaglia é che si é perso un po il
piacere della scoperta. Ricordo che una dozzina
di anni fa non avevo soldi per comprare piu di
un disco al mese (come poi anche adesso) però
ci mettevo piu di un mese per decidere che disco
comprare, stando ore nel negozio a valutare le
copertine, e una volta comprato lo ascoltavo tutti
i giorni, anche se non mi piaceva, fino a farmelo
piacere.
Anche voi come Adriano Modica - intervistato in questo stesso numero - avete
scelto di esordire con una trilogia in fieri.
Eccesso d’ambizione? Brama di suicidio
commerciale? Semplice mancanza di ragionevolezza? Cos’altro?
Eccesso di ambizione e mancanza di ragionevolezza ci stanno per quel che ci riguarda. Suicidio
commerciale no, perche lo dici? A parte che vendere poche copie non ci spaventa affatto, ci siamo
abituati. In realtà abbiamo pensato “facciamo
una trilogia così anche chi compra solo un disco
e non gli piace é costretto a comprarsi comunque
gli altri due”.
A quando il terzo capitolo? E dopo cosa
accade?
Il terzo capitolo é difficile a dirsi, vogliamo fare le
cose con assoluta calma, deve essere il piu bello,
come nella migliore tradizione delle trilogie, vorremmo chiudere alla grande. Dopo non si può
dire, nessuno può vedere così lontano.
Stefano Solventi
Turn On /
11
These are Powers
These Are Powers? Or these are ghosts?
La mutazione del sottobosco newyorchese più wave verso
una nuova forma di electro infestata da fantasmi industriali. Signori e signore, i These Are Powers.
C’eravamo ripromessi di approfondire il discorso
su questo trio newyorchese in tempi non sospetti.
All’epoca cioè delle prime produzioni ufficiali e
del primigenio hype: l’esordio lungo Terrific Season che aveva avuto il merito di far conoscere
al mondo dell’underground le scorribande della
band newyorchese, e il successivo mini Taro Tarot che allo stesso tempo ne confermava le premesse e ne spostava lievemente i confini.
A colpirci all’epoca era stato l’afflato tipicamentenewyorchese che pervadeva le musiche di questo oscuro terzetto poco propensoalle pubbliche
relazioni. Quel mettere in scena – in quei primi
passi sparsitra autoproduzioni, cassette, 7 pollici
– tutto l’universo delle musiche wave più sinistre
e virate in nero che la grande mela ha instancabilmente tenuto in grembo e partorito di volta in
volta nell’ultimo trentennio.
Musiche nere etimologicamente, nel senso cioè
diossessività e cupezza ma anche nere come d’origine black: ritmiche e ritmate, ancestrali ma pur
sempre smostrate, abbrutite, essiccate. Dalla nowave più out e sfasata fotografata nella leggenda12
/ Turn On
ria No New York a quella brutalmente e rumorosamente rock di Sonic Youth e progenie tutta,
passando per l’amore per certo noise-rock dei 90s
– di quello che appestava il Lower EastSide, per
intendersi – fino ad arrivare al versante più arty e,
perché no?, danzereccio dell’ultima ondata d’inizio millennio, un sottile filo rosso sembrava giungere fino ai These Are Powers.
Proprio da uno dei più rappresentativi combos
di questa ennesima folata rumorosa made in NY,
i Liars, prende il via l’esperienzaThese Are Powers. Il fondatore Pat Noecker era infatti il bassista informazione ai bugiardi al tempo dell’esordio
They Threw Us All in a Trenchand Stuck a
Monument on Top; dopo una parentesi invero
non felicissima con No Things (insieme all’altro
transfuga dai bugiardi Ron Albertson), e incontrata la bassista Anna Barie ha messo su questo
progetto. A completare il triangolo, e adar sostanza alle evanescenze del gruppo, la batteria di Bill
Salas a.k.a Brenman, solito percuotere pelli anche
con Our Brother The Native.Proprio l’ingresso di
quest’ultimo al posto del batterista originario Ted
McGrath ha – oltre che stabilizzato la formazione
– anche introdotto nellapercussività tribaloide caratteristica del gruppo sin dai primi passi, un alone altro, subumano, quasi alieno. Merito dell’uso
di chincaglierie e batteria elettronica apportato
da quest’ultimo e che ha il merito di sfasareancor
di più, quasi sfaldare la muscolarità tipica di certi
numeri di genere.
Si diceva degli esordi. Sia Terrific Season che Taro
Tarot viaggiano sulle coordinate di quel concetto
di musica ben sintetizzato nella autodefinizione
di ghost-punk. Nulla ditotalmente nuovo: una
wave tesa come il rock ma scura come la pece.
Destrutturata, ectoplasmica, evanescente, proprio come un fantasma punk. E lìrisiede lo scarto
con proposte simili. Terrific Season – esordioufficiale in cd edito dalla Hoss Records – raggruppa un paio di uscite brevicarbonare e si immola
totalmente al virare in nero il corpo morto del
ritmopost-punk/funk/no-wave,
innervandolo
però di loudness da noise-rock in disarmo. È il
concetto di ghost-punk che si materializza lungo
tutte le 8 tracce dell’album.
Taro Tarot continua sulla stessa falsarigadel precedente, ma segna già un ulteriore punto di fuga.
Se All Night Services apre il disco con una marcia
catacombale dal cui sottofondo emergono rumori
e distorsioni, gorgoglii e detonazioni con Pat impegnato asbraitare una nenia drogatissima, per
comprendere lo scarto col disco precedente e l’allargamento dei confini bisogna skippare al settore
conclusivo del mini: Untitled (Garbage Bird), Peel
Some Off e soprattutto Twin Remains spostano
l’asse verso certe asperità industriali frequentate
dagruppi come Pain Teens, mutando dal di den-
tro l’idea musicale del trio,rivoltandola, pur mantenendone il canone catchy e dancey sui generis.
Dal ghost-punk degli esordi all’haunted electrorock dell’attualità il passo, giunti a quel punto, è
dunque breve. E infatt il’appena uscito All Aboard Future accentua le declinazioni electro,
mantenendo in nuce allo stesso tempo l’ossessività percussiva el’attitudine ectoplasmica, invasata,
fantasmatica. Ossimorici, si diceva a ragione in
sede di recensione, e l’ascolto ripetuto dell’album
edito per Dead Oceans avvalora quella chiave di
lettura.
I tre si avvicinano alle derive industrial à la newyorchese messe in scena da acts/collettivi come
Excepter, altroprogetto dall’appeal tribal-dancey
infestato da scorie radioattive e rifiutidella cultura
post-industriale occidentale. All Aboard Future
è, nei suoi momenti migliori realmente hauntedrock: pervaso da umori alieni e/opost-umani
come potrebbe intenderlo un Genesis P-Orridge
emaciato e post-11 settembre (Light After Sound),
affetto da visioni da perturbantepost-vittoriano
alla Turn Of The Screw (Sand Tassels) o contaminato da impercettibili vocals catturate dopo un
fall-out atomico.
We are free…We are a language ofsound…We
are a celebration…We are present in dreams and
energy…We are the dynamics of being and the
infinity of possibility, dicono di sè. E contraddirli
è cosa veramente ardua.
stefano pifferi
Turn On /
13
Yoñlu
Mecanica Celeste Aplicada
Il titolo dell’articolo riprende una delle tracce che andranno
a modellare il debutto lungo di Yoñlu, adolescente brasiliano morto suicida nel 2006.
L’interessamento della Luaka Bop di David Byrne farà sì che a breve, dopo la pubblicazione di
un cd per il solo mercato sudamericano, la musica di Vinicius Gageiro Marques sarà alla portata
di tutti. La sua è una storia triste. Nel segno della
musica, la sua arte.
Un caso umano e musicale. Un talento in erba
cristallizzato, ormai, per sempre nelle sue sedici
primavere.
Non staremo qui a stendere di battiti socio-psicologici sui perché di questa vicenda (non ci compete né ciinteressa), ma impossibile trascendere
la vicenda musicale da quella umana di Yoñlu,
musico la cui breve esistenza lascia ai posteri una
manciata di canzoni che finalmente, grazie alla
volontà di David Byrne, vedranno la luce anche
al di là dei territori verde oro.
Il fatto risale al 2006, ma andiamo con ordine.
Vinicius Gageiro Marques, brasiliano di Porto
Alegre classe 1990, è figlio di una psicoanalista
14
/ Turn On
nonché docente universitaria, Ana MariaGageiro, e secondo genito di Luiz Marques, segretario
della cultura di Rio Grande tra il 1999 e 2002.
Una famiglia “bene” dove, gioco forza, istruzione
e cultura sono di casa.
Vinicius è il cosiddetto“soggetto strano”: a scuola,
durante le lezioni, non si separa mai dalle suecuffie; consuma, appena tredicenne, le opere di Kafka e immortala ogni istantedella giornata nell’inseparabile fotocamera; sa esprimersi, in virtù di
unsoggiorno transalpino con la madre, in francese e apprende, stavolta guardando semplicemente
la tv, in modo esemplare l’inglese. Mostra, inoltre,
una tendenza particolare verso la critica musicale
che espone in vari scritti e nel contempo, tra le
mura di casa, si prodiga a produrre acetati dilettandosi con chitarra, basso, batteria e effettistica
varia guardando riverente gli eroi Gilberto Gil e
Vitor Ramil.
“Un ragazzo estremamente sensibile”, diranno poi i genitori, la cui crescita desta qualche
preoccupazione:l’empatia col la realtà pare non
appartenergli. Meglio il viatico 2.0.
Il non-luogo. La terra di nessuno dove ci si ca-
muffa e traveste (“Datemi una maschera e vi dirò la verita”, diceva un noto
aforisma di Oscar Wylde) per volere
dell’io represso. Chat, forum. Il giovane ci incappa e si rallegra. Cambia pelle diventando Yoñlu e come d’incanto
si esponenella sua disarmante purezza.
Con la nuova identità propone lasua
musica senza remore, e il nome comincia a circolare via World Wide Web
dall’Inghilterra alla Scozia, dal Belgio
al Canada sino all’Africa alimentando
i consensi deinet-friends, che di contro
al mondo terreno - inesorabilmente
escluso, familiari compresi – godono dell’assoluta
priorità.
La rete, dunque. Una realtà (?!) latente che aiuta e annienta. Naturalmente l’approccio ad essa
sicontestualizza al soggetto fruitore. Dopotutto e
più pericoloso un coltello trale grinfie di un serial-killer che non tra le mani del pensionato sotto
casa.
Dopo un paio di mesi trascorsi in un ospedale psichiatrico, Vinicius un giorno incappa in un forum
particolare dove si parla e si innalza a “romantico
gesto” l’atto del suicidio. Ritornando al discorso
di cui sopra, una persona mentalmente stabile,
alla vista di simili argomentazioni, dopo l’iniziale curiosità avrebbe rigato facilmente altrove, ma
lui, che desiderava - come dice una lettera rinvenuta poi - mettere fine alla sua sofferenza, vi trova
un che da approfondire.
In pratica, i frequentatori di questi forum non ti
evitano di farla finita se ne hai l’intenzione e/o
lavorano sulla psiche dell’individuo, al fine del fatal gesto, se questi manifesta avversione alla vita per la cronaca: dal 2001 ad oggi, le vittime di tali
modalità superano le 100 unità con fascia d’età
stimata dai 13 ai 27 anni.
In breve, nel pomeriggio del 26 luglio 2006 un
Yonlusedicenne pianifica, on-line, la sua fine: entra nel bagno di casa sua lasciando sull’uscio un
biglietto che riporta: “non entrare, massicce dosi
dimonossido di carbonio”. Fine.
Come accennato qualche riga addietro, il lascito
del ragazzo - un cd-r e svariati file mp3 - è stato
assorbito dalla Luaka Bop di Byrne che pubblicherà entro l’anno un disco preceduto, a breve,
da un ep. Tre pezzi dalla scrittura illuminata dove
si avverte, al cospetto dell’età, la matura voce di
Yonlu. In I Know What It’s Like vi suonerà come
un Elliott Smith tropicalista; The Boy and the Tiger, dopo le prime note incredibilmente The Trees
Community, ripiega in elettronica casereccia e dada-pop mentre Humiliation- una perla tra Nick
Drake e Vitor Ramil - ha la grazia del cantore
navigato.
Nel disco lungo, si vocifera,l’inerzia verterà decisa in territori tropicalia. Staremo a sentire.
Vi lasciamo con le parole dellostesso Yonlu, uno
dei tanti messaggi ritrovati nella sua camera:
“Credo che ritmo e armonia, se ascoltati nel momento giusto, possano rendere felici anchei momenti più bui”.
Gianni Avella
Turn On /
15
zione che possedi. Suono in questa città dal 1994,
e dunque in quegli anni ho incontrato tanta gente e qualcuna di queste scene hanno cominciato
a sovrapporsi in un modo organico. Quando sei
circondata da questa energia è emozionante e te
ne nutri come l’aria e l’acqua. Potrò fare qualche
lavoro pazzesco o fare tante cose per ottenere la
gig ma non sono mai stanca quando mi getto sul
palco o nel DJ booth. Ma d’altra parte realmente
non dormo molto….
- Stefano Solventi
Honeychild
Coleman
Leggendo le tue note biografiche nella
cartella stampa sono rimasto sbalordito
e anche un po’ confuso dalla quantità e
varietà di esperienze, di progetti, di collaborazioni. Come hai fatto?
Io amo suonare e creare musica così tanto che
non mi sento molto concentrata o limitata su un
solo genere, stile o scena. New York è un posto
16
/ Tune In
magico nel senso che puoi avere 2 gigs estremamente diverse in una notte. Per esempio, ho suonato un solo spettacolo electronico in Tribeca alla
Warper Party e poi sono andata all’East Village
per una gig suonando la chitarra con Apollo
Heights. L’energia e il passo della città è incredibile e se hai tanti interessi (come me!) sei solo
limitato con la quantità dell’energia e concentra-
La sensazione è che con l’album d’esordio tu abbia voluto rappresentarti in ogni
sfaccettatura. Se è così, quanto sei soddisfatta del risultato?
Come artista in fase di produzione, ho lavorato
con il dub, esperimentale, electronic, cantautore,
e progetti di Rock. Ma questo è la prima volta che
mi sento di aver fatto un lavoro che incolla completamente tutto insieme, e più importante, che
SUONA come me. Scrivo diversi tipi di musica,
quindi quando è arrivato di fare questo album,
a me sembrava innaturale fare un disco dove lo
stile di ogni canzone era esattamente lo stesso.
Sono estremamente contenta di come è venuto
perché sento che tutti questi elementi sono portati insieme in una sensibilità pop. La musica Pop
è criticata severamente in questo paese perché il
valore del pop è considerato commerciale o ‘usa
e getta’, non è molto rispettato al di fuori della
vendita dei dischi. Ma per me, artisticamente, lo
scopo della musica Pop è aggregare gente e far
sì che le canzoni gli si incollino in testa. Spero di
averlo fatto con quest’album.
È davvero notevole e anche un po’ strano il
modo in cui diluisci la componente black
nelle forme electro e rock, a partire dal
tuo modo di cantare. Sono convinto che
in un “blind test” sarebbe difficile intuirne la provenienza, potrebbe essere New
York, Bristol, Monaco, Londra o Chicago.
Quanto c’è di istintivo e quanto invece hai
dovuto lavorare per definire il tuo stile
espressivo?
Mentre non mi sono mai proposta di creare il
mio stile o sentita forzata a distinguere me stessa
dagli altri musicalmente, per così tanti anni mi
hanno detto che sembro abbastanza nera, non
suono Americana o sono troppo ‘retro’, ecc.
Sono cresciuta a Louisville, Kentucky (esattamente il centro degli United States, tecnicamente
nel mid-west ma spiritualmente davvero piuttosto
meridionale), stato colonizzato da scozzesi e irlandesi con una forte influenza di tante tribù native
americane. Musicalmente, nella mia scuola c’era
forte concentrazione sul materiale americano tradizionale, folk music inglese e irlandese. Suonavo
la cetra, l’autoharp o un piccolo xilofono qualche
volta alla settimana. Era così normale, come saltare la corda.
A casa, mio padre ha gestito qualche band di
blues e funk, quindi le loro cassette erano sempre
in giro e la musica era sempre presente. La radio
era sempre dappertutto perchè i miei ascoltavano
tutto, dai Led Zeppelin a Aretha Franklin,
new wave e disco. Non sono cresciuta in una
chiesa o cantando la musica gospel, sebbene i
miei avessero qualche disco stupefacente in giro
la casa, come The Staples Singers, Reverend
Cleverland James, The Pointer Sisters, Soul
Trains Greatest Hits, ecc. Avevo veramente
trovato la mia voce fra la musica folk e i Beatles che cantavamo nella scuola elementare e la scuola media - e lo radio. Stavo diventando adulta nei
primi 80 e rimanevo alzata fino a super tardi tutti i martedì sera per ascoltare lo spettacolo BBC
Rock Over London. Ha cambiato la mia vita.
Dopo di quello c’era stata l’esplosione di MTV e
avendo potuto vedere gli aspetti dei questi artisti
e che c’era pure gente di colore in altre parte del
mondo che faceva diverse tipi di musica mi ha
aperto un mondo intero. Quando stavo cantando
nella Danimarca qualche anni fa e facevo un solo
set apertura per Dejligt, qualche persona pensava che io fossi irlandese. Questa stato davvero
Tune In /
17
interessante perchè quando canto e incido riesco
a sentire il mio accento meridionale che torna.
Ma non posso fingerlo, è una testimonianza dello
stato naturale della mia voce.
Stupisce e inorgoglisce che un disco come
Halo Inside sia stato concepito e realizzato - seppure in parte - assieme ad artisti
italiani e in Italia. Perché credi che sia andata così?
Grazie a una serie dei eventi diversi e collaborazioni nella scena electro di New York, sono diventata amica con Jim ‘Phyle’ Coleman (di Cop
Shoot Cop). Jim ha iniziato lavorando su un disco con M.Teho Teardo (di Meathead/Matera) da un’idea che avevano avuto conoscendosi
in precedenti tour. Loro hanno sentito il disco che
avevo fatto con il projetto di Dj Olive we ™,
mi hanno chiesto ad ascoltare qualche brano e
fargli sapere se fossi interessanta a cantare sul
loro disco. Immediamente mi sono innamorata
della loro musica e sono andata nello studio con
loro. Le sessioni sono andate bene e alla fine mi
hanno invitata a cantare su una compilazine tributo a Robert Wyatt. Uno dei nostri singoli,
Apart, ha beneficiato di una una heavy rotation
video e quindi qualche mese dopo mi hanno invitata a venire in Italia per qualche tour dates.
Il gruppo è andato avanti per registrare un paio
di EP e ho fatto qualche altro tour con loro. Durante questo periodo sono diventata amica con
Matteo Dainese e siamo restati in contatto.
Quando Matteo ha lasciato Ulan Bator e cominciato lavorando come soliata al suo projetto
Dejligt, ci siamo incontrati in Irlanda e UK per
suonare qualche gig insieme (stavo facendo un
tour con Apollo Heights al momento). Mi sembrava un evento naturale lavorare al suo disco.
Contemporaneamente abbiamo cominciato la
lavorazione di Halo Inside. Io e Matteo abbiamo
passato tutta l’estate a scambiarci file via Skype e
internet. Dainese ha lavorato anche col producer
Max Stirner e questo è il motivo per cui Stirner
18
/ Tune In
si è occupato dell’arrangiamento del mio album,
in più si è occupato del missaggio e ha suonato qualche strumento. Che tipo Max: ha impacchettato il suo equipaggiamento e lo ha portato
a Brooklyn accapandosi nel mio appartamento.
Incredibile!
Gli ospiti sono molti e molto diversi,
anch’essi in un certo senso descrivono le
tue inclinazioni, le tue esperienze, la tua
vita. Qual è il filo rosso che unisce Mad
Professor e Robin Guthrie??
Rischiando di suonare retrò, tornando indietro
nel tempo potresti sentire entrambi gli artisti nella
stessa sera e nel medesimo club. Quel che conta
però è che afferrano sonicamente qualcosa in me
che è eterno, sognante e ancora astratto. Esteticamente, nei loro primi anni - e grossomodo attorno
allo stesso periodo – sia Mad Professor che Guthrie nei Cocteau Twins usavano apparecchiature elettroniche similari, come reel-to-reel tape
machines, drum machines, grezzi suoni campionati e voci doppiate con pesanti effetti. Quando le
ascolto, queste cose mi sembrano evidenti. Anche
adesso, dopo aver suonato con Professor e dopo
aver visto Robin suonare solo un paio di volte,
trovo che non siano molto diversi on stage.
Ognuno di loro porta grandi suoni che sono pienamente controllati a portano alla creazione di
una fortezza sonica. Questo è anche il mio approccio alla perfomance a livello elettronico. La
mia filosofia on stage è stata “quanto noise e
suono una persona può creare da solo?” Ecco,
questo è l’obbiettivo. Così in un senso, siamo tutti
spiriti affini.
Le etichette sono una maledizione necessaria e in fondo divertente. Ti hanno paragonata a Bjork, a Kate Bush, a Diana
Ross, a Miriam Makeba... A chi tra queste o altri senti di dovere veramente qualcosa?
Potrei elaborare sulle suddette etichette e dire che
Bjork (Electronic/Dreamy), Kate Bush (Classical/Dreamy), Diana Ross (Pop/Retro) e Miriam
Makeba (African/Folk) e un mix di queste, non
sarebbe lontano. Quando ho iniziato a prendere il
canto seriamente e studiare intonazione classica e
jazz verso i 20 anni, quella che mi ha influenzato
di più era stata Sarah Vaughn. Il suo controllo,
timbro e stile mi hanno spinto ad essere elegante e liscia. Lei era una regina per me. Ma sono
anche cresciuta con il sound Motown, e le The
Supremes erano la mia band preferita quando
ero piccola. Ricordo chiaramente il giorno in cui
mia madre ha dovuto dirmi che non stavano più
assieme. Ho pianto!! Una brava compositrice che
alla fine è diventata la mia influenza più forte,
è stata comunque Chrissy Hynde dei Pretenders. Lei ha scritto dei testi profondi, aveva l’attitudine e poteva suonare la mean guitar. Il suo
era un modo sexy eppure raffinato. Aveva tutto
ed era dell’Ohio e quindi, quando l’ho ascoltata alle superiori ho pensavo “Guarda! Lo sta facendo! Anch’io posso farlo!” Ho appena sentito
qualcosa dal suo nuovo album questa settimana
ed è ancora in forma! È molto eccitante e fonte di
ispirazione vedere una donna pop/rock che non
si è hai mai compromessa per rimanere ‘trendy’.
Anche cimentandosi col dub nel singolo Private
Life (uscito nel 1980, in contemporanea alla versione di Grace Jones) è rimasta se stessa. Forse
le devo di più di tutte.
Stefano Solventi
Tune In /
19
Dm Stith
David as a musician
- Gaspare Caliri
Un predestinato alla musica, nato da una famiglia di musicisti, che però l’ha sempre mantenuta
in un luogo intimo, per dedicarsi alle arti visive. Oggi ci ha ripensato, DM Stith; i risultati non
possono che causargli soddisfazione. Speriamo non sia una scelta provvisoria.
P ortrait
of the artist as a musician
Sulla fotografia se ne dicono di tutti i colori. C’è chi dice sia un artificio che fa rivivere il passato, chi
la preferisce considerare un fatto isolato dalla storia. C’è chi ha parlato di “indici”, perché come un
indice puntato la fotografia è traccia di una presenza, è garanzia di qualcosa che è avvenuto. Chi si
limita al proverbiale istante che viene colto. Di sicuro la fotografia fissa qualcosa, che può essere estremamente variabile come lentissimamente in movimento.
Ne parliamo (ma poco) perché vorremmo usare questa metafora per metaforizzare qualcosa che un
certo David Stith sta facendo su se stesso; vorremmo coglierlo nell’atto di scattarsi un’istantanea della
propria fantasia. Abbiamo ascoltato la sua recente produzione musicale e lo abbiamo intervistato.
20
/ Tune In
David non è certo una persona che ha paura di
esporsi; il suo sito è un blog dove aggiorna i suoi
lettori; ma non è sempre stato così, e soprattutto
non è solo questo che ci interessa; è la musica che
oggi David ha scelto come espressione centrale
della sua creatività, nonostante per anni essa fosse stata messa in secondo piano. Il nostro è infatti quello che si dice un figlio d’arte all’ennesima
potenza. È cresciuto in una famiglia di musicisti
– con padre e nonno direttori d’orchestra, con
il secondo pure professore universitario, la madre pianista, la sorella poliedrica strumentista e
cantante – e completamente avvolto dalla musica. Fin da piccolo ha seguito lezioni di tromba,
percussioni, canto… e però appena ha potuto ha
deciso è stata di fare l’artista visuale.
“Ho sempre avuto bisogno di fare cose per me stesso; mi
chiedo se io non abbia scelto l’arte visuale solo per differenziarmi. L’arte visuale apparteneva per me a una dimensione privata, e così, stranamente, anche l’ascolto della musica. Con tutta quella musica attorno, è stato importante
per me ritagliarmi uno spazio privato nella mia vita dove
essere solo coi miei pensieri. La musica era un buon modo
per aiutarmi a sentirmi separato, per escludere quell’altra
musica che non mi piace.”
Eppure in quegli anni David ascolta molta musica classica, abitudine che neanche oggi ha abbandonato. Per chi ha idea, può essere significativo sottolineare la ricorrenza con cui David parla
di Mahler e dell’influenza che ha avuto nei suoi
ascolti. Non è un caso che citi uno dei più grandi
scrittori di sinfonie in decadimento; uno dei più
grandi direttori d’orchestra e di padronanza musicale come leit motiv tra gli ascolti eteroimposti
da bambino e quello che ora gli è rimasto. La
sua vita sembra orientata al graphic design sposato un’immensa, ma intima, passione musicale;
dipinge mentre ascolta Sonic Youth, Flying Saucer Attack, Nobuzaku Takemura; il suo orecchio
sposa persino la causa dei droni, da cui è sempre
stato affascinato: “Sono sempre stato attirato dai droni
in musica, musica che distingue i dettagli dentro piccoli
gesti epici. Amo ancora questa musica e non l’ho mai posizionata in un periodo preciso della mia vita. Sono legato
a questi riferimenti come d’altra parte, alle orchestrazioni
di Gorecki o ai lavori vocali di Caetano Veloso”. David
tenta persino di fondare un gruppo “noise”, dove
le virgolette sono consigliate dal diretto interessato, ma i cui componenti alla fine pensavano più a
“dipingere le proprie chitarre” che a suonarle.
La svolta, nel turbine di espressione artistica di
David, avviene quando decide di trasferirsi a New
York. È lì che incontra tra gli altri – compreso
Rafter Roberts, altra conoscenza importantissima
- Shara Worden, miss My Brightest Diamond.
“Penso che Shara mi abbia molto influenzato dal punto di
vista dell’etica del lavoro come musicista. È una delle persone più dedite al lavoro che abbia mai incontrato e mette
tutta se stessa nella musica. È una cosa davvero entusiasmante! È stata una gigantesca fonte di incoraggiamento
per me”.
È un incontro fondamentale, ma non per gli ovvi
motivi che si immaginano, tra cui l’immensa dedizione al lavoro di Shara, i tentativi di lei di fare
in modo che lui torni a suonare, si esprima musicalmente; non è di un supporto morale che David
ha bisogno; ma di fotografie. E Shara è la fotografia di un punto di contatto; tra la sua famiglia,
che quasi lo ha predestinato alla musica (tanto
da permettere di descriverlo efficacissimamente
come uno a cui “mancano solo le stimmate”) e a un
tempo per questo motivo allontanato, e l’amicizia. Tra l’infanzia e la maturità; tra la tradizione e
l’indie; e infine - proprio nel momento in cui Shara chiede a David di sviluppare da graphic designer qual è l’artwork per le uscite My Brightest
Diamond – ella diventa la fotografia vivente del
punto di contatto tra musica e arte visuale.
The musician as a musician
“Attualmente non sono più molto un pittore. Vedo però delle
Tune In /
21
connessioni nel processo di creazione. Essere di fronte alla
tela bianca o a un file ProTools vuoto mi causa la stessa
la stessa esitazione e richiede lo stesso impegno e la stessa
ricerca interiore di raffinatezza. In questo modo musica
e pittura sono collegate per me. Certamente i mezzi dono
diversi e fanno emergere idee differenti dallo stesso artista;
in questo momento sono più interessato alla musica come
mezzo di espressione, ma non mi basta del tutto. Continuo
a lavorare come graphic designer e a dipingere con penna,
inchiostro e matita; trovo di averne comunque bisogno.”
Questo ci confessa David sul rapporto tra pittura
e arte visiva. Ma cos’è intercorso nel frattempo?
È successo che David si è deciso a diventare (ritornare?) musicista, ha scoperto che il dominio
davidstith.com è già occupato da qualcun altro
e soprattutto che esiste già un David Stith musicista. Ha recuperato quindi il suo middle name
– Michael – e ne ha accostato l’iniziale a quella del nome. “Nessuno mi chiama “DM”, è solo
il nome del mio progetto musicale”. La parola
“progetto” non può che farci drizzare le antenne,
in materia di provvisorietà di linguaggi espressivi e di fotografie esistenziali. Ma ci torneremo.
David completa subito – nel 2007 - una raccolta
de suo primissimo materiale da songwriter e la
chiama Ichabold And Apple. Tra sito e MySpace si può ascoltare qualcosa di quella produzione; ma la sua produzione è copiosa e monta in
qualche mese decine di pezzi di materiale. Shara,
ancora una volta mentore dell’amico, indirizza
David alla Asthmatic Kitty, label attenta a queste
sonorità che intuisce probabilmente all’istante il
potenziale di DM Stith. Più che un potenziale,
poi, è già materiale vivo; in mezzo anno – tra dicembre 2007 e giugno 2008 - David pensa scrive
suona realizza registra i brani che poi compariranno nel suo primo EP e nel suo primo album.
L’EP si chiama Curtain Speech e vede la luce nel
dicembre 2008, ovviamente per i tipi asmatici. Il
disco contiene già i semi dell’album che pubblicherà di lì a qualche mese; risultano lampanti le
differenze tra la produzione laterale che il web ci
22
/ Tune In
concede di DM Stith – “solo esperimenti” - e quello
che poi finisce nei dischi ufficiali.
L’incedere ci ha ricondato subito da un lato i
Black Heart Procession, dall’altro il mondo Devendra Banhart.
“Mi piacciono sia i Black Heart Procession (il cui album
3 secondo me spicca nella loro produzione, e fra l’altro è
stato anche mixato da Rafter!) che Devendra, ma non li
ho mai considerati tra i miei principali riferimenti. Probabilmente, invece, io e loro condividiamo le stesse influenze.
Non saprei dare dei nomi precisi. Preferisco focalizzare
il discorso sull’ispirazione che ho tratto da scrittori come
Herman Hesse o Frederick Buechner per fare qualcosa di
più “crudo”, e per le conclusioni a cui sono arrivato. La
produzione mi ricorda una vecchia registrazione dei Muppets che possiedo. Noto invece che alcune mie costruzioni
vocali hanno come riferimento Mary Margaret O’Hara,
nel modo in cui gli accidenti e le peculiarità riescono a
parlare e dare forma ai momenti in cui ripartono i miei
crescendo”.
Proprio a proposito di letteratura, lyrics e di costruzioni linguistiche, ascoltando il flusso-arpeggio di Abraham’s Song (Firebird), all’interno di
un verso dello “stornello”, fa la sua comparsa il
titolo perfetto per la musica di DM; “Heavy hammer, heavy ghost, firebird, firebird…”, dice il verso, e preannuncia quel Heavy Ghost (Asthmatic
Kitty) in uscita a marzo 2009, di cui riferiamo in
questo numero di SA, n°53. Abbiamo anzitutto
una conferma, che nasce da due parole quasi antitetiche che sopra abbiamo già usato. Il “flusso”
e la “canzone”. Sembra quasi che tutta la produzione di David si giochi nel limbo che misteriosamente unisce queste due categorie musicali,
la seconda delle quali di molto collegata al soul
degli anni Cinquanta.
mimando cantanti del passato che ho amato, o semplicemente addestrandola e allenandola. Se vi riferite, per quanto riguarda il “flusso”, ai brani presenti sul mio MySpace,
quelli sono vecchi demo, parte del processo di creazione che
mi piaceva segnalare”.
Ma è proprio quel processo che si insinua anche
nella canzone più organicamente organizzata. E
lo strumento principe è proprio la produzione, il
lavoro di aggiunzione o di cesello, operato proprio da DM per i suoi dischi.
“Ho prodotto io il mio disco! Tutti i suoni sono registrati
da me, scritti da me, arrangiati da me. Rafter li ha mixati, con le sue orecchie magiche. Ha aggiunto un sacco
di senso di spazio, necessario al mio suono. In generale
comunque tendo a registrare moltissime idee e ho ancora
qualche problema a sistemarle, selezionarle, per chiudere un
mix pulito. Da questo punto di vista, lavorare con Rafter è
stato utilissimo”.
Il processo dunque è una sommatoria di elementi
che creano un effetto di montaggio, nel senso della panna montata. In quel processo, la fotografia
è una canzone estratta dal flusso. Paradigmatico
il caso di Pity Dance, brano dove è indecidibile la
propensione verso una forma o l’altra.
E in realtà l’individuazione di tale oscillazione
tra flusso e forma canzone nasce dal tentativo
di questo articolo, cioè immortalare un flusso di
creatività; alla fine quello che emerge dall’ascolto è il talento cristallino di Stith, le sue capacità
disarmanti di compositore della ambiguità canzone-flusso. Ma dopo tutto, tornando all’idea di
“progetto” dietro DM Stith, è lecito domandarsi
quanto durerà tutto questo. DM Stith è un’istantanea di David Michael Stith o la fotografia del
culmine del suo percorso?
“Le differenti forme d’arte si alimentano a vicenda. Non
vedo la mia musica come un culmine di una crescita e di un
impegno artistico, ma di certo è stata una parte importante
del progresso. Dal momento che sono stato timido e poco
propenso a fare e condividere la mia musica per moltissimo
tempo, fare in modo che quella parte di me oggi venga conosciuta è stato incredibilmente liberatorio ed entusiammante;
mi ha fatto conoscere aspetti della mia arte di cui non ero
al corrente”.
Insomma, pur superato lo scoglio e la timidezza,
la domanda è rimasta comunque parzialmente
inevasa. Aspetteremo un suo concerto per avere
elementi in più per darci a nostra volta una risposta più compiuta. A quanto ci ha detto, plausibilmente lo vedremo in Italia, dal vivo, a maggio.
Difficilmente apprenderemo la conferma della
notizia con indifferenza.
“È una questione difficile da sviscerare. Credo che la mia
soul-ness provenga dal modo in cui canto ora. Mi sono
molto divertito a osservare quello che la mia voce può fare,
Tune In /
23
Nicolas Vernhes
Rare Book Room
La biblioteca analogica
Da più di dieci anni Nicolas Vernhes cura il
sound di alcuni dei gruppi di punta della scena
newyorkese. La nascita della sua nuova label ci
ha fornito il pretesto per una breve chiacchierata.
Se un giorno vi capitasse di ritrovarvi a ciondolare senza meta dalle parti di Brooklyn & co. sappiate che potreste incrociare la strada che conduce al Rare Book Room Studio ed imbattervi
in alcuni dei leggendari personaggi che in tempi
recenti hanno popolato l’immaginario della east
coast. E se quelle stanze insonorizzate e avare di
finestre non trattenessero abbastanza decibel, ne
udireste anche le gesta sonore. Di lì a breve un
piccolo truman show potrebbe dispiegarsi davanti ai vostri occhi: l’ombra sottile di Bradford Cox,
chitarra in spalla e dito sul citofono, il passaggio
della bella Eleanor Friedberger, capelli freschi di
phon e foulard infiocchettato intorno al collo e,
infine, la parata degli Animal Collective, in gita
da Baltimora con un seguito di freak friends.
Nato nel 1995, il RBR ha visto passare in sala
regia un esercito di nomi legati ad alcuni dei migliori dischi brucia-ipod dell’ultimo decennio: Se24
/ Tune In
- Francesca Marongiu
cret Wars degli Oneida, Gallowsbird’s Bark
dei Fiery Furnaces, Creature Comforts dei
Black Dice, Cryptograms e Microcastle dei
Deerhunter, per non citare che i più noti. E il
boss Nicolas Vernhes negli ultimi tempi ha deciso di rischiare di più, affiancando allo studio di
registrazione una label dal nome omonimo, che
ha già all’attivo l’esordio di Palms e Lia Ices.
Nostalgici ed elettrowave i primi, di catpoweriana
memoria ed infinita grazia la seconda, hanno partecipato insieme ad alcuni dei gruppi sopra citati
alla compilation inaugurale dell’etichetta: Living
Bridge (recensita su SA n.51), che è stata solo il
pretesto iniziale per una piacevole chiacchierata
via mail con Vernhes: “Living Bridge parte da un
intento promozionale e passionale; volevo inaugurare la mia etichetta con un disco che non fosse
interamente riconducibile ad uno stesso genere e
allora l’idea della compilation mi è parsa quella
più plausibile. Per l’occasione ho contattato alcuni gruppi con cui avevo già lavorato e un po’ di
gente nuova”.
Ne è venuto fuori un mix (nel senso letterale della
parola, dato che Vernhes ha cucito insieme tutti
i pezzi con magistrale abilità) che ricorda un po’
le reunion tra ex-compagni di scuola. Seduti allo
stesso tavolo troviamo un’egregia rappresentante
della scena di Louisville (Tara Jane O’Neil, exRodan), uno di quella, più recente, del freak folk
(Avey Tare), esponenti di punta della new wave
dello shoegaze (Deerhunter, Telepathe) e altri ancora che, come i Black Dice, hanno anticipato di
qualche anno il digital shoegaze di Growing e
Fuck Buttons: “Ciò che lega questi gruppi e musicisti
è che tutti sono pronti a correre il rischio che comporta il
comporre buona musica e io ho voluto dare loro la possibilità e gli spazi per portare a termine i rispettivi progetti.
Quando ho chiesto ad ognuno di loro di portarmi una can-
zone, il mio proposito era di farli sentire liberi dalle tipiche
dinamiche che si creano quando si registra un album in
studio”. Tra tutti i brani proposti spicca la traccia
di Avey Tare, I’m Your Eagle Kisser, un’apripista
che fa ben sperare, tra visceralità e goliardia, freakedelica e per nulla nostalgica: “Dave si è presentato in studio con un pezzo su cui stava lavorando
e lo abbiamo arrangiato insieme, strumento per
strumento. È stato molto semplice, lui è un ottimo musicista, quindi è stato un piacere stargli
dietro”. Ma non si va oltre con le confidenze sui
gruppi che hanno lavorato lì, men che mai sui
Fiery Furnaces: “Non posso raccontarti aneddoti
su di loro. In studio sono come un prete in un
confessionale. Quel che accade lì è strettamente
riservato!”.
Spostando invece il discorso sulla scena di Brooklyn e dintorni, cerchiamo di provocarlo riguardo a un punto che ci sta particolarmente a cuore: le parole di Martin Rev sulla fase attuale del
rock, definita da lui come “interpretativa” e sulla
sensazione che dalle parti della east coast escano probabilmente alcuni dei dischi migliori degli
ultimi tempi, ma che comunque non si faccia la
storia: “Sono pienamente d’accordo, viviamo in una fase
interpretativa del rock e credo che ogni musicista lo riconosca e cerchi di rapportarsi a proprio modo con tutto ciò.
Ma, d’altro canto, oggi circola anche tanta vecchia musica
e magari chi vi si avvicina può prenderla come unica fonte di ispirazione per la propria. Non parliamo, ad ogni
modo, di fenomeni nuovi perchè molti gruppi lo facevano
già in Inghilterra negli anni Sessanta, ascoltando il blues
americano, che era la loro piccola, segreta, miniera d’oro.
È da lì che è nata la commistione di generi diversi come il
rock, il folk e il blues Oggi abbiamo bisogno di alleggerirci
dal peso della storia quel tanto che ci permetta di aprire
una porta sul futuro della musica. Se si pensa che l’hip
hop è stato l’ultimo grande genere musicale inventato…Per
quanto riguarda Brooklyn e la East Coast, alcune città da
cui escono le così dette “scene” non sono poi le uniche note
per esportare nuovi sound. C’è da aggiungere che quelle più
in vista, come Philadelphia o Baltimora, sono economiche.
Là un musicista può davvero vivere con pochi soldi e ha, di
Tune In /
25
conseguenza, più tempo da dedicare alla musica. New York
invece è molto costosa, anche per chi vive nella periferia più
remota ed è quindi difficile trovare un posto dove vivere e
provare senza spendere molto. C’è ovviamente anche gente
coraggiosa che viene qui con il sogno di suonare nella grande città e grazie alla propria creatività se la cava bene”.
Ma qual’è la discriminante che rende un disco più
o meno riuscito, più o meno in grado di influire
sulla storia? “Un album funziona quando è ispirato da
una sorgente emotiva forte che incontra una struttura che
coinvolge l’ascoltatore nello sviluppo del pezzo, a differenti
livelli, simultaneamente.” E parlando dei punti di riferimento principali nel suo percorso di fonico e
producer: “Mi piace tutta la musica che si trasforma nel
suo svolgersi e riesce, allo stesso tempo, ad essere ipnotica.
Nel caso si tratti di un gruppo che viene in studio, deve comunicarmi la sensazione che stia accadendo qualcosa di importante mentre sto registrando. Se poi penso ai dischi che
rappresentano un punto di riferimento nel mio percorso musicale, bè, la lista è lunga: dai The Kinks di Arthur Or The
Decline And Fall Of The British Empire a Safe As Milk di
Captain Beefheart, dalla Brigitte Fontaine di Vous et Nous
ai Circle di Sunrise. E poi Sonny Sharrock, Jacque Dutronc,
Gainsbourg (escluso il periodo reggae), Scott Walker…”.
Alcuni dei dischi che hai citato hanno dietro una
produzione impeccabile, c’è una cifra particolare
che è data dalla mano del maestro…Ciò vale per i
dischi prodotti al RBR? “Le persone dicono che i dischi
registrati al RBR hanno un suono specifico. Io non me ne
accorgo, come nessuno può accorgersi del modo in cui la propria voce viene percepita all’esterno. Penso che gran parte del
merito del suono “RBR” sia da attribuire ai musicisti con
cui ho lavorato, davvero ispirati, in gamba e con un minimo
di bagaglio tecnico. Qualità essenziali per riuscire a catturare i “momenti musicali” in cui emerge la vera personalità
di un gruppo”.E Brian Eno, qual’è il suo segreto? Da
qualche parte ho letto che ti piacerebbe molto lavorare con lui… “Il segreto di Brian Eno risiede nella
sua intelligenza e nell’estrema abilità nel coniugare, all’interno del processo creativo, le proprie emozioni, la psicologia
e la tecnica”.
Non si sbilancia più di tanto, Vernhes. Gli chiediamo allora una top 3 di congedo sui dischi del
26
/ Tune In
2008…“Quest’anno ho lavorato così tanto che non ho avuto
il tempo di ascoltare molti dischi, a parte quelli ai quali ho lavorato e quindi è un po’ difficile rispondere. Dando un’occhiata
su Itunes posso dirti che compare un solo disco del 2008 ed è
Visiter dei The Dodos… Il resto è tutta musica più vecchia
come Es Liebt Dich Und Deine Korperlichkeit Ein Ausgeflippter degli Workshop e Shake Sugaree di Elizabeth Cotten”.
Breve cronistoria discografica:
Silver Jews - American Water (Drag City/
Domino, 1998)
Il Rare Book Room è aperto da appena tre anni
e a Vernhes capita tra le mani uno dei dischi più
importanti della prima stagione del cantautorato
indie pop, nonché punta di diamante della discografia di David Berman. Per l’occasione il Nostro
è tornato in coppia con l’amico Malkmus, che nel
2007 sarà di nuovo al RBR per registrare Real
Emotional Trash.
David Grubbs - The Spectrum Between
(Drag City, 2000)
Ad un anno dallo sciogliemento dei Gastr Del Sol,
Grubbs aveva contattato Vernhes per registrare
Coxcomb. Nel 2000 ritorna per realizzare il primo
dei suoi dischi più fluidi e accessibili, The Spectrum Between, opera post camoufleuriana dove
troviamo un po’ tutto quello che negli anni a venire sarà un bel tormento: fingerpicking faheyano,
contrappuntistica jazz, Nick Drake, country-folk
e corteggiamenti brasiliani. Ma la collaborazione
non si chiude qui: si tornerà in studio altre due
volte in un paio d’anni: la prima insieme a Loren
Connors per Arbovitae, la seconda col gigante
Gustafson per Off Road.
Black Dice – Beaches And Canyons (DFA,
2002)
Nell’autunno del 2001 i Black Dice entrano per la
prima volta al Rare Book Room e ne escono nel
2002 con il doppio vinile Beaches And Canyons.
Opera rappresentativa di quel sound newyorke-
se recentemente esportato oltreoceano, Beaches
è forse il miglior album del dado nero, probabilmente perché tanto quel percussivismo astratto e
pervasivo, quanto quel suonare-non suonare-campionare fanno toccare alla “fase 2” dei Black Dice
il suo apice già al primo colpo. Il gruppo è tornato
in studio di recente per registrare Repo, che uscirà
i primi di aprile.
The Fiery Furnaces - Blueberry Boat (Rough Trade, 2004)
L’anno prima i fratelli Friedberger gli avevano affidato le sorti di Gallowsbird’s Bark, caleidoscopico
esordio in cui il duo di Chicago mostrava già tutti i
motivi che avrebbe sviluppato nei dischi successivi:
un music hall ossessivo e schizofrenico come solo
i Residents, capace di rileggere tanto Velvet Underground e Who, quanto Beatles, Bowie e il miglior garage rock, confezionandoli in un’ estetica
glamchic aggiornata agli anni Duemila. Blueberry
Boat si arricchisce di quel piglio elettronico scafato
e ugualmente elegante che mette in risalto l’abilità
di Vernhes nel cimentarsi sia con la forma acustica
che con quella elettronica, di cui aveva già dato
prova nell’esordio dei Fischerspooner.
Deerhunter - Cryptograms (Kranky, 2007)
Bradford Cox e soci hanno registrato i loro ultimi
due dischi e un ep con Vernhes. Cryptograms rappresenta un’ opera incompiuta ma sottilmente affascinante e ciò è dovuto anche ad un sound diviso
tra soluzioni kranky friendly e new wave made in
uk. Psichedelia shoegaze e loop un filo krauti completano il quadro di riferimento. Successivamente
la mano di Vernhes si affina, fino ad arrivare a Microcastle.
Animal Collective - Strawberry Jam (Fat
Cat, 2007)
Il collettivo degli animali non dà il meglio di sé in
questa prova, se non altro perché il rischio di ripetersi è spesso dietro l’angolo. Ma la produzione
è impeccabile: evidentemente lavorare con Black
Dice e Deerhunter è stata una buona scuola per
Vernhes. Avey Tare e soci torneranno in studio per
registrare l’ep che doppia i dubbi riposti su Water Curses,Strawberry Jam. Ma questo, si sa, esula
dalle responsabilità di produzione.
Tune In /
27
Lo spazio
del suono pt. 2
Rafael Toral
e lo Space Program
- Vincenzo Santarcangelo
28
/ Drop Out
Lo abbiamo letto nel primo numero di questa rubrica: Ralph Steinbruechel non si considera
un sound-artist, sebbene gli ambienti che accolgono le sue performance sono prevalentemente quelli di gallerie, fondazioni, spazi espositivi.
Spazi aperti o spazi delimitati da mura: in ogni
caso, spazi con i quali interagire, che finiscono
per funzionare da strumenti addizionali per la
performance.
Ancor meno si può definire sound-artist il portoghese Rafael Toral, i cui spazi - gli spazi entro
cui il suono si sprigiona - sono quelli angusti dello
studio di registrazione allestito nella sua abitazione privata di Lisbona, o quelli di concert-hall da
post-free-jazz-electronic music - come il portoghese ha definito la nuova declinazione del suo
fare artistico.
Il fatto è che il suono di Rafael Toral è divenuto
da un po’ di tempo a questa parte qualcosa di
maledettamente indefinibile, una materia ostica
e sfuggente che ad un primo ascolto non può che
disturbare o lasciare sconcertati. E al contempo,
il rapporto tra quel suono e spazio è diventato
uno dei punti cruciali attorno a cui ruota la nuova
fase artistica del portoghese. È ormai cosa nota:
Rafael Toral, considerato fino a qualche anno fa
uno dei massimi interpreti della chitarra sperimentale post-2000, ha inaugurato a partire dal
2006 un nuovo programma di ricerca che lo terrà
impegnato almeno per altri tre anni. Lo Space
Program consiste in una serie di sperimentazioni
(strutturate in tre differenti capitoli: Space Studies, Space Elementse Space Solos, ed inaugurata da quella specie di manifesto programmatico
che è stato, nel 2006, Space) che reperteranno su
supporto discografico (cd, ma spesso e volentieri
anche vinili) frammenti infinitesimali delle migliaia di ore di musica realizzate nello studio di
Lisbona dove l’artista lavora da anni - nella migliore tradizione del tecnico del suono - a dispositivi e generatori di onde sonore personalmente
brevettati.
Spazio è qui parola da accogliere nel pieno della
sua valenza polisemica - e ovviamente, il pensiero
non può che andare a Sun Ra. Spazio è l’estensione illimitata o la porzione di universo - il mezzo
della fisica acustica - entro cui il suono si propaga.
Spazio il luogo privato in cui sentirsi a casa propria - lo studio in cui l’artista sperimenta senza
remora. Spazio l’avamposto ideale di infinite possibili civiltà aliene - lo Spazio, con la S maiuscola,
attorno a cui ancora timidamente fantasticavano
i primi film di fantascienza, l’ecosistema, con tanto di fauna, di una galassia sconosciuta - riuscite
a figurarvi cosa sarebbe successo se Olivier Messiaen avesse compilato il Catalogue d’Oiseauxsu
un altro pianeta (mr. Merzbow può forse venirci
in aiuto)?
Lo Space Program, ci racconta Toral, che abbiamo interpellato per cercare di fare chiarezza su
questo ambizioso progetto, ha in realtà a che vedere con la mancanza di spazio, più che con lo
spazio. Un problema tipicamente moderno, quello della carenza cronica di spazio. «Nel corso delle
nostre vite moderne siamo ormai abituati a fronteggiare il
problema, quanto mai pressante, di una scarsità cronica di
spazio. Spazio mentale, spazio fisico, spazio acustico, spazio visuale, addirittura spazio musicale: tutto è diventato
pieno, occupato da oggetti, e così il vuoto, o il silenzio finiscono per essere percepiti come beni di lusso. Siamo disposti
a sborsare cifre da capogiro per procurarcene».
Quando parla dei progetti che lo terranno impegnato nell’immediato futuro, Rafael Toral è un
fiume in piena. Lo Space Program non è giunto,
con Space Elements vol. 1, che al terzo capitolo. In quel disco, una sorta di classico trio post
free-jazz ma che a strumenti acustici affianca le
frequenze dell’amplificatore modificato MT-10
Bender (protagonista di un brano dello Space
Solo 1), propone una musica che lo stesso Rafael Toral ha definito post-free-jazz-electronic music e che ha contratto un debito con il sistema
elaborato da Sei Miguel, compositore, direttore,
trombettista che, a detta di Toral plays his trumpet with complete awareness of the whole Jazz
history while dealing, as a music director, with the
Drop Out /
29
full spectrum of sound sources in a broad range
of innovative (and often strange) solutions, including frequent use of electronics.
Nella serie degli Space Elements - ci spiega Toral - ogni singolo materiale registrato è utilizzato
come elemento compositivo, compresi quelli provenienti da musicisti ospiti. La gran parte delle
registrazioni sono state fatte singolarmente, per
alcune tracce i musicisti addirittura non erano a
conoscenza, al momento delle registrazioni, di
quale sarebbe stata la resa finale. Vi è stata interazione fisica tra musicisti solo per quanto riguarda la prima traccia, nella quale io e Rute Praça
abbiamo suonato insieme, e per la traccia sette
- un’interazione live di un duo composto da me e
Margarida Garcia
Dal vivo, invece, l’attenzione si sposta dalla composizione alla performance. Per fare in modo che
ciò avvenga, preferisco lavorare con musicisti che
abbiano consapevolezza dei principi dello Space
Program - chi ha già collaborato con Sei Miguel è
infatti solitamente il benvenuto, dato che lo Space
Program si ispira al suo sistema.
È facile farsi una ragione della reazione offesa
provocata dall’ascolto di Space Solo1e Space Elements vol. 1, primi due capitoli dello Space Program dopo il manifesto programmatico Space
(Staubgold, 2006); di quella, sprezzante, di chi ha
sentito tirare in ballo il jazz - ma cosa ha da spartire, il jazz, con i monologhi autistici di macchine
improvvisate? - a proposito dello Space Program.
Poi osservi Rafael Toral armeggiare con quelle
macchine e torni a riflettere sul rapporto che intercorre tra gesto, comunicazione, spazio e suono.
«Sono molto interessato al problema dell’origine della musica - spiega Toral - mi affascina l’idea di avere a che
fare con suoni essenziali, prodotti per necessità. Penso agli
ominidi che comunicavano tra loro con un misto di segni e
vocalizzi ad alto contenuto emotivo, spesso dotati di musicalità. Il fatto che stia cercando una sintassi che strutturi
un nuovo linguaggio musicale non fa che ricondurmi alle
origini del suono».
30
/ Drop Out
Osservando le macchine di Rafael Toral, e il loro
strano funzionamento, ci si torna ad interrogare
su quale sia, precisamente, la natura di quelle interfacce tra uomo e segnale che i libri e le scuole ci
hanno insegnato a chiamare strumenti. Lo Space Programpuò essere considerato un contributo
alla riflessione sul ruolo delle interfacce, forse non
consapevole, sicuramente di tipo intuitivo.
È lo stesso Toral a confermarlo: «Si è trattato più che
altro di una evoluzione naturale. Non credo di poter ricavare stimoli dalle riflessioni che si è soliti fare guardando
al laptop come ad un valido dispositivo per generare suono;
trovo anzi che sia uno dei più inadeguati strumenti che
siano mai stati utilizzati per fare musica».
Spesso la musica che nasce da una ricerca consapevole su nuovi strumenti rischia di diventare
inconsistente. Quello di Rafael Toral è invece
un tentativo di rispondere a domande essenziali,
quasi banali nella loro essenzialità: dispongo di
un nuovo strumento, che utilizzo ne farò? È possibile generare una nuova grammatica per strutturare un discorso musicale? Cosa condiziona la
mia decisione di procedere da un suono ad un
altro?
«Mi sembra piuttosto naturale considerare la performance
come quella attività in grado di coinvolgere il corpo del
musicista e stimolare una gestualità - una serie di gesti all’interno di uno spazio».
Lo Space Programè frutto di un intelligente domandare su temi che assillano da secoli i teorici della musica. L’improvvisazione, ad esempio.
Perché Toral, nel momento in cui doveva presentare lo Space Program, ha parlato di jazz? Che
reazione si aspettava dai puristi?
«Nutro sospetto verso l’ideale del purismo, ma capisco che
parlare di jazz sia parso un affronto perpetrato a danno
degli appassionati del genere - i quali, immagino, non mi
riserveranno troppe attenzioni. La mia intenzione è di generare suoni elettronici tramite performance basate su decisioni prese all’istante; avevo bisogno, a questo scopo, di una
vera e propria forma di disciplinamento, anche perché avrei
suonato strumenti con una tecnica del tutto inedita, senza
servirmi dei software abituali e usando liberamente l’intero
spettro delle frequenze - nessuno spazio concesso ad accordi
o a scale. Tutto ciò è già stato fatto innumerevoli volte, ma
non nel campo dell’elettronica - la storia dell’elettronica,
dunque, non poteva fornirmi alcuno spunto utile».
Non restava allora che rivolgersi a tecniche ed
insegnamenti provenienti da altri generi. «Se ho
pensato al jazz è perché si basa su decisioni individuali regolamentate da una sorta di austera
disciplina. L’approccio personale al suono ed alla
musica, l’importanza conferita al fraseggio inteso
come unità significativa minima, la capacità di
prendere decisioni in tempo reale: ecco cosa accomuna lo Space Program al jazz. Quando suono penso esclusivamente in termini di fraseggio
e di swing, non guardo alla mia musica come si
trattasse della performance di un compositore».
Toral non è un compositore,
non un semplice ingegnere
del suono. Un chitarrista sa
come accordare lo strumento e come cambiare le corde,
un batterista come accordare pelli. È normale per chi si
occupa di musica elettronica
avere competenze ingegneristiche, saper usare un saldatore o aggiustare un sintetizzatore.
«In fin dei conti si tratta solo di
avere dimestichezza con gli attrezzi che si utilizzano, con la materia che si manipola: prerogativa da
cui nessun artista può prescindere.
Tuttavia l’oggetto della musica è
il suono (insieme al silenzio) e ritengo più utile approcciarsi ad esso
attraverso le leggi della fisica che
tramite concetti astratti come note
o scale».
I materiali che il musicista
forgia sono il suono ed il silenzio: «La musica è come
una moneta a due facce – il
suono ed il silenzio – che ruota sull’asse del tempo.
Il tempo è l’unico parametro che suono e silenzio
hanno in comune. Non esiste più alcuna definizione esatta di cosa significhi oggi comporre; tutti
i suoni sono generati manualmente, fisicamente,
direi, su un fondale di silenzio».
Drop Out /
31
BBreaks
Lungo il continuum con Harmonic
313, Zomby, Lukid, Actress,
Hudson Mohawke
- Edoardo Bridda, Marco Braggion, Giancarlo Turra
Stretta di mano tra Animal Collective e Zomby ed è subito
remember di un’epoca che ritorna mutante e mutata in
alcuni nomi contemporanei. Non solo. L’occasione è delle
migliori per riflettere sulla non troppo famosa (da noi)
teoria del continuum postulata da Sir. Simon Reynolds
A lmanacco
del giorno prima
L’11 febbraio 2009 Simon Reynolds ha tenuto alla Foundation for Art and Creative Technology di
Liverpool una conferenza sulla non troppo famosa teoria sull’Hardcore Continuum. Teoria espressa in
una serie di articoli apparsi su The Wire prima e dopo le varie stesure del libro Energy Flash, che non
è niente di meno dell’unica vera bibbia della generazione E. Uscito sul calar dei Novanta, il tomo di
oltre 600 pagine storicizzava - prima di tutti e soprattutto in maniera vertiginosamente definitiva - tutti i moti dell’ultima grande generazione del dopoguerra. Quella che sentì Detroit pulsare di futuro e
quella stessa che, passando per Ibiza, ballò e sballò a velocità supersonica per poi schiantarsi a terra e
frantumarsi sotto le due Torri. Tutti oramai sanno tutto dei profeti americani della motor city come della
32
/ Drop Out
Chicago che diede vita all’House. Techno e House oramai sono cose scritte nei libri e pure la giovane Berlino di Allien e The Hacker, degli squat e
della Parade ha oramai i suoi anni sul groppone.
Eppure se questi concetti sono oramai ascritti e
inscritti nella pietra a tutt’oggi la scuola Brit non
gode degli stessi blasoni. Stranezza comprensibile
o incomprensibile visto che il buon Reynolds la
considera non a torto come la broda dalla quale
tutta l’elettronica dance (e non) nacque e si sviluppò. Lo scorso anno parlavamo di un ritorno
dell’Ambient: venata techno o di quella brutta
parola, l’IDM, musica intelligente elettronica,
chiamata così per distinguerla dall’hardcore dei
ragazzetti sballoni. I “faceless bollocks”, i coglioni senza volto che ogni santo WE morivano di - e
per - una musica decerebrata (punk), tutta uguale (punk), che tutti potevano fare (punk) e che risponde meglio di tutte al degrado di una nuova
generazione di ragazzi con meno valori, meno
obbiettivi e meno speranze di quella precedente
(insomma: punk al cubo). Era l‘ardkore, rivoluzionaria per l’insieme dei cromosomi che forgiarono
una genetica mutante. Diversa e affine dalla sua
gemella nazi-metal belga. Un continuum, per dirla con Reynolds e Star Trek. A farla breve, finito il
dominio dei dogmi Derrick May, Model 500 (ma
anche gli Inner City), la sbornia di computer e
modularità dell’ethos detroitiano che mantenevano un mercato in bilancio a prevalenza import, i
ragazzi inglesi tirano fuori questo impasto tamarrissimo post aceeed e ancor più smaccatamente
pro-chimica. Prima, è vero, c’era il bleep’n’bass,
ed è noto quanto le prime produzioni WARP di
Forgemasters, Sweet Exorcists o LFO siano debitrici a quelle Roland d’oltre atlantico. Soprattutto a quella serietà che il nuovo paradigma sfascia
con perfetto spirito punk. Era un pasticcio strano
di codici morse, voci pompate nell’elio, degerazioni di tastiere alla Derrick May con la ciliegina
sulla torta di un elemento magico e anti-scientista: il break beat. Il campione rubato. Roba che
viene anch’essa dall’America ma, ed è qui il bello,
se gli Stati Uniti avevano creato Techno e hiphop, sono stati i kids in UK a unire i lembi del
foglio black e a rivoltarlo sul lato white. Personaggi catalogati alla voce drum’n’bass e IDM come
Liam Howlett (Prodigy), gli Autechre erano nati
B-boys e cresciuti adorando i bassi dei ghetto-blaster, quegli scatoloni di plastica con le cassette e le
mille leve. I pulsantoni e le mega casse. È sempre
e comunque Il bass, lo stesso che inizia ad esseDrop Out /
33
re una scienza
con LFO e
Sweet Exorcists e che
conduce
lungo varie ondulazioni al
Dub-Step.
Ma
dai
modi
più
stravaganti e
hand-made per
far tremare i vetri
della disco al campione di Funky Drummer
c’è un salto, l’Hardcore,
scritto con spelling volutamente
ignorante e proletario in ‘ardkore perché una botta in
faccia che sale dal basso,
in tutti i sensi. Bleep sta
pur sempre a Kraftwerk
e la Centrale elettrica
tedesca trasportata a
Detroit, città di motori.
Brum Brum futurista a
chiusura del Novecento, dove ‘ardkore fa rima
con you know the score. Ed
è slang hip-hop che strappa da quella cultura il cuore della faccenda: il campione. Che, attenzione, può voler
dire strategie per ottenere il basso
scientificamente più detonante possibile (LFO) ma anche altro. Molto lontano
dall’ideologia che sta dietro al sound computazionale Techno, porta a un campione di Sesame Street
(Smart e’s, Sesame Treet) o ai dialoghi di Star Trek
(Mr Kirk’s Nightmare, 4 Hero). E un Hardcore Hiphop
break - velocizzato per bene da Shut Up And
Dance via Mantronix - causa un’epilessia nuo34
/ Drop Out
va. La quale avrà nei Cold Cut (Beats and Pieces,
1987) dei profeti del funky drummer di James Brown
per estendersi fino al funk e ai post-modernismi
da classifica del Beck in combutta coi Dust Brothers, giusto per citare un esempio per tutti.
Anni di crossover i Novanta ricordate? Così come
Pump up the Volume dei M/A/R/R/S e Theme from
S’Express di S’Express erano la roba seminale
che preparava il terreno albionico alo scossone,
l’ardkore. Cromosomi nuovi che traducono, amplificandoli, gli effetti dell’MDMA tagliato con lo
speed e ne sono diretti boomerang sonici. Più che
no future è euforia oltre-epilettica. È pronto alla
dark side, come dice Reynolds ma, per quel che
ci interessa, creativo e povero nel senso dei mezzi,
due spiccioli e un’idea - anche scopiazzata, anzi:
decontestualizzata - che muta in altro per puro
sbaglio lasciato nel mix. E nel mix non dimentichiamo la Giamaica e il suo dub, altra scienza
che gravita potentemente intorno ai break veloci
e getta un altro ponte, tutto inglese questa volta, tra i neri con i joint e i bianchi pieni di E.
Il cerchio base è pronto per il salto temporale in
un 2009 che inizia con fatti assai curiosi come il
seminario di cui sopra e un articolo, sempre del
Nostro critico albionico preferito, dove scopriamo un aneddoto succulento. Ovvero che gli Animal Collective, ancora sull’onda del nuovo Merriweather Post Pavilion, additano un oscuro
dj-produttore dub-step a loro mito e ne ostentano
le affinità in una mentalità votata al loop e al(le)
pastiche. È Zomby il cui album/caso Where Were
You In ’92, entrato per il rotto della cuffia pure in
diverse classifiche di fine anno, riporta in vetta le
sonorità del periodo ‘ardkore old skool dal ‘90 al
‘92. Il biennio d’oro, la fase all’elio prima delle
nubi nere che avranno la meglio col semi-gabba
(via Belgio e Beltram), cui seguiranno schianto
e ricomposizione (la minimal) da una parte, e
dall’altra il nuovo punto fermo del continuum:
Jungle e drum’n’bass. L’album di Zomby è un
prodotto studiato a tavolino e lo stesso ragazzo
brit che lo abita ci ha fornito nomi e cognomi,
fatti e connessioni. Le etichette sono Formation,
Ibiza e Music House. I nomi Manix, Acen, 2 Bad
Mice, Origination, Noise Factory, Hackney Hardcore,
Lennie De Ice. Da buon carbonaro ha tralasciato
tante cose, particolari importanti ma che importa. La cultura White Label è l’opposto dello stardom, e per l’inedito più recondito c’è sempre il
peer to peer a farla finita coi segreti assoluti. Che a
dire il vero non ci sono mai stati, ragion per cui il
segmento minimo ci interessa ancor di più perché
chiave d’accesso per entrare e modificare il continuum. Prima di parlare della sua connessione,
dunque, è doveroso salire in cattedra.
B it G enerations
Suonano parecchio simili nella lingua inglese, le
due parole su cui ruota questo articolo. E, cosa
ben più importante, rappresentano i pilastri di
un’ampia fetta degli ultimi trent’anni di musica o
poco meno. Bit e beat: frammento e ritmo. Entità
che più distanti tra loro non potevano sembrare
fino all’avvento dell’hip-hop. Finché ci rendemmo conto che un passaggio estratto da un disco
altrui e ripetuto - manualmente o campionato faceva poca differenza - poteva tramutarsi in cosa
totalmente altra rispetto all’originale. Qualcosa
che con gli Shut Up And Dance figliati dai Public
Enemy decollerà fino al “cartoon sound” ardkore. Parola chiave: accelerazione frenetica di vita
e consumi nella quale siamo immersi; velocità
addizionata speed che porterà il continuum alla
drill di Aphex o Squarepusher come agli astrattismi degli Autechre. Gente lontana dai furti di
strada - il funky drummer - eppure così vicina
ad essi. Bit e beat infatti sono le chiavi anche per
loro, le stesse degli hip-hoppers nei parchi di New
York, magari addizionate di futuro e chimica, ma
il meccanismo incubatore è lo stesso. In mezzo a
questo varco c’è l’ardkore in Inghilterra e l’hiphouse della grande mela, ambedue zone franche,
specie la prima dove non c’è ego né brand e tutti
copiano, pardon campionano. La magia di tutto
ciò è che Erik Satie e Brian
Eno valgono tanto quanto
Grandmaster Flash
o Steinski. E la musique concréte di Pierre
Henry, passando
per i Muppet e
Spock, arriva alle
masse ed entra
in ogni casa. Pop
non stop e tanti
saluti all’accademia.
Che si tratti del
rumore di piatti e
bicchieri di un café
o del ronzio di fondo di un aeroporto, di
drone chitarristico o polvere di glitch, di scratching
sul giradischi o collagismo che più
funky si muore, il frammento coagula le
infinite potenzialità dell’attimo. È un autentico e
multiforme ipertesto che rinasce continuamente,
diverso eppure uguale in forma e spirito. Prima
si accennava a Funky Drummer di James Brown,
break ritmico per eccellenza che torna in Ottanta
e Novanta, alla base dei Public Enemy di Fight
The Power e di acid e ’ardkore. Come un virus
vivente decurtato di ogni legame di sangue, ci
porta fino al ponte dove gli Animal Collective
e Zomby s’incontrano e si scambiano i complimenti. In quel bit e in quei beat reiterati ci sono
elettronica e collagismo, mutazioni genetiche e
anomia (“ma anche” anemia). Tutte caratteristiche dalle quali partono entrambi e alle quali
entrambi ritornano in un rito che ha tutto del pre,
più che post adolescenziale. Ma non è tutto qui.
Il presente è anche Harmonic 313, incarnazione
del noto ex ambientale Mark Pritchard. Altri
sono il legami che legano ciò che oggi è cool alla
broda primi Novanta. Curioso, se non addirittura
sublime, il ritorno a casa Warp di sonorità b-boy
Drop Out /
35
che in un sol colpo coronano i
tre decenni di anniversario
e ricongiungono gli ’80
ai ‘90. In When Machines
Exceed
Human Intelligence tornano
i calcolatori di
Forgemasters
e LFO - quindi Detroit e
Krafwerk in
un sol colpo
- e quell’atteg giamento
da cultura del
ghetto, mutante
e mutata come le
deviazioni estreme
di casa Anticon. In
altre parole, sono Break
beat e tastiere analogiche,
l’altra faccia del ritmo looppato
e programmato delle scuole intelligenti.
Drum machine Roland o Korg e le beat box.
Sempre su WARP, il nuovo e.p. di Squarepusher altro non è che il secondo
omaggio dichiarato all’ardkore,
meno ovvio di Zomby per via
di quel tipico taglio intelligent, ma altrettanto evidente. Breakbeat e origini dunque anche per lui
e, sempre a proposito
di nuove uscite della
casa, ecco un Hudson
Mohawke a ripescare
vocine in elio, battuta
sincopata e un bel cappuccino Anticon. C’è
proprio voglia di soffiare all’etichetta non solo
le caratteristiche che l’han36
/ Drop Out
no resa famosa, ma addirittura reinnestarle nei
circuiti che una volta conversavano direttamente
con l’hip hop. Adorabile Hudson quando (probabilmente) campiona o rifà l’attacco di Stings Of
Life di Derrick May in Speed Stick ed emblematico
lo svolgimento del brano con la comparsa di vocine di bambini dallo spazio come un Aphex o
dei Boards Of Canada. Come dire: le tradizioni
e le contaminazioni da manuale. Di fatto, per il
nuovo nodo del continuum è ancora presto ma
chissà, con la vita spericolata e iperaccelerato di
oggi. Per la riscoperta dei basamenti del ritmo
Novanta troviamo della Drum’n’Bass che torna
praticamente com’era. Prima un Roni Size che
rifà se stesso (New Forms 2, Mercury 2008) e
poi una manciata di echi dei lussi e della velocità del suono morse hardcore (Prodigy e 4 Hero
fino a Goldie). Redivivo quel classico rullante in
Commix (Fabriclive 44) e nell’album di Utah Jazz
It’s A Jazz Thing, dove brillano pure i campioni vocali in stile A Guy Called Gerald (altra
bella ristampa di qualche tempo fa Black Secret
Technology, A Guy Called Gerald Music, 2008).
Non possiamo nemmeno tralasciare quell’humus
di cui Zomby
fa parte,
il Dubstep
fi-
glio dei precedenti e che, tecnicamente, non è
mera isola ma snodo del continuum, provetta in
sottrazione di battute e basso ‘ardkore. Che questo stile ritorni in pasto alla Techno detroitiana
non sorprende, anzi concilia. Oltre atlantico la
Techno ritrova il basso tosto e a Nord d’albione,
dice Reynlods, le produzioni house tagliate sempre più funky stanno aumentando. Funky drummer is back and proud.
W arp A t W erk
Nel calderone delle re immersioni focus quasi ovvio per l’intorno di Mr. Zomby ovvero l’etichetta
Werk che assomiglia tanto (ma tanto) alla Warp
all’inizio. Ancora giovane l’etichetta piace proprio per questo incrocio dei pali che la Warp stessa attraverso i suoi nuovi acquisti non vuole farsi
scappare. Zomby, Actress e Lukid fanno tesoro
di lasciti hip e hop, ambient house (a proposito ricordiamoci che Mark Pritchard era con Middleton nei Global Underground), idm, e ovviamente
break beat. Il mix ha il taglio mentale Warp come
le influenze electro che virano verso il dubstep
sono roba della Muziq. Ma parliamo di quel piccolo gioiello che è Hazyville di Actress Roba che
urta dietro la quale c’è Darren J. Cunningham,
mezzo capoccia della label assieme all’amico DJ
Gavin Weale, uno a cui piace l’automazione
del groove in stile ambient house primi novanta:
cassa ovattata e snare d’antan. Quella di Hayville
è IDM che punta direttamente a certa house in
bassa battuta ma che - badate bene - non è sci-fi.
Lui fa il sub nei mari del groove e, furbescamente,
giostra di cesello gli ingredienti. La dose giusta al
momento giusto che in Crushed ricorda da vicinissimo gli Antares dell’indimenticata Omniverse.
Parlando di ambient, nel quartiere centrale della
Werk bazzica Lukid a.k.a. Luke Blair con il suo
Foma. Una chicca per teste cresciute a pane e Boards Of Canada il suo secondo album che dopo
Onandon è una faccenda che sa di jazz, elettronica e funk con spalmate d’unguenti Prefuse 73,
Dabrye e Flying Lotus. Nel titolo non sfugge,
ai più attenti, il riferimento al postmodernismo di
Kurt Vonnegut e Foma è sinonimo di bugia, nondimeno il il ragazzo di fandonie non ne smercia.
Anzi: i suoni prendono forma dall’estetica Werk e
impastano tutto con una spolverata delle recenti
visioni Animal Collective.
O utro
Così, sul calar degli anni zero, tante cose ritornano a poppa. I classici cicli e ricicli portano a
galla connessioni urgenti come quelle tra house/
techno e hip hop/electro. E proprio come a inizio Duemila assistevamo a un’ondata di ventenni
in riarmo post-punk, ora la fiamma brilla per ciò
che diede origine all’ardkore e al suo continuum.
Non di meno, alcuni segnali arrivano pure dagli
ambienti più propriamente hip hop, anch’essi in
ricarica old skool (vedi Cool Kids ma anche per
certi versi i Kill The Vultures con la loro typewriter beat box e campioni d’antan). Saranno le lezioni di Grandmaster flash e Steinky di nuovo in
ristampa e riflettori a far da echo. Saranno i soliti
miraggi di noi scribacchini ma, fateci caso, sono
proprio i momenti più autenticamente punk e le
loro scosse di assestamento che fanno e rifanno
scoccare scintille. Detonazioni a distanza generazionali. Il presente dunque, anche quello ipertestuale d’oggi, è come allora, inconoscibile e servono perciò distanze e mitologie per reinventarlo
e ricrearlo ogni volta. Certi momenti sono più
coraggiosi di altri. è vero. Questo è un momento
ancora di riesame del Novecento.
Drop Out /
37
►►►►recensioni ►► ►► marzo
The Radio, che in effetti se la cavano bene senza
però evitare un senso di effettistica posticcia, certo comprensibile vista l’irraggiungibilità dell’originale.
Alla fine quei cazzoni dei (delle?) Scissor Sisters
piazzano una Do The Strand che svapora e sculetta nell’allucinazione dancefloor che è un piacere, mentre occorre rendere merito alla graziosa
Lily Allen di una caruccia Straight To Hell (non
a caso la aiuta quel marpione di Mick Jones...).
Quanto al resto, ordinaria amministrazione live
per dei sudati Franz Ferdinand, ordinarie palpitazioni per Elbow, e poi tanto mestiere per Estelle, Peaches, Yeah Yeah Yeahs... Ok, vale la pena
rinunciare ad una pizza e fare questa cosa buona
e giusta.(6.8/10)
Stefano Solventi
hexlove
AA. VV. - Dark Was The Night (4AD, Feb
2009)
G enere : R ed H ot compil ation
Æthenor
A C Newman - Get Guilty (Matador,
Mar 2009)
G enere : power pop , indie
Nel secondo album solista di A.C.Newman, alias
Carl Newman dei New Pornographers, si
precisa ancora meglio la sua cifraautoriale, fatta di sincera passione per il power pop e per i
Beach Boys o permeglio dire il nume tutelare
BrianWilson. Con tutte le derive del caso, che
abbiamo imparato a conoscere viavia dal gruppo
madre, ossia una non secondaria propensione per
lo psych rock eper una folk-wave agitata da pulsioni, insieme al consueto gusto per lacitazione
sparsa musical-letteraria. Ecco che Get Guilty
appare come un melting pot che potrebbe essere
stato partorito qualche anno fa dalla prolificità di
unElvis Costello o di un Todd Rundgren beatlesiani più del solito (si vedano l’iniziale There
AreMaybe Ten Or Twelve e la finale AllOf My
Days and All Of My Days Off), mentre altrove
38
/ recensioni
fanno capolino omaggi più che dichiarati ai Felt
nell’assolo di chitarra (Element), citazioni glam
rock e soul a volontà, con una facilità compositiva
e una leggerezza non molto dissimile d’altronde
dagli ultimissimi pornografi. Newman conferma
così la sua statura autoriale con un album che
scorre via leggero ma sedimenta, lasciando il segno.(7.3/10)
Teresa Greco
AA. VV. - Warchild - Heroes (EMI, Mar
2009)
G enere : pop rock
Terza profusione di cover per la War Child, che
casomai non lo sapeste è una ong dedita al sostegno dei bambini vittime dei catastrofici e demenziali conflitti in Medio Oriente e Africa. Non
ci dilunghiamo certo sull’importanza di tale iniziativa, che travalica un milione di volte le mere
questioni musicali di cui siamo soliti occuparci,
ma appunto di cosucce soniche ci occupiamo e
quindi non ci resta che guardare a queste quindici rivisitazioni con l’umile curiosità che si conviene al recensore/ascoltatore.
Complessivamente è un ascolto agile, un modo
come un altro di verificare lo stato delle cose tra
concezione pop contemporanea e i fasti di un passato che qui riluce in titoli presi in prestito a Roxy
Music e Stooges, Costello e Springsteen, Dylan e
Joy Division, Bowie, Stevie Wonder, Beach Boys
e via discorrendo. Ti aggredisce Beck - a occhio
e croce il padrino della congrega - con una Leopard-Skin Pill-Box Hat che ruggisce glam rugginoso, cui fa eco più avanti un Rufus Wainwright
perfettamente a suo agio coi setosi languori da
camera e i singulti fiabeschi di Wonderful/ Song
For Children, le due tracce più disinvolte assieme
forse a una Transmission resa amniotica e pulsante assieme dai londinesi Hot Chip. Ovviamente
la traccia che più mi incuriosiva era la bowiana
title track, presa in cura dagli splendidi Tv On
La Red Hot Organization riesce sempre a unire l’utile al dilettevole, dignitosamente. Per il suo
ventesimo anno di attività nella raccolta di fondi
per la lotta contro l’AIDS, l’associazione di beneficienza internazionale pubblica con l’aiuto
della 4AD la sua ventesima compilation. E lo fa
affidandone la cura e la produzione ad Aaron e
Bryce Dessner dei The National.
Il risultato è Dark Was The Night, ovvero 32
canzoni disponibili su doppio cd, triplo vinile o
semplicemente in download. Ma oltre lo scopo
umanitario dell’iniziativa, qui da lodare c’è anche l’ottimo livello qualitativo musicale, non fosse
solo che a partecipare sono tutti i nomi migliori
che il panorama indie, quello più introspettivo,
potesse offrire. Questi alcuni protagonisti che tra
cover (Nick Drake, Nina Simone e Bob Dylan),
inediti, rivisitazioni e veri e propri duetti artistici
onorano la causa: Andrew Bird, Dirty Projectrors
& David Byrne, The National, Bon Iver, The Books & José Gonzales, Feist & Ben Gibbard, The
National, Yeasayer, Iron & Wine, Antony, The
recensioni /
39
Highlight
Actress è Darren J. Cunningham, mezzo patron della
Werk. Hazyville riprende i suoni subacquei e ovattati
della house più cool targata 90. Dopo il No Tricks EP
del 2004 il ragazzo ci spara tre quarti d’ora velocissimi
e caldi, cose che hanno il groove nella testa; quei break
che a molti ricorderanno i sorrisi balearici e le atmosfere soulful delle estati con il 9 davanti. Come bibliografia melodica ci sono i Boards Of Canada, mentre
come sezione ritmica si pompano le low frequencies
che è un piacere, perché la tendenza è questa. Ieri l’altro con gli anticipi del dubstep
di classe, oggi si spara in orbita sua maestà the bass. Qui ovviamente non si calca
troppo la mano sul drill energizzato, anzi, si crea un acquario da esplorare trattenendo il respiro. In questo downtiming subacqueo viene in mente pure la lezione della
Ninja Tune con il campione Funky Porcini: una di quelle uscite che potete benissimo
continuare a lasciare andare sul lettore e che non vi stancheranno. Piccoli maestri crescono. Forse il testimone è definitivamente passato di mano. La house ritrova le sue
origini break (l’hi-hat in controtempo del singolone Crushed) e le ripensa mescolate
deep-bass. Prevedere dove sarebbe andata l’ambient era dura. Qui abbiamo il vaticinio corretto. Brekbit all night long.(7.5/10)
come ben sapete. Il programma dunque si profila
come una sorta di anti-festival, opposto, incompatibile e tutt’altro che complementare a quello
dei fiori proprio perché figlio di una situazione
“reale”, da cui il rock zampilla come una finzione/reazione simbiotica. Quindi, secondo l’estro
del caso, travolgente (Zu, il Teatro Degli Orrori) e dissacrante (Zen Circus), onirico (A Toys
Orchestra) e convulso (Settlefish, Beatrice
Antolini), amaro (Cesare Basile) e dolciastro
(Disco Drive), trepido (Paolo Benvegnù, Roberto Angelini) e appassionatamente disincantato (Dente, Mariposa). Eccetera eccetera. Quasi dimenticavo i padroni di casa: più che una
canzone, quella di Agnelli e soci sembra un manifesto necessario, una ballad più foga e sostanza
che bellezza, pretestuoso anello di congiunzione
tra dimensioni così lontane così vicine, con quel
“e tu vuoi far qualcosa che serva” che chiosa il
tutto come meglio non si potrebbe. Quasi dimenticavo 2: molto bella anche l’immagine di copertina. Chapeau all’iniziativa e - massì - alla musica.(7.3/10)
Marco Braggion
Stefano Solventi
Actress - Hazyville (Werk Discs, Nov 2008)
G enere : N arcotic B reakbeat H ouse
Decemberists, Grizzly Bear, Sufjan Stevens, Arcade Fire, Spoon, Beirut, Yo La Tengo, Cat Power,
Conor Oberst, Blonde Redhead, Kevin Drew,
The New Pornographers, Buck 65, My Brightest
Diamond, ecc. Insomma, la “notte sarà stata pur
buia”, ma la Red Hot ha saputo bene come scaldarla con 32 bagliori se non salvifici, almeno consolatori(7.5/10)
Andrea Provinciali
AA. VV. - Afterhours presentano:
Il paese è reale (Casasonica, Feb
2009)
G enere : rock italiano
Hai capito gli Afterhours. Vanno a beccarsi un
40
/ recensioni
bel po’ di promozione a Sanremo aizzando gli
strali di detrattori della prima e ultima ora, salvo
poi reinvestire il tesoretto mediatico in una operazione di tutto rispetto, prestandosi cioè a fare
da portabandiera e specchietto per le allodole di
questa compilation che passa in rassegna 19 campioni (non nel senso sanremese) del rock italiano cosiddetto alternativo. Intendiamoci, nessuna
sorpresa, tutti nomi ben noti ai lettori di S&A,
però è bello pensare che qualcuno - sia pure uno,
porco cane - si ritroverà a farci i conti per la prima volta, scoprendo qualcosa di più sostanzioso
della insulsaggine festivaliera e radiofonica in genere. Per poi magari scoprirsi dentro vibrazioni
di un’altra categoria. Roba che dà dipendenza,
AA. VV. - A Psychedelic Guide To Monsterism Island (Lo Records, Mar
2009)
G enere : incredible strange music
Musica da cocktail dell’altro mondo. No, mettiamola meglio. Relax esclusivo negli hangar del
dopo bomba, con posticci ricordi dell’ultima vacanza exotica. Le scorte scarseggiano, berremo
un acqua colorara alla bell e meglio Un tempo la
chiamavano incredible strange music, non ci sono
però gli abiti del ‘sultano’ Korla Pandit, nemmeno
le pose di un Arthur Lyman o di un Lex Baxter.
C’è però una label britannica, da sempre celere
nel cavalcare l’onda del retro-nuevo, grazie alla
sua personale scuderia e ad una serie di raccolte
a tema coraggiosamente assemblate. La psichedelia è qui argomento molto soffuso, quasi uno
strumento a disposizione di biologi predestinati,
che forse prestano più attenzione all’elettronica
dei primordi, al jazz dei 40/50 o ad un’idea di
cinema per le orecchie dello scorso secolo.
Jonny Trunk da astuto collezionista e direttore
artistico che è – la sua Trunk una delle migliori
etichette specializzate in ristampe weird (su tutti i
nomi di Basil Kirchin ed il disco gospel fantasma
di Herbie Hancock) – prenota un posto al sole
con l’ancestrale rare groove di Nest We Forget,
mentre il trasformista Luke Vibert rigenera vecchi synth nella peculiare ricostruzione di vecchi
movimenti folk d’antan, un vero e proprio caso
di musica per ectoplasmi. Poi alcuni dei protagonisti assoluti del catalogo Ghost Box – il marchio tanto incensato da Simon Reynolds - come
gli alieni Belbury Poly – per assurdo la loro Designated Wizard Practice Area sembra un brano
dei Residents precipitati in zona easy listening – e
gli esoterici The Advisory Circle, la cui Lair Of
Grolfax viaggia tra onde di theremin, drum machine e moog d’epoca. Sono musiche fantastiche,
esteticamente legate alle più nobili avanguardie
ma contenutisticamente vicine ad un pop ultraterreno, addirittura impalpabile. Musica di domani suonata ieri e viceversa.(7/10)
Luca Collepiccolo
AA. VV. - XXperiments (Die Stasi, Mar
2009)
G enere : crimson wave
Una compilation ben riuscita è sempre una cosa
positiva, tanto più che decisamente rara; se poi
l’uscita può vantare meriti ulteriori, allora si carica
di significati interessanti per il quali è bene che le
si renda merito. È questo il caso di XXperiments
i cui pregi di cui sopra sono, in primis, di uscire su
die Stasi, un’etichetta che ha avuto il merito di far
debuttare acts come Zola Jesus e Wrists (il progetto synth-punk dei Wax Museums); in secondo
luogo di essere una compilation su vinile, cosa
piuttosto insolita oggi giorno. Infine, cosa più importante, di essere più che una mera raccolta di
canzoni; trattasi infatti di un vero e proprio marecensioni /
41
nifesto musicale che rappresenta le linee guida ed
i dettami estetici di quella neonata sottoscena di
band e progetti individuali, tutti al femminile, che
ha recentemente preso il nome di crimson-wave
(termine che in gergo indica il ciclo mestruale –
giusto per schierarsi ulteriormente), là fuori, da
qualche parte nel Mid-West sperduto degli Stati
Uniti. E questi caratteri che accomunano i nomi
presenti sulla compilation (alcuni già noti ai più
attenti, altri al debutto) sono quanto di più ostico
e spiazzante ci possa aspettare da un manipolo
di signorine: che sia il blues ultra primitivo delle
Cro Magnon, la narcolessia elettronica di Luxury
Prevention e Buckets Of Bile o le claudicazioni
di Bird e U.S. Girls, l’inquietante sensazione di
stare ascoltando la soundtrack di un film di fantasmi è assicurata. Talvolta i toni si inaspriscono e
talvolta invece si fanno più epici e potenti, come
nel pezzo di Zola Jesus che chiude brillantemente il disco con una prova degna dell’interesse che
questa ragazza ha recentemente suscitato intorno
a sé. In tutti questi casi, però, vale il monito, che,
tanto per essere ineccepibili, la dieStasi ha fatto
incidere sulla parte interna, non stampata del vinile: “Beware of the crimson-wave”.(7/10)
Andrea Napoli
Ada-Nuki - S/t (Whosbrain records,
Apr 2008)
G enere : P unk N oise R ock
Abbiamo avuto già modo di parlare di una sorta
di new wave del post rock tarantino in occasione
di alcune uscite della Psychotica Records, caratterizzate da un piglio decisamente punk-noise.
Dall’esperienza
psychotica proviene il batterista Giorgio Maniglia, che assieme al bassista Stefano Spataro (ex
Anonima Folk), ha deciso di mettere su un duo,
circa un annetto fa, che è finalmente arrivato al
suo esordio grazie alla francese Whosbrain Records. Aggirato il pericolo di cadere negli schematismi abusati di certo math rock (che ultimamente
sembra l’unico punto di riferimento di chi si ispi42
/ recensioni
ra dichiaratamente al post-rock) i due musicisti
tarantini, aiutati, in alcuni casi dalla chitarra di
Michele Maglio e arricchiti dai field recordings di
Donato Epiro, hanno elaborato uno stile progressivo orientato verso una libertà espressiva che,
più che ai June Of ’44 guarda ai migliori Sonic
Youth e a certo hardcore punk. Il mix di sussurri
e urla media fra la band di Thurston Moore & co.
e le violente scudisciate vocali di Ray Cappo degli
Youth Of Today. Il suono compresso di basso e
chitarra e una batteria a dir poco furiosa costituiscono la base del
sound della band,
che non mantiene
mai la stessa tensione, dileguandosi in
episodi al limite della musica concreta
(Hotel Clodio), in
uno
psych-noise
estremamente minimale (Lo Gnomo) o esplodendo in schizofrenici
momenti free (Plastic French Mozarela) e post-core (Sakara Bondage; Polistirolo). Perché non abbiano trovato spazio su un’etichetta italiana viene
spontaneo chiederselo. Ma al di là delle provenienze, un disco che finalmente riesce, al tempo
stesso, a portare la musica nostrana oltre gli scimmiottamenti del math rock a stelle e strisce e a riscoprire gli estremismi dell’hardcore straightedge
dal punto di vista del progressive. Una piacevole
contraddizione. (7.2/10)
vsga; per chi non li conoscesse, il moniker sotto
il quale si nascondono calibri del peso di Nathan
Young e Brad Rose. Quest’ultimo dimentica per
un momento – per modo di dire vista la sterminata discografia a nome Ajilvsga – le bucoliche
lande solitamente toccate con The North Sea e si
abbandona ad un
grumoso mostro
droning dall’appeal ritualisticoblack metal e dalla
resa funesta e spietata. Boschi infestati, maschere e
cappucci, teschi e
magia nera, l’iconografia black d’ordinanza tutta riemergono in
questo Medicine Bull tra i flutti disperati di drones sapientemente prodotti da Pete Swanson. E se
nel finale, negli struggenti 10 minuti di Leviathan
Vanquished si provvede ad un barlume di luce
seppur sepolto sotto una cappa di malinconia,
nell’incipit del disco – i 21 mortali minuti di Big
Black Meteoric Star – non c’è altro che devastazione, implosioni, nichilismo. Per chi scrive, uno
dei migliori momenti della discografia a nome
Ajilvsga. (7/10)
Daniele Follero
Nella vostra fantasia più recondita è mai girata
l’idea di un progetto che travasasse l’esistenzialismoindie di Casiotone For The Painfully Alone nei
beat dei Daft Punk era Discovery? Nella mia sì,
francamente. Alaska In Winter è il singolaremoniker di Brandon Bethancourt, americano dai tratti
euronordici - a vederlo sembra il fratellino acquisito dei Royksopp - al secondo parto in proprio.
La formula non è nulla di trascendentale, poiché
trattasi di synth-pop da balera alternativa (ma
anche per intimismo da cameretta) accostato alla
Ajilvsga - Medicine Bull (Dreamsheep, Gen 2009)
G enere : drone
L’occhio/orecchio lungo di Valerio Cosi si dimostra eccellente anche quando non si tratta di
comporre musiche o scegliere collaborazioni e/o
etichette, quanto di mettere su un proprio angolo
di paradiso sotto forma di label. Una delle prime
uscite della Dreamsheep è Medicine Bull di Ajil-
Stefano Pifferi
Alaska In Winter - Holiday (Regularbeat Recording, Mar 2009)
G enere : synth pop
voce, maschile e femminile, filtrata al vocoder.
Un trionfo della banalitàinsomma, eppure
Bethancourt riesce a regalare momenti che, nel
mentre del lorosvolgersi, vi sembreranno preziosi. D’altronde, la peculiarità delsynth-pop più
kitsch (e qui ce n’è) risiede nell’appiccicarsi sulla
pelle il tempo necessario che il collante termini il
proprio corso.
Un episodio come Berlin (probabile omaggio alla
nuova residenza del Nostro) non si sbaglia a definirlo emo-disco: 4/4 di getto house,voce di lui
alla stregua di Owen Ashworth e contrappunto
femminile vertiginoso.Vi verrà da ballare anche
se debilitati.
Dopo l’esistenzialismo disco di cui sopra, il baricentro di Holiday ripiega nelle sue intenzioni naif (Highlander Pt. 1 e 2) e smaccatamente anni ‘80 (StreetgangPt. 3 e Close Your Eyes
Remix,quest’ultima impreziosita dalla voce di
Zack Condon dei Beirut ), concedendosi spaccati
folk (We Are Blind And Riding the Merry-GoRound sempre con Condon mastavolta all’ukelele)) e melanconici electro-slow da lacrimuccia
(Streetgang pt. 1). Finché il collante durerà, ripetiamo, non ne potrete fare a meno. (7/10)
Gianni Avella
Appleseed Cast (The) - Sagarmatha
(Vagrant, Feb 2009)
G enere : post - rock
Il sesto album degli Appleseed Cast conferma la
deriva post-rock intrapresa dalla band dopo quei
primi dischi per la Deep Elm che la fecero eleggere
come una delle migliori e autentiche realtà emocore a cavallo tra fine Novanta e inizio Duemila.
Quella componente emozionale però non è mai
svanita del tutto: la maturità artistica, raggiunta
già con il terzo lavoro in studio doppio Low Level Owl, l’ha sì attenuata ma mai negata, anzi. In
Sagarmatha essa emerge contratta ma efficace fin
dalla prima traccia, As The Little Things Go: oltre
otto minuti di dilatazioni sonore con tanto di saturazioni mogwaiane inframezzate però da “sentirecensioni /
43
Highlight
Æthenor - Faking Gold & Murder (VHF, Feb 2009)
G enere : avant
Il terzo disco degli Aethenor nasce sotto il segno della
suggestione alchemica già a partire dal titolo e se il tutto
viene vergato a mano e dichiarato a voce dalla luciferina presenza di Anok Pe David Tibet l’assonanza con
i primi Current 93 viene iocoforza spontanea. A maggior ragione ascoltando questi quattro nuovi brani.
Già il precedente, Betimes Black Cloudmasses,
con l’innesto dei percussionisti Alexandre Babel e Nicolas Field aveva spostato il suono dei tre in una direzione ancora più improvvisata e libertaria, ma il quadro si completa per forza di cose giunti a questo terzo disco dove la formazione viene
ulteriormente completata con l’ingresso di Alexander Tucker alle chitarre.Stephen
O’Malley, Daniel O’Sullivan e Vincent De Roguin diventano quindi i tre sacerdoti di
un cerimoniale free decisamente virato al nero, dove in qualche modo si riesce a trovare il punto di equilibrio tra avant metal e musica di ricerca, in un modo che davvero
non si era mai ascoltato a questi livelli di efficacia. L’attacco deflagrante e senza freni
delle percussioni introduce al disco come un fulmine a ciel sereno, inscenando un
caos meditato in ogni più piccolo particolare. Il paragone con i primi Current 93,
ma anche con certi Nurse With Wound, si accentua ancora di più con i liquidi onirismi del secondo brano dove tra organi e drones il senso di minaccia si fa incombente
ma non opprimente. Si prosegue poi nella maniera più sperimentale possibile: una
serie si shuffle di batteria con un recitato minaccioso e acidissimo che divulga qualche
verità che non avremmo mai dovuto ascoltare. A voler rimarcare un ulteriore segno
di pregio del disco si segnala un ritrovato David Tibet molto meno declamatorio e
didascalico nelle sue performance vocali e più prossimo alla musicalità di un vocalist
degno di questo nome. La quarta traccia chiude quasi sottotraccia, dimessamente,
con un sentore d’apocalisse sottopelle e una serie di drones scorrevoli e ficcanti pronti
per chiudere un concerto suonato evidentemente all’inferno.(7.5/10)
Antonello Comunale
Arboretum - Song Of The Pearl (Thrill
Jockey, Mar 2009)
G enere : H ard B lues
Corey Allender, Daniel Franz (anche nei Beach
House sporadicamente), David Heumann e Steve
Strohmeier hanno toccato quota 3. Terzo album
per iragazzi di Baltimore e primo a vedere la stessa identica line-up per ogni songin scaletta. Registrato presso il Lord Baltimore Recordings da
Rob Girardi, insoli due mesi l’autunno dell’anno
appena trascorso, Song Of The Pearl mostrauna saturazione del suono che fa piacere a chi ama
gli ultimi Pontiak. Qui peròla psichedelia, come
di costume per gli Arbouretum, divaga verso derive pesantie lisergiche Anni ‘60, senza farsi compromettere dall’hard della decadesuccessiva.
False Spring, per esempio, è d’un bell’acido, Mad
River style, mentre Dave Heumann e Steve Strohmeier trovano l’alchimia chitarristicaperfetta in
Another Hiding Day, insostanza un bel numero
folk elevato pian piano, ingravidato il numero dei
giricon polifonie vocali di contorno, fino a sfinirsi
nell’epos duellante più puro. Una Last Trip To
Tulsa addolcita dagli America e incrociata con i
Rainbow. David Heumann, nonostante l’aiutosporadico di Rob Wilson, rimane sempre il compositore principale della band,l’asse sonoro della
quale si perpetua, nella sostanza, ricalcando melodie folky cristalline e profonde (Song Of The
Pearl) degne della Laurel Canyon Scene’ che fu
(Susan Carter, Neil Young o Judee Sill). Eccezioni alla regola, hard blues ‘esistenziali’ quali Thin
Dominion o l’heavy metal thunder che fulmina
Infinite Corridors.(7/10)
Massimo Padalino
mentali” break ora chitarristici ora vocali. Proprio
questi saliscendi emo, dai quali paradossalmente
si erano evoluti, rappresentano il valore aggiunto
dell’album. Ma non tutti gli episodi riescono a far
emergere così bene questa peculiarità, rischiando
così di convogliare il loro post rock su binari più
44
/ recensioni
anonimi e monotoni, tra Mogwai ed Explosion
In The Sky. Gli Appleseed Cast dovrebbero equilibrare maggiormente testa e cuore: impresa titanica, ma ci stanno lavorando e sono sulla buona
strada. Il tempo ci dirà. (6.5/10)
Andrea Provinciali
ATOM™ - Liedgut (Raster Noton DE,
Gen 2009)
G enere : elettronica minimale
Erede del post romanticismo estetico alla Kraftwerk, Liedgut è il nuovo lavoro di Uwe Schmidt
(meglio conosciuto con lo pseudonimo ATOMTM) in uscita per Raster Norton.
Le attitudini elettroniche dell’artista austro-tedesco si manifestano sin dal 1994, anno in cui fonda l’etichetta Rather Interesting. Subito dopo il
suo trasferimento in Cile che influenzò molto le
scritture future (2000-2001 El Baile Aleman).Un
approccio alla materia assolutamente di dettaglio
a cui si aggiungono scelte trasversali, tra riduzionismo digitale, genialità elettrificate e l’insegnamento delle avanguardie della musica cosiddetta
“dotta” dei maggiori compositori del novecento.
In bilico tra razionale e irrazionale, la poetica artificiale di Schmidt si lascia cogliere tra i drones,
le glissate ritmiche di “Wellen und Felder 4”, le
familiari interferenze telefoniche (Im Rausch der
Gegenwart 1) o gli automi in vocoder di “Wellen
und Felder 2” a cui presta la voce Florian Schneider (Kraftwerk).Ci si ritrova così immersi in
luoghi del tutto instabili a metà strada tra elettronica, techno e bossanova; anche i confini che
delimitano l’analogico e il digitale sembrano sfocarsi e finiscono spesso per coincidere in blocchi
ritmici o rallentati.
Ispirato e sicuramente pieno di contrasto ma
anche d’identità Liedgut apre nuovi dibattiti tra
passato e presente, senza far a meno delle vecchie
buone maniere ma, allo stesso tempo dettandone
delle nuove.(7/10)
Sara Bracco
Baikonour - Your Ear Knows Future
(Melodic UK, Mar 2009)
G enere : new prog
Dal punto di vista umano, Jean-Emmanuel Krieger in arte Baikonour è solo da elogiare, poiché,
da abituale frequentatore del sud asiatico, ha lavorato per la raccolta di fondi per i rifugiati tibetani istituendo, inoltre, un associazione per la
salvaguardia del Nepal. Ma musicalmente, purtroppo, il francese di Marsiglia rasenta (a voler
essere buoni) la mediocrità. Your Ear Knows Future è un pastrocchio dalle intenzioni prog-kraut
- tra le influenze citate, Amon Duul 2 (ma dove?!
Forse quelli stanchi di fine ’70?!), Popol Vuh (querecensioni /
45
sta poi…) e Magma (evviva il campanilismo! Magari ci fossero..) – che sfocia nelle peggio pagine
di Alan Parsons e Mike Oldfield. Gli unici momenti rilevanti sono alcuni passaggi di Fly Tiger
e Summer Grass/Winter Worm e l’omaggio ai
Neu! di Ye Ama Piooo!; il resto è tanta volontà
e poca anima. Ha un gran cuore, Jean-Emmanuel. Che lo sfrutti per beneficenza.(5/10)
Gianni Avella
Bishop Allen - Grrr... (Dead Oceans,
Mar 2009)
G enere : I ndie pop
Per questa nuova uscita i nostri non pescano dal
ricco serbatoio degli EP: le 13 canzoni del disco
sono infatti tutte nuove, a dimostrazione che il
blocco della scrittura di qualche anno fa è definitivamente superato, e che la loro musa è in ottima salute, vista la freschezza con cui scorre la
scaletta.
Lontane sia da certe pur piacevoli svenevolezze
del precedente che dal lo-fi
degli inizi, le
composizioni di
Grrr.... sono
preparate con
gli ingredienti
soliti del genere: melodie trascinanti, arrangiamenti semplici ma con ogni dettaglio al posto
giusto e un velo di ironia che stempera l’enfasi e
addolcisce quel filo di rabbia in più rispetto al passato che caratterizza il disco (un’ironia che a noi
non dispiace affatto, ma che ha innervosito qualche recensore, convinto evidentemente che scherzare sulle cose significa non prenderle sul serio).
Muovendosi su una linea che tocca Magnetic
Fields, Hidden Cameras e la vera musa nascosta di certo indie pop, quel Jonathan Richman maestro del drammatizzare ammiccando,
i Bishop Allen mettono insieme un disco ottimo
46
/ recensioni
per spiegare ai vostri amici che “rock indipendente” non significa necessariamente fragore e
dissonanza, e che ci si può divertire con la taranta di True or False, il rock dell’iniziale Dimmer,
lo stomp di Rooftop Brawl i Belle and Sebastian di Shangaied e la “saggezza” di The Ancient Common Sense of Things. Ma è tutto il disco che funziona, tra un “whoo-whoo” inatteso e
perfetto e intelligenti punzecchiate di chitarra nel
corpo delle melodie. Una piacevole conferma,
specie nel mese in cui un gruppo che chiamò Pop
un suo disco conferma invece di aver perso quella
verve che qui invece abbonda.(7.1/10)
Giulio Pasquali
Black Lips - 200 Million Thousand
(Vice Records, Mar 2009)
G enere : G arage sixties
I Lips son passati attraverso la morte di Ben Eberbaugh, due lp per la Bomp!, uno per la In The
Red, sino agli ultimi due per la Vice Recordings.
200 Million Thousand non cambia etichetta e
continua sulla linea di quel flower punk che ammazzerebbe d’infarto Seeds, Troggs e Swamp
Rats se solo ascoltassero oggi questi cattivi ragazzi di Atlanta. Hanno registrato ben 25 canzoni
per il nuovo disco. 15 ci finiscono a tutti gli effetti
dentro e incupiscono il discorso lasciato in sospeso dai precedenti due in studio (niente numeri da
junkie-”Porky’s” qui, come “Bad Kids”, però).
Take My Heart suona come se Seeds e Fireworks
avessero deciso di coverizzare, mischiandosi negli
effettivi, l’intero Raw Power degli Stooges. Drugs
è un surf deviato che i Cheater Slicks avrebbero
potuto rubare ai New York Dolls, se mai uno ne
avessero scritto. Questo il versante rude. Poi c’è
anche il tempo di tirare il fiato, con i Byrds strafatti di Starting Over o la Butterfield Blues Band
con Iggy Pop alla voce di Trapped In A Basement. Il suono è profondo, le chitarre sventrano
la luce, l’ugola di Cole Alexander sputa fuori la
propria gioventù bruciata dalla fogna dei Sixties
perfida e ammaliatrice. E così si susseguono i
Turtlescimiteriali di I’ll Be With You, il capolavoro del disco Big Black Baby Jesus Of Today
(degli Shadows Of Knight necro-blues) o quella
tirata beat-psichedelica che è Again & Again, una
Chocolate Watchband che imbocchi la strada del
Sunset Strip macchiandosi di sangue e dolore.
(7/10)
Massimo Padalino
Broken Spindles - Kiss/Kick (Blank.
Wav, Feb 2009)
G enere : new wave / electro - indie rock
Quella di Joel Petersen, bassista dei Faint, e del
suo progetto solista Broken Spindles è una storia
particolare. Nato fra un tour e l’altro con la band
madre principalmente come progetto multimediale, combinava all’inizio elementi trash ’80 con
una netta propensione al cazzeggio figlio di certa
laptop-generation.
Diventato poi collage di bozze maximal electro e
minimal ambient
con Fulfilled/
Complete, evolutosi in una ricerca di stramba forma canzone per
piano sconsolato e movenze electro con Inside/
Absent e tornato indietro verso un isolazionismo
decadente nell’incompleto quadro ambient fin
troppo introverso di Document Number One
(per la prima volta “self released”), questo quinto
capitolo vede la “luce” per la prima volta. Luce
per la scelta di cantare finalmente senza vergogna
e per partorire 10 canzoni degne di essere chiamate tali. Tutto ciò che di precario e raffazzonato respirava nelle prove precedenti qui prende
vita totalmente, una vita che si compie mediamente sui 3 minuti. Niente di male in questo se
non fosse che la scrittura del nostro non luccica di
chissà quale memorabile splendore: sembra che
lo spirito dance – e vincente – dei Faint sia stato
estirpato quasi di netto lasciando delle costipazioni Devo, delle ritmiche Neu!, delle atmosfere
ultimi Deerhunter, ma senza il genio e la brillantezza che ivi abitano. E quindi ci troviamo a
sottolineare i momenti più carichi in cui si crea
un ponte con la band madre (il singolo schizoide
con spruzzate punk-wave Introvert, la ballad per
basso-slap e laptop Beat Down Break Up, il passo
andante di The Moist Red Mess) o momenti in
cui la personalità del nostro si focalizza e tira fuori dal cilindro numeri compiuti (la wave concisa
di Figure Face Pretty Boy, il fantasma di Bradford
Cox nella scorrevole In The Dark, gli accenni di
folktronica in We All Want To Fit In). Il resto
passa senza colpo ferire. Certamente rimarcabile
il balzo in avanti, Kiss/Kick mostra però il fianco laddove a lasciare il segno non ci sono veri assi
ma solo buone canzoni e la forza di queste non è
tale da supportare un album da ricordare. Questo non toglie che siamo davanti al miglior disco
di Joel, il che aumenta la speranza per quello che
verrà. (6.7/10)
Alessandro Grassi
Claudio Sanfilippo - Fotosensibile
(Maxine, Feb 2009)
G enere : songwriting
Tante collaborazioni illustri (canzoni per Finardi
e Mina, un premio Tenco per il suo esordio nel
‘96), 4 album e un cd libro: questa la produzione
nel corso di un decennio del cantautore milanese
Claudio Sanfilippo, un’anima raffinata di autore
colto, tra bossa nova, amore per la poesia dialettale della sua città e songwriting classico. Fotosensibile è stato realizzato con l’arrangiatore e
produttore Rinaldo Donati e acclude anche, in
un bel packaging, un DVD (Nel bere nel mare) in
cui l’autore si racconta con autoironia. In Fotosensibile si fonde la canzone d’autore con una
cifra più leggera, pop, esprimendo così le molte
facce dell’autore. Quindi ecco che bossanova,
pop, rock si coniugano ad arrangiamenti accurati, con uno stile al solito sospeso ed onirico, sua
recensioni /
47
cifra stilistica, insieme ad un senso profondo di
intimità coniugato alla poesia. De André, Piero
Ciampi, Paolo Conte, i cantautori francesi ma
anche americani e brasiliani (Jobim) vengono
spesso alla mente. Una sintesi riuscita e fascinosa.(7.2/10)
vague. Ben suonato, ben interpretato (anche se la
voce di Cristian Fanti si rivela un po’ monocorde
alla distanza), è un disco che cuoce a fuoco lento
un immaginario forse non eclatante ma solido.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Teresa Greco
Collettivo Ginsberg - Pregnancy (Il
Vaso Di Pandora, Feb 2009)
G enere : blues rock cantautoriale
Fin dalla traccia introduttiva - breve raggrinzito
estratto da un vinile di Amanda Rodriguez - si respira l’aria dei malanimi desueti, crucci old style,
roba maturata nei barrique dei turbamenti Cave e
Waits, due nomi che prima o poi andavano spesi e
quindi ben vengano Maudì e The Farm, così non
ci pensiamo più.
Il Collettivo Ginsberg è un quartetto
allargato
anzi aperto agli
apporti di un bel
manipolo di amici, che portano
in dote archi e legni, tastiere e chitarre, fisarmoniche e cori. Con Pregnancy, il loro
secondo album, mettono a fuoco un cantautorato
ombroso e turgido, letterario (come si evince dalla ragione sociale) in senso beat, ciò che li fa flirtare con l’ebbrezza freak avariata dei tardi sixties
(vedi il passo doorsiano di Woodstock Cypress e
Yama), consegnandoli altresì alle morbide palpitazioni di un Tim Buckley via Mark Lanegan (soprattutto Child Eyes, e con disarmata delicatezza
in To The Womb).
Trovo poi affascinante quando in questo immaginario americano si fanno largo chiari influssi
mediterranei, mi riferisco a quella I’m Waiting
che snocciola un testo di Ginsberg su ciondolante blues jazzato, mentre la fisarmonica e i cori
squadernano sfarfallii filmici in odor di nouvelle
48
/ recensioni
Condo Fucks - Fuckbook (Matador,
Mar 2009)
G enere : indie
Un ragazzone davvero simpatico James McNew,
solitamente bassista per Yo La Tengo ma inguaribile appassionato di musica. Con lui potete tranquillamente discorrere di Corrosion Of Conformity e Prince (a cui dedicò un album di cover in
versione lo-fi a titolo That Skinny Motherfucker
With The High Voice? per i tipi di Shrimper),
mai vi sembrerà spiazzato. Un giorno gli donai
addirittura un disco di Mad Professor, ma tant’è...
Abituato alle fughe in bassa fedeltà il nostro torna con la stessa Matador a pubblicare con i Condo Fucks, trio ‘politically correct’ proveniente dal
Connecticut. Oltre che scimmiottare il celebre social network, il titolo dell’album è anche un gioco
di parole sul Fakebook di Yo La Tengo, uno degli
album più celebri del gruppo prima della meritata esplosione mediatica. I Condo Fucks suonano
un garage pop striminzito, mai fuori misura, registrato in maniera del tutto casalinga e privo di
qualsivoglia sussulto intellettuale. Non degli integralisti per questo, invero fini ricercatori delle proprie fonti. Disco ad uso e consumo di appassionati
veri però, con 11 tracce che vanno direttamente
a scartabellare nella storia del rock’n’roll più storto. Al vetriolo una Accident degli Electric Eels, più
fangosa che surf la Shut Down dei Beach Boys,
verace la With A Girl Like You dei Troggs.
La palma della migliore re-interpretazione spetta a The Kid With The Replaceable Head, brano
che appariva in testa al secondo album di Richard Hell And The Voidods: Destiny Street.
Acerbi per diletto. Non per tutti. (6/10)
Luca Collepiccolo
Crystal Antlers - Tentacles (Touch &
Go / Quarterstick Records, Apr 2009)
G enere : prog - psych
Se ne parlava tempo addietro, all’epoca dell’omonimo ep d’esordio, di questo gruppo californiano.
Struttura classica basso (appannaggio di Johnny
Bell così come la voce), batteria rinforzata da un
percussionista, due chitarre con la new entry Errol Davis a raddoppiare quella del fondatore Andrew King, e un organo, suonato da Victor Rodriguez, che è perno centrale delle composizioni
del sestetto di Long Beach.
Le coordinate di questo Tentacles non sono dissimili da quelle dell’ep autoprodotto di cui parlavamo, il cui successo spalancò le porte di una
Touch’n’Go sempre meno etichetta di genere e
sempre più “open-minded”. Forse ancor più che
in passato è proprio l’organo di Rodriguez, nerboruto e lungocrinito mezzosangue messicano,
a segnare le coordinate del sound
iridescente
del
gruppo. Quel suono d’organo così
incredibilmente
vintage che connota giocoforza tutti
i brani di Tentacles. Così centrale
nell’economia del suono da fare il paio solo con
l’invadenza quasi fastidiosa della voce di Bell, il
cui permanere sempre sopra le righe non può
non rimandare che verso Mars Volta e progenie
progdelica tutta piuttosto che sul versante della
psych meno ortodossa e più rumorosa figlia di Altamont. Oltre questi due indizi, un terzo – la produzione “aperta” affidata a Ikey Owens, guarda
caso proprio un Mars Volta – ci fa propendere per
una sorta di suono post-MV, più corposo e sfatto,
più da dislessia-rock in disfacimento, scintillante e
colorato come un trip sul punto di andare a male,
spesso attraversato da marasmi free (i 7 minuti
della conclusiva Several Tongues) ma pur sempre
limitrofo a quello dei progsters più amati/odiati
dell’attuale panorama musicale americano.
Un limite o un vantaggio? Mai come in questo
caso vale la proverbiale regola del de gustibus.
Per noi l’ascolto alla lunga risulta un po’ stancante nel suo incedere monocorde.(6.5/10)
Stefano Pifferi
Dan Deacon - Bromst (Carpark, Mar
2009)
G enere : electro minimalista
Ci abbiamo già ragionato a lungo su Dan Deacon. Abbiamo descritto, in occasione dell’uscita della sua scorsa fatica, Spiderman Of The
Rings, la vicenda di un passaggio da compositore conservatoriale di musica minimalista ad
animatore – pur comunque uguale al se stesso di
prima – di schizzatissime piste da ballo electro.
La buona notizia è che la sua follia in Bromstnon si è attenuata; eppure è più riflessiva, per così
dire. Ci sono meno pacchianerie usate come strumenti – anche se le voci cartoonistiche compaiono ancora qua e là; meno colpi ad effetto, meno
vicende tiratissime basate su una sola idea. Red F
è l’esempio ideale; contiene in sè il potenziale di
tre dei brani che animavano Spiderman…e in
definitiva è una sofisticata suite minimalista per
drum machine e macchine giocattolo.
La successiva Padding Ghost ci suggerisce che
Dan non punta al nostro sballo, ma all’ipnosi a
grande velocità.
Ma il nostro stupore si concentra altrove; Deacon ci concede addirittura quella che nei primi
minuti si potrebbe definire una “ballata electrominimalista”, un “lento” alla sua maniera (tecnica usata anche in Slow With… e Balthirose), che
tanto ricorda le armonie di Brian Eno, Snookered; è ovvio che prima o poi quel giro debba
diventare un crescendo fino al ballo-sballo, allo
scuotimento di teste e bacini; ma sentite il genio
che Dan ci mette per creare le condizioni per cui
quell’esplosione sia già in corso quando avviene,
definitivamente, al sesto minuto; nel frattempo il
recensioni /
49
nostro ha citato con un breakbeat vocale la IDM,
e chiuso nel silenzio più notturno dei campanellini
che ci approssimano alla traccia che viene dopo, Of
The Mountains. Che dire? Proprio questo mese su
SA ragioniamo di brekbit, di hardcore continuum;
il brano sembra perfetto per essere messo sul piatto
della discussione, ma non solo; abbiamo esposto
proprio il quell’articolo le tesi di Simon Reynolds in
proposito, da cui siamo partiti; ebbene, il Reynolds
cita proprio direttamente Bromst di Dan Deacon
come la controparte americana ed euforica del nurave britannico. Gli
andiamo dietro con
una considerazione; Dan con questo
disco esce dall’autoreferenzialità necessaria (per uscire
dalle accademie) di
Spiderman… ed
entra in un possibile discorso di movimento a scala più ampia della
musica da ballo. E lo fa con un album nettamente
meno danzereccio o sfrenato del precedente; forse
perché sa che è dal vivo che quello sfracello paranu-rave può avvenire, mentre il gioco delle parti gli
dà la corda necessaria per esporre quello che ha da
dire senza foga. Badate bene dunque; il discorso
eteroreferenziale non avviene solo perché Deacon
fa annusare riferimenti esterni (ancora la tecnica di
compressione del break in Woof Woof); ma per la
calma con cui le cose vengono suonate.
Non c’è foga, in Bromst, ma asserzione dei propri mezzi e del proprio stato dell’arte. Forse asserzione ripetitiva, ma dal punto di vista di chi
scrive ancora una volta convincente, forse sulla
lunga più convincente. Era difficilissimo fare un
album non prevedibile dopo Spiderman Of
The Rings; Bromst non è imprevedibile; è
intelligente.(7.3/10)
Gaspare Caliri
Danny Given - Appunti Di Viaggio n.5
(Abaco, Gen 2009)
G enere : J azz P op
Interessante l’idea della Abaco di dar vita ad una
collana di audiolibri dedicata ai musicisti. “Appunti di viaggio”, nell’epoca del download sfrenato e
della conseguente perdita di identità degli artisti,
persi nel mare della virtualità di internet, con le
loro opere trasformate in semplici e anonimi file
audio, propone un’esplorazione approfondita e non
solo musicale di alcuni artisti, per lo più gravitanti
nel panorama jazzistico – cantautorale. Diari nei
quali i musicisti parlano dei loro “viaggi” musicali,
riportando impressioni, fantasie, storie, foto, citazioni, che hanno caratterizzato in qualche modo il
loro percorso artistico. Libri da sfogliare, leggere,
ascoltare e guardare, attraverso i quali entrare in
contatto con la personalità degli autori, che sottolineano gli aspetti multimediali della musica.
Il volume 5 della collana è dedicato ad un cantante
legato alla scena jazz-pop, una di quelle voci bianco-nere nate ascoltando in chiesa le donne del popolo afroamericano e cresciute all’ombra del soul
e del jazz. Voce profonda, scura, ma estremamente dolce, il quarantenne Daniel “Danny” Given è
nato a San Francisco quaranta anni fa, nel pieno
della summer of love, ma i suoi riferimenti sono
tutt’altri. In verità, se non fosse per la sua voce
calda e che nel timbro ricorda quella di Antony,
spogliata degli eccessi di vibrato di quest’ultimo, la
musica passerebbe senz’altro in secondo (se non in
terzo) piano, anche se non dispiacciono le versioni
soft di uno standard come One For My Baby e la
straniante versione pop-soul di Walk On The Wild
Side di Lou Reed, un azzardo che di certo gli fa
onore. 27 minuti di musica sembrano pochi, anche come colonna sonora di un diario, ma possono
bastare a creare l’atmosfera per un viaggio. Di ottima qualità il libro e le foto, frutto di un lavoro di
editing certosino e costoso. Il rischio è quello che i
testi e le immagini prevalgano di gran lunga sulla
musica. Come in questo caso. (6.5/10)
Daniele Follero
50
/ recensioni
Highlight
Anni Rossi - Rockwell (4AD, Mar 2009)
G enere : avant pop orchestrale
Polistrumentista di formazione classica, la ventitreenne
americana Anni Rossi potrebbe benissimo essere l’anello di congiunzione tra Joanna Newsom e Carla Bozulich. Un’attitudine alla canzone e nello stesso tempo alla musica contemporanea, per un avant pop che
mischia elementi sinfonico-orchestrali con dissonanze
e destrutturazioni. La viola è infatti il suo strumento
di elezione, e questo le permette l’improvvisazione e
la stratificazione tra gli elementi, per composizioni o
meglio mini suite sempre sul punto di deflagrare, in un continuo saliscendi emotivo
ed armonico. Una scrittura cinematica e molto free la sua, che le consente le massime variazioni, anche della voce, usata come un vero e proprio strumento aggiunto,
modulando le armonie insieme alle progressioni armoniche strumentali.
Rockwell è compiutamente il biglietto da visita di Anni: alcuni dei suoi precedenti
pezzi in repertorio sono stati, sotto la guida di Steve Albini, rivisitati e arricchiti
strumentalmente, e rispetto all’anarchia e all’impeto delle prime prove, la sua energia incontenibile viene incanalata al servizio delle composizioni. Afflati sinfonico orchestrali (Deer Hunting Camp 17) che si uniscono alle variazioni e alle dissonanze
(Wheelpusher), strutture canzoni contaminate (Machine), massiccio uso della viola, ma anche di organo (Ecology), clarinetto (Venice), violoncello, fiati e soprattutto
percussioni. La controparte femminile dei Beirut o di Final Fantasy, una My
Brightest Diamond meno “normalizzata”, una Carla Bozulich per il lato selvaggio e destrutturato, il John Cale che dal vivo percuote la sua viola, le coloriture
Joni Mitchell della voce, questi gli immediati paragoni che ci vengono in mente.
Una bella sorpresa davvero.(7.3/10)
Teresa Greco
De Rosa - Prevention (Chemikal Underground Records, Mar 2009)
Genere: indie-folktronica
Giungono al disco numero due, i De Rosa.
Mend, debutto risalente al 2006, aveva delle carte da giocare.
Le medesime anche in questo Prevention Martin John Henry, Chris Connick, James Woodside,
Neil Woodside e Andrew Bush ritentano: dosi di
emotività incontrollata, ornamenti preziosi ma
sempre fluidi di melodismo iridescente, lirchie
criptiche eppure affascinanti (scritte da Martin).
Forse manca qual qualcosa in più a che far gridare troppo presto al miracolo (come fece Mojo
loro riguardo); dopotutto l’amalgama di folk ed
elettronica soffusa da melodie evocatrici non è di
recensioni /
51
per se nuova. Uno qualsiasi dei labelmate della
Nostra band basterebbe qui a testimoniare la veridicità di siffatta illazione. Disco maturo. A volte
anche eccessivamente.
Se cade dal ramo cui penzolava poco c’è da sperar che resista.
Si spappolerà e basta...(6/10)
Massimo Padalino
Deep Cut - My Thoughts Light Fires
(Club AC30, Mar 2009)
G enere : shoegaze
Che il ritorno in forze dello shoegaze fosse molto più di una impressione, ce lo ha dimostrato la
reunion – definitiva? temporanea? produttiva?
non resta che aspettare e sperare – dei padrini
My Bloody Valentine oltre che una serie di dischi
e gruppi (nuovi e/o vecchi) che trattammo tempo
addietro al tempo dello sguardo sul Digital Shoegaze. Qui guarda
caso c’è di nuovo
la Club AC30 a
mettere il proprio
marchio sul disco,
nello stesso modo
in cui c’è e c’era
l’etichetta britannica dietro i Televise e dietro questa
neue welle dello shoegaze made in UK.
Deep Cut, la nuova sensazione in casa Club AC30
è un quintetto londinese, ma non di verginelle del
pentagramma si tratta; e proprio il riemergere
delle passate esperienze di alcuni componenti –
in primis Mat Flint, chitarra dei guitar-pop Revolver prima che decennale bassista di Death In
Vegas – ci fa propendere per la bontà e sincerità della proposta. Che a dirla tutta si sposta più
sullo shoegaze puro che sul versante spacey del
genere. Perciò melodie pop zuccherose ma non
sempre, atmosfere sognanti e sospese, chitarre in
super delay, afflato pop-psichedelico, grinta indie
e stratificazioni di feedback come se piovesse.
52
/ recensioni
Insomma, frecce al proprio arco ne hanno eccome. Thought Crimes, ad esempio, con un giro di
basso di quelli epici suffragato da atmosfere Lush,
o le citazioni Joy Division di Failure To Bond, i
Curve nascosti e accelerati di Dead Man Walking, le pulsioni electro di Just Chasing, il postBreeders di Bullshit Detector e Freezer Burn e il
reminder 4AD di Automatic Instant.
Ottima la produzione e l’esecuzione strumentale,
con un particolare plauso alla voce della cantante Emma Bailey, aggressiva e sognante allo stesso
tempo. I miei pensieri accendono il fuoco, sentenzia il titolo dell’album. E come dare loro torto,
visti i risultati?(6.5/10)
Beach Boys esotici, ai numi tutelari Lee Hazelwood, Gainsbourg, al Prince piùsoul e falsettato, al surf fine Cinquanta (con la cover dei
Four Preps, 26 Miles Santa Catalina), al tropicalismo chesegue la fortunata scia dei Vampire
Weekend, al country.
Il tutto tenuto insieme da un’attitudine scanzonata eautoironica che ce lo fa diventare empatico
sin da subito. Come da incipit del disco, Welcome
Mr. Dent!(7/10)
Stefano Pifferi
Genere: dub
Ex Wave - Apri Gli Occhi (Do It Yourself, Gen 2009)
G enere : E lettronica C ameristica
Allo stesso tempo parata di stelle e stelline della
battuta in levare e mammut nella durata (più di
settanta minuti l’edizione europea con due bonus
track) la quinta fatica dei canadesi Dubmatix. Se
l’idea di una band reggae proveniente da Toronto
vi suona strana, tenete presente che: a) siamo nel
terzo millennio e il mondo è ormai un fazzoletto,
b) i nomi Africa Unite e Pinerolo non vi hanno
probabilmente insegnato nulla. Insomma, ci siamo capiti: allo stesso modo è chiaro che benché
nulla sarà l’impronta che lascerà sull’evoluzione
della musica giamaicana (di per sé ampiamente
codificata al pari di tutte le altre…), Dubmatix è
compagine d’indiscussa abilità.
L’esecuzione strumentale mostra degli appassionati esperti, la scrittura sostiene senza cedimenti
una ritmica duttile ma possente, spesso disposta
a slarghi dub anche nei brani cantati); l’impasto
fiatistico è ricco e policromo, le coloriture d’organo puntuali. Quando poi hai la fortuna di sistemare di fronte al
microfono gente come Linval Thompson e Michael Rose, Sugar Minott e Wayne Smith,
significa soltanto che la tua fama è consolidata e
la cultura originale cui ti ispiri riconosce le tue
capacità, dunque puoi offrirne un catalogo riassuntivo. Accade in modo assai convincente nei
fluenti dub che compongono metà della scaletta
Certe musiche da film non hanno tempo e fanno
ormai damolto la fortuna di parecchi musicisti,
magari anche bravi. Basta un pianoforte, qualche semplice e languido fraseggio, un accompagnamento non troppo invadente e il prodotto è
confezionato, pronto per essere utilizzato inuna
sequenza amorosa, durante la scena di un triste
bacio d’addio o per accompagnare la passeggiata
solitaria di un ipotetico protagonista introspettivo. Potrebbe essere un progetto molto interessante quello messo in piedi dal pianista Lorenzo
Matarazzo e dal violinista Luca D’Alberto, se
noninsistesse troppo su queste soluzioni facili ed
orecchiabili, impossibili da odiare, se non per il
loro eccessivo “buonismo”. L’idea di unire il timbro dolce e lirico di strumenti“classici” come il
pianoforte e il violino, all’elettronica e a beats da
dancefloor, si rivela interessante solo quando riesce ad uscire dagli schemi prevedibili della musica da tappezzeria, quando la tensione aumenta
sfuggendo al tonalismo più essenziale e banale e
gli strumenti possono evadere dalle strette maglie
dell’ambient, come nel caso della conclusiva Lda,
in cui, assente il pianoforte,viene fuori più chiara
l’anima sperimentale di D’Alberto.
Ci si accorge solo alla fine, dunque, delle potenzialità del progetto, troppo spesso soffocate dal
minimalismo sdolcinato del piano, che inesorabil-
Dent May - The Good Feeling Music of
Dent May & His Magnificent Ukulele
(Paw tracks, Mar 2009)
G enere : orchestral pop , tropical , surf
Un personaggio davvero Dent May. Con un
aspetto da nerdprimo della classe, lo si direbbe
uscito da un immaginario fities alla AmericanGraffiti di George Lucas, con tutto un corollario
di crooning pop,swing, surf music e tropicalismo
assortito. Un Jens Lekman o un Adam Green o
per meglio dire uno Stephen Merritt.
Non è esattamente un esordiente, ha infatti all’attivodiversi gruppi negli ultimi anni, che vanno dal
synth power-pop dei Rockwells,fino alla country
music (Cowboy Maloney’s Electric City) e persino alla dance (Dent Sweat).
Un incontroprovvidenziale con gli Animal Collective a inizi 2008, mentre il gruppo di Panda Bear registrava l’ultimo disco, e dasubito una
collaborazione che ha portato a questo esordio
su Paw Tracks. Su una base orchestral pop si innesta la voce da coroner di Dent, spesso in falsetto, per un incrocio tra umori swing, country,
sixties,tropical, surf, dominati dal suo ukulele,
strumento principe.
Un buon amalgamae pezzi abbastanza coesi, sia
quando si cimenta in riproposizioni/omaggi ai
e nell’innodica Peace & Love; nella torpida ipnosi
Dub In Me Hand e nel sensuale ancheggiare di
Easy Down; in una Blessing Of Compassion che Alton Ellis aromatizza di soul e nello scioglilingua
rastafariano Tornado. A dispetto del chilometrico
minutaggio, a Renegade Rocker si arriva in fondo
(quasi) senza accorgersene e ci si torna per centellinare i momenti più godibili. Non da tutti, ne
converrete (6.6/10)
Giancarlo Turra
Teresa Greco
Dubmatix - Renegade Rocker (Echo
Beach, Gen 2009)
recensioni /
53
mente conduce alla staticità gran parte del lavoro.
Non si può dire che l’apporto di drum machine e
altre strumentazioni elettroniche fornisca un apporto determinante, pur costituendo,a volte, un
elemento di rottura (Apri GliOcchi) Un disco da
sognatori faciloni, appagati da sensazioni dolci e
confortanti.
Astenersi ascoltatori attenti e critici rompicoglioni (5.8/10)
Daniele Follero
Highlight
DM Stith - Heavy Ghost (Asthmatic Kitty Records, Mar 2009)
G enere : soulstreampop
Padronanza. Ricerca calcolata di un effetto e costruzione di particolari per arrivarci.
Non voglio essere troppo prolisso per introdurre questo disco che coglie la freschezza di
una bravura che si esprime con una facilità imbarazzante. A volte oscurando meccanismi meno controllabili ma forse più incisivi nella musica.
DM Stith inserisce nel suo esordio sulla lunga durata le
tecniche che da piccolo ha imparato e poi ha metabolizzato negli anni per poi sfruttarle grazie alla conoscenza di
figure dell’indie di particolare potere trascinante. Heavy
Ghost ci mostra anzitutto le sue capacità, dunque. Prendete Pity Dance. Una canzone che a ben vedere non è
una canzone; ma una lunga preparazione a basso tasso di
crescendo che accompagna al tema corale della fine. In
mezzo una capacità di perseguire un effetto strabiliante,
con tocchi che ricordano i Black Heart Procession come Devendra (presente anche
in Pigs). Si notava fra l’altro nella monografia allo Stith dedicata che nella sua musica si
coglie un’oscillazione tra flusso e forma canzone, tra ambient e soul, ovvero tra ambiente e anima. David Stith è anzitutto un grande cesellatore di quella soglia che fa di una
canzone – anche a toni soul, anche che citi i cori degli anni ’50 – un processo (ascoltate
Creekmouth, che è un messaggio per noi di potenzialità di orchestrazione ritmica); in definitiva una composizione; come Mahler stressò la sinfonia fino al limite, Heavy Ghost
gioca con i piccoli stratagemmi delle canzoni pop per dipingere ciò che Stith vuole esprimere – come per la perfezione armonica di Thanksgiving Moon. Che può succedere a
DM Stith? Di non toccare, neanche sfiorare la nostra anima. A un certo punto a volte la
padronanza e il calcolo stroppiano e risultano artificiosi. Non è il caso di Heavy Ghost,
e come esempio conclusivo – non casuale – si potrebbe citare la pseudo-poliritmia di
Spirit Parade. Un soffio corposo. Una melodia vocale che minaccia trasparenza. Coltre
spessa di spiriti; fantasmi
pesanti.(7.2/10)
Gaspare Caliri
54
/ recensioni
Faust - C’est Com Com Complique
(Bureau-b, Mar 2009)
G enere : K rautrock C hansons
Proprio un mese fa si parlava di derive kraut nelle
sonorità contemporanee. Neanche a farlo apposta ritornano i padri di quel sentire che guarda
al cosmo e che vede oltre. I Faust, i dinosauri di
quell’era da cui è nato il post-rock (e non solo)
ci sono ancora; e con la consueta macchina organizzativo-pensante tedesca impongono il loro
marchio al solito mondo e parzialmente al mondo alieno della canzone francese. Certo ormai a
ben vedere i Faust di oggi sono per metà francesi, se pensiamo che a fianco a Péron c’è anche
l’Ulan Bator Amaury Cambuzat. Ma non è una
novità.Gli ex ragazzi sanno che comunque la
struttura è quella. Sanno che si può ancora sforare di minutaggio e infarcire la tradizione con
quelle chitarre missili che ti sparano in alto. Fuochi artificali nella notte del post.
E quindi ci vanno di progressività che è tutto un
ricordo. L’iniziale Kundalini Tremolos è una rivisitazione dello shoegaze con quei crescendi che
hanno fatto la fortuna delle band targate Constellation, 9 minuti che ti introducono in un mondo
alieno, in un magma fatto di piatti che disorientano (Accroché à Tes Lèvres), downtempo dark
e melismi che guardano al santone Stockhausen
(Stimmen appunto). E poi ti rendi conto che la
base su cui stanno viaggiando è un afflato che
più rock non si può: un basso più carico che mai
di slap, una chitarra che trasuda pinkfloydismo
da ogni poro e una percussività che si mescola
osmoticamente con l’elettronica pastosa e analogica dei moog. E Zappi, che con quel battere pachidermico di batteria riconosceremmo tra mille,
autonomo e trascinante insieme.Una strategia
che affianca e che scuote le basi della chanson
francese.
Un terremoto che va indietro nel tempo a suon di
trombe, riverberi pastosi e un cut up vocale sussurrato dal futuro. Dopo 30, 40, 50, 1000 anni
(essendo oltre, i nostri non hanno più età) i Faust
sanno ancora quello che fanno. Altro che demenza senile. Loro ci sono ancora. Qualche volta affidarci alla sicurezza dei pilastri ci conforta. Certezze d’antan.(7.2/10)
Marco Braggion, Gaspare Caliri
Francesca Lago - The Unicorn (Autoprodotto, Mar 2009)
G enere : folk
Ascolti The Workings Of A Dubious Life e ti viene da pensare in un battibaleno alla P.J.Harvey
di Uh Huh Her.Stessa flebile asprezza della
voce, stessa sei corde elettricascarnificata. Eppure, ciò che ti si para davanti inquei due minuti
e trentasette, èsolo parte del bagaglio musicale
di Francesca Lago, una breveparentesi che fa il
paio con il folk spettrale messo in bella mostranel resto del programma. L’intentosembra essere
quello di togliere consistenza al suono, per dar
spazioa un cantato solitario in bilico tra introspezione e sussurro,sfumatura e melodia minimale,
grazie anche a chitarra acustica,qualche sovraincisione e rarissime basi elettroniche. Una ventina diminuti spesi su variazioni che richiamano la
tradizione folk inglese– la title-track – e aperture
melodiche di più ampio respiro che tuttavia non
vanno maioltre la soglia dell’essenzialità. Per un
disco che scegliecoscientemente la via di un’autoproduzione orgogliosa e necessaria,in aperta
contrapposizione con quel MoscaBianca pubblicato da Edel dodicianni fa che rappresentò il
primo passo di Francesca Lago nel mondo della
discografia ufficiale.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Francisco Lopez/Lawrence English HB (Baskaru, Gen 2009)
G enere : elettronica sperimentale
Non è sempre detto che “due menti lavorano meglio di una”, è il caso della nuova uscita siglata
Baskaru, dell’artista visuale e sonoro Lawrence
English e del portoghese Francisco Lopez, riconosciuto come uno dei più eclettici esponenti
recensioni /
55
dell’elettronica sperimentale.
Entrambi non sono certo nuovi alle collaborazioni, avendo in passato diviso dischi e progetti
con artisti blasonati (Steve Roden, Mark Behrens
o Andrey Kiritchenko per Lopez; David Toop,
Ami Yoshida e KK Null per English).Come certamente è comune il linguaggio utilizzato, fatto di
devozione al silenzio, impressioni in presa diretta,
attenzione agli stati percettivi o la ricercata materia sonora, dai suoni ambientali e industriali (Lopez) alle relazioni tra suono e struttura (English).
Aperture conosciute quelle di Lopez (Untitled),
sensibili come sempre alle assenze del mondo
tra ronzii e tremolii, che quasi sembrano diventare, per English, premesse da maneggiare con
estrema concretezza e astrazione tra crescite in
distorsione (Pattern Review by Motion) o letture
di superfici (Wire Fence Upon Opening).
Ed infine le chiusure di Lopez (Untitled #204) in
perduti soundscapes al confine con il visibile grazie all’efficace sovrapposizione di field recordings
dall’anima concreta.
Alle quattro tracce di HB nate da un interscambio virtuale manca però un tema comune, sicuramente voluto ma latente alla prova dei contenuti.
Diverso il caso della tecnica, scorta iil più delle
volte a dialogare con profitto, pur se in alcuni casi
prevalicato dal manierismo di Francisco Lopex
(quello stesso rilevato nella sua traccia di Audible
Geography per fare un esempio). (6.4/10)
Sara Bracco
ve. Non c’è il pathos del concerto dal vivo, non ci
sono l’aspetto visivo delcontesto né tanto meno
l’aspettativa del sotto palco, il sudore, lacondivisione. Insomma, si sarà capito. I live non mi piacciono e questo LastNight… è un live. Registrato
tra il Clwb Ifor
Bach di Cardiff
(dovesuonarono
i primi, incogniti shows un paio
di anni addietro)
e il Water Rats
di Londra sul
finire dell’agosto scorso, questo 19 tracce inaugura il legamediscografico
con la 4AD e propone molti brani dal debutto
Curses,compresi gli ottimi singoli adeadenemyalwayssmellsgood e FingersBecome Thumbs,
oltre che quattro nuovi pezzi che dovrebbero finire sulnuovo album. Di sudore ce n’è tantissimo,
tanto per tornare su temiorganici, nella cover
dell’album che immortala il bassista Kelson Mathiasscatenato in mezzo al suo pubblico.
Di energia, altrettanta, specialmente nellaconclusiva Cloak The Dagger: 10 minuti di furibondo noise-rock proprio al confine con i (furono)
McLusky.Nonostante la mia atavica idiosincrasia,
Last Night…fotografa un gruppo in grande forma e spolvero lasciando ben sperare per il nuovo
album in arrivo.(6.5/10)
Stefano Pifferi
Future Of The Left - Last Night I Saved
Her From Vampires (4AD, Mar 2009)
G enere : noise - rock
Giuseppe Ielasi - Aix (12k, Feb 2009)
G enere : elettronica ambient
Non ho mai capito l’utilità dell’album dal vivo,
tantomeno la necessità che un gruppo ha di farne
uscire uno, ma credo sia unproblema mio. Forse
ad un certo punto della propria carriera si avverte
ilbisogno di mettere un fermoimmagine sulla propria arte, immortalando un precisomomento dello
sviluppo artistico di un determinato progetto.Da
ascoltatore però non riesco proprio a digerirli, ili-
Indossa una veste nuova lo Ielasi di Aix, album
che prende il nome dal luogo dove è stato registrato (Aix en Provence, dove l’artista si è trasferito per l’anno 2008-2009).
Il ritmo sembra ormai di casa considerate le premesse in giradischi ed elettronica funk della trilogia Stunt (Schoolmap Records), organizzato in
impulsi e brevi segmenti che in Aix lasciano il po-
56
/ recensioni
sto a rotture e sequenze di micro blocchi.
Si selezionano le materie prime in campioni, la cui
trama rimane sintetica pur con il percepibile rilievo acustico di percussioni, chitarre, tromba e vinili;
campioni che sfasano gli accostamenti sonori lineari e principalmente orizzontali di Stunt e funzionano da materia prima di verticali in on/off.
L’attenzione al dettaglio è rigorosa, orientata e condizionata dal ritmo, tra danze jazz e 4/4 di delicate sorgenti minimali. Mentre la presa di coscienza
dello spazio è prestabilita all’interno d’un griglia
già definita, fissato una volta per tutte nei movimenti d’organo su fondi sfrigolanti di Untitled 01,
nei battiti rigorosi di Untitled 02. C’è chi poi non
potrà fare a meno degli slanci di Untitled 03, dei
primi piani di Untitled 05, o, per i più nostalgici,
delle elettroacustiche in riff di Untitled 09.
Per poi rendersi conto che la materia è assolutamente differente non solo rispetto agli stili cari
alla 12k, ma anche rispetto alle stasi, le meditazioni e i drones dall’ampio respiro di August o
alle acustiche a sei corde di Plans.(7.3/10)
Sara Bracco
Gnaw - This Face (Conspiracy
Records, Mar 2009)
G enere : N oise - drone sintetico
Gli Gnaw sono la nuova creatura del cantante
Alan Dubin, che messi da parte iKhanate presta
la sua voce agghiacciante a una ennesima cronaca del terrore.Con lui Jamie Sykes (Burning
Witch, Thorr’s Hammer) alla batteria, infineCarter Thornton e Jun Mizumachi, insieme a modellare la melma nera, l’abissalenoise sintetico che
costituisce la sostanza fondante di questo disco.
Devastante il primo brano, Haven Vault, in cui
gli Gnaw sommergono conun oceano di ultrabassi, colpi sparsi di batteria che come un epilogo alcontrario introducono ai sabba infernali
post-mortem del resto dell’album. Da Vacant in
avanti si innescano ritmi primordiali e vengono
alla mente gli Scorn di VaeSolis o una versione
black-metal degli Shit&Shine. Feelers esplodeco-
me un’apocalisse in slow-motion, dopo una cupa
introduzione si innescamassiccio un implacabile
crollo. A venire percosse non sono più pelli ditamburi, ma l’intero segnale, una sequenza temporale scandita da tuoni esquarci.
Backyard Frontier, Shard sono psichedelie da bad
tripche attraverso percussioni primitive e graffi digitali conducono la mente inluoghi che non
si vorrebbe mai esplorare. Pulsazioni convulsive,
dissonantinenie si sovrappongono e si distaccano
fino a sezionare la percezione, in unasensazione
di torbido stordimento che permea tutto il disco.
Ma è ancoranell’aritmia di Ghosted che i Gnaw
danno il loro meglio, quando Dubindeclama
scomposto come dei concetti troppo terribili da
spiegare, mentre tutto intorno è buio e disperazione. Delle belle sensazioni.(7.5/10)
Leonardo Amico
Goblin Cock - Come With Me If You
Want To Live! (Robcore / Touch And
Go, Gen 2009)
G enere : A cid D oom R ock
Tuniche e cappucci in stile Ku Klux
Klan,rigorosamente nere, cinque energumeni che
imbracciano altrettante chitarre,nascosti dietro
esilaranti nickname (Lord Phallus, Ass-Pounder,
Braindeath), unimmaginario eroico da Power
Metal, curiosa parodia dei serissimi Manowar,
e unnome che non lascia dubbi sull’ironica presa in giro: Goblin Cock, dove laseconda parola,
stando ai vocabolari della lingua inglese, sta sì per
“gallo”,ma si riferisce anche all’attributo maschile per eccellenza. Così come nei mascheramenti
e nei simpaticissimi video(quasi una versione metal di alcuni deliranti clip dei Residents), anche
nellamusica la band di Rob Crow, approdata,
dopo un silenzio durato quattro anni, alseguito
dell’esordio (Bagged And Boarded), presenta una
versione del tutto suigeneris del metal. In realtà i
Goblin Cock più che una band doom, come qualcuno l’hadipinta, ricordano la versione più graffiante e dura del grunge anni ’90, i Tade lo psych
recensioni /
57
rock dei Jane’s Addiction. Le atmosfere, più che
tendere altenebroso, si infittiscono di trame acide e psichedeliche, fino ad abbandonarsia ballate
paranoiche alla Alice In Chains (Tom’s Song).
Anche gli episodi piùThrash come la conclusiva
Trying To Get Along With Humans o gli inconfondibiliriff doom di Ode To Billy Jack, possiedono solo un vago sapore metal e sono“sporcate”
da distorsioni chitarristiche che hanno poco a che
vedere con lapossenza dei riff metallici, divagando spesso e volentieri verso i lidi delnoise rock.
Uno stile, in fondo, completamente fuorviante
rispetto all’immaginedel gruppo, che crea uno
scollamento rispetto alle aspettative. Un giocodivertente e sarcastico nei confronti del metal più
pomposo e grossolanamente epico.(7/10)
Daniele Follero
Handsome Furs - Face Control (Sub
Pop, Mar 2009)
G enere : elettropop
Al secondo disco Dan Boeckner (Wolf Parade)
e fidanzata Alexei Perry sembrano aver perso
quel po’di tensione emotiva e concettual-musicale che animava il loro esordio PlaguePark del
2007.Formatisi come duo elettronico minimale
a latere deinumerosi progetti gravitanti intorno
al gruppo madre e alla scena indie diVancouver,
laddove nel primo coniugavano suoni ed estetica ’80 zona Suicide/New Order con elementi
Bowie/Arcade Fire, qui accentuano la componente elettro, scarnificandolaparecchio.
Il risultato non è però quello sperato, risultandopovero di idee e piuttosto monotono nei suoni.
Il solito contrasto chitarra evoce bowiana contro
suoni minimali lascia il tempo che trova, e quando si tentadi immettere qualcos’altro (ritmiche e
suoni Jesus And Mary Chain in NyetSpasiba
per esempio) il risultato è tutt’altro che esaltante.
Non bastal’attitudine pop e fashion indie questa
volta a reggere il gioco, scopertissimo del resto.
Peccato.(5.5/10)
Teresa Greco
58
/ recensioni
Heartless Bastards - The Mountain
(Fat Possum, Feb 2009)
G enere : heavyblues
Highlight
Gli Heartless Bastards provengono da Dayton,
Ohio.E subito verrebbero in mente nomi quali
Guided By Voices o Brainiac.Niente di tutto questo. Erika Wennerstrom bazzicava i locali
cittadini inquello squarcio di Nineties vide le citate band in azione. Ma The Mountaingioca carte
diverse. L’ispirazione e il coraggio per formare il
gruppo, le harubate ai suoi eroi in note, eppure il
dato di fatto musicale la vede ben lungidal perseguire pedissequamente orme già calcate. Almeno
non dalle summenzionateband! Doni Schroader,
Billy White, Ricky Ray Jackson, Mark Nathan,
Zy OrangeLyn e McCarthy completano la formazione che suona il disco recensito. Tracceblues
dei padri fondatori (Could Be So Happy), sprazzi
di cantautoratocountieggiante (Hold Your Head
High), esplosioni di fragorosi baccanaliheavyblues (The Mountain, Early In The Morning).
Erika, chitarra evoce, ci fa spesso la figura di una
Plant in gonnella. Posseduta dademoni che le
corrono lungo la spina dorsale formicolandone
le libidini blues,la Wennerstrom mostra capacità scrittorie notevoli (Out At Sea, NothingSeems
The Same, che si ispira ai ‘talking blues’ di Jeffrey Lee Pierce). Fossero usciti nel 1994 avrebbero fatto concorrenza ai Gits.(7/10)
Druid Perfume - Self Titled (Pigs, Dic 2008)
G enere : new - free - detroit - underground
Massimo Padalino
Gaspare Caliri
Henrik Schwarz/Ame/Dixon Grandfather Paradox (BBE,
2009)
G enere : A vant -T echno
Non dev’essere facile fare il punto di una scena cittadina
in un disco; cioè, non farlo programmaticamente, ma
esserlo di fatto, il punto, per un crocevia di tempistiche,
coordinate, personaggi. I Druid Perfume sono probabilmente una ottima rappresentazione della scena
underground della Detroit di oggi. E il loro esordio self
titled raccoglie in primo luogo l’eredità dei Piranhas,
i cui 3/5 di formazione (Jamie “Jimbo” Easter, Bryan
Wade, Ryan Sabatis) sono confluiti nella band profumata di druido; altro grosso peso. E però i Perfume non sembrano proprio agire pensando a tutte queste responsabilità, ma con il solo obiettivo di fare musica lancinante.
L’ugola del piccolo pesce ferocissimo si è indurita e si è imparentata con Beefheart,
citato – ma solo a tratti – pure dal sax folle presente nel disco; forse è persino tornata
a ululare come negli happening di Allen Ginsberg; ma al capitan scoreggia si deve
pur tornare per quel la partita a scacchi tra ritmo e armonia – qui vinta dal potere
del riff, ma a punti - fino ad annusare quella suddivisione di memoria pereubu-iana
tra sezione ritmica rock-ancestrale e dada-follia atonale e free – e se non vi è chiaro
ascoltate, in Ego Death, il rapporto tra synth/theremin e sax da un lato e il combo
batteria-basso-seicorde dall’altro, con la decelerazione che fa da collante per assurdo.
E ancora, patafisicamente, respirate a pieni polmoni il forte e autodichiarato sentore
di baracca circense, lo spirito endovena di Laughing Clowns, quello di Stu Spasm… Lungo la fuga/deriva free della finale It Sleeps, vi accorgerete di una cosa;
di esservi dimenticati del punto da cui siamo partiti, le scene, la summa, Detroit; ci si
ricorderà per un po’ dei Druid Perfume, ma come Druid Perfume punto.(7.5/10)
The
Feb
Scendonoin campo tre dei produttori minimaltechno più in voga, quasia mettere nero su bianco
le loro fascinazioni musicali, per una voltasvincolati dall’idea del riempipista a tutti i costi. Un’indagineche travalica i confini del genere. Inteso
come tributo ai propripadri putativi The Grandafther Paradox – come recita lo stessosottotitolo –
è un viaggio imprudente a cavallo di 50 annidi
musica minimalista. Ferma restando la verace
attrazione verso imaestri moderni del ritmo quali
Robert Hood, Daniel Bell, Plastikman,Mike Ink
o – altrove davvero – Panasonic, i nostri mettono
manoad un ideale catalogo omnicomprensivo,
valutando secondo un processocreativo azzeccatissimo i crismi secondo cui procedere. Come
accadutoin passato per la stessa label, gli artisti si
cimentano sulla doppiadistanza, presentando un
primo cd mixato ed un secondo fatto diselezioni
autentiche, in questo caso estratti da dischi cruciali. Hosempre apprezzato Schwarz, una sorta
di revisionista elettronico delverbo afro-funk, in
questo contesto arrivo anche ad accettare laverve
di Ame e Dixon, notoriamente più impelagati
nellaquestione minimal-techno. Ho sempre sostenutoche l’idea di dance non dovesse essere unicamente relegata ad un boxasettico, nè tanto meno
recensioni /
59
all’ordine preposto dei bpm. La danzain quanto
metafora antica è una catarsi senza tempo, ed ilparadosso in questione vuole indirizzare la clunb
culture versoquelli che sono gli albori di un movimento, di una cadenza,riscoprendo l’ardore di
un viaggio tribale. Decisamente portentosa laselezione mixata, una cassa mai invadente funge da
collanteassorbendo I passi di un minimalista per
eccellenza quale Steve Reich (in combutta con
Pat Metheny nell’Electric Counterpoint) sfiorando lesuadenti onde house di Etienne Jaumet
(in un remix ad hoc dellostesso Ame), le figure ritmiche dei Liquid Liquid di Lock Groove s’incastrano nell’incedere
solare dei giganti
black Cymande.
Scivoliamo poinella nera electro del
regista John Carpenter – The President IsGone – per
assaporare a breve
giro The Three Faces Of Balal diYusef Lateef, che come d’incanto
si trasforma in una remota hit stilebalearic. La
selezione dei tre trasfigura spesso e volentieri brani aloro modo simbolo, inseguendo però un nobile modus operandi. Nel secondo cd oltre agli
originali altre chicche d’epoca, al fianco di un
immancabile Arthur Russell – Make 1,2 – la
wave germanica dei Pyrolator – November Mulheim – poi i Can di Sunday Jam a braccetto con
i Young Marble Giants di N.i.t.a. Una lezione di
stile in pillole.(7/10)
ste canzoni.Dopo arriva il resto della band, che
gioca fra le maglie di un malinconico dream pop
figlio di ragnatele Tindersticks e di sensualità
glaciale degna degli ultimi Devics. Aggiungete
un po’ di sana spazialità figlia dello shoegazema
in chiave pop, melodie perlopiù ruffiane e telefonate, uno strano senso diperfezione e di “ogni
cosa al suo posto” (che ahimè deve essere dovuto
alla produzione di Nigel Godrich, che a mio avviso fa magie solo con i Radiohead) e una curiosa
tendenza versoil mellifluo e avrete una confezione fantastica con un album solo sufficiente al suo
interno. Emozioni di plastica verrebbe da dire.
Scorre talmente bene che sembra di essere intontiti, quasi intorpiditi, se non fosse che qualche numero veramente esce dal mazzo: il singolo Cities
Burning Down Again è mestiere shoegaze versione Rapid EyeMovement, Digital Hearts è lafantastica caratura di una Tanya Donnelly che emerge, Treasure Hunt insieme a Ms.Bell’s Song sono
il meraviglioso spirito dei Devics reso ancora più
toccante ed europeo. Si cade invece nell’iperglicemico quando si materializzano spettri Berlin
nella sconsolata Nightingale, quandol’innocenza
si fa parodia di se stessa (Let’sBe Kids) o quando
il soul abbattuto prende il sopravvento nella conclusiva How Long (che sia la versione femminiledi Condemnation dei Depeche Mode?). Non si
stronca un disco così, perchè si sente che il lavoro
è stato fatto mediamente bene, ma la puzza di
patinato e di compitino è ovunque e il dispiacere
per il fatto che determinati spunti di base interessanti non siano diventati stimolo per rischiare,
lascia un po’ di rammarico.(6.3/10)
Luca Collepiccolo
Alessandro Grassi
Howling Bells - Radio Wars (Pias,
Mar 2009)
G enere : indie pop
Hudson Mohawke - Polyfolk Dance
EP (Warp Records, Gen 2009)
G enere : H app y W onky - hop
Il ritorno degli Australiani Howling Bells (trapiantatia Londra) è un disco che si presenta solido,
incentrato sulla bellissima voce di Juanita, protagonista indiscussa dell’impatto emotivo di que-
Dietro al nome Hudson Mohawke si cela un ragazzo di 22 anni di Glasgow. La periferia che
guarda a Londra e che mescola mescola mescola.
Il suo EP (a cui seguirà probabilmente quest’estate
60
/ recensioni
il full lenght) viaggia ai confini dei generi. Passepartout estetico obbligatorio più che mai per farsi sentire nel magma electro. Ma la sua proposta
non urla, anzi ride. Happy hop è la parola d’ordine sulla bocca di tutti i critici e bloggers electromusicali. Il giochino che nasce con l’ardcore e
che tramite il brekbit sopravvive al tempo; il famoso ‘continuum’ teorizzato e professato da quel
santone della critica che è Simon Reynolds.Qui i
suonini giocattolo la fanno da padrone, ma è un
giochino in stile eden Animal Collective. Il disco
che abbiamo sottomano non supera nemmeno i
20 minuti, ma ci parla di molte sonorità che spopolano: il funky bianco post Gang of Four in salsa
brekbit, quel suono che toglie un colpo al quattro ed è gia dubstep (Overnight), le vocine all’elio
muppetsiane must per gli ‘ardkore maniacs (Polkadot Blues), il d’n’b mascherato da Zecchino
d’Oro e scuola Aphex (Velvet Peel) e in generale
una visione che gioca a nascondino con la storia
dell’elettronica.Un tributo ai maestri che prelude
al successo. Hudson, u know the score.(7/10)
oscurità in drones (Invocation) passando attraverso i cristallini fondali di In Absentia o le recondite
risacche di violoncello (Gloaming), il passo è breve e l’anima umorale paradossalmente opposta. Il mutamento è evidente e non è dettato dai singoli episodi, ma dall’insieme, quasi ogni elemento
si concedesse al successivo plasmandolo, influenzandolo o negandolo. La sensazione è che poco
per volta l’identità prenda forma tra atmosfere
lynchiane (Portrait of God with Broken Toys),
dialogate latenze (Chaplins of Ms Selfridg), o
memorie elettroacustiche (Freeview) in chitarre
(Mouth Replaced, Tears Removed) e pianoforti
che si ritagliano attese in radiofrequenze (Exanimation) o anime narranti (Dalkeith Night).Non
temono confronto i chiaroscuri di Human Greed con i delicati torpori del Basinski o la dark
ambient di Aidan Baker. Stati umani d’ urgente
oscurità e di morbosa bellezza a tratti violenta,
a tratti confortevole: in cui trovare rifugio o nei
quali riscoprirsi appartenere.(7/10)
Sara Bracco
Marco Braggion
Human Greed - Black Hill: Midnight
at the Blighted Star (Lumberton
Trading Company, Gen 2009)
G enere : elettronica ambient
Parlano uno straordinario linguaggio le quindici tracce di Black Hill:Midnight at the Blinghted
Star, terza uscita degli scozzesi Human Greed, progetto musicale di Michael Begg e Deryk
Tommaso.La formula collaudata e riconosciuta
delle passate esperienze, si arricchisce del prezioso contributo di artisti quali: Julia Kent (Antony
& la Johnsons, Blind Cave Salamander), David
Tibet (Current 93), Fabrizio Modonese Palumbo
(Blind Cave Salamander, Larsen) e Clodagh Simonds (Mellow Candle, Fovea Hex).La vocazione dark è insita nelle trame oscure e plumbee che
assecondano l’insieme, tra elettronica ambient
ed elettroacustica; il tutto filtrato attraverso una
contemporanea matrice concreta. Dalle iniziate
Il parto delle nuvole pesanti - Slum
(Storie di note, Giu 2008)
G enere : etnico
“Slumsono le bidonville nate nelle periferie dalla
periferia del mondo, inAfrica. Sobborghi disperati, discariche umane, dove la povertà e lasolitudine della fame e di malattie atroci scandiscono
il destino diintere famiglie, assieme al mai sopito desiderio di scappare e ilsogno di un Europa
tanto a lungo immaginata, troppo spesso cosìdiversa dalle aspettative”. È un’opera ambiziosa,
Slum,un progetto che unisce teatro e musica.
In primis nella forma, dalmomento che ci si trova di fronte a un tutt’uno di note e recitazione,
e poi nell’intuizione, per una volta sensata, di
unire CD e DVD in un unico supporto. Si parla di viaggi della speranza, nell’ora di spettacolo,
di una scelta obbligata che si trasforma nel pellegrinaggio senza ritorno di Mirna, emigrante
africana in cerca difortuna e destinata invece,
recensioni /
61
alla strada. Un viaggio fatto disacrifici e violenza,
per sfuggire da un passato feroce e dal doloreper la morte del figlio. A dar voce al personaggio
in un monologo catartico e coinvolgente, Milvia
Marigliano, attrice, autrice eregista. Un’artista
che riesce nell’impresa di non banalizzare iltema
dell’immigrazione nella solita macchietta da TG
cannibale,facendo emergere, invece, il dramma
umano nascosto dalle notizie d’agenzia. Con il
gruppo che diventa attore, scenografia ecaratterista, oltre che curatore della colonna sonora,
pronto ainteragire con la Marigliano e bravo a
musicare i vari momenti della rappresentazione con un fluire etnico di note calde provenienti
dall’Europa mediorientale, dall’Africa e dal Sud
Italia.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Jacob Kirkegaard - Labyrinthitis
(Touch Music UK, Nov 2008)
G enere : elettroacustica
Sicuramente la materia non è nuova; qualcosa
lo si era già detto nelle premesse settecentesche
di Giuseppe Tartini con il suo omonimo “sistema tartini”, successivamente rese pubbliche nel
“trattato di musica” di Romieu (1751), passando
attraverso le nuove questioni sulla percezione e
l’ascolto attivo; cardini compositi del John Cage
di 4’33” a cui sicuramente devono molto le sinusoidali in relay di CM Von Hausswolf (performance/evento Touch 2006).
Parliamo delle “emissioni di otoacoustic”, veri e
propri “prodotti” sonici che si generano all’interno della coclea; quando l’orecchio viene stimolato da due toni puri a una determinata frequenza
al punto che, a causa di fenomeni di distorsione si
genererà un terzo tono; l’orecchio a questo punto
da semplice traduttore diventerà un vero e proprio meccanismo attivo.
Partendo da questi presupposti e servendosi di
specifiche strumentazioni mediche Jacob Kirkegaard cattura e studia il fenomeno per poi combinarlo e riprodurlo artificialmente tra distorsioni
62
/ recensioni
in frequenza e primarie micro tonali. L’approccio
sonoro è affascinante merito di quella modularità spaziale itinerante, dettata dalla frequenza
e dalla tonalità, il tutto elegantemente avviato
in lineari stesure a tre fasi tra singolarità, dualità ed opposti. Trentotto minuti di perspicace ed
incantevole educazione all’ascolto tra scienza e
pratica sonora; più difficile da dirsi che da ascoltarsi!(7.5/10)
Sara Bracco
Jeremy Jay - Slow Dance (K Records,
Mar 2009)
G enere : songwriting
A distanza di neanche un anno dall’ultimo notevole A Place Where We Could Go, ecco ritornare JeremyJay, songwriter e polistrumentista
americano con tutto un immaginario
europeotra sixties
ed eighties. La
formula è rimasta
perlopiù immutata, vale a dire unmix di sensibilità
vintage filtrato attraverso gli Ottanta (Buddy Holly rivistoda Elvis
Costello), di attitudine spiccata verso il cantautorato decadente francese (Gainsbourg/Hardy)
epronunciata new wave, con le tastiere e i bassi
sempre preponderanti. C’è da dire che i suoni
rispetto al precedente si fanno un po’ più rarefatti ed elettronici, riprendendo abbastanza il synth
popGary Numan/OMD filtrato con l’oggi degli
Air. Con forti rimandi al primo Tom Verlaine
pre-Television dei Neon Boys con Richard Hell,
a testimonianza dell’amore del Nostroper quel
periodo della New York di metà ’70, dove dandysmo ed estetismodecadente si sono incontrati, si
vedano anche i Modern Lovers prodotti da John
Caleche gravitavano allora nell’area. Non manca
comunque la consueta dose psych in voce acida,
che condensa una certa sintesi di cantautorato che
dal già citato Costello porta a Micah P.Hinson
(Winter Wonder), e gli umori rock-glam seventies
(Will You Dance With Me?) alla Bowie periodo
HunkyDory. E proprio il rimando a Bowie ci
riporta al primo pezzo deldisco, quel We Were
There con lacitazione delle tastiere kraftwerkiane
alla TransEuropa Express, pezzo che omaggiava
il Duca Bianco berlinese dandy. E il cerchio si
chiude intorno all’immaginario di Jeremy Jay. In
Slow Dance non c’è però poi molto di differente
rispetto all’album di esordio, ci si aspettava magari una svolta in una direzione precisa piuttosto
che la riproposizione più o meno pari pari di piste
già battute.(6.8/10)
Teresa Greco
John Zorn - The Crucible (Tzadik,
Dic 2008)
G enere : A vant J azz M etal
Sembrava essersi fermata al terzo capitolo, la
nuova esplorazione del metal estremo da parte
di John Zorn, musicista già avvezzo a contaminazioni del genere sin dai tempi dei Naked City.
E invece, senza perdere troppo tempo, il saxofonista americano smentisce l’idea della trilogia,
inaugurata da Moonchild e ricompone il trio
Mike Patton – Trevor Dunn – JoeyBaron, stavolta rafforzato da una new entry, Marc Ribot. La
presenza di quest’ultimoe del suo stile chitarristico blueseggiante, seppure limitata ad un solo
brano(9x9, “a Led Zeppelin influenced track”,
come l’ha definita lo stesso Zorn),può dare l’idea
del cambio di rotta che The Crucible rappresenta
in rapporto ai suo predecessori. Il sound metal
perde il valore assoluto che possedeva in Moonchild, senza tuttavia sparire come elemento identificativo del combo,mentre acquistano spazio e
visibilità elementi jazzistici e modalismi alla Masada, incantevoli fraseggi diatonici del sax che si
insediano tra un urlo di Patton e un’ esplosione
rumorista. Metal ma non solo, dunque. A partire
dai due brani iniziali, probabilmente i più legati
al passato della band: Almadel e Spaceshifting alternano riff metallici a violente sezioni free,nelle
quali Patton esprime le qualità più acute della sua
voce. Diverso il discorso per il resto dell’album,
che vira in più direzioni, verso le atmosfere dark
doom di Maleficia (con Pattonche recita con voce
sussurrata e stregonesca, su un substrato ritmico
quasi tribale) e Incubi (con il Zorn piùjazzistico),
o in direzione di territori più vicini all’idea musicale estremista di Naked City e Massacre (Hobgoblin). Il basso compresso di Dunn e la batteriaschiacciasassi di Baron restano sempre un punto
di riferimento, sia nei momenti più “pesanti”,
sia quando la pulsazione aumenta notevolmente, sfiorando il jazz-core di band come Zu, salvosviare completamente e in maniera del tutto
inattesa in episodi di caos-ordinato tipicamente
zorniani. Un altro, l’ennesimo, lavoro imperdibile per chi segue appassionatamente il saxofonista
statunitense (ma come si fa a non perdere nulla di
un musicista che pubblica una ventina di dischi
all’anno?)(7.7/10)
Daniele Follero
Julie’s Haircut - Our Secret Ceremony (A Silent Place, Mar 2009)
G enere : psichedelia - kraut
Il disco che non t’aspetti. O forse si. Le avvisaglie
c’erano tutte all’epoca di After Dark, My Sweet, un tre anni fagrosso modo. Ma questo doppio,
monumentale, nuovo disco – 90 minuti equamente divisi tra i sermoni del primo cd e le liturgie del secondo – sposta di parecchio gli equilibri
del sestetto emiliano. Forse a contribuire – per lo
meno nell’immaginario di chiascolta e scrive – è
anche il marchio col quale Our Secret Ceremony vede la luce, (quello della pugliese A Silent
Place) ma quello messo in scenada Julie’s Haircut
sembra il punto d’arrivo di un percorso di crescita contraddistinto ultimamente dalle collaborazioni/amicizie con gente come DamoSuzuki e
Sonic Boom. A segnare le coordinate del suono
del doppio è infatti l’incrocio tra il motorik kraurecensioni /
63
to riconducibile alle escursioni del primo el’alea
psichedelica dilatata e liquida delle esplorazioni
del secondo. Paradigmatico di questo procedere è
Origins, per chi scrive il pezzo migliore del lotto:
un crescendo circolare che esplode, si placa, riparte per poi avvitarsi su se stesso avvinghiato ad
un giro di basso semplicemente eterno alla fine
dei 12 minuti del pezzo.
Non da meno le restanti tracce del cd
Sermons:l’iniziale Sleepwalk col suo beat sintetico + basso imperioso mostraconfini nuovi da
subito; il carrarmato (dopo)rock The Stain dilata
quei confini verso l’Albione più hardelica e sospesa evocata dai Black Angels; TheDevil In Kate
Moss gioca di specchi con White Light/White
Heat e poi siabbandona ad una cantilena allucinata; Let Oracle Speak riesuma lo spettro piùevanescente dell’asse Loop/Hair & Skin Trading
Company e chiude il cerchio. Non sono da meno
le 6 tracce di Liturgy: il centropropulsore resta il
motorik del basso/batteria ma i tempi si dilatano,
le atmosfere si frastagliano, i suoni si fanno caleidoscopici. Entra in gioco l’anima jazzy-ludica
(l’esorcismo della seconda parte di The Devil In
KateMoss), le immersioni nel deliquio psichedelico sixties polveroso e malato (HiddenChannels
Of The Mind), lo spargimento di note di piano
sui 12 minuti di BreakfastWith The Lobster. Se
fosse un esordio ci sarebbe da rimanere a bocca
aperta,ma visto e considerato che è lo zenith di
un percorso creativo che ormai vaavanti da anni
su livelli di eccellenza, non considerare Our SecretCeremony un capolavoro con la C maiuscola sarebbe un delitto oltre che un’offesa ai Julie’s Haircut.(8/10)
mantenuti da altri componenti. Intanto lui e il
batterista Wyskida continuano insieme come duo
e nei Khlyst, O’Malley (chitarra nei Khanate) ha
i suoi Sunn O)) oltre a mille altri progetti e infine
il cantante Alan Dubin esce con i nuovi Gnaw
(in questo SA). Clean Hands Go Foul non è
del nuovo materiale, ma risale a delle registrazioni fatte nel febbraio 2005, durante le session di
Capture & Release. Una sorta di testamento,
quindi, e il suono del disco lo testimonia. Se nei
precedenti lavori la musica dei Khanate sembrava
offrire un muro ad ogni moto d’animo, atrofizzare l’ascolto di fronte a manifestazioni
di violenza senza
vie di fuga, Clean
Hands Go Foul
sembra invece catalizzare delle emozioni. Progressioni
su scale minori che
mai avevano avuto
un ruolo predominante nella loro discografia, ora
costituiscono il tema portante. C’è come una sorta di rassegnazione tragica in questo disco, come
se nemmeno i Khanate stessi siano più riusciti a
sopportare la tremenda oppressività della loro
musica e avessero deciso in una volta sola di
sciogliere tutte le tensioni mai risolte accumulate
negli anni precedenti.
Intendiamoci, siamo sempre di fronte a distorsioni
oltre misura, urla disperate e lentezze glaciali. Ma
per la vera sostanza virulenta, quella dei migliori
Khanate, è meglio cercare altrove.(6.5/10)
Leonardo Amico
Stefano Pifferi
Khanate - Clean Hands Go Foul (Hydra Head, Mar 2009)
G enere : ultra - drone
I Khanate non esistono più. Questo è quanto. James Plotkin (bassista della band) nel suo sito spiega di aver lasciato il gruppo causa impegni non
64
/ recensioni
Lady Vallens - Double Mirror (Second Family Records, Gen 2009)
G enere : electro dark
C’erano una volta i parmensi Brother James, e
non so se ci siano ancora. Lo ricordo come un trio
che s’impegnava a far quadrare estro funk-rock e
ghigni math con risultati lusinghieri ma piuttosto
in ritardo sui tempi (correva l’anno 2004 ai tempi dell’opera seconda Days). Confesso di averli
scordati, però Matteo e Rodolfo (rispettivamente
chitarra e batteria dei BJ) tornano oggi sotto una
nuova ragione sociale per una net label da loro
fondata (all’insegna del free download), ed è inevitabile attivare link con quell’esperienza ormai
lontana nel tempo e nei modi: con questa nuova
avventura - battezzata Lady Vallens – danno vita
infatti ad un impasto scabro e brumoso di ipnosi
sintetiche e ruggini elettriche tra i Cure e i Depeche Mode più solenni (vi basti Beauty), su cui il
canto di Matteo caracolla ombroso tipo uno Ian
Curtis sfibrato, strattonato e dissacrato (?) dalla
livida stagione post-rock.
Una parata di ghignanti oscurità che propongono vivide variazioni nell’apparente monotonia,
vedi come Hate Song scomoda scabrezze desertiche tra Black Heart Procession e Dirty Three, o
i guizzi sintetici caliginosi di una Death Katana
come potrebbero degli Swans ipnotizzati Notwist,
oppure prendete la vetrosa iridescenza di Crisis
che ammicca My Bloody Valentine via Autechre,
o ancora il funk quasi industrial di Ice On The
Crack in derapage verso una noise-psych incarognita.
Va detto che se l’impronta sonica è forte, non è accompagnata da una scrittura altrettanto incisiva.
Nonostante ciò la proposta si difende bene, onorando quella svolta che auspicavamo. (6.9/10)
Stefano Solventi
Laura Marling - London Town EP
(EMI, Gen 2009)
G enere : cantautorato folk
La ragazzina batte un colpo, così che non rischiamo di scordarci di lei. No che non potremmo,
malgrado l’esordio ci avesse stupito più che altro per i suoi diciassette anni, ché quei folk vibranti e ombrosi si fermavano giusto sulla soglia
dell’eccellenza, accontentandosi di una pur rilevante – quasi incredibile - compiutezza. Un anno
dopo ecco questo ep nudo e crudo a metterci sul
chi vive, chitarra acustica e voce per due tracce
inedite (una title track all’insegna di passione al
guinzaglio e impeto trafelato - la prima Suzanne Vega trascinata per Soho da Beth Orton - e
una She’s Changed fatta di palpiti Carole King e
guizzi teatrali quasi Frida Hyvonen) e una riproposizione in chiave raccolta delle già note (e notevoli) Failure e Tap At My Window, quest’ultima
praticamente una versione demo con sottofondo
di cinguettii veri.
Le precedenti impressioni trovano piena conferma: se tutto ciò gli sboccia da dentro, e se non si
guasterà strada facendo, potremmo sentirne delle
belle.(6.7/10)
Stefano Solventi
Lebowski - The Best Love Songs Of The
Love For The Songs And Best (Valvolare, Dic 2008)
G enere : post - punk
Cosarispondete se vi dico Devo, GangOf Four,
Liars, OneDimensional Man? “Sonograndi
gruppi, ma noi ci sentiamo molto legati al periodo post-punk e quindi più vicini ai primi due che
hai citato”. Basta questo a circoscrivere l’ambito
di riferimento dei Lebowski. A pattoche dell’immaginario chiamato in causa, riprendiate non
solo le andature scoordinate e le chitarre spinose,
ma anche l’autoironia.
Solo così potrete comprendere appieno il significato di un esordiodiscografico sui generis in cui si
mescolano elettriche taglienti,ritmiche in levare,
progressioni uncinanti e testi del tipo “Ma io l’elfo
l’ho visto, assomiglia a Clint Eastwood, solo che
è muscoloso, solo che è più peloso”. Post-punk e
surrealismo, ma anche noise e psichedelia, a infettare musica – la parte conclusiva di Didier e il suo
cesto di Droga – ma sopratutto testi. Questi ultimi trasformati in un trip (apparentemente) senzasenso fatto di finte ingenuità (Ho fatto all’amore
con Carlo,Carlo il più fico barista dell’Arci, Padre
perdono se ho molto peccato, ma ciò che è accaduto mi è proprio piaciuto) e quotidianità nemrecensioni /
65
meno troppo improbabile (“È stato in Russia e
ha comprato un cappello, con su il disegno della
falce e martello, di politica gli importa niente, ma
l’han menato uguale e quasi perde un dente”). Il
tutto con l’obiettivo di far sorridere, stimolareuna riflessione ma soprattutto raccontare storie,
poco importa se in rima alternata o in forma di
narrazione (Zuber Buller e la giàcitata Didier e
Il suo cesto di droga). A tirare per il baverol’anima più “fricchettona” della band e a riportarla
coi piedi per terra, una scrittura musicale senza
sbavature unita a un perfezionismo che coinvolge
ogni aspetto: dagli automatismi tra gli strumenti
a liriche che non ne vogliono sapere di spendersi
in inutili in florescenze. Particolari che la dicono
lunga sulla serietà “professionale” di questi “marchigianacci” un po’ scapestrati.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
Level - Opale (Spekk, Ago 2008)
G enere : elettronica minimale
C’è chi nel comporre non ci mette solo la testa
ma, anche il cuore, lo dicono apertamente gli
equilibri, gli assaporati momenti e le consapevolezze delle otto tracce di Opale neo uscita per
G.B.Nichols e la giapponese label Spekk.
Le prefazioni l’artista le aveva anticipate tra le
decostruzioni digitali di Cycla (dicembre 2006,
Spekk) trattate con assoluto minimalismo, adeguata attenzione alla lentezza, alla percezione
dello spazio e delle distanze, il tutto sottoposto a
quella personale maniera che ne cattura la materia e ne ibrida l’essenza.
Le intenzioni rimangono tali ma, non si lasciano
condizionare dalle manipolate e fratturate scritture care al disco precedente, per concentrarsi sulle
fonti sonore, trai marmorei loop di pianoforte di
Keith Berry e Linden Hale, le ambientazioni in
drones e le tracciate origini in campioni.Indulgono alla meditazione ed inseguono le nostalgie
i quarantasette minuti di Opale attingendo alla
riuscita d’insieme a tratti dimenticandosi della
singolarità in traccia senza temere confronto con
66
/ recensioni
le eleganti gesta di William Basinski, l’arte minimale e digitale di Taylor Deupree o la profondità
zen di Kenneth Kirschner.
Se si è amanti delle scene sottili, legati al riduzionismo o ai suoni fissati e considerando inoltre la
preziosa cura non solo nei contenuti ma, anche
nel contenitore; non c’è niente da fare ne rimarrete catturati!(7.3/10)
Sara Bracco
Lily Allen - It’s Not Me, It’s You (EMI,
Feb 2009)
G enere : synth pop dance
Dopo l’acclamato MarkRonson, Lily Allen
si affida, per la produzione del secondo album,
a Greg Kurstin, già presente in alcuni pezzi
dell’esordio Alright,Still del 2007. Siamo dalle parti di un dance pop Ottanta virato erivisto
Air, con il consueto appealda bad girl londinese dei quartierialti e con tanto di esplicit lyrics al
seguito. Synth pop a volontà (Everyone’s at It),
melodie accattivanti e iperpop, accenni countryeggianti (Not Fair) e jazzati di maniera allagirl
group sixties (He Wasn’t There).Ma Lily non è
Amy Whinehouse o Adele e la sua voce piuttosto “normale”è sì funzionale alla produzione di
stampo teen white, ma non fa brillare più ditanto
il disco.
Qui sembra mancare una personalità decisa, un guizzoche renda il tutto personale. Siamo di fronte alla versione brit di certo teen pop
USA.(5.8/10)
Highlight
Hexlove - Pija Z Bogiem (Dreamsheep, Mar 2009)
G enere : psychedelia post - moderna
Ci sono artisti che sfuggono alle classificazioni e rifuggono dall’essere riconoscibili preferendo percorsi
musical-artistici trasversali e misteriosi. Zac Nelson
a.k.a. Hexlove fa indubbiamente parte di questa categoria. Autore di una serie di dischi per etichette come
Holy Mountain e Temporary Residence sia in solitario
come Hexlove che con altri progetti come Prints e
Who’s Your Favorite Son, God?, Nelson sembra
essersi ormai stabilizzato con l’attuale moniker. Ciononostante, Nelson ama confondere ulteriormente le acque con altri aka come Faulouah, col quale aveva prodotto lo scorso anno un doppio vinile split, in pratica con se
stesso, sdoppiandosi tra i due moniker. Questo doppio Pija Z Bogiem vede la luce
per Dreamsheep, etichetta di un altro personaggio trasversale e al limite del geniale,
Valerio Cosi che i lettori di SA ormai dovrebbero conoscere abbastanza bene. E
proprio come Cosi, seppur in ambiti stilistici diversi, Hexlove dimostra maturità invidiabile nella commistione di generi e stili, con un approccio realmente personale e
sviluppando un muoversi spastico, al limite dell’autistico tra input diversi e variegati.
Quelle di Hexlove sono pop-songs, ma non ortodosse, bislacche, post-moderne, testimonianza di un universo musicale in perenne e irrefrenabile espansione. Prendete
Herb come pietra di paragone per l’intero album: french sound a la Air + Spacemen
3 + svisate drum&bass in continua accelerazione/decelerazione che si protrae per
15 minuti, inducendo ad una sorta di trance mutante, metà psych-folk, metà electrodigitale. Gran bel disco. Di quelli che uno si aspetterebbe nelle classifiche di fine
anno se solo ci fosse ancora la voglia e il tempo – in tempi di sovraffollamento musicale – per “rischiare” un ascolto impegnativo. Noi abbiamo rischiato senza pentirci
assolutamente.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Teresa Greco
Lotus Plaza - The Floodlight Collec
tive (Kranky, Mar 2009)
Genere: shoegaze
I Lotus Plaza sono emanazione dei Deerhunter, dato che dietro al moniker non c’è altri che
ilchitarrista del combo di Atlanta, Lockett Pundt.
Detto questo, ovvio modo diprocedere è di confrontarsi con il gruppo “maggiore”; anche perché
(come per Atlas Sound) non si tratta di una fuga
dalla ragione sociale che ha dato fama e gloria
a Pundt e compagni, ma di unprogetto che anzi
comprende anche in un brano (Different Mirrors) la “fatica” batteristica diBradford Cox e il
missaggio di Brian Foote.
La cosa principale da dire è allora che il confronto con i Deerhunter non esprime per nulla una
discontinuità; valga all’ennesima potenza ciò che
fudetto per Microcastle – e che del resto si era
detto anche in precedenza, con anticipo obiettivo, riguardo alle reminiscenze primi Ride; dietro The Floodlight Collective c’è tantosuono
4AD e tantissimo shoegaze, virato spesso dreampop. Alcuni episodi (Quicksand) sono mimetici ai
recensioni /
67
liturgismi Galaxy 500 – magari sciolti in ulteriore bambagia, altri mescolano le ambientazioni
acquose e sbiadite dello shoegaze più dolci con
i maturi Spacemen3. Meglio quando si spinge
fino in fondo l’opzione trip (These Yeasr); comunque i nomi erano e rimangono sempre i soliti.
Ora: lo shoegaze secondo chi scrive non è probabilmente mai rinato. Non almeno così come si
suonava quindici anni fa. Rimane il fatto che lo
si possa fare bene o male; per quanto un giudizio
cosìsia tagliato con l’accetta, rimane da segnalare
che Pundt sa fare il suo mestiere. Perché è evidente che sia un mestiere.(6.5/10)
Gaspare Caliri
Low Frequency In Stereo (the) - Futuro (Rune Grammofon, Mar 2009)
Genere: post rock
Possiamo anche sbagliarci, ma pare alla Rune
Grammofon, di recente, pensino più ad ingrassare
il catalogo chealtro. The Low Frequency In Stereo è uncombo post-rock (esiste ancora?!) all’europea, come dei Deus dalle fattezzekraute. Futuro (mai titolo fu più inappropriato) sciorina ossute
trame tra jazz e rock (Turnpike) che si perdono in
spirali psichedeliche (Mt. Pinatubo) e digressioni
pop (se Geordie la Forge e The End is the End
richiamano la cricca di Barman come Stereolab,
Sparkle Drive rischia la querela dai Blonde Redhead) senza pertanto colpo ferire. Enfatica la
chiusa, forte di una Solar System che sembra farina dei primiVerve quando amavano perdersi in
jam furibonde. Dischi come questo ci rammentano l’inesorabile scorrere degli anni.(6/10)
Gianni Avella
Luca Carboni - Musiche Ribelli (RCA,
Gen 2009)
Genere: cantautorato pop
Luca Carboni è uno di quelli che non è uscito
vivo dagli anni ottanta, dove quei suoi disarmanti minimi termini - la fragilità frugale e fiera da
fratellino introverso di Vasco Rossi, il disfattismo
68
/ recensioni
intimista, quel background di periferia alla stregua di un universo auto-referenziale, come una
cameretta con vista su un mondo che accelerava
ostico e imprendibile - avevano un senso preciso di contrappasso rispetto ai clamori tossici, agli
azzardi sintetici, alle sarabande patinate e ai sempre più confusi spaesamenti poetici che giravano
intorno.
L’impatto coi novanta però fu letale: il sarcasmo
ad alzo zero di Ci vuole un fisico bestiale (in Carboni, correva il ‘92, ultimo lavoro bagnato da un
considerevole successo) mise a nudo i limiti di un
autore sperso che tenta la carta del sarcasmo finendo per sguazzare nella accattivante mediocrità da tormentone sotto vuoto. Per quel che mi
riguarda, mi piace identificare la resa definitiva
con l’imbarazzante Il mio cuore fa ciok, traccia
contenuta nel successivo Diario Carboni (1993).
Per non farla troppo lunga, più ne scriveva e
meno ne azzeccava. Spiazzato, senza appigli nella contemporaneità, senza mordente né senso,
fuori ruolo, fuori tempo.
Da allora la temperatura si è mantenuta appena
tiepida a suon di live, raccolte e qualche collaborazione più o meno opportuna (da Pino Daniele a Tiziano Ferro passando per Jovanotti). Ecco
quindi che uscire con un album di cover a tema,
il qui presente Musiche ribelli, sembra una via
d’uscita più che plausibile.
Direi di più: naturale. E assieme una dichiarazione di alterità, visti i titoli scelti: materiale anni
settanta di area cantautoriale - De Gregori, Guccini, Bertoli, Jannacci, Finardi, Bennato, Dalla,
Lolli, Battiato - dal piglio poeticamente engagée,
che la voce chioccia e stropicciata del Nostro fa
sembrare altrettanti soliloqui nostalgici, demarcazioni territoriali più che messaggi nella bottiglia da un’epoca più consapevole. Altrettanto opportuna anzi armonica la scelta di un producer
come Riccardo Sinigallia, che pur limitandosi a
fare il compito con garbo e senza azzardi aggiorna e non di poco il verbo sonico del Carboni (ne
aveva un bisogno disperato). Non possiamo non rendere merito alla scelta di
un pezzo come Ho visto anche degli zingari felici
(in duetto col Sinigallia) quale singolo apripista,
atto meritevole e coraggioso visti i chiari di luna.
Ma è pur vero che, in ragione di tutte le premesse
suddette, la pallottola si rivela piuttosto spuntata.(5.8/10)
Stefano Solventi
Lucio Capece/Mika Vainio - Trahnie
(Editions Mego, Feb 2009)
G enere : elettronica ambient
è proprio vero che i poli opposti si attraggono: è
il caso di Luca Capece e Mika Vainio e della loro
recente collaborazione per Editions Mego.
Se le identità si muovono stilisticamente su territori diversi e la tecnica spazia dall’indiscussa
intelligenza elettronica di Mika
Vainio alle improvvisazioni e
le scritture jazz
di Luca Capece,
l’intenzione
si
intuisce comune.
In fondo i punti
d’incontro si trovano: basta volerlo o basta, come in questo caso, avere piena
coscienza della materia e della tecnica sonora e se
a questo ci sommiamo la naturale voglia di sperimentazioni, ecco che gli orizzonti si allargano tra
geometrie d’intensa e incisiva identità.
Le discipline di Trahnie si fondono tra soavità ed
estremismi, ne sono un esempio i passaggi forzati
di Escapes, dalle ruvide superfici e graffianti ferite
aperte che si scontrano nei fondali elettronici in
texture, o volutamente cedono il posto alle battaglie di Valontuo, in soffocati scontri di superficie
di vivida presenza.
Lo dichiaravano già l’apparente quiete dell’apertura Ujellus, lo confermavano (Juurake) le robotiche in beats tra interferenze elettroniche ed acu-
stiche.Affinità, si diceva, materie che si plasmano
l’una con l’altra, in questo caso prendendo le
sembianza del primo Vainio - si ascoltino anche i
sette minuti in drones di Hondonada.
Ci sono poi le violenze di Sahalaitainen, i battiti di Tolmavuo, le dualità atmosferiche di Sigilio
o infine le chiusure in malinconie elettrificate di
(Manana).
Che siano lacrime o sangue, l’intensa vibrante
attenzione al suono e alla percezione colpisce e
lascia il segno.(7/10)
Sara Bracco
Lukid - Foma (Werk Discs, Gen 2009)
G enere : W onky E lectro -H op
Luke Blair è il ragazzo prodigio della Werk, l’erede dell’IDM trasfigurata dal wonky. Il suo secondo lavoro prende le mosse dalla tradizione mesh
di Prefuse 73, Flying Lotus e Dabrye, approdando
in una terra fatta di visioni post-hip-hop e di ibridi electro. Insomma, la svolta che tutto il popolo
dell’elettronica attendeva. Ma anche qui (come
nel disco dell’amico Actress) ci si fionda sul pompaggio artificiale e gommoso del basso. E quindi
la connessione con il brekbit non può mancare.
Gli ingredienti della black street music mescolati perfettamente con la generazione che ha fatto
della Warp un simbolo.
E che quindi ha nelle orecchie un’estetica musicale oggi un po’ manieristica, fatta principalmente di/con taglia e cuci. Questa la nuova aria che
si respira dalle parti di Londra: i loop deeppissimi
di Slow Hand Slap (citazione ancora obbligata ai
Boards Of Canada), il richiamo al dubstep nei
beat superbassi di Chord e l’ambient in trip cosmico-hop (che ricorda guardacaso le astrazioni
di DJ Krush) di Ski Fly. Il downtempo di chi ha le carte giuste per sfondare. Il disco della maturità sia per l’artista che per
l’etichetta. Sempre e solo London, sempre e solo
stile. Werk rulez.(7.2/10)
Marco Braggion
recensioni /
69
Madlib - Beat Konducta Vol. 5-6
(Stones Throw, Feb 2009)
G enere : hip - hop / bl ack
Dopo aver fatto il gioco del produttore nascostodietro alla presunta faccia di dj, ora Madlib pare
volere fare viceversa e fa l’MC punto e basta. Ma
questo disco non puòessere letto nella sola ottica
della storia di Otis Jackson Jr. E difficilmente poteva essere diversamente, dato che i capitoli 5 e 6 della serie BeatKonducta sono in realtà un tributo
a James “J Dilla” Yancey – o Jay Dee,scomparso
tre anni fa, considerato dal produttore black della
Stones Throw comeil “Coltrane del
Beat”, e in generale da alcuni citato
come il miglior
beat-makerdi sempre. In effetti la figura ormai passata a mito dell’MC
di Detroit ben sisovrappone a Madlib; non solo perché la professione di entrambi è una e trina -dj, produttori ed
MC insieme; ma perché a unirli c’è l’amore per il
beat, leforme brevi e i cambiamenti repentini; e
sopra ogni altra cosa la capacità difar pulsare nel
hip-hop il funk e il soul dei ’60 e ’70.
La solarità di J Dilla è sì filtrata dal magone della
suarecente mancanza, ma tenuta intatta, in una
“gioia nostalgica”; in questoMadlib è bravo; trova
episodi di hip-hop Novanta e li associa mirabilmente allastruggenza di pezzi di decine d’anni addietro; il suo ormai noto gioco deilivelli ci fa sentire
trascinati nella meravigliosa No More Time? (The
Change), per poi disconnetterci con una risatasguaiata e sfumare dentro un altro suono di calda
anima, quello di Do You Know (Transition); e lì
Otis usaun escamotage che ha un antenato iperillustre, con la sua operazione geniale;si tratta di
quella You’re Nogood cheTerry Riley trattò nel
1968 come nastro su cui fare i propri esperimenti
(e divertissements?) minimalisti; qui Madlib tratta
70
/ recensioni
l’inizio del brano come una falsa partenza, comeloop minimalista. Ma è solo uno dei giochi delle
emergenze – cioè delle coseche emergono e poi
tornano 10000 leghe sotto il mare della California
- e deilivelli cui Madlib ci ha abituato.
C’è poi un’altra cosa che Madlib sa fare benissimo; è produttore dentro;ma non solo produttore
di un disco, cioè persona che sta dietro la stanza deibottoni di un uscita discografica; Madlib
calibra le sue azioni da produttoredi una intera
scena, di un mondo, quello della black music. E
in mezzo a tuttigli altri tributi a Jay Dee, questo
forse è meno dettato dal calore umano, ma più
dal flusso catalogatorio ed enciclopedico del beat
konducta.(7/10)
Gaspare Caliri
Matteo Uggeri/Alessandro Calbucci - The Distance (Why Not Ltd, Mar
2009)
G enere : drone
È etimologicamente la distanza il centro nevralgico di questo lavoro tra due dei più prolifici
musicisti dell’underground italiano.Distanza stilistica, in primis, nonostante un sentire comune.
L’uno (Calbucci),di matrice rock, già batterista/
chitarrista per Sedia, From Hands, End OfSummer; l’altro (Uggeri), artista prevalentemente
“sperimentale”, dedito ad un lavoro di ricerca su
field recordings ed elettronica deforme con Hue,
Sparkle In Grey e mille altri nomi/collaborazioni
ancora. Ma anche distanza fisica, geografica tra i
due, colmatanella miglior tradizione dei lavori a
distanza con l’interazione per via telematica. The
Distance è un lavoro che si snoda su 4 tracce per
40 minuti didroning ambientale, nato da inediti
field recordings binaurali di Uggeri sui quali Calbucci ha lavorato di cesello, smontando e rimontando quegli input e aggiungendovi set di guitarloops e drones in modalità impro. Il risultato è
una sorta di suite in più movimenti in cui screzi
e graffi, sbuffi e strappi si stratificano sulle maree
di droning mai eccessivamente cupe, creando un
coinvolgente senso di dilatazione mantrica alquale, volenti o nolenti, si finisce col cedere. Pubblica,
tanto per ribadire il concetto di distanza, una minuscola etichetta di Singapore, la Why Not Ltd,
sussidiaria della più nota Herbal.(6.7/10)
Stefano Pifferi
Mirah - (a)spera (K Records, Mar
2009)
G enere : indie folk
Lasciate le vicissitudini degli insetti nel capitolo
insieme agli Spectratone International di un paio
d’anni fa, la nostra torna a parlare di relazioni
personali, direttamente, con quella caratteristica
tutta particolare che fa sembrare che stia parlando
solo a/per te. Il fidato Phil Elverum è ancora in
regia e supervisiona partecipando attivamente a
3 tracce, e questo è un bene dato che la sua mano
si sente, e come era stato in C’mon Miracle aumenta le potenzialità atmosferiche delle melodie
cristalline di Mirah. A differenza di quel passato/picco illustre però la chiave di lettura questa
volta non risiede
nell’uso fibrillante
della batteria e degli archi: la voce si
riappropria della
propria centralità
anche attraverso
controcanti azzeccati – come a manifestare un rafforzato interesse affinchè il messaggio arrivi – mentre l’esperimento “world” di
Share This Place ha lasciato la voglia di usare
una strumentazione “multietnica” anche in questo capitolo. Quello che porterebbe a pensare che
(a)spera sia una mera somma di elementi dei
precedenti due dischi citati, si scopre errato – in
parte – nel constatare che la quadratura delle
canzoni è dovuta principalmente a giochi di luce
e a incontri di atmosfere diverse che non alla caratura della scrittura, che ahimè questa volta è
leggermente sottotono rispetto ai suoi standard.
C’è sicuramente un senso di intimità più matura
in queste nuove tracce, intimità che esplode nei
soli di kora in Shells, che si rende meravigliosamente dark in The World Is Falling (decisamente
lo “strike-out” del disco), che si fa preziosa nella
kalimba di While We Have The Sun o che si tramuta in delicatezza accennata nel violino e nel
violoncello di Generosity. Al contempo si ha la
sensazione che l’autrice di Portland abbia azzardato un po’ troppo come nella samba fuori fuoco
di Country Of The Future, nei quasi 8 minuti
della mielosa e sfiancante The River, o in Bones
& Skin che, è semplicemente una nuova Monument non altrettanto toccante. Si avverte la voglia di evolvere, e spesso il passo in più si coglie
chiaramente ma la differenza rispetto a quanto
proposto finora sta semplicemente nella forza
delle canzoni che, ben lungi dall’essere mediocri,
purtroppo non hanno lo stesso impatto – a breve
e lunga gittata – rispetto a quanto fatto finora.
Poco importa alla fine che la lista degli ospiti includa Tara Jane O’neil, Chris Funk dei
Decemberists, Tucker Martine (batterista di
Laura Veirs) o Adam Selzer dei Norfolk &
Western.(6.8/10)
Alessandro Grassi
Miss Kittin And The Hacker - Two (Nobody’s Bizzness, Apr 2009)
G enere : M inimal D eep 80
Ritorna il duo che ci ha fatto percepire la minimal
con l’anima retrò ereditata dagli 80. Lui il produttore, lei la diva. Se le prove soliste della gattina
non ci entusiasmano più -come quando narrava
le sue scorribande tardoadolescenziali dagli studi di Radio Caroline, qui la liason si ricongiunge e per un attimo sentiamo ancora quei brividi,
quella consapevolezza di essere l’incarnazione di
un’estetica che ha segnato con una lunghissima
scossa tutto il mondo electro.
Non ci sono più i singoloni à la Frank Sinatra, ma
c’è ancora voglia di stare sul battito e sul pezzo. Le
voci di Miss Kittin spazializzate come il buon Giorrecensioni /
71
Highlight
Les Fauves - N.A.L.T. 2 Liquid Modernity (Urtovox, Mar 2009)
G enere : avant pop
Tanto ci avvinse e convinse N.A.L.T. 1 da farci quasi
scordare che trattavasi del primo capitolo d’una trilogia dedicata alle “luci ed ombre del comportamento
alieno” (sic!). Se quella era una “fast introduction”, il
sottotitolo di questo atto secondo recita Liquid Modernity, citando un testo del filosofo e sociologo polacco
Zygmunt Bauman, severo critico della societa dei consumi. Insomma, sticazzi: questi quattro buontemponi
da Sassuolo confermano di voler subdolamente fare
sul serio, brandendo con piglio agro la lama dell’ironia
e del nonsense però corroborata da un arsenale sonico - è il caso di dire - esplosivo.
Il dadaismo psych-wave delle prove precedenti cede il passo ad un bailamme di espedienti sintetici, sgassate acide, fregole zappiane, estri caraibici, singulti afro e svenevolezze visionarie che è un piacere. Il tutto senza venir meno all’imperativo categorico
della potabilità, che occhieggia e riaffiora malgrado la stralunatezza degli ordigni.
Canzoni informate perlopiù al lirismo sciroccato e febbrile di un Robyn Hitchcok,
ora rotolato nella camera dei giochi neo-pop Flaming Lips (il tango caramelloso di
Drops Drops Drops, la paonazza Everlasting Soup), ora strattonato da robotico turgore Stranglers (nel soave disincanto para-prog di Death Of The Pollo), ora impantanato in lisergica cremosità Beach Boys (Snow In Trinidad And Tobago). Altrove
t’imbatti in una Funeral Party che è semplicemente il pezzo pop (battente, ebbro,
asprigno, scentrato) che sempre si augurano i fan di Wayne Coyne, mentre in Berolina Party Suite t’immagini i Wire morsi dal morbo tribal-funk, così come Lagos si fa
stralunare da fregole Zappa, spasmi Byrne e devoluzioni... Devo. Potrei aggiungere
dell’obliqua apprensione di Keep Living In A Subway, non distante dallo spirito di
certi Clash però avvolti in una nube Mercury Rev, o del funky strinito tra vampe di
tromba e aciderie d’organi e chitarre di Pitslicker (su cui sospetti scendere dall’alto
una benedizione P.I.L.), ma son certo che già vi sarete fatti un’idea. La mia è quella
di una band che ha messo la freccia e si sta portando sulla corsia di sorpasso. Il momento di salirci sopra è adesso. (7.6/10)
Stefano Solventi
gio Moroder ci ha insegnato (Party In My Head), le
pomposità dei primi Depeche Mode (Indulgence),
le cavalcate cosmiche à la Lindstrøm (Emotional
Interlude) e le atmosfere dark/melo che guardano
72
/ recensioni
alla deep (il singolone 1000 Dreams è il marchio
di fabbrica del buon Michel Amato): questi gli ingredienti di un disco che non può stupire, ma che
tutto sommato non delude. Senza spocchia, i due
alfieri della minimal ci credono ancora. Noi un po’
meno, ma lo stile non si perde così su due piedi.
1000 di questi sogni, beyond the Ray Ban.(6/10)
Marco Braggion
zione di McClure, che esprime l’intenzionedi collaborare presto col presidente del Venezuela Hugo
Chavez. D’improvviso, tutto è chiaro come il sole.
(4.5/10)
Giancarlo Turra
Mongrel - Better Than Heavy (Wall
Of Sound, Feb 2009)
G enere : indie cros sover
Esistono casi in cui l’epocale “don’t believe the
hype” dei Public Enemy pare fatto apposta e dunque andrebbe imposto a mo’ di decreto legge.
Mettetevi comodi: i Mongrel sono un -uh - supergruppo allestito nel 2008dall’ex bassista degli Arctic Monkeys Andy Nicolson insieme al compagno
dimerende Matt Helders, a un ex Babyshambles e
un tizio proveniente dai carneadiassoluti Reverend
& The Makers. Insieme a loro c’è pure Lowkey dei
PoisonousPoets a snocciolare rime. Non quel che
definisci un parterre d’eccezione,insomma, ma
qualsiasi attesa su cosa potesse mai sortirne è stata prontamentemessa al tappeto dal risultato. Una
sorta di confuso e pasticciato coacervo tra indie,
funk e hip-hop, bagnatonel pop però gravato da
arrangiamenti discutibili, forzature e velleitàassortite. Fate conto i Supersystem in crisi di ipoglicemia (Barcode), una versione liofilizzata deiGorillaz
(Lies, il singolo The Menace.) oppure dei Cornershop conospite Elvis Costello (Julian).
O,ancora, il cartonato degli Hot Chip, sottile che
basta una spintarella e già è perterra a prendere
polvere. Ci provano, i cinque, a dare una verniciata a ideeche sono già vecchie in partenza se concepite con un occhio al NME e l’altroalla saccoccia
(perché, visti gli odierni chiari di luna, c’è il rischio
chequesta roba finisca in classifica, quantomeno
oltremanica.) Non basta gettare nelcalderone il
rap “made in UK” se le chitarrone fanno ridere,
la laccatura dub altrettantoe s’inciampa in pedestri
orientalismi; va a finire che le melodie annaspanoscontate e all’operazione non manca solo il senso
dell’ironia, della misura e della storia ma il senso
tout court.
Cerco notizie in rete e mi imbatto in una dichiara-
Mountains - Choral (Thrill Jockey,
Mar 2009)
G enere : ambient
I Mountains, duocostituito da Koen Holtkamp
e Brendon Anderegg, approdano su Thrill Jokey conquesto che è il loro terzo disco. Questo
significa necessariamente una maggiore visibilità
ancorché pur sempre con cifre che continuano a
rimanere ridicole. Vada se però, che accompagnandosi al debutto di Koltkamp distribuito pochi
mesifa da Type, tutto assume contorni un po’ più
spessi. La musica che i Mountainspropongono è
una tipica tintura ambient con riflessi cosmici mista ad una forma molto umana e molto canonica
di chitarre folk. Le composizioni più informalisono costituite soprattutto da layers di droni immaginati come onde che simuovono incessantemente, da qui la mareggiata cosmica dell’inaugurale
Choral o l’estasi molto prossima a certi Stars Of
The Lid di Melodica.Il lato più umano e folk si
affaccia in composizioni che nascono evidentementecon gli elegiaci arpeggi di chitarra acustica,
vedi Map Table o Telescope.L’episodio più interessante sembra quindi quello che meglio riesce
a far convivere le due anime del disco, quando
in Add Infity una cascata di arpeggi e un tappeto
di droni paradisiaci disegnano una parabola non
troppo distante da certi Popol Vuh.(6/10)
Antonello Comunale
Mulatu Astatke/Heliocentrics (The)
- Inspiration Information (Strut
Records, Apr 2009)
G enere : A fro J azz
Abbiamo dovuto attendere ma la nostra pazienza è stata infine ripagata con gli interessi. Serviva Talento in condizioni di forma superiori alla
recensioni /
73
media e così il terzo volume della collana Inspiration Information è botto eclatante di un 2009 sin
qui anemico. Sorprende ascoltare un classe 1943
come Astatke - pianista leggendario, padre del
jazz etiopico - entrare in perfetta simbiosi con gli
Heliocentrics, il cui Out There ci impressionò due
anni or sono e che qui si ritagliano un ruolo solo
apparentemente defilato. Discreti, lavorano di
cesello e passione impedendo lungaggini e conservando immediatezza; conferiscono una lieve
modernità retrofuturista e, in un reale scambio,
guadagnano in compattezza. Smaltito l’impatto iniziale, a mente serena ci sovviene che - giusto per dire: il curriculum completo riempirebbe
pagine e pagine
- Mulatu è stato il
primo africano a
frequentare il prestigioso
Berklee
College Of Music,
che ha lavorato
con Duke Ellington (si sente, oh sì) ed è produttore apprezzato.
Le sue orecchie sono da sempre pronte a recepire mantenendo saldo il cordone ombelicale che lo
lega alla madre Africa, ed è solo dialogando con
presente e passato, tradizione e modernità che
oggi si possono partorire dischi belli e destinati
a durare. Tale è la cifra di quest’ora abbondante
fatta di suggestioni orchestrali e tasti jazz, fanfare
spagnoleggianti e archi disco, ritmi moderni ma
ancestrali. È funk avvampante alla Isaac Hayes
Addis Black Widow, pure potrebbe appartenere al
Dj Shadow di Entroducing e nessuno avrebbe a
ridire; Mulatu riserva lo stesso trattamento alla fissità di James Brown riportandola alle origini;
Blue Nile sparge nello spazio sensualità trapunta
d’ottoni e una chitarra tra Bristol e blues. Esketa
Dance ondeggia ubriaca però groovy come Mingus non poteva essere per questioni cronologiche
e Chinese New Year ne aggiorna la grammatica tra
corde di contrabbasso e violino. Chick Chikka, De74
/ recensioni
wel e Live From Tigre Lounge giostrano stordenti e
(im)possibili natali tra Caraibi, jungla e jazz intellettuale newyorchese. Non c’è un minuto in cui
alla partecipazione emotiva subentri l’autocompiacimento: neppure dove le partiture toccano
la classica per incastrarvi un lucido senso della
tecnologia (Phantom Of The Panther). Verrebbe da
citarli tutti, i quattordici brani di questo cd superbo per come fonde - senza sforzo: il trucco sta
esattamente lì - opposti in teoria inconciliabili.
Astrale e terrigno, fisico e cerebrale, primordiale
e futuribile, possiede le doti di ogni Grande disco.(8/10)
Giancarlo Turra
Neko Case - Middle Cyclone (ANTI-,
Mar 2009)
G enere : folk pop
Ok, di attrattive questo sesto lavoro da solista della bella canadese ne possiede a bizzeffe. A partire dall’autrice, ovvio, che in copertina appare
più battagliera che mai, splendida quasi-quarantenne in posa da pin-up tarantiniana sul cofano
di una ruggente Mercury Cougar anni settanta.
Poi c’è una ragguardevole lista di ospiti-amici che
elargiscono il loro essenziale contributo senza invadere la scena, membri di Calexico e Los Lobos,
Giant Sand e - naturalmente - New Pornographers, l’ormai grande M. Ward ed il leggendario
Garth Hudson. Come resistere poi al fascino di
questa voce che riverbera miraggi fifties, languori
country e iperboli psych con la grazia maliosa ed
esoterica di una sirena posterizzata?
Però almeno altre due armi di seduzione si aggiungono in faretra, scombinandone il centro di
gravità: l’impegno animalista/ambientalista su
cui galleggiano le tracce suggerendo punti di vista
particolari per la dimensione umana, e una netta maturazione della scrittura - del resto già accennata in Fox Confessor Brings The Flood - che
smorza lo slancio vitalistico prediligendo scorci
inquieti e palpitanti, con particolare attenzione
agli “ambienti” sonori (vedi l’inafferrabile esoti-
smo di Polar Nettles, le brume d’archi della titile
track, il rag rurale - non lontano dalle nostalgie
auree di Neil Young altezza Harvest Moon - di
Don’t Forget Me, tra l’altro cover di Harry Nilsson). E la voce, quella voce, s’accoda, s’adegua,
si presta al gioco con fiera postura, cova subbugli
vellutati (in Magpie To The Morning, in Vengeance Is Sleeping) e assalti jingle a denti scoperti (il
singolo People Got A Lotta Nerve), confrontandosi senza tema con retaggi Motown in Red Tide
e con l’epica tra il franco e il retorico di Never
Turn Your Back On Mother Earth (un pezzo del
‘74 a firma Sparks).
Un album non eclatante ma intenso, battagliero, appassionato, senza cadute degne di rilievo.
Ti amiamo come si può amare un tornado, Mrs
Case.(7.2/10)
Stefano Solventi
Pack AD (The) - Funeral Mixtape (Mint,
Mar 2009)
G enere : R aw B lues
Il problema, a costo di suonare noiosi, è sempre ilsolito: la democrazia tecnologica ci ha reso la vita
un mezzo inferno. Nel senso che siamo sommersi
da una marea d’uscite discografiche ormai fuoricontrollo, nella quale è un autentico miracolo se
- artisticamente parlando -qualcosa più della cresta dell’onda sopravvivrà per la gioia dei posteri.
Troppidischi e per la maggior parte insignificanti,
inutili: roba che un tempo non avrebbe mai visto
la luce grazie al darwinismo musicale. Due decenni fa, verosimilmente, il secondo disco delle
canadese Pack AD sarebberestato quel che è: un
demo inviato a qualche etichetta e da questa lasciatonel dimenticatoio. Perché sono volenterose,
Becky Black e Maya Miller, ma di coppie chitarra/batteria/voce alle prese con un ruvido blues
corteggiante l’hard ce ne sono in giro di assai più
capaci e non da ieri. Perché la manoesecutiva
pesante ci può stare ma i suoni opachi e metallici
no; perché lascrittura latita e la deferenza ai modelli diventa di conseguenza schiacciante; perché
non basta volere essere una versione garagista
di P.J. Harvey o Chrissie Hynde: bisogna anche
potere. Ad eccezione delle passabili Dannemora
Blues e Worried, di Funeral Mixtapealla fine non
resta in testa nulla, per la semplice ragione che le
Nostre non possiedono né la penna né l’abilità a
variare la formula che rendono White Stripes e
Black Keys quel che sono. Ovvero, gente capace
di lasciare il segno(6.6/10)
Giancarlo Turra
Pan American - White Bird Release
(Kranky, Feb 2009)
G enere : ambient
Ormai Mark Nelson viene trattato con la stessa
deferenza accompagnata da affetto che si concede ainonni. A ragion veduta probabilmente.
Lui c’era e faceva quello di cui oggi siabusa, in
un’epoca che sembra ormai lontanissima. Dopo
tutto ha contribuito molto anche lui
alla formazione e
standardizzazione
del suono Kranky.
Ma in fin dei conti, senza andare ad
indagare influenze
su influenze, si potrebbe semplicemente sentenziare che quando un’artista supera
per più di due o tre volte la generale mediocrità in
cui sembra condannato il suono contemporaneoallora val sempre la pena cominciare ad erigere
monumenti quando ancora si è invita. Del resto
la prospettiva del sesto disco a nome Pan American è quella di uno zibaldone riveduto e corretto
di tutte le puntate precedenti. La consueta egenerale atmosfera soft, ovattata e morbida, come se si
stesse sprofondati in una poltrona e tutti i rumori
del mondo esterno arrivassero dalla finestra come
ritardati da una distanza siderale. WhiteBird
Release è quindi una raccolta di nove storie che
nonno Nelson siconcede di raccontarci. Alla sua
recensioni /
75
maniera ovviamente. Quindi con i suoi tempi…
rallentati, i suoi suoni… espansi e attutiti, quella
voce… sottovoce che quando appare (There Can
Be No Thought Of Finishing, Both Literally AndFiguratively) lo fa sembrare come un Leonard
Cohen di una qualche nuova epoca biomeccanica. La rilassatezza non necessariamente porta al
disimpegno e se proprio dobbiamo trovare una
vena evolutiva in questo lavoro è nelle rifiniture
ansiose che tramutano le andature più dub nel
passato in corridoielettro dall’umore angosciato
(How MuchProgress One Makes, In A Letter To
H.G. Wells, 1932). A conti fatti l’ennesimo bel disco di Nelson anche se il suo, ormai, sembra un
canone difficilmente superabile.(7/10)
Antonello Comunale
Prefuse 73 - Everything She Touched
Turned Ampexian (Warp Records,
Apr 2009)
Genere: Brekbit Mesh-hop
Manco a farlo apposta, parli di brekbit e la Warp
ti sputa fuori pure il disco nuovo di Guillelmo
Scott Herren. Uno che ha scardinato l’hip-hop
assieme a Dälek, Dabrye, Cannibal Ox e una
congrega di altre menti che tempo fa gravitavano
su Anticon, ma che oggi riprendono la parola dal
pulpito della casa madre con la W maiuscola. Il
titolo poi ci riporta all’analogico. Quel tocco à la
Re Mida che riscopre il sapore dello sporco e che
solo su nastro Ampex può consacrare la sua natura frammentaria.
In effetti il nostro
uomo sin dagli
esordi ci ha proposto la sua personale
visione del brekbit,
distante dall’ardkore e più vicina
allo street hop. Il
suo modo di comporre, distaccato dal mainstream e sempre con
un tocco di visionarietà poshy, si congiunge oggi
76
/ recensioni
di prepotenza a tutto quello che sta succedendo
nel mondo dell’electro ‘allargata’. Tanto per fare
due nomi: Animal Collective e MGMT.
Che questo scazzo consapevole sia una delle possibili tendenze è ormai confermato da critici e
guru. Ma che uno come Prefuse 73 ci consegni
un patchwork così fresco e pieno di ‘warpgeist’
a noi sembra stupefacente. La sperimentazione
cui ci ha abituato si congiunge con il ritmo street-based e conferisce uno status nuovo a quella
che chiamiamo forse impropriamente ambient.
Va bene che siamo abituati al miscuglio di pezzi da fonti disparate. Ma costruire poco meno di
50 minuti di sonorizzazione che contenga lounge
(Regato), funky (Four Reels Collide), raga-acidstep (Violent Bathroom Exchange), vocal IDM
(Simple Loop Choir), 8bitness (No Lights Still
Rock) e tanto altro è un gioco per gente dura.Un
vocabolario postmoderno che insiste sul basso.
La battuta di questo 2009 è scolpita sul breakbit
che si fonde con l’hip-hop evoluto. E questo album ne è la consacrazione. L’illbient di Spooky
e DJ Olive si connette con i ragazzini smanettoni
del 92. Il risultato è un disco che apre nuovi orizzonti e che ci fa respirare aria fresca, rispettando
l’eredità della blackness slowtempo. Un viaggio,
un trip che ha in sè del profetico. Prefuse nuovo
santone.(7.3/10)
Marco Braggion
Rafael Toral - Space Elements Vol I
(Staubgold, Gen 2009)
G enere : avanguardie
Lasciate da parte le premesse di Violence of Discovery and Calmo of Acceptance, disco che si
dibatteva tra suoni analogici e le chitarre, Rafael
Toral dirige oltre la sua personale propensione
alla sperimentazione, attingendo alle naturali origini al suono ed arrivando a fondare un vero e
proprio neo-logos sonoro.
Un seguito a tratti dovuto, se si considerano le
naturali affinità dell’artista con la materia, dalle
sue macchine auto-costruite, passando per i suoi
molteplici approcci ai mezzi dell’improvvisazione
e dell’elettronica come veri e propri vocaboli a
cui spettano innegabili sentenze comunicative.
Istantaneo, fisico e viscerale, l’astrattismo di Space Elements Vol I, tutto giocato su approcci di
matrice elettroacustica e una ricercata assenza di
fondo, o meglio sarebbe dire, di forza di gravità.
A dominare è un tripolarismo che relaziona tempo, spazio e silenzio; gioca con i toni e gli accostamenti, di violoncelli, le modularità in frequenza e
drones I.I, su percussioni e intermittenze I-II.
Si riprende così velocemente contatto con una
materia sonora prima e di tale qualità da costringere immancabilmente l’ascoltatore a mettere in
discussione teoria e pratica del fare musicale ed
artistico!(7.5/10)
Sara Bracco
Reigns - The House On The Causeway
(Monotreme Records, Mar 2009)
G enere : electronic post rock
Sono in due, sono inglesie sono fratelli. Roo e
Tim Farthing. Come Reigns fanno musica già da
un po’ epossono vantarsi di aver collaborato con
gente come Pj Harvey e RobEllis. Questo è
il loro terzo disco, ma il primo a tutti gli effetti
di unanuova collaborazione con Monotreme, che
suppongo sia rimasta affascinata dallato elettronico cantautorale del duo. La musica qui proposta non si allontanamolto dalla prassi degli Arab
Strap anche se si calca di più la mano sullato
dark delle atmosfere e sul piglio rap dei recitati.
Tutto è un po’ confuso e inconcludente, oltre che
parecchio monotono.
I brani si trascinano stanchi vuoi per la lentezza media dei mid tempo generalizzati dei brani,
vuoi per il goffo accumulo di cliché e soluzioni
abusate: bassi cavernosi da Bristol triphop, chitarrine post rock da lacrima, timbro vocale da
3.00 del mattino, pianoforti struggenti e col cuore
in mano, goffi toni dark da comic book. Si salva
poco o niente.(5/10)
Antonello Comunale
Rinôçérôse - Futurinô (V2 Music,
Mar 2009)
G enere : F rench T ouch R ock
Justice sì, è da molto che li aspettiamo. I padrini
del french touch viaggiano per il mondo con le
loro croci e la loro pop-trasgressione. Nell’attesa
ritornano i Rinôçérôse. Loro che quasi quasi ce
li siamo dimenticati, l’anello di congiunzione fra
The Hacker e i galletti pre-Ed Banger, propongono una cosa che spinge verso il rock e lascia per
strada quelle casse bassissime che li avevano resi
un faro. La svolta estetica (e iconografica) sui binari del rock non sorprende, anzi a tratti annoia. Sì ci sono le chitarre in uptempo, le tastierine e
altri ingredienti che fanno molto Franz Ferdinand degli esordi. C’è anche qualcosa di progressivo e spacey (Mind City), il richiamo a Santogold
(Time Machine), il coretto à la Soulwax (The
Heroic Sculpture of “Rinôçérôse”), la ballad à la
Tellier (Week End Of Sin) e altri gingilli nu-rave.
In aggiunta i featuring da Infadels, Ride (l’unico
punto che scuote del disco è il fidgeting di Where
You From?), Go! Team e Deaf Stereo. Passabile
per i fan. Per gli altri, andatevi a recuperare i primi dischi di Patrice Carrié e Jean-Philippe Freu e
sentirete la differenza (5/10)
Marco Braggion
Robyn Hitchcock/The Venus 3 - Goodnight Oslo (Proper, Feb 2009)
G enere : psych rock
Robyn Hitchcockancora con i Venus 3 (Peter
Buck,Scott McCaughey e Bill Rieflin, come dire
R.E.M.e Minus 5 insieme) per un altro disco del
prolifico musicista inglese.
Suono elettrico in prevalenza americano e uso
difiati: Hitchcock questa volta si discosta un po’
dalla sua consueta misturapsych inglese a base di
Barrett e rock folk di matrice byrdsiana. Infatti
fannocapolino qua e là non consuete sonorità r’
n’ b (What You Is) e western (HurryFor The Sky e
Your Head Here, Up To Our Necks, quest’ultima
un omaggioa Bo Diddley e presente nellacolonrecensioni /
77
na sonora dell’ultimo film di JonathanDemme,
Rachel sta per sposarsi, film dove il musicista
fa un cameosuonando proprio questo pezzo. Non
manca comunque nell’album il folk di provenienza Byrds/ R.E.M. tipico di Hitch (16 Years), si
veda per esempio lapsichedelica title track, sospesa erarefatta, pezzo simbolo del Nostro e che non
poteva di certo mancare. In sostanza una conferma dell’amalgama con i Venus 3.(7/10)
Teresa Greco
Roses Kings Castles - Self Titled (The
Sycamore Club, Gen 2009)
G enere : pop
Ilquotidiano di Adam Ficek è scorticare i tamburi neiBabyshambles. Un compito che, a seconda dell’umore del
f ro n t - m a n d e l l a
band, Pete Doherty, potrebbe
rivelarsi eccitante o gravoso, ma
che fuor di dubbio gli permette
di portare a casa
la“pagnotta” senza grosse difficoltà.
Soddisfatti i bisogni primari e appurata un’eccedenza di tempo libero, il Nostro ha pensatobene di destinare qualche oretta al suo progetto
solista, - quiall’esordio – un’esperienza musicale
che, neanche a dirlo, è quanto di più lontano ci
si possa immaginare dallo stile dallaformazione
citata in apertura. Il che significa ventinove minutiessenzialmente acustici retti da un pastiche di
chitarra,piano, vibrafono, batteria, armonica, archi, capace di schiuderepassioni pop insospettabili. Qualcosa tra Belle & Sebastian,Kings Of
Convenience e certo pop sixties tutto archi e
cuori infranti, pacato nei tempi, easy nell’estetica,
vagamente jazzato nei colori, sospeso tra ottoni e
battiti di mani, con in più qualche particolare ritmico quasi esotico. Un’opera che fa della leggerezza e dell’appeal melodico i suoi punti di forza,
78
/ recensioni
che piace inmaniera ingenua, che non richiede
alcun sottotitolo, ma che pure non pretende di
essere ricordata negli anni a venire.(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Saint Four (The) - The Saint Four E.P.
(El Cortez, Mar 2009)
G enere : garage / alt . country
Maimescolare garage e blues, folk americano
e ballads struggenti, anarco-insurrezionalismo
Dream Syndacate e armoniche à la Dylan. Il
rischio è ubriacarsi senza quasi accorgersenecon
un cocktail mortaledi amplificatori valvolari e chitarre Gretsch, Rickenbacker e Vox. Chi la sente,
poi, la vostra ragazza il giorno dopo, quando ledite che non avete voglia di uscire perché siete in
pieno downpost-sbornia? Certo, se il gioco vale
la candela, come nelcaso di questi Saint Four, il
discorso cambia, dal momento che Parigi– venti
minuti spesi tra frontiera e accelerazioni elettroacustichetutte basso, chitarra e batteria – vale bene
una messa. Tanto piùse la nostra personale Parigi
è a un passo da casa. Nascostotra i crediti ritroviamo infatti Stiv Cantarelli, uno checerti suoni
yankee li frequentava già a fine millennio con iSatellite Inn, a infettare una The Country You Were
Born che richiama la Bob Dylan’s 115th Dream
e a biascicare dei BrianJonestown Massacre
sottoanfetamina in Disco Queen. Duebrani che
da soli giustificano l’esistenza di questo Ep - pubblicatodall’americana El Cortez - e che uniti a
Fades And Dies,Don’t Hang On Me e TheKiller
danno un’idea abbastanza chiara dell’ottima cifra artistica dei Saint Four.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Sight Below (The) - Glider (Ghostly
International, Mar 2009)
G enere : ambient techno
Alla sua seconda produzione (l’ep d’esordio, No
Place For Us, è in download gratuito sul sito della GhostlyInternational), Justin Toland aka The
Sight Below porta alle estreme - eoniriche - con-
seguenze le intenzioni di The Field, riallacciandosi, sotto forma idm, all’espressionismo post
ambient di Pop a firma Gas. Quella di The Sight
Below èmusica che alle movenze del corpo preferisce sollecitare l’inconscio. Senza rendersene
conto gli occhi caleranno e ogni cosa non avrà
più senso. Without Motion - una dichiarazione
di intenti - pulsa, complice unachitarra in trance
esecutiva (Kevin Shields? Forse Fripp?!), austera
emelanconica insieme; Life’s Fading Light amplifica, sempre al seguito della sei corde in delay, la
componente dancey e Dour travasa i Labradford
inspirali minimal. Il 4/4 è la costante dell’intero lavoro ma, sovente, il battito si adombra e ad
ergersi è un muro ambientdebitore parimenti a
Brian Eno (vedi AlreadyThere e Nowhere) nonché -sollecitati dalle parole dello stesso autore che
si dice influenzato dal vecchio catalogo Factory –
al Vini Reilly dei primi Durutti Column (palese il
rimando in Further Away).
Un raccordo tra due mondi, quello dance intelligente e ambient, non nuovo di certo – tra i tanti, i
nomi di cui sopra lo testimoniano – ma laprofondità, la sincerità con cui Toland li riprende accantona ogni invettivacitazionista. Sul My Space di
The Sight Below campeggia un monito: Lonely
Is A New Dance Party.(7/10)
Gianni Avella
Skiantos - Dio ci deve delle spiegazioni* (Universal, Mar 2009)
G enere : R ock demenziale
Dopo le disavventure con la EMI gli Skiantos approdano alla Universal con questo disco (prodotto da due ultrafan mecenati) sperando finalmente
in promozione e distribuzione più efficaci.
I temi e lo stile sono quelli consueti, per niente
addolciti dall’approdo alla major: a partire dal titolo che, in un’epoca che si sente più in crisi delle
altre, non perde tempo a prendersela con governi
o teleimprenditori e si rivolge direttamente all’autorità somma.
Non c’è una title-track che approfondisca il ti-
tolo: la domanda nasce semplicemente dal consueto panorama di disagi tracciato dal gruppo, in
particolare il senso di esclusione e inadeguatezza
(Testa di pazzo, che apre il disco all’insegna di un
rock blues che fluisce fresco e spontaneo rinforzato dall’hammond di Pippo Guarnera; gli ispirati
virtuosismi verbali e poetici di Tu
tremi, lentone anni ’50 sui vari tipi di tremori
moderni -con tanto di sax anni ’50-visti-dagli-’80
dell’ex Charlie Molinella e mescolanza surreale
finale; il torrido
blues “filosofico”
di Senza libretto di istruzioni) e
l’emarginazione (le
teorizzazioni antilavoriste di Una
vita spesa a skivar
la fresa, o il valzer surreale con inserti hard e twist e (im)morale
conclusiva di Senza vergogna, col quale trovano
anche il modo, loro emiliani, di dedicarsi per la
prima volta al liscio).
Tutto classico, come detto, con un rock a metà tra
la tradizione di Signore dei dischi e il crossover di Saluti da Cortina. Ma la penna funziona, e se Il razzista che c’è in me segue una classica
formula Chili Peppers e Sensazione magica sconta un chorus debole, non mancano lampi lirici e
momenti musicali che le riscattino; Merda d’artista poi, un testo già musicato in Ironikontemporaneo 2 e qui trasformato in un hard-funk di
rara potenza, nonché l’inno punk di Odio il
brodo – che ovviamente va oltre l’aspetto alimentare per prendersela con tutto – meritano davvero. E poi vista la relativa diffusione dei dischi
precedenti non è che il pubblico sia esattamente
saturo del loro stile e dei loro temi: il disco perciò,
oltre ad arricchire comunque un repertorio che
non dorme sui ’70, può funzionare anche come
compendio di poetica per nuovi adepti.(6.8/10)
Giulio Pasquali
recensioni /
79
Soap&Skin - Lovetune For Vacuum
(Pias, Mar 2009)
G enere : chamber - l aptop
È la diciottenne austriaca Anja Franziska Plaschg
a celarsi dietro la sigla sociale Soap&Skin. E mai
ci saremmo aspettati, un po’ per l’età anagrafica
un po’ per la semplicità acqua e sapone evocata
dal nome, un siffatto condensato di oscuro romanticismo e di sofferto cantautorato.
Sono le note classicheggianti di un piano a imperare sovrane in queste tredici tracce che compongono il suo esordio discografico Lovetune For
Vacuum, alle quali si aggiungono lievi e sospese orchestrazioni, intrise di spettrali apparizioni
elettroniche. Ma è la voce della Nostra, ora eterea
e sussurrata, ora dolente e profonda, a rendere
l’atmosfera ancor più solenne e sacrale, se non, in
alcuni casi, addirittura lugubre e funerea.
Una coraggiosa e convincente personalità artistica quella di Soap&Skin, che se nel prossimo futuro
riuscisse a smarcarsi abilmente dalle evidenti influenze boreali di Bjork e Susanna e a rendere più
movimentata la sua proposta musicale, potrebbe
sicuramente affrontare la scalata all’Olimpo delle
chanteuse, alla stregua di un’altra scandagliatrice
dell’anima, Liz Durrett. Che canzoni come Cry
Wolf, Mr. Gaunt Pt 1000 e Cynthia non hanno
niente da invidiare a nessuno, emozionalmente
parlando. Soap&Skin: un Maximilian Hecker al
femminile. (6.8/10)
Andrea Provinciali
Squarepusher - Numbers Lucent EP
(Warp Records, Gen 2009)
G enere : E clectronica B reak - core
Tom Jenkinson ritorna dopo il non troppo esaltante Just A Souvenir ripensando alle origini con
queste nuove 6 tracce in bilico tra remember e il
classico tocco. Basso slappato dunque ma anche
una rinata passione electro. Come dire: lo stemma
Warp nel cuore. Dalla congrega che ha definito
il suono electro dei 90 e che oggi torna a imporlo
di brutto (vedi Harmonic 313) si pesca negli ar80
/ recensioni
chivi della memoria. E allora vai di suoni funk a
8 bit per teen che non avevano vissuto quell’eden
(Zounds Perspex), vai di tastierine brekbit filtrate Aphex-wonky con basso house in salsa fusion
(Paradise Garage), vai di velocità e di camere al
confine con il drill’n’bass à la Dopplereffekt in
pieno acido Autechre (Heliacal Torch), ricordi da
lacrime acidificate E, seduzioni per DJ cartonate
che danno lezioni a Kid 606 (Arterial Fantasy) e
per finire suoni industrial à la R&S degli esordi
e alle voci dei 4 Hero inevitabilmente breakbit
(stupendo l’ardcore di Illegal Dustbin). Piccolo
grande ritorno per Tom. Ora, Richard (D. James)
manchi solo tu. (7.2/10)
Marco Braggion
Stefano Barone - Particolare#uno
(CANdYRAT Records, Gen 2009)
G enere : folk rock strumentale
Il poco più che trentenne Stefano Barone nasce
napoletano e cresce pianista, ma nel suo futuro
ci sono Roma (dove vive dal 2001) e la chitarra.
Pare che la folgorazione definitiva l’abbia avuta
nel 2003 scoprendo Aerial Boundaries, l’album
di Michael Hedge che nel 1984 ridefinì i confini
e le possibilità del fingerpicking, un ascolto che
spinse definitivamente Stefano nell’abbraccio
delle sei corde, divenendo discepolo di Pino Forastiere. Tuttavia, in questo album d’esordio Barone si discosta nettamente dallo stile e dai modi del
suo mentore, rivelando un approccio più vivace
ed eclettico all’arte del chitarrismo
solitario, da un
lato ammiccando
istanze minimaliste e dall’altro concedendosi guizzi
e lazzi funky jazz,
carezzevoli ipnosi
ambient-pop, rarefazioni filmiche, meditazioni
serotine e tumulti allegri-ma-non-troppo.
Gli influssi Hedge sono palpabili un po’ ovun-
que, vedi la marcia ipnotica della title track, la
soundtrack intimista di Syberia e quella The Return con la sua festa mesta di luccicoso malanimo
e tecnica percussiva asciutta. Se poi una Spankie
rievoca i guizzi jazzy calorosi di un Tuck Andress,
altrove t’imbatti in episodi a loro modo sorprendenti come TCLD - sorta di blues hop androide
- e l’accoppiata Batman-Alexander Supertramp,
che sciorinano affabili palpitazioni e stupefatti
incanti tipo gli EST devoti al verbo pop secondo Brian Eno. Apice del programma è tuttavia
Minimalaction, composizione per 12 chitarre (!)
che si snoda ossessiva, misterica, allarmata come
l’incubo floydiano d’un John Martyn cullato dai
Tortoise più garruli. è un disco che intrattiene
con garbo e intensità, risolvendo i passaggi più
complessi con morbidezza e dinamismo, senza
mai scadere nei virtuosisimi a perdere. Consigliabile anche ai non appassionati del genere, e non è
una frase fatta. (7/10)
Stefano Solventi
Steinbruchel - Mit Ohne (12k, Ago
2008)
G enere : sintesi minimali
A testimoniare l’eleganza dell’assenza in dichiarate matrici di forma breve ci pensano le sette tracce del nuovo progetto dell’artista Ralph
Steinbruchel in uscita per la 12k.
Un’edizione limitata a sole 500 copie per MIt
Ohne i cui crediti risalgono a una collaborazione
con l’artista Yves Netzhammer da cui prese forma un’installazione audio-visuale presentata nel
2003 presso il Museum Fur Gestaltiung a Zurigo.
Originariamente il compito di questi poco più di
18 minuti era quello di intraprendere una vera e
propria lettura di superficie che andasse oltre ai
limiti fisici del contesto, per arrivare a tracciare
proprio attraverso l’audio i limiti di uno spazio
immaginato. Uno spazio ideale in cui lasciare
ampio dibattito tra le bipolarità degli elementi
che, nonostante la loro differenza in stato fisico,
dialogassero liberamente sincronie d’insieme e
poetiche a tre dimensioni. Premesse dovute, la
cui scelta in formato a due canali per alcuni potrebbe essere limitante ma, non è questo il caso.
Perché è proprio la materia sonoro tanto vibrante quanto permeante che non perde l’obbiettivo,
impadronendosi del piano d’ascolto e trasportando l’ascoltatore all’interno dello stesso suono.Le
componenti in scrittura tra emissioni tonali, identità in fase, layer in movimento e contaminazioni
di fondo si lasciano organizzare in elementi, che
non segnano il passaggio ma si dirigono verso la
forma unica. Il tempo si rettifica nella purezza di
stesura tra cristalline, vibranti e solitarie calligrafie che sostengono il silenzio e governano il non
luogo con impeccabile stile.(7.8/10)
Sara Bracco
Swan Lake - Enemy Mine (Jagjaguwar, Mar 2009)
G enere : indie rock
La triade Dan Bejar, Spencer Krug e Carey Mercer, coinvolta in gruppi quali Destroyer,Wolf
Parade, New Pornographers, per citarne alcuni, ritorna con il secondo album dopo l’apprezzato esordio Beast Moans del 2006. Laddove lì
il lavoro di ognuno si differenziava,mostrando le
diverse personalità del supergruppo, in quello che
si poteva definire folk pop obliquo, passando per
la somma delle parti con in più dosi di Bowie/
TV On The Radio, R.E.M., Robyn Hitchcock, qui
emergono sì le
diverse
peculiarità, ma si riesce
ad amalgamare il
tutto in maniera
coesa ed unitaria.
Come se in fondo
ormai si trattasse di un’unica personalità musicale, segno della maturazione avvenuta tra i tre. Le
diverse anime vengono allora fuori con facilità,
sitratti del cantato in tensione Bowie ’80 misto a
recensioni /
81
stratificazioni TV On The Radio nella ballad
sghemba Spanish Gold, 2044, dell’indie rockmodello Arcade Fire/Destroyer (Seattle On
Your Skin, Battle Of A Swan Lake) o qualsiasi
dei gruppi da cui provengono e delle misture che
sembrano uscite dagliultimi Animal Collective (Peace). In sostanza i tre confermano la vena
prolifica e ben definita che possiedono anche altrove.(7.1/10)
Teresa Greco
This Will Destroy You - Field Studies
(Magic Bullet, Gen 2009)
G enere : post - rock
Uno split diviso a metà fra This Will Destroy You
eLymbyc Systym. I primi, texani di provenienza,
fanno quello che meglio riescono a fare, e lo eseguono al top: post-rock strumentale che mai degenera nellapropria pervicace via sulle tracce dei
Mogwai, quelli di MogwaiYoung Team. Un
tiro emotivo e un rilasciamento elettrico, un respiroaffannato dal sentimento e un capriccio sfuriato nell’elettricità catartica,sino a esaurimento
fiches. Con sempre un occhio allo svolgimento:
densoe del tutto privo di reali zone morte. Due i
brani proposti dalla band, per 15minuti e noccioline di musica totali. E veniamo ai Lymbyc Systym. Stesso gioco, stessa puntata. Post-rock, anche
stavolta, solo infacito d’elettronica fra spazi vuoti
e motionlessemotive. Tre pezzi in totale, 11 minuti e spiccoli di durata.(6/10)
Massimo Padalino
con una blackness che frutta movimento e voglia
di far muovere i culi. Ma non c’è solo la componente dancey. Qui si ripescano le esperienze
dell’imminenza e della velocità del dubstep. Proprio lui -che sulla velocità ha costruito un’estetica
e che probabilmente dello step è stato precursore
(inconscio?)- torna a rimettersi in gioco assieme a
due vocalist in trip ghettoblastico.Prendete quel
singolo che dà il nome al progetto. Two Fingers
è il riscatto grimey con un basso da paura che
ha in sè il potenziale squassante dei migliori riff
del Wu Tang Clan (omaggio esplicito al collettivo nel ritornello da
lacrime per noi ex
b-boyz). E poi la
ritmica sudamericana rimodernata
con filtri acidi che
guardano al rave
di Mr. Oizo (Keman Rhythm), il
banghra di Jewels & Gems, l’omaggio a M.I.A.
in Bad Girl, il ragga di Whatuknowaboutit e in
generale un ripensamento sui binari della south
london più break-horror. Le esperienze delle
crew del 2008 ripensate da uno dei guru della
tecnica del cut’n’paste.Con questo disco il breakbit e l’anystep collidono. L’esplosione è poderosa
e segna la strada sulla mappa electrobased che
ogni giorno muta. Una delle possibili direzioni,
guardando ai 90 verso il 2010. Amon Tobin it’s
the man.(7.4/10)
Marco Braggion
Two Fingers - Two Fingers (Big Dada
Recordings, Mar 2009)
G enere : R agga M esh - hop
Amon Tobin ritorna con un nuovo progetto. E
questa volta è hip-hop mutante. La collaborazione con Sway e Ms. Jade lo porta nei territori del
mesh più stretto à la Bug. Una cosa veloce che
ricorda i pastiches ritmici di Missill e che lo stacca
dal brekbit troppo cerebrale che aveva influenzato le sue ultime performances. L’anima si rinnova
82
/ recensioni
U2 - No Line On The Horizon (Universal, Mar 2009)
G enere : R ock
Il singolo che anticipava l’album numero quinze
faceva temere il peggio: Get On Your Boots, a
voler essere buoni, è una canzone dalla melodia
casuale e raffazzonata, su un riff che poteva essere sfruttato molto meglio e che il produttore tenta
di salvare con ricami sonori e variazioni anche
riusciti, ma degni decisamente di miglior brano.
Probabilmente il peggior singolo degli U2, a dar
ragione a quelli che li considerano artisticamente finiti (poi ci sono invece gli 8 milioni di copie
inspiegabilmente vendute da How To Dismantle... e amen). E rispetto alle premesse il disco,
alla fine, risulta migliore di quanto paventato
(e del precedente), ma riserva comunque poco
di cui gioire: se infatti si eccettua la maestosità
della title track in apertura (i Simple Minds di
Street Fighting Years un po’ -ma non troppomeno pomposi) e gli esperimenti -riusciti solo in
parte- di Fez - Being Born, il resto cerca di far
convivere un parziale ritorno all’elettronica con
l’abbandono della semplicità (o giovanilismo)
rock degli ultimi due e con gli stimoli provenienti
dal Marocco, dove parte del disco è stata concepita e registrata. Ma di questi stimoli c’è pochissima traccia (come di The Edge, qui al minimo
sindacale), e il risultato raramente va oltre la ripetizione di quanto fatto -meglio- in passato: i pochi altri segnali di vita vengono dal pathos della
sommessa irlandese White As Snow, o da qualche
momentanea trovata di arrangiamento o di produzione: non certo da Magnificent, più U2 che
mai nonostante le abbiano appiccicato un inizio
elettro-ambient (che poi diventa Rockets...), né da
una Moment Of Surrender tirata chissà perché
oltre i sette minuti, o dal crossover sconcertante
di Stand Up Comedy, per tacere di una I’ll Go
Crazy If I Don’t... che andrebbe tenuta nascosta e invece, visto l’andazzo, potrebbe pure essere
uno dei prossimi singoli. In poche parole un disco che chiude -male com’era iniziato- il peggior
decennio, artisticamente parlando, della loro carriera. Ma forse non lo chiude: il gruppo infatti,
soddisfattissimo dei risultati, dice che le sessioni
hanno prodotto 50-60 brani e che quindi l’anno
prossimo potrebbe esserci un altro disco. Non
che questo cambi qualcosa: se il livello è questo,
il futuro Best 2000-2010 -posto che lo faccianosarà un disastro.(4.9/10)
Underdog - Keine Psychotherapie
(Altipiani, Gen 2009)
G enere : avant jazz rock
Settetto romano attivo dal 2004, gli Underdog
- nome ispirato alla famigerata autobiografia
di Charles Mingus, e già questo ce li rende parecchio simpatici - debuttano con questo Keine
Psychotherapie, undici tracce senza timore reverenziale a base di: blues ghignante Bad Seeds e
nevrastenia Primus (Mr. Condom, Prendi 5), jazz
avariato (quella B-Line che coverizza con bella
disinvoltura i Lamb) e caligine androide Portishead (Satellite),
teatrini
battenti
(Circus), tribalismi
tarantolati (Zighididi) ed esotismo
posticcio come un
Capossela invasato Patton (Spectra), inquietudine
sprimacciata da
memorie Matia Bazar (Like People), funk isterici
come una Yoko Ono schiaffeggiata Nina Hagen
(Doppelpersonlichkeit) e psichedelia spalmata su
tratturi western (una Relax che rievoca Jefferson
Airplane e Giant Sand).
Strutturate le orchestrazioni - elettricità di chitarre e ammennicoli sintetici, trombone, pianoforte
e violini... - ma senza perderci in immediatezza
e ferocia, risentono felicemente del post ovvero
non ne accolgono le pose ma lo spirito dissacrante, sciamando poi verso un espressionismo vivido
e famelico.
L’alternarsi delle voci di Barbara e Diego - schizofrenie incrociate di setosa irrequietezza e delirio
saturnino - sembrano esalare da una stessa anima
inquieta, pasturata dalle memorie senza né freni né appigli della modernità. Eccitanti, estrosi,
cupi: teniamoli d’occhio. (7.3/10)
Stefano Solventi
Giulio Pasquali
recensioni /
83
Unmade bed - Loom (Seahorse Recordings, Gen 2009)
G enere : post - psichedelia
Waines - STU (Waines - myspace.
com/3waines, Gen 2009)
G enere : garage , hard - blues , pop , psych
PinkFloyd, Twink, My Bloody Valentine,
Pavement, Mogwai: unite i puntini e, stando a
quanto si dice nelle note biografiche del gruppo,
otterrete gli Unmade Bed. Che altro non rappresentano, in effetti, se non la somma degli addendi,
con in più Paolo Messere nel ruolo di produttoreartistico.
Obiettivo principale degli sforzi congiunti dei musicisti, quello di scendere nell’indefinito del sogno
e dei ricordi, fondendo in un sospiro di musica impalpabile pianoforte, orchestrazioni, synth, basso,
elettronica, vibrafoni, tastiere.
Esattamente ciò che accade nelle dieci stazioni del
disco, con lavoce timida ma ininterrotta di Lorenzo Gambacorta a filtrare tra le intercapedini di
suono e racconto. Tutto perfetto se si rimane in
superficie.
I dubbi nascono quando si abbandona quell’epidermide raffinata che rappresenta un po’ il biglietto da visita della formazione, per scendere un po’
più in profondità: si scopre allora che a guardar
bene non v’è traccia dei trip laterali del Barrett più
allucinogeno, che gli incantesimi dafolletto propagandati dall’exbatterista di Tomorrow e Pretty
Things sono solo un ricordolontano, che le trasposizioni degli afflati melodici sghembi euncinanti
della band di Stephen Malkmus non paiono poi
così uncinanti. Sostituite invece da un eccesso di
lustrini con pocomordente, gradevole, certo, ma
raramente indimenticabile.
Dal passato rinviene lo sciabordio morbido delle chitarre di Loveless,qualche rimembranza
Mercury Rev, un’organizzazione dei contenuti che privilegia il lavoro degli strumenti – caro,
vecchio,post-rock -, qualche stranezza nelle melodie. Non abbastanza, comunque, da consentire al
disco di sforare la soglia del sette.(6.6/10)
Di questo power trio palermitano - rigorosamente bass-less – dal sound potente eroccioso si
è già parlato nelle pagine di We Are Demo (SA
#45-46) a propositodell’EP A Controversial
Earl Playing, che altro non era se non ungustoso
antipasto in attesa della portata principale. STU
(si scrive tutto maiuscolo, come il nome del gruppo) è una vera e propria abbuffata di riff
granitici, slide guitar
imbizzarrite e rullate
telluriche imbastita
nel nomedel blues,
che per i WAINES
non è solo un’ispirazione ma una fede,
sacro fuocoprimigenio che tutto muove. Tanto che
l’oceano di catrame in cui Fabio Rizzo (già nei Second Grace), RobertoCammarata e Ferdinando
Piccoli navigano saldi è lo stesso di Blues Explosion, White Stripes, BlackKeys ma anche AC/
DC, Motörhead,Allman Brothers e compagnia
lercia. Aldilà dei più che riusciti tributi al genere (i
funambolismi di Server, le devote evoluzioni Page/
Plant di Red CrossStore), ai tre bisogna riconoscere
personalità e palato tali da spingere iltutto verso il
pop, in un crossoverriuscito tanto nelle trame delle
melodie (il Beck spiritato e sudista di LetMe Be,
i Beatles trapiantati ZZ Top nell’incipit di Flow
River Flow, i Raconteurs anfetaminici e truzzi di
Woooo, ma pure gli hook degli strumentali Have
You Heard The News e ReadyTo Taxi), quanto
- più esplicitamente - nell’efficace rivisitazione di
NY Excuse dei Soulwax, già pezzo forte dell’EP.
Se aggiungiamo che lasupervisione del veterano
Daniele Grasso dei The Cave Studios di Catania
(cuisi sono affidati fra gli altri John Parish, Greg
Dulli, Afterhours, CesareBasile) è una garanzia,
e che l’autoproduzione della band (il disco è invendita sulla loro pagina myspace) sfoggia gusto e
Fabrizio Zampighi
84
/ recensioni
consapevolezza da vendere(suono caldo, denso e
massiccio; da vinile), siamo decisamente di frontequalcosa di più che un prodotto “locale”. Chiamatelo (indie) rock daesportazione, se vi va. O, meglio
ancora, cazzutissimo rock’n’roll made in Italy. Pardon, Sicily. (7.5/10)
Antonio Puglia
Wheels Of Fire - Get Famous (Big Legal
Mess, Mar 2009)
Genere: Garage
Descritto come perfetto incrocio fra Elvis Costello
e Stooges, il quintetto dell’Ohio è, in realtà, animale da palco per eccellenza. I WOF hanno concepito questo loro esordio lungo on the road, per strada, battendo, tappa dopo tappa, Europa e States
adrenalinicamente carichi di esplosivo rock’n’roll.
Tornati a casa, si son chiusi in uno scantinato, armati di soli microfoni e un vecchio registratore.
Get Famous! è il frutto di quel parto creativo. John
Garris (voce, chitarra), Matt Chaney (batteria), Susan Musser (tastiere), Mike Chaney (voce, chitarre)
e J.J. Reed (basso) amano Sonics, Kinks, Beatles,
Big Star. E questi rappresentano il lato poppy del
loro carattere musicale. A trasformare ogni pezzo
in verace e scalmanato numero rock’n’roll ci pensano i padri ‘cattivi’ di questo suono: Oblivians,
Stooges, Animals. Sì, gli Oblivians. Un nastro dei
Nostri andò a finire, dopo un’esibizione live sostenuta insieme, proprio nelle mani di Jack Oblivian. E dalle sue, poi, a quelle di Bruce Watson,
il deus ex machina di casa Fat Possum. Un sacco
di ‘agganci’ con le blue notes, i Wheels On Fire
li hanno, nelle loro song. John Lee Hooker è uno
dei miti della formazione. Apre l’album Midnight
School che è blues nel senso inteso dagli sporchi
Oblivians. Tirato ed elettrico detrimento dei sensi
rock’n’roll attraverso 3 minuti 3 di forma-canzone.
Anche meglio fanno I’m Turning Into You o il boogie cadenzato dall’organo di Can’t Get A Line.
Che i Reigning Sound abbiano trovato, di già, i
loro eredi?(7/10)
Zukanican - The Stumbling Block
(Pickled Egg, Gen 2009)
G enere : avant funk jazz
Col debutto Horse Republic (Pickled Egg Records, 2006) i quattro Zukanican da Liverpool
piantarono una interessante bandierina sul pianeta free-funk, mischiando visioni retrofuturiste e
suggestioni avant coi piedi piantati in un presente
bello carico di energia, di ispirazione, di azzardo
edificato sulla più sana impudenza. Col successore, il qui presente The Stumbling Block, il tono
si acquieta, tenta una riflessione sul posto, esplora i dintorni per verificare il raggio d’azione, a
tratti cincischia che non sai bene dove e se voglia
spingere o spegnere l’avventura, perlopiù sciorina
vampe e rombi ed ectoplasmi foderandoli d’umore discendente, destinandoli ad una pacificazione meditativa. Basso, batteria, tastiere e tromba,
questa la quadratura basilare che poi va a frangersi nella calligrafia incalzante, misterica, seriale, tumida e aerea, roba che potrebbero distillare
in un laboratorio di alchimisti in fregola Can e
Terry Riley, del Miles Davis sciamanico, dei Massive Attack più torbidi. Il sound è ora androide e
spasmodico - con la fauna elettronica a sfrigolare,
il drumming asciutto e veemente, le pennellate
brevi e pastose della tromba (vedi Inca Hoots e
la giocosa All The Saints Are Sinners) - oppure
sospeso in una sarabanda di visioni oscure, filmiche, coi rigurgiti di passato sempre in agguato
(fantasmi boogie nel tribal funk seriale di Tell It
To The Kif, folate Sketches Of Spain e arabeschi
floydiani nell’antro motoristico di Koanish). Segnalata una Penny Dance Test che rievoca brume
vibratili Tortoise su cui moog e cornetta impazzano mercuriali, spendiamo un plauso per la potenzialità espressa e uno speranzoso rammarico
per quella che sembra essere rimasta sul taccuino. (6.9/10)
Stefano Solventi
Massimo Padalino
recensioni /
85
il dvd
il libro
Mark Fell - Attack On Silence (Line) dvd
Giuseppe Basile / Marcello Nitti - ‘80, New Sound, New Wave
Autentiche sculture sonore quelle del progetto audio e
video Attack On Silence di Mark fell.Il suo lavoro mette
in gioco esperienze percettive attive ardite, grazie a geometrie spazieli e di frequenza che arrivano a tracciare
alienate simbiosi.
Un vero e proprio quadro digitale dal tratto dichiaratamente minimale, che a differenza del Royoji Ikeda di
Formula fa a meno dei ritmati registri, ma non del colore limitato comunque a un determinato monocromo su
sfondo nero.
Tre capitoli nettamente differenti, dalle repentine ascese
e discese della prima traccia che prende vita nei caleidoscopici accostamenti in fasce orizzontali, alle geometrie in 8x8 pixel dei successivi sedici minuti.Una sorta
di configurazione incrementale di una multiviewer per
segnali in 16:9 alla cui base stanno le sfumature e le tonalità (del grigio,del blu o del verde) mentre alle estremità le intermittenze sono realizzate con accostamenti
cromatici puntuali e atonali.
Decisamente intrigante la sospensione che permea
l’ascolto dei trentanove minuti della terza e ultima sezione, una sorta di banda orizzontale suddivisa in sezioni verticali di colori vibranti e sanguigni.Tangibile in
questo caso la fonte sonora che abbandona la gerarchia
per sottoporsi alla diffusione, al contrasto e infine al repentino mutamento.
Per tutta la durata di Attack On Silence lo schermo
appare ibridato e l’immagine statica ma la matrice
pulsante:un’esperienza sonora e cognitiva di notevole
impatto o una sorta di consapevole e profondo passaggio iniziatico.Da avere!
(7.5/10)
Di sguardi sulla wave, anche obliqui o trasversali o paralleli e particolari, ne sono circolati molti negli
ultimi anni. Anche in Italia. Soprattutto durante il revival cui siamo stati sottoposti in questi anni 00 a
base di emul-rock commerciale e becero, rivisitazioni genuine e spontanee o celebrazioni à la page e
nazional-popolari. Mai però ci si era trovati di fronte ad una indagine – un libro nello specifico – che
trattasse quel periodo d’oro limitandone il raggio d’azione alla provincia meno cool (oggi come ieri) della
periferia dell’impero di certo rock.
Cosa buona e giusta, a dir la verità. In primo luogo perché dimostra passione, tanta, forse troppa visto
poi il disgregarsi di certe forze, sia all’epoca delle vicende narrate – immaginate cosa significasse quasi
trenta anni fa sbattersi per organizzare concerti nel sud d’Italia – sia nell’attualità della nascita di questo
’80 New Sound, New Wave, lavoro certosino e immaginiamo difficilissimo di reperimento delle fonti da
parte di Giuseppe Basile (prevalentemente testo) e Marcello Nitti (prevalentemente immagini e foto).
Due protagonisti diretti di quella epopea, sconosciuta ai più in verità, che vide i più grossi nomi della
wave d’oltremanica calcare i palchi improvvisati di Taranto, estremo sud dello stivale, all’epoca dei fatti
ancora al limitare dell’illusoria tendenza espansionistica che certe industria pesante (ma non pensante)
prometteva senza poi mantenere. Taranto, luogo ameno, non proprio votato alla musica, specie a quella
d’avanguardia come sottolinea Basile nella prefazione, si risveglia però proprio sull’onda di quella nuova onda; la sua gioventù assetata di novità, di input, di ancore di salvataggio sembra rinascere proprio
attraverso quelle musiche allora di confine dimostrando una vitalità, una sorta di coscienza identitaria
connessa a “una musica di nicchia che usciva dalla nicchia”, a tutt’oggi invidiabile.
Proprio nel taglio insieme documentaristico e sociologicamente altro del libro risiede lo scarto maggiore e
il pregio principale di questo ’80 New Sound, New Wave. Se da un punto di vista prettamente sociologico
i due autori, procedendo per immagini e parole, sembrano sottolineare in senso positivo, quasi rivendicandola, proprio la matrice “provinciale” del lavoro, attenta cioè ad indagare lo stretto legame tra provincia e mondo musicale in espansione; da quello
più squisitamente documentaristico forniscono non la solita, trita e ritrita
riflessione sulla wave (electro, dark, gothic, post-punk che sia). Bensì, una
indagine “quotidiana” della passione musicale che bruciava in quei primi
anni ’80. Ricordi, memorie, chiacchiere in libertà con i protagonisti di quel
periodo. Legami intensi, fili interrotti o ripresi, revival nel senso etimologico
del termine che ha il pregio di farci (ri)vivere aneddoti e momenti sinceramente interessanti (comici e/o seri) su artisti del calibro di Simple Minds e
Bauhaus, Siouxie e New Order tra i tanti. Oltre che mostrarceli, miti demitizzati, giovani tra i giovani, nella quotidiana vita della rockstar in provincia. Due su tutte: i Cult a cena nel ristorante del Tursport, il centro sportivo teatro della maggior parte
degli eventi narrati, come una qualsiasi comitiva di ventenni; o i Bauhaus goffamente intenti a giocare a
calcio, gotici e emaciati come d’ordinanza, nel campetto del suddetto centro sportivo. Un libro da leggere
e guardare, insomma, ma anche, perché no?, per riflettere sull’importanza della wave primigenia.
Sara Bracco
Stefano Pifferi
86
/ recensioni
recensioni /
87
live report
Handsome Furs (Locomotiv 20 Feb
2009)
Se siete inguaribili frequentatori delle feste scolastiche di fine anno, se il divertimento fine a se
stesso, per voi, è quasi un comandamento, se alla
musica non chiedete altro che un paio di accordi
di chitarra elettrica e una base elettronica su cui
saltare, catapultatevi a un concerto della band
canadese: non rimarrete delusi. E come potreste,
del resto, visto che i Nostri sono i primi a coltivare
quella grottesca pantomima che accompagna il
rock da che mondo è mondo, fatta di pose plastiche, espressioni divertite, teste che si muovono a
tempo e ubriachezza (per nulla) molesta? E allora
decoltè in bella vista, calzamaglie zebrate e piedi
nudi a tenere il beat (Alexei Perry), tatuaggi di
rigore, jeans stretti e anfibi consumati a celebrare
a mo’ di macchietta una carica animalesca solo
presunta (Dan Boeckner). Un modus operandi
che trasforma il no fun di Iggy Pop in occhiate
ammiccanti, ringraziamenti fin troppo scontati,
sorrisi compiaciuti e quasi incredulità per una
serata in cui tutto gira a dovere. Il pubblico dimostra di gradire il mix di new wave e shoegaze
che parte dagli amplificatori, ne studia la grana
grossa, lasciandosi convertire dalla coolness messa in bella mostra. Ma è un compito fin troppo
facile, dal momento che chi suona fa di tutto per
accaparrarsi la simpatia di chi ascolta, arrivando
a declinare il concetto di “fellatio” in un italiano
stentato ma già gergale.
88
/ Rearview Mirror
Se in musica esistessero le caste, i Kills starebbero dieci scalini sopra questi Handsome Furs, che
della formazione anglo-americana riprendono
l’organigramma aziendale ma certo non il cinismo metropolitano, le accelerazioni sintetiche ma
non la statura artistica. Tanto da arrivare a svilire
dal vivo persino quella compartimentazione stagna dei ruoli - e dei suoni - che su disco ci aveva
affascinati, in favore di un impeto festaiolo sbracato e in saldo. Insomma, un esperimento gradevole e innocuo la nuova avventura discografica
del vocalist dei Wolf Parade, come una domenica pomeriggio al mare o lo sciroppo per la tosse
al gusto di amarena. In attesa che il demone del
rock si ricordi anche di loro.
Fabrizio Zampighi
Hell Demonio, Crystal Antlers (Locomotiv 26 Feb 2009)
Esteticamente i Crystal Antlers sono brutti assai ma funzionano alla grande. Sono icone off
della California all’epoca di Altamont e ci fanno
parecchio. C’è il negrone pacchiano a ballare e
mimare le canzoni con tamburelli e diamonica.
Un tastierista matrono messicano con gran chioma, carnute braccione e tocco altrettanto pesante. Diciamo minimal, con le dita a tirare lunghe
note sopra lo sfracasso chitarristico di un cantante vestito, per caso, grunge. Una sorta di Cobain
con i baffi. Un Cobain felpa e cappuccio, jeans e
camicia una taglia sopra. Lo strazio vocale simil-
Handsome Furs
mente scream(o) a ricordarlo. Ultimi: batterista
giovanissimo e a petto nudo, icona gay istantanea
e un trendy secondo chitarrista caschetto-munito
con camicetta bianca e pulita.
Sono immagini che spiegano il suono più dei paragoni. Raw and control. Non proprio grunge
e non proprio math e non lo definirei prog à la
mars volta. Personalmente sia con loro che con
gli Hell Demonio, esibitesi in apertura, è sembrato di sentire una dismissione non totale della
lezione novanta dei Don Cabballero, alla quale
sopravvivono arrangiamenti angolari di striscio
soprattutto per gli Hell. C’è quell’urgenza dell’accelerazione massiccia. Da sogno hippy andato a
male e venti pasticche di mandrax in corpo. Ed
è qui che ritorna il mito stonesiano di Altamont:
l’omicidio inspiegabile e reiterato del rock a velocità supersonica. Lo strazio hardcore sempre
pronto al vortice noise psych che, nel migliore dei
casi, fa pensare a un ipotetico gruppo hard del
Manzarek doorsiano.
C’è quasi da preferire gli Hell demonio ai CaliRearview Mirror /
89
forniani pitonati per un paio di motivi: non dispiace quello stridulo cantato a catturare l’isteria
del miglior Zach de la Rocha, soprattutto se in
appoggio abbiamo un cingolato hard slegato dalle pose Black Sabbath dei vetusti Rage Against
The Machine. E persino per quegli assoli piovuti dal nulla a due chitarre in stile Iron Maiden
periodo Powerslave, i tamarraci italici meritano
un premio. Come non menzionare, infine, i riff,
minimo comune denominatore di due band che
non mirano all’anthem ma al sound. Chiamalo
hard in provetta o come ti pare, proprio come ai
tempi dei Don, ma anche su questo punto gli Hell
Demonio, meno animali da palco e meno ricchi
di quella tastiera e di quel mix, primeggiano e si
portano a casa l’applauso. Controllato anch’esso.
S’intende.
Edoardo Bridda
The Damned (Estragon 13 Feb 2009)
E pensare che erano stati tra gli alfieri del punk
inglese. A distanza di più di trent’anni dagli esordi i Damned non riescono ad andare oltre un raccapricciante spettacolo di cabaret. Volontario o
involontario che sia.
“Se pure un giorno sono stati qualcosa di importante, di sicuro oggi non lo sono più. Non sono
proprio più niente!”. Le parole di Mario, amico dai discreti gusti musicali, ma poco avvezzo
al punk e ai suoi derivati, nella loro semplicità
sintetizzano alla perfezione le sensazioni che anche a me, estimatore di ciò che i Damned hanno
rappresentato alle origini del punk, ha suscitato il
concerto della band londinese.
Pensare che sono passati più di trent’anni da quando ha visto la luce New Rose, quello che molti
ritengono sia storicamente il primo singolo mai
registrato da una band punk. Un lasso di tempo
che dà le vertigini, se solo si pensa che i vecchietti che stasera sono saliti sul palco dell’Estragon,
sono gli stessi che si sono imposti agli albori del
punk, nella sua culla londinese, suonando insieme
ai Sex Pistols. Se a questo si aggiungono le innu90
/ recensioni
merevoli trasformazioni della band, dal punk al
gothic, fino a influenze sempre più cabarettistiche
e melodiche, con il solo Dave Vanian a portare la
bandiera durante tutti anni, si può già intuire ciò
che attende il pubblico bolognese. Ma a volte la
realtà è peggiore delle peggiori aspettative.
Vabbè la leggenda, ma, quando i cinque salgono
sul palco si fa davvero fatica a riconoscere in quel
crooner dei poveri vestito da cameriere, con tanto
di guanti neri e ciuffo bianco che spunta da una
pettinatura alla Elvis (Vanian) e nel vecchietto
forzatamente giovanile che imbraccia ancora la
chitarra penzolante sulle ginocchia come quando
aveva vent’anni (Captain Sensible), due tra i legittimi genitori del punk inglese.
L’approccio è fiacco, il sound tutt’altro che graffiante, complici le tastiere di Monty Oxy Moron,
che spesso e volentieri prende la scena saltellando
come un forsennato e mostrando il lato volontariamente più clownesco della band. All’umorismo
involontario ci pensa Vanian: impacciato e chiaramente poco a suo agio, si muove (poco) dando
l’impressione di non sapere proprio cosa fare.
L’ultimo lumicino di speranza, in questi casi, è
legato al revival. Quando finalmente viene fuori
l’unica cosa interessante del concerto: il passato
della band. Neat, Neat, Neat, New Rose, Smash
It Up risuonano con piacere nella memoria
dell’ascoltatore nostalgico, ma le nuove versioni
hanno poco a che vedere con la ruvida essenzialità di quegli esordi ormai lontani, tanto da far fare
addirittura bella figura allo scialbo rock psichedelico dell’ultimo album.
Il pubblico, discretamente numeroso da riempire
metà della platea dell’Estragon, sembra accontentarsi e mostra di gradire. Non si capisce veramente cosa.
Daniele Follero
Eugene Chadbourne (Museo Della
Musica 24 Feb 2009)
Comicita e ricerca musicale, parodia e eclettismo.
Eugene Chadbourne dimostra ancora una volta
che la musica sperimentale può andare tranquillamente a braccetto con il country, il noise, il metal e il clownesco.
Alla faccia di chi pensa che la musica sperimentale (d’avanguardia, anticonformista o come diavolo la si voglia chiamare) sia per forza una roba
noiosa e di chi crede che i musicisti “impegnati” debbano (chissà per quale motivo, poi) essere
barbosi bacchettoni che suonano per un pubblico
elitario e serissimo. L’altra sera, nella saletta del
Museo della Musica di Bologna, Eugene Chadbourne ha dato prova del contrario, dimostrando
che la comicità può andare perfettamente a braccetto con la ricerca musicale, senza che quest’ultima perda di credibilità. E lo ha fatto a modo
suo, con quell’ inconfondibile stile da americano
giramondo, capace di adattarsi a qualsiasi platea
e, soprattutto, a generi musicali distanti anni luce
tra loro.Solo con un banjo e una chitarra, il musicista statunitense, noto per le sue svariate collaborazioni (da John Zorn a Fred Frith, da Jello Biafra
a Derek Bailey, fino ai romani Zu), è riuscito ad
ipnotizzare i presenti per un’ora e mezzo con uno
show esilarante e capace di abbracciare, in poco
più di un giro d’orologio, mondi musicali agli antipodi.
Senza tanti convenevoli, Chadbourne ha esordito con una serie di brani country, che spesso e volentieri si dilatavano, sfociando in improvvisazioni free, con il banjo trasformato in un ibrido tra
uno strumento a corde e una percussione.Dopo
una mezz’oretta eccolo imbracciare la chitarra
elettrica, distorta e compressa all’inverosimile, e
lanciarsi in una serie di cover. Are You Experienced? Di Hendrix sarebbe praticamente irriconoscibile sotto le sferzate noise della sei corde, se
non fosse per l’ormai classico stop and go con la
declamazione della frase che da il titolo al brano.
Dal rumorismo estremo al suono chiaro e limpido ci passa un colpo al pedale degli effetti. Ed
ecco il Nostro esibirsi in un duetto (degno di un
imitatore di professione) tra Bob Dylan e Louis
Armstrong sulle note dello standard Stardust. Ma
non c’è sosta e il pubblico non ha ancora smesso
di ridere che arriva la sua personale rilettura del
classico del classici del rock’n’roll, Roll Over Beethoven, trasformato per l’occasione in un geniale
“Roll over Berlusconi”!
La comicità musicale di Chadbourne possiede
l’efficacia che solo i grandi attori riescono a suscitare, tanto è raffinata e mai grossolana. E, soprattutto, imprevedibile. Quanto meno te lo aspetti,
il vecchio Eugene ti mostra il pezzo da novanta,
tirando fuori uno strumento di sua invenzione: il
rastrello “elettrificato” (!). Chadbourne gironzola
per un quarto d’ora esplorando tutte le sfumature
del rumore con il suo nuovo arnese, ora graffiando il pavimento,ora sfruttando il suono del contatto elettrico con le luci.
Non importa che sia un concerto gratuito e che
ai presenti potrebbe già bastare. Lui è in vena, il
pubblico anche e quindi, imbracciato di nuovo
il banjo, ricomincia con le sue deliranti melodie
pseudo country.
In questi casi ci si può solo lamentare del fatto che
tutte le cose, prima o poi, finiscono. Eccezionale.
Daniele Follero
recensioni /
91
WE ARE DEMO
#34
Old Polaroid - Man Who Hate Women
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati dai vostri devoluti redattori di
S&A. Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Sirens - Acheloo
Acheloo è lo pseudonimo dietro cui si cela Carlo
Luzi, chitarrista romano folgorato da ambient e
musica cosmica. Uno che raggiunge latitudini estreme con un suono glaciale, dilatato, pervaso dal lavoro dell’Ebow e del multieffetti. Il tutto mantenendo
un approccio alla materia piuttosto diretto, che in
questa demo delinea inquietanti paesaggi (Teles)
come profondità irrisolte (Ligeia), crescendo senza
fine (Deianira) e parentesi dai profumi vagamente
post-rock (Melody Of Darka).Scindere tra autoreferenzialità e creatività, coraggio e reiterazione
non è impresa facile quando ti ritrovi ad ascoltare
brani che arrivano a sedici minuti di durata senza
differenziarsi gran ché al loro interno o dal resto del
programma. Ci pare tuttavia che Sirens meriti comunque una segnalazione all’interno della nostra
rubrica.(6.3/10) Fz
Kernel Drop - The Dreambox
Stefano Serafino da Torino alias Kernel Drop, i cui
sogni si riproiettano ipnotici rimbalzando algebrici
miraggi Kraftwerk teletrasportati Orbital, quindi
una sottigliezza che intaglia futurismi olografici e
percezione androide della meraviglia sonica, sgocciolando come l’avatar di una immaginaria musica
concreta, pulsando danza intelligente per giunture
immateriali, cogliendo frutti warpiani tra arguzie
minimali come dei Pan Sonic ringalluzziti Faithless
e Autechre. Facciamo che c’è in questo The Dreambox - sette pezzi per oltre cinquanta minuti - una
freschezza tenace, a suo modo inesorabile, che lo
rende intrigante come pochi ascolti electro mi siano
capitati da un pezzo. Marcatelo stretto.(7.2/10)Ss
Le Morceaux Anatomiques - Self Titled
è ancora acerba questa formazione di Voghera, eppure l’indie-rock che propone ci ha convinti. Merito
92
/ recensioni
Dalla Sicilia con fragore visionario, sfrigolante, eccentrico, suadente, mescolando il torbido dei Blonde Redhead con l’onirico Flaming Lips, il guizzo irrisolto dei dEUS, l’irriverenza riverente di Jon Spencer e il fiero post-modernismo afro-black
di Eryka Baduh. Questo, con molta approssimazione, sono gli
Old Polaroid, liasion artistica tra Francesco Cipriano e la cantante sudafricana Zoe Berlin, col non certo piccolo aiuto del di
lei marito Chaz e di Enzo Cimino (già Mariposa) alle ritmiche.
Quattro i pezzi, vorrei fossero di più, ma già si prevede debutto su lunga distanza a primavera, allora quando finisce questo
delirio organizzatissimo posso ritenermi più che soddisfatto, aperitivizzato.(7.6/10) ss
di una malinconia di fondo in stile Blonde Redhead sospesa tra musiche misurate e una voce, quella
di Alessia Praticò, dimessa ma, al tempo stesso, in
grado di adattarsi con un certo stile alle linee vocali
frammentarie dei brani. Per una musica che sfiora
il noise ma accetta di buon grado anche la melodia, mostra una certa epicità, vive di cambi di ritmo
frequenti, con basso, chitarra elettrica e batteria a
suggellare passaggi musicali insoliti frutto anche di
una buona coesione tra le parti.(6.8/10)FZ
Mayflower - Jumping My Skipping Rope
In Your Backyard
Quartetto tutto al femminile da Benevento, attivo
dal gennaio 2006 sulle tracce di un folk rock venato di retaggi seventies ovvero disposto a concedersi
suggestioni jazzy e blues, col risultato di scomodare
barbagli Jefferson Airplane stemperati da un’aura
sbarazzina Go Go’s, oppure se volete una benemerita via di mezzo tra la Suzanne Vega meno prolissa
e la Alanis Morrisette più intensa. Poi, ok, c’è quella
Recollecting che potrebbe passare per la sorellina
di Jeremy dei Pearl Jam, e con questo è il caso di
chiudere coi riferimenti per spendere un ragionevole elogio alle Mayflower, band che sceglie di percorrere una strada poco trendy ma coraggiosa e foriera
di buoni sviluppi. I mezzi - a partire dalla voce di
Miriam - non mancano. Quanto alla robustezza del
sound, son cose che si conquistano anche lungo il
cammino. In bocca al lupo.
(6.7/10) SS
Randy Watson - S/t
Si trova tra grunge e hard, post-rock e stoner, psichedelia e noise, il domicilio dei Randy Watson da
Pavia. Un pugno di brani quasi del tutto strumentali
costruiti su chitarra elettrica, basso, batteria, che non
si interessano di nient’altro se non far urlare gli am-
plificatori, saturare i toni grevi o picchiare sui tamburi. Dopo qualche frequentazione emerge pure
un lavoro di stratificazione delle parti tutt’altro che
improvvisato, in cui si alternano momenti di calma
apparente e muri di distorsioni, campionamenti di
voci e geometrie allentate, su suoni che mostrano
attitudini vagamente progressive.Ci chiediamo che
cosa potrebbe fare il gruppo se all’entropia già affascinante di questo demo, sostituisse una quadratura
maggiore dello stile e un’identità specifica.(6.7/10)
FZ
Toleko - Self Titled
C’era una volta un duo (chitarre, basso e voci) che
dall’inizio del millennio si mise in testa di portare in
giro per l’Italia il proprio folk-rock intenso e visionario. Ai due busker-camperisti si aggiunse nel 2007
un trombettista dall’estro più mariachi che Nino
Rota, ed ecco che la triangolazione combattiva e
poetica trovò compimento e un barlume di consacrazione, anche grazie al qui presente demo piuttosto apprezzato dalle radio “engagée”. Diciamocelo:
non c’è da strapparsi i capelli, e non per colpa della
frugalità delle incisioni. Con una produzione come
si deve e una sfrondatina agli eccessi lirici, potremmo sentirne delle belle. (6.3/10) SS
Un Incoerente Come Tanti - Il pianobar
ai giardinetti
Mi fosse piovuto addosso - diciamo - un paio d’anni
fa, avrei gridato al prodigio. Versi come “compreremo ossigeno da spacciatori boliviani” oppure “il
sole lo abbiamo spento per risparmiare energia” o
ancora “guarda che tristezza, stanno arrotolando il
cielo”, con la cruda franchezza chitarra-voce con
cui vengono espettorati, sarebbero bastati per fare
di pezzi come Plastica da imballaggio, Di seconda
mano e La vita virtuale la mia magnifica ossessione
d’un mese o due. Però oggi in un certo senso viviamo
nel dopo-Vasco Brondi, e con tutta la buona volontà non possono non sembrarmi ricalcate sui cliché
già definitivi di Canzoni da spiaggia deturpata. Poi
però t’imbatti in una Nelle case occupate e in una
Primo Maggio davvero toccanti, in un modo che
De Gregori potrebbe ancora se non si fosse messo in
ammollo nel Vernel bevendo per non affogare. Così
come la tesa Teatrino sembra Godano che strattona
un profilo Rino Gaetano piuttosto trafelato, citandone pure l’epica Ma il cielo è sempre più blu. E
tutto ciò senza mai smettere di funzionare. Allora
concedi volentieri al pratese Un incoerente come
tanti il beneficio della fiducia. In attesa di.
(6.8/10) SS
recensioni /
93
A warehouse of songs and stories
le stagioni
del cuore
l’emocore 20 anni dopo
- Giancarlo Turra, Andrea Provinciali, Luca Collepiccolo
C’è uno spettro che si aggira per i media e il suo nome è “emo”. Non date retta a quanto vi spacciano sotto tale etichetta, però: di un genere per definizione sotterraneo ma di portata e impatto
significativi non è restata, lì, altro che la buccia. Approfittando del clamore mediatico, del ritorno
degli Appleseed Cast e degli anni trascorsi nel frattempo, abbiamo voluto provare a storicizzare un
fenomeno sgusciante però, a suo tempo, vivissimo.
94
/ Rearview Mirror
“Questi sono i tuoi anni importanti, la tua vita.”
(Hüsker Dü)
C’è voluto un po’ meno del solito a causa della
compressione e dell’ipervelocità alle quali viviamo oggigiorno, ma è accaduto di nuovo. Che un
sottogenere - al quadrato, stavolta: evoluzione di
quell’hardcore a sua volta derivato del punk - e
fortemente underground sia arrivato in classifica
e assurto a fenomeno di costume. L’evidenza del
suo essere stato infine inglobato dal “sistema” è
prova del nove di un cerchio infine chiusosi su se
stesso, perché, come con il punk del ’77 e il grunge
del ’91, l’entrata nei top 20 rappresenta lo sfondare della diga e il cristallizzarsi delle forme. A invadere i media, più spesso che no, sarà la versione
scandalistica ed edulcorata delle stesse ed è una
vicenda stravista. Il primo seme invece entra nelle
enciclopedie e nei libri, involandosi dagli scaffali
di “quelli che c’erano” a testimoniarne nascita e
sviluppi. Di noi che adesso puntualizziamo ma,
soprattutto, ricordiamo. Dunque che amarcord
sia, con tanto di lacrimuccia sincera e trattandosi
di emotionally driven hardcore appropriata. Che era
lontanissimo dalla robetta tagliata su misura per
gli adolescenti seguaci della vampiresca saga di
Twilight, un target che - si fa per dire, eh - evolve
il “target MTV” dei Tokyo Hotel nelle playlist di
Carlo Pastore. Che, in fondo ci sia andata addirittura peggio che col grunge? Quanto spessa è - se
esiste - l’intercapedine che separa Silverchair
e My Chemical Romance? O, per restare sui
nostri lidi, Dari e Timoria? Certo è che il minimondo di frangette e lamenti, vestiti neri sottratti
al fratello maggiore ex “dark” (è troppo immaginare il papà? forse no...) e canzonacce pompose
e insopportabili incarna l’emo se oggi chiedete in
giro a ggiovani o male informati. A noi, ovviamente, tutto questo non interessa.
C’era infatti ben altro in epoche neppure lontanissime. Ci fu l’ultima mutazione plausibile del
punk, mentre una sua faccia diventava macchina
da soldi al posto della vacca grunge spremuta oltre l’immaginabile.
Qualcosa di cominciato veramente “dal basso”,
sebbene sulla base d’esempi elevati. Tocca tornare alla fine degli anni ’80, nei giorni in cui gli
immensi Hüsker Dü pubblicano il testamento Warehouse: Songs And Stories (Warner,
1987; 10/10), uno dei rari dischi di cui è in pratica impossibile - qualora non sciocco - sottovalutare grandezza e importanza. Nei suoi solchi vibrano tuttora anime che cercano di oltrepassare
le proprie debolezze affrontandole a viso aperto,
dialogando tramite Canzoni memorabili.
Sensibilità che pulsa corporea e le rende a volte difficili da sostenere per come passano ai raggi X ogni problematica, errore e rimpianto; per
come tratteggiano con franchezza sguardi e parole che dall’ostile sfumano in pura amarezza.
Un modo di rapportarsi alla musica che fluttuava
nell’aria dopo lo spegnersi delle fiamme hardcore, specialmente dalle parti di Washington D.C.,
dove - conclusa l’esperienza “straight edge” nella sua forma genuina - Rites Of Spring (s/t;
Dischord, 1985; 7,5/10) ed Embrace (s/t;
Dischord, 1987; 7,3/10) concepivano il verbo
non più come proiettato all’esterno, prediligendo
l’introspezione alla dottrina. Formazioni che osavano oltre l’ortodossia, ne immaginavano un post
tendendo l’orecchio alla inafferrabilità di Squirrel Bait (Skag Heaven; Homestead, 1987;
8,0/10) e Slint (Spiderland; Touch & Go,
1991; 10/10). Ne derivò una maggior complessità sonora, la tortuosità confessionale perfetta per
esprimere quei moti del sentimento cangianti per
definizione. Fondamenta dell’emocore da cui si
dipartono i rivoli che rispecchiano la complessità
del sottobosco anni ’90 e dell’attuale; che testimoniano la difficoltà nel tracciare linee che - lo
confessiamo - hanno regalato piacevoli grattacapi
al momento di mettere ordine.
Compiuto non senza sforzi e diffidenza da parte
dell’ala più “machista” del mondo hc, il passaggio
Rearview Mirror /
95
a testi personali e sonorità più complicate seppe
farsi largo con costanza, inseguendo l’autenticità
dell’esporsi in prima persona e della conseguente
indipendenza e autogestione di processi produttivi e promozionali.
Quando - dalle ceneri delle due gemme della Capitol City di cui sopra - nascono i Fugazi (s/t;
Dischord 1988; 8,0/10), l’argomento acquisisce
tratti somatici chiari, anche se le targhette ancora
non sono state appiccicate.
In California spetta ai Jawbreaker recepire il
messaggio in composizioni vibranti e a lento rilascio, mentre nervi e ferite scoperte saranno appannaggio dell’etichetta Ebullition; alla tendenza
trasversale di San Diego, invece, il compito di
scandagliare modalità più oblique, ardite contaminazioni new wave senza negarsi furiosi assalti
sonici. Trattandosi di faccenda altamente “personale” (ma pur sempre di un privato costretto a
divenire pubblico, perché l’arte è in prima istanza comunicazione), l’assaporeremo attraverso
impulsività espressive, dischi e band che lasciano segni estemporanei, piccoli ma significativi e
spesso riscoperti a posteriori. Poi sarà il tempo
di un’autentica alluvione di gruppi e gruppetti
devoti a snocciolare accorate liriche alternando
carezze e aggressione. Curioso sulle prime, ma in
ragione di quanto sin qui scritto assai indicativo,
il passaggio di testimone a metà anni ’90 tra il
“Seattle sound” e le avanguardie emo avvenuto con i Sunny Day Real Estate, il cui Diary
(Sub Pop, 1994; 7,2/10) resta tuttora riferimento
di peso. La pelle che cambia all’infinito nel mondo indie è pronta ad accogliere il fenomeno, così
che esso risponde mutando senza sosta sulle ali
di complessità formale e drammaticità espositiva. Dai potenti e squadrati riff dei Quicksand
- influenti su decine d’epigoni, tra cui svettano i
Metroschifter di 4; Doghouse, 1997; 7,2/10)
- alle contorsioni dei Drive Like Jehu il passo
non fu breve, se si valuta che in mezzo ci finirono
la narratività dei Karate (s/t; Southern, 1995;
7,6/10) e la seconda ondata washingtoniana
96
/ Rearview Mirror
con i nerboruti Jawbox (Novelty; Dischord,
1991; 7,2/10) e le elucubrazioni di Shudder
To Think (Funeral At The Movies; Dischord,
1991; 7,0/10).
Quanto le cose si stessero però oltremodo confondendo, lo dimostrò l’insensata inclusione degli
Weezer e di altre band di stampo power-pop nel
filone. L’aspetto più tenue e melodicamente romantico, semmai, era indagato in profondità da
Texas Is The Reason e Sensefield, latori di sfoglie fragili però robuste che fornivano indicazioni
evidenti: un college-sound seducente e pindarico,
aperture alate colme di sferza e raccoglimento.
Come se Smiths o i Cure meno estenuati e più
chitarristici fossero nati su questo lato dell’Atlantico e innervati di piglio rockista squisitamente
americano.
Alla fine dello scorso decennio, l’emocore si frantuma ulteriormente mentre inizia a decadere e
cristallizzarsi: indaga una visione decadente della
provincia (Antioch Arrow), intavola commerci con lo shoegaze (Appleseed Cast: End Of
Ring Wars; Deep Elm, 1998; 7,4/10) e la trasversalità dei Pavement (i Van Pelt di Stealing
From Our Favorite Thieves; Gern Blandsten,
1996; 7,4/10); strizza le ultime gocce di sangue
rimaste (i Cursive, partiti come fedeli alla linea
e giunti, col commovente Domestica; Saddle
Creek, 2000; 7,8/10, al colpo di coda finale del
genere) e abbraccia l’impeto autodistruttivo dello
screamo. Infine muore sotto l’autoreferenzialità e
più di tutto le colate di saccarosio e luoghi comuni che scaleranno le charts nel pieno del terzo
millennio, nel quale i farseschi Blink 182 fanno cassa e la scena reagisce chiudendosi e moltiplicandosi in modo esponenziale. Il guitar-pop
smarrisce brillantezza e spontaneità spalancando
la porta all’artificio (si veda la parabola degli At
The Drive-In dopo In/Casino/Out; Fearless
1998; 7,4/10); allorché l’ammiccare ruffiano di
Dashboard Confessional, Joshua e Jimmy
Eat World conduce alle citazioni di O.C. e ai Fall
Texas is the reason
Out Boy, la misura è colma. L’emotività subisce
il contraccolpo del mercato e diviene messa in
scena; l’esercizio di stile paga e l’attualità non fa
sconti, sbatte per qualche mese il mostro al centro del palco e sotto il riflettore. Dentro il quale
finiscono i “ragazzi tristi” che - ci spiace - proprio non sono come noi. Che posseggono mille
risorse per comunicare ma non ne sono capaci.
Che si accontentano di sbocconcellare annoiati la
musica sull’Ipod perché sono nati piccoli e piccoli
resteranno anche da cresciuti. Noi, invece, arrischiavamo soldi in busta chiusa a minuscole etichette per ricevere in cambio uno scricchiolante
7” e ci scopriamo adulti adesso, ma lo eravamo
anche allora. Faccenda chiara da subito a Blake Schwarzenback dei Jawbreaker, che con
partecipato sarcasmo canterà in Boxcar un rivelatore “1-2-3-4, who’s punk? What’s the score?”. Avere
vent’anni…
Of Eyes And Misery.
“Il tuo posto è ancora al cure di ogni mia cosa, e devo
fartelo sapere.”
(Texas Is The Reason)
Nessuna delle band che hanno fatto la storia
dell’emocore ha mai apprezzato e tanto meno
condiviso l’essere inserita sotto tale cappello. Faccenda già vista con diverse sfumature per infiniti
generi e sottogeneri, ma col senno di poi lungimirante, alla luce della disastrosa deriva odierna.
Eppure, se la critica specializzata - soprattutto le
fanzine super underground - si è per tutto il decennio scorso fissata ossessivamente su quelle tre
semplici lettere, un motivo ci sarà. Occorre guardarsi indietro per capire, al solito: sviscerando lo
sviluppo delle frange più melodiche dobbiamo
chiamare in causa i sottovalutati Jawbreaker.
Unfun, (Shredder, 1990; 6,0/10), esordio del
trio californiano è un discreto mix di accelerazioRearview Mirror /
97
ne punk e immediatezza pop tagliato da urgenza
comunicativa adolescenziale. Solo a una più attenta analisi emergono i barlumi della cifra che
s’imporrà, come le liriche introspettive, il cantato sofferto e le improvvise decelerazioni sonore.
Semi che germogliano nel successivo Bivouac
(Tupelo, 1991; 7,8/10), dove la durata media dei
brani si dilatata e le trame strumentali si accodano senza smarrire veemenza; il ritmo rallenta e
lascia spazio a improvvisi cambi di tempo, a languidezze chitarristiche di arpeggi e sospensioni.
mineral
Protagonista è il cantante-chitarrista Blake Schwarzenbach che - notevoli capacità letterarie e
voce simile a Richard Butler - combina impeto
punk e sfera del privato nell’interpretazione intima e tormentata, malinconica e sentita: Shield
Your Eyes è emblematica per come indaga l’impossibilità nostra di scrutare la verità in un crescendo sonoro grondante elettricità. Nei successivi 24 Hour Revenge Therapy (Tupelo, 1994;
7,4/10) e Dear You (Geffen, 1995; 7,0/10), la
band interiorizza la lezione sulla scia degli altri
pionieri e mostra una via che saranno in tanti a
percorrere. I testi sfociano nell’intimismo diaristico, si sganciano dalla sfera politica inglobandola
98
/ Rearview Mirror
nel personale: tratti somatici di ciò che la stampa
definirà emocore, nientemeno. Da dove arriveranno sfumature e parafrasi, picchi qualitativi e cadute spossanti, tuttavia è evidente quanto questa
band (Schwarzenbach è poi tornato con i Jets To
Brazil di Orange Rhyming Dictionary; Jade
Tree, 1999; 6,8/10) esprimesse con personalità
istanze di cambiamento vive nel sottobosco musicale americano, riflesse tramite l’evoluzione tra il
primo e secondo lp. Sempre in California, infatti, i Samiam tracciavano col loro debutto (s/t;
New Red Archive,
1989; 7,4/10) altrettante coordinate
per future, assidue
frequentazioni:
il
tiro mostra obblighi verso l’hardcore
melodico, ciò nonostante il cantato sofferto e il raggomitolarsi chitarristico
allestiscono un rilevante corto circuito
emotivo. Le successive pubblicazioni
seguiteranno ad abbinare testi toccanti e atteggiamento
strumentale frenetico nei 33 giri Soar (New Red
Archive, 1991; 7,3/10) e Billy (New Red Archive, 1992; 7,3/10), dopo i quali l’impatto sonoro
andrà stemperandosi. Come loro, numerose altre band di “twentysomething” interpretarono
agli albori dei Novanta l’insegnamento di Grant
Hart e Bob Mould in una continua ridefinizione dei canoni. Ne risulta una miscela di velocità
esecutiva e mood confessionale che mira al cuore
di adolescenti e tardo adolescenti. I quali, occorre precisare, stavano dentro un confortevole alveo
underground tutto passaparola e nicchie: con un
sorriso di circostanza ricordiamo - e liquidiamo
- gli sciocchi sfottò dei fondamentalisti verso quel-
la che bollavano come lacrimevole deriva della
“fede hardcore”. Essendo l’attenzione della critica rivolta verso Seattle e il grunge, se la stessa e le
major si interessarono all’emo fu per scovarvi una
possibile next big thing. Facendo al contrario e puntualmente un buco nell’acqua e nell’autenticità
dei gruppi messi sotto contratto, costretti in un
ruolo che non gli apparteneva a soccombere sotto il peso delle mancate vendite. Del resto, quella
via di vivificare il punk nasceva da un’esigenza e
un sentire comuni che oltrepassavano le strategie
discografiche, abbeverandosi con moderna indole alla fonte del punk primigenio.
Durerà almeno fino a metà anni Novanta, cioè
fino a quel 1996 che segna fine della golden age.
L’impeto propulsivo scema e si riassume l’accaduto, spesso pubblicando antologie che compendiano la produzione dispersa di nomi importanti;
dall’altro lato, viceversa, l’industria annusa l’aria
e si getta sulla cosa a massificare, causando i danni che sappiamo. Tornando ad allora, l’energia
al servizio di cuore e mente restituiva un’onda in
perenne mutamento che - perfetta figlia del suo
tempo - assorbiva di tutto, anche se non sempre
focalizzato dalla corretta attitudine sincretica.
Nondimeno l’emocore restava vivo e pulsante
tourbillon, presente anche dove mai avremmo
sospettato e, tra le tante intuizioni, avrà enorme
seguito il soffio melodico - epico, mai banale - dei
Buffalo Tom (Let Me Come Over; Beggars
Banquet, 1992; 8,5/10). Caso emblematico la
label californiana Revelation, partita nell’87 coi
massicci Gorilla Biscuit e Youth Of Today
- da cui peraltro discesero i Quicksand (Slip;
Polygram, 1993; 7,4/10) - e più tardi albergo
di Sense Field e Texas Is The Reason, maestri dall’inconfondibile scintillio, imprescindibili quanto ad autenticità e fragranza dello stile. Nati dalle ceneri degli “old school” Reason
To Believe, i Sense Field consegneranno tre lp
da possedere prima di spegnersi in un contratto
major: dai saliscendi elettroacustici dell’omo-
nimo esordio (Revelation, 1994; 7,4/10) e la
transizione di pregio Killed For Less (Revelation, 1994; 7,3/10), sbarcheranno su Building
(Revelation, 1996; 8,0/10), affresco di melodie
spezzacuore, intrecci di chitarre e liriche raffinate. Al loro fianco siedono con pieno merito Texas Is The Reason (Do You Know Who You
Are?; Revelation, 1996; 7,3/10), formati dall’ex
Shelter Norm Arenas e all’opera con melodie
similmente struggenti. Altrove, case discografiche medio/piccole ma pugnaci evidenziavano
la fertilità della scena, spesso aprendo le porte
a band il cui suono esulava dagli stilemi, espandendosi a macchia d’olio negli Stati Uniti e anche nel nostro paese. Ecco sbocciare Boy’s Life
(s/t; Crank!, 1997; 7,3/10) e Mineral e i loro
bozzetti malinconici però guizzanti. Soprattutto i
secondi sembravano incarnare una certa concezione “piangente” dell’emocore in The Power
Of Failing (Crank, 1997; 7,5/10), languido e
uggioso nelle atmosfere che ragionano d’amore. Una tendenza per così dire “soffice” di cui
la label Jade Tree si fa portatrice con il pop-indie
di Promise Ring (Nothing Feels Good; Jade
Tree, 1997; 7,2/10) e la Polyvinyl con gli acuti
Braid (Frame And Canvas; Polyvinyl, 1998;
7,2/10), punte di un sommerso gradevole ma
troppo spesso stracolmo di band-fotocopia o di
convertiti alla moda del punk sentimentale. Qui
il nocciolo della questione e l’inizio della rovina:
tra i molti che rimedieranno figure artisticamente
mediocri, vi sarà addirittura qualcuno capace di
farsi baciare in fronte dal successo. Questo sarà il
colpo mortale: l’iperproduzione influisce sul livello medio delle uscite e ben presto ne avremo tutti
le tasche piene. In modi diametralmente opposti, allo scoccare del 2000 furono Get Up Kids
(Four Minute Mile; Doghouse, 1997; 7,2/10)
e Jimmy Eat World (Clarity, 1999; 6,0/10)
a sancire la capitolazione. Meglio senza dubbio
i primi che - sinceramente indebitati con i Jawbreaker al punto da citarli nelle liriche - si sfalderanno in un dapprima passabile e poi anonimo
Rearview Mirror /
99
pop-rock universitario, senza peraltro cedere al
mainstream; cosa che faranno i secondi, scaltri
nel catalizzare su di sé l’attenzione al momento
propizio, spuntano un contratto con la Capitol
grazie a suoni laccati e poco convincenti. Da qui
in poi le cose si fanno sommamente patinate e
diteci se non vi è cosa più lontana dall’emozione; le
due band - forse inconsapevolmente, ma tant’è offrono sul piatto d’argento i modelli dell’attuale
baraccone. Amaramente, l’irrigidimento formale
dell’emocore avviene là dove tutto era iniziato,
cosa di per sé coerente alla sua natura elusiva.
Fatta di pensieri e parole che volano via veloci
come fotogrammi, noi dietro a inseguirli con il ricordo. Provando a fermarli per sopravvivere alla
bruttura odierna.
The Rebel Sounds Of Failure.
“Non c’è alcuna stabilità nella storia, ci si trovano solo
bugie su bugie.”
(Native Nod)
Ci piace iniziare da un libro, poiché spesso sono
le immagini a servire da icona e rendere al meglio
un’idea. The Unheard Music – Photographs 1991-1997
è il testamento visivo lasciato da Chrissy Piper
nel 1997, documento che immortala una stagione dell’underground americano tra le più feconde
dello scorso decennio, la cui influenza rimane tuttora ben avvertibile. Nel volume sfilano, in rigoroso bianco e nero, alcuni dei protagonisti di quello
che genericamente definiremmo “emocore”, folto
contingente che abbraccia lo spettro del rock chitarristico da ciò che un tempo era il college rock
a più vandaliche escursioni nel metal e nel rumore. Sono immagini che si commentano da sole e
restituiscono un fenomeno che ha positivamente
“corrotto” la gioventù statunitense, riportando in
auge l’autoproduzione e l’autogestione, amplificandole con un impegno socio-politico legato a
una mai doma spiritualità. Scorrono, tra le tante,
100
/ Rearview Mirror
immagini di un giovane Eric Richter dei Christie Front Drive mentre digrigna i denti e degli
sfuggenti Clikatat Ikatowi. Da qui passa buona parte del racconto: se la “Summer Of Love”
washingtoniana dell’86 aveva rappresentato la
stagione della semina, servì un decennio scarso
perché l’universo indie americano si scoprisse
abitato da gruppi che trafficavano con l’aggettivo
heartfelt. Spesso ci siamo interrogati sulle origini
di questo suono, ma la strada appare nitida osservando le numerose micro scene localizzate in
California, quell’iceberg con punte gemelle nelle label Gravity ed Ebullition dal quale promana
una comune fascino per la new wave soprattutto
britannica. Influenze dichiarate scopertamente
dai diretti interessati, peraltro, giacché bastava
scorrere i “poll” di fine anno della fanzine “Heartattack” (redatta da Kent McClard, deus exmachina dell’Ebullition) per leggere - tra i gruppi
migliori di tutti i tempi - i nomi di Joy Division e
Smiths. Fatto che non sorprende, piuttosto evidenza la radice di un afflato emozionale dal quale originano anche gli accenti più marcatamente
antagonistici.
Radici sedate eppure assai nobili stanno anche
alla base di una vena astrattamente romantica
che spesso si affaccia nei testi di Native Nod,
Current (Complete Discography; Council
Records, 7,2/10) e Indian Summer. Nulla di
più svagato se riferito alla vena “nuda e cruda”
della scuola newyorchese, ma altri sono filosofia e segreto: congelare le emozioni per lasciarle esplodere in fragorosi crescendo; un tentativo
riuscito di mappare sonicamente l’intimità con
tutte le sue contraddizioni e i suoi saliscendi. Ne
fa fede l’attitudine che farà grandi i Native Nod
di Chris Leo, successivamente agli onori della
cronaca coi pensierosi Van Pelt. La formazione
- giunta dalla costa orientale al banchetto “made
in New Jersey” della Gern Blandsten - registrerà una manciata di 7” e un lp (Today Puberty,
Tomorrow The World; Gern Blandsten, 1996;
7,4/10) offrendo un manifesto in Back To Mim-
swing kids
sey, memorabile danza adolescenziale all’ombra
di louisvilliane raffinatezze. Proprio da là, dall’inconsapevole cittadina in cui il rock incontrava nemesi e successiva rinascita, si dipana un’asse che
guida nuovamente a Washington, D.C. chiudendo un cerchio. Nel triennio ’93-’96 si consuma
la transumanza dall’emotività tipica della prima
Dischord alle destabilizzazioni del formato canzone. Ne sono fautori i Crownhate Ruin (Until The Eagle Grins (Dischord, 1994; 7,3/10)
di Fred Erskine, Joseph McRedmond e Vin
Novara, che piegavano agilmente post, indie e
hardcore dentro distensioni atmosferiche, ma soprattutto il progetto parallelo portato avanti da
Erskine e McRedmond tra 1992 e 1994: ovvero
quegli Hoover che nel superbo The Lurid Traversal Of Route 7 (Dischord, 1994; 7,8/10)
influenzarono addirittura i Fugazi di In On The
Kill Taker. Da riscoprire per l’autorevolezza di
tessiture che sposano la potenza sbieca di Drive
Like Jehu alle traslucide pensosità degli Slint. Solo
una felice e logica conclusione, allora, che Erskine sia poi entrato nei fondamentali June Of 44.
Musica di brusche risalite, questa, come lo era
quella ordita dai Native Nod, che rischiavano imberbi di avvicinarsi allo stridere di trombe e ugole
architettato da Nation Of Ulysses e ripreso dai
Cap’n Jazz, alias dei fratelli Kinsella pre Joan
Of Arc (Analphabetapolothology, discografia completa; Jade Tree,
1998; 7,2/10). Non accadrà: progressivamente
si approprieranno di una
ipnosi che raccoglie il fervore armonico e la penna
del post-punk, anteponendo all’immediatezza
l’intarsio. Ancora più paradigmatica la parabola del culto Moss Icon
(Lyburnum Wit’s End
Liberation Fly; Vermiform, 1994; 7,5/10): provenienti dal Maryland e
condizionati dal caos emotivo della capitale, matureranno una dimensione vicina alle eteree propaggini di certo post-rock. Nascono nel 1986 e
la loro è una fuga temporale per post-adolescenti
ancora alla high school apparentemente come
tante; dopo il 12” It Disappears (lo trovate nella
versione cd di Lyburnum…) affrontano le registrazioni dell’album, vero e proprio travaglio che non
uscirà fino al 1994. Il suono è sorprendente, dilatato e orizzontale, fiorente di declamate liriche
sottili - ne faranno tesoro i Van Pelt - che espande la grammatica del genere. Farina del sacco
di Tonie Joy, vera mente del gruppo, sincero e
competente appassionato di musica che presterà
servizio come bassista nei Born Against e proporrà opere preziose con Universal Order Of
Armageddon (s/t, discografia completa; Kill
Rock Stars, 1996; 7,0/10). Band accasatasi presso la Kill Rock Stars, il cui capoccia Slim Moon
mai ha celato la propria “ascendenza” e che,
guarda caso, salderà il conto ristampando l’intera
discografia dei Born Against stessi.
Diramazioni pressoché inesauribili, avrete inteso,
testimoni di un’influenza permeata ovunque e
perciò non sempre facile a distinguere. Un poliedro che specchia il post rock e le trasfigurazioni
indie degli Unwound, firmatari del numero uno
Rearview Mirror /
101
su Troubleman Unlimited (s/t; Troubleman Unlimited, 1993; 7,4/10). Casa discografica che, dal
decentrato New Jersey, anticiperà molti “luoghi”
dell’underground contemporaneo, nella quale
transiteranno ad esempio Black Dice, Wolf
Eyes e Young People e che accoglie gli enigmatici Hal Al Shedad (Textures Of Tomorrow;
Troubleman Unlimited, 1998; 7,3/10). Picco da
riscoprire di un catalogo policromo, al pari di un
vinile condiviso tra Karp e Rye Coalition (s/t;
Troubleman Unlimited; 7,3/10), dove al bellicoso incedere melvisiano dei primi risponde il passo
trafitto dal melodramma dei secondi, ipotetica
congiunzione tra Nation Of Ulysses e Rodan.
All’interno di un quadro folto e intersecato fino
allo stordimento, ricordiamo che i Rye Coalition
sorsero dalle ceneri di una delle più divinatorie
esperienze dell’East Coast, i sofferti Merel (s/t;
Gern Blandsten, 1995; 7,4/10). Linguaggio adeguatamente spiritato e persuasivo, non dissimile
alle pagine più raccolte della casa d’eccezione
Ebullition. Situata a Goleta, dove il “padrino”
McClard organizzava un seguitissimo festival,
la label è (stata) tra le più attive del circuito grazie alla robustissima filosofia DIY e allo spiccato
carisma, coi quali ha trasceso le angustie autoreferenziali di una scena talvolta affossata da esagerazioni autocelebrative. Anarchico convinto
abile a predicare ma soprattutto razzolare, Kent
ha funto da eminente spauracchio e taste maker,
suscitando l’ammirazione di numerosi estimatori
e le ire di altrettanti detrattori. Al di là di faide
e chiacchiere, nessun dubbio sussiste sul ruolo
fondamentale giocato dalla sua label nel delineare alcune caratteristiche sonore e “ideologiche”
dell’emocore. Erette anche sullo scontro politico
attraverso “Heartattack”, che della label è tuttora
agenda e portavoce, le sue provocazioni non sono
mai state gratuite, semmai conseguenze coerenti
di una concezione quotidiana dell’attivismo (eh,
Hüsker Dü…) e della riflessione sui rapporti umani. Laddove non sconfina nel gratuito, dal punto
di vista sonoro Ebullition offre esempi tra i più
102
/ Rearview Mirror
azzeccati del lato più ruvido dell’emocore: chiodi
e vetri strusciati sulla pelle per sentirsi più vivi,
i ciclonici Portraits Of Past (s/t; discografia
completa; Ebullition, 2008; 7,4/10) e i militanti
Econochrist (Discography, Ebullition, 2000;
7,2/10); i meditativi Amber Inn (All Roads
Lead Home; Ebullition 1999; 7,5/10) e Iconoclast (s/t; discografia completa; Ebullition,
2000; 7,4/10); realtà misconosciute come Policy Of 3 (Anthology; Ebullition, 2004; 7,0/10)
o romantiche tipo gli Still Life (From Angry
Heads To Skyward Eyes; Ebullition, 1997;
7,4/10) sprigionavano materia densa adatta a
riflessioni ed esaltazioni. Straziante quanto straziato e genuinamente punk nell’anima, il sound
fondeva noise e metallo a toccanti pause introspettive. Di tale abrasivo diletto, le summenzionate formazioni rappresentano l’apice assoluto
prima che gli epigoni Locust (a capo l’arbiter
elegantiarum, ambiguo “uomo-scena” nonché ex
Swing Kids Justin Pearson), Orchid e Crimson Curse volgarizzino la miscela in pose e
ipercinesi violence, null’altro che pantomime prive
dell’originaria sfida sociopolitica. Più sensato, tra
il rarefarsi delle uscite discografiche e il naturale
mutare in clichè, rifugiarsi nella “all star band”
Yaphet Kotto (tre lp all’attivo, il più significativo
The Killer Was In The Government Blanket, Ebullition 1999; 7,4/10) o nello sguardo al
passato di Bread And Circuits (s/t, Ebullition, 2000; 6,8/10); altrimenti commemorare i
Mohinder (Everything, discografia completa;
GSL, 2001; 6,8/10), brevemente attivi nell’epoca d’oro e seconde schiere delle più apprezzabili.
Accanto a Goleta, l’altro eccellente polo californiano era localizzato a San Diego, d’influenza al
pari importante ma lontanissimo per espressività,
incanalata in uno sfaccettato “art post hardcore”. Spetta al marchio di garanzia Gravity documentarne le gesta, benché uno dei gruppi colà
migliori - i Julia - incidesse per Bloodlink (s/t;
1998; 7,3/10). Il trittico che incarnava il fiore
all’occhiello era composto da Angel Hair, An-
tioch Arrow e Clikatat Ikatowi, formazioni
cruciali tanto quanto i catastrofici Heroin (s/t,
discografia completa; Gravity, 1997; 7,7/10) per
come ripescarono, in epoche non sospette, stilemi new wave poi propagatisi ovunque. Gli Angel Hair (Pregnant With The Senir Class,
discografia completa; Gravity, 1998; 7,8/10) di
Sonny Kay - in passato intestatario del marchio
Gold Standard Laboratories, ora illustratore per
Mars Volta - erano spiritati e caotici, dall’ordito
chitarristico secondo solo al capitale e ingegnoso math & roll dei concittadini Drive Like Jehu
(Yank Crime; Interscope, 1994; 8,0/10). Del
resto, da una band capace di maltrattare Stigmata
Martyr dei Bauhaus non ci si poteva che aspettare grandezza, che toccherà al sequel VSS portare avanti; una cover che fa il paio con la Warsaw eseguita da Swing Kids (Discography; 31G,
1999; 7,4/10), altro nome per pochi tuttavia
rilevante non solo per gli sviluppi successivi cui
si accenna poco sopra. Discorso che vale anche
per Antioch Arrow che, abbandonata la Gravity
e gettati i semi dell power violence, si inventeranno
un’immagine glamour e un superbo lp tra glitter ’70 e teatro no-wave come Gems Of Masochism (Amalgamated, 1995; 7,8/10), prima di
perdersi in mille rivoli di cui vale la pena citare
almeno i Get Hustle del batterista extraordinaire
Ron Avila. Come era Mario Rubalcaba, ex
talentuoso skater sedutosi a mulinare tamburi e
piatti per Clikatat Ikatowi (Orchestrated And
Conducted; Gravity, 1996; 7,8/10), appuntito
oggetto di venerazione tra i più enigmatici e fascinosi di tutto il post-punk statunitense. Ragionevole perciò che Rubalcaba - dopo un intervallo
speso con Black Heart Procession - vesta oggi
dignitosi panni hard rock e gli altri siano dispersi
dopo stimolanti esperienze filo-jazz. Destino analogo per Seth Nanaa, attualmente batterista free
jazz a New York e un tempo parte integrante di
Indian Summer (Science, discografia completa;
autoprodotto, ; 7,3/10) da Oakland, California.
Il loro stile, continuamente caratterizzato da memorabili armonie, rimarrà a lungo efficace termine di paragone negli anfratti più remoti della
scena di riferimento.
La nostra indagine potrebbe tranquillamente
proseguire e perdersi dentro infinite altre traiettorie fino a sconfinare nel maniacale. Meglio allora
fermarci a un passo dal sovraccarico sensoriale e
rimarcare, un’ennesima volta, quanto quei dischi
amorevolmente curati, quei sassi gettati contro
l’indifferenza, quel sincero tormento esistenziale
fossero teatro di uno snodo importante del suono anni Novanta. Di quelli in grado di proiettarsi oltre e durare nel tempo, a dispetto tanto
dell’aberrante mainstream che delle parrocchie
underground. Ecco perché, a quasi due decenni
di distanza, ancora suonano fresche, coinvolgenti, sincere. Erano e rimangono affari del cuore, e
il segreto è, in fin dei conti, ben conservato lì.
Rearview Mirror /
103
Ristampe
Birdsongs Of The Mesozoic - Dawn
Of The Cycads: The Complete Ace Of
Hearts Recordings (1983-1987) Cuneiform
Preziosa e curatissima ristampa in doppio cd dei
primi passi mossi dall’entità Birdsongs Of The
Mesozoic, all’epoca ancora progetto laterale di un
paio di Mission Of Burma, Roger Miller e Martin
Swope. awn Of The Cycads compila le uscite targate Ace Of Hearts, in rigoroso ordine filologico:
l’omonimo ep dell’83, Magnetic Field del 1984 e
Beat Of The Mesozoic dell’86, con l’immancabile
aggiunta di bonus e perle sparse. In questo caso
non sono le prime a farsi notare (Pulse Piece, The
Common
Sparrow e POP Triassic
provengono dalle stesse session di
Magnetic Field),
quanto
l’intero
set del Live From
Nightstage
del
maggio dell’87 che
ci mostra il quartetto (forse) all’apice dell’espressione artistica. Considerando le 20 pagine del booklet in cui ognuno
dei quattro BOTM – Roger Miller, Erik Lindgren,
Rick Scott e Martin Swope – ricorda le circostanze
della nascita del gruppo e un intero archivio contenuto nel secondo disco e completo di poster, foto,
lyrics, partiture, scansioni di set live e stravaganze
104
/ Rearview Mirror
varie, ecco che la musica contenuta in Dawn Of
The Cycads potrebbe correre il rischio di passare
in secondo piano. E invece non è così. Fermo restando la notevole distanza temporale dalle registrazioni e anche l’attestarsi della band su lidi più
propriamente prog – non un declino, ma quasi –
c’è da dire che l’art-rock strumentale, vagamente
classicheggiante, imparentato col prog meno borioso e pomposo non mostra la corda, anzi si fa
apprezzare ancor di più. Un ottimo ripescaggio,
non esclusivamente per fan. (7.0/10)
Stefano Pifferi
Eluvium - Life Through Bombardment (Temporary Residence)
Esercizi di memoria o rimpianto nell’annunciato
box Life Through Bombardment per il compositore Matthew Cooper e l’etichetta Temporary
Residence.Un’uscita limitata alle 1000 copie che
racchiude in 7LP tutta la formula Eluvium, inediti dal prezioso formato e contornate squisitezze
da collezionismo tra pieghevoli, finezze di stampa, autografi d’artisti e note di copertina.
L’operazione a dir poco imponente a tratti potrebbe sembrare limitata o indirizzata solamente ai fan
più incalliti, ma non è questo il caso.Acquista bellezza Life Through Bombardment nell’interezza di
lettura che rasenta l’opera tra ritrovate naturalezze
in stesura e corollari dal biografico stile.Le coordinate rimangono tali, riconducibili ai mutati percorsi dell’artista, dai crescendo elettroacustici (The
Unfinished) passando per le armoniche in chitarra
(Under The Water It Glowed), le esplorazioni in
drones dalla scrittura ambient (Zerthis Was A Shivering Human Image) o le puntuali introspettive
in piano (Genius And The Thieves) che diventano
centralità (Perfect Neglect In A Field Of Statues)
tra classica ed impeccabile tecnica (The WellMeaning Professor). Ci sono poi
le modularità, le
sovrapposizioni
in pulviscoli elettroacustici (New
Animals
From
The Air) i tappeti
e le dilatazioni di
fondo (Area 41),
le volute prime fila di chitarra (Taken),le tonalità
ibridate (One) o inguaribilmente malinconiche
(Swallows In The Bath).Si racconta Life Through Bombardment dagli acustici amori giovanili di
Lambert Material (2003)che muovono i primi passi attraverso l’elettronica per poi acquistare continuità timbrica e di sfumatura in Talk Amongst
The Trees (2005), consacrate alla lunga distanza
Behind Your Trouble (2005) e maturate nelle variabili vesti di Copia (2007). Prendendo distanza
dalla freddezza della raccolta e concentrandosi
su quella vera e propria arte a cui molti cercano
di avvicinarsi ma a cui pochi sanno avvalersi con
profonda cultura ed ispirata eleganza tra realtà
e sogni.C’è chi li rinchiude in un cassetto e chi li
adopera tra inediti in cofanetto, qualunque scelta
si faccia, basta ricordarsi ogni tanto di rispolverarli
e riscoprirli con cura!
(7.0/10)
accluso nel 40th Anniversary Box che la ReR sta
per mettere in commercio allo scopo di festeggiare i
quattro decenni dall’atto di fondazione degli Henry
Cow. Nati a Cambridge nel 1969 - ed autori di una
serie di capolavori quali Leg End(Virgin, 1973), Unrest (1974), Desperate Straights (1975, con gli Slapp
Happy) e In Praise Of Learning(1975) - gli Henry
Cow qui testimoniati stazionano dalle parti dell’ultimo studio album citato, quello del 1975, dibattendosi fra improvvisazione libera pura (Stockholm 1)
e istrionismi zappiani esercitati con piglio liederistico da Dagmar Krause (Erk Gah). Nella line up dei
due concerti (strepitosi!) nel cd contenuti - il primo
suonato a Stoccolma il 9 Maggio 1977 ed il secondo a Göteborg il
28 Maggio 1975,
entrambi poi trasmessi dalla radio
svedese Tonkraft
- figura il redivivo
Lindsay Cooper,
senza il quale la
band diede vita a
In Praise Of Learning ed appena tornato in formazione con l’Aprile
del 1975. Stockholm & Göteborg, per quanto mi
riguarda, non vale meno del grande doppio Concerts (Compendium, 1976), registrato in parte ad
Udine. Georgie Born, Lindsay Cooper, Chris Cutler, Fred Frith, John Greaves, Tim Hodgkinson e
Dagmar Krause danno qui il meglio di sé, fra una
cover jazzata di Ochs (No More Songs) e set freeimpro irresistibili (Göteborg 1 e Stockholm 2). Un
disco da avere assolutamente!
(8.0/10)
Massimo Padalino
Sara Bracco
Henry Cow - Stockholm & Göteborg
(ReR Megacorp)
Tempo di celebrazioni per la band pilota del Rock
In Opposition anglosassone nei 70’s. Stockholm &
Göteborg, bene precisarlo da subito, verrà anche
Lafayette Afro-Rock Band - Darkest
Light: The Best Of (Strut Records)
Maledetta Strut: non fai nemmeno in tempo ad
archiviare le raccolte pubblicate l’anno scorso che
già, bellicosa più che mai dopo la rinascita, la label
capitanata da Quinton Scott apre il 2009 calanRearview Mirror /
105
do un asso niente male. Splendidamente suonante
grazie a un remastering coi fiocchi, questo stipatissimo cd mette in fila quindici irresistibili gemme
di una formazione misconosciuta del “seventies
funk” e dalla storia piuttosto curiosa: formatisi a
Long Island come Bobby Boyd Congress, nel 1971
si trasferivano armi e bagagli in Francia a causa
dell’eccesso di concorrenza. Perso per strada Boyd,
i membri restanti si ribattezzavano Ice- un terzo di
scaletta è dedicato a loro: il sound
è lievemente più
“easy” e spaziale:
piacerà ai fan degli
Air - per divenire la
house band dello
studio Parisound di
Pierre Jaubert. Diventati di casa nel
quartiere parigino di Barbesse grazie a infuocate
esibizioni e alla forte presenza di immigrati africani, fecero sì che le influenze del continente nero
(evidenti soprattutto nelle trame percussive) s’infiltrassero via via dentro al loro ipnotico e sensuale
funk intessuto di grasse tastiere, fiati rutilanti e voci
in costante “call & response” che qui ci si premura di riassumere. Allorché decisero di debuttare su
lp nel ’73, già erano divenuti Lafayette Afro Rock
Band, ragione sociale mantenuta per ulteriori due
ottimi album (Soul Makossa e Malik); dopo un
altro vinile come Ice fecero ritorno in madrepatria e si sciolsero nel ’78. Ora: se chiedete a Public
Enemy, Jay-Z e De La Soul cosa ne pensano, vi
risponderanno che il fatto di averli campionati più
volte è omaggio che parla da sé e sottoscriviamo
in pieno. Stessa cosa per quanto concerne gli appassionati di quello che oltremanica passa sotto il
nome di “hard groove”. Per tutti costoro, e per chi
verso la black nutra qualcosa più di un interesse
superficiale, Lafayette Afro Rock Band rappresenta un’autentica manna in caduta libera dal cielo.
(7.6/10)
Giancarlo Turra
106
/ Rearview Mirror
Lloyd Cole - Cleaning Out the Ashtrays - Collected B-Sides and Rarities 1989-2006 (Tapete Records)
Il 1984 inglese viene ricordato anche per l’esplosione di un album, Rattlesnakes, a nome Lloyd
Cole and the Commotions, in cui si coniugavano
songwriting classico USA alla Leonard Cohen/
Lou Reed/ Bob Dylan con attitudine new wave
e un senso tutto british dell’introspezione, anche
letteraria, in una versione ancor più dolente, se è
possibile, del pop Smiths-iano che seguirà.
La parabola di Cole, uno dei talenti meno emersi
dalla sua epoca, poi è stata molto breve: il tempo
per altri due non memorabili dischi (fino al 1987)
e il successivo scioglimento del gruppo, che in realtà già da tempo
cominciava a stare
stretto all’ eclettico
ed irrequieto cantautore, innamorato dell’America e di
New York. E infatti
lì si trasferirà da
fine ’80 in poi, fino
a tutt’oggi. Comincerà quindi una carriera solista altalenante per
resa, che mostra comunque interessi ad ampio
raggio, forse mai ben focalizzati e finalizzati fino
in fondo, ma raramente banali. Un musicista che
avrebbe certamente meritato maggiore considerazione e fortuna.Così tra rock, pop, soul, orchestrazioni, songwriting urbano e poetico, si assiste
a una parabola più che trentennale, che viene attraversata in minore - questa la scelta tematica
- con b-sides, demo, live, inediti e cover, testimoni
quest’ultime dell’essere “fan” e “omaggiatore” ad
ampio spettro. I nomi coverizzati sono svariati,
dagli amati Marc Bolan, Cohen, Dylan, Reed,
Television, fino a Tim Hardin, Arthur Lee, Burt
Bacharach & Hal David e Nick Cave.Il percorso
della raccolta è cronologico, fin dagli anni iniziali
nella Grande Mela, dove comincia a collaborare
con Robert Quine e Fred Maher nei primi album,
fra i quali spiccano Don’t Get Weird On Me, Baby
(1993), quest’ultimo anche con Paul Buckmaster,
e Love Story (1995) due degli highlight del percorso artistico, dove songwriting, accenni di folk
e tanto pop orchestrale si incontrano, a raggiungere ed eguagliare, in una versione più “adulta”
il Rattlesnakes degli esordi. Seguono successive
collaborazioni con Stephen Street, riavvicinamenti ai Commotions, vendite non esaltanti, fino
al ritorno alla forma nel 2003 con Music In A
Foreign Language uscito su Sanctuary.Non tutto è focalizzato in questa messe di brani, molti
sono perlopiù bozzetti appena accennati. Altrove
si assiste al recupero di non trascurabili b-side e
materiale sparso, a dimostrazione del fatto che
quando era centrato e ben prodotto, il Nostro si
esprimeva al meglio. Una tensione emotiva e lirica mai spenta, nutrita di suggestioni tematiche e
letterarie forti, insieme ad una buona capacità di
scrivere canzoni accorate ma mai retoriche, agrodolci ed autoironiche insieme, con autoriflessioni
sul proprio essere uomo del nostro tempo: tutte
caratteristiche che fanno di Lloyd Cole un testimone, sia pur rimasto in disparte, della nostra
tormentata contemporaneità.
(7.4/10)
Teresa Greco
Red Red Meat - Bunny Gets Paid (Sub
Pop)
Il punto focale attorno al quale da sempre ruota
la carriera di Tim Rutili è il blues. Da intendersi innanzitutto come categoria dello spirito e, di
conseguenza, faro della sua indagine sonora. Mai
un passo falso in vent’anni o poco meno, giusto
gli inizi incerti nel panorama indie americano
con i discreti Friends Of Betty, e da lì in poi solo
oro. Dai carati variabili, va da sé, come del resto tocca a chiunque perfezioni la propria Arte
nello scorrere degli anni; chi - ed è gente sempre
più rara - lavora di bulino e cesello allo scopo di
dar voce all’animo e ai suoi moti. All’interno di
un percorso tuttora in movimento con i Califone,
Bunny Gets Paid era per Red Red Meat un passo
- come dire… - meravigliosamente intermedio:
seguiva l’omonimo esordio promettente e ruvido
e un secondo passo sofferto ma assai più focalizzato come Jimmywine Majestic, a mezza via tra gli
Stones straccioni dei primi ’70 e una Magic Band
acquietata. Delle intuizioni sfoggiate in ambedue
rappresentava apogeo colmo di passi narcolettici
e stupefatti così tipicamente anni Novanta, però
irrobustiti dalla profonda conoscenza critica dei
fondamentali tecnici ed espressivi. Incanto e malinconia rendevano già allora indimenticabili il
post rock venato soul Chain Chain Chain, le dodici battute strapazzate da Taxidermy Blues In
Riverse, lo stile che inizia a farsi riconoscibile marchio di fabbrica in
Sad Cadillac. Giri
la moneta e trovi il
contrappunto dolente sotto forma di
struggenti ballate
corali (There’s Always Tomorrow) o
estasi da bassifondi
(non è un ossimoro: ascoltare per credere Oxtail,
Buttered.) Bellezza da masticare avidamente,
perché poi arriverà lo sconvolgente kraut-blues di
There Is A Star Above The Manger Tonight e
nulla sarà lo stesso anche per la band. Che andrà
in frantumi sotto il peso di un tale capolavoro, del
quale qui si gettano ben più che le mere basi. Lo
sapevano benissimo i diretti interessati allora e lo
conferma oggi la Sub Pop, tornando sulla scena
del crimine con una doppia ristampa “deluxe”
che, nel secondo cd contente materiale poco o
affatto noto, mostra un po’ di futuro dub e offre a
mo’ di sottolineatura un pugno di demo, inediti e
versioni alternative. Soprattutto, consegna finalmente i Red Red Meat nel novero dei classici di
ogni epoca. (7.8/10)
Giancarlo Turra
Rearview Mirror /
107
(GI)Ant Steps #25
classic album rev
Frank Zappa
Alan Parsons Project
Hot Rats (Bizarre, 1969)
Tales Of Mystery And Imagination (charisma, 1976)
Hot Rats è il lascito zappiano forse più conosciuto
e apprezzato dai rockofili. Non senza qualche fraintendimento. Ma è soprattutto un disco importante,
pionieristico. Un classico rock. Jazz-rock. Forse, jazz.
Se questa rubrica vuole suggerire possibili approcci
jazz per chi di solito mastica rock, Hot Rats pare, per
paradosso, quasi doveroso. Oggi – acqua sotto i ponti
ne è passata ed anche il post-moderno è roba vecchia
– potrebbe anzi essere considerato un classico del genere: tra le prime, ancora ruvide, miscele jazz-rock,
abbrivio imperfetto di quella che poi sarà la fusion.
Dalle parti, ma le differenze sono abissali, di Bitches
Brew. HR non è il disco di Zappa come spesso si sente dire: è semplicemente un suo disco molto bello. E
importante. Da’ il via alla sua carriera post-Mothers,
ne sdogana le qualità di chitarrista, HR disco jazz di
Zappa. Con tutte le ambiguità del caso. Lui che non
amava particolarmente questo linguaggio che pure ha
praticato (si pensi a King Kong, che lo accompagnerà
da Lumpy Gravy fino all’ultima tournée), e dalle cui
fila ha tratto la meglio crema dei suoi (tre nomi: George Duke, Jean-Luc Ponty, Vinnie Colaiuta). Amava certa roba free & dintorni, e figure di culto come
Don Ellis, esperienze ritagliate ad hoc per nutrire gli
sperimentalismi free(k) dei Mothers. Ma di tutto questo in HR c’è poca traccia. Jazz qui in un’accezione
più morbida, sfumata, paradossalmente, meno zappiana. Vediamo. Registrato su un 16 piste artigianale,
vero tripudio di sovrincisioni, HR è un lussureggiante
intrecciarsi di chitarre, tastiere e fiati, con Ian Underwood, già Mothers, a farla da padrone. L’effetto
finale è vividissimo: timbriche, densità e dinamiche
a metà tra cariche orchestrali, coloriture bandistiche
Nel 1976, il ventottenne Alan Parsons, prima didecidere di farsi avanti come autore, era già un’istituzione
nel campo dellapopular music. Negli anni in cui la figura del produttore comincia ad imporreall’attenzione
del pubblico il suo ruolo decisivo e determinante non
soloriguardo all’aspetto tecnico, ma anche creativo,
dei prodotti discografici,Parsons ha già un bagaglio di
esperienze invidiabile. Trovato il suo alter ego creativo
in Eric Woolfson,musicista dilettante, ma con qualche
esperienza come compositore legata aglianni del beat,
il gioco è fatto: nasce la prima band di non musicisti
dellastoria del rock: The Alan Parsons Project, un collettivo di musicisti scelti inbase alle composizioni e con
un’orchestra sempre presente, diretta da AndrewPowell. L’idea di esordire con un concept album basato
suiracconti di Edgar Allan Poe deve aver spaventato
un po’ la critica e creatoaspettative che hanno condizionato l’accoglienza dell’album, a dire la veritàun po’
freddina. Con il senno di poi, che permette di analizzare le opere inrelazione al percorso successivo (e talvolta completo) degli artisti, ci mostrainvece un lavoro
premonitore, anticipatore di quelle soluzioni musicali
cheavrebbero fatto la fortuna del Parsons musicista nel
decennio successivo. Deveessersene accorto anche lo
stesso autore, altrimenti non si spiegherebbe ilmotivo
del ritorno in studio, undici anni più tardi, per remixare
tutto l’albumed aggiungere la voce recitante di Orson
Welles, curiosamente esclusa dalla primaedizione. Un
evidente gesto di considerazione verso un album che,
guardatodall’alto sta esattamente tra i pesanti arrangiamenti orchestrali di Atom EarthMother dei Pink Floyd
e la svolta synth pop. Seppure i moog e i sintetizzatori
sono lontani dal ruolo predominanteche avranno negli
anni a venire, lo stile è già orientato verso la direzionefutura. Nell’arpeggio di chitarra dell’iniziale A Dream
Within A Dream ci sonogià, in embrione, le atmosfe-
108
/ Rearview Mirror
e combo jazz. Ospiti di lusso: Beefheart, nell’unica
canzone, e i violini di Sugar-Cane Harris e Ponty.
Lowell George, anche lui già Mothers, poi anima
dei Little Feat, alla ritmica (ma non è accreditato) e
vari turnisti jazz a spartirsi basso e batteria. Peaches En
Regalia è uno dei classici zappiani, capolavoro di ironia musicale tutto da fischiettare, dai mandolinismi
iniziali alla giocosa ripresa del tema nel finale. Willie
The Pimp, blues-rock secco, riff semplice e ficcante,
vede il cameo del Capitano, che le appiccica addosso il suo marchio catarroso e sbraitante. Son Of Mr.
Green Genes, arzigogolo del Mr. Green Genes già su Uncle Meat, scopre sorprendenti affinità con Peaches e
presenta uno dei soli di chitarra più generosi e avvincenti di tutta la discografia zappiana. Little Umbrellas
(il cui ciondolante gioco contrabbasso-piano-batteria
sarà campionato dai dEUS per First Draft), in un una
parola, e scusate il bisticcio, umbratile, è un pezzo praticamente lounge, ma dall’incedere sottilmente sinistro. The Gumbo Variations, lunga jam, è lo showcase
delle contorsioni al sax di Underwood. Inquietudine
sottile che riprende e sviluppa il clima di Umbrellas,
ma con un tocco (auto)ironico feroce e deformante,
come sempre nel miglior Zappa, It Must Be A Camel
è la perla segreta del disco, capace di aprire squarci
sui modi sempre più ricercati che caratterizzeranno
la sua produzione settantina. Il discorso di HR continua tra i solchi di Waka/Jawaka (meno riuscito) e
di The Grand Wazoo (elegante progetto big band).
PS: HR è il disco preferito di Matt Groening.
Gabriele Marino
re di Sirius, così
come nella voce
filtrata dalvocoder di The Raven (a quanto sidice la prima canzone
pop-rock ad utilizzare questo effetto, ancora tanto invoga oggi) si intravvedono già le sperimentazioni “robotiche” di Pyramid e IRobot. La prima parte dell’album è tutta incentrata su unpop-rock tanto leggero ed
essenziale nella struttura quanto pesante e barocconegli
arrangiamenti, in cui l’orchestra si mescola a strumenti
elettronici edelettroacustici, sfociando, in alcuni casi, in
interessanti contrappunticlassicheggianti (A Cask Of
Amontillado), altre volte in più semplici episodiblues
rock (The Tall Tale Heart e ilsingolo (The System Of)
Doctor Tarr AndProfessor Fether). Completamente
diversa la seconda parte del disco: The Fall Of The
House Of Usher pesa, nelcontesto dell’album, almeno
quanto tutti gli altri pezzi messi insieme e nonsolo per
i suoi 15 minuti di durata. Qui le singole parti della
suite, formatanto in voga nel progressive in quanto riferimento alle strutture ampie dellamusica “classica”,
sono utilizzate in una logica di sviluppo progressivo
dellatensione attraverso la trasformazione continua
dell’organico strumentale. Ilpreludio è affidato all’orchestra, che rielabora alcuni estratti dell’ omonimaopera di Debussy basata sul racconto di Poe. La tensione
aumenta quando iltemporale (II. Arrival) accompagna
l’arrivo dell’ospite nella macabra casa el’ingresso di
batteria, basso, chitarre e tastiere, che si proiettano in
unprog decisamente floydiano.Dopo questo crescendo
di emozioni intense espaventose, To One In Paradise
segna una dolce distensione, forseeccessivamente stucchevole nell’orchestrazione, ma dolce e incantevole
come la fine di un incubo.
(7.8/10)
Daniele Follero
Rearview Mirror /
109
Guerre Stellari
(Star Wars)
(di George Lucas - Usa, 1977)
Leggendo la marea di cose che sono state scritte
su Guerre stellari a partire dall’anno di uscita
mi tremano un po’ i polsi a pensare di poter dire
ancora qualcosa a riguardo. Quindi prima di tutto metterò le mani avanti scusandomi con l’intera
tribù di cultori, appassionati e critici che hanno
amato e vivisezionato l’opera a dovere fino a rendere superfluo qualsiasi altro commento. Secondariamente vi dirò subito che cercherò di riflettere
sul film da un punto di vista preciso e ben ristretto
nel tempo, il 1977 appunto, senza considerare il
fenomeno che si è scatenato dal film stesso, ovvero
i vari sequel e prequel, giochi di ruolo, catena di
store dedicati interamente alla saga e gadget multimediali annessi e connessi. Mi limiterò solo a dire
che quando oggi pensiamo che simili operazioni di
marketing siano aiutate dal digitale e dalle convergenze finanziarie delle industrie culturali diciamo
di certo una cosa verissima, ma dovremmo ricordare che già nel 1977 la strategia aziendale funzionava a pieno regime in questa precisa direzione.
110
/ Cult Cinema
Dopo L’uomo che fuggì dal futuro, suo primo film, prodotto da Coppola, Lucas realizzò
American Graffiti che fu un grande successo
e gli permise di fare quello che voleva per il progetto di Star Wars. Con la produzione di Gary
Kurtz e la distribuzione 20th Fox, Lucas mise insieme un cast tecnico eccezionale sotto la guida
di John Dykstra della neonata Industrial Light &
Magic. L’obiettivo era quello di realizzare una
specie di fumetto animato, carico di effetti speciali e innovazioni tecnologiche. L’impeto originale
veniva da un comic strip che Lucas aveva molto letto e amato nella sua infanzia, ovvero Flash Gordon di Alex Raymond. Già prima di American
Graffiti Lucas cercò di acquistarne i diritti ma
il prezzo era troppo alto così dal 1973 al 1976
cominciò a scrivere un soggetto originale ispirato
alla tradizione delle avventure nello spazio (sottogenere della SF chiamato space opera) alla maniera
del romanzo seriale John Carter of Mars di
Edgar Rice Burroughs a cui lo stesso Raymond si
era ispirato. La storia che ne esce è molto simile
a quelle tipiche dei comics della Marvel chiamati
“sword and sorcery” (spada e magia nera), oltre
che alla SF più avventurosa e naif, quando ancora problematiche scientifiche o tecnologiche,
bomba H soprattutto, non avevano fatto la loro
apparizione. È inutile anche solo l’accenno alla
storia che ormai chiunque, anche se alla lontana,
conosce: ribellioni e guerre interplanetarie, pirati spaziali e mostruose strutture social-politiche,
armi medievali e tecnologie sofisticate nel tipico
modello in cui la forma del futuro è fornita da un
passato apocalittico. In sostanza grande divertimento e non troppo coinvolgimento intellettuale o psicologico; Guerre stellari non contiene
nessuna paranoia, angoscia e monito ma solo ottimismo e visione fiduciosa di futuro e tecnologie,
non c’è nessuna metafisica (2001 di Kubrick) ma
solo avventura in un tempo/spazio fantastici presentati come se fossero reali, ordinari.
Ebbene la risposta del pubblico tutti la conosciamo: gente che nel 1977 - tempi bui per il cinema,
a livello di botteghino - faceva la coda dalle nove
del mattino per assicurarsi l’entrata in sala… fino
alle attuali tribù di cultori e stimatori. La risposta della critica, invece, fu meno entusiasta nelle
delibere di approvazione (!) ma comunque predisposta a scrivere fiumi – letteralmente - di parole
su questa kid’s stuff. È paradossale ma pare che,
nonostante – o, forse, grazie a - il materiale superficiale, Guerre stellari abbia avuto un potere straordinariamente evocativo sulle menti dei
moviegoers, innescando i seguenti riferimenti che
cito, per amor di notizia e curiosità, per ciascun
campo afferente. Fumetto: Buck Rogers, Jeff
Hawke di Jordan (da cui è stata presa molto fedelmente la famosa scena del saloon spaziale di Mos
Eisley), oltre a Flash Gordon fra i più diretti; cinema: Sentieri selvaggi (scena del ritrovamento
dei cadaveri degli zii), Il trionfo della volontà
(scena di Luke, Han e Chewba che camminano
trionfanti alla fine del film modellata sulla marcia
di Hitler, Himmler e Lutze verso il Monumento
di Norimberga nel film di Leni Riefenstahl), Il
mago di Oz (iconografia), un’infinità di film di
aviazione sulla seconda guerra mondiale (tutte le
scene della missione finale, peraltro ripetute, successivamente, da Top Gun), i film della tradizione di cappa e spada con Douglas Fairbanks e Errol Flynn (Luke e Leia si lanciano con una corda
sospesa sull’abisso), i film giapponesi di samurai,
Il pianeta proibito (tematiche varie); la letteratura di SF: Dune di Frank Herbert, Starship Troopers di Robert Heinlein, le suggestioni di Tolkien; senza contare i riferimenti agli eroi
del passato dispersi nella cultura pop americana
e non: Tarzan, Zorro… Numerosi critici hanno
portato in questione, forse suggestionati anche
dal riferimento alla Riefenstahl, persino parte del
credo nazista (misto di eroismo e misticismo) e la
teoria di Bergson sull’élan vital e quella di Jung
sull’inconscio collettivo (nella frase di Kenobi sulla
fondamentale unità della natura, il senso di connessione di tutte le cose) e persino Julius Evola è
stato scomodato…e qui davvero mi fermo perché
i riferimenti rischiano di rasentare il ridicolo. La
cosa non ci dice nulla se non una paurosa tendenza dei critici ad usare proprie categorie concettuali per spiegare quello che hanno dimenticato
essere ‘semplicemente’ un film, cioè una particolare forma espressiva che ha sue precise pratiche
narrative e discorsive. I critici, ovviamente, dopo
aver molto letto Baudrillard, storcevano il naso
su questa “deliberata superficialità”, questo film
“pavloviano”, questo prodotto della “forza tranquilla del capitale che tutto assorbe e ingloba” e
si irrigidivano sempre di più vedendo il pubblico
consenziente e si mettevano a gridare contro la
connivenza dei media che pubblicizzavano questo tipo di prodotto, invece che un molto più impegnato ma meno piacevole (a loro parere) film
di Godard come La Gaia Scienza. Come dare
loro torto? Anche se ne discutessimo per ore non
troveremmo un punto finale. Ma questo non contribuisce alla comprensione del film che è il nostro
obiettivo. Per cui - se non per il gusto della curioCult Cinema /
111
sità - potremmo benissimo dimenticare la marea
di cose scritte e cercare di ripensare con onestà
a quello che è (stato) Star Wars come simbolo,
in un certo senso, di quello che accadeva nel cinema hollywoodiano finita la fase più forte – è
il 1977 – delle generazioni degli indipendenti e
come prodromo di quello che sarebbe accaduto
negli anni a venire.
Ciò che ha sempre caratterizzato il cinema americano è la sua capacità di creazione di una mitologia mai totalmente portata a oggetto di sistema
(se non dalla critica, chiaramente) e basata su di
un fondo di sostanziale pragmatismo; sempre tradotta, cioè, in azione e mai in pensiero. Sebbene,
eccezionalmente, possa essere temporaneamente
interrotta, questa tendenza è rimasta inscritta nel
suo DNA e Star Wars rappresenta uno dei film
maggiormente esemplari in questo senso: velocità d’azione, molti effetti speciali, un pizzico di
psicologia e molto divertimento. Dagli anni 80 in
poi il cinema americano blockbuster ha ripetuto
incessantemente questo modello. In fondo l’appartenere alla SF di Guerre stellari è un fatto
non troppo accertato. È forse più un fantasy e, se
si guarda bene, il genere fantasy è uno dei generi
più frequentati nel cinema degli ultimi decenni.
Prendiamo il problema della tecnologia per
esempio. Nel film non c’è nessuna minaccia nelle
macchine (la minaccia è il male) e il misticismo
antitecnologico dell’ordine degli Jedi non cambia
la natura sostanzialmente positiva della messa
in scena di gadget tecnologici o di robot. Contrariamente a quello che direbbe McLuhan la
tecnologia, nella tematica di questo film, dipende
dall’uso che se ne fa, dipende dalla natura degli
uomini che se ne servono. I robot sono dotati di
sentimenti umani e, anche per quanto riguarda
la tecnologia, tutto si riduce ad una semplicistica
opposizione di bene e male, richiamo di vita e
richiamo di morte. Concetti che provengono da
una vaga componente di misticismo che era pre112
/ Cult Cinema
sente in quegli anni (si parlava molto del famoso
manuale di Hérrigel, Lo zen e il tiro con l’arco, in cui si sposano la tecnica e la mistica) ma
che non aggiungono nulla a questa concezione di
base positiva, proposta senza imperativi ma con
piacere e fiducia, come nel più tipico immaginario infantile.
In un’intervista Lucas dice di aver utilizzato gli
effetti speciali con tecnologie sofisticate al solo
scopo di dare un senso di realtà all’immaginario
fantastico (Robert Benayoun e Michel Ciment, in
Positif, n.197, sett. 1977). I critici non hanno mai
visto di buon occhio questo atteggiamento, considerato ipocrita, di utilizzare la tecnologia in senso
antitecnologico come un attacco alla scienza moderna, intriso, appunto, di misticismo (stessa cosa
per Wall-E). Ma si dimenticano che nella storia
del cinema di SF - compresa l’ultima fase con l’introduzione della nuova tecnologia del digitale che
ha segnato sia una sfida che una potenzialità per
l’immagine fotografica su cui il cinema si fonda
- sono sempre state maggioritarie le occasioni di
recupero, di fronte al dilagare della tecnologica,
dell’importanza dello spirituale, del sentimento,
della corporeità (o della pellicola stessa rispetto
al digitale) come un rassicurante porto dove ritornare a rintanarsi, un nido sicuro in prossimità
dell’umano. Come una sorta di riequilibrio delle
eccessive sollecitazioni sensoriali portate da tecnologie pervasive.
Una delle maggiori ragioni di ingenuità venivano
mosse a Star Wars riguardo alla collocazione
della vicenda in un tempo/spazio dove tutto è accettato con un totale sentimento di famigliarità;
Luke è un “abbonato dello straordinario”, niente
lo potrebbe stupire. Ma come la storia di Ulisse,
dei Cavalieri della Tavola Rotonda, o L’isola del
tesoro, Star Wars ha una sua costruzione fantastica coerente: un mondo esotico che l’eroe esplora e in cui qualunque cosa straordinaria diventa
famigliare. Senza scomodare Freud e il sogno si
potrebbero contare una quantità infinita di riferimenti, anche aulici (vedi Omero), per questa tipologia narrativa. Certo, sono le convenzioni del
genere SF a creare questo senso di famigliarità
nello straordinario, ma è anche un riferimento al
mondo del sogno (cioè il cinema). Allora, al di là
delle polemiche sull’ingenuità, non si tratta solo
di una regressione personale di Lucas verso le letture dell’infanzia ma è anche una regressione fatta dal cinema stesso verso i suoi albori, una specie
di recupero dell’immaginario perduto dopo anni
di contestazione, di rabbia, di rinnovamento (gli
anni 60). Da lì in poi, infatti, arriveranno Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., la saga
di Indiana Jones, per citare i “maggiori”, che
hanno occupato quasi interamente il cinema e
l’immaginario fantastico degli anni 80.
Per finire, sul piano dell’esemplarità, Guerre
stellari è un altro tassello di quella tendenza
sempre più presente nel cinema americano - dagli anni 70 in poi - a riflettere su stesso, a prendere il cinema come oggetto principale, magari
nascosto, non immediatamente esplicito, del racconto. Nella maggioranza dei film degli ultimi
decenni è possibile vedere che, al di sotto delle
varie linee narrative e dei vari contesti, è sempre
il “fantasma“ del cinema a cui si sta dando la caccia. Anche Star Wars è così: dietro un western
travestito da SF, con scene da war movie ed elementi fantasy c’è sempre la solita vecchia storia,
gli stessi meccanismi di fondo e le solite pratiche
discorsive che alla fine ci fanno intravedere, al di
sotto, una trama sempre uguale che ha il cinema
stesso come oggetto principale.
Riscoprire tutti questi motivi di attualità, se non
altro, può essere interessante.
costanza salvi
Cult Cinema /
113
Il curioso caso di Benjamin Button
(di David Fincher - USA 2008)
Tratto dall’omonimo racconto breve del 1922 di
Francis Scott Fitzgerald, il film ha avuto una
genesi travagliata prima di venir affidato a David
Fincher, passando anche attraverso la candidatura di Ron Howard. La storia bizzarra è tutta
un flashback, che muove dal presente della New
Orleans a ridosso dell’uragano Katrina (siamo
nell’agosto del 2005) indietro fino alla nascita di
Benjamin (Brad Pitt), bambino nato vecchio
che man mano ringiovanisce con il tempo. Con
l’espediente della lettura di un diario, seguiamo il
protagonista nel corso della sua vita che si intreccia con la storia del Novecento, in una serie di rimandi spazio temporali, la cui costante è fornita
dalle sue trasformazioni fisiche e psicologiche e
dall’inseguirsi con l’anima gemella Daisy (Cate
Blanchett).
Ma più che i tormenti interiori in una vicenda
inconsueta come quella capitata al protagonista,
Il curioso caso di Benjamin Button rivolge
la sua attenzione ai cambiamenti esteriori, non
lasciando mai veramente il segno. Altra cosa davvero rispetto al film che subito viene alla mente,
Forrest Gump (di Robert Zemeckis, 1994) e
quel suo personaggio che invece attraversava la
storia americana con nient’altro che il suo candore. Naiveté presente anche qui (non a caso lo
sceneggiatore Eric Roth aveva collaborato anche
alla pellicola di Zemeckis), ma che non basta a
risollevare le sorti del film. Quel che sembra interessare a Fincher è osservare, con la cura maniacale di un entomologo, come si comporta il
protagonista vecchio con la mente di un bambino
e viceversa.
Una riflessione sul tempo e sulla brevità della
vita, sulla morte perciò e sul rincorrersi da parte di esistenze diverse con sfalsamenti temporali.
C’è l’alone della malinconia e della nostalgia per
il tempo che trascorre, tema tutto fitzgeraldiano
114
/ La Sera della Prima
quest’ultimo, reso anche attraverso un ovattamento della fotografia. C’è una cura formale molto
elevata, un’ossessione per i particolari che toglie
anima; e d’altra parte i personaggi non sono approfonditi, bensì semplici maschere che si lasciano attraversare dagli eventi. Niente veramente
tocca, neanche i momenti che si vorrebbero più
emozionanti, resi del tutto calligraficamente.
Al film avrebbe giovato anche una minore durata (166 minuti sembrano davvero troppi!) e un
montaggio più snello, con una maggiore fluidità
tra un periodo e l’altro della vita di Benjamin.
Non mancano momenti di puro kitsch, del tutto
superflui (intere sequenze temporali che si potevano tagliare per esempio: è il caso del viaggio
in Tibet, per citarne uno) e segmenti di comico
del tutto involontario, come il lungo monologo di
Daisy, ballerina classica che racconta a un indif-
ferente Benjamin della scena parigina legata alla
nascita della danza contemporanea e dell’ascesa
del coreografo Balanchine.
Quel che resta del film allora sono le attente trasformazioni fisiche digitali, mentre ci si domanda
come invece sarebbe stata la resa da questo punto
di vista con mezzi meno potenti. Forse più artigianale e meno algida. Da questo versante tutto
sembra perfetto, Brad Pitt si toglie man mano con
il passare del tempo gli anni dal volto e dal corpo
come un consumato Dorian Gray wildiano in
un patto con il diavolo, però senza consapevolez-
za e con noncuranza quasi. Se non si sta a pensare agli effetti digitalizzati quasi si trova la cosa
naturale ed appare facile la resa del personaggio
da questo versante. Comunque una prova ottima
la sua, così come è ottima anche la camaleontica
Cate Blanchett alla quale siamo ormai tanto
abituati che quasi non se ne percepisce più la fatica attoriale, ma solo la naturalità. Per Fincher,
un’occasione sprecatissima.
Teresa Greco
La Sera della Prima /
115
L’America di Josè Cura
e Cristina Zavalloni
Due diversi sguardi sulla musica del Novecento musicale americano, dagli Stati Uniti al caldo e profondo sud. La versatilità
ritmica dei compositori latini e le sperimentazioni cageiane, la compostezza di Samuel Barber e le ricette di cucina di Leonard Bernstein: Josè Cura sul podio dell’Orchestra del teatro Comunale di Bologna e Cristina Zavalloni, accompagnata da
clarinetto e pianoforte, senza volerlo hanno fornito, a distanza di pochi giorni, due istantanee complementari della musica del
Nuovo Mondo. Di Daniele Follero
J osè C ura – T eatro M anzoni
B ologna (2 F ebbraio 2009)
di
B ologna (30 G ennaio 2009) C ristina Z avalloni – T eatro C omunale
L’argentino Josè Cura, tenore di gran
classe(abbiamo avuto modo di apprezzarlo l’anno scorso nel ruolo di Sansone in Samson Et Dalila di Saint Saens) questa volta è arrivato nella
città petronianavestendo i panni di direttore d’orchestra, con un programma tutto americano edel
tutto trasversale, a dimostrazione della varietà e
vastità dei repertorid’oltreoceano. Un percorso di
andata e ritorno, partito dal nord con illinguaggio chiaro e neotonale di Samuel Barber, per
tuffarsi nella terra del fuoco con la disinvoltura
degli esploratori più audaci. Giù, sempre più giù,
attraversandola cultura di confine del Messico
di Josè Pablo Moncayo e la foresta tropicaledel
brasiliano Villa-Lobos, con una lunga pausa nella
patria di Cura,l’Argentina del tango, di Piazzolla
e Ginastera. Per risalire, infine, verso il nord. Un
ritorno brusco, nel tempo e nello spazio, al Nuovo Mondo settentrionale, ma questa volta filtrato
dalla mente europea di Dvorák che,ormai trasferitosi a New York, volle dedicare al folklore americano la suaultima sinfonia, non a caso titolata
Z Novèho Svrta (“dal nuovo mondo”).Miracoli
della musica, che riesce ad annullare distanze che
sembrerebberoinaffrontabili e che, invece, grazie
al linguaggio universale dei suoni siaccorciano
fino ad annullarsi.
Cura dà l’impressione di tenere particolarmente
alle sue scelte, tanto che, quando arriva ad affron-
tare l’esecuzione delle partiture dei suoi conterranei, sente il bisogno di fermarsi e parlare alpubblico, tirando fuori tutto il suo carisma per
sottolineare il carattere inedito di queste composizioni. Con l’orgoglio di chi è consapevole del
valoredi musicisti poco noti solo perché lontani
dai repertori “classici” e da quello che i musicologi definiscono Canone Occidentale. Compositori “periferici” rispetto ai punti di riferimento europei, ma proprio per questo affascinanti
egià post-moderni nel loro stretto rapporto con
le tradizioni dei loro paesi diprovenienza. Con
l’eccezione di Piazzolla, ormai noto alle platee
di tutto il mondo,e (forse) di Villa-Lobos, nomi
come Moncayo e Ginastera non dicono nulla aipiù. Un’occasione imperdibile, dunque, quella di
tuffarsi nella vitaleesuberanza di Huapango del
messicano Moncayo e nella varietà ritmica dellasuite dal balletto Estancia del compositore argentino. La vivacità di questemusiche riflette alla
perfezione il carattere estroverso e istrionico di
Cura,che nel dirigere sembra quasi un ballerino
sudamericano, con tanto di movimenti di bacino.
La sua è una direzione che definirei “fisica”, nella
quale il corpo si muove con la musica. Il direttore
trascina l’orchestra in questi balli,connotati ovunque da una grande varietà ritmica e la accarezza,
come si fa conuna partner di danza.
Dopo queste scintille, i tratti tardoromantici della
di
Nona sinfonia di Dvorák, al di là dei suoi meriti
storici, hannodato l’impressione di rompere un
incantesimo, così come la compostezza diBarber
aveva creato una falsa premessa rispetto al viaggio verso il caldo sud. Se Cura ha deciso di attraversare in lungo ein largo l’intero continente,
la mezzosoprano bolognese Cristina Zavalloni,
nelsuo concerto (titolato, per l’appunto Americana) al Teatro Comunale nell’ambitodella stagione
“contemporanea” di Musica Insieme, si è fermata interamentenegli U.S.A., esplorando i poco
noti repertori vocali di John Cage, CharlesIves e
Leonard Bernstein. Accompagnata dal clarinetto
di Gabriele Mirabassi e dal pianoforte di Andrea
Rebaudengo, la Zavalloni ha dato, ancora una
volta,prova della sua vocalità versatile e teatrale,
riuscendo con gran classe adalternare le ricette
culinarie de La Bonne Cuisine musicate dall’autore di WestSide Story, alla poesia The Wonderful
Widow Of Eighteen Springs di James Joycenella
versione di Cage e alle Songs dal sapore leggero,
quasi pop di Ives.
Un concerto tutto d’un fiato, senza pause,che ha
perso tensione quando la cantante ha lasciato soli
sul palco gli strumentisti alle prese con la Sonata per Clarinetto di Aaron Copland eAmerican
Bersek di John Adams. Troppo importante per
non esserci, la Zavalloniè tornata sul palco per
eseguire in prima assoluta l’opera Nueva York
delgiovane compositore italiano Carlo Boccadoro (presente in sala e meritatamente applaudito)
basata su due poesie del periodo newyorchese di
Federico GarciaLorca. Il bis è tutto all’insegna
del virtuosismo,dell’ironia e dell’improvvisazione
jazzistica, con un brano composto appositamente
per i finali di concerto e intitolato appunto…Bis.
Il modo di approcciare alla musica dellaZavalloni, giocoso anche se tremendamente serio e disciplinato è uno deglielementi che maggiormente
conferiscono spessore al suo stile. La suadisinvoltura nell’affrontare repertori quasi agli antipodi
(dall’opera baroccaalle avanguardie, fino al jazz)
fa il resto, tanto che ogni sua esibizione rimaneun
capitolo a sé. Quella di questa sera non ha fatto
certo eccezione.
a night at the opera /
117
Giacinto Scelsi
La vita in una sola nota
Misterioso, isolato, nobile decaduto assolutamente sui generis, Giacinto Scelsi è un personaggio a sé stante nel panorama
della musica contemporanea, un capitolo a parte nella storia delle avanguardie. Precursore dei precursori, ha sperimentato
le tecniche minimaliste almeno un decennio prima di La Monte Young, pur rimanendo, a modo suo, legato alla tradizione.
Di Daniele Follero
“Mi sento più affine alle filosofie
orientali, che parlano contro la violenza,
contro le manifestazioni della vita terrena su un livello
pratico.
Preferisco pensare e vivere su altri livelli, il più possibile”
(Giacinto Scelsi)
MortonFeldman lo ha definito “il Charles Ives
italiano”. Un’opinione condivisibile se, al di là
dei dati anagrafici, si confrontano i personaggi
sul piano del fascinoe dell’influenza che entrambi hanno avuto sulle successive generazioni di
compositori. Come il compositore americano,
infatti, è stato da molticonsiderato il capostipite dell’avanguardia statunitense, così Giacinto
Scelsi,grazie al suo particolarissimo e radicale approccio alla musica, ha precorso di parecchi anni
l’avvento del minimalismo e, più in generale, del
radicalismo post-strutturalista.
La figura di Scelsi brilla di luce proprianel panorama della musica contemporanea italiana e
internazionale.
Un isolamento non solo artistico, ma anche esistenziale, che lo ha portato prestoa dileguarsi da
qualsiasi, seppur minima, visibilità, rifugiandosi
nella torre d’avorio delle sue consapevolezze, alla
quale hanno avuto modo di accedere soloalcuni suoi studenti, gli unici ad essere veramente in
grado di parlare di lui e suonare la “sua” musica
così come il Maestro l’aveva concepita.
Misterioso e inafferrabile, Scelsi non ha mai vissuto una vita “normale” o, per meglio dire, paragonabile alla media dei suoicolleghi compositori.
Nato a La Spezia da una famiglia nobile, il piccolo conteGiacinto Francesco Maria Scelsi d’Ayala
Valva visse la sua infanzia prevalentemente presso il castello di proprietà della famiglia materna (ilcastello di Valva, in Irpinia), dove ricevette
un’educazione alquantosingolare: un precettore
gli dava lezioni di latino, scherma e scacchi. Le
anacronistiche abitudini aristocratiche, però, non
alimentarono mai in luisentimenti e atteggiamenti elitari e snobisti, ma furono certo una tra le
causeoriginarie del suo isolamento, della scelta di
prendere le distanze da un mondocui non sentiva
di appartenere del tutto.
I primi approcci con la musica Scelsi li ebbe a
Roma, dove seguì le lezioni di piano del Maestro
Sallustio, prima di venire acontatto con l’èlite culturale dell’epoca. Nei salotti bene della capitaleconobbe grandi personaggi del mondo artistico
come Virginia Wolf e Jean Cocteau,ma fu fuori
dall’Italia che trovò i più importanti stimoli musicali della sua formazione. Arrivato a Ginevra con
un bagaglio di conoscenze e di influenzemolto
legato alla figura di Ottorino Respighi e a quella
schiera di musicisti neoclassici denominata Generazione dell’80 (dal comune decennio di nascita
ditutti i musicisti che vi facevano parte) studiò con
Koelher, che lo iniziò alsistema musicale di Skrijabin. Scelsi rimase affascinato dalle alchimiearmoniche e dallo spiritualismo del compositore
russo più che dalla dodecafoniaschoenberghiana,
con la quale venne a contatto a Vienna, aderendo
solo in parteal serialismo e restando, per questo, più
vicino a Berg che
al Maestro. Le suecomposizioni giovanili, scritte prevalentemente per
il pianoforte (strumento che predilesse, almeno fino
ad un certo punto
della sua carriera
artistica),risentono
molto del linguaggio atonale,
pur conservando
un’attenzione formaleche
richiama elementi neoclassici: la Sonata
n.3 del 1939 è un
chiaro esempiodi
come lo stile berghiano, unito alle eteree soluzioni armoniche di Skrijabin abbiano fornito la
base all’embrionale creatività di Scelsi. Ma c’è
qualcosa,in questa come in molte composizioni
di questo periodo (tra le quali spicca ilQuartetto
n.1 del 1944), che si allontana dai linguaggi di
provenienza. C’è qualcosa in quell’insistenza nel
girare attorno ad una nota sola, che giàprelude
alle sue ossessioni future, a quel suo abbandono
radicale del discorsomusicale che presto sarebbe arrivato all’annullamento totale delle altezze
equindi del rapporto diacronico tra suoni di differente frequenza.
La crisi e l’approccio alle filosofie orientali: l’”ato-
mizzazione del suono singolo”
Trascorso l’intero periodo della Seconda guerra
mondiale in esilio forzato nella neutrale Svizzera,
Scelsi soffrì,qualche anno dopo il conflitto, forti
problemi psicologici, la cui causa scatenante fu,
con molta probabilità, la fine del
suo matrimonio.
Questoepisodio
segna una tappa
importante nella
vita così come nel
percorso musicaledel compositore
ligure, che uscì
dalla sua crisi attraverso un bruscocambiamento
di rotta delle sue
ricerche. A partire dalla Cantata
“La NascitaDel
Verbo” (scritta nel
1948, ed eseguita
solo nel 1950) il
linguaggio musicaledi Scelsi virò
verso quello che
Daniela Tortora ha definito “atomizzazione delsuono singolo”, culminata negli splendidi Quattro Pezzi Per Orchestra, basatisu una singola nota
ciascuno. Il fascino per la filosofia orientale, per
letecniche yoga, mutuate per lo più dalla cultura
indiana, contribuì non poco ad alimentare questo
nuovo procedimento compositivo che, annullando la dimensione melodica, si proponeva di concentrare l’elaborazione musicale unicamente sultimbro. Restando solo con le sue metamorfosi, il
suono singolo perde il suoruolo di semplice punto
all’interno di una composizione, per caratterizzarsicome suono, essenza stessa della composizione, che diventa così, a sua volta,una continua
i cosiddetti contemporanei /
119
elaborazione di una singola frequenza. Un minimalismo ante-litteram, costruito attraverso un
massiccio utilizzo della tecnica degli armonici e
dei quarti di tono, ottenibili solo dagli strumenti
a corda e afiato. Ragione questa, o conseguenza,
del fatto che in questo periodo Scelsi abbandonò
del tutto il pianoforte, lo strumento meno adatto
per mettere inpratica le sue idee.
L’isolamento in cui si chiuse una voltatornato a
Roma, pur collaborando a progetti importanti
come
l’associazioneNuova Consonanza e
l’omonimo gruppo di
improvvisazione
(cui
aderirono, tra glialtri
Franco Evangelisti, Aldo
Clementi ed un giovane
Ennio Morricone), contribuìa creare un’aura di
mistero attorno al compositore, sempre più
capitolinod’adozione.
Stanco, irreversibilmente spossato dalla crisi di
nervi, Scelsi,negli anni
’50 decise di non scrivere più e di affidarsi a dei
trascrittori dalui stesso
istruiti, che avrebbero
riportato nero su bianco
le sueimprovvisazioni registrate su nastro magnetico. è per questo motivo che ladatazione delle
opere di Scelsi è spesso complessa e difficile, tenuto contodel fatto che può capitare che siano
trascorsi anche molti anni tra lacomposizione e
la sua trascrizione, come nel caso di due tra i suoi
capolavoricameristici, Elegia per Ty, per viola e
violoncello (concepita nel 1958 evenuta alla luce
solo otto anni dopo, nel 1966) e la Trilogia per
violoncellosolo, la cui composizione cominciò nel
1957 per terminare definitivamente nel1961 ed
essere trascritta nel 1965.
C ome
un profeta con i suoi discepoli
Durante gli anni della svolta, Scelsi nonabbandonò del tutto la tradizione, ma la elaborò da particolari punti di vista,lontani dal neoclassicismo e
molto legati a concetti musicali essenziali, comequello di polifonia. Ne sono un esempio i Divertimenti per violino solo (decisamente tonali), la già
citata Trilogia per violoncello e il brano persoprano solo Ho, nei quali la polifonia è ricreata a
partire dalla monodia,attraverso giochi percettivi
(favoriti dalle risonanze) che ricreano nellamente una dimensione verticale dei suoni apparentemente inesistente.
Una“polifonia virtuale”, come la definisce
Dujka Smoje, già nota
a Bach e Telemanne
riscontrabile in altri
autori
contemporanei a Scelsi come Berio (Sequenze),Xenakis
(Nomos Alpha, Kottos,
Keren, Theraps) e in un
altro grande maestro
del Nostro, Edgar Varèse (Density 21,5).
Ma tradizione per
Scelsi fu esso stesso un
concetto molto ampio,
profondo, non semplicemente legato alle origini
della cultura occidentale, bensì a quelle dell’uomo: la mitologia, la cultura delle civiltà antiche,
dai Maya alla grecia classica, dall’antico Egitto
agli assiri, le culture orientali, contribuiscono ad
alimentare il suo misticismo. A partire dai titoli,
le sue opere divengono sempre più criptiche, attingendo da lingue e culture arcaiche (Pwill, Kya,
Uaxuctum, Hurqualia, Ygghur -“catarsi” insanscrito).
A partire dal 1958 Scelsi ritornò, dopo unalunga
pausa a comporre per la voce: gli 8 Canti Popolari per coro di 4 voci e iTre Canti Sacri, per 8 voci,
rappresentano un altro importante passaggio
delsuo stile e anticipano le complessità corali di
Uaxuctum. Le tecniche di scrittura vocale, basate
sulla costruzione di masse sonore verticali, formateda suoni sovrapposti a distanze micro tonali
gli uni dagli altri (in modo da
provocare il fenomeno acustico
dei “battimenti”), da qualcuno sono stateparagonate alle
micropolifonie di Ligeti. E il
paragone sarebbe in partegiustificato, se non fosse per il carattere decisamente più mistico
checontraddistingue le opere
di Scelsi. Non solo quelle vocali, in verità, chèanche gli ultimi
lavori sinfonici rispondono a
queste caratteristiche. Inrealtà
Hurqualia (1960), Aion (1961)
e Hymnos (1963) potrebbero
essereconsiderati anche movimenti di un’unica
grande sinfonia, l’ultima di Scelsi.Che continuò a
comporre sempre più a rilento, spesso rielaborando opereprecedenti, come nel caso di Anagamin
(1965), Ohoi (1966) e Natura Renovatur (1967)
generate, rispettivamente, dal Secondo, Terzo e
Quarto Quartetto. Ma non mancano certo opere di un certo rilievo tra la fine degli anni ’60 e
ildecennio successivo, composte per variegati organici, spesso inediti (Tkrdg del1968 per coro di
6 voci, chitarra elettrica e percussioni) o composti
in coppia(Pranam I e Pranam II, 1972-73), anche
se il capolavoro di questo periodo èconsiderato
Knox-Om-Pax, mastodontico lavoro per coro e
orchestra, seguito da un timido ritorno al pianoforte, stavolta “preparato” (Aitsi, 1974).
za isuoi migliori, se non gli unici, esecutori della
sua musica. Tanto che alcuni,come il cantante
giapponese Michiko Hirayama (per la cui voce
furono scritti,nel 1962, i Canti Del Capricorno) e
la violoncellista statunitenseFrances-Marie Uitti,
sono diventati dei veri e propri simboli della sua
musica,che, a tutt’oggi, rimane, in parte, inedita.
Scelsi continuò a comporre
fino a poco prima di morire
e la sua ultima composizione,
oltre ad assumere il carattere
del commiato sin dal titolo (Un
Adieu), ritorna significativamente al pianofortesolo, quasi
a voler chiudere un cerchio. Il
cerchio più grande.
Se ne va così, con un poetico
e raccolto addio, in maniera
quasi mistica, il “compositore
di una nota sola” come qualcuno lo ha definito, chiudendo i contatti con il
mondo il giorno 8.8.88 egli occhi il giorno dopo.
Nel frattempo, come un profeta, ma anche unpo’
eremita, Scelsi cercava di trasmettere il “verbo”
ai suoi pochi pupilli.Quelli che diverranno gli
unici detentori del suo sapere e, di consegueni cosiddetti contemporanei /
121
sentireascoltare.com
a breve di nuovo online......