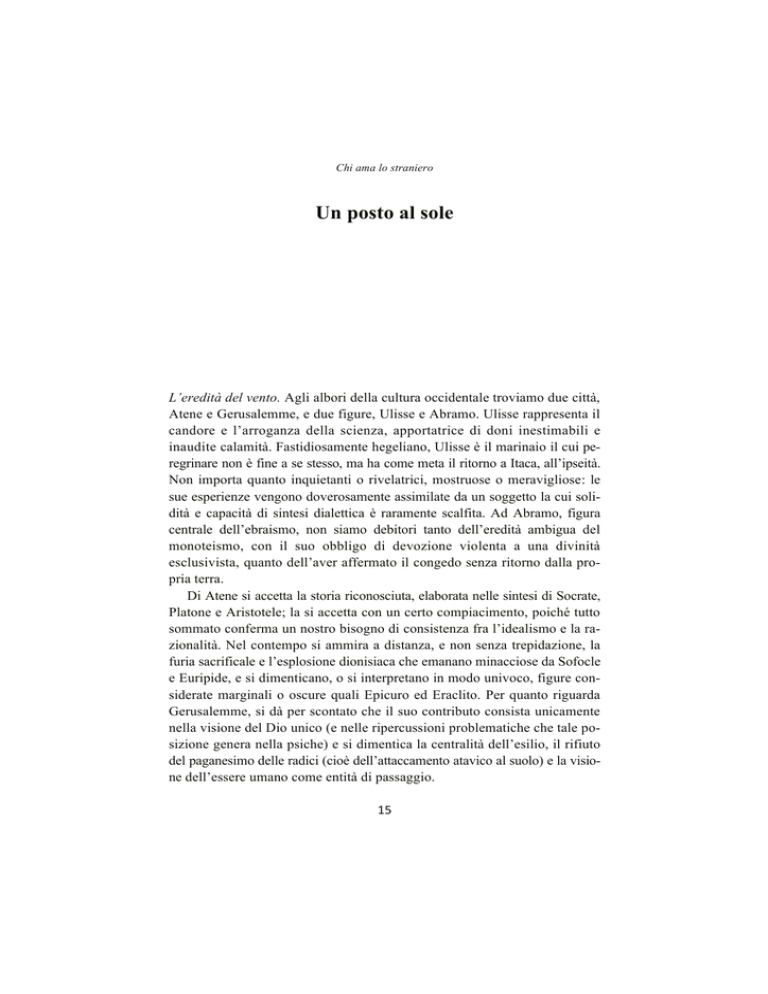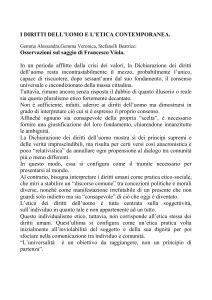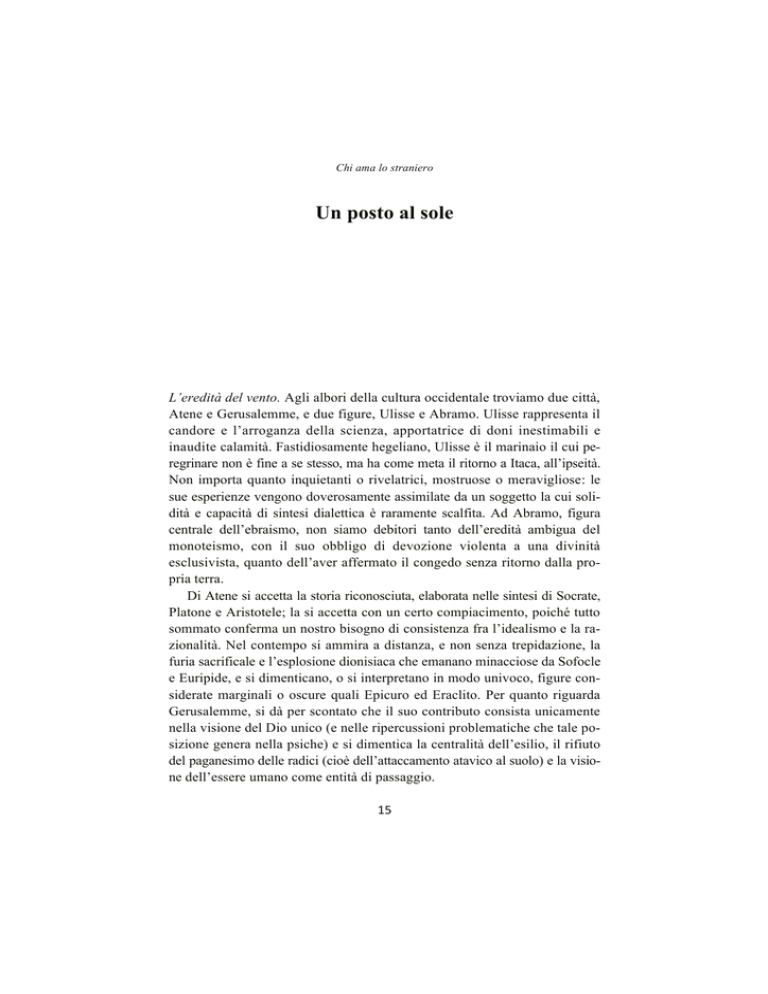
Chi ama lo straniero
Un posto al sole
L’eredità del vento. Agli albori della cultura occidentale troviamo due città,
Atene e Gerusalemme, e due figure, Ulisse e Abramo. Ulisse rappresenta il
candore e l’arroganza della scienza, apportatrice di doni inestimabili e
inaudite calamità. Fastidiosamente hegeliano, Ulisse è il marinaio il cui peregrinare non è fine a se stesso, ma ha come meta il ritorno a Itaca, all’ipseità.
Non importa quanto inquietanti o rivelatrici, mostruose o meravigliose: le
sue esperienze vengono doverosamente assimilate da un soggetto la cui solidità e capacità di sintesi dialettica è raramente scalfita. Ad Abramo, figura
centrale dell’ebraismo, non siamo debitori tanto dell’eredità ambigua del
monoteismo, con il suo obbligo di devozione violenta a una divinità
esclusivista, quanto dell’aver affermato il congedo senza ritorno dalla propria terra.
Di Atene si accetta la storia riconosciuta, elaborata nelle sintesi di Socrate,
Platone e Aristotele; la si accetta con un certo compiacimento, poiché tutto
sommato conferma un nostro bisogno di consistenza fra l’idealismo e la razionalità. Nel contempo si ammira a distanza, e non senza trepidazione, la
furia sacrificale e l’esplosione dionisiaca che emanano minacciose da Sofocle
e Euripide, e si dimenticano, o si interpretano in modo univoco, figure considerate marginali o oscure quali Epicuro ed Eraclito. Per quanto riguarda
Gerusalemme, si dà per scontato che il suo contributo consista unicamente
nella visione del Dio unico (e nelle ripercussioni problematiche che tale posizione genera nella psiche) e si dimentica la centralità dell’esilio, il rifiuto
del paganesimo delle radici (cioè dell’attaccamento atavico al suolo) e la visione dell’essere umano come entità di passaggio.
!
*%!
!
Manu Bazzano
L’Europa ha iniziato da due secoli un processo di sprovincializzazione,
aprendosi alle culture orientali; processo ambiguo fin dall’inizio, inaugurato dal fervore pessimista (e dal fraintendimento) di Schopenhauer per il
Buddhismo, un fraintendimento che continua tutt’oggi e fa del Buddhismo
un’altra religione istituita, cioè un altro sistema di denigrazione della vita.
Più che il pessimismo e la passività della contemplazione, centrale agli insegnamenti del Buddha è la diserzione del proprio posto al sole, l’abbandono
delle radici illusorie dell’ipseità ogni qualvolta esse si solidifichino. Un atto
di estrema ribellione: il rifiuto di essere, la fine del dogma finora indiscusso,
da Platone a Heidegger, una rapina nel quartier generale dell’ontologismo.
Comprendere tale insegnamento provoca una conversione individuale, e
non solo: comporta anche una modifica delle strutture archetipe della cultura ellenica e giudaico-cristiana. Ulisse non ritorna a Itaca, Abramo rimane
fedele all’originaria complicità con il vento.
Invito alla diserzione. Una delle esperienze più significative nei miei anni
di pratica Zen fu il ritiro di strada. Assieme a una decina di altri praticanti
ho vissuto per tre giorni la vita di un senzatetto per le strade di Londra; fu
un tentativo di aprirsi alla loro esperienza e tentare di comprendere che “loro”
non sono diversi da “noi”. Criticato da molti, forse giustamente, come un
atto compiacente e di condiscendenza verso chi è meno fortunato, l’esperienza
mi ha aiutato a provare un’empatia meno astratta verso la condizione dei
senzatetto. Le implicazioni non sono unicamente sociali, ma connesse a una
pratica centrale nello Zen e nel Buddhismo: l’abbandono del sé, un atto di
diserzione dalla passerella di moda e dal gioco del prestigio sociale. Tentare volontariamente di abbracciare una condizione dalla quale altri cercano
disperatamente di fuggire è un atto di abbandono e di surrender, ed equivale
effettivamente a sfidare un tabù. Abbandonare momentaneamente la solidità
del sé mina alle fondamenta tutto ciò su cui riposa l’idea di una società cosiddetta civile.
Disertare il proprio posto al sole non è rinuncia oltremondana ma azione
etica, nata dalla consapevolezza che il mio posto al sole significa il tuo posto
all’addiaccio: è accantonare l’atavismo dell’identità – commettere un atto
volontario di auto-disorientamento e dislocazione; un atto di cui soltanto un
idiota è capace, o un poeta. Avventurarsi nel non-io, non fare più ritorno a
!
*&!
Chi ama lo straniero
esso, danzare fin dentro la molteplicità, sentire nelle ossa l’assenza di fondamento: è in tal modo che il sé viene alla luce. Dalla destrutturazione della
nozione del sé si accede a una fluidità inquietante ed esilarante; si entra
nella corrente, un’immagine comune sia al Buddha che ad Eraclito. Ciò
non corrisponde allo sgretolamento dell’identità all’opera nella patologia,
come si sarebbe portati a credere se si considera (come fa certa psicologia
junghiana e post-junghiana) l’archetipo di Dio o l’archetipo della totalità
essenziale all’archetipo del Sé (con la maiuscola), ma all’accettazione più
piena della sfida esistenziale presente nell’essere umano, senza ricorso al
giogo della totalità.3 L’ipseità, puntellata dalla nozione del Dio unico, conferma il consensium gentium; il primo passaggio obbligato vede l’identità
diventare fluida, pericolosamente ma riccamente aperta alla pluralità nel
graduale processo di attualizzazione, forse l’esatto opposto del percorso
della “rivelazione psicologica” che trasformerebbe il paziente da pagano a
monoteista.4 Una democrazia della psiche è tanto auspicabile quanto una
democrazia nella polis, e l’accettazione e il dialogo con le varie divinità interne
crea una maggiore fluidità senza l’intervento normativo di un “Sé” che è
l’eco e il riverbero del Dio unico della monolatria.
L’individuazione è perdita. In ogni civiltà che meriti tale appellativo alberga
la brama dell’impossibile, il desiderio di emancipazione dalle ristrettezze
del reale, il credere che l’utopia sia realizzabile individualmente e politicamente. Soltanto un idiota oserebbe tentare il cambiamento, soltanto un idiota
oserebbe diventare il cambiamento; e soltanto un poeta introdurrebbe modifiche nel linguaggio, e quindi nella percezione stessa del reale.
Abbandonare l’ipseità e il proprio posto al sole è un atto di rivolta radicale che mina l’essere alle fondamenta. Le ribellioni filosofiche ed estetiche
del passato, da Rousseau a Wilde a Thoreau, hanno finito col rafforzare, nonostante il loro entusiasmo iconoclasta e la sovrana bellezza dell’espressione,
!
3
Per Gianfranco Tedeschi (2000, p 13) “Dio vuole la completezza, l’autorealizzazione conscia
della propria totalità, e ciò facendo l’uomo sperimenta la presenza di Dio fuori e dentro di
lui: totalità, amor Dei, sono delle equivalenze psichologiche”.
4
“Ogni nevrotico è dominato, posseduto dagli idoli della sessualità, dell’ambizione, da esigenti spiritualismi. Egli dovrà trovare una sintesi tra queste tendenze e altri contenuti... in
nome della completezza, della totalità, di Dio. Ogni paziente, nell’analisi junghiana, entra in
terapia come pagano e ne esce come un monoteista” (Tedeschi, 2000, p 15).
!
*'!
!
Manu Bazzano
l’idea borghese di un io auto-sufficiente, un’idea riprodotta e centuplicata
dall’iniziativa capitalista, dall’etica del lavoro, dal culto della scoperta avventurosa nel territorio inesplorato (e perciò colonizzabile) del non-io. La
diserzione delle fantasticherie di conquista dell’ego e la rinuncia al calcolo
acquisitivo non comporta tuttavia passività contemplativa: quando non è
più l’ansia dell’appropriazione, motivata dalla carenza, a imprimere il moto
verso l’esterno, subentrano il bisogno e il desiderio, i quali, pur non apportando
soddisfazioni autentiche, ci sospingono fra le braccia dell’altro, anticipando in
tal modo l’inevitabile caduta e l’errore dal quale usciamo trasformati: sbagliando s’impara...
Nel desiderio senza oggetto e senza scopo, l’escursione oltre i confini
dell’ipseità ha valore solo in quanto riverbero dell’alterità; allo stesso modo
l’individuazione è frattura, vedovanza e perdita. E l’esilio è avventura che
avvicina l’esule alla natura provvisoria – scevra di illusione – della condizione
umana, non uno stato di anormalità – come ebbe a pensare Weizmann, teorico
del sionismo politico e fautore, assieme a Herzl, della mobilitazione che
contribuì alla creazione dello stato di Israele – dal quale si viene curati mediante il ritorno nel grembo di una nazione. Nel passaggio psichico fluido e
vulnerabile dell’esilio covano i pericoli del messianismo e del dogma nazionalista, fomentati dallo spirito di vendetta che vuole impossessarsi della
psiche dei diseredati, e al contempo la possibilità di esplorazione di una
dimensione esistenziale. Un ribaltamento della prospettiva e l’identificazione
del cittadino privilegiato con la condizione esistenziale delll’esiliato generano empatia e destrutturano l’ipseità.
Il desiderio, la vergogna e la colpa. La ricerca del piacere, castigata dai
moralisti di ogni chiesa, ci fa sporgere oltre il confine dell’essere e ci apre
all’alterità. Sporgendomi dal limite della mia dimora innesco, volente o nolente, il processo doppiamente rischioso dell’affettività: nell’esternare il desiderio, nell’agire, delimito deliberatamente le possibilità ancora latenti nella contemplazione, e mi apro alla ferite dell’imbarazzo (la vergogna della
nudità esposta) e del disappunto.
Nella morale borghese, così come nell’etica borghese del lavoro e del
profitto, il rischio è invece minimo: il tiepido amore coniugale è per lo più
partnership di routine, rinnovata da una quotidianità che pretende di cono-
!
*(!
Chi ama lo straniero
scere l’inconoscibile; l’avventura imprenditoriale si fonda sul guadagno e
valuta la perdita come momentanea debâcle da cui imparare in vista di
conquiste future. Il borghese non può ammettere divisioni interne, fratture e
inconsistenze nella psiche poiché esse minacciano la solidità illusoria della
ipseità, cioè la credenza superstiziosa del sé come entità uguale a se stessa.
Il borghese
ha sempre, da tutta la vita (per nascita e censo) posseduto; non gli è balenato neanche mai per un istante il sospetto di non possedere.5
Nel bisogno e nel desiderio la ferita e l’inautenticità che ci fanno esseri
umani ci aprono ai doni sontuosi della nudità rivelata. Nel movimento verso
l’esterno mi apro alla pienezza dell’essere, un essere che non si rivela più
come l’essere del pensiero tradizionale – ipseità, potenza, indipendenza – ma
come alterità: mi sporgo verso di esso attraverso il bisogno e il desiderio. Il
desiderio mi sospinge pericolosamente verso l’altro; una volta esposta
l’essenziale nudità (vulnerabilità, finitezza, imperfezione) sorge la vergogna, cioè l’incapacità di far dimenticare agli altri la mia essenziale nudità.
Ma è per l’appunto nella reciproca rivelazione delle ferite che la comunicazione può aver luogo. Per l’Heidegger del Parmenide la vergogna è umore o
“tonalità emotiva” che pervade l’essere, un sentimento ontologico, la vergogna stessa di essere. Lévinas, invece, nel tessere lode pacata al bisogno
umano di evasione (che si traduce in grandi e piccoli sistemi di trascendenza,
strategie di evanescenza e vacanze farmacologiche dalla dea ragione) arriva
indirettamente a una definizione della vergogna, percepita come impossibilità radicale di nasconderci a noi stessi.
Nella crisi che segue al disappunto e alla vergogna, si apre la possibilità
di una conversione, non evento trascendente ma vertigine, nausea e malessere
che rivela la nostra finitezza (avere, abitare, essere un corpo). Dalla vertigine ci
si allontana subito, alla ricerca di mappe e sentieri tracciati: si ossequiano le
modalità convenzionali d’evasione, i triti rituali della trascendenza, condividendo e condonando l’umano bisogno di fuga. Ma vi è anche una fuga
all’interno delle radici stesse del corpo mortale, una trascendenza all’interno
dell’immanenza, un’eternità che è intensificazione del singolo essere caduco,
!
5
!
Pasolini, 1968, p. 83.
*)!
!
Manu Bazzano
un’eternità che è violenza poetica, e si dirige puntuale con Arthur Rimbaud al
delirio di cielo e mare all’orizzonte.
La colpa occupa dunque un posto legittimo nel progetto di rivalutazione
dell’etica e superamento della morale proposto in queste pagine, specialmente se posta in opposizione alla travisata “attualizzazione di sé” della
psicoterapia dominante e all’infantilismo della New Age. In giuste dosi,
idealmente affrancata dalla psicopatologia delle ingiunzioni religiose, la
colpa può temperare l’arroganza di un ego (individuale o collettivo) che ha
perduto il senso della misura. (Una medicina, forse, il senso di colpa autentico, per diversi leader politici contemporanei sfacciatamente sfuggiti alle
condanne spettanti ai criminali di guerra. Si pensi al caso incredibile e
scandaloso delle autorità italiane, che mai chiesero scusa per le atrocità
inflitte all’Etiopia, alla Somalia, alla Grecia e alla Jugoslavia, e che mai
ammisero che le nostre truppe commisero crudeltà identiche a quelle dei
nazisti. Qui l’ipocrisia o l’ingenuità borghese delle buone intenzioni e della
diplomazia cede il posto alla logica dello struzzo, tipica di chi possiede
un’immagine distorta di sé e non vede né la trave nel suo occhio, né le mostruosità celate sotto il sorriso da buontempone).
Esiste nel contempo una vera e propria ideologia della colpa, in particolare la colpa del superstite, sostenuta dalla tesi sospetta secondo cui “il superstite è innocente ma tuttavia obbligato, come tale, a sentirsi in colpa”.6
La tesi è sospetta non solo perché incita il soggetto a un guilt trip istigato
dall’aspetto punitivo del super-io (letale in individui il cui amor proprio e
rispetto di sé siano carenti), ma anche in quanto rappresenta una risposta
generica e “diplomatica” a problemi gravi nella loro specificità. Scrive
Agamben al riguardo:
L’assunzione di una colpa di questo tipo [...] evoca la diffusa tendenza ad
assumere una generica colpa collettiva ogni volta che non si riesce a venire
a capo di un problema etico.7
La prontezza con cui i tedeschi dichiararono la propria colpa collettiva
dopo la sconfitta del nazismo non corrispose a una disponibilità pratica
!
6
7
!
Agamben, 1988, p. 87.
Ibidem.
"+!
Chi ama lo straniero
nell’individuazione dei responsabili. E la Chiesa Cattolica, pur riconoscendo
tramite l’episcopato francese la propria colpa collettiva rispetto agli ebrei,
non ha mai ammesso la gravissima complicità di Pio XII con il fascismo e
il nazismo.
Una riflessione sugli eventi del XX secolo ci spinge a riorientare le categorie dell’etica e a domandarci, con Agamben, se sia ancora efficace usare
come modello il paradigma tragico comune all’era classica e all’idealismo, o
il superamento nietzscheano del risentimento, o ridare invece valore, alla
luce delle mostruosità e dei massacri, al risentimento. Ma l’orrore non può
essere cancellato: ritorna eternamente perché abita nella psiche delle vittime,
nel teatro del sogno e in quello della memoria. E tuttavia un’etica radicale
che si fondi sulla solidarietà e sulla risposta consapevole all’alterità non può
ritrarsi da un’affermazione attiva dell’esistenza.
Due idolatrie comuni: spiritualità e paganesimo. Superato il falso bisogno di
ontologia, sia la spiritualità che il paganesimo si rivelano come pratiche idolatre volte a reificare l’ipseità e a pietrificare l’appartenenza della specie
umana al suolo e al mondo, a un luogo transitorio. Entrambe si rivelano ideologie del fondamento.
La spiritualità cerca tale fondamento in nozioni trascendenti, nutrita dai
capezzoli avvizziti della tradizione; nel tentativo di traghettare le anime
verso l’altra sponda, trascura i doni incommensurabili di questa, alimentati
dall’oltraggio della finitezza e dalla tragica ironia della provvisorietà. Nella
sua traiettoria paradossale, la spiritualità (le religioni monoteiste, gran parte
del Buddhismo, la psicologia transpersonale, le confraternite New Age, ma
anche l’idealismo pseudo-esistenziale di Heidegger) finisce per rafforzare
l’ipseità, e il viaggio di solidificazione del sé viene accompagnato da rassicuranti omelie e mantra consolatori. La spiritualità ci tiene abbarbicati al mondo,
regalandoci tuttavia la prestigiosa illusione di perseguire un sentiero elevato.
Il paganesimo (la seconda idolatria, il secondo ostacolo al pieno apprezzamento del divenire) è il culto delle radici, incapacità di immaginare un
varco liberatorio nel viavai del mondo, di districarsi dalla palude del suolo
e dai tentacoli della carne, dalle maglie del mondo e dal turbinio delle passioni, dalla ragnatela protettiva intessuta intorno all’identità e ai possedimenti. Il paganesimo erige un muro intorno alla propria fragile idea di mondo,
!
"*!
!
Manu Bazzano
intorno al terrore che proviamo di fronte all’inesorabilità del tempo e
all’imprevedibilità degli eventi e delle cose.
La ribellione all’ontologismo nelle sue manifestazioni spirituali e pagane
è un’impresa individuale, di un’individualità che non è identica al solipsismo
cartesiano. A Cartesio siamo debitori della nozione di separazione che genera, nella terza meditazione cartesiana sulla relazione fra la res cogitans e
l’infinità di Dio, il pensiero al di là del pensiero, il pensiero come anelito
inestinguibile. La ribellione è quella di un essere individualizzato, orfano ed
esule della sua tribù, i cui dettati morali e religiosi egli ha osato sfidare in
nome d’una dolorosa ed esilarante ricerca di autenticità. L’individuo così
inteso erige una risposta etica sulle ceneri di norme coercitive, imperativi
categorici e verità universalizzanti.
Dal crepuscolo del dovere emerge l’etica radicale: risposta aporetica, non
universalizzabile, non-universalizzante. A chi obietta che ciò dà via libera al relativismo morale, rispondo affermando che, nonostante il rischio, è importante
difendere l’inalienabile libertà/responsabilità dell’individuo come unico locus
effettivo di trasformazione e di azione indipendente.
Il desiderio e l’anelito. Il movimento verso l’esterno è desiderio. La sua traiettoria è sovranamente vana, al di fuori della sfera progettuale dell’eros (che cerca
invece l’unione nostalgica e l’utopia). Il desiderio è anelito dell’impossibile:
grazie a esso il sé abbandona la propria dimora e si immerge, attraverso le vicissitudini della perdita di sé, nella sfera dell’esperienza.
Quando il desiderio diserta la sua natura non-utilitarista di anelito, e cede al necessario miraggio dell’eros, esso si solidifica nel progetto: la poesia
diventa prosa, la danza diviene passerella di moda, e Mitsein (essere-con)
diventa Mitmarschieren (marciare-con). Ma nessuna utopia crede davvero
in se stessa, e la tenia dell’incertezza ne rafforza l’armatura dogmatica e la
creazione di capri espiatori. Il mondo non ha perso solo Dio ma anche il
Diavolo; da allora la demonizzazione dell’altro è ugualmente importante
quanto l’agiolatria. La fuga rovinosa e sovrana dall’identità è anche fuga
dal gruppo tribale d’appartenenza; nell’evadere dal gruppo, evado anche da
ciò che, consciamente o meno, percepisco come la nevrosi intrinseca del
gruppo. Freud insegna che non esiste metro adatto a misurare la follia di un
dato gruppo; assorbito in sé, un gruppo è un micro-clima che crea il proprio
!
""!
Chi ama lo straniero
universo e la propria visione del mondo esterno. Il gruppo è folle per
definizione. Ciò vale non soltanto per le sette eccentriche della New Age e
i gruppi integralisti, ma anche per le religioni istituzionalizzate e per le
nazioni-stato.
Un’etica della carezza? È possibile formulare un’etica della carezza che segua
i contorni fluidi del corpo accarezzato, un moto che non afferri o possieda,
ma insegua il futuro, cioè l’inafferrabile? Tale etica oserebbe l’impossibile:
risolvere (sciogliere) l’atavismo dell’odio, inevitabile quanto l’amore, e
prometeicamente liberarsi della divinità esclusivizzante, il Dio di Caino e
Abele che inaugura la discordia, il Dio di parte che approva il sacrificio
dell’uno ma non quello dell’altro. Bisogna saper osare la devozione all’altro
senza dover giurare fedeltà al Dio possessivo ed esclusivista di Abramo, e
identificare con il termine “alterità” l’intero campo dell’esistente, l’io compreso. Nel tentativo di elaborare un’etica è difficile non ripetere l’errore “anglosassone” che Nietzsche attribuì a George Eliot: quello di sbarazzarsi cioè
di Dio, liturgie e intero apparato devozionale giudaico-cristiano, mantenendo
tuttavia intatto l’edificio morale che a tale sistema è intimamente connesso.
L’alterità va riconosciuta anzitutto come esteriorità. Ne I Persiani, Eschilo
ci insegna l’empatia immaginativa che si concentra sul dolore dei vinti invece che sull’esultanza dei vincitori. Egli invita i concittadini ateniesi, dopo
la vittoria di Salamis contro i Persiani, a pensare radicalmente, a coltivare
un pensiero e un’immaginazione esterni alla propria esperienza, a considerare
il dolore profondo e il lutto dei vinti. Che debba essere il teatro e non la religione istituita a invitarci a tale radicale modifica della percezione riflette
la natura potenzialmente radicale dell’arte.
Come spesso accade, la violenza si sposa alla metafisica e alla miope
trascuratezza delle complessità inerenti nel quotidiano; l’incapacità di pensare
e immaginare l’esperienza esteriore, il rifiuto di considerare il nemico con
serietà e rispetto ha reso l’Occidente estremamente vulnerabile agli inizi del
XXI secolo.
Perdonare l’imperdonabile, dare ciò che non si è. Il perdono autentico non
ha motivazione alcuna: si perdona l’imperdonabile poiché soltanto l’imperdonabile può essere perdonato. Il perdono è un atto gratuito, e a ogni nuovo
!
"#!
!
Manu Bazzano
tentativo di attuare il perdono si crea un nuovo orizzonte. Nella manovra radicale del perdono autentico si cancella il passato, le catene che avevamo
immaginato indistruttibili, il karma che si era creduto insormontabile: un
gesto di volontario dissolvimento dell’identità, che a sua volta si rivela come
l’insostenibile e vano edificio su cui persino il radicalismo della seconda
metà del XX secolo ha indugiato, con l’enfasi sulla ricerca delle radici, la
conoscenza degli antenati, l’esplorazione del suolo e l’intera gamma dei
miti d’appartenenza, con l’enfasi sulla memoria storica volta a reificare la
propria nozione artificiale di identità.
Quanto più stimolante l’arte del dimenticare, la disciplina dell’oblio...
Dimenticare e perdonare sono attività gemelle, il rancoroso ricorda tutto.
La patologia del rancore e dello spirito di vendetta fomenta la brama idolatra
di potere; il potere è patologia, la sete di autorità è per definizione patologica.
La persona investita di una carica ufficiale si prodiga in una sola attività:
mantenere la propria posizione a tutti i costi. Se la politica è showbiz per i
brutti, la religione è politica per gli introversi...
L’artista può e deve denunciare tale stato di cose, poiché l’artista è sin
dal Medioevo per definizione l’estraneo, lo straniero. Kuenstler era un termine che nel Medioevo designava sia l’abile artigiano che l’individuo senza
dimora o lavoro fisso, la cui esistenza era vissuta al di fuori della gerarchia
dei valori sociali ed economici, un estraneo che provocava regolarmente il
sospetto, e veniva percepito come incarnazione del demonio. L’artista non
si diletta nella superiorità morale di chi non è in grado di commettere le ingiustizie dell’uomo di potere; invece di dire, come ci rammenta Hannah
Arendt, “Grazie a Dio, io non sono capace di tanta avidità o crudeltà”, egli
proferisce: “L’uomo è dunque capace perfino di far ció”. Una voce destinata a
echeggiare nel deserto o ai margini della Storia perché l’uomo o la nazione
al potere non ammettono la sconfitta.
L’orrore è raramente visibile in tutto il suo obliquo malanimo; è costellato
di piccole azioni doverose e banali, di richiami costanti ad attitudini “realiste” imposte dalle circostanze. Nel pensiero della Arendt l’etica viene alla
luce come pensiero e azione personali e individuali, un dialogo con se stessi
che non è “esame di coscienza”, rassegna interiore di norme e dettati del
super-io, ma simile invece al dialogo con il proprio daimon. E chi sa dialogare
con il proprio daimon sa dialogare con un altro: è in tal modo che nasce il
!
"$!
Chi ama lo straniero
pensiero, ma esso si atrofizza in una società che manca di silenzio e riflessione,
e che non ha fiducia nell’alterità. Le società totalitarie creano un’atmosfera generale di sfiducia nell’altro, e le società “democratiche” del tardo capitalismo
contaminano il silenzio con la proliferazione della pseudo-informazione.
Oltre la coazione all’ontologia. L’antinomia dell’etica non è il male; lo è
piuttosto la monolatria, cioè l’interpretazione monistica e uni-dimensionale
di un soggetto che evita la risposta precaria e orizzontale posto di fronte
all’infinito, e ricorre invece alle risposte prefrabbricate fornitegli da un sistema totalizzante.
Il male, d’altro canto, non va qui inteso univocamente come invasione
psicotica dell’io da parte di forze esterne e interne, ma come vasta dimensione dionisiaca densa di potenzialità creative, una dimensione dionisiaca
che cerca compimento, maestria e raffinamento (l’assimilazione di attributi
apollinei) dopo la fase dirompente iniziale. Tali potenzialità sono considerevolmente ridotte se l’etica viene relegata alla camicia di forza dei dettati
religiosi, a meno di saper abbracciare un universo kafkiano come traduzione
della teologia monoteista, ritrovando nell’assurda impresa del protagonista
de Il castello l’intensità e il dilemma esistenziali andati perduti con il platonismo di massa instaurato dal Nuovo Testamento.
Se non si accede all’etica attraverso la ferita umana, attraverso l’inevitabile
tallone di Achille, nessuna trasformazione significativa può aver luogo. Il
super-io si adorna allora di massime “spirituali” lasciando intatta l'armatura. Il
borghese medio – stressato dal lavoro, piagato dall’insoddisfazione di piaceri
futili, o spaventato da una malattia che d’improvviso ha colpito se stesso o
un parente – si rivolge alla psicoterapia e alla meditazione, cercandovi
sollievo, consolazione, la promessa di una qualsiasi “felicità spirituale” o
“integrazione psicologica”. Ma egli non vuole (non può, non sa come) accettare la ferita; si strugge invece nell’aggirarla, medicarla, risolverla, a
modo suo, sanarla; troverà nel sentiero spirituale da lui perseguito un nuovo
catechismo, un modo per evitare l’assenza di fondamento che si insinua
nella sua esistenza con voce petulante. Accetterà una metafisica spicciola,
acquisterà le prime parvenze di un sistema acconcio e a portata di mano che
offra un’uscita dall’angoscia e dal senso incombente di futilità. Ma anche
se egli possedesse strumenti e disciplina necessari a far sua una metafisica
!
"%!
!
Manu Bazzano
sofisticata ed elevata, la situazione non sarebbe diversa: la metafisica in sé
è un’assurdità; ciò vale per l’idealismo di Kant e Hegel, ma anche per il
neo-idealismo di Heidegger. Certo, una particolare idea trova a volte un
fortuito connubio con la veridicità, diventando verificabile e transitoriamente
valida; ma breve è per l’appunto la sua fortuna, e inevitabilmente soggetta al
cambiamento: emerge nel fiume del divenire e nel fiume scompare, perdendo
la falsa numinosità di essenza, l’autorità spuria di colonna portante.
In tale scenario i termini della filosofia mutano: essa non è più coazione
all’ontologia ma tentativo di catturare diapositive del vivere-e-morire, adattando la vertiginosa discesa dell’esistenza all’artificialità necessaria della contemplazione. A redimere la filosofia è la gratuità della sua indagine e la
prossimità di tale indagine con la meraviglia e la consapevolezza dell’assenza
di fondamento. Il buon senso della saggezza filosofica è una qualità rara: un
dono della divinità, direbbe il religioso, un gesto poetico, direbbe l’artista,
se per poesia s’intende l’opposto dell’utilitarismo e della trivialità.
Opinare che qualcosa esista al di fuori del quotidiano è un atto di ingratitudine, un sintomo di malattia. Saper discernere il mistero e la magnificenza
della quotidianità è ciò che qui s’intende per meditazione: il contegno di un
organismo sano che si permette il lusso di essere grato e manifestare la propria volontà di potenza attraverso il dono di sé. La vera causa della malattia
nell’uomo è il nichilismo: nichilismo è percepire il quotidiano come “nulla”,
dirottarne il significato nello spirito, nell’idea, nell’illusione menzognera di
un fondamento e di una realtà decodificata.
Sia lodata la quotidianità. All’elogio del quotidiano diamo dunque il nome di
etica, in omaggio a chi ha affermato la superiorità dell’etica sull’ontologia, e
più precisamente di etica radicale, perché l’etica non ha essenza; la sua
essenza è per l’appunto incomodare le essenze. La sua identità è assenza di
identità, e suo compito è disfare l’identità. L’etica radicale, intesa come elogio
incondizionato del quotidiano, importuna la vanagloria dell’essere e il melodramma del nulla. Essere o non essere? Mai vi fu domanda più istrionica.
Al sogno a occhi aperti del fondamento facciamo immancabilmente ritorno come un viandante che sentimentalmente accarezza l’idea di patria.
La psicologia umanistica contemporanea ha saputo uscire dall’amorevole
gabbia platonica dell’unione: si è addentrata coraggiosamente nella vedo-
!
"&!
Chi ama lo straniero
vanza dell’individualità, aprendosi un sentiero nella giungla fertile della
molteplicità; poi, d’un tratto, sperduta e perplessa di fronte a tale spazio
smisurato, ha iniziato a ripercorrere il sentiero della nostalgia platonica, ha
fabbricato nozioni atte a riconciliare il sempiterno bisogno di consolazione
nel tentativo di superare un innato senso di inferiorità verso la psicoanalisi,
e un senso di inefficace e idealistica ingenuità nel misurarsi con il comportamentismo e il cognitivismo. Emergono così in seno ad essa nozioni di
“profondità relazionale” e “configurazioni del sé” nel bel mezzo di tradizioni radicali quali l’approccio centrato sulla persona, ispirato all’opera di
Carl Rogers. Rogers aveva tuttavia rifiutato nozioni metafisiche quali la
profondità (frutto della fede religiosa nell’esistenza di un inconscio), la nozione cartesiana di un apparato psichico separato e auto-sufficiente, e quella
freudiana della psiche come meccanismo costituito di parti.
Sembrerebbe quasi che una permanenza prolungata nell’esteriorità sia in
qualche modo insostenibile, e che il soggetto cerchi (tragicamente e comicamente) di rientrare nel ventre di un’unione nostalgica. È deludente constatare
come le nozioni sperimentali e falsificabili della psicologia umanistica vengano
cristallizzate in dogma; ciò è forse ulteriore riscontro di come la psicologia e la
psicoterapia abbiano gradualmente sostituito la religione. Esperienze chiave, pietre miliari, esperienze vetta: sintomi nostalgici della divinità perduta,
svendita della quotidianità nel sublime, del rigore terapeutico nel misticismo.
A meno di leggere la profondità come larghezza...
Una conversazione non-dialogica. Riconoscimento dell’alterità va ben oltre
la retorica del dialogo, dove il soggetto è un editor che corregge la narrazione del vissuto, e l’interlocutore un testo da venir letto e interpretato. Tale
attitudine conferma una credenza nel racconto, in un significato immaginato
che va o scoperto o detto diversamente. Nella visione dialogica/inter-soggettiva
ha luogo, nel migliore dei casi, una conversazione collaborativa, a cui si
accede da una posizione di non-sapere. Il dialogo è un modo di placare l’ansia
per la dualità intrinseca e la contraddizione presente in ogni individuo. Il discorso tende tuttavia alla seduzione, all’argomentazione, alla condiscendenza,
attraverso l’uso dell’attrazione, della revulsione, dell’indifferenza, nel tentativo
di rassicurare noi stessi che l’altro è simile a noi.
!
"'!
!
Manu Bazzano
Per Blanchot vi sono essenzialmente due modalità di dialogo: dialettica
e non-dialettica (o poetica). La modalità dialettica si ramifica a sua volta in
tre attitudini fondamentali: obiettiva, inter-soggettiva e immediata.
Nella dimensione obiettiva l’altro è percepito come oggetto di studio, di
osservazione “scientifica”, come un aggregato di istinti e pulsioni, un portatore
di sintomi e problemi da risolvere, un soggetto da riprogrammare e rieducare.
Tale intervento è essenzialmente normativo, invariabilmente in accordo con
i dettati del mercato, l’ideologia dominante, e del tutto indifferente ai bisogni
reali della persona.
Nella dimensione inter-soggettiva l’altro è percepito come un altro sé,
diverso, e con il quale sono tuttavia in grado di avere un contatto tramite
una qualche forma di identità primaria. Esponente chiave di tale modalità è
Stolorow, influenzato a sua volta da Gadamer, un pensatore che ha forse
tralasciato la dimensione etica e politica, ignorando l’influenza abbindolatrice
dell’ideologia borghese. La cosiddetta comunicazione libera e dialogica è
ovviamente una fantasia ingenua, e Habermas ad esempio considera il metodo di Gadamer conservatore e tradizionalista; su tale metodo, tuttavia, si
fonda buona parte della visione intersoggettiva. L’alterità non è scoperta
eclatante, e il pensiero occidentale l’ha certamente discussa; ma l’altro viene considerato in quanto altro da me: soltanto l’ambito dell’ego è originale
(Husserl) e l’altro è degno sì di considerazione, purché doverosamente subordinato all’astrazione dell’essere (Heidegger).
Nel tentativo di fusione con l’altro che avviene nella dimensione immediata,
il sé dimentica la distanza: intensità, autenticità, perdita di sé diventano qui
elementi chiave. L’alterità dell’altro va perduta in tale fusione, che diviene
effettivamente una forma di bypass spirituale ed esistenziale. La singolarità
dell’altro viene sacrificata a diversi altari: al misticismo New Age, alla seduzione delle antiche religioni, al fascino dell’Essere neutro di Heidegger.
Le tre modalità condividono una tendenza, persino una coazione all’unione:
l’analista-obiettivo, il praticante inter-soggettivo, lo spiritualista-empatico
tentano in modo unanime di ridurre il disagio che essi provano nel trovarsi
faccia a faccia con l’alterità. E tutti e tre si lasciano sfuggire l’elemento
fondamentale d’ogni incontro: la separazione. È tale coazione all’unità un
beneficio? Fra i sinonimi della parola “unità” troviamo “accordo, totalità,
armonia, unisono, conformità”; unità è dunque armonia, ma anche conformità,
!
"(!
Chi ama lo straniero
un argomento spinoso se consideriamo l’odierna polemica sull’integrazione
dei migranti. Fra tutte le illusioni, credere di “capire” un altro è forse la più
insidiosa. Il desiderio di conoscere e appropriarsi dell’altro appartiene all’arte
della guerra, della politica, della diplomazia; il desiderio di diventare uno
con l’altro appartiene alla nostalgia platonica dell’unione e alla fuga nella
trascendenza. Lo spazio fra il sé e l’altro va invece non solo mantenuto, ma assiduamente coltivato: bisogna saper attivamente rinunciare al bisogno di comprendere l’altro.
La modalità di dialogo non-dialettica è una modalità senza modalità, una
modalità poetica, che non aspira all’unità ma riconosce appieno l’estraneità
dell’altro: il logos si avvicina alla poesia, diviene discorso senza riferimenti
all’unità. La sfera a cui tale interazione appartiene è la sfera dell’infinito:
l’abisso fra le due sponde, il tu e l’io, non viene colmato, spiegato o celato, ma
sentito e riconosciuto.
Verso un’etica anarchica. Fin dai suoi albori la psicologia ha imitato le
scienze naturali; ma le scienze naturali hanno totalizzato l’infinità del mondo, organizzandola, catalogandone e descrivendone gli aspetti allo scopo di
esercitare padronanza su di essa. La psicologia si è analogamente prodigata
a descrivere e classificare gli esseri umani: un compito arduo e insoddisfacente, visto che gli esseri umani resistono alla totalizzazione. Nonostante
ciò, la tecnica, spronata dalla coazione all’efficienza, continua a esercitare
sulla psicologia una seduzione incessante; il risultato è il cinismo dell’azione,
la manipolazione efficiente che soggioga finanche l’umanista, lo psicoterapeuta e il filosofo.
Il movimento opposto vede nelle scienze umane espressioni dell’etica,
di un’etica che, seguendo l’esempio di Lévinas ed Ellul, non esito a definire
anarchica. L’ascendenza dell’altro sul soggetto, ci insegna Lévinas, interrompe il soggetto e lo lascia senza parole. In tale moto, politico e al tempo
stesso poetico, si comincia a intravedere una valida alternativa alla visione
dominante, essenzialmente neo-hobbesiana, della legge del diritto; al suo
centro non più l’alienazione bensì l’obbligo originario verso l’altro, e ciò
avviene fenomenologicamente, nella presenza corporea. Tale presenza, inscritta nei fenomeni, non va confusa con la nozione di concretezza: la concretezza è nient’altro che l’altra faccia dell’astrazione. Tale sterile binomio
!
")!
!
Manu Bazzano
trova oggi la sua apoteosi nella neuroscienza o neuroscientismo, che pur
adottando un linguaggio misticheggiante e poetico, variamente ispirandosi
a Spinoza, alla relazione primaria nell’infanzia e alla sociabilità inerente degli
umani, finisce col riaffermare e ridurre la consapevolezza a onde cerebrali, e la
mente al cervello.
Una terza via al di fuori della trappola concretezza/astrazione ci viene
indicata proprio da un neurologo le cui intuizioni precedono di qualche decennio la psicologia della Gestalt e la visione organismica della psicologia
umanistica: Kurt Goldstein. Un caso eccezionalmente raro e originale di
medico-filosofo, Goldstein identificò tale alternativa in ciò che egli chiama
la sfera dell’immediatezza, originata dall’identico mondo in cui viviamo.
(L’immediatezza di cui parla Goldstein non va confusa con l’immediatezza
precedentemente attribuita al testo di Blanchot; Goldstein parla di sfera condivisa, Blanchot di fusione).
L’incontro fra l’Io e il Tu è un incidente. La metamorfosi dell’uomo, da
creatura a monade, e da monade a simulacro, rappresenta il passaggio che dal
tardo-romanticismo è giunto al modernismo e infine all’anima borghese,
un’anima ancor più potente perché diffusa e mimetizzata.
Fu possibile asserire un tempo che una fiducia naturale caratterizza ogni
incontro con gli altri, non solo con chi si conosce appena ma perfino con gli
estranei, e che la sfiducia verso lo straniero avviene soltanto in circostanze
estreme. Fu necessario (e gratuitamente generoso) affermare che la vita
umana non può sussistere senza tale fiducia fondamentale; ma aver fiducia
significa esporsi, e se non si è capaci di tale fiducia, di tale resa, subentra il
conflitto o il surrogato del conflitto, la proiezione moralizzante, le accuse e
l’intimità perversa dell’odio. Feriti, con furia amorosa (amore in absentia,
eppur sempre amore) si distrugge il tenue legame che avrebbe permesso la
riconciliazione, e si aprono così i cancelli all’inferno della dissociazione.
È ancora possibile, nell’era dell’omologazione globale e dell’universale
orrore e tedio à la Baudelaire, avere fiducia nel rinnovamento incessante della vita? Soltanto tale fiducia può permettere che l’alterità riemerga a nuovo
dall’ingombro delle restrizioni con le quali è stata classificata, condannata e
dovutamente tenuta a bada con la retorica degli encomi. L’esistenza umana
si rifiuta d’essere ridotta a una gamma di comportamenti passati; alle ma-
!
#+!
Chi ama lo straniero
glie del determinismo ogni individuo si ribella e afferma il proprio diritto
d’appello: ogni individuo vuole esser visto nella luce incerta e prodigiosa di
un nuovo giorno, a ogni individuo dobbiamo permettere la redenzione di
nuove parole e nuove azioni. Può la spinta naturale verso la fiducia nel rinnovamento continuo della vita avere la meglio sulla reificazione dell’esistenza?
Forse le due tendenze sono egualmente necessarie, come Eros e Thanatos,
come la libertà e il determinismo; forse, alla stregua di Eros e Thanatos, esse
sono complementari...
Senza la fiducia gratuita nell’altro la comunicazione non può aver luogo
poiché essa comporta abbandono e rischio. Ma non ci è dato risiedere a lungo
in tale stato: la dimensione dell’Io e del Tu, senza la quale non possiamo
considerarci realmente umani, è miracolosa, cioè fortuita: non può essere ordita o fabbricata dalle proprie buone intenzioni. È ingenuo pensare, come fa
gran parte della psicoterapia contemporanea, che a tale sfera si possa accedere
semplicemente tramite la creazione delle condizioni sufficienti e necessarie.
Tali condizioni – contatto, congruenza, empatia, considerazione positiva incondizionata, e via dicendo – creano indubbiamente l’atmosfera, preparano
l’ambiente ideale alla visitazione dell’ospite, ma la sua venuta è incerta, imprevedibile, e al di fuori della portata del mio agire. I difensori a oltranza della
dimensione dialogica e inter-soggettiva dimenticano che per Buber la dimensione dell’Io e Tu è un evento raro, e non l’oggetto desiderato di una
utopia facilona.
Dalla psicologia infantile si apprende quanto l’interazione degli adulti
influisca sulla psiche dei bambini, e si dimentica tuttavia quanto le relazioni
successive fra adulti continuino a influenzarci e a modificare il nostro mondo, e
perfino il nostro destino. La ragione per cui ignoriamo ciò è duplice: prima di
tutto perché non ci accorgiamo dei fenomeni più ovvi, secondariamente
perché ci peserebbe considerare appieno quanto la nostra condotta scalfisce
la vita degli altri.
Il radicamento nei fenomeni non è sinonimo di materialismo. È alla patologia, cioè alla sofferenza umana più acuta, che dobbiamo la possibilità di
studiare la psiche; tale studio è radicato nella biologia, intesa come studio
degli esseri viventi e non come aderenza alla presunta obiettività del modello
clinico-biologico. Il radicamento nella biologia assicura un abbandono del-
!
#*!
!
Manu Bazzano
l’antropocentrismo e dello zoo-morfismo: in tal modo si riconosce psiche
nella sua interezza, un altro nome che descrive l’esperienza organismica
senza tuttavia essere da essa delimitata. Il nesso con la biologia assicura un
radicamento nel corpo, con l’essere nel mondo, e distanzia psiche dall’idealismo platonico; nei sintomi che emergono dall’organismo si riconoscono tentativi di soluzione, risposte organismiche al disagio, invece che espressioni
isolate di danni localizzati. Purtroppo la tendenza alla compartimentalizzazione dei sintomi sembra venir confermata dagli ultimi sviluppi nel campo
delle neuroscienze.
L’attenzione al corpo, ai fenomeni, alla percezione, non ci riporta al materialismo o alla negazione dell’inconoscibilità dell’esistenza e del suo mistero;
al contrario ci invita ad ancorare la nostra pratica di vita nel corpo – una mossa
vitale, presi come siamo nel labirinto di valori dell’era post-moderna; ci invita
anche a rimirare con attitudine nuova ciò che l’atomismo dà per scontato.
Ci si trova così ancorati al corpo e all’attenzione fenomenologica, allo stesso
tempo consapevoli della loro natura misteriosa. In tal modo la crisi di legittimazione non è più sintomo dell’incompletezza del progetto modernista,
che aprirebbe le porte al mostruoso catalogo dell’eterotopia paventata da
Foucault. Il modernismo non poteva che girare a vuoto o arenarsi nella proliferazione di pseudo-soluzioni positiviste e susseguenti svalutazioni.
Fin da Cartesio, e attraverso il positivismo logico del XX secolo, il progetto
modernista ha sottolineato la centralità dell’epistemologia e la necessità di
interpretazioni adeguate riguardo alla relazione del soggetto con una presunta realtà, una realtà armoniosa e perfino equa; velleità che puntualmente
si rivelano essere emanazioni del pensiero religioso che il modernismo
s’era illuso d’aver sconfitto, nonché emanazioni di una tradizione filosofica
dominante che, sbirciando impudentemente oltre il sipario dell’apparenza,
non manca mai di scoprivi un immaginario e rassicurante “essere”. Geniale
e poliedrica, l’impresa modernista era tuttavia destinata a fallire: fino a
quando il soggetto può immergere una scodella nella corrente del fiume e,
osservandola poi diligentemente fra quattro mura, credere di stare esaminando
il fiume stesso? La corrente scorre inafferrabile, imprevedibile se non nella
sua destinazione finale; impossibile che il fiume ritorni alla sorgente. Colui
che soffre, afflitto da insicurezza ontologica e da patologie, avverte intensamente ciò che i più evitano, neutralizzano o accettano passivamente: chi
!
#"!
Chi ama lo straniero
soffre intensamente vuole uscire dal fiume della vita perché esso conduce
alla morte, vuole rifugiarsi nel ritualismo e nella coazione, tentando di sottrarsi alla corrente del vivere-e-morire.
Ingrato è il compito del terapeuta: sospingere il paziente indietro nel fiume
della vita e rinnovare così la promessa della morte. Ancora più ingrato è il
compito del filosofo: rammentare a se stesso l’impegno originario di vigilanza al delicato e profuso affaccendarsi di “sora nostra”. Memento mori –
poiché di memento mori si tratta, ma questa volta si spera senza i toni striduli
e denigratori della religione, ma di un monito che serva da tonico e rimembranza, che ci spinga alla pienezza del vivere e alla gioia tragica. Anche il
praticante buddhista dovrà riconoscere prima o poi la centralità di tale consapevolezza non fine a se stessa, ma disadorna di preziosità spiritualeggianti
e adunata attorno alla provvisorietà e aleatoreità dell’esistenza.
Posti di fronte a un oggetto ci si chiede spontanemante: “Che cos’è?”, e
se si possiede un’inclinazione filosofica ci si può domandare: “Qual è la
sua essenza?”. Entrambi i quesiti sono artificiali, indotti dalla rimozione arbitraria dell’oggetto dalla corrente del divenire. La medesima domanda Che
cos’è?, un koan nella pratica Zen coreana, non si riferisce all’oggetto o al
soggetto, non crea tale distinzione, ma indirizza il divenire stesso, colto nella
totalità dell’esperienza presente: ci conduce a un’attenzione panoramica, e
tuttavia ancorata nel corpo, nei fenomeni e nella percezione, a una consapevolezza del presente dove il presente non è più.
Lealtà alla fenomenologia. Dal terreno fertile della fenomenologia alcuni
sono passati all’affermazione di un io trascendentale, e c’è chi si è affidato
alla neutralità di un Essere che ospiterebbe in sé gli attributi della cura. E
c’è poi chi ha aperto la fenomenologia all’etica e all’alterità riformulando
così le basi dell’etica, non più subordinata a strutture sociali, morali o religiose,
né a funzioni psicologiche, ma complice dell’esigenza implicita nell’alterità:
prim’ancora dell’essere, prim’ancora dei processi psichici, ciò che conta è
un tentativo di risposta adeguata all’altro. Riconoscere tale obbligo non
richiede perizia o raffinatezza particolari, ma il desiderio di sporgersi, di
entrare in contatto con l’alterità e di lasciare in tal modo il proprio posto al
sole. Nello sporgersi verso l’alterità, il sé per la prima volta viene alla luce,
abbandonando la crisalide del solipsismo con cui è stato da sempre confuso,
!
##!
!
Manu Bazzano
e ritrovando se stesso nella ferita vertiginosa della comunicazione. Sospinto
e ispirato dal desiderio, l’individuo osa l’intimità necessaria con l’estraneità
e abbandona il sé della metafisica, il sé nato dal consenso sociale e dalla
morale totalizzante. Abbandona il soggettivismo e accoglie l’individualità
che emerge nell’ambito condiviso, la sfera che Kurt Goldstein chiama della
immediatezza, che non è una dimensione mistica ma la quotidianità stessa,
una quotidianità condivisa e temporaneamente decolonizzata da interpretazioni logico-dialettiche e dal progetto acquisitivo dell’ipseità. A tale sfera si
accede mediante una resa volontaria di sé – una momentanea sospensione,
o epoché – messa in atto senza timore di perdere se stessi.
Tale resa non comporta una catarsi né un rilassamento della tensione
(come ha creduto gran parte della psicologia umanistica) a meno che si tratti
di un organismo sofferente. L’infermo ricerca l’alleviamento del dolore e al
tempo stesso la preservazione delle sue funzioni basilari: in tal senso
l’istinto di preservazione va considerato come patologia. La tendenza naturale
dell’organismo è diretta invece verso l’attualizzazione: volontà di divenire
è volontà di potenza, volontà di creare e di espandersi, di unirsi alla spinta
della vita a superare se stessa. Animati dal desiderio, facciamo esperienza
più piena di noi stessi in quanto persone attive e desideranti, e non passivi
intercettatori di cieche pulsioni (come ha creduto la psicoanalisi classica) o
sospinti dalla carenza e dall’assurdo (come ha creduto l’esistenzialismo).
La sensibilità etica esige una riformulazione radicale di concetti che si
sono fossilizzati in dogma, ratificati dalla medicina, dalla psicologia e dalla
religione. Si consideri ad esempio la sofferenza, santificata dalla retorica
religiosa, nobilitata dall’insegnamento buddhista, e giustificata dalla teodicea laica presentata dalla medicina e dalla psicologia. La giustificazione
della sofferenza altrui non può mai venire accettata dall’etica radicale, la
cui posizione di impegno esistenziale (di impegno attivo verso l’esistente, il
che necessariamente comporta diserzione dell’essere neutro) è essenzialmente una presa di posizione politica, cioè animata dal senso di giustizia,
dal rifiuto di accettare la sofferenza dei diseredati e degli oppressi. È altresì
una presa di posizione anarchica, nel senso di rifiuto dell’ontologia e anche
dell’autarchia implicita nell’archè, quindi riconoscimento dell’ascendenza
dell’alterità, impegno a non usare la prevaricazione nell’inevitabile disparità
di ogni incontro. L’etica così intesa è più importante della religione, della
!
#$!
Chi ama lo straniero
spiritualità e anche, come direbbe William James, più importante della psicologia stessa.
Un altro ambito messo in discussione dall’etica è quello giuridico, in
una sfida che osa pensare la legge e il diritto al di fuori dell’influenza cinica
e pessimista di Hobbes, e al di fuori dell’utilitarismo su cui largamente si fonda. L’etica antepone al peccato (e all’alienazione) originale l’obbligo originale:
un obbligo, ci affretteremmo ad aggiungere, che può e deve sfuggire alle maglie del super-io.
È possibile la psicologia al di fuori del ristretto campo della neurologia?
Una psicologia incarnata, radicata nel corpo, che abbia assimilato gli insegnamenti di Nietzsche e di Merleau-Ponty, non dovrà abdicare al riduzionismo
che s’illude di spiegare la psiche con le onde cerebrali. È possibile una psicologia che destrutturi e decentri il sé?
L’etica ha attraversato diverse fasi: dalla critica della soggettività cartesiana all’affermazione del quotidiano come prima moralità, o attraverso il
graduale riconoscimento che un’indagine adeguata dell’esistenza umana si
muova oltre la preoccupazione di sé. Essa ha affermato stati decentrati del sé,
stati di passività e assenza radicali quali la semplicità, la pazienza, l’umiltà,
tutte anomalie nella psicologia contemporanea, perché la psicologia, animata finora dall’invidia delle scienze naturali, ne ha parodiato i procedimenti
cercando nelle vicissitudini umane quello stesso ordine naturale riscontrato
da tali scienze. Nonostante il fatto che gli esseri umani continuino a rintuzzare tale quantificazione e a non comportarsi come docili oggetti di studio
positivista, ogni nuovo sviluppo della psicologia rinnova impassibile la
tecnologizzazione dell’intervento terapeutico, conferma una coazione
all’efficientismo utilitarista e a un filisteismo pragmatico che, oltre a essere
privo di immaginazione, è centrato sulla manipolazione del soggetto e sulla
sua reintegrazione nel mondo della produttività.
La filosofia radicale, alla stregua della poesia e dell’arte, ha bisogno di
decenni per venire assimilata. L’adesso – maintenant in francese – è ciò che
teniamo per mano (e tuttavia continua a sfuggirci). Viviamo l’adesso guidati
da nozioni del passato, mentre l’artista-filosofo descrive il presente, ciò che
a noi sfugge eternamente come sabbia fra le dita.
!
#%!
!
Manu Bazzano
Una nuova psicologia? Non è possibile costruire una nuova psicologia ispirata all’etica poiché quest’ultima rifiuta la creazione di sistemi. Dalla sua
prospettiva audace è tuttavia possibile sondare la psicologia stessa, ben al
di là della sua mera destrutturazione, poiché in tal caso vi è certo qualcosa
fuori dal testo: l’alterità, la persona a cui il testo viene implicitamente rivolto.
L’altro – la tenerezza e vulnerabilità del volto – non può venire omologato
nel mio sistema poiché l’alterità è vertigine e ferita. L’umano sfugge alla
dimensione discorsiva e risponde alla carezza, alla sofferenza senza ricompensa dell’individuo, di chi attraversa la landa desolata dell’abbandono, del
lutto e della colpa, e in tali regioni paradossali trova un apprendistato nuovo
che nobilita più di quanto siano capaci di fare le strategie del profitto personale.
Bisogna nel contempo sapersi districare dalla cornice esistenzialista e
affermare che il problema del Dasein non è urgente quanto lo sono la diserzione dell’essenza e l’idonea passività di rispondere all’altro. Bisogna saper
rabbrividire nell’estasi della ferita che ci apre all’esistente, e nel brivido e
nel riverbero che ci confonde trovare le basi stesse della consapevolezza.
Un’era post-metafisica? Potremmo forse definire la post-modernità, con
Bauman, come “modernità senza illusioni”.8 Quali sarebbero le illusioni in
questo caso? Che sia davvero possibile, ad esempio, organizzare il caos inerente alla condizione umana senza avvilirla. Che vi siano risposte metafisiche
(risposte in grado di fornire un fondamento al divenire) oltre alle fallibili e
temporanee soluzioni da noi create in circostanze contingenti. L’etica è
possibile soltanto nell’era post-moderna, o forse sarebbe meglio dire, con
Rorty, nell’era post-metafisica; in essa la moralità viene ri-personalizzata al
di fuori dei codici etici della religione e della morale. Il relativismo morale
che ne conseguirebbe è un pericolo necessario: la dignità umana comporta
necessariamente arbitrarietà e rischio, e la filosofia morale è un lavoro per
così dire interno anziché esterno. Il mistero kantiano della moralità interna
si espande nel mistero dell’esteriorità concreta dell’altro a cui sono obbligato
a rispondere senza ricorso ai puntelli della metafisica e dell’utile. Ed è bene
ricordare che furono per l’appunto queste due necessità, la metafisica e
l’utile, a spingere Caino all’omicidio: reagire all’ingiustizia di un Dio
esclusivista ed eliminare un concorrente.
!
8
!
Bauman, Z. 1993.
#&!
Chi ama lo straniero
Il rispetto radicale. Il trionfo della disinformazione tecnologica rende la
pratica dell’etica radicale ancora più urgente. La frammentazione apportata
dalla tecnologia, pur occultando la natura olistica della vita umana, ha dissezionato il presunto atomismo morale dell’io, accelerandone così il rischio
e la responsabilità. In un mondo meccanizzato nel quale è sempre più facile
dare la colpa all’ingranaggio di cui si è pedine inconsapevoli, la risposta
etica del singolo individuo acquista peso ancora maggiore. Un’azione equa
– semplice e schietta – diviene nel paesaggio dell’iper-modernità atto controculturale. Nell’era tecnologica e neo-machiavellica, in cui i mezzi sono del
tutto separati dal fine, ciò che interferisce con il dogma efficientista diviene automaticamente altro. In un’epoca nella quale l’individuo stesso viene preso
in considerazione come emanazione del noi, come il travisamento morale
coadiuvato dall’ingiunzione grammaticale che vede nell’io il singolare del noi,
l’azione equa di un singolo è un atto radicale. Uno di questi atti è il rispetto,
che spezza l’incantesimo della meccanizzazione: ri-spettare è guardare due
volte, rispondere al muto richiamo e all’implicita esigenza dell’altro: il secondo
sguardo spezza l’obbedienza a una legge neutra, e se corrisposto instaura la
complicità fra due esseri finiti e inaugura l’etica.
Ho esplorato con allievi e colleghi in diversi seminari e laboratori l’emergere
di tale esigenza etica implicita, come viene descritta dalla teologia esistenziale
scandinava, in particolare da Løgstrup. Dall’ascolto attento della silenziosa
presenza dell’interlocutore emergono messaggi fondamentali quali Non farmi
del male, Ricevimi, ricevi la mia presenza, Sii gentile con me, Ascoltami,
Guardami, Sporgiti. È possibile spezzare l’incantesimo del noi attraverso
l’ascolto attento dell’altro, e prima di tutto di noi stessi, mediante la cristallizzazione di un locus interno di valutazione; bisogna momentaneamente
perdere il noi, la somma inorganica di aggregati e cifre, e riconquistare l’io
come soggetto etico. L’introspezione è una fase necessaria in tale percorso:
uno sguardo rivolto all’interiorità non conduce all’ipseità, alla cristallizzazione dell’io, ma ci fa constatare la sua natura fluida e interdipendente. La
contemplazione, paradossalmente, ci apre alla esistenza relativa dell’io, invece
che al solipsismo. L’esperienza della relatività (!"nyat#) è aperta, generosa, e
ci apre alla creatività. Nell’incontro con l’altro, dallo spazio aperto di rischio
e opportunità, per la prima volta l’io emerge.
!
#'!
!
Manu Bazzano
Asimmetria dell’incontro. La risposta all’esigenza elevata della morale
astratta, idealizzata dalle ingiunzioni religiose e dall’imperativo categorico
kantiano, viene attuata paradossalmente attraverso l’etica radicale e la ripersonalizzazione della morale. Le intuizioni kantiane hanno dovuto aspettare
due secoli per manifestarsi, e ciò è avvenuto non grazie alla morale religiosa (o
alla morale illuminista che da essa deriva) ma invece, paradossalmente, grazie
alla fenomenologia. Con tale svolta imprevista l’etica ha contraddetto i principi utopici dell’illuminismo e la simmetria che il pensiero dialogico (da
Buber a Gadamer) aveva dato per scontata, affermando invece il suo opposto: l’asimmetria.
Presupporre una reciprocità simmetrica fra gli esseri comporta l’accettazione di una neutralità che, come in ogni neutralità (ontologica o tecnologica
che sia), condona il soggetto impedendogli di cimentarsi nell’ansia della
scelta etica, privandolo della dignità esistenziale che tale scelta comporta.
Essere con (Mitsein) su tale territorio neutro vuol dire trovarsi di fianco
all’altro; ma solo l’incontro faccia a faccia può inaugurare l’avventura etica.
Mitsein ricostruisce invece il noi, un luogo neutro nel quale ci troviamo a
marciare a tempo con l’altro, a combattere insieme l’alterità (nel nome di
un’identità, di una nazionalità, di una divinità intorno alla quale ci stringiamo ansiosi); essere per l’altro comporta invece impegno etico, l’unico
attraverso il quale l’individuo si denuda dell’ipseità e riemerge come individuo
in grado di rispondere. Essere-con appartiene ancora al dominio dell’astrazione
neutra e può, in quanto tale, venire regolato dalla legge; essere-per sfugge
invece alle ingiunzioni esterne, e risponde alla necessità interiore, al mistero
dell’etica-dentro-di-me. Ma tale necessità non è propriamente interiore (visto
che l’interiorità non esiste intrinsecamente ma è un termine descrittivo): è
piuttosto una risposta dettata dalla presenza e dal volto dell’altro, un atto
per molti versi non-razionale, l’ospitalità di chi riconosce l’impossibilità intrinseca di abitare in qualsiasi luogo se non come ospite, passeggero, persona
itinerante. L’ospitalità del bodhisattva, di un essere abbandonato alla propria infinita solitudine, e quindi in grado di rispondere adeguatamente
all’inalienabile solitudine dell’altro. Non è la società a fare di noi persone
etiche; l’osservanza delle regole sociali fa di noi rispettabili borghesi, ma
non ancora cittadini nel senso che Hannah Arendt attribuisce al termine,
persone in grado di una solidarietà e un senso civico che eccede l’applicazione
!
#(!
Chi ama lo straniero
di regole dietro cui si cela la banalità (ma anche la sinistra magnitudine) del
male. Per diventare partecipi della società umana, per essere società, l’io deve
passare attraverso la propria solitudine e trovare, nella notte buia, una risposta al lume che balugina misteriosamente dall’altra sponda del fiume scuro.
Fin dall’infanzia, la barriera allo stimolo ci protegge, secondo Freud,
dall’artiglieria delle sensazioni, e finisce col proteggerci dagli altri. La congettura bio-poetica di Freud in Al di là del principio del piacere attribuisce
un carattere prominente alla protezione, più importante del processo stesso
di ricezione degli stimoli. L’organismo creerebbe una barriera complessa
ed efficace verso gli stimoli esterni ma non verso quelli interni, ed è per
l’appunto a tali aspetti negati della psiche che andrebbero attribuite le famigerate proiezioni – famigerate perché ogni proiezione è proiezione del male.
Tale prospettiva è confutata non da ultimo da Daniel Stern: oggi viene universalmente accettato che l’infante cerchi stimoli attivamente invece che
costruire una protezione contro il mondo esterno. Sul carattere di fondamento della relazione primaria si è venuto a formare un vasto consenso che
vede nell’inter-soggettività la chiave alla comprensione, se non della condizione umana, per lo meno di ciò che costituirebbe una relazione terapeutica
riuscita; resta da vedere se in tale entusiasmo per la dimensione intersoggettiva si trascura l’autonomia dell’individuo, e con essa la sua solitudine
e il bisogno altrettanto cruciale di separazione.
L’inter-soggettività nella psicologia e nella psicoterapia è andata a caccia
di radici filosofiche che dessero lustro e profondità alle sue affermazioni;
ha trovato maestri e figure a cui ispirarsi, estraendo dal pensiero di ognuno
caratteristiche che giovassero alla diffusione di un modo di sentire per molti
versi pregiudiziale, cioè deciso in anticipo. Da Buber la psicologia intersoggettiva ha preso in prestito la nozione dell’Io e del Tu, dimenticando che
tale elevato modo di relazionarsi all’altro è rarissimo, qualcosa che avviene
per caso, o dopo una lunga e complessa disciplina del rischio e del sacrificio:
rispettivamente mettendosi a nudo, esponendosi al pericolo della ferita e
dell’intimità, e successivamente abbandonando le infinite potenzialità di un
organismo vibrante e cristallizzando l’atto creativo nell’accettazione della
sua finitezza e irripetibilità. Nel saccheggiare la rigorosa e tersa etica buberiana, gli psicologi dell’inter-soggettività hanno altresì trascurato la presenza
della divinità, senza la quale la santificazione della relazione umana è vuoto
!
#)!
!
Manu Bazzano
simulacro. La questione non è Dio o non Dio, ma se alla divinità corrisponde
l’esperienza dell’infinito, la decentralizzazione dell’ipseità, il disorientamento
e l’anelito senza oggetto, l’indigenza di un volto che esige da noi una risposta,
oppure l’interpretazione totalizzante, la codificazione e personificazione di
norme, lo stendardo di un’identità collettiva fondata sulla violenza e sull’odio
dell’alterità.
Relazione d’aiuto? Dal pensiero di Gadamer la psicologia dell’intersoggettività ha preso in prestito la fallibilità, che ci apre potenzialmente alla
conversazione e all’indagine autentiche, e ci segnala l’inevitabilità del pregiudizio nel processo interpretativo. Nell’universalizzare tuttavia tale posizione – e nella trasposizione dall’ermeneutica alla psicoterapia, dalla relazione del
lettore con il testo a quella del soggetto con l’interlocutore – si sorvola
sull’inerente disparità di ogni relazione, e in particolare sull’inevitabile disparità all’interno della relazione d’aiuto. Il termine stesso “relazione d’aiuto”
è sospetto: si dimentica la fondamentale diseguaglianza e asimmetria di tale
incontro, si dimentica il peso dell’ideologia che inevitabilmente opera una
contraffazione di ogni presunta comprensione. L’ermeneutica di Gadamer
può essere usata come metodo valido soltanto se abbinata a una critica sociale
attenta, che dubiti attivamente di ogni comuncazione diretta e spontanea fra gli
individui in nome di un’aspirazione alla giustizia sub specie aeternitatis. Un
dialogo si avvicina forse alla comunicazione diretta soltanto se considerazioni sociali, economiche e politiche ne sostengono a ogni svolta il ritmo,
evitando lo scivolamento nel populismo.
Estraneo a me stesso. L’etica è necessariamente al di là del bene e del male.
Secondo il Mumonkan, testo chiave dello Zen, preoccuparsi del bene e del
male equivale ancora a desiderare il paradiso e temere l’inferno, e tradisce
un’attitudine servile. La vita virtuosa, apportatrice di felicità – l’eudomonia
di Aristotele – vuol dire in tale contesto prestare attenzione al proprio daimon,
seguire la propria vocazione, ubbidire sia al fato che al proprio carattere
(inscindibili per Eraclito). Attualizzarsi non è attualizzare un sé, per sua natura
fluido e privo di esistenza intrinseca, ma seguire la tendenza dell’organismo
verso l’attualizzazione. Kurt Goldstein, e successivamente la psicologia
umanistica, ci ha insegnato che l’attualizzazione coincide con una presa di
!
$+!
Chi ama lo straniero
posizione positiva da parte del sé, di cooperazione e contributo attivo alla
vita sociale. È d’obbligo tuttavia acquisire capacità valutative interne che
non coincidano con la mentalità tribale e con l’ideologia del gregge di cui il
sé è frammento interiorizzato; e ciò vale ancor di più in un’era post-moderna
che, sanzionando la fine dell’ideologia, conferma involontariamente il dominio assoluto e occulto dell’ideologia borghese.
L’humus originario deve diventarci estraneo, ma ciò non basta: dobbiamo
diventare estranei a noi stessi. In tale estraniazione si apre un vuoto che ci
invita a setacciare i contenuti culturali che ci hanno costituito; distaccatosi
dall’ideologia tribale, avendo seguito un percorso individuativo di volontaria discesa ed esilio, l’individuo ritorna nella comunità umana per offrire un
contributo sub specie aeternitatis. Tale processo è danza, apprendistato e
iniziazione a phron$sis e sophia, alla saggezza spicciola e alla visione del
mare aperto, al buon senso e al sublime. A differenza che in Aristotele, nel
Buddhismo troviamo l’unificazione di tali due aspetti in prajñ#, risposta
immediata alla provvisorietà dell’esistenza; non si ravvisa la stessa unità
nella teologia classica che ha invece contestualizzato phron$sis e sophia
nella divisione arbitraria fra immanenza e trascendenza.9 L’assimilazione
del Buddhismo in Occidente è avvenuta tramite l’idealismo tedesco, il trascendentalismo americano e le varie ideologie dell’espiazione di matrice
cristiana, e tali categorie hanno colorato il Buddhismo occidentale fin
dall’inizio. Prajñ# è una: va digerita, direbbe Huang-Po, nella pratica quotidiana, al cui centro vi è la meditazione senza oggetto, o zazen. Le virtù
(paramita) vengono apprese, assimilate invece che acquisite dalla volontà,
che è una facoltà del sé, e che finirà per dichiarare (come avviene nelle persone cosiddette virtuose) la propria dirittura morale. Allo stesso modo i
precetti buddhisti non sono ingiunzioni né metodi volti al risveglio spirituale, ma manifestazioni della natura-di-Buddha.
Fra le conseguenze della morte di Dio vi è il fraintendimento dell’etica come
transazione e normativa, e la perdita di quelle caratteristiche, eredità dell’ellenismo, che la interpretano invece come coltivazione del carattere, cura di sé
attraverso la disposizione virtuosa che sorge dall’ascolto del daimon, dal co!
9
Per una discussione approfondita della phron$sis secondo Epicuro, si veda Romano Màdera,
Il nudo piacere di vivere, in particolare il secondo capitolo, “Lo scacco”, pp. 23-33.
!
$*!
!
Manu Bazzano
raggio, dall’umiltà e dalla compassione (attributi connessi all’istante), dalla
loro successiva organizzazione nella moralità, nella lealtà e nella giustizia (attributi connessi all’intervallo). L’individuo non sopravvive a lungo nell’istante,
nella dimensione dell’Io e del Tu, della comunicazione autentica, della vulnerabilità e del rischio, né sopravvive unicamente nell’intervallo, nel dominio
della legge codificata, nel rispetto lineare delle norme sociali; nel primo caso l’individuo brucerebbe come meteora nel cielo d’estate, nel secondo si
troverebbe imbalsamato nel museo della rispettabilità. Entrambi sono caricature dell’etica e distruggono la natura poetica della virtù, una dea che
continuamente sfugge, una dea che esiste in fuga.
La sfera della legge vede il trionfo della cattiva fede istituzionalizzata,
ciò che siamo soliti chiamare vita sociale, un’esistenza organizzata secondo
complesse strategie di non-incontro, una rete di incontri mancati; poiché non è
possibile evitare d’imbattersi e avere a che fare con l’estraneo e lo straniero,
elaboriamo complessi rituali di non-incontro allo scopo di mantenere viva la
nostra pretesa di esseri morali. Vi sono ovviamente casi in cui tale elaborata
farsa viene accantonata per far posto alla barbarie e al primitivismo: l’olocausto,
le leggi sull’emigrazione, il razzismo verso i migranti, l’abominevole operazione white Christmas nel Nord Italia per sbarazzarsi dei “clandestini”.
La legge etica non viene dunque appresa (Kant) o contemplata (Platone)
e successivamente messa in pratica: è creata invece nell’istante, nell’incontro a
tu per tu, nella percezione del volto di chi mi sta di fronte. Non un atto di
volontà ma una convergenza gratuita fra la circostanza e l’apertura vulnerabile dell’individuo, l’operato della grazia, il miracolo. Oppure, se non si
vuole abdicare alle interpretazioni prosaiche della religione, la poesia.
Nell’atto gratuito del perdono, nell’atto gratuito dell’amore, si percepisce
l’istante, la soglia dove il percorso lineare del tempo acquista per la prima
volta significato (ed è sempre la prima volta). Il perdono razionale invece
sa scusare solo ciò che è scusabile, e nel far ciò dimostra la superiorità morale di chi magnanimamente (e ostentatamente) perdona; al contrario il perdono
che nasce dalla visione poetica perdona l’imperdonabile. E si finisce spesso
per amare chi si è perdonato.
Vladimir Jankélévitch ha elaborato un’analisi del perdono che smaschera
abilmente i diversi tipi di perdono inautentico con i quali imbellettiamo il
nostro agire. Si perdona per un calcolo probabilista: come giocatori d’azzardo,
!
$"!
Chi ama lo straniero
assolviamo il malfattore nella speranza che il futuro ci darà ragione; si perdona spinti dall’ottimismo e dall’arroganza: in preda alla concupiscenza
spirituale, si vuole redimere il colpevole, trasformare un’anima persa tramite
il contatto con la nostra smisurata bontà; si perdona strategicamente: odium
amore expugnare (Spinoza). Se poi veniamo colti in flagrante dalla grazia, dalla poesia, ci scusiamo, e, parlando, tessiamo lodi utilitariste nel linguaggio della
compravendita. Imitiamo Pascal che persuade l’ateo a una fede probabilista.
Forse il perdono autentico non esiste; se esiste è una forma d’amore, un
amore non civettuolo o “romantico”. Il giullare sforna sonetti e canzonette,
ma in verità è innamorato di se stesso, della propria anima nobile che s’irradia
in melodie loquaci e ritmi compiaciuti. E tuttavia dall’amore si può venire
travolti, nell’istante in cui la finitezza dell’altro ci viene rivelata e inonda il
cuore di malinconia e gentilezza, l’indicibile dolcezza della musa virgiliana,
pre-cristiana, libera cioè dal cattivo gusto dell’amore esclusivo e fanatico, libera dalle lusinghe dell’anima immortale e dei suoi melodrammi di redenzione e
peccato. La pietas (o bodhicitta) è asimmetrica. L’amante è disinteressato, il
suo canto è fiamma e carezza: si fa beffe dell’espiazione, del karma, della giustizia pesata sulla bilancia del mercato, dell’occhio per occhio, della barbarie
determinista presente in ogni religione. La pietas va al di là della mera gratitudine, che è frutto della compravendita e dell’obbligo, sorella dell’ingratitudine
e troppo spesso rivestita dei panni bigotti dello zelo religioso.
Nel perdonare si corre il rischio di apparire sublimi, se il perdono nasce
da una decisione, un calcolo nato nell’intervallo e non è invece, come suggerisce Stendhal, cristallizzazione, la trasfigurazione dell’amore che fa dell’amante
un genio del cuore. La trasfigurazione avviene nell’istante e spinge ad agire
eticamente, più tardi forse si scovano ragioni e principi, ma chi vive poeticamente perdona poiché presuppone ciò che Nietzsche chiama l’innocenza
del divenire: si accetta l’altro. L’accettazione accetta perché accetta. Il
bodhisattva non rimane in attesa dell’ipotetica illuminazione: agisce adesso,
cioè nell’istante. L’amore ama perché ama, per causa propria. Anni luce dal
dramma solipsista del pentimento, il perdono ci sospinge verso l’esteriorità e
nell’impatto con essa veniamo educati, istruiti. L’educazione non è maieutica,
monologo esistente a priori che l’abile interlocutore socratico ci aiuta a estrarre
dalla miniera immaginaria dell’interiorità: nasce dall’impatto con l’esteriorità,
!
$#!
!
Manu Bazzano
dal fare i conti con l’alterità e con l’irriducibile inconoscibilità di chi mi sta
di fronte.
Impersonalità della saggezza antica. Chissà, si domanda Kant ne I fondamenti
della metafisica, se ci sia mai stato un singolo atto virtuoso nella storia
dell’umanità... Una domanda validissima: la virtù non appartiene al dominio
dell’ipseità. L’amore disinteressato e il perdono non sono attributi dell’identità,
la compassione è la qualità naturale di una divinità, l’apparizione che avvenendo ci sfugge, che accade in relazione. Il perdono si dà in relazione, è diverso
dalla clemenza degli stoici e dalla generosa benevolenza di chi perdona e
ama in modo impersonale, come un re che distribuisce doni ciecamente ai
sudditi anonimi e senza volto. La saggezza antica è spesso impersonale e
trova un correlativo inaspettato nella ricerca del neofita post-moderno di un
rifugio elevato dal tumulto samsarico di questa valle di lacrime; nella contemplazione l’esausto abitante della metropoli e il surfer solipsista della
world wide web cercano l’atarassia, un’equanimità fraintesa come indifferenza, un balsamo qualsiasi per le ferite multiple della condizione umana.
La filantropia generica predicata dagli stoici, la benevolenza astratta di
chi ama la foresta ma non conosce l’albero, il misticismo della psicoterapia
transpersonale contemporanea che sorvola sulla persona senza averla prima
compresa, il neo-Zen trascendentale che dimentica il sé senza averlo prima
studiato nell’ambito in cui esso emerge, cioè nell’impatto con l’alterità…
Viene da chiedersi se tale sete di trascendenza che continua a manifestarsi
in ogni epoca non sia una fuga dalla condizione umana.
Risonanza e riverbero. L’etica non è possibile senza la consapevolezza
dell’impermanenza; in tal senso essa precede la filosofia, la scienza, la religione, che invece si occupano di domande riguardanti l’essere, i fatti e
l’eterno. Senza la consapevolezza dell’impermanenza, l’arte e l’amore non
sono possibili. Tutto cambia incessantemente, compreso il soggetto che osserva il cambiamento, compresa la consapevolezza che in alcune tradizioni
spirituali è immutabile testimone dell’universale caducità; in breve, il
testimone non esiste.
La questione del tempo è centrale nell’etica. L’atto radicale e immotivato del perdono conferma il divenire, la dimensione fugace contro cui certa
!
$$!
Chi ama lo straniero
filosofia erige sistemi, la religione chiese e templi, e la politica palazzi e
penitenziari. Nell’accettare il divenire si accetta la frammentarietà dell’io,
la sua esistenza effimera; l’esteriorità, in tale dominio, ci raggiunge allora
non più come risonanza ma come riverbero. La risonanza: un termine alla
moda nella psicoterapia dialogica, al suo centro l’io, che riconduce a sé ogni
genuino impatto con l’esteriorità, facendo di ogni esperienza un’escursione
turistica. Nel riverbero il centro è invece l’altro, e nell’apertura ai cerchi
concentrici del suono che irradia dal centro del suo essere l’io viene trasformato; la centralità dell’altro e la centralità del divenire sono correlate
intimamente. La fedeltà al divenire non è astratta spontaneità ludica, e
l’apertura al divenire, all’apparenza, all’impermanenza sono ancora più potenti
se sostenute dalla facoltà della memoria: la memoria, che è immaginazione,
arricchisce l’esperienza, costituisce lo sfondo su cui l’irripetibile espressione
dell’istante diventa vivida fino all’inverosimile. Complici del divenire, e
tuttavia radicati in una facoltà, la memoria, che è anch’essa soggetta al
cambiamento. L’immaginazione ricostruisce nel presente ricordi remoti, e
mutamenti nell’esperienza presente modificano la natura stessa dei ricordi.
Il rancore resiste al divenire: congela chi ci ha insultato e non accetta
modifiche, non accetta il fatto che l’altro è parte del fiume incessante del
vivere-e-morire. Il perdono abbraccia il divenire, dissolve la presunta solidità del sé e dell’altro e va incontro alla vita senza pesi sulle spalle. Si impara
a dimenticare, si pratica la disciplina dell’oblio attivo, dissolvendo così gli
antichi spettri del rancore, che erano mantenuti in vita da vecchie superstizioni; nel dissolvere il rancore, si dissolve la memoria del male subìto. Nel
rancore, ci ricorda Jankélévitch, miriamo a un oggetto che si è spostato nello spazio e in tal modo colpiamo a vuoto. E se l’amore per un fantasma è
per definizione stregato, il rancore lo è doppiamente: non soltanto superato,
ma anche nocivo.
Il percorso di individuazione non segue qui i tracciati del convenzionale
e sentimentale ritorno a se stessi, che è segnato dalla risonanza: un suono
esterno viene assimilato e neutralizzato. Nel riverbero, invece, l’alterità mi
raggiunge mantenendo intatta la sua forza poetica e il suo potenziale inquietante e trasformativo: non vi è reazione né risposta ma ascolto, la disciplina fluida
che come l’acqua finisce per corrodere la rigidità ostinata dell’ipseità.
!
$%!
!
Manu Bazzano
Ostacolo al riverbero e al suo impatto trasformativo è la mia stessa convinzione rispetto alla solidità del mio mondo e del mio milieu culturale.10
Nel desiderio senza oggetto e senza scopo l’escursione oltre i confini
dell’ipseità ha valore solo in quanto riverbero dell’alterità. Allo stesso modo
l’individuazione è frattura, vedovanza e perdita. E l’esilio è avventura che avvicina l’esule alla natura provvisoria – scevra d’illusione – della natura umana.
Jamais vu. La discesa nel divenire conduce il soggetto a risultati ambigui:
nell’accettare l’imperfezione e l’impermanenza si potrebbe credere d’essere
in qualche modo “salvi”, di scampare ai suoi pericoli. Nel divenire si trova
ristoro, ma al contempo si fa esperienza diretta della sofferenza. La temporalità
è a un tempo rigeneratrice e letale: l’organismo malato giunge lentamente
alla salute, e il cuore ferito trova infine un luogo di ristoro; ma il tempo
conduce inesorabilmente alla vecchiaia, alla diminuzione dell’energia, alla
stagnazione e infine alla morte. Difficile nutrire fiducia completa nel divenire;
la sua ambiguità ci seduce ma finirà con l’ucciderci. Eppure la consapevolezza del ritmo dialettico del divenire può spronarci ad accettarne il cimento
e rispondere attivamente, invece che assorbirne i colpi letali supinamente. Il
perdono passivo, nato da una percezione univoca della caducità, è dunque
apatia, amnesia più che amnestia, come ci ricorda Jankélévitch. Il perdono
che accetta il ritmo dialettico del divenire è invece rivolto all’altro, è consapevole della sua mutevolezza e della morte-in-vita, cioè del cambiamento
cui l’altro è soggetto; tale forma di perdono è dunque diversa dal perdono
concesso dall’egoista spirituale che ha fatto tesoro dell’ingiuria, decorando
così ulteriormente la propria anima nobile.
Il tempo e l’oblio da soli non possono guarirci dal rancore: “È passato
così tanto tempo… – si dice comunemente – certo che ti ho perdonato!”. Ma
devo essere in grado di farlo io stesso, mediante un atto istantaneo, immotivato,
un atto mio malgrado: si tratta di una decisione al di fuori della volontà, perché
la volontà è per sua natura egoica; è un dono gratuito, un atto creativo che
osa sfidare i processi psicologici e l’evoluzione biologica, che contraddice il
darwinismo spicciolo della psicoterapia e della spiritualità contemporanea,
secondo cui il processo e la cosiddetta crescita sono tutto.
!
10
Per approfondire l’argomento si veda Blanchot 1981 III, VI “L’assenza del libro” ne
L’infinito intrattenimento e Bachelard La poetica dello spazio 1960.
!
$&!
Chi ama lo straniero
Agire eticamente comporta una rottura, un ricominciare da zero: non
crescita ma creazione, l’inverosimile, il mai visto, mai accaduto. Jamais vu
piuttosto che il trito déjà vu del misticismo dozzinale: un jamais vu che è
perplessità, dubbio, meraviglia, esperienza di ciò che non può venire rimpiazzato. L’atto etico è l’atto di un grande artista che scompare nella creazione,
un atto contro-natura, contrario alla territorialità e alla tendenza verso la
violenta cristallizzazione nell’identità su cui si fondano i principi religiosi
naturali (e naturalmente violenti) e contrario al conformismo di ciò che viene
comunemente ritenuto naturale. In tal senso l’etica è arte, invece che morale; è per sua natura anti-reale, nel modo in cui lo è ogni arte che meriti tale
appellativo, perfino l’arte realista.
Merita forse l’impersonalità del saggio (di chi, come Socrate, né perdona
né prova rancore nei confronti del tribunale ateniese, ma si limita a dire
“Nessuno fa del male consapevolmente”) l’appellativo di atto etico? Nell’antica
saggezza stoica, così come in quella della spiritualità New Age, la saggezza
sorvola sull’umanità caduca dell’altro, non entra in relazione con esso ma
eleva chi ha subìto il torto così in alto che l’offesa non può raggiungerlo: espediente igienico, e al tempo stesso denigrazione dei sentimenti umani. In alcuni
gruppi Zen si parla similmente di “compassione idiota” e ci si inchina alla spada discernente del Buddha Manjushri; nel denigrare la compassione idiota
(che prende giustamente le distanze dalla pietà paternalista) si sorvola tuttavia sulla ferita implicita in ogni relazione, e sul necessario attardarsi in una
dimensione sommariamente liquidata come “relativa”.
L’etica va oltre il perdono cognitivo o la conversione intellettuale che
avvengono al cospetto dell’insegnante o del maestro che impartisce perle di
saggezza in accordo con l’idea del bene. Si trova tale invito a una conversione intellettuale in Leibniz, il quale esorta l’individuo, monade limitata, a
sintonizzarsi con l’armonia del cosmo; lo troviamo altresì in Spinoza, che ci
invita a diventare amici del prossimo e anzitutto amici di noi stessi; e anche nel
Nuovo Testamento, dove ci viene detto che sia gli astanti che gli assassini
“non sanno quello che fanno”, e si rifiutano peraltro di credere all’insegnamento di un uomo ordinario che non appare loro in vesti divine o regali.
Troviamo l’invito alla conversione nell’ellenismo, sotto le spoglie di quella
padronanza di sé che Nietzsche tradurrà in superamento di sé, nel possedere
se stessi e diventare padroni del proprio fugace esistere oltre la razionalità,
!
$'!
!
Manu Bazzano
nel rispetto per la passione dell’intelligenza, della sottigliezza potente della immaginazione.
Si tratta certo di una conversione, un rigirarsi su se stessi a trecentosessanta gradi, riconoscendo la complessità della psiche e la sua natura polimorfa;
si tratta di scoprire una padronanza che non si fondi più sull’io monadico ma
sull’individualità. Tale conversione (laica, simbolica, poetica prim’ancora
che religiosa) si muta alchemicamente, grazie alla combinazione vincente
di passione e disciplina, da comprensione intellettuale in embodiment. Sintomi della conversione avvenuta sono la vertigine, il senso di pericolo che
sentiamo allorché abbiamo abbandonato la falsa stabilità di un “centro” che
in primo luogo non era mai esistito. Metodo sicuro per usare la fiamma dello
sguardo intellettuale senza il fumo dell’ego è la sospensione del giudizio, il
metodo suggerito da Sesto Empirico e reso efficace dalla fenomenologia e
dalla psicoterapia esistenziale, e noto come epoché; resta poi da vedere se
tale sospensione annuncia la trascendenza husserliana o se è invece essenzialmente un atto d’amore (di passività radicale, il desiderio di una conoscenza che
per Lévinas è amore), e anche un atto di impegno le cui implicazioni sono,
per Sartre, politiche.
Esso è comunque un atto di rinuncia che apre la possibilità dell’amore e
divincola la moralità dalle grinfie del super-io. L’intuizione di un’essenza
(vera o immaginaria) passa attraverso l’empatia e una conoscenza che è
non-sapere; più l’amante ama, meno egli conosce l’amata. Il suo è uno stato
di ignoranza profonda che crea una volontaria distanza fra sé e l’autonomia
e l’inconoscibilità dell’altro, una cecità voluta e cercata, contraria alla lucidità del rancore e all’intimità perversa dell’odio. L’odio inonda l’oggetto di
una luce poliziesca accecante: nel dissezionarlo ne estrae una confessione,
ne apprende particolari triviali e incriminanti, ma si allontana dalla musica
sottile che lo anima e a ogni istante lo sospinge nel fiume dell’esistenza; un
sapere siffatto uccide l’altro e costruisce al suo posto un simulacro da manipolare a piacimento. Il non-sapere si ispira invece ad Eros, figlio di Poros
e Penia: povero, abita nel bisogno e nel desiderio, ma è anche coraggioso,
intenso, e un grande cacciatore. A Eros dobbiamo il movimento essenziale
che dalla vetta della saggezza impersonale discende all’amore personale,
alla sfera quotidiana, all’immanenza, all’imperfezione del divenire: un atto
folle che ama ciò che non è amabile né degno d’amore. È una caduta rovinosa
!
$(!
Chi ama lo straniero
che dà tuttavia senso alla nostra esistenza e ci sottrae dalla ricerca tirannica della
felicità. È un amore scandaloso che rifiuta la presunta saggezza dell’impersonalità del tempo e dell’oblio, e mantiene un difficile confronto con l’altro.
All’oblio passivo Jankélévitch preferisce il risentimento, poiché in esso sussistono ancora serietà, profondità e un impegno del cuore, il rifiuto di rilassarsi
nell’accomodamento di una confortevole e blanda riconciliazione. Coltivare
il rancore nasce tuttavia da un rifiuto di accettare un incontro con l’altro e
dalla conferma riconosciuta della propria inferiorità.
Bisogna poi considerare casi in cui la solidarietà verso un popolo oppresso
si tramuta nell’obbligo di dover rispettare gerarchie e pregiudizi di quel
particolare gruppo; anche all’interno delle società oppresse l’alterità viene
negata e i privilegi rimangono immutati. Una radicalità che rispetti l’alterità
afferma invece l’esilio, l’assenza di dimora, una laicità che si esprime nel
rifiuto dell’integrazione e dell’identità poiché nell’esilio – condizione penosa e difficile – si cela la promessa dell’assenza di dimora ontologica, cioè
libertà dal falso bisogno di possedere identità e nazionalità, nonché libertà
dall’avere e dall’essere. Irreversibile nelle società omogenee del capitalismo
globale, l’esilio – forzato o volontario che sia – afferma la natura nomade della
condizione umana; ciò comporta l’accettazione piena delle conseguenze della
morte di Dio. Una laicità profonda rifiuta qualsiasi ombra di Dio, compreso
lo scientismo, la fede nella politica e nelle pratiche idolatre della felicità.
Dopo Hegel, la laicità è stata associata alla fede nella Storia, intesa come
fonte metafisica e origine esplicativa mediante cui interpretare gli eventi in
chiave evoluzionista, determinista, o dialettica; sarebbe interessante riconsiderare in tale contesto gli insegnamenti di Vico e di Gramsci, entrambi
esponenti di concezioni non messianiche e non-totalizzanti della Storia e
tuttavia emancipatrici.
L’esito finale di una laicità che scavi nel profondo è la messa in discussione
dell’identità in quanto ultima eredità (assieme a quell’altro fantasma dello
psicologismo, l’integrazione) di un Dio deceduto da tempo. Abbandonare
volontariamente la nozione falsa di identità: in ciò consiste, incidentalmente,
l’oggetto primario della meditazione buddhista. Il Buddhismo – un Buddhismo
senza fedi e pregiudizi – è un percorso volontario di disorientamento e non
va identificato con la contemporanea ricerca della felicità e la creazione
di una bio-moralità, coaudiuvata dalle neuroscienze e dalla terapia cognitiva
!
$)!
!
Manu Bazzano
e comportamentista. Abbandonare il proprio posto al sole, abbandonare volontariamente la propria identità – e con essa la nozione stessa di identità –
comporta un’apertura alla polifonia di voci all’interno del sé e all’interno
della cultura o culture in cui si è cresciuti. Non più il banale universalismo
– da sempre dettato da culture e nazioni egemoni – che si inventa sintesi ideali
di società disparate, dimenticando la loro specificità; non più un amore per
l’umanità che sorvoli sulla fondamentale asimmetria (e ingiustizia) che caratterizza i rapporti sociali e i rapporti fra le nazioni; non più il trascendentalismo
evoluzionista oggi di moda, che si illude di raccogliere e integrare le scoperte
di diverse tradizioni spirituali sorvolando sulla loro unicità antropologica,
mitica e socio-economica.
Chi può al giorno d’oggi abbracciare l’esilio e il nomadismo, la laicità
radicale e il rifiuto consapevole dell’identità e dell’integrazione? Prima di
tutto chi, trovandosi costretto in tale posizione dalle democrazie occidentali
e dai valori imposti dalle nazioni-stato e da regimi tuttora feudali, non può
che accettare attivamente tale stato di cose, esprimendo in tal modo la propria dignità. E poi l’artista, l’intellettuale anti-dinastico, chi per irrequietezza
etica ed estetica non è fedele a nozioni populiste di appartenenza tribale, e
si trova a rifiutare la lealtà astratta a un gruppo etnico o politico. Il ruolo
dell’artista è per l’appunto quello di frantumare le vaste identità nazionali,
culturali e trans-culturali, e smascherare l’universalismo dei potenti; compito
difficile e tuttavia urgente. Rivelare la pseudo-omogeneità e pseudo-organicità
di qualsiasi gruppo sociale, politico, nazionale; affermare l’individualità nel
senso di Montaigne invece che di Cartesio: non un ritorno al solipsismo e
alla dubbia universalità del raziocinio, ma rivalutazione delle nozioni di critica e originalità, di studio di sé, dell’irriducibilità e irripetibilità di una identità
fluida, che momentaneamente si allea a movimenti e gruppi che in modo
eclatante subiscono la barbarie dei gruppi egemoni, di quelle minoranze il
cui moto appartiene al divenire invece che alla Storia. Lealtà agli oppressi
non è lealtà dogmatica a una classe, ma esser pronti ad affiancare chi non
ha alcun sostegno. Per un artista o intellettuale borghese che vuole continuare
a definirsi artista e intellettuale, ciò comporta necessariamente la rinuncia ai
propri diritti e all’idea stessa dell’identità e del potere.
!
%+!
Chi ama lo straniero
Entropia borghese. Un’etica borghese è una contraddizione in termini. L’etica
richiede il saper riconoscere le esperienze esterne al soggetto, mentre la vita
di una persona borghese è per definizione centrata su di sé e definita
dall’incapacità di comprendere e apprezzare ciò che si dispiega al di fuori
del recinto che delimita i suoi possedimenti.
L’omologazione globale iniziata dopo la fine della seconda guerra mondiale ha fatto dell’ideale borghese un modello universale, un fenomeno che
Pasolini chiama entropia borghese,11 un termine che smaschera la squallida
implosione e la decomposizione soddisfatta della felicità recintata – uno
stato di protezione (e quindi di auto-incarcerazione) che eleva la misantropia
a ideale e la misologia a pratica di vita: l’odio dell’altro e l’avversione alla
conversazione, al confronto, alla discussione (in ultima analisi all’amicizia
e alla filosofia). Senza il confronto-incontro con l’altro (diverso, esterno da
me) l’etica non è possibile poiché essa non è ripetizione ma creazione: simile alla performance musicale, simile all’amore – in cui l’atto originario
viene eseguito come se accadesse per la prima volta.
Nell’azione etica (di risposta radicale all’alterità), così come nella musica
e nell’amore, si disfa volontariamente il velo protettivo del dogma (dell’opinione fossilizzata o articolo di fede) che si pone fra noi e le cose, fra noi e le
azioni: l’individuo abbandona l’ipseità borghese – lo fa involontariamente,
come un musicista che suo malgrado tocca il cuore dell’ascoltatore. O come
accade forse nel rammarico sincero e penoso che si impadronisce di noi e ci
fa comprendere il danno provocato a un altro senza ricorso al melodramma
della morale istituita, alla commedia hollywoodiana della redenzione. Si cade
(o ci si imbatte) nell’azione etica, nella gioia e nell’estasi. Si arriva all’amore
infine, ma da esiliati. L’etica è un fiore del deserto, non un’orchidea coltivata
in una serra: è connessa alla sofferenza, alla gioia profonda, alla gioia tragica.
L’etica, come la filosofia, è un’arte: c’è chi considera la filosofia una scienza,
ma per alcuni pensatori la filosofia è un’arte simile alla poesia, alla poesia del
vivere. La filosofia deve saper abbandonare l’ontologia e l’asservimento
all’avidità aspirazionale del raziocinio che trasforma gli uomini in semidei
arroganti e patetici. Un mondo ipotetico in cui la religione avesse ancora
senso sarebbe subordinato alla fede. Il mondo post-religioso inaugurato da
Kant e dall’Illuminismo si è convertito alla dea Ragione innalzando in suo
!
11
!
Pasolini, 1972.
%*!
!
Manu Bazzano
onore un insigne tempio metafisico; ma nel mondo post-metafisico nel quale
ci troviamo ora a operare l’unica scelta per la filosofia è il suo stesso dissolvimento nell’estetica e nell’etica. Niente più ci obbliga a ubbidire alle
“avide aspirazioni” e alle “irritazioni” della ragione, come suggerito da Kant
all’inizio della Critica della Ragion Pura; niente più ci obbliga a ubbidire a
una divinità esclusivista nel cui nome le nazioni si massacrano. E niente più
ci obbliga a sottometterci alla necessità.
L’esempio filosofico più noto di un tentativo di insubordinazione alla
necessità è quello di Platone, la cui filosofia ha tuttavia evaso la realtà e si è
rifugiata nella fantasia (insubordinazione fallita, la sua, poiché ancora soggiogata al determinismo, sia pure a un determinismo a testa in giù), mentre
l’esempio filosofico più noto di abnegazione alla necessità ci è dato da
Aristotele, che ci invita ad arrestarci di fronte alla necessità. Entrambe le posizioni sono metafisiche: la prima presuppone l’esistenza di un substrato al di
sotto della necessità, la seconda rinforza una credenza dogmatica nei fatti.
Ma né lo spiritualismo né l’empirismo soddisfano in modo esauriente la
passione del pensiero creativo, a meno che si tratti di uno spiritualismo materialista, o di un materialismo aperto al mistero della materia.
A Hume dobbiamo la scoperta che i legami cosiddetti necessari normalmente attribuiti ai fenomeni sono relazioni fra eventi, e che chi parla della
necessità è simile a colui che sogna l’essere, ma da sveglio non ne percepisce
la realtà; il filosofo inglese non si spinse oltre ma riuscì certo a intravedere la
possibilità di un risveglio. Ma è possibile risvegliarsi alla necessità (secondo l’incoraggiamento di Kierkegaard e di Shestov), accettarla attivamente,
spezzare l’incantesimo e il sonno millenario del pensiero occidentale. Probabilmente i Greci dell’era tragica pre-socratica furono a conoscenza di tale
dimensione risvegliata, ma ciò che abbiamo ereditato è passato mediante il
filtro della filosofia stoica. Per Seneca neppure la divinità può permettersi il
lusso della creazione poiché anch’essa obbedisce alla necessità, e per Cicerone
il fato guida i volenti e trascina i nolenti. Al polo opposto e complementare
troviamo Platone, precursore d’ogni spiritualismo che seguirà, la cui posizione
è caratterizzata dal rifiuto della necessità e dall’enfasi sulla facoltà visiva, su
un’intuizione cognitiva elargitaci dalla ragione e il cui dono supremo ordisce
una maledizione: la “contentezza di sé” che trasforma l’essere umano in
sasso cosciente. Del resto Platone esita ad abbandonarsi del tutto a una visio-
!
%"!
Chi ama lo straniero
ne spirituale che finirebbe col servire il male, e che si allontanerebbe dalla
filosofia, cioè dalla pratica della morte, meletê thanatou, e che nello Zen
diventa pratica del vivere-e-morire. Acquisire una visione cognitiva, coltivare l’intuizione, è dunque in tale contesto la pratica del male, inteso non
nel senso moralistico attribuitogli dalla tradizione giudaico-cristiana, ma
come trivialità: il male come attitudine anti-estetica per eccellenza, il pessimo
gusto del giocatore d’azzardo che, volendo vincere a tutti i costi, dimentica la
sovranità della chance.
Da Platone a Pascal al XIV Dalai Lama viene riconosciuta la “naturale”
tendenza umana di ascrivere il vero al piacere, alla felicità e al tornaconto,
personale o spirituale che sia; ogni campo dello scibile e ogni campo
d’indagine è dunque passivamente subordinato ad Ananke, dea della necessità. Pochissime le eccezioni, per lo più poeti, filosofi/poeti o pensatori che,
come Kierkegaard, si affidano coraggiosamente fra le braccia dell’Assurdo.
Poeti non nel senso di sciorinatori di versi leggiadri, seducenti o disperati,
ma di individui che accettano attivamente la gioia tragica e in tal modo scrivono a nuovo il vocabolario della saggezza tramandata nei secoli. Poeti forti
diremmo, nel senso di individui la cui etica, appartenendo all’estetica e
all’apparenza, non si culla sugli allori dell’ontologia e della metafisica, ma
mostra già all’interno dell’immagine rivelatrice e sublime l’elemento caduco, l’imperfezione umana e contingente nel cuore di ogni un nuovo sistema
interpretativo. Qui la percezione dell’eternità avviene mediante la finitezza
del tempo: la lezione di Proust, attraverso la chiave interpretativa di Benjamin,
e anche la lezione di Baudelaire, di come sia piccolo il mondo agli occhi
del ricordo. Né eternalismo né materialismo: il poeta percorre a occhi aperti
il vivere-e-morire, apprende la sua arte alla scuola del morire (apothnêskein), si
familiarizza con la realtà inesorabile e delicata della morte, che è il nostro
futuro certo. Il poeta diventa amico e complice del vivere-e-morire, accetta
la necessità in modo dignitoso e non subordinato. La sua sapienza-saggezza
cessa di essere mera riorganizzazione di un vocabolario antico e venerato e
unisce – in modo ri-creato, discontinuo, istantaneo – la meditatio vitae alla
meditatio mortis. Chi si sottopone volontariamente a tale apprendistato arduo
e sublime non andrà più a caccia dell’essenza ma esprimerà con ogni gesto
la potenza e suprema vulnerabilità e paradosso dell’essere umano, al di là del
bene e del male, al di là del dolore e del piacere, compreso il piacere della
!
%#!
!
Manu Bazzano
contemplazione. Il Buddha realizzato ritorna sui suoi passi e si dirige verso
la piazza del mercato; egli non ha nulla da insegnare: l’ineffabile rimane ineffabile, non asservito all’utile, alla virtù mercenaria, al feticcio della proprietà
privata, dello status sociale e della conoscenza.
Dormendo, sognare il risveglio. Il moralista, lo scienziato e il prete hanno
sfidato la necessità, e la necessità ha vinto. Da ognuno di questi personaggi la
società ha tratto informazioni utili, efficaci per continuare a dormire e,
dormendo, sognare il risveglio; e dai metodi di risveglio radicali si impara a
dormire ancor più profondamente. Perfino l’insegnamento radicale del Buddha,
“sii la tua isola”, si trasforma in pseudo-autonomia isolazionista, in contentezza e rifiuto borghese di misurarsi con l’alterità e rischiare un’educazione.
Ogni filosofia radicale, inizialmente concepita come esplorazione, finisce
con l’erigere una metafisica e col regalarci un sistema meramente edificante.
Fra i filosofi dell’Ottocento, forse soltanto Kierkegaard e Nietzsche (il primo non a caso fra i pochi che avrebbe compreso la sofferenza immane di
Nietzsche proprio perché egli stesso ne fece esperienza) riescono a non scadere nel tedio della didattica moralista edificante, che da Socrate a Spinoza fa
di ogni filosofo un pedante. Forse soltanto Kierkegaard e Nietzsche hanno
saputo fare della filosofia e della spiritualità avventure rischiose, se concordiamo con il fatto che la fede (senza oggetto, immotivata) è un altro nome per
l’assurdo. Questo è il moto fondamentale che in Kierkegaard va dall’attitudine
del cavaliere della rassegnazione (della sobria razionalità) a quella del
cavaliere della fede: non un crociato, ma la persona che dalle rovine dei secoli
emerge con un sorriso di gioia e uno di scherno per la sovranità ingannevole di quel “giudice malvagio” (la Storia), al cui cospetto Hegel e gli europei
borghesi si inchinarono.
Nulla è impossibile per chi, abbandonata ogni speranza, abbandonato
ogni credo, abbandonata l’appartenenza ai culti idolatri della salvezza mondana
o oltremondana, ha fede; per chi rimane sereno e gioioso pur avendo fatto esperienza dell’assenza di fondamento, per chi è andato al di là della ragione e
della conoscenza. Dall’apoteosi del dubbio e della rassegnazione verso l’anelito
coraggioso per l’impossibile; dall’esilio tribale e dall’estraniazione psichica
all’affermazione della dignità che sorge nell’alterità. Che tale superamento passi attraverso l’esilio e l’estraniazione, e non tramite la hubris dello scientismo e
!
%$!
Chi ama lo straniero
della religione, evita il pericolo del titanismo, la sostituzione della divinità
con l’ego: alla divinità fa posto il cielo vuoto, l’assenza di fondamento, e il
primo messaggero di tale sublime vertigine è la presenza vivida, contingente
e miracolosa dell’altro. La sua presenza non è indicata nella Bibbia se non
negativamente, né nei sistemi della logica e della dialettica se non come
oggetto di studio; la religione e la scienza si inchinano alla necessità con
preghiere e formule matematiche e non riconoscono l’altro, a meno che egli
si manifesti come figlio dell’Uomo, essere realizzato o solida entità atomica
da analizzare.
Il pensiero occidentale dipende ancora dalla filosofia classica tedesca,
cioè dall’infatuazione per tutto ciò che è meccanismo. Perfino lo “spirito”
di Hegel risulta essere nient’altro che quella stessa “ragion pratica” kantiana
per la quale ci si comporta come se Dio esistesse, l’anima fosse immortale, e
il volere libero. Con l’ottimismo sinistro della Critica della Ragion Pura
Kant arriva ad affermare che, date le possibilità di esplorare il fenomeno
delle scelte umane, non vi sarebbe raggio d’azione che non sia possibile
prevedere nella catena di causa ed effetto; il medesimo determinismo meccanico lo troviamo nella legge del karma e nel fatalismo. Proprio sulla base di
tale visione meccanica sorge poi la glorificazione della libertà individuale,
come il sogno di libertà del prigioniero, come il presentimento della verità
fra gli abitanti della caverna platonica e il primo sentore di un risveglio vero
di cui parla Plotino. Tuttavia sognare la libertà non libera il prigioniero, ma
lo rinchiude fra le mura di una cella su cui egli ha dipinto il cielo.
Il poeta-filosofo si rifiuta di obbedire a tali fantasticherie addomesticate:
Orfeo non teme la discesa nell’Ade, Amleto segue il consiglio dello spettro
di suo padre, Don Chisciotte crea una realtà vibrante, comica ed eroica,
Pigmalione esige il miracolo, un giovane dona la sua vita per una notte
d’amore con Cleopatra. E se la cosiddetta liberazione risiedesse lontano dal
dominio della ragion pratica e dello spirito? E se un’azione non-reattiva – un
atto libero – appartenesse a una sfera al di fuori della legge? E se Kant disobbedisse all’imperativo categorico? E se, infine, Hegel violasse lo Spirito?
Abbandonare l’ipseità è, paradossalmente, il compito dell’individuo; allo
stesso modo abbandonare una matrice interpretativa eternalizzante è il
compito di ogni civiltà elevata. Il pensiero convenzionale teme sia la contemplazione individuale che collettiva della finitezza, poiché le interpreta
!
%%!
!
Manu Bazzano
come forme di autodistruzione, nonostante il fatto che tali caratteristiche
siano riscontrabili nel folklore e nei miti di civiltà evolute e nella biografia
di individui geniali.
Primo segnale tangibile della presenza della morte è la presenza dell’altro,
di quel prossimo il cui mistero non riusciremo mai a dischiudere, e la cui
implicita esigenza mi costringe a dare alla luce me stesso. Non ci si cimenta
più nel voler conquistare la morte ma nel liberarsi invece dal vivere-e-morire
mediante la partecipazione al vivere-e-morire: trascendenza mediante una
profonda discesa nell’immanenza. Dobbiamo perciò essere in grado di ammettere che non ci è dato osservare il dipanarsi del vivere-e-morire dall’esterno, o
immaginare il non-nato e il non-morente come stati separati: in tale ammissione, complice dell’assenza di un punto di vista oggettivo, consiste per
l’appunto l’integrità. Il risveglio avviene nell’istante, nel cuore del viveree-morire; la vita non ostacola la morte – ci insegna lo Zen – e la morte non
ostacola la vita.
Allo stesso modo dobbiamo resistere all’artificio di creare cosmologie e
fabbricare redenzioni: se vi è salvezza, essa è esistenziale, un risvegliarsi
cioè all’emancipazione di una volontà in sintonia con il divenire. La saggezza ci sprona a non indugiare nel samsara e la compassione ci invita a
non indugiare nel nirvana; l’etica che emerge nel cuore del samsara e nel
miasma di una vita insoddisfacente e provvisoria è un altro nome per il
Dharma, per la legge di originazione dipendente il cui operato non può essere
compreso mediante le teorie di immanenza e trascendenza.
È possibile creare una cosmologia del risveglio che riconsideri il rapporto fra il tempo e lo spazio? Paragonato allo spazio, il tempo viene di solito
considerato interiore, a causa della sua struttura bidimensionale e dinamica.
Nel pensiero occidentale, Kant comprese il tempo come intuizione interiore;
Husserl vide nel tempo l’intenzionalità della consapevolezza, e Heidegger
fondò la sua concezione dell’essere-nel-mondo nella concretezza del tempo;
in tutti questi esempi il tempo ha supremazia sullo spazio, un fatto dovuto,
secondo Abe, alla predominanza del sé come punto di riferimento e di riflessione. Riorganizzare il rapporto spazio-tempo dando maggiore attenzione allo
spazio comporta invece un decentramento del sé e l’apertura alla presenza
dell’altro. Predominanza dello spazio sul tempo comporta una rivalutazione
dell’esperienza intesa come esteriorità invece che Erfarhung, che è effettiva-
!
%&!
Chi ama lo straniero
mente, secondo l’accezione di Buber, surfing, attraversamento delle superfici
multiple e accumulazione di dati senza alcun impatto trasformativo: dallo
spazio, dal vasto campo esperienziale emerge l’individuo, si fa esperienza
delle cose e del sé in esse e l’esperienza diviene inclusiva. La metafisica
occidentale ha tralasciato la dimensione esperienziale in cerca di un principio
universale trascendente. Una discesa consapevole e riconoscente nel reame
dell’esperienza ci apre, invece che alla trascendenza, a una trans-discesa
che, sia pure lontana dall’esperienza pura vagheggiata da alcuni fenomenologi,
ci conduce tuttavia a una maggiore partecipazione. Da tale discesa volontaria
nella sfera esperienziale sorge l’etica, non più dipendente dalla matrice classica soggettività-oggettività: le cose emergono e il sé viene dimenticato (ma
non trascurato), e ciò che rimane è l’attività incessante del divenire nella sua
innocenza. L’etica che sorge da tale evento è intuitiva, e la risposta all’alterità è
originata dall’impatto che l’alterità ha sul soggetto: una risposta multiforme, imprevedibile e sconvolgente nella sua bellezza.
Saigy! era un monaco buddhista e poeta del XII secolo che, all’età di
ventitre anni, aveva rinunciato alla sua posizione di samurai di corte e aveva
vagabondato per il Giappone. Un giorno si trovò a passare da un tempio
semi-abbandonato; in fondo alla sala principale del tempio vide un altare
e, pur non sapendo cosa rappresentasse, si sorprese a piangere lacrime calde
e silenziose.
Etica eteronoma ed etica autonoma. Per l’etica eteronoma, la moralità deriva
dall’autorità esterna: obbediamo agli ordini di Dio e del sovrano. Troviamo
l’apoteosi di tale posizione in Duns Scotus; nella sua visione, Dio non ci
ordina di fare determinate cose perché esse sono buone, ma esse sono considerate buone semplicemente perché ordinate da Dio. Per l’etica eteronoma,
la natura umana è essenzialmente malvagia, una prospettiva condivisa da
Hobbes e da chiunque abbandoni la difficile disciplina dell’individualità per
l’obbedienza a una legge impersonale: fare del bene in ossequio alla grandezza del sovrano, della legge, o della divinità. L’etica autonoma è invece
più complessa e variegata: prendo qui in prestito la classificazione di Nishida,
che suddivide a sua volta l’etica autonoma in etica razionale, edonica, e attiva.
L’etica razionale, fondata sulla teoria intellettuale dell’etica, vede il bene
e il male secondo il criterio del vero e del falso. Per il teologo razionalista
!
%'!
!
Manu Bazzano
inglese Samuel Clarke (1675-1729), le relazioni fra le cose nella sfera umana
sono chiare quanto lo sono i principi matematici: ubbidire a Dio è ubbidire a
un sommo principio razionale. Volontà, sentimenti e istinti non vengono
presi in considerazione, in un’attitudine che ricorda il razionalismo radicale
degli stoici e dei cinici, dove vi è poco spazio per l’empatia umana.
L’etica edonica, auspicata da Aristippo ed Epicuro, instaura l’etica del
dominio dell’igiene volto al mantenimento della serenità egoica, una prospettiva che precede l’edonismo universalizzante di pensatori utilitaristi quali
Jeremy Bentham. Persino un pensatore kantiano convenzionale si opporrebbe
all’edonismo e all’utilitarismo perché tali attitudini non abbracciano la nonrazionalità dell’altruismo: amiamo l’altro nonostante, e a scapito del calcolo
egoico; persino l’ombra di un vantaggio o di un piacere reconditi impedirebbe
la gioia immotivata del dono. L’ipotetico pensatore kantiano fonderebbe i
suoi giudizi di valore nel cuore della necessità interna, di un’esperienza cosiddetta interiore, e non nell’attualizzazione di valori e principi ideali.
L’etica attiva ha le sue fondamenta in Aristotele: scopo della vita sarebbe
eudemonia, la felicità, riduttivamente interpretata, come già discusso, come
trionfo della ragione e non come ascolto della dimensione daimonica; ma
perfino la versione aristotelica è in disaccordo con la sottomissione acritica al
dovere e alla legge, con il moralismo dozzinale normalmente spacciato per
etica. L’entelechìa aristotelica comprende sia la manifesta completezza di
un’entità che il potenziale raggiungimento di tale completezza; poiché ciò
che è manifesto è in armonia con il suo potenziale, esso acquista bellezza, ma
tale bellezza è figlia illegittima della dea ragione. Non avendo sofferto le
tempeste delle energie daimoniche, la bellezza aristotelica (e platonica) deve infine appellarsi, allo scopo di preservare la sua armonia dorica, alla
legge e al dovere (esterni o interiorizzati nella presupposta auto-sufficienza
di una consapevolezza originaria e trascendentale), un movimento non del
tutto dissimile da quello di Kant e anche di Husserl, un movimento che finisce
col riaffermare la realtà trascendente dell’io. Un’affermazione, beninteso,
solenne – l’affermazione di un io sublime, in grado di operare il bene, di
percepire l’essenza delle cose attraverso il potere dell’intuizione, di un io
eroicamente districatosi da impulsi e desideri fuorvianti, di un io spiritualmente
avido che non ha resistito, direbbe Montaigne, agli eccessi della saggezza – di
un io non propriamente umano, che trionfa sulle ceneri della ricca pluralità
!
%(!
Chi ama lo straniero
psichica e senza la fertilizzazione della sfera daimonica. Nell’assistere sbigottiti all’emergere di tale io trascendentale, morale e spirituale, applaudiamo
imbarazzati il trionfo della legge interiorizzata, del Dio esclusivista che instaura il suo dominio di violenza nella psiche nel nome dell’integrazione e
della presunta solidità dell’io. L’idea stessa del sé viene modificata: da
quella di un sé in balia dei propri desideri a quella di un sé moralmente solido.
Eppure ciò che va perduto è per l’appunto la preziosa coscienza della sua
natura fluida, organismica e provvisoria – l’unico barlume nello scafandro
dell’io, di fatto l’unica speranza di salvezza. Tuttavia la cristallizzazione del sé
nell’individualità è una tappa necessaria, dal piacere egoista all’individualismo
che abbraccia l’ineffabile, un evento poeticamente descritto da diverse tradizioni. Nello Zen, esso viene descritto come la grande morte, o kensho –
vedere nella propria natura.
Gran parte dell’epistemologia moderna ha ridato sovranità al soggetto,
attribuendo a esso caratteristiche un tempo appartenenti a Dio soltanto.
L’idealismo trascendentale – da Kant e i neo-kantiani a Husserl, a gran parte
del pensiero positivista – vede il soggetto come creatore, e il sapere e la comprensione come atti di creazione; la vita e la natura vengono percepite come
caos a cui l’intervento dell’uomo e della cultura deve dare ordine. Il passo
successivo vede la creazione di un io trascendentale separato dalla sua stessa
esistenza, dal mondo e dagli altri esseri. Nella filosofia trascendentale, così
come nel positivismo, ogni relazione del soggetto è relazione con oggetti
al plurale.
Sia l’obbedienza alla legge divina o della polis che la sovranità dell’io
trascendentale oscurano la natura dell’etica. L’etica deve attraversare altri
percorsi che riconoscano la natura fluida e impermanente del soggetto: percorsi
da iniziazione, in un certo senso, poiché essi richiedono una morte e una rinascita necessarie. Richiedono la percezione della vacuità – o relatività – e
una risposta adeguata all’esigenza etica imposta dalla presenza dell’altro. In
entrambi i casi ci troviamo al di fuori della sfera della legge e del dovere.
Opus contra naturam? Se l’etica appartenesse unicamente alla sfera umana,
come credono la biologia contemporanea e i neo-darwinisti, essa sarebbe allora
una sorta di ribellione, l’opus contra naturam di una specie e, all’interno della
specie, di individui singolari, o di individui che in particolari circostanze ri-
!
%)!
!
Manu Bazzano
spondono eticamente, o eroicamente. L’individuo diverrebbe creatore di
un’etica sradicata dalla natura, un soggetto eroico che si oppone da solo alla
tirannia del gene egoista. Che gli esseri umani debbano imporre alla propria
natura una legge etica vuol dire che l’umanità è selvaggia e incivile, e in tale
visione l’etica darebbe una mano di vernice all’animalità dell’homo homini
lupus, una formula ingiusta verso il genere umano e verso i lupi. Credere
che gli esseri umani siano radicalmente diversi e separati dal regno animale,
in grado di ricevere precetti religiosi (e derivare da essi i principi morali a
priori) è una forma di negazione antropica, cioè il rifiuto di accettare le caratteristiche che noi umani condividiamo con gli animali; il supporre che la
natura e le specie animali siano dotate di qualità morali ci pone difronte al
problema opposto: l’antropocentrismo.
L’esigenza etica. Si fa esperienza della fiducia reciproca quotidianamente,
sia che ci si trovi a incontrare amici, conoscenti o estranei. La fiducia che
riponiamo nell’altro non occulta ma aumenta la minaccia – il male, secondo
Sartre – che l’altro rappresenta. Sospesi nell’incertezza della risposta altrui,
in condizioni relativamente normali optiamo per la fiducia; tale fiducia va
al di là delle buone maniere, ci apre e ci rende vulnerabili all’altro, in un atto di resa il cui rischio spesso consiste nella ferita e nel disappunto, allorché
il dono della resa non viene corrisposto dalla disponibilità dell’altro.
Fiducia vuol dire fede nel continuo rinnovarsi della vita: regaliamo all’altro
la libertà e opportunità di cambiare, di essere altro; e così facendo riconosciamo implicitamente la natura fluida e impermanente del sé. La fiducia è
il rifiuto di ridurre la natura umana a una gamma di forze reattive e statiche, il
regalo, a noi stessi e all’altro, della libertà di rispondere attivamente e consapevolmente con nuove forme di espressione; non un atto eroico ma il
fondamento stesso della conversazione. Si scopre l’impatto che si ha sull’altro,
la natura interdipendente e fluida delle relazioni, e tale scoperta contraddice
la visione dominante di un sé incapsulato e immune da influenze esterne. Si
scopre di essere parte integrante del mondo e del destino dell’altro. Tale
scoperta è rara, sia perché la consapevolezza stessa dei fenomeni quotidiani
è rara nel sonnambulismo che accompagna la nostra esistenza alienata, sia
perché si preferisce anestetizzare la consapevolezza che le proprie parole e
azioni possano determinare la gioia e il dolore dell’altro, e in qualche modo
!
&+!
Chi ama lo straniero
influenzarne le scelte di vita. Mi rendo conto a un tempo della mia potenza
e della mia responsabilità; la seconda risponde a ciò che il teologo esistenziale Løgstrup chiama “esigenza etica”, la richiesta silenziosa, implicita e
tuttavia imperiosa che emana dalla presenza dell’altro prima ancora delle
ingiunzioni morali e religiose, prima ancora di una rivelazione o di una
conversione. Prima che la mia mente trovi il tempo di fabbricare un noumeno,
il fenomeno stesso esige la mia risposta attenta, mi convoca alla radicalità
di una risposta adeguata. Mediante tale risposta il soggetto diviene per la
prima volta umano.
A causa della sua duplice natura di rischio (apertura all’altro) e risposta
(alla muta esigenza etica), la comunicazione non può avvenire fra due o più
individui intatti, ma attraverso una comune ferita. La ferita è originaria,
primaria: rappresenta l’imperfezione, finitezza e fragilità di essere umani;
permettere che l’altro ci veda in tale fragilità ed essenziale nudità è precisamente il requisito della comunicazione. Intesa in tal senso, la comunicazione,
premessa e cornice dell’etica, è al di là della norma e della legge: le convenzioni sociali tuttalpiù facilitano le relazioni fra le persone, ci proteggono
dall’esposizione psichica (a volte fino a isolarci), ma esse non sono etiche.
Le buone maniere dettate dalla bontà e dalla gentilezza mantengono sì in
vita relazioni più o meno stabili, ma non rispondono alla muta esigenza etica,
bensì alle aspettative e complesse strategie dell’ego. Compiacersi vicendevolmente nella placida atmosfera di conoscenze anemiche e innocue o volere
cambiare l’altro usando la scure del giudizio moralista: entrambi tali modi
relazionali sono perversioni della comunicazione, utili al mantenimento
dello status quo e al rafforzamento di fossili entità istituzionali, morali e religiose, ma non aperture alla comunicazione autentica.
Rifiutare le norme prestabilite ci apre tuttavia a difficoltà pressocché insormontabili; senza il ricorso alla mediazione dell’ideologia, due esseri si
trovano ad annaspare nei flutti dell’immediatezza e della passione. L’amore
non-mediato facilmente diventa odio, consumazione vicendevole e fomenta
l’irruzione del caos e dell’assurdo. Trovandosi a barcollare in un universo
incerto il cui meccanismo si rivela difettoso, i più periscono, e ogni debâcle presenta le sue particolarità: dall’estraniazione all’appartenenza, dall’isolamento al
conformismo; chi sa resistere al fuoco dell’assenza di mediazione senza perire si apre a un amore senza sentimentalismo. L’esigenza etica non richiede
!
&*!
!
Manu Bazzano
lacrimosi esibizionismi del cuore, ma una risposta netta senza mediazioni e
la disponibilità a mostrarsi all’altro nella propria nudità di essere mortale;
l’assenza di mediazione conduce i più dall’unione estatica al desiderio di
possesso, alla gelosia e all’esclusione degli amanti dal resto del mondo. Qui la
mediazione è inevitabile, la trasformazione dell’evento in necessità, mediante
la creazione di un terzo: la prole, o un progetto creativo e di vita comune.
Cosa succede se l’assenza di mediazione straripa? Il fuoco dell’amore
diventa rabbia, eppure nella rabbia c’è ancora speranza, poiché essa è intensità
e desiderio di correggere un danno subito, reale o immaginario. Quando invece
l’immediatezza dell’amore si trasforma nell’intimità perversa dell’odio, si
ammette la propria inferiorità nei confronti dell’altro: si tende a odiare la
persona verso cui ci si sente inferiori, si odia colui che ci sconfiggerebbe se
dovessimo sfidarlo apertamente. L’odio (al contrario della rabbia, che brucia di un fuoco puro e immediato) è simulazione: ci si rifiuta di ammettere
la propria incapacità, si proietta tale impotenza sull’altro, e in tal modo si
riesce a mantenere una sorta di intimità con il nostro opponente, a invertire
l’unione dell’estasi nella connessione perversa dell’odio.
La mediazione, garantita da interessi comuni, tempera l’intensità della
visione erotico-religiosa e introduce un reame intermedio. Ciò non deve necessariamente tradursi nell’abdicazione alla norma e alla tradizione, di fatto
nella fase statica che segue l’evento una distanza igienica dalla norma è
concomitante all’osservanza di essa. Senza la distanza dalla norma si ha
l’aderenza dogmatica, che è tipica del moralismo e dell’integralismo di ogni
fede, sia religiosa che laica. L’etica agisce al di là e prima della norma: nasce
dalla necessità di una risposta adeguata alla muta esigenza dell’altro il cui
volto mi sta di fronte, una necessità che non mi dà il tempo di consultare il
codice prima di agire. Si consulta il codice e ci si appella alla moralità allo
scopo di dimostrare la propria superiorità di cartapesta, e gongolare dalla
vetta della propria rispettabilità.
Un appello all’etica è sovversivo in un’epoca in cui l’imperativo del superio si è trasformato nel mantra enjoy!, echeggiato dalle multinazionali e dalle
corporation che, nel venderci uno dei loro numerosi e inutili prodotti, ci
ordinano sorridendo di divertirci nel consumo. Divertitevi!: l’ingiunzione ci
fa correre ansimando nella calca dei sudditi compratori a racimolare in fretta monete e briciole che cadono dalla cornucopia di plastica. Tuttavia
!
&"!
Chi ama lo straniero
l’appello sovversivo dell’etica può trasformarsi in nuove forme di dovere e
di colpa, o fornire a una persona frustrata il ripiego compensatorio di una
missione utopica nella quale perfino l’etica diviene dogma e ideologia: fare
il bene per gli altri diviene imposizione, e la gentilezza caritatevole diviene
arroganza spirituale, illudersi di sapere di cosa gli altri abbiano bisogno.
Ogni relazione è relazione di potere, e l’etica deve tener conto di ciò
realisticamente, e non fuggire nell’idealizzazione e nell’utopia coercitiva
dei samaritani o dei cosiddetti psicoterapeuti buddhisti o cristiani. Il tentativo di rispondere adeguatamente all’esigenza etica ci pone al di fuori della
sfera della reciproca menzogna delle buone maniere e dall’arroganza di
cambiare l’altro mediante una cornice ideologica o un sistema di fede. Dico
“tentativo” perché è arduo esprimere una risposta adeguata: l’esigenza
dell’altro è implicita, inespressa, e la sua eventuale espressione non ha luogo
mediante le norme sociali. Non vi è direzione, indicazione, non vi sono mappe,
le norme morali approssimano e regolarizzano la risposta all’esigenza radicale,
ma da sole non bastano.
Biglietto di sola andata. Il fuoco di eros non garantisce ethos o l’amore. La
passione erotica ci rende in parte immuni a un coinvolgimento più completo,
nonostante l’apparenza totalizzante del fuoco che ci consuma. Nella definizione
di Løgstrup, la passione erotica è l’incontro tra lo sconosciuto e il disimpegnato; al lato opposto si trova ovviamente la spiritualizzazione dell’amore, con il
suo diniego del contenuto erotico.
La consapevolezza è moto verso l’esteriorità, un biglietto di sola andata.
Una consapevolezza che incessantemente parta dal soggetto e ritorni puntuale
ad esso non merita il nome di consapevolezza, così come una consapevolezza
priva di desiderio, e quindi al riparo dal pericolo di una crisi che puntuale
segue il desiderio, non può chiamarsi tale.
L’ideogramma cinese equivalente alla parola crisi è composto di due elementi, pericolo e opportunità: il movimento urgente verso l’esteriorità ci apre
all’opportunità dell’innocenza e al rischio dell’ingenuità, all’opportunità di
usare la spada del discernimento e al rischio di tagliare la presunta solidità
del soggetto. Il movimento verso l’esteriorità non ritorna al soggetto ma si
disperde nella molteplicità, un atto di diserzione, rinuncia e abbandono: diserzione dal proprio posto al sole, rinuncia alla felicità egoica e abbandono
!
&#!
!
Manu Bazzano
della trascendenza. Diserzione dall’impero del medesimo, dal colonialismo
dell’identità; rinuncia alla disperata autonomia della monade, abbandono
della propria tribù d’origine raccolta accanto alla propria divinità. È un atto
di bontà, di bontà folle, che rifiuta l’idolatria tout court ma anche le idolatrie ontiche i cui venerati mantra adornano i variegati strati dell’illusione
primaria dell’identità: religione, nazionalità, suolo, costume. Si può obiettare
che è stato per l’appunto il capitalismo globale a erodere gli aspetti regionali
sostituendo a essi l’ubiquità del dio denaro, creando una liquidità che è liquidità del mercato, una libertà che è libertà del profitto, un’universalità
che è universalità dell’alienazione. Ma la bontà folle dell’etica è dispendio
immotivato che nella generosità manifesta pienamente la volontà di potenza,
o se si preferisce usare la terminologia conciliante della psicologia umanistica,
la tendenza all’attualizzazione: non possiede mete definite, ma nel percorrere
un sentiero crea il sentiero: una teleologia immaginaria.
Esporsi volontariamente all’esteriorità è eccezione ed eccesso: incitare
una crisi, invitare l’azzardo e l’opportunità, svelare la vergogna e l’imbarazzo,
scoprendo che soltanto venendo incontro all’esteriorità, nel moto del desiderio
e dell’abbandono, nasce la consapevolezza. Tale moto è così urgente da detronizzare la morte, se per morte s’intende il nulla, il non-essere, cioè la visione
della morte tipica di chi uccide l’altro o lo riduce a mero oggetto di una
transazione; la visione di Caino, dunque, e la visione alienata del borghese.
Il moto verso l’esteriorità traccia lo spazio vertiginoso che mi separa da essa,
lo spazio del non-sapere; non il non-sapere socratico, trucco scaltro da prestigiatore nel circo della dialettica, ma il non-sapere inteso come ospitalità e
amicizia. Se il non-sapere dialettico appartiene al dialogo, il non-sapere come
intimità appartiene alla poesia, alla meditazione, ai sussurri degli amanti, al
balbettio dei morenti.
Il non-sapere come intimità precede il dialogo, allo stesso modo in cui
l’etica precede la dialettica. Se si accetta tale ipotesi, il linguaggio non è più
divinità neutra ma ospitalità, accoglienza: nell’accoglienza rinnovo la mia
non-appartenenza al suolo, confermo la mia natura fugace, la mia nonsostanzialità; nell’accogliere affermo la mia capacità di ricevere, cioè la
mia capacità di apprendimento. Non si tratta di un’attitudine irrazionale,
perché è per l’appunto la ragione a concepire l’accoglienza, e nel far ciò
contraddice la maieutica e introduce lo studium, cioè l’amicizia, la devo-
!
&$!
Chi ama lo straniero
zione per il bene dell’altro. Studiare il sé è amare il sé, il sé che emerge per
la prima volta nell’incontro con l’altro, un sé in cui la conoscenza non è innata, o in perpetua attesa di una levatrice socratica o dell’innesto immaginario della memoria platonica. L’apprendimento nasce dall’incontro con
l’esistente, e rende del tutto superfluo l’essere heideggeriano; nasce nel
cuore della dimora – un luogo transitorio, un giardino circoscritto, segreto
perfino, ma pur sempre finestra che incornicia la visione dell’orizzonte.
Dalla nostra dimora di polvere e argilla facciamo esperienza del cielo.
Nell’incorporazione è il mistero laico della molteplicità, e trovandoci a
nuotare in essa nessuna alterità è alterità in assoluto, e in ciò è doveroso
contraddire Lévinas, che vide nel femminile l’alterità propriamente detta.
Certo, per me che scrivo queste parole la donna è alterità, la mia fuga legittima dalla luce neutra della solitudine dell’essere avviene nella dimora e
mediante l’incontro con una donna, è Eros a condurmi fuori dalle maglie
del platonismo, Eros che si manifesta come desiderio. E tuttavia Eros non
ci conduce, come vorrebbe Lévinas, al di fuori dei fenomeni, in un indefinito
altrove che ben presto viene definito dall’anelito sistematizzante della religione. Ci conduce certo al cospetto dell’altro e al di fuori del trascendentalismo
husserliano: rivendica Eros, lo denuda degli indumenti platonici e cristiani
e lo restituisce alla polvere della strada, all’esistenza precaria e sovrana del
fanciullo mendicante. Il padrone di casa, nel ricevere l’ospite, viene così
egli stesso ricevuto dalla propria dimora: è felicemente espropriato, un soggetto svuotato di ipseità, un inquilino. L’ospitalità precede la proprietà.
Siamo in un territorio diverso da quello della sfera giuridica e politica
dove si stipulano accordi di pace nel breve intervallo fra un bombardamento
e un genocidio. L’ospitalità, l’abitare poetico, è possibilità di pace in quanto
sospensione del sé, epoché, attitudine radicale che per prima disintegra la
neutralità di Heidegger; essa non è apertura (Offenheit) a meno che intesa
come vulnerabilità e non come nei due significati più comuni di apertura di
un oggetto a ogni altro oggetto (la terza analogia dell’esperienza nella Critica
della ragion pura), o come l’apertura dell’essere gettato nel mondo. Tale
prospettiva rivaluta la soggettività in quanto ospitalità, invece che reinterpretarla come interiorità.
!
&%!
!
Manu Bazzano
Il sacrificio. C’è spazio per il sacrificio nell’etica? Il sacrificio è anzitutto
rinuncia delle potenzialità inesauribili e realizzazione graduale che la scelta
che mi spetta a ogni svolta del sentiero finisce col modellarmi; in tal senso
il sacrificio conduce alla formazione, all’acquisizione di una forma scultorea definita fra le variegate possibilità che il divenire dispiega all’orizzonte
della coscienza.
Ma c’è anche il sacrificio di chi si dedica a una causa (nel caso dell’etica,
alla giustizia). Il sacrificio di sé nel nome di una causa ha per noi un che di
sacro, è il messaggio che ci giunge dalle trincee fin nel tepore delle retroguardie, nel bel mezzo della quotidianità protetta della nostra esistenza.
Opposto alla protesta soggettiva, romantica, e a conti fatti egoista, il sacrificio è
un atto di generosità che tuttavia rischia di restaurare l’universalismo hegeliano
della realtà. Ciò accade perché non si è ancora compreso l’individualismo al di
là del solipsismo, e si è rimasti intrappolati fra due polarità ugualmente tiranniche e illusorie: l’universalità neutra e la rivolta individualista. La via
d’uscita da tale impasse consiste nel comprendere la nozione del debito
prima del prestito, la strana libertà che nasce dall’assunzione estrema di responsabilità, una responsabilità atea, cioè multidimensionale. Pur accettando
l’assioma dell’interdipendenza, tale posizione – che potremmo definire fenomenologia dell’ospitalità – volutamente indugia su un aspetto trascurato
dall’odierna ortodossia dialogica e inter-soggettivista: la separazione. Sia
Lévinas che Derrida si sono soffermati su tale punto: la parola stessa etica è
un’approssimazione ellenista dell’ebraico kadosh, la sacralità di ciò che è
separato; ciò comporta l’affermazione della separazione fra i soggetti e
l’affermazione della sublime tristezza dell’inevitabile addio. Saper pronunciare un sì profondo e sincero nel mezzo delle rapide dell’impermanenza:
in ciò consiste la mia aderenza al sacro; un atto temerario, credo, al quale
accedo con trepidazione poiché esso richiede la sospensione del sé e un ritrarsi che crea una fenditura nel tempo stesso, una dislocazione che perturba
l’ordine lineare del tempo, come lo fa una visita inaspettata o perfino indesiderata, o l’incontro con lo straniero e l’estraneo.
Come una traccia di Dio stesso (Esodo, 33), la rivelazione è in tal senso
visitazione, visita improvvisa, incidente che mi apre all’opportunità e al rischio, alla crisi che incrina le rappresentazioni abituali. Non vi è iniziazione
propriamente detta per chi non sia in grado di accogliere gli altri nella di-
!
&&!
Chi ama lo straniero
mora della propria (presunta) soggettività; non vi è rinascita per chi evade
l’incontro con l’estraneità; non vi è ordinazione, poiché ordinazione non è obbedienza cultuale, ma perseguire la disciplina dell’affermazione dell’esistenza;
non vi è res publica senza libagioni offerte alla dea del-l’ospitalità, senza che
l’intolleranza ceda il posto non alla civile tolleranza utilitarista, ma all’amore
immotivato. L’ospitalità ci rende umani non nel senso che ci sintonizza
all’ipotetica natura umana, la cui fondamentale bontà si immagina perduri nel
profondo, al di sotto dei condizionamenti negativi della civiltà, ma perché
diventare umani è opus contra naturam, atto di sfida irriverente al polemos
platonico, allo stato di guerra (Zustand des Krieges) e alla minaccia
(Bedzohung) kantiani, al cinismo hobbesiano, alla dialettica hegeliana.
Che la pace sia o meno lo stato naturale è una questione ontologica, cioè
oziosa, una domanda cui l’etica radicale si rifiuta di rispondere, o a cui risponde con l’ospitalità incondizionata ed extra-giuridica, dove la pace precede
l’idea stessa di natura. La cosiddetta ospitalità offerta dalle nazioni-stato è
invece condizionale, ipocrita e utilitarista, poiché riflette le fluttuazioni di
mercato e gli equilibri diplomatici internazionali. La pace dell’etica è antigiuridica e anarchica – essa nasce dalla sospensione dell’ipseità di fronte alla
presenza reale separata, e perciò sacra, dell’altro. Allo stesso tempo si ricostruisce con quest’attitudine la propria dimora, non più luogo recintato
ma soggiorno, la distanza e la separazione dall’altro che nutrono il desiderio.
Non più suolo su cui mettere radici illusorie, piantare bandierine e intonare
l’inno di una comunità immaginaria, non più occupazione di diritto di chi
sacralizza arbitrariamente l’universalità dello Stato e del Dio che vi soprassiede, ma riparo momentaneo dal vento, ristoro nell’incessante vagabondare nella
dimensione contingente, luogo in cui accogliere l’estraneità e da essa imparare.
Mi rendo conto che tale posizione anarchica rischia di sfociare nell’egoismo
della soggettività, nella protesta romantica dell’individuo che si oppone allo
Stato e finisce col venerare unicamente se stesso. Allo scopo di evitare tale
scivolamento, Lévinas propone l’immagine di una fecondità paterna, di una
ospitalità originaria e primordiale che sfugga sia all’individualismo che alla
tirannia universalizzante dello Stato. Il moto lévinasiano ricorda obliquamente Lacan per il quale la legge del desiderio può dispiegarsi unicamente
sotto l’egida di un super-io strutturante; è l’etica strutturale a ricordarci che
!
&'!
!
Manu Bazzano
prim’ancora di pensare all’auto-preservazione dobbiamo prenderci cura della
vedova, dell’orfano, e dell’estraneo.
Io è un altro e così via. L’idea dell’identità egoica non è mai stata del tutto
convincente, e dall’impossibilità di dimostrare l’ipseità Marx deriva la nozione
fertile di alienazione, socialmente intesa. Più tardi, con la tragica disillusione
che vide la rivoluzione trasformarsi in oppressione, il pensiero europeo ripropone l’alienazione in termini ontologici, come il fallimento stesso del ritorno a
se stessi. Heidegger intervenne prontamente a salvare il salvabile, collegando
la soggettività trascendentale di Husserl all’edificio della metafisica, riproponendo la soggettività come ricettacolo della luce neutra dell’essere; ma
l’essere, ci ricorda Lévinas, ha bisogno dell’umanità come la natura ha bisogno del suolo. La neutralità dell’essere invece reprime e annulla il soggetto, la singolarità irripetibile della persona, e la inscrive nel radicamento
dell’essere e dell’ideologia. Il paradosso consiste in questo caso nel bisogno
che un individuo eletto divenga messaggero e poeta dell’essere – di fatto un
ritorno, dopo una lunga deviazione di rotta, alla metafisica del soggetto, e
quindi un tradimento dell’iniziale intuizione dell’essere-nel-mondo con il
quale Heidegger aveva creduto di proporre un’alternativa credibile al sé cartesiano e all’apparato psichico freudiano.
Una visione della soggettività libera sia dall’universalismo che dal solipsismo la rende inevitabilmente complice della vulnerabilità, della nudità
delle pelle esposta alle carezze. Ed è forse utile chiedersi, con Lévinas, se
siano possibili molteplici interpretazioni del “Je est un autre” di Rimbaud;
mi chiedo se, accanto alla lettura classica dell’io come alienazione primaria, primordiale inconoscibilità del sé da parte del sé, siano possibili altre
letture. Accusarsi: accusare se stessi di fronte al dolore di un altro confermerebbe la tesi secondo cui tutto ciò che è umano è per sua natura esteriore,
dispiegato nell’aperto, esposto agli elementi e alle vicissitudini della natura
e della cultura. E ci si potrebbe altresì chiedere, pensando alle influenze
culturali che mai cessano di plasmarci, se l’identità stessa non sia per sua
natura multipla, impermanente, problematica, e continuamente soggetta a
modifiche. La soggettività è incapace di richiudersi in se stessa, i sensi sono
aperti e in connessione continua con l’esteriorità che è, in tale complessa
relazione, molto più di un insieme di stimoli o una causa che produce effetti.
!
&(!
Chi ama lo straniero
L’altro per il quale io mi trovo a soffrire mi convoca a esistere, mi resuscita
dal sepolcro della mia dimora borghese, mi incita a riconoscere per la prima
volta la mia paradossale soggettività, mi scopre, mi denuda, mi rende indifeso e
al suo cospetto mi arrendo. Tale relazione precede lo stimolo della presenza fisica: ho desiderato la sua apparizione: visitazione, evento, annunciazione
che conferma la mia soggettività in quanto essere-per-l’altro.
Viaggio in terra straniera. Nel naufragio dell’essere vengo chiamato in causa,
mi si chiama, vengo convocato; nell’affrettarmi verso il luogo dell’incontro
raccolgo la mia mente, mi sorprendo a pensare; penso, prima della logica,
prima della concettualizzazione, prim’ancora che mi si offra, non richiesta,
la purezza di un io trascendentale.
Nell’enigma della mia soggettività, io vengo pensato, il pensiero mi accade così che io, simulacro dell’oltreuomo, della persona vera senza prestigio,
possa presentarmi al cospetto dell’altro e offrire il mio potlatch, il dispendio
inutile, e perciò sacro, della mia vita. Non v’è fanfara che celebri l’emergere di
tale individualità, nessuna marcetta trionfale, funebre o nuziale, né sonetto
bucolico all’amicizia o all’amore: invece il corpo esposto alle intemperie, alle
carezze, alla possibilità dell’encomio e della vergogna, poiché anche questa
nascita è dolore.
La filosofia, come la morte, è per Platone un viaggio in terra straniera
(Fedro, 61); a meno che si tratti di turismo, viaggiare vuol dire fare esperienza.
Cos’è l’esperienza? Per Lévinas, un’esperienza merita tale appellativo se ci
trasporta al di fuori della cosiddetta interiorità, all’esterno di ciò che consideriamo la nostra natura. La verità – una particolare visione della verità verso cui
il presente lavoro si dichiara parziale – comporta esperienza, l’apertura della
presunta interiorità; la filosofia in tal modo concepita è eteronomia, cioè
indagine di ciò che è propriamente estraneo ad essa. Una visione della filosofia più convenzionale vede invece in essa l’indagine libera di un soggetto
che, dopo escursioni in terre ignote, ritorna a se stesso, uguale a se stesso;
presume l’autonomia del soggetto e la solidità dell’essere, e nel far ciò essa
riduce l’altro al medesimo; le filosofie dell’occidente sono nella loro essenza
filosofie del medesimo. Un pensiero siffatto ha incoraggiato – direttamente
o indirettamente – e ha fornito ornamento concettuale agli imperi e al colonialismo, all’esportazione di un’identità e di un modo di vita, il “nostro”,
!
&)!
!
Manu Bazzano
opposto al “loro”. Rappresenta il contrario della religiosità, intesa come rivelazione di una divinità la cui presenza è radicalmente altra, una trascendenza
compresa come rivelazione di ciò che ci è estraneo.
La filosofia dominante è dunque una forma di autarchia o una egologia,
per usare il termine di Husserl, e una psicologia che ne riproduca motivi e
tematiche non genera psico-terapia ma ego-terapia. L’errore in tal caso
consiste nel confondere l’alterità della psiche – la sua vastità e inconoscibilità –
con l’intimità atomizzata dell’ego e della personalità, o con un apparato psichico
autonomo e meccanizzato. Perfino la relazione con l’oggetto della tradizione
kleiniana e l’inter-soggettività evitano l’alterità assoluta dell’esperienza poiché
l’esistenza di un oggetto e di un soggetto presuppone l’esistenza a priori di
una rete di relazioni, di una inter-dipendenza che dimentica, nel suo afflato
dialogico e intersoggettivo, l’inalienabilità della separazione. Nella cognizione,
l’individuo viene afferrato, ap-preso, un campione da studiare in laboratorio
nell’ambito di una generalità, quindi di una scienza, di un addomesticamento
e di un possesso. La traduzione simbolica di tale moto filosofico è il denaro,
che ci permette di possedere momentaneamente l’esteriorità distruggendone
l’autonomia, e con essa la possibilità di imparare e fare esperienza. Nel
mondo che abbiamo edificato, la libertà si manifesta come ricchezza, e al
dio denaro viene soggiogata la dea ragione che elabora a nostro vantaggio
strategie di potere e di appropriazione.
Della coscienza come cattiva coscienza. La rivelazione-apparizione dell’altro
all’orizzonte della mia consapevolezza reca con sé un messaggio fondamentale: non farmi del male. L’intimazione deriva dall’incontro asimmetrico con
l’altro invece che da un’ingiunzione divina. La nudità dell’altro, la vulnerabilità del suo essere, la pelle esposta agli elementi, la sua stessa mortalità di
esistente, i suoi occhi che mi guardano: tutto ciò pone fine, se sono in grado
di ascoltare, al melodramma dell’isolamento egoico del soggetto, e con la
fine dell’isolamento nasce la soggettività. La risposta all’alterità non è dunque dovere, comandamento divino o morale, né l’aspirazione, dettata dal
super-io, di essere giusto nei miei rapporti con gli altri. Se dimentico che
l’altro è anche potenzialmente il male o l’inferno, se dimentico che l’altro è
anche la cosa mostruosa e oppressiva, allora scivolo ingenuamente nella
idealizzazione dell’altro, un’attitudine influenzata da Lévinas. Ciò che ri-
!
'+!
Chi ama lo straniero
mane valido e genuinamente radicale nel pensiero lévinasiano è tuttavia
l’aspirazione anarchica di resistere all’ineluttabilità del dominio, opporre
resistenza etica all’imperialismo del medesimo. Che si possa fare tesoro di
tali intuizioni senza doverle confezionare in una nuova ideologia rappresenta
il compito di chiunque si cimenti nell’ardua disciplina dell’etica radicale.
A tale proposito è utile adoperare il solvente chimico nietzschiano – allo
stesso modo in cui Nietzsche adoperò il solvente eracliteo – allo scopo di
dissipare la stagnazione periodica dell’etica in sistema morale. Rimando il
lettore al secondo libro della Genealogia della morale, in particolari a quei
paragrafi, dal quindicesimo in poi, dove Nietzsche si pone la domanda
dell’origine della cattiva coscienza e ne trova il nesso in ciò che qui egli
chiama istinto di libertà (la futura volontà di potenza).
Questo istinto di libertà reso latente a viva forza [...], questo istinto della
libertà represso, rintuzzato, incarcerato nell’intimo, che non trova infine
altro oggetto su cui ancora scaricarsi e disfrenarsi se non se stesso: questo,
soltanto questo è, nel suo cominciamento, la cattiva coscienza.12
Nel caveat nietzschiano è presente il salutare egoismo dell’artista che sa
e deve fare da contrappeso a un senso di colpa universalizzante che paralizza
gli istinti più fieri e li addomestica in un bontà presunta e generica, che è
repressione della volontà di creare. Il super-io, nelle sue fattezze più rozze,
è sempre in agguato per il soggetto che si avventura nella pratica etica; al
centro della proibizione siedono la colpa e la cattiva coscienza, ombre dei
condizionamenti culturali specifici e mutevoli cui l’individuo fa del suo
meglio per obbedire. Tradizionalmente le ingiunzioni sono pervenute dal
sistema patriarcale, ma nelle società occidentali contemporanee esse provengono sempre più da una complessa rete di derivazione cristianeggiante e
pseudo-socialista, universalmente nota come political correctness, con la
quale l’ideologia borghese contemporanea ha cooptato in nuova etichetta di
buone maniere ciò che ebbe un tempo valenza dirompente nella lotta per la
giustizia sociale, razziale e nella parità di genere. Uno degli avamposti di tale
controriforma è tristemente costituito dalla psicoterapia che, avendo somma!
12
!
Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, p. 77.
'*!
!
Manu Bazzano
riamente svenduto la propria originaria valenza trasformativa, è divenuta nucleo di ri-educazione del nuovo conformismo sociale e dell’ideologia invisibile.
Al centro dell’impresa psicoterapeutica va invece posta la sublimazione,
intesa come rispetto del sublime anelito del soggetto incanalato nella ricostruzione delle narrazioni del vissuto e mediante l’arte. L’ipotesi che qui propongo
è che, a seguito della scomparsa della relazione antica fra il soggetto e il bene
sovrano, non è dato a tutti il compito difficile dell’attualizzazione, ma unicamente alle nature tragiche e in grado di accettare la gioia dionisiaca; la
maggior parte di noi, posti di fronte al fuoco dell’esigenza etica, ha bisogno
della protezione simbolica ed estetica offerta dalla psicoterapia e dall’arte.
Lévinas ignora il fatto che due millenni di ideologia giudaico-cristiana ci
hanno intriso di colpa e cattiva coscienza: posti di fronte alla lama tagliente
dell’alterità, i più verranno vivisezionati all’istante. Ma una risposta è tuttavia indispensabile se vogliamo continuare a considerarci esseri umani, una
risposta che onori l’esigenza etica e non si rifugi nell’astrazione dell’essere,
nell’utilitarismo del bene comune, e nelle dubbie consolazioni della morale
borghese. La sublimazione in tutte le sue forme offre tale risposta, così
come l’accettazione di ciò che Critchley chiama “inautenticità originaria”:
al centro dell'esperienza del soggetto, di fronte a una scelta etica, ci si
accorge di essere inadeguati, non in grado di comprendere fino in fondo.13
L’accettazione modesta dei propri limiti regala una vacanza inaspettata dagli obblighi imposti dal super-io: un’attitudine forse in sintonia con l’indagine
fenomenologica, specialmente in Merleau-Ponty, che, invece di servire da
prolegomeno all’obbligo filosofico di sfornare ontologie, getta luce sul modo
in cui comprendiamo noi stessi e la nostra esistenza in relazione alla dimensione fisica, sociale e storica.
Per Plessner, la posizione dell’essere umano è una posizione eccentrica,
il non-coincidere con se stesso, l’abitare una breccia fra la dimensione fisica
e quella psicologica. L’essere umano, la cui esistenza è inserita nell’animalità, si
è volutamente posto al di fuori di essa mediante una desistenza (Abgehobenheit).
In questa situazione peculiarmente umana di “immediatezza mediata”, l’essere
umano fa esperienza di sé come e in una cosa, ma una cosa che
!
13
!
Critchley, 2008.
'"!
Chi ama lo straniero
si differenzia da tutte le altre perché egli stesso è quella cosa. Da essa egli è
sostenuto, circondato, con e tramite di essa ha sviluppato una efficacia, e
tuttavia allo stesso tempo essa presenta una resistenza che non viene mai del
tutto superata.14
Riconoscere tale condizione ci affranca dall’obbligo di epistemologie
semplificate – siano esse di immanenza o trascendenza – e ci invita ad accettare l’ambivalenza tipica dell’essere umano, il suo altalenarsi fra presenza e
desistenza, prossimità e lontananza, presunta oggettività e altrettanto presunta soggettività.
Critchley sviluppa tale nozione in modo interessante, rischiando forse di
tentare un’ontologia a testa in giù – nell’esagerare ad esempio la funzione
dell’umorismo (in tono serioso) che naturalmente emerge dalla cornice eccentrica dell’immediatezza mediata. Tutto sommato però egli arriva a conclusioni
allettanti, suggerendo ad esempio in modo convincente come l’umorismo
possa divenire una funzione meno ostile del super-io.
L’amore non c’entra. Già s’intravedono fraintendimenti che confondono l’etica
con l’amore, con l’affettività e i sentimenti soggettivi, oppure con l’indigenza
e il bisogno di colmare il vuoto della propria esistenza. L’alterità esiste al di
là della mia sete, il moto del mio desiderio non è mai soddisfatto, l’altro è
inalienabilmente altro, separato, sfuggevole, incomprensibile: mediante il
desiderio mi trovo costretto ad affacciarmi sull’orlo del mio isolamento, e
nel rischio a cui non posso sottrarmi imparo, faccio esperienza. Il desiderio
insoddisfatto realizza se stesso come desiderio senza oggetto, e nel suo sacro (inutile) anelito fa piena esperienza dell’alterità. La gioia di Eros nasce
dalla sua assoluta povertà, dalla sollecitudine e la prontezza nel darsi pienamente e ricevere nulla in cambio, se non il dilatarsi ulteriore dell’abisso
che separa dall’altro. Similmente ciò che ci viene dato è elargito come dispendio immotivato – la vita stessa ci viene regalata per un breve periodo di
permanenza sulla crosta sognante del pianeta. La risposta etica è per l’appunto
condivisione generosa del tempo e dello spazio assegnatici; non nel nome
di comportamenti raccomandati dalla buona creanza, ma un modo stesso di
abitare sulla terra, poetico perché ha come sfondo l’infinito e precede per!
14
!
Plessner 1970, p. 41, traduzione dell’autore.
'#!
!
Manu Bazzano
sino l’idea della cosiddetta libertà individuale, in quanto la percezione
dell’infinito ci alleggerisce della coazione al possesso, del colonialismo e
turismo delle relazioni. Nel far ciò ci presenta un’alternativa concreta (sia
pure come aspirazione il cui percorso viene per noi abbozzato) al percorso obbligato della violenza, un’alternativa al sentimentalismo e all’appropriazione
che siamo soliti chiamare amore, e come esigenza morale al di là della morale
comunemente intesa.
Può una filosofia offrire e restare fedele a tale rigore etico, a tale sete
d’infinito, a tale impegno anarchico? Esistono premesse sufficienti per
l’elaborazione di un pensiero che critichi alle fondamenta la struttura del
pensiero occidentale? Come onorare le profonde intuizioni che da Nietzsche
in poi, attraverso Merleau-Ponty, Sartre, Lévinas e Derrida hanno minato
l’edificio dell’ipseità, dell’identità, e che attraverso Arendt, Adorno e Said
hanno esteso tale critica all’ambito sociale e politico?
L’incontro non può avvenire tramite l’uso di mezzi o tecniche ma, al contrario, è solo quando le tecniche vengono meno che l’incidente dell’incontro
poetico con l’alterità diventa possibile, e solo in un incontro con l’alterità ciò
che chiamiamo il presente può aver luogo, l’attimo vivo e pulsante, non il
decreto di una fine che chiude il passato e ci pone di fronte al futuro. E tuttavia non possiamo risiedere in tale puro incontro con l’alterità: l’intensità
lirica è insostenibile oltre rari momenti privilegiati, ma senza di essa, come
ci ricorda Buber, la nostra esistenza non è vita ma sopravvivenza. L’etica
radicale abolisce le antiche macchinazioni della religione e della scienza,
così come le mediazioni promulgate dal nuovo ethos dialogico e intersoggettivo; al loro posto introduce l’eterogeneità assoluta, un’eterogeneità che,
nel rispettare la differenza, rinuncia al progetto dell’unità e dell’universalità,
affermando, come fa Sartre in San Genet, la separazione e l’esilio. Un esilio
duplice: esilio dall’essere e dall’avere. Sartre attribuisce a Genet ciò che
Rougemont aveva attribuito a Don Giovanni dicendo: “Egli non è abbastanza
per poter avere e non ha abbastanza per poter essere”. L’individuo che accetta
senza riserve l’eterogeneità assoluta (in se stesso come negli altri) giunge a conoscere l’orrore della solitudine, come Genet fa dire al suo personaggio
Querelle, ma anche il suo incanto immortale. Egli si è incamminato sull’orlo
di un abisso e da lì ha contemplato le morti accatastate e accantonate dal diniego quotidiano della storia umana, che opera nel nome della preservazione e
!
'$!
Chi ama lo straniero
del rinnovamento edificando i musei del vivere di cui noi viventi siamo, come
dice Sartre, gli allestitori; per contro, guardare l’abisso è rinnovare in sé
un’ansia che per Hegel è nient’altro che spirito, e per Kierkegaard libertà.
L’individuo che accetta appieno l’etica rifiuta di perpetuare l’automatismo
del bene quanto la banalità burocratica del male, e recupera ciò che vi è di
gratuito, di poetico nel male stesso; nell’identificarsi con esso, egli scopre
un sentiero che lo conduce alla poesia e alla rivolta. Senza tale percorso necessario di diserzione e di disorientamento volontario rimarremmo inibiti
fra le maglie dell’onestà manichea, che sa esprimere empatia per l’orfano
ma si crede distante dal ladro e dal criminale; senza ciò che Sartre chiama
giansenismo del male, cioè la formazione di un’etica buia che rifiuti i canoni
della morale e della religione, il moto dell’etica verrebbe comodamente assorbito dal liberalismo borghese e dalle ingiunzioni di un super-io atavico
pre-lacaniano. Senza tale rivolta non ci è dato comprendere appieno la dignità
di cui parla Genet: il rifiuto da parte dell’esiliato, dell’immigrato clandestino e
dell’oppresso di fare ossequiosa domanda d’appartenenza al gregge che dice
di ospitarlo concedendogli il dubbio privilegio del lavoro nero a basso costo.
Vi è in tale dignità un parallelismo con la passività radicale dell’insegnamento
buddhista, in quanto essa non aspira all’acquisizione di identità, potere e
ricchezza, ma mette in discussione società alienate.
A differenza di Sartre, per il quale la dignità degli oppressi è strategica e
muterebbe in azione rivoluzionaria allorché le circostanze lo consentano,
ciò che viene qui proposto è il carattere irriducibilmente anarchico e il rifiuto dei valori stessi della borghesia. La dignità in Genet si riappropria di una
nozione originariamente associata al rango e all’autorità, conferite da una
carica pubblica; Agamben fa risalire la costruzione di una “teoria della dignità” ai giuristi e canonisti del Medioevo, e spiega come nella Roma, così
come nella Francia monarchica, essa designò un’entità fittizia, “una specie di
corpo mistico che si affianca al corpo reale”15 fino a diventare, con la morale,
del tutto separato dal possesso di una carica. Il passaggio successivo della
nozione di dignità è dalla morale all’etica radicale, dalla presunta autonomia dell’esperienza interiore intesa come espiazione e riscatto individuale
al volontario affacciarsi, nella vulnerabilità della risposta etica, all’alterità.
!
15
!
Agamben, 1988, p. 60.
'%!
!
Manu Bazzano
L’umano è ciò che non può venire rappresentato. Nel venire convocato
dall’alterità, il soggetto che risponde all’appello afferma la propria esistenza,
ma tale affermazione non coincide con l’antica e venerata autarchia della
tradizione filosofica occidentale. Nel venire chiamato in causa dalla presenza
dell’altro, mi sorprende registrare la sua precarietà e la sua vulnerabilità; vengo
alla luce come essere umano precisamente in tale sporgermi, nell’esilio dalla
mia confortevole identità.
Tale esilio mi definisce, ciò che fa dire a Lévinas “l’umanità è lacerazione
dell’essere”.16 Una lacerazione duplice: la precarietà dell’altro mi rimane
impressa, ma per arrivare a percepirla devo rischiare, sporgermi e recidere,
sia pure momentaneamente, il mio legame a un’identità fittizia. L’incontro
fra l’Io e il Tu non appartiene all’arcadia sentimentale della psicologia contemporanea, ma avviene dopo aver disertato l’ipseità: una posizione vertiginosa
e incerta, che provoca paura e ansia: paura di essere ucciso, svergognato, denunciato, scoperto, ansia di fare altrettanto nei confronti dell’altro. A coprire la
paura e l’ansia intervengono la moralità, la razionalità, l’utilitarismo, lo spirito di preservazione, ma nessuna di queste strategie si avvicina lontanamente
alla posizione dell’etica radicale; quest’ultima interrompe il circolo vizioso
del narcisismo, e sola ci sospinge oltre la cattiva coscienza.
Il rapporto che nasce dal superamento della paura di essere annientati
e dal superamento dell’ansia di annientare l’altro appartiene al dominio della
poesia, una dimensione paradossale che oltrepassa sia il dialogo intersoggettivo che la fusione simbiotica, entrambi elaborati modi di evasione della
precarietà. Parliamo ovviamente di una situazione limite che non si addice a
tutti, e che ci pone di fronte al rischio dell’immediatezza e del masochismo
(e del sado-masochismo in senso lato). A salvarci temporaneamente da tale
impasse e dal pericolo che ne consegue interviene la sagacia di Spinoza, che
ne L’etica ci rammenta che il desiderio di vivere nel giusto comporta il desiderio di vivere, di preservarsi; in altre parole l’istinto di vita, la sana complicità
con il desiderio e con l’istinto di libertà, deve qui contro-bilanciare dualisticamente un dettato tirannico del super-io che, nel campo dell’etica, specie se
influenzata dal pensiero ispirato di Lévinas, rischia di scandire e giustificare
l’istinto di morte. Scrive Judith Butler:
!
16
!
J. Butler, 2004, p. 134.
'&!
Chi ama lo straniero
È possibile [...] leggere Lévinas come un elevato masochista e non ci è di
aiuto, nel voler evitare tale conclusione, considerare che, quando gli fu chiesto
cosa pensasse della psicoanalisi, a quanto pare abbia risposto: non si tratta
forse di una forma di pornografia?17
È ovvio che coloro che godono di rappresentanza hanno opportunità
maggiori di venire umanizzati rispetto a chi ne è privo; questi ultimi corrono
il rischio di venire trattati come esseri inferiori – sfruttati, ignorati, o trasformati in capri espiatori.18 Con il trionfo della tecnologia dell’informazione,
la disseminazione dei volti anonimi piegati a significati simbolici e il trionfo
delle personalità, i criteri tradizionali che caratterizzano la disumanizzazione
e conseguentemente l’umanizzazione della persona sono tuttavia mutati: la
personificazione stessa de-umanizza, trasforma il volto umano (sordo alle
strategie della conoscenza acquisitiva nell’incontro a tu per tu dell’intimità)
in oggetto. Sebbene il volto si situi al centro dell’anti-ontologia di Lévinas,
esso non va confuso con la rappresentanza-rappresentazione. È possibile disumanizzare l’umano, ma è lecito, anzi urgente, chiedersi cos’è l’umano, un
quesito che è al centro dell’indagine filosofica contemporanea (Foucault,
Butler, Agamben) e che ha indotto una formulazione che non esiterei a definire essenziale: l’umano è ciò che non può venire rappresentato, “ciò che
delimita il successo di qualsiasi pratica di rappresentazione.19
!
17
Butler, op. cit. p. 140.
Ibidem, p. 141.
19
Ibidem, p. 144.
18
!
''!
!