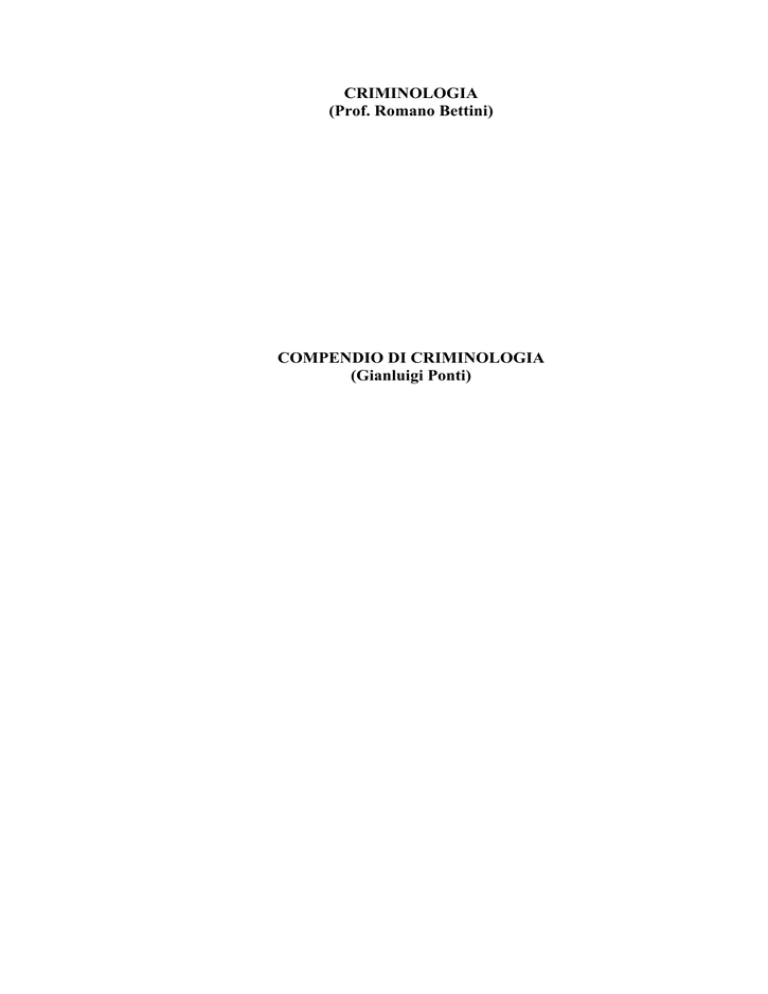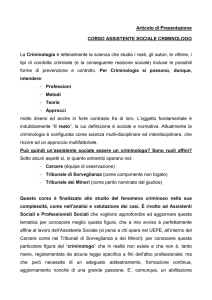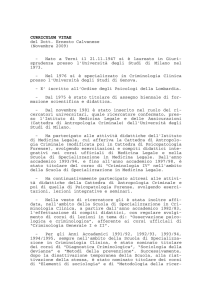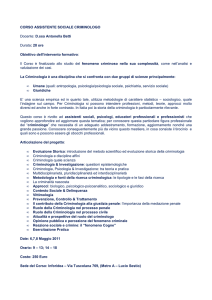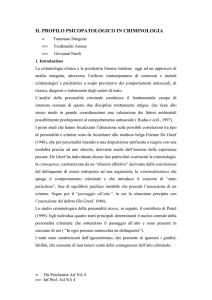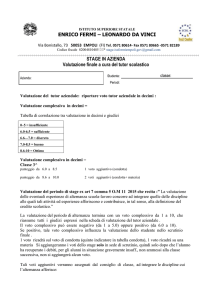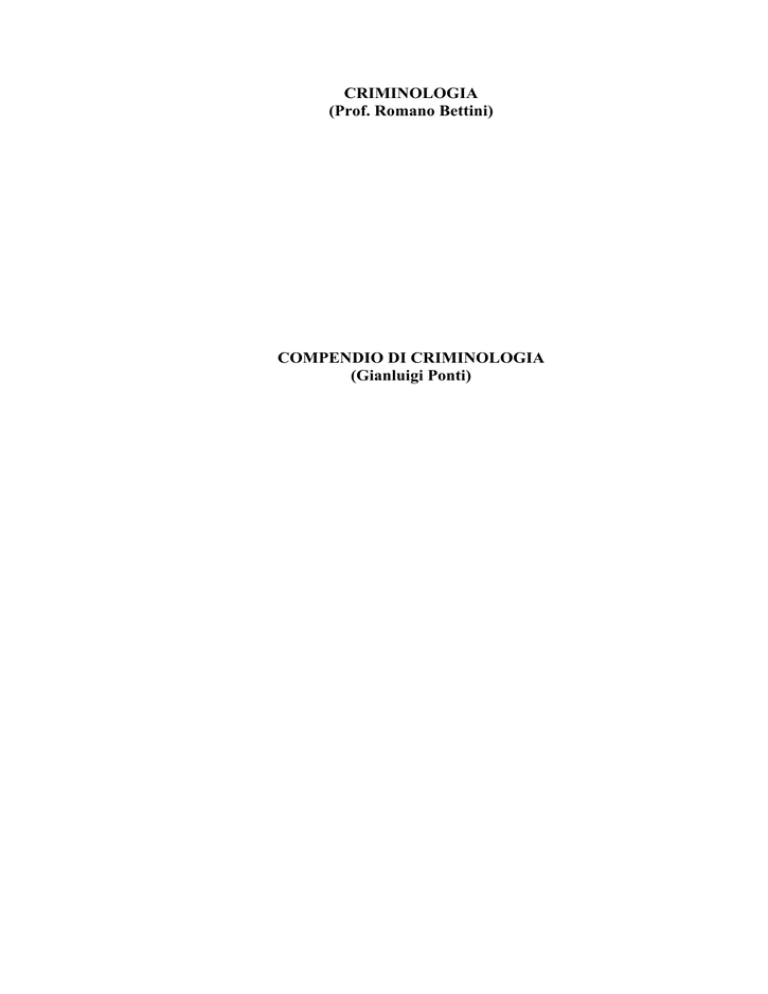
CRIMINOLOGIA
(Prof. Romano Bettini)
COMPENDIO DI CRIMINOLOGIA
(Gianluigi Ponti)
CAPITOLO 1
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CRIMINOLOGIA
1.1 – PREMESSA
La criminologia, contrariamente a quanto si creda, non è riservata solo agli addetti
ai lavori: essa offre anche , in una prospettiva umanistica, molteplici spunti per
ampliare le conoscenze e favorire una migliore conoscenza della persona umana.
Fornire conoscenze maggiormente approfondite, che non ricalchino solo il comune
buon senso o gli stereotipi e i luoghi comuni sul crimine è lo scopo specifico di
questa disciplina.
1.2 – LE SCIENZE CRIMINALI
Le discipline che hanno come loro interesse i fenomeni delittuosi si denominano
“scienze criminali” e ad esse appartengono, oltre alla criminologia:
-
il diritto penale, sia sostanziale che procedurale – esso è la scienza che
studia, analizza ed approfondisce il complesso delle norme giuridiche rivolte
ai cittadini, le quali divengono, in forza di legge, regole di condotta. Pertanto,
il delitto, che è il campo degli interessi e delle indagini scientifiche della
criminologia, viene ad essere definito dal diritto penale: poiché la
criminologia si occupa di studiare i fatti delittuosi, gli autori dei delitti e le
differenti reazioni che la società mette in atto per combatterli o prevenirli, ne
consegue che la criminologia sarà debitrice al diritto penale della definizione
dell’oggetto su cui deve indirizzare la sua ricerca e il suo sapere.
-
Il diritto penitenziario – che ha come oggetto l’insieme delle disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano la fase esecutiva del
procedimento giudiziario penale.
-
La psicologia giudiziaria – che studia la persona umana non in quanto reo
(ambito questo della criminologia e della psicologia criminale) ma quale
attore, in differenti ruoli, nel procedimento giudiziario (imputato, parte
offesa, periti, avvocati, magistrati della pubblica accusa e giudici, ecc.).
-
La politica penale (o politica criminale) – composta da molteplici filoni di
pensiero che hanno come obiettivo quello di studiare, elaborare e proporre
gli strumenti ed i mezzi (legislativi, giuridici, sociali, trattamentali,
preventivi) per combattere la criminalità. Essa costituisce l’insieme dei
contributi che molteplici discipline forniscono al legislatore per la
formulazione delle leggi penali, affinché operi non solo sotto la spinta delle
sollecitazioni dell’opinione pubblica e dei valori della cultura di quel
momento, ma anche alla luce delle ricerche, degli studi e degli apporti
dottrinari.
2
La criminalistica, invece, non va confusa né con la criminologia né con le scienze
criminali: essa è da intendersi come l’insieme delle molteplici tecnologie che
vengono utilizzate per l’investigazione criminale. Si tratta di tecniche di polizia
scientifica che hanno come obiettivo la risoluzione di svariati problemi di ordine
investigativo, utili per la qualificazione del reato, per la identificazione del reo o
della vittima, per la caratterizzazione delle circostanze (es.: analisi grafometrica,
analisi di campioni biologici, indagini tossicologiche, ecc.).
Rientrano invece nelle competenze della criminologia gli studi e le applicazioni
pratiche aventi per oggetto l’identificazione del reo utilizzando le caratteristiche
psicologiche e comportamentali degli autori di taluni tipi di reato.
1.3 – PRECISAZIONI SEMANTICHE
Per quanto attiene ai fatti delittuosi, nel comune linguaggio il delitto, il crimine, il
reato, così come pur avendo un significato sostanzialmente equivalente, contengono
sfumature semantiche differenti: la parola reato ha un significato meno
stigmatizzante ed implica reazioni emotive meno negative di quanto non comporti
la parola delitto, riservata di solito per definire atti di particolare efferatezza. Le
dizioni atto illegale o illeciti penali, pur avendo sempre il significato di atto previsto
dalla legge come reato, sono più neutre e non comportano un giudizio morale
particolarmente severo. Le espressioni verbali quali comportamento disonesto o
disonestà, poi, pur sempre indicando un agire proibito dalla norma penale,
implicano una ancor minore reazione sociale di censura, sia per il poco rilevante
danno economico dell’azione disonesta sia per la larga diffusione di quel tipo di
azione. Nel linguaggio giuridico, invece, tutte le azioni penalmente perseguibili
vengono denominate reati: tra di essi si differenziano i delitti e le contravvenzioni, a
seconda della natura delle pene (ergastolo, reclusione, multa nel primo caso; arresto
e ammenda nel secondo) a loro volta correlati alla maggiore o minore gravità del
reato. In criminologia si preferisce non tener conto dell’uso generico dei termini
anche perché i nomi che indicano i fatti delittuosi e gli autori di delitti variano da
paese a paese cosicché dizioni uguali hanno spesso significato giuridico diverso.
Analogamente accade per i nomi con i quali si indica l’autore di fatti previsti dalla
legge come reati. Nel linguaggio dei codici egli può essere reo, delinquente,
condannato, indagato, indiziato, imputato, appellante, ricorrente, ecc. Nel
linguaggio quotidiano le dizioni delinquente e criminale non sono astrattamente
usate per indicare chi infrange la legge ma contengono in sé impliciti giudizi di
valore negativi, disapprovazione, censura. Nel contesto dei gruppi e della società si
effettuano differenziazioni nei confronti della criminalità secondo una gerarchia dei
valori violati, cosicché non tutte le infrazioni della legge penale suscitano uguali
reazioni negative, essendo talune sentite come più gravi di talaltre percepite come
meno severamente censurabili. Il criminologo deve tendere a spogliare la parola
delinquente, criminale, reo (“colui che fa il male”), da implicazioni emotive e da
giudizi etici, considerandole semplicemente quali termini per indicare coloro che
hanno commesso azioni proibite dalla legge penale.
Delinquente, in ogni caso, per il criminologo va usato non tanto come sostantivo,
quanto piuttosto come participio presente: colui che delinque. Criminale,
3
delinquente, reo, dovrebbero semplicemente indicare colui che ha compiuto azioni
che la norma giuridica definisce reati ed evitare dunque generalizzazioni. Non
esistono, infatti “i” delinquenti come categoria o come astratti concetti ma una
realtà costituita da una infinita varietà di singole fattispecie delittuose e di singoli
autori: dunque, è necessario, per essere scientificamente corretti, parlare sempre al
singolare piuttosto che al plurale. Sarà bene poi non usare i verbi all’indicativo ma
utilizzare piuttosto espressioni possibilistiche o probabilistiche perché le certezze
non sono delle scienze dell’uomo e men che meno appartengono alla criminologia.
1.4 – OGGETTO E SPECIFICITÀ DELLA CRIMINOLOGIA
La criminologia si colloca fra le discipline che hanno come loro oggetto di studio la
criminalità e che abbiamo definito quali scienze criminali. Tratto caratteristico della
criminologia, però, è il confluire integrato e non meramente giustapposto degli
apporti di diverse discipline secondo una prospettiva sintetica. Il criminologo,
dunque, è in grado di coltivare conoscenze e di informare su delitto e delinquenti
secondo un più ampio ventaglio di prospettive. Vediamo le sue caratteristiche in
particolare:
-
l’ampiezza del campo di indagine – che considera i fatti criminosi e i loro
aspetti fenomenologici, le variazioni nel tempo e nei luoghi, le condizioni
sociali ed economiche che ne favoriscono la diffusione e le modificazioni.
Rientrano nell’ambito dei suoi interessi anche lo studio degli autori dei
delitti, i diversi tipi di reazione sociale che il delitto suscita, l’analisi delle
conseguenze esercitate dal crimine sulle vittime, del fenomeno della
devianza.
-
È una scienza multidisciplinare – nel senso che è una scienza che per il
proprio autonomo sviluppo richiede competenze molteplici: essa si occupa
quindi dei fenomeni delittuosi secondo molteplici prospettive e competenze.
Afferiscono alla criminologia conoscenze fornita da più discipline quali la
sociologia, la psicologia, la psichiatria, la psicologia sociale, ecc. mentre è
esclusivo compito della criminologia il coagulare in sé i loro apporti per
quanto può essere utilizzato per lo studio del crimine. Il criminologo è lo
studioso che deve saper integrare in una visione sintetica dati, conoscenze,
approcci e metodi provenienti da campi diversi del sapere.
-
È una scienza interdisciplinare – poiché ha necessità di dialogo con altre
scienze per poter, congiuntamente a queste, affrontare questioni alla cui
risoluzione necessitano molteplici competenze.
-
È una delle scienze dell’uomo – tali si definiscono quelle scienze che
studiano quella realtà complessa, articolata e multiforme che è il
comportamento umano in seno alla società nei suoi infiniti aspetti. Con le
altre scienze dell’uomo (posologia, antropologia, pedagogia, storia,
economia, psichiatria, ecc.) la criminologia ha in comune lo studio dell’uomo
nella sua dimensione individuale e sociale, e come suo specifico oggetto lo
studio dell’uomo allorquando viola la legge penale.
4
1.5 – LA CRIMINOLOGIA COME SCIENZA
Per poter parlare di scienza è necessario che un certo tipo di sapere abbia alcune
caratteristiche. Irrinunciabili requisiti delle scienze sono:
-
la sistematicità – nel senso che una scienza è l’insieme delle conoscenze
acquisite in determinati ambiti del sapere, integrate in un complesso
strutturato ed armonico;
-
la controllabilità – posto che le enunciazioni debbono poter essere sottoposte
al vaglio delle critiche logiche e al confronto con i dati della realtà;
-
la capacità teoretica – per la quale una scienza deve riunire e riassumere
molteplici osservazioni e dati sui fenomeni di cui si occupa in proposizioni
astratte unite da un nesso logico (le teorie) e intese a spiegare, in una
costruzione semplice e comprensibile, i rapporti causali, le correlazioni e le
variabili dei fatti oggetto della sua analisi;
-
la capacità cumulativa – consistente nella caratteristica delle scienze di
costruire teorie in derivazione l’una dall’altra talché le più recenti
correggono, modificano, amplificano o perfezionano le teorie prima
formulate;
-
la capacità predittiva – anche se è doveroso precisare che le scienze
dell’uomo presentano grandi limiti nella possibilità di prevedere quali
saranno i futuri comportamenti sia collettivi che dei singoli individui.
L’uomo, infatti, non è mai “costretto” ad agire in un certo modo ma è libero,
sia pur in modo non totale, di scegliere la sua condotta: la quale è
influenzata, anche fortemente, dal sistema delle relazioni interpersonali,d agli
obblighi legali e dalle norme di costume, così come lo è dai fattori sociali,
economici, familiari, ma alla fine la condotta è pur sempre rimessa alla scelta
dell’individuo.
Posto ciò, vediamo ora quali siano le particolari prerogative di dottrina scientifica
della criminologia.
Di certo la criminologia è stata da molti ricompresa fra le scienze empiriche, nel
senso che sarebbe fondata solo sull’osservazione della realtà criminosa e non sulla
speculazione astratta o su presupposti teorici o su giudizi di valore, e nel senso che i
suoi dati dovrebbero avere carattere oggettivo. Pertanto, le interpretazioni che essa
fornisce del suo campo di indagine, le valutazioni cui perviene e gli sviluppi
teoretici che propone dovrebbero essere unicamente il frutto della osservazione
della realtà. Ciò però accade solo per talune delle teorie criminologiche poiché altre
sono invece fortemente influenzate dall’atteggiamento soggettivo dello studioso. Il
carattere avalutativo e neutrale della criminologia intesa come scienza sempre e solo
empirica, a lungo sostenuto nel passato è oggi assai ridimensionata. Le teorie
criminologiche non vengono più considerate come oggettive certezze anche se
rimane pur sempre alla criminologia il requisito di scienza anche emprica, ma solo
relativamente a talune delle sue acquisizioni. Un altro aspetto del suo essere scienza
empirica si manifesta con la sua qualificazione come scienza descrittiva dei
fenomeni criminosi: per questo ad essa competa la descrizione fattuale, la
classificazione e la differenziazione tassonomica dei delitti e dei loro autori, Nel
5
momento in cui alla descrizione si aggiunge però anche la ricerca e la
identificazione dei fattori responsabili di tali eventi, la criminologia viene ad
assumere il carattere di scienza eziologia, cioè di scienza che ricerca le cause dei
fenomeni da lei osservati.
Aspetto empirico/descrittivo
giudizi di fatto
Criminologia
Aspetto ideologico/critico
giudizi di valore
Quando la criminologia costruisce le sue teorie, viene dunque ad assumere
prevalenti connotazioni di scienza eziologia: in questo senso, sottolineando
l’importanza di alcuni fattori e indicandoli come cause della criminalità, viene in
definitiva ad effettuare giudizi ispirati a valori e perde quindi le sue connotazioni di
scienza empirica. Ciò si verifica rinunciando al metodo induttivo in favore di quello
deduttivo, particolarmente nella costruzione di talune teorie, nelle quali è
preminente non tanto la ricerca empirica, quanto piuttosto la interpretazione di
taluni fatti secondo una visione ideologica o sociale: assume in tal caso le
caratteristiche di quelle scienze che si fondano su giudizi di valore.
E’ opportuno a questo punto ricordare la ormai classica distinzione di Norberto
Bobbio tra scienze che formulano giudizi di fatto e scienze che si occupano di
giudizi di valore: in questo senso, quando la criminologia coltiva essenzialmente
l’aspetto empirico e descrittivo dei fenomeni criminosi, è prevalente la prima
caratteristica; quando la criminologia entra nel merito di valutazioni che sono
ideologiche o etiche, quando privilegia taluni fattori sociali conferendo ad essi
valore di causa unica o prevalente della criminalità essa assume caratteri di scienza
speculativa che si fonda su giudizi di valore.
Un’altra caratteristica della criminologia è quella di essere anche una scienza
applicativa. Fra le molteplici competenze del criminologo, vi è anche quella di
intervenire operativamente sui fenomeni criminosi e sugli individui: agisce sui
fenomeni con l’attuare interventi di prevenzione generale e speciale, o con
l’attivarsi nei programmi di mediazione fra reato e vittima; interviene sugli
individui per favorire, con le tecniche proprie delle scienze dell’uomo, l’educazione
dei rei minorenni e la risocializzazione dei condannati adulti, ecc.
1.6 – RELATIVITIA’ DEL SIGNIFICATO AVALUTATIVO E NEUTRALE
DELLA CRIMINOLOGIA
Anche se l’evolvere della scienza ha consentito di acquisire via via sempre maggiori
certezze nell’oggettività di taluni dati del reale, non altrettanto sicurezza è stata
raggiunta nell’interpretazione organizzata in una teoria dei dati stessi. Infatti,
requisito fondamentale delle teorie scientifiche è il loro carattere di falsificabilità o
confutabilità: questa caratteristica, così denominata da Popper, consiste nella loro
6
non dogmaticità, perché è proprio delle teorie scientifiche il poter essere demolite e
sostituite da nuove che dimostrano così la fallacia di quelle che le hanno precedute.
Non vi è cioè una verità assoluta, valida per sempre, ma piuttosto un succedersi di
verità, sempre provvisorie, in attesa di essere superate, modificate o smentite da
altre interpretazioni teoriche della realtà in cui viviamo.
Infine si contesta l’avalutatività della ricerca scientifica, affermando che i dati “non
parlano da soli” ma vengono letti alla luce della teoria: addirittura si sostiene che
sarà la teoria a permetterci di vedere certi date e ad accecarci rispetto ad altri. Il che,
poi, è tanto più vero per quelle scienze meno immediatamente a contatto col dato
naturale, e che rivolgono invece la loro attenzione all’uomo nel suo agire sociale o
individuale: dunque, tutte le scienze nelle quali lo scienziato è nello stesso tempo
osservatore di eventi e attore partecipe di quel contesto sociale, obbligatoriamente
contengono delle scelte di valore e riflettono gli orientamenti generali della cultura
del proprio momento. Quindi, anche la criminologia non può essere solo scienza
empirica e conoscitiva (il che comunque non salvaguarderebbe l’assoluta neutralità)
ma include in sé necessariamente anche aspetti di scienza etico-normativa poiché le
sue acquisizioni, oltre che basarsi su giudizi di fatti, contengono anche giudizi di
valore.
1.7 – VERITA’ E TEORIE CRIMINOLOGICHE
E’ opportuno chiarire un’altra delle peculiarità delle teorie del comportamento
umano, rappresentato dal carattere relativo delle “verità” da esse enunciate.
Relativamente al carattere di verità sulle cause proposte dalle varie teorie, è da
premettere che nel corso del tempo ne sono state identificate moltissime il che
farebbe sospettare che le cause indicate da ciascuna di esse non siano veri fattori
causali. Molti approcci teorici, sia sociologici che psicologici, si propongono come
teorie unicasuali, nel senso che hanno polarizzato il loro interesse su di un unico
fattore, ritenuto il più rilevante o addirittura esclusivo. Altre teorie tentano invece di
conciliare molteplici fattori che intervengono nella causazione per offrire così una
prospettiva interpretativa più ampia: queste si denominano teorie multicausali.
Nello studio del comportamento umano, è da intendersi il significato di causa in
termini molto relativi: l’enorme numero dei fattori concorrenti, unitamente
all’estrema varietà individuale nel rispondere e reagire anche a identiche
condizioni, devono render cauti sul significato della causalità nel comportamento
umano. Nessun fattore può mai da solo completamente spiegare un fatto, e
reciprocamente lo stesso comportamento può essere inquadrato e spiegato secondo
varie teorie causali: questa è semplicemente la conseguenza del fatto che i vari
ricercatori rivolgono il loro interesse maggiormente sull’uno piuttosto che sull’altro
degli innumerevoli fattori che concorrono nel comportamento sociale dell’uomo.
Intendere la condotta in termini polarizzanti sulla causalità espone al rischio di
considerarla secondo la prospettiva del determinismo: ciò vuol dire che col dar
valore di causa come antecedente che da solo spiega l’agire, si finisce col
prospettare un’interpretazione meccanicistica che non lascia più spazio a quella che
è la variabile fondamentale del comportamento umano e cioè la libertà di scelta.
7
E’ poi ormai risaputo che nelle scienze umane la libertà di autodeterminarsi non ha
carattere dogmaticamente assoluto ma è sentita come una responsabilità che può
essere spesso attenuata e ne parliamo pertanto come di una libertà morale
condizionata. Ben sappiamo che gli spazi della libertà umana sono molte volte
compromessi, anche in maniera rilevante, da handicap sociali, o da appartenenze a
particolari sottoculture o dallo stigma o da fattori psicologici e biologici. Ma al pari,
il nostro momento culturale rivaluta la residua possibilità di scelta dell’uomo dai
vari condizionamenti, riafferma la sua responsabilità e quindi anche la possibilità di
formulare giudizi in termini di merito o di demerito.
Sul terreno teorico risulta poi sterile ogni affermazione generalizzante o di priorità
fra le varie cause (o fattori) evidenziate dalle varie teorie: La complessità dei
fenomeni della psiche umana, e conseguentemente della condotta, impedisce di
stabilire delle gerarchie di importanza tra tali fattori: solo utilizzando i vari approcci
in una visione integrata e non esclusiva verrà favorita la migliore comprensione dei
fenomeni. Ciò che dovrà evitarsi, dunque, sarà il dogmatizzare una sola teoria.
Va chiarito comunque che il concetto di teoria unicausale non equivale a quello di
teoria deterministica, ben potendosi formulare teorie unicausali che non considerino
il fattore da esse eletto a condizione principale anche come escludente l’intervento
della scelta personale; viceversa, possono darsi teorie multifattoriali ma
deterministiche in quanto asseriscono che il concorrere di un certo numero di fattori
comporta necessariamente l’esito criminoso. Ma sarà comunque ben difficile che
una singola teoria possa soddisfacentemente chiarire, sotto il profilo causale, o
anche solo esplicativo, ogni tipo di condotta criminosa.
Tornando alla questione delle verità delle teorie criminologiche, c’è da ricordare
che il carattere distintivo della bontà di una teoria non è il suo essere più o meno
vera. Ogni costruzioni teorica che miri ad identificare la causa o le cause del
comportamento criminale incontra un primo insuperabile ostacolo nella estrema
variabilità dei crimini che sono straordinariamente diversi fra loro. Questa
considerazione consente di affermare che non ci sarà nessuna teoria in grado di
identificare una o più cause efficienti per ogni tipo di crimine, e che pertanto
nessuna teoria sarà più “vera” di altre.
Una seconda considerazione deriva dal fatto che le cause identificate (o comunque i
fattori ritenuti dalle varie teorie più importanti) oltre ad essere numerosissime sono
spesso inconciliabili tra loro.
Bene, oggi siamo consapevoli che il metodo scientifica, in modo particolare quello
che si utilizza nelle scienze dell’uomo, non è in grado né lo presume, di fornire
verità incontrovertibili: siamo consapevoli di non poter esprimere certezze sulla
personal umana.
Mentre la verità è un concetto assoluto, le teorie hanno una validità solo relativa e
provvisoria. Una teoria dovrà essere valutata piuttosto in funzione del suo valore
euristico: cioè della capacità di stimolare altre ricerche e a favorire il sorgere di
nuove conoscenze. Una teoria è perciò vera (quindi non in senso trascendente e
assoluto) solo se è utile (cioè se si presta a essere utilmente impiegata per
ulteriormente facilitare la comprensione di un fenomeno, per accrescere le
conoscenze e per più efficacemente intervenire su di esso).
8
Non si deve dunque cercare la teoria più vera, posto che nessuna lo è in assoluto: il
criminologo si avvarrà piuttosto dei contributi derivanti da vari approcci teoretici,
così da poter fruire di un più ampio ventaglio conoscitivo. In questo senso
giocheranno infine un ruolo importante anche le affinità e gli orientamenti di
ciascun studioso in quanto sappiamo che non è possibile prescindere completamente
dai giudizi di valore, che necessariamente sono informati all’ideologia e alle
inclinazioni culturali di ciascuno.
1.8 – IL CONCETTO DI CAUSA IN CRIMINOLOGIA.
Gli uomini hanno costantemente costruito spiegazioni causali alla ricerca di dottrine
capaci di offrire una spiegazione al perché viviamo, e al perché dell’universo di cui
siamo parte: non deve dunque sorprendere se anche la criminologia si sia posto il
problema di identificare le cause della condotta delittuosa.
Abitualmente si designa coma causa di un fatto l’antecedente necessario e
sufficiente al suo accadimento.
Nel cercare la causa, non possiamo rifarci solo alle condizioni necessaria in quanto
esse sono molteplici e una siffatta esasperata e paradossale visione condizionistica è
del tutto sterile. Ciò che si indica come causa deve essere non solamente necessario
ma costituire anche una condizione sufficiente: si deve cioè, fra gli infiniti
antecedenti necessari, identificare solo quello che in definitiva ha provocato
l’effetto. Chiamiamo pertanto causa, fra tanti fattori pur necessari, solo quella
condizione che è più direttamente intervenuta nel fenomeno esaminato, trascurando
gli altri, e senza la quale l’effetto non si sarebbe verificato. Cerchiamo, cioè, la
conditio sine qua non. Fra i tanti antecedenti, quello è la causa efficiente.
Se poi, in un’altra prospettiva ci si propone non semplicemente un fenomeno ma
anche di intervenire per modificarlo, è chiaro che è necessario trascegliere dal
complesso degli antecedenti talune condizioni che si reputano più importanti perché
sono quelle sulle quali possiamo intervenire per modificare l’effetto. Di fronte a tale
esistenza di una causalità pragmatica si trova anche il criminologo, chiamato ad
indagare e comprendere, ma possibilmente anche a contrastare il comportamento
delittuoso.
Questo comune concetto di causalità, che chiameremo casualità lineare (dalla causa
A deriva l’effetto B, che esprimiamo graficamente con la formula A ----- B è stato
a lungo il paradigma dominante dell’età del Positivismo quando, nel secolo XIX,
vigeva una visione meccanicistica ed una fiducia assoluta nella capacità esplicativa
della scienza secondo la quale i fenomeni naturali (e con essi anche il
comportamento umano) derivavano, in una visione deterministica, da fattori noti
che producevano necessariamente certi effetti, in armonia con leggi di natura che
erano certezze non discutibili.
Ma se per molti fenomeni naturali più semplici la causalità lineare ha ancora pieno
valore, questo principio di causalità non ha oggi più credito per quanto attiene ai
fenomeni di cui si occupano le scienze dell’uomo. La prospettiva della causalità,
relativamente al comportamento umano è cambiata radicalmente: essa è intesa
9
infatti secondo una prospettiva sistemica e alla luce di un nuovo concetto di
causalità detta di “causalità circolare”.
La teoria dei sistemi (Bethalanaffy, Bateson) invece di considerare i fenomeni
come “effetto necessario” di una causa data, certa piuttosto di analizzare le
reciproche influenze fra i fenomeni che sono inseriti nel sistema: questa teoria si
fonda sul concetto di “insieme” per il quale una unione di elementi è qualcosa di
diverso dalla semplice somma dei singoli componenti; essa spiega inoltre come
nell’insieme dei rapporti interpersonali, costituenti appunto un sistema, la condotta
di un soggetto influenza quella degli altri, e come quest’ultima a sua volta si
ripercuota sul comportamento del primo agente: è questo il concetto di causalità
circolare. Il modello è mutuato dalla cibernetica, che sostituisce lo schema della
causalità lineare con quello di “retroazione” o feedback per il quale ognuna delle
parti di un sistema influisce sulle altre (A --- B): ne deriva che la differenziazione
fra causa ed effetto viene in tal modo a perdere il significato perché ogni parte del
sistema è nello stesso tempo causa ed effetto e non può più parlarsi pertanto di
causa efficiente. E’ dunque centrale il concetto di sistema nel quale sono
ricompresse oltre all’attore del fenomeno osservato anche le altre persone e
circostanze con le quali il soggetto è venuto in rapporto, e le correlazioni tra di essi.
La criminologia, adottando una modalità esplicativa di queste genere favorirà una
conoscenza più ampia di quel soggetto e di quella condotto ma finisce per
ostacolare il giudizio morale nei suoi confronti e rischia di favorire un
atteggiamento globale di giustificazionismo e di deresponsabilizzazione: l’eccesso
del comprendere può portare all’impossibilità del giudicare.
Le attribuzioni di responsabilità debbono avvenire secondo un modello differente di
causalità, la causalità giuridica materiale, che procede secondo la logica della
causalità lineare.
Fra le molteplici teorie giuridiche sulla causalità, preferibile appare la teoria della
causalità cosiddetta umana, per la quale la condotta umana può considerarsi causa
dell’evento quando: a) è conditio sine qua non del medesimo, in quanto senza di
essa l’evento non si sarebbe prodotto; b) l’evento al momento della condotta era
prevedibile come conseguenza verosimile di essa, secondo la miglior scienza ed
esperienza del momento storico”.
Ecco che se il criminologo con le sue conoscenze è in grado di favorire proprio
attraverso la logica della casualità circolare, la comprensione approfondita di un
comportamento delittuoso identificando il reticolo dei fattori remoti e prossimi,
psicologici e relazioni che hanno avuto un ruolo più o meno rilevante nella condotta
incriminata, deve però astenersi dal formulare giudizi in quanto non solo perché
quanto maggiore è la comprensione tanto maggiore sarà la tendenza a giustificare
ma perché giudizi e giustificazioni spettano solo al giudice.
1.9 – Il campo delle indagini criminologiche
La criminologia, già si è detto, non può avere una propria autonomia nel delimitare
il proprio ambito d’indagine perché è delimitata in questo dal diritto positivo. Il
delitto è un fatto sociale che la legge definisce come tale per convenzione pubblica.
10
Fra gli innumerevoli comportamenti il diritto ne indica infatti alcuni come proibiti,
prevedendo sanzioni per chi viola la proibizione: solo che l’indicazione di ciò che è
proibito cambia nel tempo e nei luoghi.
Oltre che mutevoli, le definizioni del diritto positivo sono necessariamente rigide e
schematiche. Per molti studiosi il delitto si sostanzia in una condotta che lede o
mette in pericolo un bene di rilievo per la collettività, nel senso che la sua lesione o
messa in pericolo costituisce danno sociale: essa cioè risulta intollerabile per la
società stessa e non altrimenti evitabile se non utilizzando sanzioni criminali.
Fin dal secolo scorso, all’epoca della Scuola Positiva, è stato rivalutato il vecchi
concetto di delitto naturale – contrapposto a quello di delitto come fatto
storicamente e socialmente contingente – che mira a identificare i delitti secondo un
criterio e un’etica universali, non subordinate al variare delle norme legali. Secondo
questa prospettiva giusnaturalistica, esisterebbe una sorta di “sistema legale non
scritto” cioè un insieme di valori che le leggi costantemente tutelano in ogni
momento storico e che rispecchierebbero i contenuti etici fondamentali, immutabili
e trascendenti, di una supposta “natura dell’uomo”: essi si affiancherebbero al
diritto positivo dei singoli stati e delle singole epoche, essendo indipendenti o
addirittura superiori ad esso ed è di essi che la criminologia dovrebbe soprattutto
occuparsi.
L’antropologia e l’etnologia informano invece che nessuna delle condotte proibite
dalle norme si è mantenuta immutata nel corso dei secoli. Tutti i valori etici, tra cui
anche quelli che parrebbero più radicati, non sono dunque frutto di principi innati o
del patrimonio biologico o di principi immanenti e immutabili ma della evoluzione
sociale e culturale.
Il delitto non è pertanto “fatto naturale” bensì “fatto sociale” identificato da una
definizione convenzionale, necessariamente mutevole con il mutare delle società e,
pertanto, l’idea del delitto naturale risulta inaccettabile per chi affronta il problema
in una prospettiva antropologico-culturale.
Nel tentativo di definire il delitto secondo criteri di validità generale, svincolata
dalle norme contingenti e mutevoli de diritto positivo, si è anche tentato di utilizzare
il principio della antisocialità o della pericolosità sociale. Sulla pericolosità si
incentrava la politica criminale propugnata della Scuola Positiva del diritto ed era
intesa come una specie di innata tendenza a compiere delitti non necessariamente
connessa con l’effettualità di comportamenti legalmente proibiti e che sugli
individui socialmente pericolosi si andò incentrando l’interesse dei criminologi di
quell’epoca. Ma l’antisocialità e la pericolosità sono però condizioni ben difficili da
oggettivare da arte delle scienze dell’uomo ed è in definitiva un mero giudizio di
valore espresso nei confronti di taluni individui in ragione non solo di talune loro
caratteristiche somatiche e psicologiche ma in pratica molto spesso semplicemente
del loro status. Rientrerebbero pertanto tra questi esseri antisociali anche coloro che
pur non avendo commesso reati ne vengono reputati potenzialmente capaci: si
ammette così l’esistenza di una criminalità “potenziale” o “induttiva” svincolando il
concetto di delinquente dal quello di delitto consumato o tentato. C’è anche da dire
che nel diritto penale moderno, il criterio della generica antisocialità ha assunto un
significato diverso in quanto beni giuridici meritevoli di tutela penale sono oltre i
11
beni prevalente individuali anche quelli di più ampio interesse cosicchè sono
ritenuti fatti antisociali l’inquinamento ambientale, gli attentati all’ecologia, i reati
economici.
Non possono nemmeno seguirsi quei pensatori che, sempre nell’intento di
svincolare il campo d’indagine della criminologia dal diritto positivo, hanno parlato
di una criminologia dei diritti umani, muovendo dall’intento di prendere in esame
anche quei comportamenti che costituiscono violazione dei fondamentali “diritti e
libertà dell’uomo” e che sono stati definiti dalla Carta dell’ONU nel 1946
prescindendo dal fatto che siano, ovvero no, previsti come reati dal diritto positivo
delle singole nazioni. La questione è ancora oggi aperta in quanto comporta
limitazioni della sovranità dei singoli stati.
Analogamente non sono accettabili le ormai superate proposte di estendere
l’interesse della criminologia ai crimini del sistema,le cui prospettive politiche di
sinistra erano fin troppo palesi: “sistema”, prima della caduta del muro di Berlino,
era inteso come la struttura economico-plitica dei paesi occidentali e capitalistici e
come tale era da criminalizzare.
Peraltro, si è cercato di differenziare i delitti a seconda del criterio della maggiore o
minore gravità, pensando di circoscrivere la competenza della criminologia solo ai
primi: ma secondo quale gerarchia di gravità dei reati? Anche il parametro della
gravità, è evidente, può subire oscillazioni in funzione delle scelte contingenti di
politica criminale e degli orientamenti seguiti nella priorità della repressione penale.
E’ evidente, pertanto, che anche questo criterio non può essere accolto, essendo
contingente anche la valutazione di maggiore o minore gravità dei reati. La “gravità
del reato”, infatti, è prevista dal codice penale quale uno dei parametri per
l’applicazione discrezionale fra minimo e massimo della pena edittale (art. 133 c.p.)
e si tratta, quindi, di una prerogativa del giudice. In particolare, è prerogativa del
legislatore il porre il principio generale e, del giudice, l’identificare nelle singole
fattispecie la maggiore o minore rilevanza sociale del delitto, non certo del
criminologo.
Piuttosto, la criminologia si occupa anche della corrispondenza (o non
corrispondenza) fra la percezione nel corpo sociale della gravità degli illeciti penali
con quella della legge, percezione valutata attraverso ricerche empiriche, inchieste,
sondaggi di opinione, che vengono comparati con la scala di gravità emergente dalla
minore o maggiore entità delle pene.
In definitiva, il parametro per delimitare i confini del campo degli interessi della
criminologia può essere solo quello della legge.
La stretta dipendenza della criminologia dal diritto positivo non va intesa però come
subordinazione concettuale nei confronti della norma: anche la norma giuridica
costituisce una realtà sociale nei confronti della quale il criminologo mantiene la
propria libertà di studioso, esercita una analisi storica, ne studia caratteri e
dinamiche, evoluzioni e meccanismi.
Certo è che non vi può essere nei confronti del diritto un atteggiamento di inerte
accettazione dello status quo o di passiva acquiescenza, per cui se la criminologia
studia il delitto e il delinquente alla luce di ciò che definisce come tali la legge
12
penale, nello stesso tempo, quale scienza autonomia, essa non si trova nei confronti
del diritto in una posizione subordinata, ma esamina e analizza criticamente, e in
piena indipendenza, la legge medesima, le sue modalità di applicazione e gli effetti
che produce.
1.10 - Il delitto quale convenzione sociale mutevole col succedersi delle culture:
la sua relatività storica
I delitti non sono qualificati come tali come espressione di valori eterni e
trascendenti: la loro identificazione è da intendersi come una convenzione sociale,
e, come tale, mutevole col succedersi delle culture.
La relatività del concetto di delitto deriva innanzitutto dal fatto che la norma penale
è espressione dei valori prevalenti e degli interessi particolarmente tutelati in una
determinata società.
In larghi archi di tempo, si può osservare che sono stati puniti come reati
comportamenti che successivamente non sono stati pi ritenuti tali (stregoneria,
eresia, maleficio, ecc.) e, per converso, atti oggi severamente puniti, in altre epoche
furono puniti con maggior mitezza se non addirittura non penalizzati.
La relatività del concetto di diritto si osserva anche per il fatto che nella stessa
epoca, concezioni assolutamente difformi sono presenti in diversi paesi, pur
appartenenti ad analoghe strutture culturali e, ancora, di più, in aree culturali fra
loro maggiormente differenti, possono osservarsi, in uno stesso momento storico,
assai diverse qualificazioni i delitti o un’assai dissimile percezione di gravità.
Per comprendere il carattere relativistico del delitto, occorre ricordare che tutta la
vita umana è ordinata da norme (legali o di costume) che vengono apprese e che
differiscono, con limitato margine di discrezionalità individuale, come ci si debba
comportare e viceversa come non sia lecito agire nelle varie circostanze.
L’apprendimento di tali norme è un fatto squisitamente culturale ed è favorito da un
insieme di strumenti di controllo sociale che agiscono su ogni attore sociale affinché
si conformi ai precetti del suo gruppo. L’insieme delle regole di comportamento fa
sì che tutte le azioni – dalle più semplici a quelle apparentemente innate, a quelle
più complesse – siano previste nel modo e nel tempo in cui debbono essere eseguite
lasciando uno spazio di libertà e di scelta al singolo individuo che è sempre limitato.
La maggior parte di queste norme non è codificata ed è talmente connaturata ai
costumi e alla cultura da passare del tutto inosservata, o dal farla ritenere non tanto
la conseguenza dello sviluppo della cultura realizzatosi nel millenario succedersi di
diverse società quanto addirittura “naturale”, cioè legata alla stesa struttura
biologica dell’uomo.
La dinamicità delle regole è tipica dell’evolversi delle varie culture e le leggi si
modificano e si succedono in un divenire continuo, per adeguarsi costantemente
all’evoluzione della società. Alcune regole durano più a lungo e sono ritenute
immutabile e perciò intrinseche alla natura dell’uomo; altre si modificano più
rapidamente e perciò vengono apprezzate più agevolmente come mutevoli regole
sociali.
13
Si sono inoltre sempre poste distinzioni fra le varie norme, alcune delle quali
vengono ritenute di minor conto ed altre valutata come più importanti: sono quelle
che tutelano principi e beni che sono ritenuti primari e la cui osservanza è garantita
dal controllo esercitato dalla legge penale. Questo vuol dire che viene effettuata una
selezione fra principi, beni, interessi, diritti, secondo una precisa gerarchia di valori.
Qualche volta queste infrazioni possono anche essere lesive di valori morali, la cui
osservanza è però lasciata alla discrezione dei singoli e non è tutelata con punizioni
legali, bensì mediante il controllo esercitato in modo informale dai gruppi sociali
(riprovazione, derisione, emarginazione, censura, ecc.). A protezione di principi e
beni ritenuti essenziali esistono invece (nelle società simili alla nostra) norme
scritte, tradotte in codici e leggi, che ufficialmente ne proibiscono l’inosservanza,
prevedendo, per ciascuna trasgressione, la corrispondente pena.
Le leggi penali sono pertanto da intendersi come uno dei numerosi sistemi di
controllo sociale mirati a inibire quei comportamenti ritenuti più gravi, perché
minacciano quell’insieme di beni, materiali e no, che una data società ritiene
maggiormente preziosi e che protegge in modo privilegiato, mediante appunto
l’intimidazione e l’irrogazione della pena.
Di volta in volta, la società distingue per convenzione ciò che è lecito da ciò che
non lo è e, pertanto, anche la definizione di reato è mutevole e convenzionale, cioè
non assoluta, ma frutto di scelta, di decisione o accordo in funzione di una a sua
volta mutevole gerarchia di valori.
Il carattere relativistico delle definizioni legali di delitto non autorizza peraltro
alcune soggettivismo, per il quale, essendo la legge una convenzione, sarebbe a
ciascuno lecito decidere, secondo un proprio codice personale, se accettare e
rispettare la norma legale, ovvero rifiutarla e non osservarla. Principio irrinunciabile
di ogni società è l’osservanza della legge esistente, che mantiene la sua imperatività
anche constatandone il valore contingente e on trascendente. Semmai, le leggi
vanno modificate quando non sono più socialmente percepite come adeguate ai
valori della cultura.
1.11 - Strumenti di controllo
Ogni società è retta da regole di comportamento, parte non codificate, parte tradotte
in norme legali (fra le quali quelle penali) al fine di assicurare coesione fra i suoi
membri e stabilità sociale: senza regole, infatti, qualsiasi contesto, dl più arcaico al
più evoluto, non può esistere. Questi obiettivi sono assicurati dalla esistenza di
sistemi di controllo che hanno appunto lo scopo di assicurare la coesione e la
salvaguardia di ogni dato contesto sociale.
Il termine “controllo sociale” va spogliato dl pensiero che si tratti di qualcosa di
opprimente e va inteso, invece, in modo neutrale, avendo la consapevolezza che
nessun sistema sociale può esistere senza l’osservanza di regole e questo per il
benessere di tutti.
Isaiah Berli, uno dei maggiori rappresentanti del liberalismo europeo, scriveva,
giustamente, che “la libertà è l’area entro cui una persona può agire senza esser
ostacolata dagli altri” ma per fruire di questo bene fondamentale necessario che la
14
libertà dei singoli sia garantita appunto dai sistemi di controllo che, senza per ciò
essere necessariamente oppressivi, ne assicurano la salvaguardia.
Per comprendere l’utilità di queste strutture di salvaguardia, prendiamo in
considerazione il concetto di “agenzie di riduzione dell’ansietà”. Tali agenzie
svolgono una fondamentale funzione di stabilità sociale e sono rappresentate da
tutte quelle struttura più o meno istituzionalizzate o informali alle quali gli attori
sociali aderiscono per vari motivi e in vario modo (comunità, associazioni, partiti,
movimenti, organizzazioni sportive, ecc) che forniscono contestualmente
costellazioni di valori (ideologie, fede religiosa, fede politica, ideali, mete collettive,
etica sociale, regole di vita): il loro venire meno si riflette in aumento di ansia
sociale. Tali agenzie sono vissute come pregnanti: tanto più il singolo individuo può
riferirsi ad esse e tanto meno deviante sarà la sua condotta.
Queste agenzie costituiscono uno dei tanti mezzi di cui la società dispone per
assicurare nei suoi membri la massima osservanza delle regole che caratterizzano la
sua cultura e quindi anche per contenere la criminalità. Ogni tipo di società
impiegherà tutti gli strumenti idonei a evitare le tendenze devianti dai suoi valori
fondamentali: questi sono appunto gli strumenti di controllo sociale.
Fra gli strumenti di controllo sociale distinguiamo:
1) quelli istituzionalizzati o di “controllo formale” - che sono cioè organizzati
e regolamentati da specifici organismi. Controllo formale è il controllo
esercitato dagli organi pubblici in base a norme giuridiche che ne prevedono
esplicitamente le competenze e le procedure. I controllo formale è quello
esercitato dalle forze di polizia, dalle sanzioni detentive e pecuniarie, dalle
misure di sicurezza, ecc. Sono tutti strumenti che, regolamentati in precise
istituzioni, mirano a garantire il rispetto delle norme.
2) Quelli di controllo informale istituzionalizzato – sono organismi fondamenti
che, pur avendo diversi fini istituzionali, rappresentano anche
importantissime fondi di informazione normativa e canali di comunicazione
dei valori fondamentali, e che quindi fungono anche da agenzie di controllo
del comportamento. Il controllo informale è rappresentato dall’azione di
strutture riconosciute dal diritto per finalità diverse dalla lotta alla
criminalità (ad esempio, la famiglia, la scuola, la chiesa, il sindacato) o
anche indifferenti al diritto (es: le comunità abitative e le associazioni
spontanee) che, intenzionalmente o meno, concorrono a determinare
l’adattamento degli individui agli schemi delle società in cui vivono o anche
a correggere situazioni , comportamenti e abitudini di vita che fanno temere
un’esposizione al rischio di divenire delinquenti o una inclinazione in tal
senso (servizi sociali, presidi psichiatrici, i centri per alcolizzati e
tossicomani, ecc.).
3) Quelli di controllo informale non istituzionalizzato (o di gruppo) – Si tratta
di un sistema di controllo che non si esercita mediante le istituzioni ma da
persona a persona nel contesto stesso dei vari gruppi sociali Il vicinato, le
persone che si frequentano, gli amici e i colleghi, l’ambiente di studio e di
lavoro). Ciascun individuo è infatti costantemente sottoposto al giudizio di
coloro con i quali vive a contatto e, attraverso una fitta rete di messaggi,
15
constata continuamente il grado di accettazione ovvero di critica e di
riprovazione che la sua condotta suscita. Questo tipo di controllo viene
esercitato con l’approvazione o l’elogio pubblico ovvero con la
riprovazione: quest’ultima si manifesta attraverso una gradualità di
atteggiamenti proporzionali alla gravità con cui viene giudicata la condotta
(riprovazione verbale in privato; rimprovero pubblico; severa censura;
derisione; temporaneo allontanamento dal gruppo; isolamento;
emarginazione; stigmatizzazione).
In sintesi, dunque, i controllo sociale consiste nell’azione di tutti i meccanismi
che controbilanciano le tendenze devianti, o impedendo del tutto la deviazione o,
cosa più importante, controllando o capovolgendo quegli elementi della
motivazione che tendono a produrre il comportamento deviante.
In una società vi è tanta maggior criminalità e devianza quanto maggiore è il
“vuoto di valori” o quanto più prevalgono gruppi sociali negativi.
1.12 – Connessioni fra cultura, leggi e poteri
Per cultura, in generale, si intende l’insieme dei contenuti di valore, delle ideologie,
delle conoscenze, dei costumi, della morale, e delle credenze caratteristici di ogni
società.
In una prospettiva più ristretta, la cultura consiste, dunque, in modelli astratti di
valori etici e di regole riguardanti il comportamento, che rappresentano le
impalcature essenziali e le fondamentali linee direttrici che danno specificità a ogni
particolare momento storico e sistema sociale.
Ancora meglio, ogni cultura può intendersi come l’insieme delle norme (tradizioni,
costumi e leggi) che danno concretezza e tutela ai valori caratteristici di una data
società.
Rientra nella logica dei fatti sociali che si stabilisca, all’interno della società, ciò che
è lecito e meritorio e ciò che, viceversa, è riprovevole e è da condannarsi: la
definizione del bene e del male si realizza perciò nel contesto della società. In una
data società, dunque, esiste un insieme complesso e articolatissimo di valori, taluni
dei quali si concretizzano appunto nelle leggi.
Uno dei fini delle leggi è quindi quello di assicurare la continua coerenza e
funzionalità tra la struttura della società e il tipo della cultura.
Ma non si deve avere una visione del divenire dei fatti sociali intesa come
esclusivamente fondata sull’uniformità del consenso di tutti gli attori sociali.
Coesistono infatti contemporaneamente per ogni società e per ogni cultura sia
l’adesione e i consenso, sia forme di dissenso più o meno radicali che alimentano le
conflittualità e che sono da ritenersi componenti insostituibili per evitare il rischio
della cristallizzazione sociale e per garantire il progredire storico delle culture
stesse.
Occorre quindi tener presente che in ogni aggregazione umana sono
contemporaneamente presenti sia consenso che dissenso: certamente essi sono
entrambi indispensabili il primo, per evitare il dissolvimento dell’aggregato sociale
16
e l’impossibilità, a causa della costante contesa, di un funzionamento operativo dei
vari gruppi; il secondo, per impedire la sclerosi dell’immobilismo e il soffocamento
delle voci minoritarie.
I concetti si “struttura” e “sovrastruttura”, mutuato dalla filosofia marxista, ben si
presta per spiegare il legame esistente tra le caratteristiche di una società e i valori
ideologici, la morale, i costumi e le credenze della sua impalcatura culturale.
Struttura è, appunto, il tipo di sistema economico di una società data, controllato
dai gruppi che detengono i mezzi di produzione dei beni; sovrastruttura è l’insieme
di valori di quella società, che risulta funzionale al tipo di sistema economico. La
coerenza è assicurata dal fatto che i valori fondamentali non sono espressi da tutti i
membri della società ma, data la divisione in classi, solo dai gruppi che in quella
società detengono più potere e, di conseguenza, fanno leggi in modo
funzionalmente armonico alla propria posizione e interesse.
In realtà, la piena corrispondenza funzionale tra valori culturali di generale
accettazione e valori culturali dei gruppi o delle classi più potenti si realizza
solamente nei periodi storici caratterizzati da stabilità sociale, quando il potere è ben
definito; quando, invece, si affacciano nuovi gruppi in ascesa o quando una società
è pluralistica e composita, con la presenza di gruppi diversi, si realizza la
contestuale presenza di ideologie e valori diversi e contrastanti, funzionali a quelli
dei differenti gruppi con conseguente difficoltà di adeguamento sociale dovuta al
“conflitto delle norme”. Quello che deve essere ben chiaro, detto questo, è che la
classe dominate, oltre ad esprimere i propri valori, possedendo gli strumenti per
formulare ed imporre le leggi, stabiliscono quali siano i beni i valori ed i diritti
meritevoli di quella tutela privilegiata che la legge penale fornisce anche se è pur
vero che – entro certi limiti – i valori più specificatamente connessi agli interessi
che sono propri di chi ha più potere legislativo vengono percepiti e fatti propri
anche dalla maggior parte degli altri gruppi sociali.
E’ da porre in evidenza anche che i valori di una data cultura non sono
esclusivamente quelli che riflettono gli interessi della classe dominante ma ne
comprendono anche altri che fanno parte di un “patrimonio comune a tutti” come,
ad esempio, i valori di famiglia, di patria o di nazione, quelli religiosi, la carità, la
tolleranza o il fanatismo, il concetto di bello o brutto, ecc.
E’ poi da chiarire che per di “gruppi di potere” non si possono identificare
semplicisticamente con una classe o una casta, dato che si osserva nell’evoluzione
storica il susseguirsi e il subentrare di sempre diversi gruppi che di volta in volta
vengono ad assumere una rilevanza dominate. Tali gruppi di potere, in una
prospettiva dinamica, possono essere stabili o contrastati, in declino o in ascesa: non
può perciò sempre facilmente definirsi quali sono i gruppi potenti.
1.13 – Metodi e fonti delle conoscenze empiriche
E’ opinione generale che la criminologia si distingua dalle altre scienze criminale
per la sua caratteristica di scienza empirica, cioè fondata sull’osservazione della
realtà e non sulla speculazione concettuale. Ma dobbiamo ricordare, tuttavia, che
ciò è vero solo in parte perché non è pensabile una criminologia senza il
17
presupposto di una visione del mondo, che è anche filosofica ed etica. Così come,
reciprocamente, la criminologia non può prescindere anche dai dati
dell’osservazione empirica dei singoli individui, dell’ambiente e della realtà sociale.
Da qui, l’importanza di conoscere metodi e fondi dei dati empirici di cui pur sempre
la nostra disciplina si avvale.
Gli strumenti statistici a disposizione del criminologo sono:
Le statistiche di massa - servono per esaminare l’estensione dei fenomeni e le
caratteristiche più generali dei fatti criminosi (frequenza, diffusione, distribuzione e
fluttuazioni nel tempo e nei luoghi) e sono effettuate su grandi numeri o sulla
totalità dei soggetti dell’universo considerato. Queste ricerche non consentono,
però, l’identificazione dei fattori sociali che concorrono alla genesi del fenomeno
osservato e l’evidenziazione delle condizioni microsociali o individuali rilevanti, in
quanto privilegiano i fattori macrosociali di più generale influenzamento;
L’osservazione individuale – tipica della criminologia clinica, consente invece di
evidenziare circostanze particolari che la statistica non può considerare
(caratteristiche psicologiche o psicopatologiche del reo, aspetti del suo ambiente
particolare, riverberi su di esso della reazione sociale, la sua carriera criminale,
relazioni interpersonali, ecc.). Risulta però impossibile enucleare con questo mezzo
di indagine i fattori di più generico influenzamento presenti nell’ambiente sociale.
Questo tipo di investigazione può estendersi a più soggetti aventi una comune
caratteristica delittuoso, così che dalla moltiplicazione dei singoli casi osservati se
ne possono ricavare profili psicologici e identikit maggiormente significativi sulla
tipologia di particolari delinquenti: ricerche di questo tipo consentono di accertare,
ad esempio, le caratteristiche comuni di ladri o truffatori professionali, serial killer,
ecc.
Le ricerche su gruppi campione – con questo tipo di ricerche, l’indagine viene
sempre centrata su singoli individui ma estendendo l’indagine su un numero più
elevato di soggetti e utilizzando certe regole di rilevazione, se ne possono ricavare
conclusioni dotate di validità generale, così come avviene con le statistiche sui
grandi numeri. La ricerca è eseguita su un numero relativamente ristretto di soggetti
che diventa però “rappresentativa” (un campione, appunto) dell’intera popolazione.
Le indagini sul campo – Quando si vogliono studiare le caratteristiche criminali di
certi ambienti o gruppi, gli orientamenti particolari di certe sottoculture, le
interazioni che esistono fra i loro appartenenti, può essere utile che il ricercatore si
inserisca materialmente per un periodo di tempo.
Le ricerche settoriali – sono condotte, senza che il ricercatore si inserisca
personalmente nel campo indagato, su altri ambienti particolarmente significativi
(carcere, istituti per misure di sicurezza, ambienti dei tossicomani, ecc.) per
indagare su dati e situazioni non altrimenti conoscibili.
Interviste a testimoni privilegiati - Si eseguono inchieste su persone che, per la loro
veste professionale (assistenti sociali, psicologi, psichiatri, insegnanti, ecc.) hanno
conoscenze vissute ed esperienze professionali particolarmente preziose.
18
Tutti questi tipi di indagine vengono eseguite con la tecnica delle interviste dirette e
con questionari, così da poter valutare le percezioni e le opinioni nei confronti di
vari problemi attinenti alla criminalità.
Quando si vogliono analizzare gli effetti di taluni trattamenti risocializzativi, le
conseguenze di certi interventi o la validità di talune innovazioni penali, si
utilizzano le ricerche operative, che consistono nel controllare i loro effetti
comparando una campione di soggetti che ne hanno beneficiato con altri che non ne
hanno fruito. In tal senso, queste possono essere definite ricerche sperimentali.
Ci sono poi le indagini anamnestiche che esaminano i risultati a distanza di tempo
di taluni interventi per valutarne l’efficacia.
Sono da ricordare anche gli studi predittivi, utilizzati per trovare indicatori che
consentono di prevedere il futuro comportamento sulla scorta di certi parametri e le
ricerche storiche, che offrono un’ampia gamma di studi, per esempio sulla
fenomenologia criminosa, sulle pene e sui sistemi carcerari di epoche passate.
1.14 – Il numero oscuro
Una importante limitazione di ogni indagine effettuata in ambito criminologico è
legata al fatto che i dati utilizzati, qual che sia la metodologia impiegata, sono
relativi ai reati denunciati dalla polizia o dai privati alla magistratura, ai
procedimenti penali istruiti, alle sentenze di condanna, alle popolazioni delle carceri
e, comunque, ai dati relativi ai criminali o crimini identificati: emergono cioè da
fonti che sarebbe erroneo ritenere rappresentativo dell’intera criminalità poiché
esprime solo la quantità e qualità di quei delitti che si sono individuati. Invece, in
effetti, il numero dei delitti che vengono quotidianamente consumati è in genere
superiore a quello che emerge alla superficie: così, la visione della realtà criminosa
risulta gravemente deformata ove essa fosse riferita solo ai dati ufficiali senza
prendere in considerazione anche quelli relativi alla criminalità sconosciuta. A ciò
fanno riferimento sostanzialmente gli studi sul numero oscuro (dark number).
Le ragioni che rendono conto del divario fra criminalità nota reale sono tante:
alcune attengono ai fatti delittuosi, altre al tipo di autori, altre ancora a particolari
situazioni che riguardano le vittime.
L’indice di occultamento (cioè il rapporto reati noti e reati commessi) varia in
modo considerevole per le differenti specie di delitti: il numero degli omicidi
volontari commessi è molto vicino a quello noto; le truffe, invece, quelle note sono
notevolmente inferiori a quelle attuate dato che non tutte le vittime denunciano il
reato subito.
Al numero oscuro relativo al mancato accertamento dei reati, si aggiunge poi – a
dilatare ancora di più la zona d’ombra – il problema della non identificazione
dell’autore dei reati pur accertati.
Il numero oscuro non è dunque da riferirsi solo ai fatti delittuosi che rimangono del
tutto ignorati e che non mettono nemmeno in moto le strutture deputate alla loro
repressione e punizione, ma ricomprende anche quei delitti ufficialmente noti e dei
quali non si è scoperto l’autore.
19
L’indice di occultamento, quindi, è sempre negativo a causa della insormontabile
sproporzione fra i fatti-reato e l’impossibilità delle strutture a ciò deputate di
perseguirli tutti e di identificarne tutti gli autori.
1.14.1 – L’atteggiamento della vittima e qualità del reato
E’ da considerare che non tutti i delitti vengono denunziati dalle vittime (o dai
testimoni) e non tutti vengono perciò a conoscenza delle autorità: anche
l’atteggiamento della vittima, dunque, gioca un ruolo determinante sul numero
oscuro.
Dobbiamo pensare infatti che vi sono certi delitti, fra cui tipici sono quelli di
aggressione sessuale, per i quali la vittima preferisce lasciare impunito l’autore
piuttosto che dare notorietà al fatto, oppure, come per il racket, per il quale la
persona offesa tace per timore di ritorsioni o vendette. Vi sono poi dei reati che non
vengono denunciati in quanto la vittima ritiene che sprecherebbe il suo tempo per
una denuncia che non porterebbe comunque a nulla, come accade per i furti in
appartamento ad opera degli zingari.
1.14.2 – L’atteggiamento degli organi istituzionali
Gli organi di polizia e la magistratura inquirente hanno, per loro finalità, non solo il
compito di identificare gli autori dei fatti denunziati o comunque conosciuti ma
anche quello di prendere l’iniziativa andando a ricercare fatti delittuosi non ancora
divenuti noti. Nella realtà, le iniziative di indagine si rivolgono invece in modo
selettivo verso certi settori di delittuosità piuttosto che verso altri, a seconda di ciò
che, in un dato momento, per le diverse esigenze e contingenze, o per l’allarme
sociale suscitata in maggiore o minore misura da certi comportamenti, viene
ritenuto essere più utile, opportuno e importante da reprimere, trascurando
conseguentemente, e perciò di fatto tollerando, altre condotte.
Il privilegiare l’uno o l’altro settore è sempre questione di necessità contingenti e/o
di scelta e ciò comporta, inevitabilmente, un aumento dei comportamenti delittuosi
in ambiti determinati in quanto ritenuti dai delinquenti “meno rischiosi”. Ad
esempio, si ricorda l’indifferenza riservata ai delitti di natura finanziaria ed
imprenditoriale.
1.14.3 – La qualità dell’autore del reato
Interferisce sull’entità del numero oscuro anche la qualità dell’autore del reato: a
parità di condotta delittuosa, per esempio, l’autore di un piccolo furto non verrà
denunciato qualora si tratti di un ragazzo di buona famiglia e questo perché
intervengono pressioni oppure considerazioni di opportunità che possono favorire
maggior tolleranza nei suoi confronti. Una inferiore esposizione al rischio di
denuncia si realizza anche, ovviamente entro certi limiti, nei confronti di minorenni
o qualora il colpevole rivesta posizioni di prestigio sociale, sia un personaggio noto
o molto ricco.
20
1.15 – Statistiche di massa
Le statistiche di massa consentono al raccolta, l’analisi matematica e
l’interpretazione di dati quantitativi, inclusa la determinazione di correlazione fra
vari dati.
Poiché raccolgono, di un fatto osservato, tutti i casi che si sono verificati, o un
numero molto grande di essi, la veridicità dei dati di statistiche di questo tipo è
molto elevata. Le “statistiche sui grandi numeri” peraltro, non forniscono
interpretazioni raffinate dei fenomeni ma ne consentono in genere solo una
comprensione superficiale.
Può utilizzarsi questo genere di indagine per avere statistiche trasversali (es.:
caratteristiche della criminalità in un dato momento) ovvero statistiche
longitudinali o dinamiche (modificazioni da un momento all’altro o nello sviluppo
diacronico di un fenomeno).
Questi dati possono poi essere elaborati in funzione di numerose variabili: età,
sesso, tipo di reato, tipo di sanzione, condizioni economiche degli autori,
professione, regione di nascita e di residenza, scolarità, religione, razza, nazionalità,
condizione familiare e molti altri.
Di particolare interesse sono le correlazioni statistiche fra diverse serie di dati e
talune variabili. E’ possibile che si abbiano delle variazioni indipendenti nelle serie
confrontate (assenza di correlazione o correlazione indifferente = numero degli
omicidi e stagione in cui sono commessi); che le variazioni di un carattere
corrispondono a variazioni nell’altra serie nello stesso senso (correlazione positiva
= più aumenta l’urbanizzazione più aumenta la criminalità); ovvero nel senso
opposto (correlazione negativa = dopo i 30 anni, più aumenta l’età e minore
diventa il numero dei fatti delittuosi).
Ovviamente, le correlazioni possono variare, per uno stesso fenomeno, nei tempi e
nei luoghi. Inoltre, lo studio delle correlazioni può essere più complesso includendo
più variabili in funzione di un singolo carattere (detenuti esaminati in relazione
all’età, alle condizioni economiche e alla stabilità lavorativa nei riguardi della
residenza).
Dalle correlazioni statistiche è in genere arbitrario trarre delle illazioni di ordine
causale perché il fatto che due fenomeni si modifichino con andamento parallelo
non sempre indica che l’uno sia causato dall’altro. I fattori che intervengono nel
comportamento criminoso, infatti, sono estremamente numerosi e complessi e
accentrare l’attenzione su una variabile comporta sempre il rischio di non tener
conto di altri fattori che pur concorrono nel fenomeno osservato.
La statistica criminale è poi soggetta a errori non solo relativi all’interpretazione dei
dati ma anche per quanto concerne la loro validità come, da esempio, per quelli che
derivano dalla imprecisione o dalla non attendibilità delle fonti.
Assai ambigue sono poi le comparazioni statistiche internazionali, sia per la
diversità, da paese a paese delle fonti e dei criteri di rilevamento delle statistiche
ufficiali, sia per la variabilità delle terminologie giuridiche, del contenuto e della
procedura della legge penale: uno stesso tipo di condotta, ad esempio, può figurare
con denominazioni diverse, può costituire o no atto perseguibile, ecc.
21
Le interpretazioni, poi, possono essere inficiate da numerosi fattori di errore quali,
ad esempio, quelli derivanti da variabili non considerate o nascoste o sconosciute.
La molteplicità dei fattori che agiscono sulla condotta umana deve rappresentare
una costante remota alla tentazione sia di attribuire immediatamente, attraverso i
dati ricavati dalle indagini statistiche, valore di causa a certi fattori, sia di
generalizzare arbitrariamente.
1.16 – Inchieste su gruppi campione
Le indagini campionarie sono quelle che consentono di ricercare talune
caratteristiche su di un gruppo ristretto di persone, scelte però in modo tale da
rappresentare la totalità di una popolazione, così da essere un campione veramente
rappresentativo di essa. L’impiego di tecniche particolari rende possibile, anche se
lo studio è effettuato su di un numero relativamente ristretto di individui, di
conferire a queste indagini una validità simile a quella che si sarebbe ottenuta ove
fossero stati sottoposti all’inchiesta tutti i soggetti di quella popolazione.
Affinché il gruppo campione sia rappresentativo, è necessario che, a seconda del
tipo di indagine, esso contenga, in misura proporzionale a quella esistente nella
realtà, certe percentuali dei differenti tipi di soggetti che esistono nella popolazione.
Le inchieste campionarie sono dotate di un indubbio potere chiarificatore e hanno
consentito alla moderna criminologia di acquisire conoscenze fondamentali. Esse
conservano i vantaggi, eliminandone però i difetti, sia delle indagini di massa che di
quelle individuali.
Anche le indagini campionarie, però, consono del tutto prive di difetti e immuni da
critiche. Innanzitutto, non sempre è agevole ottenere un campione veramente
rappresentativo dell’universo che si vuole analizzare (es.: non sono tutti noti gli
autori di un determinato delitto quindi, estrarre un campione dalla popolazione dei
detenuti per quel delitto è fuorviante). Inoltre, i fattori sui quali si vuole indagare
sono difficilmente enucleabili nella complessa interferenza delle molteplici
condizioni agenti sulla condotta criminosa: incentrando l’indagine su una o
qualcuna delle molte variabili si rischia di trarre conclusioni arbitrarie.
1.17 – Le osservazioni individuali
Con i metodi individuali di indagine, si studiano singoli criminali o, al più, piccoli
gruppi in quanto esse attengono, in generale, allo studio della personalità, intesa
come unità psico-organica, e dei fattori microsociali agenti a più immediato contatto
del singolo.
Queste indagini possono essere indirizzate verso lo studio del caso, eseguito con
investigazione minuziosa e approfondita. Vengono così sviscerati, relativamente ad
un singolo caso, tutti gli aspetti relativi alla famiglia, al passato, alle caratteristiche
ambientali, mediche, psicologiche, ecc.
Talune indagini individuali particolarmente dettagliate e approfondite possono
assumere il carattere di storia di vita descrivendo tipi particolari ed emblematici di
22
carriere criminali, illuminando su fattori di peculiare importanza (es. difetti di
socializzazione o influenza di determinate vicende o ambienti sociali nel destino di
una persona) e mettendo in evidenza, con il circostanziato racconto biografico, il
riscontro e l’esemplificazione delle teorie criminologiche nel caso concreto.
Le indagini individuali hanno consentito così di enucleare fattori assai significativi
della condotta deviante e criminale: frequenza delle anomalie della personalità,
fattori familiari disturbanti, condizioni di frustrazione, ecc. E’ stato così possibile,
ad esempio, osservare il ruolo giocato nella criminogenesi dall’alcoolismo, dalle
tossicomanie, dal disturbo mentale, dalle condizioni di sfavore sociale.
1.18 – Questionari ed interviste
Fra i metodi di indagine utilizzati in criminologia si debbono citare anche i
questionari e le interviste che vengono ampiamente utilizzati negli ambiti più
diversi per effettuare sondaggi di opinione, conoscere preferenze, scelte, gusti ed
abitudini. Nello specifico della ricerca criminologia, questi vengono utilizzati per
rilevare atteggiamenti e reazioni nei confronti dei fenomeni criminali, il maggiore o
minore sentimento d’insicurezza dovuto alla criminalità da strada, le richieste e i
provvedimenti auspicati da parte delle autorità competenti.
I questionari non sono altro che “interviste strutturate” consistono in un insieme di
domande uniformi e rigidamente predefinite, volte in genere a indagare temi precisi
e circoscritti, che vengono sottoposte a gruppi campione molto estesi. Esistono poi
altri tipi di interviste nelle quali le domande non sono predisposte in maniera
altrettanto rigida, e perciò all’esaminatore viene lasciata maggiore libertà di
interloquire con il soggetto: esse possono distinguersi in “semistrutturate” o
“libere”, a seconda del maggiore o minore grado di flessibilità.
Un esempio di intervista libera è costituito dal colloqui che viene utilizzato per
scopi sia clinici che di ricerca: consiste in una conversazione opportunamente
indirizzata con il soggetto o con i soggetti studiati e consente perciò un contatto
diretto e una comprensione più approfondita, anche se meno estesa, delle dinamiche
sottese al fenomeno analizzato. Naturalmente, le informazioni raccolte durante il
colloquio non sono del tutto esenti dal rischi di condizionamento.
Tra le finalità di questi metodi di indagine vi è anche quella di conoscere meglio
l’identità e qualità dei delitti commessi: utilizzando queste interviste e questionari è
stato possibile, ad esempio, aprire qualche spiraglio nella conoscenza della
criminalità nascosta.
Le inchieste confidenziali, ad esempio, sono state utilizzate per interrogare con
questionari campioni di popolazione, chiedendo agli intervistati se avessero mai
commesso reati. Tali inchieste vengono eseguite in condizioni di massima
discrezione ed offrendo garanzie di assoluto anonimato. Anonimato vuol dire che
neanche il ricercatore stesso, al momento dell’elaborazione dei dati, è in grado di
risalire al soggetto che ha fornito le risposte; “confidenziale” vuol dire che tale
riconoscimento è invece possibile ma si assicura la completa segretezza.
Altre ricerche, sempre effettuate mediante la tecnica delle inchieste confidenziali,
sono state svolte per identificare quelle vittime che non avevano denunciato i torti
23
subiti (inchieste vittimologiche): attraverso indagini su gruppi campione e
chiedendo agli intervistati quali e quanti reati avevano subito in un certo periodo, è
emersa la conferma che i reati commessi sono ben più numerosi di quelli
ufficialmente noti. Agli stessi risultati hanno condotto le inchieste tra persone che,
per il ruolo e l’attività svolti hanno maggiore possibilità di venire a conoscenza di
fatti delittuosi (inchieste tra testimoni privilegiati).
Da più parti è stato riconosciuto come le informazioni raccolte attraverso tali
tecniche possono essere limitate o distorte da numerosi fattori quali il cattivo
ricorso, la sempre possibile reticenza o la semplice mendacità. Non da trascurare
neanche il fatto che le vittime potrebbero non avere interesse a menzionare alcuni
reati nei quali hanno avuto un ruolo attivo (es: stupefacenti o corruzione di pubblici
funzionari).
1.19 – Indagini predittive
La predizione di futuro comportamento delittuoso rappresenta uno degli obiettivi
della criminologia.
La predizione criminosa viene di regola effettuata secondo criteri induttivi, cioè
secondo esperienza e comune buon senso: intervengono in questo giudizio la
valutazione della gravità e del tipo di reato, le circostanze e modalità di
commissione, le caratteristiche personali sociali e familiari del reo, i suoi precedenti
penali.
Utilizzando una diversa metodologia, fondamentalmente viene utilizzato un criterio
statistico, che ha in sé inevitabilmente tutte le incognite connesse al trasferimento
sul singolo caso di medie statistiche.
Il più noto dei sistemi predittivi è quello predisposto da Glueck che utilizza alcuni
indici (della famiglia, del carattere e della personalità) emersi come più frequenti fra
giovani delinquenti rispetto a quelli di loro coetanei che hanno invece tenuto
condotta regolare.
La predizione del comportamento è uno dei compiti più impegnativi, nonostante le
sue conoscenze specifiche, che il criminologo incontra.
24
CAPITOLO 2
LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRIMINOLOGICO
2.0 – Ideologie e criminologia
La criminologia nasce come scienza solamente nel 1800 quando, per la prima volta,
viene affrontato in modo empirico e sistematico lo studio dei fenomeni delittuosi,
che in precedenza, venivano considerati secondo una prospettiva essenzialmente
morale e solo secondariamente giuridica.
E’ interessante perciò rendersi conto in quale modo i delitti e i loro autori siano stati
percepiti nel tempo, e secondo quali intenti si è mirato a combattere , prevenire e
punire la criminalità.
In questa prospettiva storica, è comunque da sottolineare il fatto che riandando fino
ai tempi più remoti della nostra evoluzione culturale, si constata che da sempre la
norma (sia essa legale o morale) rappresenta il fondamentale parametro regolatore
della condotta degli uomini: il definire quindi taluni comportamento come
“autorizzati” ed altri “proibiti” è dunque una esclusiva caratteristica dell’uomo,
dalla quale deriva anche l’altra sua specifica prerogativa di potere e di voler cioè
scegliere le condotte proibite anziché quelle lecite e perciò di potere e di volere
compiere anche delitti.
La netta differenziazione fra illecito morale e illecito giuridico avverrà solo in tempi
a noi vicini e sarà frutto del pensiero illuministico. In precedenza, in ogni delitto era
implicito anche un contenuto di infrazione morale e i due concetti, di fatto,
coincidevano.
Questo approccio storico può essere affrontato secondo una triplice prospettiva:
1) una prospettiva esplicativa (perché si delinque?)
2) una prospettiva finalistica (a qual fine punire?)
3) una prospettiva operativa (come punire?).
Vediamole in particolare.
1) prospettiva esplicativa – secondo questa prospettiva, oggi si risponde alla
domanda “perché si delinque?”; per lunghi secoli, invece, questa domanda era
“perché si pecca?”. Le risposte in proposito sono state molte: per ribellione al
comandamento divino, per acquiescenza alle lusinghe del demonio, cioè, in altri
termini, al mai risolto conflitto tra Bene e Male. Un simile approccio pone subito
la questione mai risolta della predeterminazione, ovvero della libertà di peccare:
questo dibattito ancora oggi è aperto tra le correnti di pensiero deterministiche,
che ritengono l’uomo totalmente condizionato nell’azione da forze a lui esterne
(cultura, società, pressioni ambientali di ogni tipo, fattori psicologici, ecc.) e
quelle che ritengono invece l’uomo comunque libero, cioè dotato della capacità
di scegliere il male (i comportamenti proibiti dalle norme) ovvero il bene (i
comportamenti autorizzati). Solo in tempi a noi più vicini, con il rafforzarsi
dell’autorità dello stato, si sono andati lentamente differenziando il delitto –
inteso come infrazione ai divieti terreni – dal peccato – quale inosservanza della
25
morale (cioè dei precetti divini) anche se etica e delitto si sono pur sempre, ed
anche oggi, in parte sovrapposti.
2) Prospettiva operativa – se ci chiediamo, invece, “come punire”, è ben notala
predilezione, nei tempi passati, per la pena capitale quale sanzione elettiva,
applicata per infrazioni ai nostri occhi anche di ben modesta gravità anche se le
pene corporali, le fustigazioni, la lapidazione, i tormenti, le mutilazioni, ed altre
atrocità non erano disdegnate. Solo ai nostri giorni la pena fondamentale è
diventata la perdita della libertà mediante la carcerazione che, comunque, è una
sofferenza irrogata come pena sia pure con sempre maggior limitazione della
sofferenza del corpo. La pena capitale è oggi prevista in un numero ancora
considerevole di Paesi anche se l’ONU ne ha raccomandato la proscrizione.
3) Prospettiva finalistica – se vogliamo invece mettere in evidenza la domanda
“qual è lo scopo della pena?” dobbiamo fare alcune considerazioni. E’ da
sottolineare innanzitutto come, in ogni tempo, non si è mai rinunciato al
principio sanzionatorio non solo come strumento di controllo sociale ma anche
al fine di appagare in ognuno il sentimento e il bisogno di giustizia. Pena (dal
latino poena, sofferenza) significa, appunto, infliggere sofferenza per fa pagare il
male commesso e la questione, oggi, non è tanto quella di non infliggere
sofferenze quanto di contenerne qualità e quantità. Nel passato la pena era
rozzamente commisurata secondo la legge del taglione, intesa quale mezzo per
compensare l’offesa subita con l’infliggere al colpevole la stessa sofferenza
causata alla vittima. Inoltre, finalità della pena fu quella della vendetta, con
l’infliggere un male al colpevole direttamente da chi ha subito il torto in
compenso del male subito. Per secoli (dal mondo greco fino ancora nel IV, V
secolo d.C. per il diritto germanico), infatti, la vendetta non fu solo la
motivazione principale della pena ma un preciso diritto della vittima o dei suoi
familiari. Le origini del diritto penale si possono far risalire allora proprio nel
momento in cui lo stato limita e regolamenta la vendetta, ponendo delle norme
legali per stabilire come e in quali casi essa poteva essere legittimamente
esercitata. Solo più tardi, l’autorità dello stato ha avocato esclusivamente a sé
l’amministrazione della giustizia togliendola alla disponibilità del privato. La
moderna finalità retributiva era, all’epoca illuministica, ancora da venire mentre
la finalità intimidativa fu sempre insita nella pena ed essa costituiva nel passato
anche l’unica modalità di prevenzione che veniva per lo più attuata con la
pubblicità della punizione da eseguirsi sulle pubbliche piazze dinanzi a tutto il
popolo. La segretezza del giudizio, quale vigeva un tempo, è stata sostituita dalla
attuale pubblicità del processo e, per contro, è divenuta nascosta nel chiuso del
carcere l’esecuzione della pena. La funzione pedagogica e di emenda morale,
caratteristica del 1800, e la funzione risocializzativa/riabilitativa del ‘900, non
erano
presenti nella cultura preilluministica ma può intravedersene una
anticipazione nei teologi della Scolastica per i quali la pena aveva un carattere
medicinale per il reo, che espiava la sua colpa davanti a Dio, guarendo così dal
male. Analogamente accadeva all’epoca dell’Inquisizione (la riconciliazione, in
virtù della quale l’inquisitore operava affinché il reo condannato morisse
chiedendo perdono per il peccato commesso e perdonando chi lo giustiziava)
quando si voleva ottenere il pentimento e il ravvedimento dell’eretico al quale si
26
chiedeva per poterlo assolvere di fare pubblica abiura onde favorire il
ravvedimento di coloro che egli, con parole e fatti, aveva traviato. E’ da mettere
ben in evidenza, ancora oggi, fra le finalità della pena, il suo contenuto
satisfattorio: la necessità di dare soddisfazione al bisogno di giustizia, vedendo
unito il colpevole, anche se oggi misconosciuto o sottaciuto, è un contenuto
sempre vissuto da tutti gli uomini come irrinunciabile. La pena risponde ad una
precisa necessità psicologica che nasce nel momento stesso in cui nasce l’etica,
vale a dire da quando l’uomo è divenuto tale. Ovviamente l’etica (cioè il
significato del bene e del male) muta nel tempo così come incessantemente muta
la cultura.
2.1 – L’Illuminismo e l’ideologia penale liberale
Il pensiero penalistico moderno nasce con l’Illuminismo.
Nell’ancien regime, infatti, tanto il diritto che la procedura quanto l’esecuzione
delle pene, erano incentrati sull’autoritarismo dispotico della monarchia assoluta e
sui privilegi dell’aristocrazia nobiliare ed ecclesiastica. Anche l’esercizio della
giustizia era arbitrario tanto quanto la struttura sociale: il diritto penale si estendeva
ad aree che ora consideriamo come di competenza della coscienza privata (i delitti
di opinione erano anche infrazione di norme religiose); non vi era diritto di critica
nei confronti dell’autorità ed era prevista un’ampia discrezionalità che molto spesso
scadeva nell’arbitrio. Il delinquente era percepito alla stregua di un malvagio
attentatore dell’autorità del sovrano, la cui persona si identificava con lo stato; il
reo, inoltre, era ancora gravato da una colpevolezza di significato anche religiose,
posto che la potestà reale era considerata come promanante e garantita dalla
divinità: egli doveva dunque essere severamente punito e, spesso, materialmente
soppresso. L’esecuzione della punizione era dunque pubblica affinché tutti
potessero vedere ciò che comportava l’aver sfidato l’autorità. E’ in questa
situazione che le idee dell’Illuminismo cominciano a farsi strada con l’obiettivo di
rischiarare la mente degli uomini dalle tenebre del dispotismo, dell’ignoranza, della
superstizione religiosa, attraverso la scienza e la conoscenza. Esso era dunque un
movimento rivoluzionario che proponeva valori alternativi: la ragione come
sostituto della tradizione; la libertà per tutti i cittadini (e non più sudditi), la loro
eguaglianza come “fatto e legge naturale” a fronte di privilegi di casta. Uno degli
elementi che avrebbe realizzato il pensiero illuminista doveva essere appunto la
giustizia: il principio dell’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge risale a
Voltaire e Montesquieu anche se, per gli illuministi, l’idea di uguaglianza si riferiva
specificamente all’abolizione dei privilegi di nascita e di classe ed essenzialmente
alla parità di tutti i cittadini di fronte all’autorità dello stato che veniva a sostituirsi
all’autorità del monarca e delle caste potenti.
Nella prospettiva politica, l’Illuminismo fu anche il pensiero che assicurò
l’affermarsi della borghesia mercantile, finanziaria e imprenditoriale e che le fornì il
supporto ideologico per sostituirsi alla nobiltà e al clero che, fino ad allora, avevano
detenuto il potere politico ed economico.
La necessità di una nuova struttura giuridico-normativa del diritto pubblico, che
desse corpo ai principi dell’Illuminismo e che ponesse le basi di un nuovo diritto,
27
trovò in Cesare Beccarla (1738-1794) il suo più famoso sostenitore e divulgatore.
“Dei delitti e delle pene”, pubblicato anonimo per timore della censura nel 1764,
rappresenta la più nota, lucida e sintetica esposizione della nuova concezione
liberale del diritto penale, che segna l’inizio di una nuova filosofia della pena e che
fra l’altro sarà anche anticipatorio dei futuri approcci criminologici.
Gli aspetti fondamentali della concezione liberale del diritto, possono essere così
riassunti:
o separazione fra morale religiosa ed etica pubblica - la funzione della pena è
quella di rispondere alle esigenze di una determinata società anziché ai
principi morali;
o presunzione di innocenza – il diritto deve garantire la difesa dell’imputato
contro gli arbitri dell’autorità;
o i codici devono essere scritti ed i reati espressamente previsti;
o la pena deve avere un significato retributivo anziché unicamente
intimidatorio e vendicativo (“ciascuno deve subire una pena che tocchi i
propri diritti tanto quanto il delitto che ha commesso ha colpito i diritto
altrui”);
o la pena deve colpire il delinquente unicamente per quanto di illecito ha
commesso e non in funzione di quello che egli è o ciò che può diventare;
o il criminale non è un peccatore ma un individuo dotato di libero arbitrio,
pienamente responsabile, che ha effettuato scelte delittuose delle quali deve
rispondere nel modo stabilito dalla legge.
Vediamo come molti di questi fondamenti sono ancora attuali mentre è cambiato
oggi il modo riconsiderare la personalità del delinquente.
2.2 – La Scuola Classica del diritto penale
Le esigenze di un effettivo adeguamento del diritto penale ai principi liberali
dell’Illuminismo trovarono, dopo la rivoluzione francese, una prima attuazione nel
codice napoleonico del 1804.
In Italia, i nuovi principi si sono articolati in una summa dottrinale che prese il
nome di Scuola Classica del diritto penale che, per quasi un secolo, ha caratterizzato
il pensiero penalistico in tutta l’Europa.
Tra i più noti esponenti della Scuola Classica, troviamo: Pellegrino Rossi, Giovanni
Carmignani, Francesco Ferrara.
Questi studiosi elaborarono una dottrina che si rifaceva ampiamente, rielaborandoli
minuziosamente, ai principi liberali.
La Scuola Classica, movendo dal postulato del libero arbitrio che intendeva
l’uomo assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni, poneva a
fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto quale
rimproverabilità per il male commesso e, conseguentemente, la concezione eticoretributiva della pena.
28
Essa si incentrava su tre principi fondamentali:
1) la volontà colpevole – il delinquente è percepito perciò come persona del
tutto libera senza tener conto, nella criminogenesi, dei condizionamenti
ambientali e sociali;
2) l’imputabilità – per aversi volontà colpevole occorre che il reo sia capace di
intendere il disvalore etico e sociale delle proprie azioni (da cui deriva il
presupposto della capacità di intendere e di volere, quale requisito necessario
per essere sottoposto al giudizio e alla pena);
3) il significato di retribuzione della pena – per il male compiuto che, come tale,
doveva essere: affittiva, proporzionata, determinata e inderogabile. La pena
dunque doveva essere severa e gravata da sofferenza fisica nel
convincimento che la riabilitazione sociale dovesse essere il frutto di una
correzione morale quale conseguenza pedagogica della sofferenza della
punizione (= emenda) che sarebbe appunto scaturita dalla durezza del
trattamento.
Il delitto veniva dunque considerato quale entità di diritto e non di fatto cioè come
una astrazione rigidamente dogmatica che prescindeva da qualsiasi considerazione
della realtà psicologica del reo e che comportava il giudizio nei suoi confronti
prescindendo dalle condizioni individuali e sociali interferenti nel suo agire.
I principi fondamentali della Scuola Classica costituiscono la base di un sistema
normativo che ancora oggi mantiene piena validità:
1) il principio della legalità – nessuna azione può essere punita se non
esplicitamente prevista dalla legge come reato;
2) il principio della non punibilità per analogia – non si può punire un
comportamento non espressamente previsto come fatto illecito assimilandolo
ad altri reati o perché potenzialmente foriero di futuri delitti;
3) il principio garantistico – con le norme a salvaguardia del diritto di difesa e
della presunzione di innocenza;
4) il principio di certezza del diritto – che mette al bando ogni discrezionalità
nell’irrogazione delle pene e che comporta la loro eguaglianza per tutti
coloro che hanno commesso il medesimo delitto.
In tempi a noi più vicini, un’aspra critica è stata portata alla Scuola Classica
dall’ideologia di derivazione marxista secondo la quale essa era la tipica
espressione del capitalismo ottocentesco, gravido di ingiustizie sociale e
incentrato sullo sfruttamento delle classi lavoratrici, che impose una normativa
penale rigidamente repressiva che andava a colpire specialmente la classe
operaia classe che, a quell’epoca, era ritenuta il focolaio della maggior parte
della delinquenza.
29
2.3 – Le classi pericolose
Nel 1800 era generale convincimento che la delinquenza fosse pressoché
prerogativa esclusiva delle classi più povere dato che il tumultuoso sviluppo
industriali aveva attirato dalle campagne grandi masse di proletari che erano
costretti a vivere in condizioni miserrime e ai limiti della sopravvivenza. Di
conseguenza, le città si popolavano di reietti la cui vita era segnata dalla miseria,
dall’ignoranza, dall’alcolismo, dalla delinquenza. In effetti, le statistiche relative
alla criminalità che proprio allora si cominciavano ad elaborare, indicavano che
la maggior parte dei delinquenti proveniva proprio da quelle fasce di
popolazione più misera così che nella cultura dominante dell’epoca, che era la
cultura borghese, andò affermandosi il concetto di “classi pericolose”. Le classi
pericolose erano considerate come agglomerati di individui degenerati e carichi
di vizi, privi di volontà e di iniziativa: alle loro deficienze di doti morali veniva
attribuita non solo la criminalità, fra essi selettivamente dilagante, ma anche le
stesse misere condizioni di vita e l’incapacità di emanciparsi da tali condizioni.
Questa concezione era ovviamente legata all’ideologia borghese dell’attivismo e
della volontà di successo dei singoli, che era congeniale a una economia fondata
sul liberalismo sfrenato e all’esaltazione dell’iniziativa imprenditoriale. Secondo
questa ideologia, dalle lontane origini calviniste, a chiunque fosse dotato di
ambizione e volontà di fare erano aperte le strade del successo mentre era
riprovevole restare poveri. Tale mentalità raggiunse il suo apice nella società
americana degli “anni ruggenti”, antecedente alla grande crisi del 1929, e sarà
riassunta nel concetto del self made man, l’uomo che si fa da sé. Ad alimentare
questi principi contribuì anche, e non poco, quella filosofia nota col nome di
“darwinismo sociale” secondo la quale le teorie di Darwin dell’evoluzione delle
specie e della selezione naturale andavano applicata anche al campo sociale: era
ritenuto funzionale all’evoluzione della società che gli “inetti” ed i “perdenti”
dovessero soccombere nella lotta per la vita e che andassero ad occupare gli
strati più squalificati della società: appunto, quelli delle classi pericolose.
A questo modo di intendere il delinquente dobbiamo riconoscere alcuni aspetti
positivi:
a) quello di aver dato l’avvio a nuove metodologie di ricerca con le “indagini sul
campo” condotte nei quartieri più poveri dei centri urbani;
b) quello di aver messo per la prima volta in evidenza le correlazioni tra
depressione socio-ambientale e condotta criminale anche se alla criminalità è
stata così attribuita una valutazione unicasuale, cosa che oggi non è più
accettata.
Nel 1800, a fianco alla visione colpevolizzante del povero e dell’inetto, andò
contestualmente sviluppandosi anche un filone ideologico cristiano e
filantropico, improntato a principi di umana carità e di aiuto nei confronti dei
“bisognosi e dei traviati” che segnò una nuova modalità di intervento nei
confronti dei delinquenti. Si trattava dunque di una concezione moralistica,
come quella della “emenda”che informava la Scuola Classica, con la differenza
che mentre per quest’ultima la redenzione doveva essere il frutto della pena
severa e affittiva, questi indirizzi alternativi miravano ad ottenere la redenzione
30
come risultato dell’assistenzialismo umanitario. Nacquero così organizzazioni
come l’Esercito della Salvezza, che mirava a redimere gli alcolizzati e i
vagabondi, le prime associazioni volontarie di soccorso e di cristiana solidarietà
per i detenuti, i primi trattamenti differenziali per i delinquenti più giovani e i
primi esperimenti di porbation, utilizzato per la prima volta a Boston. Questo
istituto, che tanto sviluppo ebbe poi in America ed in Europa, fu dettato
all’origine proprio da questa diversa percezione del delinquente che anziché
come un depravato, venne considerato per la prima volta quale persona
bisognosa di aiuto per riuscire a reinserirsi nella società.
2.4 – Primi studi statistici e sociologici (= prime concezioni del diritto come
fatto sociale)
La concezione del reato quale astratta entità di diritto, tipica della Scuola
Classica, è stata messa in crisi, verso la metà del 1800, dai primi studi statistici
impiegati per l’approccio scientifico ai fenomeni criminosi. Così, mentre in
precedenza il delitto era percepito quale azione malvagia o depravata compiuta
da un individuo del pari astratto, in quanto non considerato nel suo contesto, si
passava ad una concezione che chiamava in causa l’ambiente sociale nel quale il
delinquente agiva.
Ai ricercatori Quetelet e Guerry, che hanno utilizzato per primi i dati statistici e
demografici, ed è stato riservato l’attributo di “statistici morali” in quanto le
loro ricerche indicavano una concentrazione particolarmente elevata di criminali
nell’interno dei gruppi sociali più squalificati, ove frequentissime erano la
miseria, la prostituzione, l’alcolismo e il degrado morale. Nei loro studi, per la
prima volta fu considerata l’incidenza dei reati in relazione all’età, al sesso, alle
professioni, al grado di istruzione, ecc.: tutto ciò consentì di aprire la strada per
la comprensione del delitto anche come fenomeno sociale.
Si affermava, in sostanza, con la presenza di costanti e di regolarità statistiche
dei delitti, anche una loro qual prevedibilità – almeno a livello di grandi numeri
– quindi si apriva la strada a una percezione del crimine di tipo deterministico o
almeno pluricausata, del tutto assente in precedenza.
Ora, si poteva anche dire che se le condizioni dell’ambiente sociale
influenzavano il crimine, si poteva anche affermare che la condotta delittuosa
era determinata , al di là dell’immoralità dei rei, anche da altri fattori: è da
questo momento, dunque, che si poteva iniziare a pensare al delitto come fatto
sociale secondo la concezione di Emile Durkheim (1858-1917)che lo intendeva
come “non soltanto un’idea soggettiva ma una cosa esistente di per sé, una parte
inevitabile del tipo particolare di una struttura sociale”. Anche il delitto
costituiva pertanto un fenomeno generale di ogni società, una sua parte
integrante e non più una occasionale aberrazione di certi individui; pertanto il
delitto non poteva essere eliminato, anche se era modificabile, nella quantità e
nella tipologia, con il mutare del contesto sociale nel quale si manifestava.
Proprio del mutamento nella quantità e nel tipo di delitti si occupò Gabriel
Tarde (1843-1904) secondo cui alla radice della crescita dei delitti riscontrata
31
nel corso del XIX secolo, era da porsi l’inizio di una nuova prosperità che
fungeva da stimolo alle aspirazioni e alla instabilità sociale: infatti, prima
dell’avvento della società moderna, gli individui non solo avevano ben poche
possibilità di cambiare il proprio status ma non subivano neanche la frustrazione
derivante dal fatto di non poter conseguire determinate mete, ora divenute
possibili anche se difficili per la maggior parte di essi. La delinquenza era per
Tarde il prezzo da pagare al maggior benessere sociale.
2.5 – Determinismo sociale (la società come causa del delitto)
I primi studi statistici sul crimine misero in crisi quel concetto di libero arbitrio
del reo che aveva caratterizzato l’ideologia liberale dal momento che era ora
possibile statisticamente prevedere il numero e i tipi di delitti che sarebbero stati
consumati nella società.
Questo nuovo approccio faceva comunque intendere che il comportamento
criminoso non era più esclusivamente riconducibile alla sola volontà del singolo,
ma che su di lui agivano anche fattori legati alla società: esistendo cioè certe
circostanze nella società, il delitto doveva inevitabilmente realizzarsi.
Secondo gli studiosi che seguivano questo orientamento, nella società erano
insite delle cause per le quali le azioni dei delinquenti venivano ad essere
necessariamente e fatalmente condizionate in senso delittuoso. Pertanto, se pur
potevano esservi delle variabili individuali, il fenomeno delittuoso nel suo
complesso, quale fatto sociale, era ritenuto la diretta conseguenza di fattori legati
all’ambiente, che trascendevano dall’individuo e che erano necessariamente
provocati dalle caratteristiche della società.
Nasce così, con il primo approccio sociologico della criminologia, la visione
deterministica della condotta criminosa, col viraggio dalla percezione liberale
del delitto verso una percezione positivistica, caratteristica del IXI secolo.
Il Positivismo rappresentava infatti l’ideologia fondamentale della scienza,
secondo la quale tutti i fenomeni naturali rispondevano ad una “universale
determinazione causale degli eventi” della quale la scienza era in grado di
identificare le leggi: il Posivitismo informò di se tutta la cultura del secolo,
affermando l’esistenza di leggi universali valide per ogni campo del sapere.
Nella prospettiva sociologica, la visione deterministica del crimine consisteva
nel convincimento che solo, o prevalentemente, nel contesto della società
dovevano ritrovarsi i fattori determinanti la condotta criminale e ciò comportava
in definitiva l’assenza di responsabilità morale dell’individuo, governato
com’era da leggi e fattori che prescindevano dalla sua volontà.
Andava così prendendo corpo un determinismo sociale che doveva trovare il
suo equivalente contrapposto nel determinismo biologico di marca lombrosiana.
32
26 – Cesare Lombroso, la criminologia dell’individuo e il determinismo
biologico.
Sempre nel XIX secolo, che vide l’inizio del filone sociologico della
criminologia, Cesare Lombroso (1835-1909) rappresenta il pioniere del nuovo
indirizzo individualistico della criminologia, secondo il quale lo studio del
reato doveva polarizzarsi principalmente sulla personalità del delinquente,
fino ad allora del tutto trascurata.
Lombroso indirizzò i suoi numerosi studi sulla persona del delinquente e sulle
sue componenti morbose ritenute responsabili della sua condotta: ciò ha
rappresentato una svolta importante nei confronti dell’astrattismo di una
concezione solo legale o morale o sociale del delitto, fino ad allora dominanti.
Oggi, la maggior parte delle sue teorie è priva di valore scientifico ma ciò non
toglie a Lombroso il merito di aver per primo impiegato i metodi della ricerca
biologica per lo studio del singolo autore del reato, di aver fatto convergere
l’interesse delle scienze penalistiche sulla personalità del delinquente (prima
unicamente rivolto all’entità di diritto costituita dal reato), di aver stimolato una
larga massa di indagini sui problemi della criminalità e di aver dato avvio a un
indirizzo organico e sistematico nello studio della delinquenza (Scuola di
Antropologia Criminale) cosicché la criminologia come scienza ebbe modo di
imporsi come nuovo filone della cultura.
La teoria del delinquente nato – è la più nota delle sue teorie e sostiene che
un’alta percentuale dei più incalliti criminali possiederebbe disposizioni
congenite (cioè presenti fin dalla nascita) che, indipendentemente dalle
condizioni ambientali, li renderebbe inevitabilmente antisociali: particolari
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e psicologiche si accompagnavano
secondo il Lombroso a tali disposizioni e ne consentivano l’identificazione.
Importanti erano anche, tra le cause di innata tendenza al delitto, all’epilessia e
ad altre patologie generali.
La teoria dell’atavismo – tentava di interpretare la condotto criminosa del
delinquente nato come una forma di regressione o di fissazione a livelli
primordiali dello sviluppo dell’uomo; il delinquente era dunque un individuo
primitivo, una sorta di selvaggio ipoevoluto nel quale la scarica degli istinti e
delle pulsioni aggressive si realizzava nel delitto senza inibizioni.
Lombroso riconobbe poi anche un gran numero di delinquenti occasionali, non
dissimili per la loro costituzione dagli uomini normali, e nei quali assumevano
rilevanza, nel condizionare la loro condotta, l’ambiente e le circostanze. I fattori
individuali innati e predisponesti al delitto mantenevano comunque un
significato di privilegio: la loro primarietà fra le cause e l’ineluttabilità con cui
essi condurrebbero allo sbocco criminoso configurano quella componente di
determinismo biologico che è un carattere saliente del pensiero lombrosiano.
Il delitto rappresentava dunque nella visione lombrosiana un evento strettamente
legato a qualcosa di “patologico” o di ancestrale che alcuni uomini presentavano
come loro specifica caratteristica. Questo atteggiamento proponeva una visione
33
deresponsabilizzante del fatto delittuoso che tuttora persiste in taluni filoni di
pensiero: esistono uomini giusti, osservanti delle leggi e uomini reprobi che
inevitabilmente delinquono perché la loro natura è “diversa” e “malata”. Nei
confronti di costoro nulla può farsi in quanto predestinati al delitto, se non
difendersi dalla loro innata antisocialità. Il reato e le anomalia della condotta
vengono così visti come se fossero solo una malattia da combattere e da
neutralizzare individualmente, in un approccio che risulta essere
decolpevolizzante nei riguardi della società e del reo e che libera da ogni
responsabilità collettiva e individuale nei confronti del fatto delittuoso.
La prospettiva lombrosiana verrà ripresa attorno agli anni ’50 del XX secolo
dall’ideologia detta del “mito medico” (secondo la quale le carceri avrebbero
dovuto assumere almeno idealmente l’aspetto e le funzioni di un luogo dove si
cura o si cerca di curare) e, più di recente, da quegli orientamenti di
“criminologia clinica” sempre centrati sullo studio dell’individuo e che hanno
avuto importanti riflessi anche sulla politica penitenziaria penale.
27 La Scuola Positiva
Le teorie lombrosiane sul delitto hanno costituito la base di un nuovo
orientamento giuridico e criminologico che si ispirava al pensiero positivistico
allora imperante secondo il quale i dati dell’osservazione empirica dovevano
costituire l’unico punto di partenza per interpretare i fatti delittuosi e per
proporne i rimedi.
Unitamente a Cesare Lombroso, i penalisti Enrico Ferri (1856-1929) e
Raffaele Garofalo (1852-1934) furono i teorici e i divulgatori dei principi di
quella che si sarebbe appunto chiamata la Scuola Positiva di diritto penale.
La Scuola positiva si incentrava sui seguenti postulati:
1) il delinquente è un individuo anormale;
2) il delitto è la risultante di un triplice ordine di fattori antropologici, psichici e
sociali;
3) la delinquenza non è la conseguenza di scelte individuali ma è condizionata
da tali fattori;
4) la sanzione penale non deve avere finalità punitive ma deve mirare alla
neutralizzazione e possibilmente alla rieducazione del criminale e deve
pertanto essere individualizzata in funzione della personalità del delinquente.
La pena non doveva pertanto avere più il significato di retribuzione per la
colpa commessa o di dissuasione dal delitto mediante l’intimidazione ma
quello di realizzare il controllo delle tendenze antisociali, considerando più la
personalità del criminale che non il tipo di delitto commesso.
I principi della Scuola Positiva si tradussero in un vero e proprio programma di
politica penale, per il quale, accertata l’attribuibilità del fatto al singolo autore,
una misura di difesa sociale doveva sostituire la pena, ed essa doveva essere non
tanto commisurata alla gravità del delitto compiuto, secondo il sistema tariffario,
34
quanto piuttosto proporzionata alla maggiore o minore perniciosità sociale del
reo.
Cardine dunque di ogni misura penale era la pericolosità sociale del criminale,
sia attuale, dimostrata dalla condotta delittuosi, sia potenziale, insita nella sua
personalità.
Assai rilevanti sono state le influenze che la Scuola Positiva ha avuto sia sulla
criminologia che sulla evoluzione del diritto penale: essa polarizzò l’interesse
sulla personalità del criminale piuttosto che sul fatto delittuoso, promuovendo la
ricerca e lo studio sulle cause individuali della criminalità. Inoltre, l’approccio
con metodologie scientifiche segnò l’inizio delle prime vere scuole
criminologiche, sia di indirizzo individualistico che sociologico.
Anche se codici totalmente ispirati ai principi della Scuola Positiva non sono
mai stati adottati nei paesi europei, l’influenza del pensiero positivistico ha
portato comunque all’introduzione, in molti sistemi giuridici, del principio
secondo il quale andava tenuto conto, nell’irrogare misure penali, oltre che della
gravità del reato, anche della potenzialità criminale del reo.
Ciò si è realizzato secondo due indirizzi:
1) con il sistema del “doppio binario” (Germania e Italia a partire dagli anni
’30) – secondo il quale a fianco delle pene tradizionali, commisurate alla
gravità del reato, venivano disposte anche misure di sicurezza per i
delinquenti ritenuti socialmente pericolosi (malati di mente, plurirecidivi,
soggetti particolarmente aggressivi, delinquenti abituali e professionali) che
si aggiungevano alla pena detentiva. Tali misure erano indeterminate nel
tempo e destinate a durare fino a quando non veniva a cessare la pericolosità;
2) con il sistema della pena a “tempo indeterminato” (USA e paesi scandinavi)
– secondo il quale la durata effettiva della pena non era preventivamente
stabilita dal giudice secondo la gravità del reato ma dipendeva dalle
prospettive di successo del reinserimento sociale, in virtù del buon esito del
trattamento risocializzativo.
Alcune considerazioni in merito ai principi propri della scuola positivista vanno
doverosamente fatti. Innanzitutto una troppo cieca fiducia nelle scienze
dell’uomo e nelle loro capacità di valutazione della pericolosità e la fallacia
delle previsione sulla condotta futura e sulla modificazione della stessa. Si pensi,
ad esempio, alle incertezze di un giudizio di pericolosità fondato
prevalentemente su previsioni comportamentali incerte, su giudizi soggettivi o
meramente intuitivi e non verificabili come pure il rischio di errori e di
arbitrarietà nel valutare, senza possibilità di appello, la persistente pericolosità.
D’altro canto non può sottacersi l’importanza che comunque la Scuola Positiva
ha rivestito in quanto ha promosso anche l’introduzione nel diritto penale del
principio secondo cui le caratteristiche della persona devono entrare in gioco
nella commisurazione e nella scelta della pena, così come del debito conto che
va dato alle condizioni sociali agenti sul reo. Essa ha dunque spinto il pensiero
35
penale moderno verso i principi della individualizzazione della sanzione e del
trattamento individualizzato del delinquente.
28 – Primi indirizzi marxisti in criminologia
Il marxismo, storicamente, è stato il principale fulcro attorno al quale si sono
andati organizzando i movimenti operai e le lotte di classe ispirate al socialismo
e al comunismo e ha dato inizio in tutto il mondo alla contrapposizione fra i due
blocchi politici dei paesi del “socialismo reale” e di quelli capitalisti che ha
caratterizzato il XX secolo.
Già Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), nei loro studi
sociali e politici, si erano o occupati – sia pur marginalmente – anche della
criminalità, sostenendo che il delitto è una diretta conseguenza dell’economia
capitalistica e delle ingiustizie, squilibri e grandi disfunzioni del capitalismo del
XIX secolo. I delinquenti quindi non venivano intesi come appartenenti a quel
proletariato consapevole della propria potenzialità rivoluzionaria che, attraverso
la lotta di classe, avrebbe sconfitto il sistema capitalistico e instaurato la dittatura
del proletariato e la società comunista bensì come facenti parte di quel sottoproletariato più misero e degradato anche moralmente (appunto, le c.d. “classi
pericolose”) che non aveva acquistato coscienza di classe e che alle ingiustizie
sociali sapeva reagire solo con una ribellione individuale, il crimine appunto.
Il primo sistematico studio criminologico di ispirazione marxista è però opera di
Willem Adrian Bonger (1876-1940), che tentò di coniugare il marxismo con il
pensiero positivo allora imperante. Bonger sosteneva che un sistema di
produzione basato sulla concorrenzialità, sull’iniziativa privata e sul profitto
individuale a discapito degli interessi collettivi, era strutturalmente contrario allo
sviluppo di un’etica sociale e di legami di solidarietà e reciprocità . Lo stesso
meccanismo sociale che esigeva spietata concorrenza e antagonismo fra i
singoli, rendeva gli uomini più egoisti e quindi più propensi al delitto. Le
sperequazioni di classe e la diversa disponibilità dei beni materiali e culturali
rendevano più acuto il conflitto fra persone e stimolavano l’aggressività; tutti i
tipi di reati riflettevano i rapporti tra le classi e si manifestavano con maggior
frequenza fra il proletariato solo in funzione del maggior sfavore nelle
condizioni di vita e di un atteggiamento comprensibilmente rivendicativo nei
confronti della società che li emarginava. Se il capitalismo era la causa della
delinquenza, la sua sostituzione rivoluzionaria con un sistema di produzione non
competitivo avrebbe consentito di eliminare il delitto: una prospettiva
evidentemente utopistica che enfatizzava l’importanza dei fattori sociali.
Per quanto attiene agli aspetti positivistici, Bonger riconosceva l’esistenza di
differenze innate tra gli individui, con conseguente diversa propensione alla
violenza e alla delinquenza, ma a suo avviso era solo nell’ambiente sociale che
dovevano essere ricercati i fattori atti a provocare il passaggio dalla potenziale
aggressività di taluni al comportamento criminoso. Trapela qui quel
determinismo sociale che abbiamo visto essere tipico di quel momento storico:
avendo Bonger identificato nel sistema capitalistico la causa fondamentale della
36
criminalità, sostenne di conseguenza che tale causa portava alla impossibilità
concettuale del libero arbitrio e della responsabilità individuale.
Altri autori della scuola socialista, come Turati, Ferri, Colajanni, consideravano
anch’essi la criminalità come strettamente connessa ai fattori sociali, e più
specificamente quale conseguenza del capitalismo.
29 – Integrazione fra approccio sociologico e antropologico
Fino dalle sue origini la criminologia si è andata sviluppando secondo due filoni:
quello sociologico e quello incentrato sull’individuo (antropologico) sorto con la
scuola lombrosiana. Questi due indirizzi si sono affiancati a lungo, spesso
proponendosi in una visione contrapposta nella interpretazione dei fatti
criminosi.
Per l’approccio sociologico, lo scopo principale della criminologia avrebbe
dovuto essere quello di spiegare la delinquenza ricercandone le cause nella
società stessa; per il filone antropologico, la criminologia avrebbe dovuto invece
ricercare che cosa vi fosse di anormale o di diverso nei delinquenti che favorisce
o determina il loro divenire criminali.
La semplicistica attribuzione delle responsabilità del delinquere alla società, così
come all’opposto alle anomalie del singolo soggetto, comporta che in ogni caso
nessuno abbia né merito né demerito per le proprie azioni, e impedisce che la
collettività possa chiedere a ciascuno di render conto della propria condotta.
Solo dunque una visione integrata che tenga conto sia dei fattori sociali (cioè
degli squilibri, delle carenze e delle ingiustizie dell’organizzazione collettiva)
sia, contestualmente, del diverso modo (variabile da individuo ad individuo) di
rispondere ai fattori ambientali sfavorenti e di effettuare le proprie scelte, può
consentire una valutazione serena della condotta criminale e suggerire quegli
interventi sociali e individuali idonei a contenere il suo continuo incremento.
A – TEORIE SOCIOLOGICHE
Nella prima metà del ‘900, mentre in Europa venivano maggiormente coltivati
gli indirizzi individualistici, si sviluppa ampiamente negli USA la sociologia
criminale, che diverrà per un lungo periodo il filone più rigoglioso della
criminologia.
Vediamo in particolare le teorie maggiormente significative.
30 – Teoria delle aree criminali o teoria ecologica
Un approccio incentrato sullo studio della criminalità nelle “aree criminali”venne
iniziato da Shaw (1929) che intraprese nuove e sistematiche indagini in quei
medesimi ambiti urbani maggiormente degradati. Esse vennero proseguite da
quella che prenderà il nome di Scuola di Ghicago e che fu la prima scuola
criminologica specificamente coltivata da sociologi. Questi sociologi indicarono
con il termine di aree criminali quelle zone delle città dalle quali proviene e risiede
37
la maggior parte della criminalità comune. Secondo queste teorie, in ogni grande
agglomerato urbano possono identificarsi zone con particolari caratteristiche
ambientali (da qui il nome di “teoria ecologica”) nelle quali gli abitanti che hanno
avuto a che fare con la legge si trovano in concentrazione molto più elevata che in
altre. Sono queste le zone in cui si concentra un’alta percentuale di persone
bisognose di sovvenzioni assistenziali, dove c’è sovraffollamento nelle abitazioni,
inadeguatezza di pubblici servizi e dove finisce per risiedere la parte più indigente
della popolazione. Condizioni socio-economiche particolarmente disagiate sono una
regola per gli abitanti di queste aree, che presentano anche elevata disoccupazione o
svolgono attività squalificate e precarie. Questi quartieri rappresentano poi un
significativo polo di attrazione per coloro che cercano un ambiente più permissivo e
più adeguato al proprio status di delinquenti abituai ed anche più protettivo perché
non mette ulteriormente ai margini coloro che già sono degli emarginati. La
popolazione di tali aree può risiedervi solo transitoriamente oppure in modo stabile
ma l’avvicendamento degli abitanti non influisce sul tasso di criminalità rilevato che
rimane costantemente elevato: ciò sta ad indicare il significato criminogenetico dei
fattori dovuti alle particolari caratteristiche dell’ambiente sociale.
Per la teoria ecologica, pertanto, l’ambiente di vita è il fattore più importante nella
genesi della criminalità, almeno nelle modalità più squalificate e povere di
delinquenza comune, anche se è ovvia l’importanza di altri fattori, posto che non
tutti coloro che risiedono nelle aree criminali divengono delinquenti, e viceversa
molti delinquenti di buon livello economico risiedono anche in quartieri urbani
normali.
Questa è anche una teoria a “medio raggio” nel senso che non rende certamente
conto di fenomeni più generale: si presta a render conto solamente della
delinquenza comune più povera, della manovalanza delinquenziale.
31. teorie della disorganizzazione sociale
Possono riunirsi in questa comune dizione di “teorie della disorganizzazione
sociale” molteplici studi sociologici che hanno posto l’accento sulle profonde
trasformazioni che la sempre maggiore industrializzazione ha indotto nella struttura
della società nella prima metà del nostro secolo.
Il nucleo originario di questa teoria era costituito dalla polarizzazione dell’interesse
sul mutamento e sull’instabilità provocati dalla industrializzazione e da tutti i
fenomeni ad essa collegati (urbanizzazione, crisi della vecchia struttura patriarcale,
crisi della famiglia) fattori questi che hanno determinato la rottura di molteplici
equilibri sui quali si fondavano i precedenti valori normativi e l’etica sociale.
Il termine “disorganizzazione” non si riferisce quindi alla disfunzionalità dei
pubblici servizi, al cattivo funzionamento delle varie istituzioni pubbliche ma a
qualcosa di più profondo che viene a togliere alla società la capacità di fornire
valori stabili, punti di certezza, capacità di regolare e controllare la condotta dei
singoli.
38
In definitiva, si realizza “disorganizzazione sociale” quando perdono di efficacia
gli abituali strumenti di controllo sociale ed in particolare il controllo di gruppo e
quello familiare.
Secondo questo approccio, il singolo individuo, vivendo in una struttura instabile e
in troppo rapido mutamento, perde la possibilità di governarsi secondo i vecchi
parametri normativi, divenendo egli stesso, come la società, disorganizzato nella sua
condotta.
Questo approccio teorico non è solo rivolto a rendere conto dell’incremento della
criminalità fra gli individui più poveri e più emarginati, come faceva la teorica
ecologica ma fornisce una interpretazione a più largo raggio, idonea a spiegare in
una più ampia prospettiva il dilagare della criminalità anche in altre classi sociali,
ed anche fra coloro che subivano l’influenza della disorganizzazione sociale pur
senza essere afflitti da disagi economici.
Sutherland (1934), ha utilizzato anch’egli il concetto di disorganizzazione sociale,
legandolo, però, più che al mutamento e alla instabilità conseguenti alla espansione
industriale e allo sconvolgimento culturale a esso seguito,piuttosto all’esistenza
nella società di contraddizioni normative. Una società è disorganizzata perché le
norme sono contrastanti e contraddittorie e non assolve pertanto alla sua
fondamentale funzione socializzatrice: di rendere cioè gli individui osservanti delle
norme più cogenti. In pratica, il delitto si verifica perché la società non è
saldamente organizzata contro questa forma di comportamento.
Il conflitto di norme è quindi una delle condizioni più significative nel provocare la
disorganizzazione sociale, dal momento che la coesistenza di regole, leggi e costumi
fra di loro in contrasto riduce grandemente l’efficacia del controllo sulla condotta
dei singoli.
Una sintesi dei più significativi aspetti del conflitto di norme, responsabile della
disorganizzazione sociale e del conseguente incremento di criminalità, è stata
formulata, in epoca successiva, da Johnson (1960). Secondo questo autore, vi è
conflitto di norme:
quando vi sia socializzazione difettosa o mancante – E’ questa la situazione
che si realizza in coloro che, facendo parte di gruppi marginali, possono
essere ambivalenti verso norme legati che, in gran parte, sentono come
estranee o riguardanti solo i diritti delle più favorite fasce sociali piuttosto
che i propri (sono questi gli appartenenti alle sottoculture delinquenziali);
quando vi siano sanzioni deboli e vi è quindi insufficienza di intimidazione
punitiva verso alcuni tipi di azioni delittuose che vengono pertanto
implicitamente incentivate;
quando vi sia inefficienza o corruzione dell’apparato giudiziario o di
polizia – in questo caso le sanzioni contemplate nei codici possono essere
anche severe, ma la loro efficacia è ridotta perché le leggi vengono
scarsamente o per nulla applicate.
39
Il conflitto e la contraddizione delle norme accentuano notevolmente il carattere di
instabilità degli strumenti del controllo sociale e costituiscono pertanto
un’importante causa di disorganizzazione sociale e di delinquenza.
32 – Teoria dei conflitti culturali
La teoria dei conflitti culturali venne sottolineata da Sellin (1938) che vide nella
contrapposizione in un medesimo individuo di sistemi culturali differenti una delle
principali cause del venir meno degli abituali parametri regolatori della condotta
sociale con conseguente facilitazione alla devianza e alla delinquenza.
Sellin, per l’elaborazione della sua teoria, prese l’avvio dall’analisi dell’imminente
flusso immigratorio verificatosi nei primi decenni del 1800 verso gli USA quando,
per le esigenze del grande sviluppo industriale di quegli anni, vennero aperte le
frontiere agli emigranti provenienti da molti paesi europei.
Egli notò:
che alcuni valori normativi dell’immigrato si trovavano in contrasto con
quelli della società ospitante – il persistere dei valori della cultura di origine
poteva provocare conflitto con quelli nuovi non ancora assimilati e
indebolire così quegli autocontrolli che assicuravano in precedenza un
comportamento onesto;
il partecipare a due sistemi culturali differenti provocava una situazione di
disagio, di insicurezza, esponendo l’individuo al rischio di ogni tipo di
disadattamento, dalla malattia mentale alla criminalità;
ad essere soggetti a comportamenti devianti non erano tanto i neoimmigrati
quanto quelli di seconda generazione, cioè i loro figli – tutto ciò venne
interpretato nel senso che il conflitto tra i due sistemi di cultura era più aspro
per i giovani perché avevano perduto di significato i contenuti normativi
della cultura di origine (ancora validi per i padri) senza che fossero stati
ancora assimilati costumi e valori del paese ospitante.
Sellin distinse inoltre:
i conflitti culturali primari – risultanti dal disagio e dalle incertezze che il
singolo individuo viveva per l’attrito diretto fra due sistemi culturali troppo
differenti;
i conflitti culturali secondari – dovuti alla discriminazione e al rigetto da
parte della società ospitante nei confronti di quegli individui estranei e
“diversi”, da troppo poco tempo entrati a far parte del loro contesto sociale.
Sellin inoltre mise in evidenza che per aversi condotta integrata è necessario che vi
sia sintonia fra i valori normativi del gruppo di appartenenza e quelli di cui la legge
è espressione: se, infatti, le prescrizioni della norma legale nei confronti di tale
condotta non si accompagnano alla “opposizione del gruppo” (perché i gruppo vive
valori devianti rispetto a quelli legali) l’intimidazione della legge è inefficace. Le
norme penale, infatti, una volta interiorizzate vengono a costituire una componente
della coscienza morale dell’individuo ma ciò non è sufficiente ad evitare
40
comportamenti delittuosi se contemporaneamente non vi è l’appoggio e la
solidarietà nello stesso senso da parte del gruppo di appartenenza.
33. Struttural-funzionalismo e teoria della devianza
Il concetto di devianza ha avuto un peso notevole nel successivo pensiero
sociologico.
Questo concetto ha visto l’inizio della sua fortuna nell’ambito di una vasta scuola
sorta negli USA negli anni ’30: lo strutturalfunzionalismo. Premesso che per
struttura si intendono tutti i rapporti esistenti fra le persone all’interno di una
data società, l’aspetto funzionale è rappresentato dalla necessità per la
sopravvivenza di ogni sistema sociale che la struttura consenta di perseguire lo
scopo fondamentale che il sistema si propone, e che è costituito dalla integrazione
dei singoli attori sociali, così da assicurare il mantenimento, la stabilità e la
coerenza del sistema stesso.
Secondo questo indirizzo, i cui maggiori rappresentanti sono stati Parsons (1937),
Merton (1938) e più tardi Johnson (1060), i soggetti che agiscono nella società (gli
attori sociali) regolano il comportamento fra le persone e i gruppi in funzione di un
complesso sistema di norme che vengono, consapevolmente o inconsciamente, fatte
proprie da ciascuno: il comportamento sociale, in funzione della osservanza o della
non osservanza delle norme, si viene pertanto a collocare fra le due opposte
alternative della conformità e della devianza.
Conformità - è lo stile di vita che è orientato e coerente con l’insieme delle norme
(siano esse espresse dalle leggi codificate ovvero da regole del costume, dagli usi,
dalle tradizioni, ecc.): conforme è pertanto una condotta che rientra nella gamma
dei comportamenti permessi e generalmente accettati. La conformità è una scelta
psicologgizzata, che viene cioè a far parte della personalità dei singoli, e che rientra
fra le motivazioni ad agire anche se non sempre l’attore conosce esattamente o in
dettaglio l’insieme normativo: esiste però una precisa consapevolezza che rende
ciascuno costantemente informato della conformità o non conformità della sua
condotta. Questa conoscenza è il frutto dei processi di socializzazione e l’essere
conformi è il risultato di una socializzazione ben riuscita. Ciò si realizza attraverso
l’educazione (esempio, imitazione o insegnamento esplicito) ma anche attraverso
meccanismi psicologici complessi quali la identificazione (cioè col rendersi simili a
taluni soggetti eletti a propri modelli assumendone i valori morali e normativi) e la
interiorizzazione (cioè con l’includere nella propria coscienza norme e principi che
vengono così a costituire parte integrante della personalità di ciascuno).
Il rafforzamento e il mantenimento della conformità è poi favorito dai sistemi di
controllo sociale cioè da quell’insieme di strutture e istituzioni che consento a ogni
attore sociale di conoscere le conseguenze (pene giudiziarie o sanzioni non legali
dei gruppi quali il rimprovero, l’ostracismo e l’emarginazione) della non osservanza
delle norme.
L’ideologia, intesa quale fondamentale contenuto della cultura, contiene i valori
generali che le norme sanciscono e questi valori motivano i consociati a
conformarsi alle regole.
41
La conformità alle norme sociali del proprio momento non è garantita solo dai
valori ideologici e dal timore delle sanzioni ma anche dagli interessi costituiti, cioè
dai vantaggi legittimi che il rispetto delle norme comporta.
Pertanto, riassumendo, possiamo dire che nella genesi del comportamento conforme
possono distinguersi:
il momento dell’apprendimento delle norme – che si realizza tramite i
processi di socializzazione e attraverso i continui contatti fra persone e
gruppi;
la fase del mantenimento e del rinforzo dell’apprendimento normativo –
che è attuata dai vari strumenti di controllo sociale, dalla minaccia di
sanzioni, dall’ideologia, dagli interessi costituiti.
La devianza è la condizione opposta alla conformità. Si tratta di un concetto molto
più ampio rispetto a quello di delinquenza dato che ricomprende sia le condotte che
violano le norme penale (cioè i delitti) sia quelle contrarie alle semplici regole
sociali generalmente accettate. Vi è però devianza solo quando la violazione è
frutto di una precisa scelta e non è accidentale e solo quando lo violazione
avviene nei confronti di una norma verso la quale l’attore è orientato (cioè che
non ha perso per lui di significatività).Non è dunque deviante chi viola la norma
per mero caso o quando infrange una regola disattesa da tutti.
Ogni comportamento deviante presuppone pertanto nell’attore sociale un
atteggiamento di ambivalenza nei confronti della norma: ciò significa che il
deviante deve da un lato conoscere la persistente imperatività di quella norma ma
d’altro canto egli non ne accetta l’autorità normativa.
Pertanto, possiamo concludere affermando che nella prospettiva della sociologia
struttural-funzionalista, la devianza non è ogni condotta che violi alcune delle
innumerevoli regole che una data cultura contiene ma solo il mancato rispetto di
quelle norme che conservano ancora credibilità e che vengono ritenute più
importanti.
34 – l’anomia come causa di devianza
Allo struttural-funzionalismo va riconosciuto il merito di aver inteso fornire una
teoria sulle cause della devianza avvalendosi del concetto di anomia.
Ogni società pone dei limiti, con le norme legali o culturali, al soddisfacimento
delle aspirazioni degli individui, stabilendo quali siano i mezzi che possono essere
legittimamente impiegati per soddisfarle. Quando una società è strutturata in modo
stabile e armonico, i limiti e le norme sono percepiti e accettati come giusti: un
mutamento di rilievo nella compagine sociale, mette però in crisi taluni valori
normativi e comporta un minor rispetto di essi. Pertanto, quando le norme perdono
di credibilità, la condotta di molti individui sarà più facilmente orientata in
dispregio di esse e questa perdita di credibilità delle norme configura appunto lo
stato di anomia di un certo contesto sociale.
42
L’anomia si realizza dunque quando le regole, che in altri momenti si mostravano
idonee ad assicurare la condotta socializzata dei membri, perdono la loro efficacia
cosicché gli attori sociali si vengono a trovare in una condizione di particolare
difficoltà, dovuta proprio alla carenza dei necessari parametri di riferimento
normativo: si genera quindi disagio se le regole non sono più adeguate, se hanno
perso di credito, se pur essendo formalmente ancora presenti sono nella sostanza
divenute prive di significato.
Il temine di anomia era già stato introdotto in sociologia da Emile Durkheim
(1858-1917) all’inizio del ‘900 col significato di frattura delle regole sociali. In
particolare, egli intendeva la particolare situazione che si instaura in certe società e
che ingenera, in un elevato numero di soggetti, disagio e condotta dissociale. Per
Durkehiem causa dell’anomia era essenzialmente la iperstimolazione delle
aspirazioni che la società industriale ha indotto, e quindi nell’insofferenza verso i
sistemi di controllo che tendono a limitare le aspirazioni stesse: il difetto di quella
società sarebbe stato nel non aver saputo porre limiti alle domande dei vari gruppi
sociali. Il mito del successo, il miraggio dell’ascesa economica sempre più rapida,
hanno provocato irrequietezza, esasperazione, frustrazione e malcontento: ciò è
stato causa della rottura delle regole sociali, ovvero, anomica: che non vuol dire
pertanto assenza di norme bensì significa contraddizione, incoerenza, ambivalenza e
ambiguità delle norme stesse.
Robert Merton, negli anni ’30, ha fornito della devianza una nuova teoria.
L’anomia è intesa infatti come la conseguenza di una incongruità fra le mete
proposte dalla società e la realtà possibilità di conseguirle: una società ha
caratteristiche di anomia quando la sua cultura propone delle mete senza che
vengano a tutti forniti i mezzi per conseguirle. Questa teoria è incentrata dunque
sulla antinomia dinamica tra mete e mezzi legittimi per conseguirle. Le mete sociali
possono intendersi come le prospettive che la cultura di un certo momento pone
come prioritarie ai suoi membri, come quell’insieme di obiettivi verso i quali
debbono tendere le aspirazioni di tutti, obiettivi che sono nello stesso tempo
ideologici, morali e materiali. Naturalmente, con il variare delle società variano
anche le mete che la cultura di ciascuna società propone come fondamentali, come
più meritorie e qualificanti. Pertanto, le società, per non produrre frustrazioni,
debbono mantenere un buon equilibrio tra le norme e le mete istituzionalmente
suggerite e devono offrire la possibilità di raggiungere le mete con i mezzi legittimi
che vengono prescritti o forniti. La società industriale, ad esempio, ha come
caratteristica l’imperativo di non accontentarsi del proprio status e di mirare a
traguardi sempre più elevati ma se ciò può essere inteso come una delle ragioni
degli enorme progressi materiali compiuti vi è contestualmente insita una elevata
fonte di ansietà e di frustrazione dato che non è facile, per chi parta da condizioni
sociali svantaggiate soddisfare questo imperativo con mezzi legittimi. Pertanto, la
disuguaglianza nelle opportunità di successo sociale stimolano la non osservanza
delle norme che regolano le modalità lecite per conseguire le mete proposte dalla
cultura. Nella nostra società non troviamo solo frustrazione individuale ma anche un
più ampio fenomeno che implica un diverso atteggiamento di interi gruppi sociali
nei riguardi delle orme. Tale teoria, però, non è in grado di risolvere il problema
43
psicologico del perché alcuni individui siano più sensibili e altri meno alle influenze
anomiche.
Merton ha anche individuato le diverse modalità di reagire alla condizione anomica
(peraltro, Merton on considera la devianza come conseguenza delle differenti
caratteristiche psicologiche o di anomalie delle personalità ma come frutto di fattori
insiti nella stessa struttura sociale. Dunque, abbiamo:
1) un comportamento di conformità – che risulta tanto più agevole e tanto meno
ansiogeno e frustrante quanto maggiori sono le opportunità di successo
offerte dal proprio status.
2) Un comportamento deviante che, a seconda di come viene risolta l’antinomia
fra le mete poste dalla cultura e i mezzi impiegato per conseguirle, può
essere così manifestato:
a. Innovazione – che si realizza quando l’attore sociale è orientato verso
i fini proposti dalla cultura, mira a raggiungerli ma per ottenerli non si
pone problemi circa il carattere eventualmente illegittimo dei mezzi
impiegati. Costoro diventano delinquenti trovandosi a essere
osservanti dei fini ma non dei mezzi per conseguirli.
b. Ritualismo – questo tipo di devianza sui generis, si realizza quando
permane il rispetto per le norme e vi è invece rifiuto di ricorrere ai
mezzi illegittimi anche se ciò comporta la rinunzia a perseguire le
mete del successo sociale. Esiste in questo modo devianza solo
perché vengono mortificate le aspirazioni, ci si accontenta di ciò che
si ha.
c. Rinunzia – è la devianza che si realizza quando vengono persi di
vista sia i fini che i mezzi, cioè quando si rinunzia a raggiungere i fine
dell’ascesa economica o del successo ma nello stesso tempo non vi è
rispetto delle norme istituzionali. E’ questa la devianza di chi cessa di
combattere, dei vagabondi, dei drogati, dei derelitti: si tratta di
persone che in varia modalità infrangono le regole legali ma nelle
quali il mancato rispetto delle norme non serve a migliorare il proprio
status.
d. Ribellione – è la devianza caratterizzata dalla sostituzione delle mete
culturali con mete diverse, da un rifiuto globale della società e,
pertanto, anche delle regole circa l’uso dei mezzi illegittimi. Il ribelle,
l’anarchico, il contestatore assumono un sistema di valori del tutto
alieno e contrapposto a quello della cultura dominante e si
propongono di conseguire un sistema sociale e culturale alternativo.
35. Teoria delle associazioni differenziali
Negli anni ’30, Sutherland elabora una nuova teoria sociologia che
prese il nome di “teoria delle associazioni differenziali”.
44
Tale teoria ha come suo carattere distintiva il principio che il
comportamento delinquenziale è appreso: poco importerebbe pertanto nel
divenire delinquenti la psicologia dei singoli individui.
La delinquenza non viene appresa per semplice imitazione bensì
mediante l’associazione interpersonale con altri individui che già si
comportano da delinquenti. L’apprendimento della condotta criminosa è
in relazione pertanto con i tipi di persone con le quali si viene a contatto,
con il tipo dei loro valori, mediante un processo di comunicazione
analogo, ma di segno opposto, a quello tramite il quale si apprende il
rispetto delle norme legali.
Il termine “dissociazione differenziale” non deve essere inteso come una
sorta di società di fatto ma come semplicemente partecipazione a certi
gruppi sociali “differenti” dagli altri per la loro abituale indifferenza nei
confronti della legge.
Questa teoria venne proposta da Sutherland come schema per una teoria
generale della criminalità, una teoria eziologica capace di render conto di
tutti i tipi di condotta criminosa – non solo quella delle classi sfavorite ma
anche di quella imprenditoriale e professionistica – e del perché,
nonostante la presenza di analoghe opportunità, si verificano orientamenti
differenti da un individuo all’altro circa il rispetto o meno della legge, in
funzione della frequentazione appunto di gruppi inosservanti della legge
penale.
Una persona è dunque favorita nella scelta delinquenziale a parità di
condizioni economiche e sociali, quando si trova inserita in un gruppo
ove prevalgono definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto
a quelle sfavorevoli.
Di conseguenza, ora è chiaro che sia i valori etici che le tecniche per
compiere i delitti devono essere necessariamente appresi da altre persone.
Non esisterebbe dunque una criminalità innata, ma si imparerebbe ad
agire criminalmente assimilando i modelli di comportamento
delinquenziale proposti da un certo ambiente, sempre che questi
prevalgano sui modelli di condotta integrata.
Però non tutti i gruppi con i quali si è via via in contatto hanno la stessa
capacità di influenzare la condotta: fra i vari ambienti di cui un individuo
si trova a far parte, avranno più elevata capacità di orientare la condotta
quelli che vengono frequentati con maggiore intensità; quelli nei quali i
rapporti hanno maggiore priorità (in quanto i membri godono per il
soggetto di maggiore prestigio), quelli dove i rapporti hanno maggiore
durata e, infine, quelli che per anteriorità si sono proposti come modello
in epoca più precoce e in età più giovane.
L’associazione soggettivamente percepita come più importante, che viene
più frequentata, che è inoltre più duratura e anteriore, è quella da cui più
facilmente verranno appresi ideali, valori e tecniche di condotta: se questa
45
associazione sarà di tipo delinquenziale, si apprenderà uno stile di vita
criminoso.
Analiticamente possiamo dunque puntualizzare che:
1) il comportamento criminale è un comportamento appreso;
2) tale comportamento è appreso attraverso il contatto con altre persone
e per mezzo di processi di comunicazione;
3) esso è appreso all’interno di dirette relazioni interpersonali;
4) si apprendono anche le tecniche necessarie al compimento del reato,
le valutazioni e le attitudini nei confronti del crimine;
5) si diventa delinquenti quanto le interpretazioni contrarie rispetto alla
legge sono in un dato ambiente prevalenti rispetto a quelle favorevole;
6) le associazioni differenziali possono variare in rapporto all’intensità,
alla priorità, alla durata, alla anteriorità del “contagio”;
7) il processo di apprendimento del comportamento criminale implica gli
stessi meccanismi che verrebbero chiamati in causa in qualsiasi altro
tipo di apprendimento.
Il fatto che Sutherland si sia sforzato di costruire una teoria eziologia per spiegare
cioè ogni forma di criminalità non significa che egli ignorasse del tutto la possibilità
dell’intervento di altri fattori nell’eziologia del crimine e, anzi, li indicò nelle
opportunità, nell’intensità del bisogno, nella possibilità che vengano proposte
alternative al comportamento criminoso e, soprattutto, nella disorganizzazione
sociale. Egli era comunque convinto della necessità di ricondurre tutti gli elementi
criminogenetici in una unica teorica.
Però, se certamente è condivisibile l’assunto secondo cui le tecniche e gli
atteggiamenti criminali devono essere appresi, è difficile però condividere il
principio secondo cui tutte le forme di criminalità debbano essere necessariamente
apprese, secondo lo schema fornito da questa teoria. Del tutto insufficiente appare
infatti questo tipo di spiegazione per rendere conto della criminalità aggressiva o
d’impeto o di quello su base emotivo-passionale, agita dai singoli.
Altri appunto che si possono muovere alla teoria delle associazioni differenziali
sono:
o essa si mostra del tutto carente dal punto di vista dell’indagine psicologica in
quanto trascura il problema della “risposta differenziale” che si pone a livello
personale;
o non piega l’invenzione di nuove condotte delittuose mai utilizzate in
precedenza o anche di quella criminalità che si manifesta spontaneamente,
senza precedenti contatti con associazioni differenziali;
o è portatrice di un determinismo piuttosto rigido in quanto le motivazioni e le
tecniche attraverso cui si delinque sembrano apprese all’interno di un
46
ambiente in cui l’attore gioca un ruolo per lo più passivo, senza che gli siano
possibili, in apparenza, altre alternative.
Un indiscutibile merito di Sutherland (condiviso con la teoria dell’anomia di
Merton) è comunque quello di avere infranto l’equazione secondo la quale la
delinquenza sarebbe sempre e solo strettamente collegata all’indigenza e alle
condizioni sociali favorevoli.
36. Sutherland e la criminalità dei “colletti bianchi”
Sutherland va ricordato non solo per la teoria delle associazioni differenziali ma
anche, e soprattutto, perché per la prima volta ha indirizzato i suoi studi verso un
settore di delinquenza che era stato fino ad allora trascurato cioè quello dei reati che
vengono compiuti dai dirigenti delle imprese industriali, finanziarie, commerciali e
dai professionisti.
Egli infatti aveva notato che in certi ambienti professionistici ed imprenditoriali
prevalevano le definizioni favorevoli alla violazione della legge; ovviamente le
infrazioni che vengono commesse in tali ambienti sono ben diverse da quelle delle
sottoculture dei delinquenti comuni, ma pur sempre si tratta di reati (evasioni fiscali,
frodi nei bilanci, illeciti del commercio, bancarotta fraudolenta, furto di brevetti
ecc.). Queste sue osservazioni sono state pubblicate nel 1940 nella sua prima opra
dedicata ai delitti commessi da individui dal ruolo prestigioso “White Collar Crime”
e, nonostante il tempo trascorso, conservano la loro importanza storica in quanto
aprirono la strada alla questione del “numero oscuro” e, più tardi, all’epoca della
criminologia critica di sinistra che doveva affermarsi un ventennio dopo divenendo
punto di partenza fondamentale per i filoni criminologici incentrati sulla tematica
dei conflitti di classe.
Caratteristiche della delinquenza dei wcc sono date dal fatto che:
o questa delinquenza si realizza negli stessi ambienti ove si producono beni e
servizi ed è strettamente connessa ai processi stessi di produzione di tali
servizi e beni;
o non si tratta di delinquenza parassitaria come quella comune nel senso che si
procurano ricchezza con i reati ma senza produrre alcun legittimo beneficio;
o il suo costo sociale è rilevante perché questi reati compenetrano moltissimi
settori delle operatività produttive;
o l’indice di occultamento di questi reati è molto elevato essendo essi
facilmente mascherabili e per loro natura di difficile identificazione;
o gli autori di questi delitto godono di un elevato tasso di impunità in quanto
rivestono posizioni influenti e spesso godono di connivenze con aree del
potere politico e giudiziario;
o è minore la reazione sociale di censura nei loro confronti e ciò traspare
dall’uso di aggettivi quali “disonesto” piuttosto che “criminale”. Ciò
significa che il colletto bianco non viene associato allo stereotipo del
delinquente da parte della collettività e tale inoltre egli non si reputa. Lo
47
stigma del “criminale” è diventato una sanzione di per sé che può
accompagnarsi ad altre sanzioni o essere del tutto evitato;
o per chi compie delitti di questo tipo perdono di significato tutti quei fattori di
anomalia di personalità e di sfavore sociale che tanto hanno occupato la
criminologia impegnata nello studio dei delitti comuni;
o per configurare questo specifico tipo di delinquenza, è fondamentale la
tipologia dei reati commessi, che devono essere strettamente connessi alle
attività di produzione di beni o servizi.
37 . Gli sviluppi dell’indirizzo individualistico e la criminologia clinica (anni
’50)
Un punto di riferimento importante nello storico sviluppo della criminologia è
rappresentato dalla fine della seconda guerra mondiale. Infatti, prima della guerra,
la sociologia criminale non era ancora caratterizzata da coloritura politica cosa che,
invece, è accaduta dopo quando il mondo è stato diviso in due campi ostili da una
contrapposizione ideologica e politica che ha coinvolto la cultura, gli intellettuali e i
cittadini, divisi tra seguaci del primo o del secondo modello.
Di conseguenza, a partire dagli anni ’50, la criminologia, non solo continua a
svilupparsi secondo i due filoni di base - antropologico e sociologico – ma si
bipartirà ulteriormente secondo i due filoni ideologici che si erano imposti in quegli
anni nella politica così come nella cultura: si è avuta così una criminologia di
sinistra, di ispirazione marxista, incentrata sulla critica della società capitalista
ritenuta matrice fondamentale della criminalità ed una criminologia di destra,
ideologicamente vicina alla socialdemocrazia, che analizzerà le relazioni fra la
classe sociale e la criminalità rimanendo pur sempre sintonica con i valori di
democrazia e di libertà dei paesi occidentali.
L’indirizzo individualistico (o antropologico)
E’ stato quello che fra i due ha subito la minore influenza rispetto alla coloritura
politica ma è divenuto il cardine di una nuova politica penale incentrata sulla
risocializzazione dei delinquenti che è rimasta valida fino ai nostri giorni. In questo
filone individualistico, si sono andate articolando scuole polarizzate sulla ricerca
delle caratteristiche che, nei singoli autori di reati, potessero assumere significato di
“causa” per rendere conto del comportamento delittuoso. Di conseguenza, a
seconda degli interessi dei singoli cultori, si sono sviluppate ricerche volte allo
studio delle infermità organiche, delle diversità di costituzione, dei fattori ereditari
ma è stato soprattutto l’orientamento psicogenetico che, specialmente ispirandosi ai
principi della psicoanalisi, doveva rivolgere l’indagine sui vari meccanismi psichici
che possono rendere conto dei comportamenti criminosi. E’ stato così che si è
sviluppata una criminologia del passaggio all’atto, che cercherà di spiegare perché
taluni individui, a parità di circostanze e di ambiente, scelgono una condotta
criminosa mentre altri no.
Le teorie individualistiche trovarono il loro momento di confluenza operativa in
quella che prese il nome di criminologia clinica. Uno dei primi cultori è stato
48
Benigno di Tullio (1896-1979) al quale va anche il merito di aver mantenuto vivi
gli interessi criminologici in Italia anche durante il fascismo.
Nella prima metà degli anni ’50, Di Tullio iniziò la trasposizione in ambito
criminologico delle finalità e delle criteriologie del metodo clinico della medicina.
La criminologia clinica venne concepita come disciplina volta allo studio non tanto
dei fenomeni generali della delinquenza ma del singolo delinquente a fini
diagnostici, prognostici e terapeutici, cioè di trattamento individualizzato per
finalità risocializzativa. Parallelamente, lo studio clinico di un elevato numero di
soggetti avrebbe permesso la elaborazione di nozioni e concetti di carattere
generale, così da costruire un sapere che, in chiave eziologia, identificasse le cause
individuali (e anche microsociali) responsabili della commissione del reato.
L’opera di Di Tullio è stata poi importantissima in quanto ha realizzato una stretta
collaborazione tra diritto penale e criminologia. Se, infatti, la giustizia penale
mantiene una funzione principale nel meccanismo di lotta alla criminalità, alla
criminologia clinica spetta il compito di attuare la prevenzione speciale, attraverso
l’osservazione scientifica del reo. Infatti, se si vuole applicare il criterio della
individualizzazione della pena è imprescindibile la conoscenza in senso biologico,
psicologico e sociale della personalità del singolo delinquente. Intervento medicocriminologico che poi dovrebbe proseguire nella fase di trattamento del condannato
in carcere per rimuovere le carenze fisio-psichiche che sarebbero distintive della
personalità del delinquente.
La criminologia clinica rappresenta dunque il momento della utilizzazione operativa
delle conoscenze mediche psichiatriche e psicologiche relative alla personalità
dell’individuo e al suo ambiente microsociale, per intervenire in senso terapeutico al
fine di “curare” la criminalità, per cercare cioè di eliminare le cause individuali del
comportamento criminoso.
Il fine operativo di questo indirizzo appare tuttora quello d rimuovere i più
immediati fattori psichici e ambientali favorenti il persistere della condotta
delinquenziale, e di intervenire in definitiva al fine di indurre il delinquente ad
assumere un ruolo integrato.
La criminologia clinica si caratterizzerebbe in senso politicamente conservatore:
agirebbe cioè in modo funzionale al sistema dato, lasciando immutate le
contraddizioni sociali e cercando solo di fare accettare ai criminali una struttura
sociale che andava invece, secondo il loro orientamenti, radicalmente rinnovata.
38 - La Nuova Difesa Sociale e la politica penale della risocializzazione
Nel secondo dopoguerra, si costituì un movimento di opinione da cui dovevano
prendere forma le tendenze configuranti la dottrina della Nuova Difesa Sociale.
Antecedenti di tale orientamento possono essere considerati, sul piano ideologico e
giuridico, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU e le
numerose rinnovate Costituzioni che in quegli anni, in molti paesi, si pronunciarono
contro la pena di morte e posero i principi di una politica penale e penitenziaria che
voleva essere anche un intervento sociale.
49
Tali contenuti ideologici propri dei paesi occidentali verranno a riflettersi anche
sulla percezione della criminalità e si tradurranno in un nuovo programma di
politica penale che va ricollegato a un fondamentale principio sociale già da qualche
anno introdotto nel mondo occidentale, cioè l’ideologia del Welfare State
(introdotta da Roosevelt nel 1932 come risposta alla grande crisi economica di
quegli anni e poi fatto proprio, in Europa, dal riformismo socialdemocratico).
Secondo questo principio, lo stato non può disinteressarsi delle difficoltà dei meno
abbienti, che in precedenza non coinvolgevano la collettività e che venivano
affrontate solo con le istituzioni umanitarie e di mutua assistenza. Lo stato, in
questa ottica, dove farsi carico di assicurare a tutti i cittadini i beni materiali
fondamentali e garanzie di sicurezza e benessere. Fra le garanzie che lo stato deve
offrire vi è anche quella di fornire a chi ha compiuto reati gli strumenti per essere
risocializzato così da poter nuovamente fruire di un normale assetto sociale. La
rieducazione socializzativa – da realizzare attraverso gli strumenti risocializzativi
della criminologia clinica - costituisce dunque un nuovo diritto del cittadino e un
nuovo impegno dello stato.
In questo clima culturale, politico e giuridico, deve essere ricordata l’opera di
Filippo Gramatica, che tentò di riproporre i principi della Scuola Positiva e che
trovò espressione compiuta nei “Principi di difesa sociale”, pubblicato nel 1961. Per
l’autore, la difesa sociale si concreta in una sostituzione del diritto repressivo con
un sistema penale non punitivo di reazione contro l’antisocialità. Tale sistema
avrebbe dovuto escludere ogni riferimento al principio di punizione e conferire allo
stato il solo dovere di recuperare l’individuo allo società, negandogli quello di
punire. Sarebbe caduta, seguendo questi principi, ogni distinzione fra pena e misura
di difesa sociale (misura di sicurezza) posto che la giustizia non avrebbe avuto se
non lo scopo della risocializzazione del delinquente.
Contro questa dottrina estremistica e utopistica, reagirono i propugnatori di
posizioni pur sempre riformative del diritto penale ma di ispirazione moderata e
realistica, che raccoglieranno i maggiori consensi in seno alla Società Internazionale
di Difesa Sociale. L’opera che meglio interpreta queste esigenze e che dà il nome
all’intera corrente di pensiero è “Nuova Difesa Sociale”, di Marc Ancel, pubblicata
nel 1954. Tra i più interessanti asserti di questo movimento vi è senz’altro il rifiuto
del determinismo degli indirizzi sia antropologici che sociologici. Coloro che
hanno aderito a questa corrente di pensiero rivalutano la nozione di libero arbitrio,
in cui peraltro il riconoscimento della libertà e responsabilità dell’individuo deve
tener conto della concreta realtà umana e sociale in cui egli si trova a vivere e
quindi degli eventuali condizionamento economici e ambientali a cui ciascuno è
esposto. La Nuova Difesa Sociale parla di doveri dell’uomo verso i suoi simili e di
risocializzazione come presa di coscienza di una morale sociale vincolante. La
politica penale, pertanto, impone allo Stato precisi doveri tra cui l’obbligo di
reintegrare l’individuo che ha commesso il reato in una comunità sociale che non
sia oppressiva cui corrisponde il “diritto alla socializzazione” da parte dei cittadini.
Non si tratta quindi di sopprimere (come era stato per i positivisti) il diritto penale
come sistema o di abbandonare l’apprezzamento giuridico-penale del delinquente, e
nemmeno di sopprimere la sanzione penale retributivo sostituendola con la misura
di difesa sociale quale strumento preminente della giustizia penale. La Nuova
50
Difesa Sociale tende solo ad adeguare la reazione anticriminale ai bisogni congiunti
dell’individuo e della società, oggetti e soggetti, insieme, della protezione sociale.
Essa in definitiva tradusse in principi di politica penale i contenuti ideologici del
Welfare State.
39 – Criminologia del consenso
Sempre negli anni ’50 e ’60, oltre ai filoni della criminologia più connotati
politicamente (criminologia di destra e criminologia di sinistra>) un nutrito gruppo
di teorie sociologiche, pur sottolineando gli inconvenienti delle sperequazioni
sociale del capitalismo, non assunse posizioni ideologiche radicali. Questi filoni,
emblematicamente rappresentati dalla sociologia strutturl-funzionalistica, si
fondano sull’assunto che le norme sono suffragate dal consenso della maggioranza
dei consociati, in una visione della società in cui valori e interessi trovano il
supporto di una larga accettazione: solo i devianti e i delinquenti, con la loro
condotta inosservante delle norme, sono intesi come una sorta di elemento
patologico che devia appunto da un sistema nel suo complesso accettato. Anche se
la prospettiva ideologica di queste teorie era pur sempre la denuncia dei fattori
criminogeni insiti nelle discriminazioni sociali, il mezzo per provi rimedia doveva
essere quello delle riforme e non della sovversione rivoluzionaria. A questi filoni e
a queste teorie sociologiche è stato attribuito il nome di criminologia del consenso
dal momento che la sua prospettiva, sul piano pragmatico e della politica penale, è
ovviamente quella di ricondurre i devianti e i delinquenti alla conformità e quindi al
consenso.
Nell’ambito della criminologia del consenso, vanno collocati tutti gli indirizzi
antropologici e individualistici miranti ad identificare le peculiari caratteristiche
degli individui che commettono reati, caratteristiche che verranno valutate quali
cause della loro condotta criminosa, secondo la prospettiva della criminologia
eziologia, o quali fattori di vulnerabilità individuale favorenti, se non determinanti,
le scelte criminose.
Particolare rilievo va riservato in questa prospettiva alla criminologia
pragmatistica, che ha spostato l’accento dalla ricerca di cause o di fattori favorenti
individuali e/o sociali a quello degli interventi operativi. Il più noto esponente di
questo indirizzo è rappresentato da Leo Radzinowicz (1966) che parte dal rifiuto
degli approcci unifattoriali affermando che non esiste una singola causa della
criminalità ma solo un insieme di fattori che coerentemente concorrono in un
sempre fitto reticolo di embricazioni vicendevoli: fattori a loro volta mutevoli nelle
singole fattispecie di condotte criminose e sempre variabili col continuo mutare
delle circostanze sociali. Scopo della criminologia deve essere pertanto quello di
fornire conoscenze sempre più ampie, idonee a essere utilizzate a fini pratici per
adeguare i provvedimenti legislativi, gli strumenti istituzionali e il trattamento dei
criminali a una mutevole realtà in costante modificazione.
Traggono da qui origine le teorie multifattoriali che ebbero appunto come
obiettivo quello di integrare la conoscenza dei fattori criminogenetici ambientali
con quelli individuali.
51
40
–
Teorie
multifattoriali
(individuo/ambiente)
dell’integrazione
psico-ambientale
L’opportunità di considerare congiuntamente l’individuo e il suo contesto sociale
caratterizza l’indirizzo della integrazione individuo/ambiente tipico delle teorie
multifattoriali che sono state formulate negli anni ’50 e ’60 e che si collocano nel
filone della criminologia del consenso, prive come sono di contenuti ideologici e
politici per privilegiare piuttosto un approccio teorico dal contenuto il più possibile
fattuale e oggettivo.
Obiettivo fondamentale è quello di fornire una spiegazione alla constatazione che
non tutti gli individui reagiscono con analoghe risposte comportamentali ai fattori
criminogenetici legati al loro ambiente e alle loro condizioni socio-economiche e,
viceversa, individui con uguali caratteristiche abnormi di personalità non divengono
per ciò solo delinquenti.
Le teorie dell’integrazione hanno per l’appunto cercato di considerare
contestualmente i vari fattori criminogenetici individuali, somatici e/o psichici,
capaci di rendere conto della “risposta differenziale” ad analoghe spinte
criminogenetiche – indicandoli come componenti di vulnerabilità individuale nei
confronti di sollecitazioni provenienti dall’ambiente – ed integrandoli con le
componenti di vulnerabilità ambientale, legate ai vari handicap sociali ai quali i
singoli soggetti sono esposti.
40.1 – Teoria non direzionale dei Glueck
La teoria dei coniugi Glueck si è proposta di identificare i fattore familiarisituazionali e quelli individuali che sono più frequenti nei giovani criminali. Questi
fattori sono emersi, mediante ricerche e controlli protrattisi per circa 20 anni (19501971), dal controllo di due gruppi di minorenni, l’uno composta di giovani che
avevano commesso delitti e l’altro di coetanei che avevano avuto condotta normale,
così da poter analizzare, a parità di condizioni, in cosa differivano i delinquenti dai
non delinquenti. Il gruppo dei delinquenti e dei non delinquenti, poi, vennero divisi
in coppie che avevano in comune la residenza in zone povere e periferiche, l’età, il
livello intellettivo e la razza: così potevano essere neutralizzati i fattori che di per sé
solo già si sapeva aver efficienza nel favorire la delittuosità e poter scoprire cosa era
intervenuto a far in modo che uno divenisse delinquente e l’altro no.
Il perché del diverso comportamento sociale venne identificato nelle diverse
caratteristiche di personalità e dell’ambiente familiare di ogni soggetto.
I delinquenti minorili sono apparsi, come gruppo, diversi dai corrispondenti
“controlli” costituiti da soggetti non divenuti criminali, per cinque raggruppamenti
di caratteristiche che spiegherebbero appunto la differente condotta:
1. dal punto di vista fisico – per essere frequentemente di costituzione robusta e
muscolosa;
2. per il temperamento – essendo i giovani delinquenti più facilmente irrequieti,
energici, impulsivi, distruttivi, aggressivi;
52
3. per l’atteggiamento psicologico – per essere più frequentemente ostili,
antagonisti, pieni di risentimento, rivendicanti diritti, sospettosi, non
convenzionali e non remissivi;
4. intellettivamente – perché capaci di apprendere preferibilmente secondo
modalità concrete e dirette piuttosto che tendere al pensiero astratto,
simbolico, logico-razionalizzante;
5. per la loro condizione familiare – caratterizzata dalla inadeguatezza dei
genitori e di tutto l’ambiente familiare, da poca coesione, da basso livello di
aspirazione e scarsi valori sociali, dalla presenza di genitori non adatti a
essere guide e protettori, inidonei a fungere da modello di identificazione ed
a fornire una buona socializzazione.
Il fatto che le caratteristiche differenziali fra i due gruppi presentino una elevata
frequenza statistica indica la loro effettiva importanza nella criminogenesi tanto è
vero che il riscontro di tali caratteristiche in un dato soggetto è stato utilizzato dai
coniugi Glueck come indice predittivo di sua probabile futura criminalità.
Ora, è stato evidenziato che la predizione della futura condotta criminosa mantiene
lo stesso elevato margine di validità se anziché considerare congiuntamente i dati
psicologici e quelli familiari, la predizione venga effettuata sulla scorta delle sole
caratteristiche della famiglia: ciò sottolinea l’importanza dei fattori legati
all’inadeguatezza dell’ambiente familiare.
Si potrebbe in sintesi affermare che le aree sociali meno privilegiate dalle quali
provenivano i due gruppi di giovani esaminati dai Glueck contengono molteplici
fattori potenzialmente criminogeni: solo però nel caso in cui i fattori negativi
ambientali si sommino a certa particolari caratteristiche psichiche dell’individuo e/o
all’inadeguatezza della famiglia, si realizza più facilmente la condotta criminosa.
40.2 – La teoria dei contenitori di Reckless (1961)
Questa teoria multifattoriale si presenta come un altro indirizzo della
criminologia multifattoriale del consenso. Essa mira a spiegare in generale il
comportamento sociale identificando quei fattori che favoriscono il contenimento
della condotta nell’ambito della legalità: viceversa la carenza di questi fattori di
contenimento (cioè dei “contenitori”, da cui prende il nome la teoria) costituisce
elemento significativo nel favorire la scelta criminale.
Reckless distinse:
contenitori interni – rappresentati da quegli aspetti della struttura psicologica
più significativi per favorire l’integrazione sociale. Essi consistono in : buon
autocontrollo, buon concetto di sé, forza di volontà, buon sviluppo delle
istanza etiche, buona socializzazioni, forte resistenza agli stimoli disturbanti,
senso di responsabilità, orientamento verso fini ben chiari.
Contenitori esterni – rappresentati dall’insieme delle caratteristiche
dell’ambiente nel quale il singolo soggetto si trova a vivere. Le variabili
psicologiche non sono infatti di per sé sufficienti a render conto, da sole, del
comportamento socialmente conforme (ovvero di quello criminoso) perché
53
esse agiscono in modo differenziale a seconda dello status del soggetto e
delle caratteristiche peculiari del suo ambiente. I contenitori esterni
rappresentano i freni strutturali che, operanti nell’immediato contesto sociale
di una persona, o agenti in senso più lato nella società, gli permettono di non
oltrepassare i limiti normativi. Detti contenitori sono rappresentati da fattori
molteplici: da un ragionevole insieme di aspettative di successo sociale, nel
senso che quanto maggiori sono le prospettive di successo legate al ceto, alle
relazioni, alle qualificazioni professionali, tanto più agevole sarà mantenersi
nella conformità e non usare mezzi illegittimi per affermarsi; l’opportunità di
incontrare consensi nel proprio ambiente, il disporre di figure capaci di
offrire coerenti modelli di identificazione e una salda guida di condotta
morale.
Si rende dunque necessario considerare contemporaneamente l’integrazione e la
correlazione tra le variabili psicologiche e quelle ambientali. Esiste cioè tutto
un complesso sistema di correlazioni fra i vari contenitori che consente di
comprendere come l’accentuata carenza di taluni di essi renda
proporzionalmente meno rilevante la mancanza degli altri: in genere, quanto più
difettano i contenitori esterni, tanto minore importanza nel condurre alla
criminalità viene ad assumere la carenza di quelli interni e viceversa.
41. La criminologia del conflitto (criminologia di sinistra)
Negli anni ’60, larghi settori dell’opinione pubblica sono stati caratterizzati,
specie tra gli intellettuali ed i giovani, da un deciso viraggio verso le ideologie di
sinistra. Si realizzo così in quell’epoca una vera e propria rivoluzione culturale i
cui ispiratori teorici furono i filosofi della Scuola di Francoforte (Adorno,
Marcuse, Horkheimer) che sottopose la società neocapitalistica,
scotomizzandone i pregi, a una critica serrata per tutti i guasti di cui veniva
accusata: in primo luogo per le ingiustizie sociali e, quindi, in una prospettiva
esistenziale, per aver ridotto l’uomo al conformismo e al consumismo,
privandolo di ideali. Quelle idee furono fatte proprie dal movimento del
Sessantotto che, partito nel maggio di quell’anno dalla rivoluzione studentesca
di Parigi si diffuse in tutta Europa, specialmente in Germania ed in Italia.
Le nuove idee investirono presto ogni settore della vita politica, culturale ed
anche privata di quegli anni. I principali informatori e le parole d’ordine di quel
movimento furono soprattutto il rifiuto del consumismo e, più in generale, di
tutto il mondo capitalistico e della società industriale, la prospettiva della
rivoluzione comunista, il fiorire di un’etica solidaristica verso i poveri, i
diseredati, gli emarginati e addirittura verso i devianti ritenuti anch’essi vittime
della società. Si enfatizzava e si rifiutava il “disagio della civiltà” cioè la quota
di nevrosi e di ansia che la competitività e il consumismo comportano. Il rifiuto
di ogni inibizione si riverberò anche sui costumi privati, sulla famiglia, sulla
sessualità: anche la libertà sessuale avrebbe dovuto servire, come l’ideologia
comunista e il femminismo, a distruggere la società del consenso e
dell’integrazione, al posto dei quali gli ideali divennero il dissenso, la
contestazione, la trasgressione.
54
In questo clima culturale, in quegli anni, taluni filoni della criminologia si sono
intessuti di esplicite connotazioni ideologiche e politiche di sinistra e si sono
andata qualificando come criminologia del conflitto in opposizione ad una
criminologia del consenso. Per la criminologia del consenso, è centrale la
percezione della società come struttura non certo ottimale, con gravi disfunzioni
di organizzazione, disparità di accesso ai beni, carente di giustizia sociale, ma
comunque migliorabile con le riforme e dove la delinquenza è ritenuta favorita
da certi handicap sociali e individuali che però nulla tolgono alla responsabilità
dei singoli autori di delitti (responsabilità su cui viene in definitiva a far leva
ogni intervento risocializzativo, obiettivo fondamentale della politica criminale).
Per i filoni più estremistici della criminologia del conflitto, invece, la
delinquenza non è eliminabile senza la radicale trasformazione della struttura
economico-sociale e senza la più o meno apertamente auspicata soluzione
rivoluzionaria che avrebbe condotto alla eliminazione dei conflitti di classe e
delle ingiustizie e che avrebbe risolto anche la questione criminale.
Gli approcci meno ideologizzati e più cauti, furono quelli che negli USA si
sono rivolti allo studio delle sottoculture delinquenziali e delle bande
giovanili che vedono nelle discriminazioni sociali, nelle difficoltà economiche e
nella riduzione delle opportunità di successo la ragione prima della attrattiva
esercitata sui giovani delle classi disagiate da parte delle sottoculture criminose.
I filoni più radicali e massimalisti si sono sviluppati invece in Inghilterra
prendendo corpo nella teoria dell’etichettamento fino a giungere alla
criminologia critica che vedrà la stessa criminalità quale fatto politico ed
addirittura rivoluzionario.
42 - Teorie della sottocultura giovanile
Quando parliamo di cultura, in un senso ristretto, intendiamo indicare modelli
astratti di valori morali e di norme riguardanti il comportamento, che vengono
appresi direttamente o indirettamente nell’interazione sociale, in quanto sono
parte dell’orientamento comune della maggior parte delle persone. La cultura,
ed in particolare le norme che, in criminologia, della cultura sono l’aspetto più
importante, si riflettono nel comportamento dei singoli attori sociale, anche se in
esso intervengono pure fattori individuali, non culturalmente determinati:
carattere, personalità, istinti, intelligenza, valori etici e sociali.
Strettamente associato al concetto di cultura è quello di gruppo. Infatti, anche
nell’ambito di una cultura più ampia, esistono nella società tante culture, per
certi aspetti differenziate, quanti sono i gruppi che in essa agiscono,
intendendosi per gruppi le associazioni di individui caratterizzati da una comune
cooperazione e dal senso di appartenenza al gruppo.
Il gruppo di distingue da una massa differenziata per alcune caratteristiche:
-
i membri di un gruppo sono in rapporto stabile e non solo casuale e
passeggero;
-
in tutti i membri del gruppo si sviluppa e si mantiene un concetto chiaro del
gruppo e dei suoi limiti
55
-
un gruppo può venire a trovarsi in contrasto e anche in lotta con altri gruppi
nell’ambito del gruppo esiste un’organizzazione e divisione dei compiti,
spesso su base gerarchica
-
nel gruppo si sviluppa un complesso di usi, costumi e regole che creano una
tradizione (spirito di gruppo).
Si nota pertanto come le particolari norme, valori, principi e tradizioni del
gruppo sono inseriti nella sua cultura e sono fatti propri dagli appartenenti a quel
gruppo.
L’appartenenza a un gruppo è un fatto dinamico perché il singolo individuo può
partecipare contemporaneamente a più gruppi.
Qualora un gruppo sociale abbia una propria cultura fortemente differenziata
rispetto alla cultura dominante per taluni valori importanti, si parlerà allora di
sottogruppo che avrà, a sua volta, una sua propria sottocultura, volendo
sottolineare con questi termini il contrasto e la differenza di taluni precetti
normativi rispetto a quelli della cultura generale.
Per sottocultura delinquenziale si intende quella di un sottogruppo che ha una
sua particolare visione normativa in contrasto con ciò che la cultura generale
considera come illegale. La sottocultura delinquenziale è pertanto quella di un
sottogruppo che, pur avendo molti valori normativi comuni con gli altri gruppi, se
ne diversifica per quanto attiene a certi comportamenti inibiti dalla legge (concetto
che si ricollega dunque a quello di “associazione differenziale” di Sutherland di
qualche decennio prima). E’ bene notare, poi, che una sottocultura può esistere
anche largamente distribuita nello spazio e senza alcun contatto interpersonale fra
singoli individui o gruppi interi di individui.
Nella prospettiva sottoculturale si collocano alcune teorie che hanno mirato a
illuminare nell’ambito della criminologia del conflitto, le ragioni che favoriscono la
confluenza verso le sottoculture criminose dei giovani delle classi più disagiate.
42.1 – La teoria della cultura delle bande criminali di Cohen (1955) –
Questa teoria vuole fornire una spiegazione delle dinamiche che portano alla
delinquenza nelle grandi città i giovani delle classi più sfavorite. Per Cohen, la
sottocultura delinquenziale dei giovani di bassa estrazione sociale nasce dal
conflitto con la cultura della classe media, che rappresenta i valori più diffusi, ma
dalla quale essi si sentono estranei ed estraniati: per questi giovani, di conseguenza,
è impossibile conseguire i vantaggi ed il successo sociale di cui godono i loro
coetanei dei ceti più favoriti ed essi vivono pertanto più frequentemente
l’insuccesso, la frustrazione e l’umiliazione. Per Cohen, questi giovani trovano una
soluzione a tale dissonanza nel disconoscere le regole della cultura dominante e nel
cercare di organizzare nuovi e diversi rapporti interpersonali con proprie norme e
propri criteri di status. Quindi essi metterebbero in atto il meccanismo difensivo
della formazione reattiva che è un meccanismo psicodinamico di marca
psicoanalitica che implica la sostituzione nella coscienza di un sentimento che
provoca angoscia con il suo opposto. In tal modo, le norme e gli ideali borghesi,
essendo irraggiungibili, non costituiscono più mete culturali ambite ma sono
rifiutate e disprezzate perché espressione del sistema dominante, giudicato a loro
56
estraneo, ingiusto, da rifiutare e disprezzare. Questi giovani sono favoriti a inserirsi
stabilmente nelle sottoculture dei delinquenti abituali dal fatto che queste ultime
sono frequentemente insediate proprio nei quartieri poveri dove essi risiedono e dal
loro vivere “all’angolo della strada” con conseguente maggiore facilità di rapporti
con soggetti già facenti parte della delinquenza comune che proprio da questi
giovani attinge nuove leve.
Questa teoria, tuttavia, non offre alcuna spiegazione del fatto che fra tutti i giovani
che gravitano sulla strada per le sfavorevoli condizioni economiche delle loro classi
di appartenenza, solo una parte finisce per confluire nelle file della delinquenza.
42.2 – La teoria delle bande giovanili di Cloward e Ohlin (1960) – Nella
concezione di questi autori le sfavorevoli condizioni economiche e sociali – e in
particolare l’appartenenza alla classe operaia – si traducono in una limitazione delle
opportunità cosicché si parla della loro teoria anche come teoria delle opportunità
differenziali.
Questi autori partono dalla considerazione che la società capitalistica offre a tutti, in
teoria, la possibilità di conseguire le mete di affermazione e successo ma, di fatto, la
competizione limita le opportunità di chi parte da un piedistallo più basso. Ora,
secondo gli autori, le bande giovanili si originano dal bisogno di aggregazione tra
soggetti socialmente sfavoriti con analoghi problemi di adattamento e possono
assumere tre differenti forme:
-
le bande criminali in senso stretto – sono formate da giovani dediti
inizialmente ai c.d. reati da strada (furto, borseggio, rapina) e che poi, con
l’inserimento nella sottocultura della delinquenza abituale, ampliano e
perfezionano la loro attività criminosa passando a reati ben più gravi. Questi
soggetti diventeranno così professionisti della delinquenza comune e
acquisiscono in questo modo denaro e status symbol di successo.
-
Le bande conflittuali – che sono invece dedite alla violenza e al vandalismo
sistematico senza finalità primariamente appropriative o lucrative; mirano
soltanto a distruggere i simboli irraggiungibili del successo esprimendo così
irrazionalmente e con violenza gratuita la protesta per esserne esclusi.
-
Le bande astensioniste – che sono composta da quei giovani nei quali la
frustrazione ha provocato una fuga che esprime il rifiuto globale della cultura
stessa, dalla quale cercano di evadere mediante l’abuso di droghe e di alcol.
Queste teorie, anche se ci aiutano a capire meglio come arrivano alla delinquenza i
giovani provenienti da gruppi economicamente svantaggiati, hanno dei limiti dovuti
al fatto che:
-
hanno una visione massimalista dei gruppi sociale e sono sostenute da una
ispirazione marxista troppo radicalizzata sul conflitto di classe;
-
la delinquenza dei più giovani non è necessariamente organizzata in bande
ma può esercitarsi anche in modo isolato mentre vandalismi e violenze
spesso vengono compiuti anche da giovani appartenenti a ceti abbienti;
57
-
tanto la teoria di Cohen quanto quella di Cloward e Ohlin cadono facilmente
in un approccio che risulta rigidamente deterministico in quanto finiscono
per lasciare l’impressione che i giovani provenienti da certi gruppi siano
quasi fatalmente destinati alla delinquenza.
43 – Teorie dell’etichettamento
La visione di una società travagliata dalla continua conflittualità tra classe detentrice
del potere e le classi lavoratrici viene ulteriormente radicalizzata negli anni ’60 dai
teorici del nuovo filone criminologico del labelling approach che recuperano la
prospettiva dell’interazionismo simbolico di Gorge Mead (1934).
Gli aspetti caratterizzanti della “teoria dell’etichettamento” (Becker, Lemert,
Kitsuse) sono incentrati sui seguenti punti:
1. visione rigida e dicotomica delle classi sociali – percepite come classe dei
proletari sfruttati e classe dei padroni sfruttatori;
2. non univoca accettazione delle norme legali – in quanto ritenute funzionali ai
detentori del potere e quindi con condivise da quella parte dei consociati da
essi vessati;
3. valorizzazione del concetto di reazione sociale – quale risposta che la cultura
dei ricchi mette in atto nei confronti delle condotte devianti mediante la
stigmatizzazione, l’emarginazione e le sanzioni penali;
4. percezione della devianza e della criminalità non quali comportamenti
riprovevoli o colpevoli ma quale mero frutto di un etichettamento negativo
esercitato dal potere nei confronti delle sole condotte antigiuridiche
commesse dalle classe subalterne.
I teorici del labelling approach, affermano che il deviante non è tale perché
commette certe azioni, ma perché la società qualifica come deviante chi compie
quelle azioni: con la reazione sociale consistente nel conferire la qualifica di
deviante, la devianza viene in un certo senso “creata” dalla nostra stessa società.
Il punto focale del nuovo approccio è spostato pertanto dall’atto del singolo,
com’era nelle precedenti teorie, alle reazioni della società nei confronti dell’atto
stesso.
-
Il deviante non è più visto come disfunzionale al sistema sociale ma la
condotta deviante è invece intesa come necessaria e utile alla società
che in essa trova il confine ben delineato della propria conformità. Il
deviante, quindi, deve essere “creato” per differenziarsene ed avere un
termine di paragone negativo.
-
Il deviante svolge anche un ruolo di capro espiatorio – nel momento
in cui si polarizza contro di lui tutta l’emotività e lo sdegno per gli
autori del male, si ha il vantaggio di non far percepire come devianti
altre condotte, parimenti dannose per la società, ma che sono proprie
delle classi domianti;
58
-
Il criminale, nella comune accezione, non è tanto colui che commette
un crimine ma piuttosto colui che, fra i molti atti illegali, ne compie
certuni. I concetti di stereotipo e di stigma, rappresentano bene questi
meccanismi nel senso che lo stereotipo culturale del criminale (cioè la
concezione di delinquente diffusa nell’opinione pubblica) corrisponde
a quello della criminalità abituale e convenzionale ma non comprende
tutti gli atti contrari ai codici. Si avrebbe così una discriminazione in
relazione al tipo di delitto, all’ambiente in cui esso viene attuato e al
ceto dell’autore. La discriminazione si attua a vari livelli: chi ha più
potere può fare leggi a sé più favorevoli e decide, ne contempo, cosa
è lecito e cosa non lo è.
I gruppi sociali, quindi, creano devianza facendo le norme la cui
infrazione costituisce devianza, applicando queste norme ad alcune
persone ed etichettandole come outsider. Da questo punto di vista la
devianza non è una qualità dell’atto commesso dalla persona ma piuttosto
una conseguenza dell’applicazione di norme e sanzioni a un delinquente
da parte di altri. Il deviante è una persona alla quale l’etichettamento è
stato applicato con successo: il comportamento deviante è un
comportamento che viene etichettato come tale.
Il processo di consolidamento della devianza si realizza poi attraverso
una serie di eventi. Infatti, colui che è definito come deviante tende a
stabilizzare la sua condotta in una carriera deviante, il che comporta
l’assunzione di un ruolo deviante e conseguentemente anche il sentimento
della identità personale diviene quello di un Io deviante. La
stigmatizzazione fa dunque in modo che il soggetto che si è comportato
in un certo modo finisca per riconoscere se stesso nell’etichetta che gli è
stata posta e non tende più a modificare la condotta.
Viene inoltre distinta:
-
la devianza primaria – che definisce una condotta deviante senza
che si mettano in moto reazioni sociali e psicologiche che
modifichino il ruolo e il sentimento della propria identità del
soggetto agente; questi, pertanto, non si vive come un deviante ed
ha ampie possibilità di rientrare nella conformità;
-
la devianza secondaria – si realizza come effetto della reazione
sociale (stigmatizzazione e sanzione legale) e comporta peculiari
effetti psicologici sull’individuo che si percepisce come deviante,
sviluppa tutta una serie di atteggiamenti oppositivi che il suo ruolo
comporta, con conseguente fissazione in tale ruolo di deviante
ovvero di delinquente.
Dunque, si diviene devianti perché si è qualificati come tali e, quindi, deviante
colui al quale l’etichettamento è stato applicato con successo; viceversa, colui che
commette azioni criminose ma che non viene raggiunto dalla censura, non sarebbe
un deviante, con buona pace dei principi morali e della giustizia.
Critiche possono essere mosse a questa teoria:
59
1. la confusione fra devianza e criminalità - che sono spesso usate come
sinonimi;
2. questa teoria spiega la devianza non criminosa e la piccola delinquenza di
poco conto, la microcriminalità di strada ma non si presta affatto ad essere
applicata nei confronti della criminalità più grave in quanto i delinquenti di
questo tipo si auto-emarginano per loro scelta primaria e sono assolutamente
indifferenti alla stigmatizzazione;
3. questa teoria è deterministica in quanto la persona che ha subito lo stigma
sembrerebbe non potersi sottrarre ad un inevitabile destino delinquenziale;
4. questa teoria è deresponsabilizzante perché equiparando delinquenti e
devianti finisce per attenuare la colpevolezza dei primi che vengono a fruire
dell’atteggiamento più tollerante riservato ai secondi.
44 – Teoria della devianza secondo Matza
Il rigido orientamento classista e il giustificazionismo nei confronti della
delinquenza anche più grave propri di tutta la criminologia del dissenso sono stati
in qualche modo sottoposti a revisione, in quegli stessi anni, dal criminologo
americano Matza (1969) il cui contributo rappresenta il superamento nei confronti
della teoria della sottocultura giovanile di Cohen e di quella dell’etichettamento.
La critica verte sul fatto che i teorici delle sottoculture (Cohen in particolare)
intendono la sottocultura delinquenziale minorile come il risultato di un processo di
costruzione da parte dei giovani della classe operaia, di valori antagonisti rispetto a
quelli dominanti (quelli della classe media). Per Matza questa ipotesi è da rigettare
poiché non è possibile pensare alla condotta delinquenziale come al frutto di una
situazione in cui il soggetto definisce “giusto” il suo comportamento. Il problema,
invece, è più complesso in quanto è molto difficile convincersi che esista una netta
scissione tra i valori accettati dai soggetti conformi e quelli di coloro che
delinquono. Lo dimostra il fatto che molti giovani esprimono, dopo la commissione
del reato, vergogna e un sincero senso di colpa che non possono essere
sbrigativamente interpretati come tentativo di manipolazione da parte degli appartati
istituzionali. Dunque non si può concludere che i mondo dei giovani delinquenti
non è completamente avulso dalle richieste di conformità espresse dall’ordine
sociale dominante.
Secondo Matza, gran parte dell’attività delinquenziale è dovuta ad una
proliferazione di difese nei confronti dell’atto delinquenziale, sottoforma di autogiustificazioni per il comportamento deviante, considerate valide dal delinquente
ma non dal sistema giuridico o dalla società.
Il delinquente, cioè mette in atto un processo di razionalizzazione che gli consente
di
esprimersi in senso deviante e giungere all’infrazione normativa
“neutralizzando” attraverso particolari tecniche – le “tecniche di neutralizzazione” –
il conflitto con la morale sociale da lui almeno parzialmente accettata. Queste
razionalizzazioni non intervengono ex post-facto ma precedono l’atto deviante e
servono a escludere la responsabilità individuale e a negare la sua illiceità attraverso
la ridefinizione del proprio operato.
60
La delinquenza, non deriva dunque dall’apprendimento di imperativi o valori
devianti ma è il frutto dell’acquisizione di queste particolari tecniche di autogiustificazione.
Queste tecniche di neutralizzazione vengono presentate in cinque forme diverse:
1. la negazione della propria responsabilità – il delinquente, per aprirsi la
possibilità di imboccare la via della devianza ed evitare di doversi assumere
la responsabilità di un attacco diretto all’apparato normativo, inizia ad
autopercepirsi come una “palla da biliardo” immagine che gli consente di
viversi come agito, trascinato nelle diverse situazioni;
2. la minimizzazione del danno arrecato – il delinquente è portato a
considerare il proprio comportamento come appartenente ad una attività
vietata ma non immorale. Per lui, inoltre, la gravità della condotta viene
valutata in base al danno subito dalla vittima. La neutralizzazione consiste
nella “ridefinizione” delle proprie condotto: un atto vandalico diventa un
“disturbo dell’ordine”, un furto una “presa in prestito”, uno scontro tra bande
uno scambio privato di opinioni, ecc.;
3. la negazione della vittima – anche nel caso in cui il delinquente si riconosce
responsabile dell’atto commesso e si dichiara disposto ad ammettere la
gravità del danno causati, la responsabilità viene neutralizzata accentuando il
fatto che il pregiudizio recato alla vittima non rappresenta una ingiustizia
perché si tratta di un individuo che meritava il trattamento subito. Il
delinquente, cioè, si sente un giustiziere;
4. la condanna di coloro che condannano – coloro che sono conformi alla
legge vengono giudicati dal delinquente come ipocriti, la polizia come
corrotta, i giudici come parziali;
5. il richiamo a ideali più alti – in questo caso le forme di controllo sociale
possono essere neutralizzate sacrificando le istanza più generali della società
(norme, aspettative, doveri) a vantaggio di ideali particolari ma considerati
eticamente superiori, quali quelli della fedeltà al gruppo di appartenenza,
della solidarietà fra amici, della giusta lotta fra bande del quartiere, ecc.
Un aspetto importante della teoria di Matza è il superamento delle teorie
dell’etichettamento e del loro contenuto deterministico, quella scuola, infatti,
sorvola sul problema della “devianza primaria” (cioè la scelta del comportamento
censurabile dalla collettività) cioè di quella devianza agita dal soggetto prima
ancora che egli sia individuato come deviante e venga quindi stigmatizzato dalla
reazione sociale (foriera della devianza secondaria). Matza non si schiera né per un
totale libero arbitrio né per un rigido determinismo, egli, piuttosto, è per affermare
un “determinismo debole” che spiega con il concetto di drift, termine che non
trova una giusta traduzione in italiano ma che rimanda alla presenza di una
motivazione all’agire deviante non rigidamente vincolante. Il soggetto, cioè, si trova
in una situazione di limbo tra conformità e devianza e reagisce di volta in volta alle
richieste dell’una o dell’altre senza mai dirigere definitivamente il proprio
comportamento in senso deviante o in senso conforme.
61
La sottocultura, per Matza è il luogo in cui il soggetto per sollevarsi da situazioni
angosciose, può accentuare inclinazioni che non sente.
La volontà di violare una norma è un processo molto complesso che nasce quando
alla preparazione (che consiste nell’apprendimento delle tecniche di
neutralizzazione) subentra un vero e proprio senso di disperazione dovuto al sentirsi
incapaci di dominare gli eventi e l’ambiente circostante: disperazione che a sua
volta si traduce in un generico desiderio di far accadere qualche cosa, pur di
convincere se stessi che si è ancora padroni della situazione.
Matza dunque spiega non solo la devianza primaria ma riconferisce uno spazio di
libertà al deviante stesso (e quindi una responsabilità), pur evidenziando i fattori che
tale libertà in parte limitano.
45. Criminologia critica (criminalità come fatto politico)
Tra gli anni ’70 e ’80, in una prospettiva rigidamente marxista, la criminalità venne
intesa non più come fatto sociale ma piuttosto come fatto politico: la criminologia,
cioè, identificò la devianza con il dissenso, cosicchè tutte le classi ed i movimenti
che si opponevano alla società neo-capitalista vennero ritenuti costituire l’autentica
categoria dei devianti. Ma ciò comportò che così come i movimenti politici di
sinistra, anche i criminali vennero intesi come oppositori del sistema borghese,
talchè la criminalità venne considerata un fatto sostanzialmente politico. I criminali.
Però non avendo coscienza del significato rivoluzionario della propria condotta
dovevano essere “politicizzati” per poter assumere un ruolo consapevole di forza
promotrice dell’innovazione: questo doveva essere il compito dei movimenti di
sinistra e più specificamente della criminologia. La criminologia, pertanto, doveva
cessare di proporsi come scienza con finalità di ricerca per assumere precise prese
di posizione militanti e politiche.
In questa ottica, la stessa definizione tradizionale di delinquenza e di devianza
andava rifiutata perché fondata sulla ideologia del potere e del privilegio di classe:
criminale era ritenuta invece la classe dominante con le sue ingiustizia, lo
sfruttamento, la mortificazione consumistica e la negazione della libertà e dignità
umane.
La devianza e la criminalità venivano così a identificarsi con la lotta che l’intera
classe operaia conduce per l’edificazione della società comunista.
Il primo filone della criminologia critica si è sviluppato in Inghilterra attorno alla
National Deviance Conference (Taylor, Walton, Young, 1975) e ha preso le mosse
da una critica della vecchia interpretazione marxista della criminalità secondo la
quale questa era un diretto prodotto della società capitalistica ma riteneva il
criminale privo della consapevolezza del significato classista del suo essere
deviante, in quanto reputato mosso solo da istanze individualistiche. La new
criminology inglese affrontò invece il problema della devianza come scelta
consapevole dei singoli dinanzi ai disagi e alle contraddizioni sociali.
Questo indirizzo è stato coltivato anche in Germania ed in Italia da un gruppo di
studiosi facenti capo alla rivista Questione criminale. Nella prospettiva di questi
studiosi, la devianza veniva definita come una modalità di condotta contrapposta ai
62
canali normativi (costumi, leggi, cultura) ispirati e governati esclusivamente della
classe al potere. La devianza esprime tutte le esigenze alternative all’ideologia
borghese e si identifica con la non accettazione di questa: il fatto che la devianza sia
stigmatizzata e repressa dalle istituzioni è la conseguenza del fatto che essa viene,
dalla società capitalista, percepita come una minaccia per il suo sistema.
Viene distinta:
-
una devianza individuale - che nelle sue varie forme (criminalità,
evazione nella droga, rifiuto dell’inserimento lavorativo, ecc.) costituisce
una modalità di rigetto della società borghese, devianza che però è priva
oltre che di consapevolezza anche di prospettive;
-
una devianza organizzata – che rappresenta la lotta delle classi
lavoratrici (quindi un superamento della devianza individuale che è
parziale ed alienata) chiaramente politicizzata e ordinata nei movimenti
politici delle masse. La lotta sociale organizzata per il superamento della
società capitalistica e per l’edificazione del comunismo avrebbe dovuto
consentire anche il riassorbimento delle devianze individuali nella
devianza collettiva e organizzata dei lavoratori.
Così come inteso dalla criminologia critica, il termine di devianza è divenuto
addirittura sinonimo delle classi lavoratrici impegnate nella più matura lotta di
classe. In questa ottica, anche la pena carceraria e tutto il sistema penale vennero
visti come strettamente legati alla società capitalistica e funzionali agli interessi
economici e di controllo sociali delle classi dominanti.
La criminologia critica, anche se ha avuto il merito di contribuire ad un movimento
per la decarcerizzazione e l’umanizzazione della pena, ha alimentato un
atteggiamento dell’opinione pubblica di sinistra di eccessiva solidarietà nei
confronti dei delinquenti, visti come vittime della società piuttosto che come
individui non solo inosservanti delle leggi ma spesso anche autori di comportamenti
prevaricatori. Essa ha cioè identificato la delinquenza come se fosse solo
microcriminalità da strada, agita da soggetti provenienti dai gruppi più sfavoriti,
trascurando del tutto la più allarmante criminalità violente, la delinquenza
economica e quella organizzata.
46 - Il Nuovo Realismo
Nella seconda metà degli anni ’80, la constatata inefficienza del regime comunista e
del centralismo economico ad assicurare condizioni di vita comparabili con quelle
dell’occidente, aveva provocato un mutamento radicale anche nella politica interna
dell’URSS con la richiesta di maggiori libertà democratiche (si pensi alla
perestrojka, e alla glasnost di Gorbaciov) per giungere infine al crollo nel 1989 del
muro di Berlino e alla dissoluzione dell’impero sovietico.
Gli stessi autori di ispirazione marxista che in Gran Bretagna erano stati i promotori
della New Deviance Conference e della criminologia critica, pur sempre rimanendo
su posizioni di sinistra, diedero avvio (Lea, Young, 1984) alla scuola del Nuovo
Realismo.
63
A circa dieci anni di distanza, l’impostazione viene completamente capovolta dal
punto di vista metodologico e da quello dei contenuti: da una riflessione
esclusivamente ideologica e teorica e di fronte alle esasperazioni di un approccio
che vedeva solo nelle sperequazioni sociali la causa della criminalità e che
intendeva il deviante esclusivamente come vittima, questi autori rivolgono la loro
attenzione all’osservazione empirica, particolarmente riguardo ai reati da strada
(street crimes) che avvengono nei quartieri popolari delle metropoli scoprendo così
che la delinquenza, studiata in precedenza in una prospettiva tutto sommato astratta,
è invece una realtà di fatto. I Nuovi Realisti, scoprono l’elevata vittimizzazione e la
richiesta di protezione propria dei meno abbienti e dei più indifesi, di conseguenza,
propongono ora programmi sociali miranti a ridurre la marginalizzazione, a offrire
alternative alla carcerazione, a promuovere esperimenti di riconciliazione tra reo e
vittima (nei casi meno gravi) e a creare una organizzazione nella comunità mirante a
cooperare con la polizia in vista della prevenzione dei reati nei quartieri. La
prevenzione, prima rifiutata, diviene ora un obiettivo primario, che dovrebbe essere
perseguito attraverso “progetti di sorveglianza di vicinato” formati da comitati di
zona di cui fanno parte anche privati cittadini, in una rivalutazione, quindi, dei
sistemi di controllo informali o semi-formali.
47. Neo-classicismo e abolizionismo
Sempre negli anni ’80, dopo la fine della criminologia tutta incentrata sulla
ideologia politica di sinistra, hanno preso le mosse altri due filoni di pensiero come
conseguenza di due differenti e in un certo senso opposte ragioni:
1. l’abolizionismo – che distinguiamo in:
a. abolizionismo carcerario – come estrema espressione della critica
alla carcerazione, ritenuta inefficace quale strumento per combattere
la criminalità. E’ un movimento che prende le mosse dalle ben note
censure, già degli anni ’60, contro le “istituzioni totali”, contro il loro
effetto disumanizzante, stigmatizzante e addirittura criminogeno e
contro l’identificazione della sanzione penale esclusivamente con la
reclusione in carcere. Esso, però, finisce per massificare tutti i
criminali secondo una unica prospettiva astratta, vittimistica e
indulgenzialistica, senza tener conto cioè della estrema
differenziazione con cui, viceversa, il criminologo e l’operatore
giudiziario si trovano a confrontarsi. Una prospettiva tanto estrema
non può realisticamente conciliarsi con l’esistenza di delinquenti
particolarmente pericolosi e, infine, con istanze di giustizia e di
sicurezza che le persone sentono e vedono concretizzate nella pena
carceraria: un conto è ridurre l’uso del carcere, un conto è
l’abolizione. L’istituto della carcerazione, è stato dunque sottoposto a
una critica serrata che però non può giustificare le posizioni di globale
abolizionismo: queste rispecchiano il rifiuto di infliggere sofferenza
ma non tengono conto, dinanzi ai crimini socialmente più pericolosi,
dell’esigenza universalmente sentita di adeguata retribuzione e di
tutela pubblica e della insostituibilità del carcere quale strumento, per
64
taluni crimini, di difesa sociale. Ciò che costituisce un atteggiamento
erroneo verso l’istituto della carcerazione è piuttosto il considerarla
come l’unica o la principale modalità di punizione, buona per ogni
tipo di persona e di reato. Corretto appare invece lo sforzo, ispirato
dal principio riduttivistico, di trovare sanzioni idonee a sostituire il
carcere con altri strumenti di punizione meno dolorosi per il reo e
meno costosi per l’economia pubblica.
b. Abolizionismo penale – il più noto esponente di questa corrente di
pensiero è il norvegese Christie che, partendo dal presupposto che “la
pena è dolore e occorre ridurre al minimo il bisogno cosciente di
infliggere sofferenza legale per esigenze di controllo sociale”,
propugna la soppressione non solo del carcere ma di ogni tipo di pena
e, conseguentemente, dell’intero sistema della giustizia penale. Le
correnti abolizionisti che si sono ispirate a Christie esordiscono col
ritenere l’inutilità di tale sistema, negandone la deterrenza e qualsiasi
altra finalità positiva. Siamo pertanto di fronte ad una estrema e
semplicistica generalizzazione di situazioni viceversa tra loro troppo
differenti. L’abolizionismo penale, oltre che di impossibile
realizzazione, comporta rischi di iniquità e aumento di sofferenze per
le vittime mentre del tutto inadeguate appaiono le soluzioni alternative
proposte dallo stesso autore della risoluzione in chiave privatisticorisarcitoria fra autore e vittima del comportamento delittuoso e del
controllo disciplinare esercitato dalle comunità in quanto, tra l’altro,
rimarrebbero del tutto insoddisfatte le domande su cosa succederebbe
quando il patteggiamento fra le parti non fosse possibile o non fosse
voluto, quando non vi è vittima o quando il delitto è troppo grave.
2. il neo-classicismo – è sorto quale reazione al fallimento della politica penale
incentrata sul trattamento risocializzativo. L’ideologia del trattamento è stata
messa in crisi da diversi fattori:
a. l’ingente impegno finanziario legato alle molteplici agenzie di
trattamento non corrispondeva una sensibile diminuzione della
delinquenza e delle recidive; anzi, con il passare degli anni, la
delinquenza è aumentata;
b. la presa di coscienza, da parte degli stessi fautori e degli operatori del
trattamento, dell’impossibilità che non con tutti i soggetti si potessero
conseguire risultati soddisfacenti mediante le tecniche di trattamento
criminologico;
c. è stato rimesso in discussione l’obiettivo stesso della
risocializzzione in quanto si affermò l’idea che essa servisse solo a
creare cittadini più ossequienti, a discapito della loro libertà di
autodeterminarsi e di opporsi consapevolmente al sistema politico
vigente.
65
Così, come conseguenza di queste critiche, si è andato articolando il filone di
pensiero penalistico e criminologico inteso a rivalutare i principi
retribuzionistici della Scuola Classica del diritto, le garanzie processuali, la
certezza della pena, secondo un modello chiamato appunto neo-classicismo o
neo-retributivismo. Negli USAS, questa inversione di tendenza si è tradotta
oltre che in una riduzione dell’impegno nelle misure alternative e nei
programmi di trattamento, anche in un inasprimento delle pene e
nell’introduzione di sanzioni rigidament prefissate. In luogo della pena
indeterminata, ha avuto incentivazione il sistema della incapacitazione
selettiva, fondato sulla difesa sociale e sulla mera deterrenza e mirante ad
aggravare le sanzioni nei confronti dei delinquenti recidivi e più pericolosi.
Un polo di nao-classicismo ha preso piede anche nei Paesi scandinavi dove,
del pari, è stato riabilitato l’ideale retributivo però come reazione alla crisi
del modello terapeutico.
Vediamo come tutte le citate tendenze neo-retribuzionistiche hanno in
comune un drastico e progressivo abbandono di qualsiasi individualizzazione
discrezionale delle risposte sanzionatorie per sviluppare un sistema penale
che stabilizzi e rassicuri la società attraverso una comminazione oggettiva
delle pene, vincolata a ben precisi criteri quantitativi.
48 – L’approccio economico-razionale
I mutamenti economici hanno prodotto grandi cambiamenti anche delle idee, delle
prospettive della gente e degli assi portanti ideologici; l’economia è divenuta una
componente importante ed essa si riflette sul pensiero intellettuale e sulla cultura..
E’ accaduto così che i fattori legati all’economia si sono fatti strada pure nel
pensiero ciminologico, dal quale in precedenza erano del tutto estranei. Si è così
affacciato negli ultimi anni un approccio ai problemi della criminalità del tutto
nuovo, che vede la condotta criminosa agita secondo principi razionali: secondo
cioè quegli stessi criteri che guidano le scelte economiche.
Una comprensione dell’approccio economico-razinale è possibile utilizzando il
contributo di Becker, economista americano e capostipite della sociology economy,
che già alla fine degli anni ’60 ha iniziato ad applicare le teorie economiche a settori
di ricerca usualmente non esplorati dagli economisti, quali la famiglia, l’educazione,
le discriminazioni razziali.
Secondo Becker, la causa del comportamento criminale non deve essere ricercata in
una propensione biologica o psicologica dell’individuo né in problemi legati al suo
ambiente fo a fattori sociali: semplicemente, alla base dell’agire criminale vi è una
forte componente di calcolo e una razionale analisi dei costi-benefici connessi alla
commissione del reato. Il delinquente calcola, valuta e soppesa i vantaggi e gli
svantaggi derivanti dalla commissione di un fatto illecito e, se i benefici attesi
risultano essere significativi e superiori ai costi e agli svantaggi, si determinerà a
delinquere. Egli non si differenzia pertanto da qualsiasi altro operatore economico.
Becker sintetizza il suo assunto nella formula 0 = (P, F, U): dove 0 è il numero dei
reati commessi da una persona in un determinato periodo; P la probabilità di essere
condannato per quel reato; F la sanzione per quel reato; U una variabile complessiva
66
di tutte le altre influenze. E’ dunque evidente che taluni cambiamenti della variabile
U (ad es.: aumento del reddito disponibile, aumento dell’educazione rispetto alla
legge) potrebbero ridurre gli incentivi ad entrare in attività illegali.
Secondo Becker
i costi del delitto possono distinguersi in:
costi diretti - connessi alla organizzazione o alla esecuzione del reato;
costi indiretti – collegati al rischio dell’essere individuati e condannati (tale
distinzione si rende necessaria perché l’individuazione e la condanna
rappresentano momenti diversi affidati ad istituzioni diverse che potrebbero
avere, di conseguenza, diverso grado di efficienza);
mentre i benefici connessi alla commissione del reato - posto che in alcuni casi
possono essere valutati, dal punto di vista economico, immediatamente mentre
in altri no – sono di difficile valutazione e sono legati anche al tipo di reato
commesso. Ad esempio, gli atti di vandalismo, apportano scarso beneficio dal
punto di vista economico ma un intenso senso di piacere e di soddisfazione.
Nella scelta se compiere o meno un delitto, abbiamo visto che operano altre
variabili ambientali, quali i profitti provenienti da attività illegali e la presenza di
valori etici provenienti dalla famiglia e dalla scuola. Così, un soggetto con un
lavoro stabile ed una buona condizione familiare e sociale considererà la violazione
di questi principi etici un costo elevatissimo da sostenere nella commissione di
reati: intervengono dunque nella criminogenesi anche fattori legati alla variabilità
psicologica e ambientale propria dei singoli individui.
Recentemente Becker ha affermato che per raggiungere buoni risultati nella lotta
contro i crimini, occorre una combinazione di tutte queste misure: leggi severe e
certe ma anche tutte quelle misure sociali come il miglioramento della qualità
dell’educazione e puntare sui valori della famiglia.
La critica che può essere portata a questo approccio è che si tratta di un punto di
vista teorico troppo astratto per essere applicato a tutte le condotte delittuose: esso
non può trovare applicazione per i delitti d’impeto o connessi a disturbi psichici.
D’altro canto un settore dove più brillantemente sono stati applicati questi principi è
quello delle attività corruttive e concessive dei colletti bianchi dal momento che
coloro che compiono reati di questo tipo non possono non aver fatto una
valutazione più o meno attenta delle conseguenze del proprio agire delittuoso e la
scelta di metterlo in atto è dovuta alla convinzione o al calcolo probabilistico che i
benefici che se ne potranno trarre supereranno i costi.
L’approccio economico-razionale fornisce dunque una nuova e realistica chiave di
lettura di moltissimi delitti: sia in primo luogo dei delitti compiuti per lucro ma
anche di condotte criminali violente sulle cose o sulle persone per le quali l’utile
perseguito non è economico ma semmai psicologico quale soddisfacimento di
pulsioni e desideri.
La visione che viene fornita da questa teoria è quella di una persona umana
responsabile che, prescindendo dalle motivazioni profonde come dai determinismi
sociali, è consapevole di quel che compie e delle scelte che effettua sia nell’ambito
67
delittuoso che in quello lecito . Ma anche se la condotta delittuosa è talora
irrazionale o addirittura autolesiva, essa è pur sempre attuata per conseguire un
utile, pecuniario o psicologico che esso sia.
49. La criminologia in Russia
Nell’URSS, ancora più che altrove, la totale assenza di pluralismo politico e
l’intolleranza verso ogni manifestazione di libertà di pensiero imposti dal rigido
sistema dittatoriale, hanno fatto sì che anche i contenuti della criminologia si
uniformassero in modo particolarmente stretto con l’ideologia ufficiale e con il
succedersi degli avvenimenti che si sono colà verificati nel corso del nostro secolo e
che si non su di essa riflessi.
Prima della rivoluzione del 1917, lo studio sistematico della criminalità fu coltivato
quasi esclusivamente dalla sociologia del diritto ed essa venne inteso non tanto nella
prospettiva del tecnicismo giuridico quanto essenzialmente quale fenomeno sociale.
La ricerca proseguì anche dopo la Rivoluzione d’Ottobre: nel primo periodo
postrivoluzionario, quando ancora la chiusura verso la cultura europea non era così
rigida come accadde dopo, le tesi positivistiche esercitarono un forte fascino sui
criminologi sovietici che prestarono attenzione non solo all’indirizzo sociologico
del Ferri ma anche a quello lombrosiano.
Negli anni ’30, i contenuti di derivazione positivistica vennero decisamente rigettati
perché non conciliabili con l’ideologia ufficiale che venne rigorosamente imposta in
ogni ambito del sapere. Poiché ogni forma di delinquenza veniva ritenuta
espressione della lotta di classe, la morte del capitalismo doveva necessariamente
portare alla scomparsa della delinquenza: i pochi delinquenti rimasti vennero
considerati o come soggetti dotati di patologiche caratteristiche di personalità
ovvero quali portatori di residui valori antisociali del capitalismo. La criminalità
venne pertanto intesa come un “fenomeno accidentale” e non come una componente
normale di ogni società.
La delinquenza e il dissenso politico vennero interpretati dunque in termini
prevalentemente psicopatologici e politici, segnatamento come attività
controrivoluzionaria della vecchia classe borghese così anche legittimando
l’imponente repressione penale di tutti “i nemici del popolo”, ivi compresi
dissidenti e criminali.
Più tardi, negli anni ’50 e ’60, nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale,
la società russa fu massivamente coinvolta materialmente con pesanti sacrifici
economici e moralmente con l’impegno ideologico per sostenere la guerra fredda
contro l’occidente. La criminologia seguì l’ideologia del momento continuando a
vedere, da un lato, l’esistenza di una correlazione fra criminalità e reliquie
capitalistiche non ancora sradicate, e, dall’altro, sottolineando l’effetto delle
influenze disfattiste dei paesi occidentali che erano accusate di iniettare valori e
proporre modelli comportamentali (consumismo) ostili al socialismo per minarne la
stabilità ideologica e la forza economica e militare.
Il dogmatismo ideologico è pi andato attenuandosi e, alla fine, scomparendo negli
anni a noi più vicini nell’epoca gorbacioviana con la glasnost e la perstrjka: il crollo
68
dell’impero sovietico hanno provocato un
nuovo orientamento dottrinario
avvicinando la criminologia russa e dei paesi ex satelliti a quella occidentale grazie
anche ad una aumentata frequenza di scambi culturali, un tempo del tutto aboliti.
Anche in Russia, come ovunque, la libertà ha un presso, e nel prezzo è compreso
anche l’aumento della criminalità.
69
CAPITOLO 3
PSICOLOGIA E CRIMINALITA’
50 – La criminologia incentrata sull’individuo
Le teorie sociologiche rendono conto delle molteplici ragioni legate all’ambiente, ai
rapporti fra gruppi e alle loro reazioni che favoriscono le scelte criminose di molti
individui ma esse non possono spiegare la variabilità del comportamento
individuale dinanzi ad analoghi fattori socio-ambientali che si osserva di fatto nei
singoli casi: variabilità che è da ricondurre alle diverse caratteristiche psicologiche e
biologiche di ogni individuo. E’ pertanto necessario utilizzare un approccio
integrato che miri a evidenziare quali sono i fattori che rendono ogni persona una
entità unica e irripetibile, così che differiscono per ogni soggetto anche le risposte ai
fattori criminogenetici insiti nella società, fattori che rappresentano altrettante
componenti di vulnerabilità individuale nei confronti delle scelte criminose.
Si intendono per componenti di vulnerabilità individuale tutti quei fattori, diversi
da persona a persona, psicologici o biologici, che rendono ragione della resistenza
o della maggior fragilità o dell’elettiva propensione di taluni a comportarsi - a
parità di condizioni macro-sociali e micro-sociali - in modo conforme alle norme,
ovvero all’opposto criminoso dinanzi ai condizionamenti provenienti dall’ambiente
sociale.
Lo studio delle componenti di vulnerabilità può essere condotto:
1. attraverso lo studio delle teorie psicologiche della personalità – che mettono
in evidenza i complessi meccanismi che possono spiegare la variabilità
individuale delle risposte comportamentali e identificare aspetti della
personalità che possono esporre al rischio di devianza;
2. in una prospettiva biologica – per identificare i fattori che rendono ogni
essere vivente diverso dagli altri come conseguenza della differente struttura
del patrimonio genetico e, si conseguenza, tutti i problemi legati
all’ereditarietà, alla rilevanza di fattori neuro-fisiologici nei confronti della
organizzazione psichica e del comportamento istintuale, diverso dal
comportamento appreso;
3. in una prospettiva clinica – con l’esame di fattori psicopatologici, nel quadro
delle correlazioni fra disturbi mentali e condotta criminosa.
Nel considerare le correlazioni fra individuo e ambiente,va sottolineato che esiste in
ogni tipo di comportamento umano una loro costante integrazione. L’aspetto più
caratteristico di questa correlazione è rappresentato dal rapporto inversamente
proporzionale fra le componenti di vulnerabilità individuale e i fattori ambientali:
quanto più criminogenetici sono questi ultimi, tanto meno rilevanti sono le
componenti psicologiche o biologiche legate all’individuo; e, viceversa, quanto più
marcate sono le componenti della personalità che rendono l’individuo più incline
alla condotta criminosa o deviante, tanto meno significativi risultano le carenze, le
sollecitazioni e , in generale, i fattori criminogeni legati alla società.
70
Naturalmente, dobbiamo sempre tenere presente che questa distinzione tra fattori
sociali e fattori individuali risponde solo a ragioni di comodità espositiva perché
nella realtà il comportamento è frutto di una costante integrazione di condizioni
individuali e ambientali.
51 – Personalità, temperamento, carattere
Per comportamento (o condotta) si intende il complesso coerente di atteggiamenti
che ogni individuo assume in funzione dei suoi obiettivi e degli stimoli che gli
provengono dall’ambiente: poiché tali atteggiamenti altro non sono che, in gran
parte, espressione della psiche, ne risulta in pratica la possibilità di identificare lo
studio della psicologia con quello del comportamento.
L’attività psichica è costituita da tre fondamentali funzioni: la sfera conoscitiva, la
sfera affettiva e quella volitiva.
1. La sfera cognitiva – Sono proprie di questa sfera:
a. La conoscenza – è l’insieme delle funzioni che consento all’individuo
di essere informato sulla realtà, di parteciparvi, di accumulare
esperienze, di acquisire nozioni;
b. Il pensiero – è l’organizzazione di processi mentali di carattere
simbolico che si concretizza nelle idee.
c. L’intelligenza – è l’insieme delle capacità acquisite, che riutilizzano
oltre che a livello logico-razionale o speculativo, anche per agire nella
vita relazionale; l’intelligenza può essere dunque attitudine ad
affrontare e risolvere situazioni concrete (intelligenza pratica), ovvero
attitudine a impostare e risolvere problemi generali e astratti
(intelligenza teorica).
2. La sfera affettiva - è quella fondamentale coloritura positiva o negativa,
piacevole o spiacevole che eventi e pensieri suscitano in noi; l’affettività è
anche responsabile di quegli stati d’animo che si sperimentano
soggettivamente e che possono essere spontanei ovvero conseguenti a stimoli
esterni. Nella sfera affettiva si distinguono:
a. L’umore – inteso come il variare dell’emotività nelle varie sfumature
che vanno dalla tristezza alla gioia;
b. I sentimenti – che sono espressioni più elaborate della vita affettiva
che sorgono nel rapporto con persone e situazioni non tanto sulla
scorte di elementi razionali quanto piuttosto per la risposta interiore
che ciascuno vive nei confronti di tali persone e situazioni;
c. Le emozioni – sono sentimenti che si manifestano con una intensità
particolarmente acuta (ira, furore, esaltazione e rabbia) e che si
estrinsecano anche in fenomeni fisiologici (rossore, batticuore,
pallore, tremore).
3. La sfera volitiva – riguarda le azioni (e le omissioni) che vengono compiute
per determinati fini. Alla base del volere sussistono sia motivi consapevoli
71
sia motivazioni profonde o inconsce. Sulla volontà si incentra tutta le
tematica della libertà, del libero arbitrio, della responsabilità, o all’opposto,
del determinismo.
Importantissimo è il concetto di personalità.
1. Nell’uso comune, il significato di personalità può identificarsi con la
abilità o accortezza sociale, valutandosi la personalità di un individuo in
funzione della sua capacità ed efficienza nel reagire positivamente nei
contatti con persone diverse e nelle circostanza più varie. In tal senso, si
dice che un soggetto “ha personalità” quando sa far valere le proprie
ragione e sa perseguire con successo i suoi obiettivi; ovvero, all’inverso,
si dice che “ha disturbi o problemi di personalità” quando il modello di
esperienza interiore e di comportamento e il suo funzionamento sociale
risulta inadeguato a mantenere soddisfacenti rapporti interpersonali.
2. Una seconda accezione la personalità di un individuo è definita dalla
reazione del prossimo al modo di interagire di un individuo
(prepotente, affascinante, difficile, debole, ecc.). Si tratta di una
definizione psicosociale dato che considera la p persona nell’interazione
col prossimo.
3. la personalità può ancora essere intesa come l’insieme delle qualità e
caratteristiche di un soggetto – quale somma, cioè di aspetti biologici e
psichici suscettibili di osservazione e descrizione obiettiva, facendo
astrazione dai riflessi interpersonali;
4. la definizione di personalità può anche includere gli aspetti unici ed
irripetibili o più rappresentativi di una persona – ricalcando così il
concetto di “individuo” della prospettiva biologica ma riferendola solo
alle componenti psichiche.
Ci rendiamo conto dunque da queste definizioni come la personalità altro non
esprime se non l’insieme dei termini che vengono impiegati per descrivere il
singolo individuo, termini scelti in base a variabili e dimensioni diverse. Però, un
significato di personalità essenzialmente incentrato sugli aspetti intrinseci della
persona non può essere soddisfacente per la criminologia in quanto essa non può
prescindere dall’approccio integrato fra l’individuo e l’ambiente sociale nel quale
viene agito il comportamento delittuoso. Poiché la condotta criminale è in sostanza
un particolare tipo di comportamento nella società legato alle caratteristiche della
persona ed ai reciproci influenzamenti fra persona e ambiente, dal punto di vista
criminologico la personalità interessa sostanzialmente nei suoi aspetti psicosociali,
pertanto: la personalità può definirsi come il complesso delle caratteristiche di
ciascun individuo quali si manifestano nelle modalità del suo vivere sociale e può
essere intesa come la risultante delle interrelazioni del soggetto con i gruppi e con
l’ambiente.
Queste interrelazioni tra personalità e ambiente sociale, inoltre, sono in continua
evoluzione dinamica. La personalità è da vedersi come la risultante di tali continui
72
scambi e influenzamenti così che essa non può considerarsi come data una volta
per tutte, immodificabile ed obbligata.
Quando parliamo invece di temperamento, ci ricolleghiamo alla base innata,
ancorata alla struttura biologica, delle disposizioni e tendenze peculiari di ogni
individuo nell’operare nel mondo e nel reagire all’ambiente: così parliamo di
temperamento mite o violento, subordinato o dominatore, ecc.
I genetisti da qualche tempo stanno scoprendo l’esistenza di certi geni che sembrano
collegati al comportamento: a dimostrazione della sempre maggiore influenza che si
tende oggi ad attribuire alla base biologica nei confronti della condotta. In tale
prospettiva, il temperamento è da ritenersi come poco modificabile perché legato al
patrimonio genetico acquisito al momento del concepimento.
Peraltro, le infinite circostanze dell’esistenza incidono sul temperamento, facendo
assumere al soggetto modalità di pensare, di atteggiarsi e di agire più o meno
diverse da quelle innate: ciò intendiamo per carattere.
In sintesi, il concetto di temperamento contiene connotazioni di “potenzialità” che si
traducono in “attualità” di modi di pensare e di interagire, cioè in carattere, per
effetto delle mutevoli esperienze e vicende che la vita pone a ciascuno. Ad esempio,
un individuo dotato di temperamento aggressivo diverrà di carattere aggressivo,
cioè si comporterà in modo effettivamente aggressivo tanto più facilmente quanto
maggiori saranno state le circostanze della sua esistenza che avranno favorito l’agire
violento.
Il carattere rappresenta pertanto la risultante della interazione fra temperamento
e ambiente: il carattere non è quindi una componente statica della personalità
quanto piuttosto una componente dinamica che si modifica col tempo e con quelle
rivende di vita che ne plasmano gli aspetti.
52. La psicoanalisi
Fra le teorie della personalità, la psicoanalisi può considerarsi la prima ad essersi
posta l’obiettivo di fornire un sistematico paradigma interpretativo della struttura
psicologica e dei meccanismi psicodinamici agenti nella persona umana. E,
sebbene i diretti contributi della psicoanalisi nel fornire una sua specifica teoria
criminologia sono stati assai modesti, ben più rilevante è stato il suo apporto
nell’aprire nuove vie per comprendere in generale la condotta umana e, quindi,
anche quella delittuosa
La psicoanalisi è venuta a far parte del patrimonio culturale italiano molto più tardi
che negli altri paesi perché (come anche la sociologia) fu osteggiata dal regime
fascista.
Da quando Sigmund Freud (1856-1939) pose le basi della sua dottrina sono molto
cambiati sia gli uomini sia il mondo e, di conseguenza, molte delle sue asserzioni
appaiono incompatibili con le più recenti acquisizioni scientifiche. Del resto, che la
73
psicoanalisi fosse una vera scienza è stato da sempre contestato perché le sue
asserzioni sfuggono alla possibilità della verifica sperimentale e perché non le è
applicabile il principio di falsificalbiltà di Karl Popper.
Due contributi della psicoanalisi sono rimasti comunque fondamentali
indipendentemente dal far proprie tutte le implicazioni che la teoria comporta; il
concetto di inconscio e quello di visione dinamica della psiche. Infatti, mentre in
precedenza la personalità era praticamente identificata con l’area della coscienza,
intesa come consapevolezza, la lezione psicoanalitica ha indicato come i pensieri, le
scelte e i bisogni coscienti dell’uomo siano collegati con forze psichiche profonde,
prima sconosciute: l’inconscio, appunto. Di conseguenza, una psicologia che si
limiti ad analizzare solamente ciò di cui si è consapevoli sarà per la psicoanalisi del
tutto incapace di comprendere i motivi veri e primari del comportamento umano.
Secondo Freud, si possono identificare nella personalità tre istanze fondamentali:
l’ES, l’Io e il Super-Io, da intendersi come tre livelli o momenti dell’attività
psichica e sebbene ognuna di queste componenti si a dotata di funzioni, proprietà e
dinamismi propri, la loro interazione è così intima da rendere difficile scinderne i
singoli effetti e valutarne separatamente le conseguenze sul comportamento umano.
-
L’Es – è l’istanza posta all’origine della personalità, è il nucleo primitivo
e la matrice nel cui seno si differenziano successivamente l’Io e il Superio. Lo compongono tutti i fattori psicologici ereditari e presenti alla
nascita, compresi gli istinti e gli impulsi, le passioni, le idee e i sentimenti
rimossi. L’Es rappresenta inoltre il serbatoio dell’energia psichica nel
senso che l’Es, e in particolare gli istinti vitali fondamentali, costituiscono
la sorgente della forza dalla quale deriva ogni spinta ad agire. Tutto ciò
che è contenuto nell’Es ha la caratteristica di essere inconscio, perciò
l’uomo non è consapevole di quali siano le pulsioni e gli istinti collocati
nel suo profondo, che pure costituiscono il motore di ogni sua attività. In
una prima fase, Freud identificò nell’istinto sessuale la fonte primaria e
unica dell’energia (libido) e lo stimolo vitale da cui derivava ogni spinta:
la libido cioè non serviva solo a realizzare le pulsioni sessuali ma era
l’impulso per ogni tipo di azione. Tale visione era perciò monopolare in
quanto un solo istinto, quello sessuale, dominava e promuoveva il
comportamento. Freud in seguito cambiò questa prima versione ed
identificò nell’Es due istinti contrapposti (visione bipolare): l’uno è
l’istinto di vita (Eros) che contiene le cariche sessuali ma anche tutte le
pulsioni vitali e le spinte all’azione; l’altro è l’istinto di morte (Thanatos)
che mira invece a ricondurre verso l’inerzia, verso la quiete, verso
l’inattività da cuci l’uomo ha avuto origine con la nascita e a cui tende
con la morte a ritornare. In ogni caso, gli istinti per realizzarsi danno
origine a una carica interna che comporta aumento di energia: ciò si
traduce in stato di tensione. Quando la tensione dell’organismo aumenta
per l’azione degli stimoli pulsionali, l’Es opera in modo da scaricarla
immediatamente per riportare l’organismo al livello energetico di base. Il
superamento della tensione si realizza soddisfacendo con l’azione le
pulsioni istintuali: l’Es, che non tollera gli aumenti di tensione, agisce
pertanto stimolando l’uomo a dar soddisfazione immediata e diretta ai
74
propri istinti. Questo meccanismo di riduzione della tensione mediante il
soddisfacimento immediato delle pulsioni, da cui l’Es è governato, viene
denominato principio del piacere.
-
L’Io – si sviluppa in conseguenza dei bisogni dell’individuo che
richiedono rapporti adeguati col mondo oggettivo della realtà, rapporti
che l’Es non è in grado di avere dato che conosce solo la realtà psichica
soggettiva, costituta dal suo mondo pulsionale. L’Io invece sa distinguere
i contenuti mentali dalla realtà del mondo esterno. Quindi, mentre l’Es
obbedisce al principio del piacere, l’Io opera in funzione del principio
della realtà: egli è in grado cioè di dilazionare il soddisfacimento delle
pulsioni fino a quando non siano a disposizione l’oggetto richiesto o le
opportunità situazionali idonee a ridurre la tensione. L’Io quindi agisce
nel reale organizzando l’azione in modo da consentire all’uomo di
soddisfare concretamente i bisogni mettendoli a confronto con le
possibilità offerte dal reale. Esame di realtà, si denomina appunto la
funzione dell’Io consistente nel valutare i dati oggettivi e nell’esaminarne
l’idoneità ai fini di soddisfare le pulsioni. L’Io rappresenta quindi la
componente esecutiva della personalità.
-
Il Super-io – è il rappresentante interiore dei valori etici e delle norme
sociali; esso si va strutturando nel corso dell’infanzia, facendo propri,
mediante il meccanismo dell’identificazione, i contenuti etici e le regole
di comportamento dei genitori e poi delle altre persone con le quali si è
venuti a contatto. Il Super-io esercita la funzione di arbitro morale interno
della condotta, sia disapprovando i comportamenti contrari alle norme
sociale e facendo sentire l’uomo colpevole (funzione questa che viene
chiamata “coscienza”) sia approvandolo e facendolo sentire orgoglioso di
sé quando la sua condotta è conforme alle regole e adeguata a quell’ideale
di sé che ciascuno tende a perseguire secondo i modelli che genitori e
società impongono.
Riassumendo, in senso figurato, possiamo considerare l’Es come la
componente biologica della personalità, l’Io come quella psicologica, il
Super-io come quella sociale e morale e le tre istanza vanno intese come
semplice denominazione verbale di processi psichici agenti nell’unità della
persona.
La concezione psicoanalitica della personalità è essenzialmente dinamica nel
senso che è proposta tutta una continuità di meccanismi interiori che rende
conto del formarsi e del modificarsi nel tempo della personalità: esiste una
reciproca azione di forze impulsive (cariche) e di forze costrittive o
antagoniste (controcariche) dal cui reciproco confronto e dalle cui
reciproche compensazione e armonia deriva l’equilibrio dell’individuo.
Tutti i conflitti della personalità e tutti i conflitti fra la persona e l’ambiente
sociale, possono ridursi a contrapposizioni tra queste due categorie di forze.
Quando l’Io viene sopraffatto da uno stimolo eccessivo che non riesce a
dominare e non è possibile un equilibrato compenso fra le forze antagoniste
75
dell’Es e del Super-io, l’Io stesso vive una situazione di pericolo che porta
all’angoscia.
L’angoscia o ansia soggettivamente vissuta come disagio, sofferenza, timore,
è pertanto l’espressione di una non realizzata soluzione delle conflittualità fra
le istanze interiori, ovvero fra l’individuo e l’ambiente.
Freud distinse tre tipi di angoscia:
1. l’ansia reale – che è il timore di un pericolo insito nella realtà
oggettiva;
2. l’ansia sociale – cioè il timore della riprovazione degli altri per aver
commesso qualcosa di contrario alle norme che regolano la
convivenza;
3. l’ansia nevrotica – espressione del timore della severità del Super-io
quando gli istinti, sfuggendo al controllo, costringono la persona a
pensare, sentire, fare qualcosa (ma anche pensare o provare un
sentimento) per cui verrà riprovata appunto dal Super-io,
ingenerandosi così il senso di colpa. Questo tipo di ansia è la più
temibile perché la mancata armonizzazione fra pulsioni e coscienza,
fra richieste dell’istinto ed esigenze morali pone l’individuo in uno
stato di grave pericolo per il suo equilibrio interiore.
Normalmente l’Io è in grado di risolvere i contrasti fra le opposte istanze in
modo armonico utilizzando meccanismi razionali ma quando questi non
sono sufficienti, l’Io ha a disposizione altri particolari meccanismi psichici
che gli consentono di trovare ugualmente l’equilibrio: questi sono i
meccanismi di difesa dell’Io mediante i quali ci si difende dal pericolo della
nevrosi e della psicosi posto che questi stati morbosi si realizzano quando i
meccanismi di difesa falliscono.
I meccanismi di difesa sono molteplici:
1. la rimozione – consiste nel respingere dalla coscienza nell’inconscio qui
contenuti che provocano un allarme eccessivo. Tutte le pulsioni istintuali che
non possono essere accettate dal Super-io vengono rifiutate ma se esse non
trovano compensazione cagionano nell’inconscio una tensione da cui può
derivare una condizione di squilibrio;
2. la dislocazione – consiste nel fatto che una pulsione istintuale rivolta verso
un obiettivo e che sia respinta (dalla morale pubblica, dall’educazione o da
controcariche interne della coscienza) può essere deviata su altri oggetti o
altre mete. D’altro canto un oggetto sostitutivo non sempre riesce a ridurre
completamente la tensione originata dalla pulsione istintuale non soddisfatta
per cui si può accumulare un continua carico di tensione tanto più elevato
quanto più il Super-io è rigido, cioè inflessibile e rigoroso nel rifiutare certi
impulsi o quanto più la società pone norme costrittive al soddisfacimento
istintuale. Da ciò deriva l’insoddisfazione e l’irrequietezza.
76
3. la sublimazione – consiste in uno spostamento dell’energia istintuale per
conseguire le più elevate conquiste culturali o per raggiungere mete
altruistiche o morali
4. la proiezione – consiste nel disconoscere alcuni aspetti negativi della propria
personalità attribuendoli ad altri, così ottenendo il risultato di deviare sul
mondo esterno le conflittualità interiori. I processi di responsabilizzazione
comuni a tanti criminali (come in tutti quelli che “cercano scuse”) traggono
origine da questo meccanismo di difesa mediante il quale l’angoscia
derivante dalla riprovazione è attribuita al mondo esterno piuttosto che alle
minacce della coscienza. Tale meccanismo al di là della formulazione
freudiana, è di riscontro frequente nella forma di meccanismi di
neutralizzazione che, secondo Matza, vengono usati per autoassolversi.
5. la formazione reattiva – è un altro meccanismo di difesa che implica la
sostituzione nella coscienza di un impulso o sentimento che genera angoscia
col suo opposto (amore/odio). Un impiego in ambito criminologico di questo
meccanismo lo troviamo in Cohen a proposito delle sottoculture urbane dei
giovani delinquenti.
6. la fissazione e la regressione – la personalità di ogni individuo, per
raggiungere la maturità attraversa fasi successive di sviluppo affettivoemotivo, abbastanza ben definite (fase orale, fase anale, fase fallica, fase
genitale). Ogni nuovo passaggio comporta una certa quantità di frustrazione
e di angoscia: qualora queste divengono eccessive può realizzarsi un arresto
(fissazione) temporaneo o permanente in una certa fase dello sviluppo senza
che venga pertanto raggiunta la piena maturazione. Invece, le difficoltà
derivanti dall’incapacità di superare esperienze traumatiche possono
comportare il ritorno (regressione) a fasi anteriori e già superate dello
sviluppo (es. rifugio nell’alcolismo e nella droga può essere interpretato
come una regressione alla fase orale dello sviluppo)
7. l’identificazione – mediante questo processo una persona mira a rendersi
simile o ad assumere tratti psicologici caratteristici di un altro individuo che
viene eletto a proprio modello; si incorporano così nella propria personalità
contenuti psicologici e valori, norme comportamentali e principi morali
propri della persona eletta a proprio modello ideale. L’identificazione non si
realizza globalmente per tutte le caratteristiche di colui che è stato preso a
modello ma in modo selettivo, assumendo cioè via vai solo quei contenuti
psichici e quei valori che risultano più utili per ridurre la tensione.
L’identificazione è anche una fondamentale modalità di apprendimento e di
trasmissione nel tempo delle regole e dei valori della società dal momento
che anche i modelli di identificazione hanno a loro volta formato il loro
Super-io mediante l’identificazione con altri: si assicura così la continuità
nella cultura dei valori morali e delle regole sociali.
77
53 – Psicoanalisi e criminalità
La teoria psicoanalitica della personalità offre la possibilità di interpretare talune
modalità della condotta criminale. Si tratta dell’utilizza della chiave di lettura della
psicoanalisi anche per la identificazione di alcuni meccanismi della criminogenesi.
La visione dell’Io come istanza consapevole dell’uomo continuamente in bilico tra
le spinte dell’istinto e le controspinte del Super-Io ha accreditato una lettura
sostanzialmente deterministica della teoria psicoanalitica della personalità. L’Io cioè
non sarebbe altro che il passivo esecutore di istanze a lui estranee e nei confronti
delle quali, quindi, possiede ben poca autonomia: l’uomo pertanto non avrebbe
alcuno spazio di libertà rispetto alle proprie pulsioni istintuali e alla severità del
Super-Io quasi fossero altro da sé. Quindi la libertà di scelta e la responsabilità
scompaiono nel momento in cui l’individuo agisce solo spinto da forze che non può
controllare. Questa visione tanto rigida è stata però oggi superata da molti
psicoanalisti che considerano l’Io come dotato di maggior autonomia, non più
necessariamente succube dei desideri dell’Es e dei conflitti fra le diverse istanze ma
con possibilità di scelta perché provvisto di proprie energie.
Il più organico contributo psicoanalitico in ambito criminologico è quello di
Alexander e Staub (1929).
Secondo questi autori la condotta criminosa è l’effetto di molteplici modalità dello
svincolo dal controllo del Super-io. Essi identificano diverse condizioni nelle quali
il controllo dell’istanza superiore si riduce fino ad abolirsi completamente, secondo
il seguente schema:
1. la normalità (o integrazione sociale) – è rappresentata dal pieno controllo
del Super-io sul mondo pulsionale-istintuale: in tali condizioni vi è piena
conformità di condotta e rispetto delle regole;
2. la delinquenza fantasmatica – nella quale il controllo delle pulsionalità
antisociale è ancora pienamente efficiente sul comportamento tant’è vero che
l’individuo non delinque; esistono tuttavia istinti antisociali più pressanti che
il soggetto riesce comunque ad arginare mediante il processo della
dislocazione dell’antisocialità sul piano della semplice fantasia (ammirazione
per i personaggi devianti dei film);
3. la delinquenza colposa (condotta motivata da imprudenza, negligenza,
imperizia) – può essere interpretata col meccanismo della dislocazione delle
pulsioni aggressive: l’aggressività che il Super-io non consente che si realizzi
come tale, cioè come violenza volontaria, verrebbe estrinsecata attraverso
una condotta imprudente o negligente che provoca ugualmente danno alla
persona osteggiato o alle sue cose;
4. la delinquenza nevrotica – nella quale la condotta criminale rappresenta un
sintomo di una situazione conflittuale profonda. Il Super-io non ha
completamenti rinunziato al controllo dell’antisocialità e questi si realizza
unicamente per l’esistenza di profondi contrasti interiori che trovano una
possibilità di soluzione nella condotta deviante. Quest’ultima è dunque non
l’effetto di un progetto razionale e consapevole o di un ideale dell’Io di tipo
criminale ma una sorta di ripiego per eliminare la tensione delle conflittualità
78
interiori: la delittuosità nevrotica (piuttosto rara) non essendo completamente
accettata si accompagna pertanto a sensi di colpa (es. cleptomania).
5. delinquenza occasionale e affettiva – viene definita così quella delinquenza
che si attua appunto solo in circostanze eccezionali, particolarmente
favorevoli allo svincolo delle controspinte superiori (delitti per passionalità,
delitti scaturiti da violenti diverbi, in stato d’ira). Tale tipo di delinquenza per
gli autori è anche quella commessa quando vi sia un’ampia probabilità di non
essere scoperti oppure quando un oggetto desiderato è offerto in modo
suggestivo (furti nei grandi magazzini).
6. Delinquenza normale – rappresenta l’ultimo stadio, dove il controllo del
Super-io cessa completamente e l’Io può realizzare senza ostacoli le pulsioni
aggressive e antisociali: non essendovi più controllo superegoico il
delinquente non si sentirà in colpa per la sua condotta.
Da quanto abbiamo appena considerato, appare chiaro come l’adeguamento alla
vita sociale è da vedersi essenzialmente in funzione dell’efficienza del Super-io.
Il Super-io può essere:
1. anomalo - essendo strutturato come Super-io criminale gli ideali dell’io
sono strutturati in modo antisociale e il soggetto adegua la sua condotta
che diviene pertanto criminale;
2. debole - e non costituire una guida sufficientemente costante e valida per
la condotta: ciò si realizza quando vi siano stati fattori desiducativi
ambientali, difetti dei processi di identificazione, inadeguatezza della
famiglia o mancanza di modelli;
3. del tutto assente - si realizza in tal modo un inadeguamento globale alla
vita sociale.
Concludendo, per Alexander e Staub, si possono distinguere due tipi
fondamentali di delinquenza:
o la delinquenza accidentale – nella quale sono assenti tratti psicologici
devianti delle personalità e la delittuosità può realizzarsi con delitti
colposi o con delitti occasionali correlati a situazioni eccezionali che
inattivano il Super-io in stati di particolare pregnanza emotiva o per
occasioni particolarmente favorevoli o allettanti;
o la delinquenza cronica – che rappresenta la propensione al delitto
dovuta alla struttura stessa della personalità: essa può dipendere dal fatto
che l’Io è fragile o compromesso (per fatti tossici, per difetto
d’intelligenza) o perché esiste una condizione nevrotica perché il Superio è strutturato in modo anomalo e il delitto è coerente con l’anomala
struttura dell’istanza superiore o infine perché il Super-io è assente e
quindi la condotta dell’individuo è in balia degli istinti.
Importanti contributi di matrice psicoanalitica sono stati utilizzati al fine di
comprendere la criminogenesi (il perché del comportamento criminoso) e la
criminodinamica (il come). In base a questi studi si potrà comprendere, per
esempio, quanto l’armonica struttura dell’istanza superiore possa essere
79
compromessa dai disturbi nel rapporto con le figure parentali. Il processo
di identificazione con le figure dei genitori rappresenta infatti il primo nucleo
attorno al quale si formerà il Super-io, e disturbi in questa fase si
ripercuoteranno sulla definitiva struttura della personalità. Assenza o
lontananza dei genitori, genitori iperoccupati, autoritari, troppo deboli,
iperprotettivi, indifferenti, sono stati indicati come causa di disturbo nella
formazione del Super-io così da favorire la condotta criminosa. Inoltre,
l’identificazione con figure parentali antisociali può concorrere alla
formazione di un Super-io criminale.
E’ stata identificata anche una delinquenza per senso di colpa: alcuni
soggetti agirebbero cioè in modo criminoso unicamente per essere poi puniti,
e soddisfare, così, senza rendersene conto, un bisogno inconscio di
espiazione di stampo nevrotico.
In certe situazione, poi, i comportamenti criminali sono stati interpretati
come originati dalla fissazione alla fase del principio del piacere: la
delinquenza, in questo caso, esprimerebbe un modo di dar soddisfacimento
diretto alle pulsioni. Le frustrazioni ambientali e familiari, la marginalità, le
sconfitte, l’assenza di ragionevoli prospettive di successo sociale, sono
tipiche situazioni che ostacolano il processo di maturazione verso la fase
governata dal principio di realtà, favorendo la fissazione o la regressione a
modalità più immature di condotta.
Questa, come altre interpretazioni psicodinamiche, comportano il rischio di
fornire una lettura della condotta criminosa che finisce per essere
deresponsabilizzativi perchè il delinquente viene percepito come se fosse
costretto a delinquere da forze da lui non governabili. Il tanto deprecato
determinismo della psicanalisi consiste proprio nel fatto che vendono da
taluni ignorate, nel gioco delle dinamiche psicologiche, le componenti
volontarie e morali che sono pur sempre alla base delle scelte
comportamentali.
Meccanismo reattivo messo alla luce dalla psicoanalisi e tipicamente
collegato alla immaturità affettiva è quello dell’acting-out (passaggio
all’atto) che rappresenta una modalità impulsiva di comportamento mirante a
risolvere l’ansia, particolarmente quella derivante da eccesso di frustrazione,
con una condotta anomala: molti comportamenti criminali, specie nei
giovani, assumono il significato di azioni realizzate come compenso di gravi
carenze affettive o materiali. L’acting-out criminoso si caratterizza per il
fatto che il reato non appare in relazione a motivi o scopi normali e coscienti
(lucro, vendetta, ecc.) ma rappresenta una scarica o un sollievo da una
tensione emotiva riferibile a conflittualità o frustrazione. Questo meccanismo
non solo è all’origine di reati di tipo aggressivo ma può concretarsi anche in
furti commessi per liberarsi da tensioni interiori.
Altro aspetto dell’immaturità è rappresentato dalla bassa soglia di
tolleranza alla frustrazione: un adeguato esame di realtà, quale effettua una
personalità matura è condizione indispensabile per accettare quella dose di
80
frustrazione che inevitabilmente comporta la convivenza sociale. Quanto più
bassa è la tolleranza alla frustrazione di un soggetto tanto più facilmente egli
sarà indotto a reagire con aggressività o con impulsività, alla frustrazione
stessa. Ad analoga situazione si ricollega anche il meccanismo della difesa
dalla frustrazione mediante l’identificazione del frustrato nel frustratore: il
soggetto che ha subito ripetute frustrazioni può eleggere come propri modelli
di identificazione, figure per lui altamente frustranti divenendo pertanto egli
stesso, con l’adeguarsi ai modelli, un soggetto frustratore.
L’incapacità di identificarsi col prossimo caratterizza, secondo Musatti,
molti degli autori di reati contro la persona; fa in loro difetto quella qualità
comune invece nelle altre persone, per la quale normalmente si condivide il
dolore e la pena altrui come se fossero nostri, qualità che consente pertanto di
controllare la violenza. In quest’ottica, Musatti classifica le condotte
criminose violente in questo modo:
1. condotte dovute a deficienza globale di identificazione con
l’oggetto dell’impulso aggressivo – come accade per esempio nella
legittima difesa;
2. condotte dovute a processi di identificazione soltanto parziale – in
base al fatto che determinati valori morali non sono fortemente
avvertiti come veri e propri valori (è il caso delle sottoculture violente
o delle bande giovanili di tipo distruttivo);
3. condotte dovute a processi di identificazione particolari –
attraverso i quali la passività alla violenza si converte in attività (è il
caso della identificazione del frustrato nella figura del frustratore)
Al meccanismo di difesa della proiezione è da attribuirsi l’atteggiamento di
deresponsabilizzazione riscontrabile in tanti criminali. Proiettando su altri
(famiglia, società) la responsabilità della propria condotta criminosa, ci si
sente anziché colpevoli piuttosto delle vittime, ci si libera dal senso di colpa
e si mette il prossimo (costà, giudici, operatori penitenziari) nella posizione
di chi infierisce su un innocente.
L’incapacità di sublimazione della libido, cioè l’incapacità di indirizzare la
pulsionalità verso mete socialmente accettate anziché su oggetti proibiti,
rende conto di comportamenti delinquenziali primitivi, immediati e miranti a
soddisfare i bisogni e le pulsioni nelle modalità più rozze.
Nonostante i tanti importantissimi contributi per la comprensione della
condotta criminosa, la psicoanalisi, con l’eccessivo indulgere nella ricerca di
interpretazioni psicodinamiche può comportare il rischio di intendere ogni
criminale come persona in qualche modo psicologicamente disturbata, col
risultato di “patologizzare” la delinquenza; inoltre, le inconsce e spesso
tortuose dinamiche ipotizzate in chiave psicoanalitica rischiano di far perdere
di vista la quotidiana realtà.
81
54 – La psicologia analitica di Jung
La teoria analitica di Jung (1875-1961) fornisce una visione dell’uomo
diversa da quella psicoanalitica freudiana dalla quale deriva e propone
concetti importanti per la comprensione della condotta deviante.
Jung ha distinto, oltre all’inconscio nel senso inteso dalla psicoanalisi
classica, un inconscio collettivo, che trascende l’individuo e costituisce
l’istanza psichica più potente e di maggior influenza.
Mentre Freud vede le origini della personalità nell’infanzia, Jung risale ben
più addietro, cosicchè l’uomo è inteso come dotato di predisposizioni
trasmessegli fin dai suoi più lontani antenati.
Mentre la psicoanalisi freudiana attribuisce agli antecedenti (gli istinti, i
conflitti, i meccanismi di difesa, ecc.) un significato e un valore di causa
determinante
del
comportamento
presente,
Jung
considera
contemporaneamente, assieme agli elementi sedimentati dal passato che
agiscono in lui inconsciamente, perciò al di fuori del suo consapevole
controllo, anche la dimensione dell’individuo proiettato verso il futuro a
conseguire conformemente alla sua volontà gli obiettivi che si prefigge.
L’istanza fondamentale è rappresentata dal Sé, che costituisce il punto
centrale della personalità, e alle cui unità, stabilità ed equilibrio mira
costantemente l’individuo. L’uomo, pertanto, non agisce solo spinta dagli
istinti e dall’inconscio ma anche perché organizza la propria vita per
raggiungere le sue finalità e aspirazioni.
Concetto fondamentale della psicologia analitica è il concetto di conflitto
psichico da intendersi come l’urto fra forze, pulsioni, controspinte insite
nella psiche dell’individuo.
Con il termine di frustrazione, si indica invece quella condizione di disagio
psicologico che insorge quando taluni bisogni o aspirazioni non possono
essere soddisfatti a causa di ostacoli esterni ed anche ciò provoca, come nel
conflitto psichico, uno stato di tensione particolarmente spiacevole.
Dinanzi alla tensione, si possono realizzare modalità comportamentali di
differente polarità:
1. l’atteggiamento estroverso o alloplastico – che orienta l’individuo
verso il mondo oggettivo della realtà esterna, è caratteristico di coloro
che risolvono la tensione con l’azione, che tendono cioè a rispondere
alla frustrazione o al conflitto psichico agendo verso l’esterno, sulla
realtà, proiettando eventualmente sull’ambiente i loro problemi con
una condotta abnorme. Non si ha in tal caso la prevalenza di
sofferenza interiore e si parla in questo caso di una modalità di essere
di tipo ego-sintonico, perché l’individuo è in accordo con se stesso, si
sente nel giusto, e la sofferenza causata dalla sua condotta si riversa
sugli altri e sull’ambiente. In questo caso, la proiezione dei conflitti
sull’ambiente può portare a commettere più facilmente delitti.
82
2. l’atteggiamento introverso o autoplastico – che indirizza l’attività
psichica prevalentemente verso il proprio mondo soggettivo, è tipico
di quegli individui che risolvono ed esauriscono la tensione all’interno
della propria psiche, con sofferenza, disagio, ansia. Questa modalità di
reagire è pertanto di tipo ego-distonico, poiché l’individuo è
interiormente combattuto e in disaccordo con se stesso. In questo
caso, le condotte antigiuridiche saranno più rare perché la risposta alla
tensione non si risolve in azione nella realtà.
55. Psicologia sociale: Adler e Fromm
Dalla psicoanalisi ha preso avvio un importante filone che ha dato corpo ad
una serie di teorie che hanno riservato particolare attenzione alle interazioni
che avvengono fra gli individui all’interno del sistema sociale e alla
ripercussioni di tali interazione sulla personalità. Questo filone è la
psicologia sociale che può essere dunque definita come lo studio delle
relazioni interpersonali nel contesto sociale, ovvero del modo secondo il
quale la vita sociale si riflette sulle manifestazioni psichiche della persona.
Secondo la psicologia sociale, la personalità non può essere studiata in sé ma
solo nell’ambito dei continui rapporti che si instaurano fra l’individuo, le
altre persone e i gruppi: l’uomo, come entità psichica e come essere agente
nella società, è motivato e influenzato anche dalle relazioni interpersonali. Lo
studio dei rapporti tra gli individui, poi, oltre che tener conto della reciprocità
di essi, deve considerare che tali interrelazioni avvengono nell’ambito di un
contesto sociale, cioè in istituzioni e ambienti organizzati (famiglia, scuola,
luoghi di lavoro, gruppi, comunità, nazione) che includono categorie,
gerarchie, norme, valori che sono del pari fondamentali nel regolare le
interazioni umane.
Le teorie psicosociali possono farsi risalire a quel secondo filone di
derivazione psicoanalitica che fa capo ad Alfred Adler (1870-1937). La
psicologia adleriana considera l’individuo come mosso, anziché da cause
interiori (quali gli istinti, le dinamiche insite nelle sue varie istanze o
l’inconscio collettivo) piuttosto dalle prospettive e dai bisogni legati al suo
essere inserito nella società.
Adler vede nella volontà di potenza l’impulso fondamentale che muove
l’uomo: essa prende l’avvio dalla sua innata aggressività e costituisce la
fonte di energia psichica che consente all’individuo di realizzare le sue
aspirazioni verso la superiorità, meta ultima di ogni condotta. La volontà di
potenze inoltre sostituisce ciò che per Freud è la libido o l’Eros, vale a dire il
serbatoio di energia che promuove ogni attività: essa si realizza in una rete
di rapporti interpersonali che, iniziando dall’infanzia, si sviluppa nell’arco
della vita, fornendo sbocchi concreti all’aspirazione alla superiorità. Per
converso, il contatto sociale può alimentare, con l’insuccesso, sentimenti di
inferiorità, intesi come senso di incompiutezza e di imperfezione ma questo
83
sentimento, a sua volta, è il punto di partenza che stimola l’individuo verso il
conseguimento di livelli di aspirazione più alti.
In condizioni particolari (iperprotezione, carenza affettiva familiare, innata
disposizione) il sentimento d’inferiorità può essere talmente accentuato da
provocare manifestazioni anomale tanto da sviluppare un complesso di
inferiorità (a sua volta responsabile di atteggiamenti o condotte anomale per
la consapevolezza della propria inefficienza) ovvero una condizione opposta
di ipercompensazione altrettanto disturbante (complesso di superiorità).
Volontà di potenza, complesso di inferiorità, complesso di superiorità sono
processi psicologici che non infrequentemente possono ravvisarsi nella
criminogenesi di taluni soggetti.
La psicologia di Fromm sottolinea ulteriormente l’importanza del contesto
sociale: il tema della sua riflessione è quello della solitudine e
dell’isolamento che l’uomo prova se non armonicamente inserito nel suo
ambiente sociale; ambiente con il quale peraltro può facilmente entrare in
conflitto per la situazione ambivalente di sentirsi all’un tempo essere
individuale ed essere sociale. Nel pensiero di Erich Fromm (1900-1980) la
condizione dell’uomo, per il suo equilibrio e armonia, comporta anche il
soddisfacimento di fondamentali esigenze non materiali:
1. il bisogno di relazioni - in quanto per divenire individuo socializzato
ha bisogno di amore, comprensione e rispetto reciproco continuo;
2. il bisogno di trascendenza - che si ricollega alla necessità dell’uomo di
elevarsi al di sopra della sua struttura animale mediante la creatività;
3. il bisogno di avere schemi di riferimento - cioè di un sistema stabile e
coerente di valori che gli consentano di percepire e comprendere il
mondo, schemi che gli vengono forniti dal costume, dalla cultura,
dalle norme;
4. il bisogno di identità personale – l’uomo ha anche necessità di sentirsi
un individuo unico e riconoscersi in una immagine di se stesso
coerente e stabile.
Da tutto questo discende la necessità di associarsi, di sentirsi inserito in un
gruppo per combattere l’isolamento, la solitudine e la carenza di identità.
L’inappagamento o la frustrazione di questi bisogni sono quindi possibili
spinte alla ricerca di compensazioni proprio per la condotta delittuosa.
56. La psicologia sociale: identità personale e teoria dei ruoli
La psicologia sociale ha elaborato due concetti rilevanti in ambito
criminologico:
1) quello di identità personale – che si riferisce al sentimento che in
ciascuno si viene a strutturare in ordine all’assenza, unicità, qualità della
84
propria persona e ai fini e ai mezzi che devono informare il suo inserirsi
nel mondo.
2) Quello di ruolo – che si riferisce alle aspettative che nella società si
formano nei confronti di ciascun individuo in conseguenza della
posizione specifica che egli occupa nella società o delle funzioni che
svolge nei gruppi sociali.
Ai problemi della formazione delle disarmonie della identità personale è
dedicata buona parte del pensiero di Erikson (1963) che intende il
sentimento della propria identità come l’organizzazione di un’immagine
coerente, omogenea, continua e stabile dell’essenza della propria personalità.
La formazione dell’identità si realizza:
-
attraverso l’identificazione con successivi modelli significativi;
-
attraverso i ruoli via via proposti e assunti.
Questo iter ha il suo culmine formativo durante l’adolescenza. In questa fase
e anche successivamente, un rapporto disarmonico con la famiglia o coni vari
gruppi di appartenenza può portare a una disturbata strutturazione della
identità personale, visto che questa è fortemente influenzata
dall’atteggiamento degli altri.
Se per questa cattiva organizzazione della identità, o per qualsiasi altro
motivo, si verifica qualche iniziale comportamento deviante o delinquenziali,
si risvegliano nel prossimo aspettative negative nei confronti di tali soggetti:
ciò finisce con l’alterare l’identità personale sicchè l’attore realizza poi
stabilmente con la condotta deviante o criminosa il giudizio negativo
anticipato nei suoi confronti (profezia che si autoadempie).
La società, i gruppi, la famiglia continuamente confermano pertanto il
sentimento dell’identità personale con i giudizi, le valutazioni, le
gratificazioni, le frustrazioni. Ma in talune condizioni la società provoca una
serie di degradazioni e mortificazioni che possono alle volte condurre a una
immagine di sé valorizzata, che si denomina identità negativa. In questi casi
l’individuo riconosce se stesso come persona con valori socialmente negativi
perché i gruppi sociali gli hanno attribuito questa qualità (è lo stesso processo
dell’etichettamento). Il giudizio squalificato che un gruppo formula verso un
individuo fa sì che quest’ultimo sia facilitato ad adeguarsi a tale ruolo
negativo, assumendo una identità a esso conforme, e adottando quindi una
condotta stabilmente deviante.
Quindi, l’atteggiamento del prossimo e i giudizi istituzionali, riflettendosi sul
sentimento della propria identità possono (nel senso che favoriscono) tradursi
in fattori di decisivo influenzamento comportamentale ma non
necessariamente comportano un destino comportamentale delinquenziale.
La formazione della propria identità è influenzata oltre che dal giudizio degli
altri anche dalla posizione che ciascuno occupa nella società e dalle funzioni
che vengono svolte in coerenza alla posizione occupata. La posizione di ogni
individuo nella società, o status, costituisce un sistema relazionale che
85
caratterizza ogni persona in base a una serie di diritti e di doveri che regolano
i suoi rapporti di interazione con persone di altro status.
In tutte le società esiste un certo numero di status, tanto più elevato quanto
più la società è complessa tanto da formare un vero e proprio sistema nel
quale ciascuno occupa contemporaneamente più posizioni. Taluni di questi
status sono ascritti in funzione di ciò che una persona è (per l’età, per il
sesso, per la razza) mentre altri sono acquisiti in base a ciò che uno può fare
e divenire a partire dalla posizione sociale.
Ciò che in criminologia è importante è il fatto che in ogni tipo di società ogni
status è legato a norme che ne regolano i rapporti con gli altri, e ad
aspettative circa l’osservanza dei compiti spettanti a chi occupa quello status:
questo è quello che si intende per ruolo. Questo concetto si riferisce dunque
alle attese che esistono nella società nei confronti di chi occupa una
determinata posizione ma in questo concetto è insita la consapevolezza
nutrita da chi occupa quel ruolo su ciò che gli altri si attendono da lui: ciò si
riflette sull’identità personale, per cui ciascuno finisce per avere un
sentimento di sé coerente e conforme al proprio ruolo. Se esiste un ruolo
prescritto (allo studente è prescritto di apprendere, all’insegnante di fornire
nozioni e cultura, ecc.) esistono anche un ruolo soggettivo (la professione è
pur sempre una decisione personale così come quella di fare il delinquente) e
un ruolo svolto (divenire un insegnante impegnato o uno studente svogliato)
che sono liberamente scelti dai soggetti anche se condizioni ambientali e
varie circostanze possono favorire l’uno piuttosto che l’altro.
Significativo, in senso criminogenetico, è l’occupare un ruolo negativo. Una
serie di status squalificati (per ceto, posizione economica, regione di nascita,
razza, immigrazione, ecc.) facilitano l’assunzione di ruoli altrettanto
squalificati che favoriscono la scelta comportamentale delinquenziale.
Erving Goffman (1961) ha particolarmente sottolineato l’influenza sul
sentimento di identità e sulla stabilizzazione in ruoli negativi dell’essere
inseriti negli istituti correzionali, nelle carceri, nei manicomi, negli istituti
rieducativi e in tutte quelle istituzioni che egli chiamò istituzioni totali
perché coinvolgono globalmente l’individuo, deformandone la personalità e
limitandone le prospettive. All’individuo inserito nell’istituzione totale
veniva prospettata come più reale e più probabile l’identificazione in truoli
squalificati; egli era sentito come ridotto ad una condizione di passività che
gli frustrava l’aspirazione ad assumere o riassumere ruoli socialmente
accettabili, che gli sarebbero apparsi irraggiungibili con i propri mezzi;
avrebbe finito pertanto con l’accogliere, quale propria identità, quei modelli
negativi che l’istituzione gli proponeva e gli suggeriva, andando così a
occupare stabilmente ruoli altrettanto negativi. Le istituzioni totali ed i ruoli
negativi che in esse più facilmente si assumono svolgerebbero dunque una
parte di rilievo nell’aggravare le difficoltà di reinserimento e nel favorire la
cronicizzazione in carriere criminali persistenti. Queste considerazioni hanno
fortemente influenzato importanti scelte di politica sociale come l’abolizione
dei manicomi, la tendenza a non rinchiudere i giovani delinquenti in istituti
correzionali, la tendenza a far sempre minore ricorso al carcere.
86
Queste interpretazioni psicosociali devono, in conclusione, favorire la
comprensione dei meccanismi agenti nei rapporti fra gli uomini ma non
devono tradursi in atteggiamenti che siano delle complete
deresponsabilizzazioni nei confronti della condotta dei singoli attori né
devono sfociare nella troppo meccanicistica visione di destini inevitabili o di
colpe unicamente attribuibili alla società, senza che l’uomo sia più percepito
come libero e responsabile e perciò chiamato a rispondere del bene o del
male che ha compiuto.
57 – Psicologia sociale: devianza, emarginazione e marginalità
Alla psicologia sociale siamo debitori di altri tre concetti fondamentali:
-
1) il concetto di devianza – originariamente, nella sociologia strutturalfunzionalista, questo termine aveva il significato di comportamento
anomalo sotto il profilo statistico e raggruppava tutte quelle condotte che
si discostavano dalle regole e costumi sociali condivisi dalla maggior
parte delle persone .Ai tempi della sociologia di sinistra, i devianti hanno
assunto un significato sempre più esteso fino ad essere identificati con
coloro che erano considerati “vittime della società” a causa delle
discriminazioni e dei pregiudizi che le classi egemoni avrebbero
esercitato nei confronti dei “diversi”. E poiché ei confronti dei devianti
viene abitualmente esercitata l’emarginazione e perché pure i delinquenti
vengono emarginati si finì per includere fra i devianti anche i criminali.
Alla fine si giunse ad identificare la criminalità con la devianza. In questo
concetto sono stati racchiusi quindi comportamenti tra loro radicalmente
diversi ed è per questo che è opportuno fare una fondamentale distinzione
fra i diversi comportamenti che sono stati denominati come devianti. Vi
sono comportamenti che non risvegliano sentimenti di riprovazione o
richiesta di sanzioni ma che possono essere indifferenti, ovvero anche
provocare reazioni sociali di solidarietà e offerta di aiuto: in tali termini
queste condotte non provocano giudizi morali negativi, di tali condotte
non viene fatta ai loro autori attribuzione di colpa e non vengono
censurate (atteggiamenti dei vagabondi, di chi esercita la prostituzione,
gli omosessuali, ecc). Più correttamente si debbono considerare devianti
quei comportamenti che suscitano invece reazioni di intensa
disapprovazione e censura con richiesta di sanzione: questi
comportamenti sono attribuiti a titolo di colpa ai loro autori perché non
sono legati allo status in cui una persona si trova per nascita e comunque
non volontariamente ma sono frutto di scelta (tossicomani, terroristi, tutti
i tipi di delinquenti). La intensa disapprovazione e la richiesta di sanzione
risultano pertanto i parametri fondamentali per identificare le condotte
che meritano la qualificazione di devianza. In ultima analisi, la
qualificazione di devianza esprime un giudizio di valore, una valutazione
morale negativa, in funzione dei principi etici di comune accettazione. La
devianza è un concetto sociologico e non giuridico.
87
-
Il concetto di marginalità – Marginalità indica una condizione statica o
uno status cioè la condizione di taluni individui che “si trovano ai margini
della società”. Marginali sono quegli status sociali che provocano, per
persone o gruppi, il “vivere in condizioni diverse e solitamente peggiori
di quelle della società nel suo complesso; la marginalità comporta
riduzione delle aspettative di affermazione sociale, minore responsabilità
sociale, minore partecipazione alla vita e alle decisioni collettive”. Il
fenomeno della marginalità si osserva nei confronti di certi status
collettivi, i giovani, i vecchi, le donne, gli handicappati, le persone di
colore, gli extracomunitari. La marginalità è operata verso coloro che,
nella logica dell’ideologia del profitto, non solo produttivi o hanno
perduto la capacità di produrre beni economici: gli inetti, i pensionati, i
disoccupati La marginalità è anche la posizione nella società di certi
malati cronici e specialmente dei sofferenti di AIDS e dei malati di
mente. Infine, divengono marginali i devianti e i delinquenti. Ma mentre i
devianti o i delinquenti si vengono a trovare ai margini della società a
causa della loro condotta disapprovata, gli altri si trovano ai margini della
società per un pregiudizio aprioristico in funzione del sesso, dell’età, del
luogo di nascita ma non per colpa della loro condotta. Vi sono dunque dei
marginali per il solo fatto di essere quello che sono e marginali per quel
che hanno fatto: in altri termini, vi sono marginali per loro colpa e
marginali senza colpa.
-
Il concetto di emarginazione – L’emarginazione invece è un concetto
dinamico che viene messo in atto dai singoli e dai gruppi nei confronti di
taluni soggetti che si tende a escludere dagli abituali rapporti.
L’emarginazione è il ridurre le prospettive, è il togliere la responsabilità,
è il nutrire aspettative negative rispetto a taluni soggetti a causa della loro
condotta riprovata: essi divengono perciò marginali per colpa della loro
condotta. Il deviante e il criminale sono collocati in una posizione di
marginalità per effetto della emarginazione agita nei loro confronti:
costoro vengono esclusi a cagione del loro comportamento delittuoso o
disapprovato dalla posizione che occupavano. Donne, vecchi, gli invalidi,
la gente di colore sono in condizioni di marginalità ma non vengono
emarginati per la loro condotta ma lo sono perché occupano, in definitiva,
nella società, status più o meno squalificati.
58 – Altri contributi della psicologia
Le fenomenologia è una visione psicologico-filosofica dell’uomo che mira a
comprendere l’uomo “dal suo interno” in modo da scorgere le ragioni della sua
condotta quali emergono dal suo punto di vista e non da quello di chi indaga,
contrariamente alle altre teorie psicologiche che piegherebbero “dal di fuori”
l’uomo così come viene spiegato dall’esterno qualsiasi fenomeno della natura.
L’essere umano non vive in una realtà oggettiva e neutra che esiste di per sé e
indipendentemente da lui ma dà egli stesso vita a una realtà. La diversificazione fra
condotta e realtà, per questa psicologia, è solo apparente, poiché l’unica realtà è la
88
realtà fenomenica, espressione della intenzionalità del soggetto del suo “agire nel
mondo”. Così, l’atto criminoso, secondo questa prospettiva, viene assunto come
rivelatore di un modo di essere che, seppure si ponga violentemente di traverso nei
riguardi degli aspetti etici e normativi del vivere in società, rappresenta pur tuttavia
anche’sso una estrema possibilità espressiva dell’umano.
La teoria del campo di Lewin ha derivato i propri assunti dal concetto di campo di
forze elettromagnetiche tratto dalla fisica: ogni elemento all’interno si un sistema,
detto campo, influenza tutti gli altri elementi e ne viene a sua volta influenzato. In
psicologia ciò significa che l’individuo è costantemente influenzato dall’ambiente, e
non può quindi essere studiato isolatamente da esso, posizione del resto condivisa
da tutta la psicologia sociale. Balloni (1984) ha esteso alla criminologia i concetti
espressi da Lewin considerando “campo” la persona, l’ambiente a lui più vicino
(cioè il suo spazio di vita) e l’ambiente nel senso più ampio. La combinazione di
questi elementi può formularsi come una legge fisica in cui il comportamento, in
questo caso criminoso, è in funzione della persona e dell’ambiente.
La teoria dei sistemi, invece di considerare un fatto o una condotta come effetto
necessario di una causa data (causalità lineare) cerca piuttosto di analizzare le
reciproche influenze tra i fenomeni: relativamente al comportamento umano,
analizza il processo attraverso il quale, in un rapporto interpersonale, la condotta di
un soggetto influenza quella degli altri, cioè la loro risposta, e come di nuovo questa
risposta ha effetto sul comportamento del primo agente (“causalità circolare”).
Questo modello è mutuato dalla cibernetica che sostituisce allo schema delle
scienze classiche della causalità lineare (da A a B) un altro schema in cui per un
fenomeno detto di retroazione o feedback, ognuna delle parti di un sistema influisce
sull’altra (da A a B e da B ad A): essendo ogni parte contemporaneamente causa ed
effetto, la distinzione medesima fra questi due termini perde di significato. Centrale
i questa prospettiva è il concetto di sistema che comprende oltre agli attori o agli
oggetti di un fenomeno osservato anche le relazioni tra di essi, costituendo quindi
una complessità organizzata diversa dalla mera somma delle sue parti.
Relativamente alla criminologia, lo schema interpretativo della teoria dei sistemi è
stato applicato soprattutto nello studio dei rapporti tra reo e vittima, ritenendosi che
talora l’atto aggressivo può essere considerato come il risultato di una serie di
comunicazioni, risposte ed effetti di feedback in cui appunto non sempre è possibile
sceverare con chiarezza tra l’aggressore, la vittima ignara ovvero quella
provocatrice e a sua volta aggressiva.
Una serie di studi sulla comunicazione (Haley, 1963) derivano direttamente dalla
teoria dei sistemi. Il presupposto da cui essi partono è che esiste anche una
comunicazione di messaggi non verbali, quella appunto attuata coi genti, con la
mimica, con la postura, insomma, con l’atteggiamento. Inoltre, anche la
comunicazione fatto con le parole può assumere un significato contrario al suo
significato letterale. Inoltre, anche la comunicazione fatta con le parole può
assumere un significato contrario al suo significato letterale, poiché il tono della
89
voce, unito alle comunicazioni non verbali può comportare un messaggio di
significato opposto a quello palese. Pertanto, sia l’agire che non l’agire, sia l’attività
che l’inattività, parole o silenzi, hanno tutti valore di messaggio. Data la difficoltà o
l’impossibilità di inviare messaggi comportamentali privi di significato, l’unico
modo di segnalare la negazione di un comportamento o la non volontà di agirlo è
quella di mostrare e proporre l’azione che si vuol negare e poi di non portarla a
termine: da ciò la possibilità di leggere certi comportamenti violenti come disperato
e fallito tentativo di mostrare le proprie intenzioni non violente.
La psicologia della testimonianza – l’esistenza di messaggi non verbali, la
possibile contraddittorietà tra parole, sentimenti e atteggiamenti, le summenzionate
“patologie della comunicazione” sono tutti elementi che ridimensionano o in certi
casi minano la certezza della prova testimoniale. Le indagini e gli esperimenti
psicologici mostrano che la deposizione di un teste che crede di essere sincero non
necessariamente corrisponde alla verità poiché molti fattori possono talora
interferire sul suo ricordo e fargli riferire circostanze che egli reputa vere, mentre
non lo sono. Ciò non significa che la testimonianza debba sempre essere posta in
dubbio: starà al giudice valutare la credibilità di un teste, ben sapendo che questi
può dire il falso senza rendersene conto.
59 - Il comportamentismo
I comportamentismo (o psicologia dello stimolo-risposta) è una scuola psicologica
che si differenzia da tutte quelle fino ad ora considerate perché fornisce una teoria
della personalità maggiormente legata alle metodologie empiriche delle scienze
naturali. Pertanto, ad esso non possono essere avanzate quelle riserva di non
scientificità che sono state rivolte alla psicoanalisi dato che i suoi principi sono
essenzialmente il frutto della sperimentazione e della osservazione empirica.
Il behaviorismo si limita ad osservare come l’uomo reagisce agli stimoli provenienti
dall’ambiente, partendo dal principio che non può impiegarsi la introspezione per
comprendere la condotta umana perché tutto ciò che avviene nell’intimo della
persona non può essere conosciuto ed è al più solo intuibile o ipotizzabile: quanto
può conoscersi con obiettiva certezza dell’uomo è solo il suo comportamento che è
visibile e verificabile anche sperimentalmente. Da questa premessa, subito emerge
la profonda differenza con le altre teorie della personalità che, secondo diversi
modelli, mirano a spiegare e a comprendere le ragioni e i meccanismi psicologici
che sottendono al comportamento umano: per il behaviorismo la psicologia si deve
limitare allo studio del comportamento.
Questa teoria nasce negli Stati Uniti dal caposcuola J.B. Watson (1914). Secondo
Watson, della struttura della persona può essere conosciuto solo il sistema delle
risposte ai molteplici stimoli e sollecitazioni che l’ambiente pone a ciascuna
persona. Può solo studiarsi, in altri termini, come l’individuo reagisce al suo
ambiente, prescindendo da ogni analisi di ciò che avviene dentro di lui.
Da questi presupposti la psicologia comportamentista è giunta d un altro suo
fondamentale contenuto: la condotta umana può essere indirizzata a seconda di
90
come l’ambiente, con i suoi diversi stimoli, contrasta o ricompensa o rafforza il
comportamento. L’uomo, cioè, non è libero nella sua condotta ma ne è guidato dalle
condizioni ambientali secondo il meccanismo dello stimolo risposta: pertanto,
modificando l’ambiente può indirizzarsi il comportamento nel senso voluto.
Sarebbe inutile pertanto invocare tendenze innate, eredità o variabili psicologiche e
biologiche individuali: esiste invece un’elevata regolarità nelle risposte per cui, in
circostanze analoghe, la maggior parte degli individui reagisce agli stimoli esterni in
ugual modo. Le risposte mutano in modo statisticamente significativo non tanto per
le variabili dei singoli individui quanto col mutare delle condizioni esterne in
funzione degli stimoli cui gli individui stessi sono sottoposti.
La psicologia comportamentistica, e soprattutto quella di Skinner (1953) ha
profondamente influenzato anche il pensiero sociologico, fornendo un sistema
interpretativo della personalità umana rigidamente deterministico, secondo il quale
date certe condizioni, verrebbero lasciati strettissimi margini di libertà alla scelta
comportamentale dei singoli.
Secondo Skinner la psicologia deve studiare quali sono i rinforzi che tendono a
indirizzare il comportamento e come applicarli più efficacemente. Vi possono
essere rinforzi positivi (gratificazioni) ovvero rinforzi negativi (frustrazioni) che
sono rappresentati da tutti quegli eventi capaci statisticamente di influenzare la
comparsa delle risposte volute. Una corretta utilizzazione dei rinforzi avrà come
risultato di far sì che le persone indirizzino stabilmente la loro condotta in un certo
senso: da qui la visione utopica di una società ideale ove con una preordinata
applicazione di stimoli e di rinforzi adeguati, potranno essere eliminate tutte le
anomalie comportamentali.
La visone behavioristica è dunque quella dell’uomo determinato e condizionato
dalla situazioni ambientali e dalle modificazioni e dalle manipolazioni degli stimoli,
dunque privo di sostanziali alternative e le cui scelte, apparentemente libere, sono
invece semplici deviazioni nell’ambito di un indirizzo prefissato dalla struttura
sociale o dalla cultura del suo momento.
Dal punto di vista criminologico il comportamentismo è stato utilizzato per
identificare quali siano gli stimoli e i rinforzi che, provenendo dall’ambiente,
portano alla condotta criminosa.
I principi della psicologia behavioristica sono stati anche utilizzati in una specifica
prospettiva criminologia nella teoria della frustrazione-aggressione di Dollard
(1939) secondo cui l’emergere di un comportamento aggressivo presupporrebbe
sempre l’esistenza di una frustrazione (lo stimolo) ed esso porterebbe sempre a
qualche forma di aggressione (la risposta). Quanto più perciò una società pone mete
complesse tanto più facilmente diverrà arduo il conseguirle e si realizzeranno molte
più occasioni di vivere situazioni frustranti. L’aumento di aggressività, e più in
generale di criminalità, nella società moderna sarebbe pertanto la conseguenza di
sempre maggiori occasioni frustranti per l’eccesso di stimoli a conseguire mete
sempre più alte. E’ chiaro a questo punto il richiamo alla teoria dell’anomia di
Merton.
91
L’impedimento temporaneo o definitivo al raggiungimento di un intento può essere
perciò una delle cause della condotta criminosa. Pertanto, anche la delinquenza è
intesa come reazione comportamentale alla frustrazione.
Va sottolineato che il meccanismo dello stimolo risposta ha un valore solo
statistico nel senso che somministrato un certo stimolo la risposta voluta è
prevedibilmente ottenibile solo in una percentuale significativa di soggetti ma non
in tutti coloro che hanno ricevuto quello stimolo. Vi è sempre una quota di persone
che si comporteranno in modo diverso. Gli uomini, infatti, non sono tutti uguali e
ciascuno conserva pur sempre un suo spazio di libertà di scelta e questo spazio
rimane comunque quali che siano i rinforzi che vengono effettuati.
Le critiche che possiamo rivolgere alla teoria della frustrazione/aggressione sono:
o non tutte le condotte delittuose possono intendersi come atti
aggressivi anche in senso lato;
o non tutte le condotte aggressive hanno la loro origine nelle
frustrazioni e non tutte le frustrazioni provocano aggressività – il
diverso livello di tolleranza alla frustrazione gioca infatti un ruolo
molto importante nel provocare tipi diversi di riposte così come lo
giocano la qualità, l’intensità e la frequenza delle frustrazioni.
o La frustrazione può dar luogo all’aggressione ma, a seconda delle
circostanze e delle persone, può causare anche la fuga o la
rinunzia.
o La frustrazione è una componente ineliminabile della vita umana e
l’idea che si possa vivere senza è illusoria: non solo essa può
essere stimolante ma evitare qualsiasi occasione di frustrazione
(come nel caso di una educazione troppo permissiva) impedisce la
strutturazione di personalità forti e mature.
60. La psicologia cognitiva
La psicologia cognitiva concepisce la mente come un elaboratore elettronico
attivo che di continuo verifica la congruenza fra i propri progetti di
comportamento e le condizioni oggettive esistenti nella realtà, filtrando le
informazioni ma anche auto-correggendosi.
La prima formulazione teorica è di Neisser (1967), partito dalla cibernetica e
dagli studi di informatica sui programmi per calcolatori.
Il cognitivismo nasce in opposizione al comportamentismo: mentre per
questa scuola l’apprendimento e la condotta umana sono interpretata sulla
base del legame associativo stimolo risposta, per i cognitivisti la mente
dell’uomo non è un passivo ricettore di stimoli che gli provengono
dall’ambiente ma funziona in modo attivo e selettivo nei loro confronti,
recependoli ed elaborandoli secondo un suo preciso progetto
comportamentale. La mente è intesa come una “scatola nera” e con la sua
elaborazione attiva verifica in continuazione la congruenza fra il proprio
progetto comportamentale e le condizioni oggettive esistenti, compie
92
ininterrottamente scelte tra gli elementi in entrata operando una serie di
elaborazioni e decisioni in uscita che sono il risultato delle verifiche e delle
elaborazioni mentali compiute. Le conoscenze derivano all’individuo d
ipotesi, categorie, schemi, strutturazioni, dati dell’ambiente, regole di
comportamento che sono indipendenti dagli stimoli attuali ma che sono stati
acquisiti anche nel passato e costruiti dall’attività mentale nel corso della
maturazione della personalità: gli schemi di elaborazione delle informazioni
sono cioè indipendenti rispetto alle situazioni nelle quali si sono
progressivamente formati.
I presupposti del cognitivismo confortano pertanto una visione della condotta
delittuosa come frutto di un progetto comportamentale: il delinquente non è
dunque da intendersi come un individuo governato dalle pulsioni e dalle
psicodinamiche del profondo o dai suo complessi e problematiche
psicologiche consapevoli o inconsapevoli che siano. La mente umana è
intesa come un sistema organizzato di strutture e di processi che, oltre ad
elaborare i dati provenienti dall’ambiente è programmata per risolvere i
problemi che via via si presentano nel corso della vita, facendo uso degli
strumenti psichici di cui è dotata. La percezione dell’uomo (e, di
conseguenza, anche quella del criminale) riacquista quindi autonomia, libertà
e conseguentemente responsabilità morale.
93
CAPITOLO 4
BIOLOGIA E CRIMINALITA’
61 – L’approccio naturalistico
Come approccio naturalistico, si considera un campo di indagine che pur senza
ritenere le condotte criminose come unicamente riconducibili a cause organiche,
riserva particolare attenzione a certi fattori quali gli istinti, l’ereditarietà e le
predisposizioni all’aggressività, che rientrano nell’abito dell’indagine delle scienze
biologiche e mediche.
Questo filone della criminologia è visto frequentemente in antitesi a quello
sociologico e psicologico ma va ricordato che è da evitarsi la visione dicotomica
corpo-mente e che lo studio della condotta criminosa deve condursi nella
prospettiva più ampia possibile, mirando a integrare le conoscenze da qualsiasi
settore dello scibile esse provengano.
L’approccio naturalistico può essere dunque limitativo solo se inteso come unica
fonte di conoscenza con la pretesa di considerare l’uomo come struttura
esclusivamente biologica avulsa dal suo ambiente sociale.
Lo studio del crimine secondo l’approccio naturalistico, può essere affrontato
secondo diverse prospettive, quindi, possiamo distinguere:
a. teorie della predisposizione – per “predisposizione” si intende
l’aumentata suscettibilità di un individuo ad ammalarsi. Il trasferire
questo termine alla criminologia può comportare il rischio di
considerare la delinquenza come una sorta di malattia mentre, invece,
bisogna ben guardarsi dal cadere nell’errore di associare malattia e
criminalità. Possono inoltre ricondursi alla predisposizione biologica
solamente alcune caratteristiche psichiche o certe strutture di
personalità che possono facilitare talune condotte delittuose ma senza
che esista alcun diretto rapporto fra tali aspetti psichici e la
criminalità. Gli approcci relativi alle predisposizioni biologiche
consentono semplicemente di evidenziare taluni elementi facilitanti le
scelte delinquenziali: questa agevolazione è connessa alla esistenza di
alcune condizioni psichiche “a rischio” biologicamente determinate
nel senso che esse sono collocate nel novero dei fattori di
vulnerabilità individuale.
b. Teorie degli istinti – secondo le quali il comportamento
delinquenziale (certi tipi di delinquenza particolarmente violenta)
deriverebbero dal prevalere di pulsioni istintuali aggressive o
predatorie. Queste teorie, cadute in discredito, sono state riportate
all’attenzione grazie alle più recenti scoperte delle neuroscienze che
hanno fornito nuove angolature per indagare e comprendere le
relazioni fra struttura biologica, psiche e comportamento.
c. Sociobiologia – è un filone recentemente riproposto che mira a
identificare anche nel comportamento sociale un’origine ereditaria
94
anziché vedere le strutture sociali come solo dovute all’evolvere della
cultura.
62 – teorie della predisposizione: eredità e delitto
L’ipotesi di una correlazione fra eredità e delitto, nel senso che esisterebbero taluni
individui dotati, per ragioni genetiche, di una sorta di predisposizione innata al
delitto è da considerarsi improponibile in quanto si tratta di due entità tra di loro
non confrontabili. La criminalità, infatti, è un comportamento definito tale per
convenzione sociale e perciò variabile a seconda del mutare della cultura e delle
norme; i fattori ereditari sono invece una non modificabile realtà biologica, essendo
legati al patrimonio genetico di ciascun individuo che è indipendente dai fatti
culturali e sociali.
Per quanto attiene all’uomo, il nostro patrimonio genetico, insito nel DNA, è
immutato da circa 1000.0000 anni proprio a ragione dei lunghissimi tempi necessari
alla evoluzione e alla selezione naturale. Nella molte migliaia di anni intercorsi
dalla comparsa dei nostri diretti progenitori si sono peraltro succedute innumerevoli
culture e organizzazioni sociali: per l’essere umano il progresso dalle forma più
arcaiche a quelle attuali si è dunque verificato per una evoluzione culturale più
rapida e diversificata, rispetto ai tempi e ai modi dell’evoluzione biologica, che in
tutti questi millenni è rimasta immutata. Non è pertanto possibile che esista una
qualsiasi correlazione fra struttura biologica (ereditaria e da un centinaio di millenni
non modificata) e la criminalità ( che è connessa al più rapido evolversi della
cultura).
Esistono invece sicure correlazioni fra la struttura biologica degli individui e certi
aspetti della loro mente che possono favorire la criminalità: hanno sicuramente
matrice genetica l’aggressività, certe componenti dell’intelligenza, lo spirito
d’iniziativa, l’inventiva, la reattività. Esistono dunque fra struttura biologica (cioè
fattori psichici ereditariamente acquisiti) e criminalità delle correlazioni indirette.
E’ inoltre molto importante riuscire a separare i fattori genetici da quelli ambientali:
ciò è possibile adottando quello che i genetisti denominano “metodo gemellare”
esaminando coppie di gemelli monozigoti (che hanno lo stesso patrimonio genetico)
ciascuno dei quali sia stato allevato in un contesto familiare sociale e culturale
diverso. Si tratta di gemelli che fin dalla nascita sono stati divisi in quanto affidati a
genitori adottivi di diversa estrazione e di differente condizione sociale. Proprio
questi studi hanno consentito di accertare che alcuni aspetti psichici e
comportamentali erano identici nei due gemelli nonostante le diverse condizioni
d’ambiente nelle quali erano cresciuti. Ciò significa che questi tratti parrebbero
avere una matrice genetica perché si manifestano in entrambi i gemelli nonostante
le differenze d’ambiente.
Altre indagini con la medesima finalità di scoprire una predisposizione innata verso
la criminalità sono state condotte mediante lo studio delle famiglie dei criminali.
Da questi studi è emerso:
95
1. la frequenza di soggetti condannati fra ascendenti e collaterali è
statisticamente maggiore di quanto si possa trovare nelle famiglie di coloro
che non sono mai stati condannati;
2. coloro che hanno avuto genitori criminali possono essere maggiormente
esposti a divenire essi stessi delinquenti senza per questo dimenticare che
questi individui delinquono perché hanno avuto una cattiva educazione e
perché i loro ambiente familiare è stato carente.
Altri studi si sono in passato rivolti ad esaminare il rapporto fra la costituzione e la
criminalità, partendo dal principio che la conformazione corporea è certamente
legata a fattori ereditari e dal fatto che esiste un certo rapporto fra costituzione e
caratteristiche psichiche, inferendo che la presenza di talune di queste
comporterebbe una sorta di predisposizione alla delinquenza.
Basti ricordare gli studi di:
1. Lombroso che aveva costruito la sua tipologia criminale correlando certe
caratteristiche morfologico-costituzionali con la predisposizione al delitto;
2. Di Tullio che considerava, a fianco del delinquente meramente occasionale
e di quello psicotico, tre tipi di delinquenti costituzionali: soggetti ciui
sarebbero prevalenti fattori ereditari condizionanti una loro specifica
struttura psicologica. Egli distingueva il “delinquente costituzionale a
orientamento ipoevoluto” (così chiamato per lo scarso sviluppo delle
caratteristiche psichiche superiori), il “delinquente costituzionale a
orientamento psico-nevrotico” (nel quale prevalgono dinamismi psichici di
natura nevrotica) e, infine, i “delinquenti costituzionali a orientamento
psicopatico” (che hanno come tratto caratteristico le anomalie del carattere e
i disturbi di personalità).
3. Sheldon (1942) – ha costruito una classificazione tripartita che prevede la
corrispondenza fra la costituzione fisica e certi tratti del temperamento.
a. La “costituzione endomorfa” – nella quale è presente una struttura
corporea morbida e rotondeggiante con scarso sviluppo dei muscoli
alla quale corrisponderebbe un orientamento psichico caratterizzato
da socievolezza, ghiottoneria, amore per la comodità, umore stabile,
tolleranza;
b. La “costituzione mesomorfa” – nella quale la struttura corporea è
forte con prevalente sviluppo della muscolatura e particolare
resistenza al dolore e agli sforzi fisici; ad essa corrisponderebbe un
temperamento volto verso l’aggressività e l’amore per il rischio;
c. La “costituzione ectomorfa” – con struttura corporea longilinea e
delicata caratterizzata da un temperamento volto al forte
autocontrollo, carattere chiuso, timore della gente, amore per la
solitudine.
Da questi studi condotti su popolazioni di detenuti, Sheldon è giunto alla
dimostrazione una particolare frequenza fra costoro di individui con
costituzione mesomorfa: i soggetti con tale costituzione avrebbero
96
pertanto una sorta di predestinazione costituzionale a diventare criminali
posto che la struttura fisica e il corrispondente temperamento siano
sicuramente dovuti a fattori genetici.
Tutti questi approcci, naturalmente, sono oggi caduti in discredito e la validità delle
correlazioni fra fisico e psiche è limitata a un semplice livello statistico perché le
variabili psichiche individuali sono talmente tanto numerose da risultare arbitrario il
farle corrispondere a una tipologia costituzionale che prevede così poca varietà.
Semplicistico e improprio è pertanto il parlare di disposizioni ereditarie al delitto in
quanto il fattore genetico non può invocarsi per una modalità di condotta così
complessa come la criminalità nella quale interferiscono circostanze ambientali e
situazionali, momenti storici differenti, diversità di luoghi, culture, norme e
soprattutto valori morali. Si può parlare solo di predisposizioni biologicamente
determinate in senso genetico verso particolari caratteristiche mentali che possono a
loro volta diventare condizioni favorenti (= fattori psichici di vulnerabilità) il
comportamento criminoso: tali sono specialmente l’aggressività, lo scarso controllo
dell’emotività e delle pulsioni, l’intolleranza alle frustrazioni.
63. Teorie della predisposizione: i geni e la mente
In tema di predisposizione biologica verso la criminalità è stata avanzata negli anni
’60 l’ipotesi che esistessero tendenze innate verso la condotta criminale dovute ad
anomalie dei cromosomi cioè i filamenti di DNA depositari del patrimonio
genetico di ogni individuo. I 46 cromosomi dell’uomo sono accoppiati a due a due,
dei quali l’uomo proviene dalla madre e l’altro dal padre così che il patrimonio
ereditario di ciascun individuo è per metà materno e per metà paterno.
L’interesse per il menoma umano e la scoperta di fattori genici responsabili di certi
tratti psichici e comportamentali non ha però condotto ad una visione organicistica
della persona e della condotta umane né ha alimentato nuove illusorie ricerche di un
“gene del delitto”.
Oggi sta prendendo piede un nuovo determinismo biologico che ha trovato alimento
dal grande sviluppo in questi anni delle neuroscienze : le scienze che studiano il
funzionamento del cervello e che si avvalgono di tecniche sempre più sofisticate
che consentono di osservare come funziona il cervello in tempo reale. Sta così
sorgendo una nuova visione materialistica e deterministica per la quale il libero
arbitrio, la morale la mente e l’Io non esistono più: l’uomo è programmato
geneticamente fino ai minimi particolari.
L’assunto di partenza è il cervello è programmato biologicamente secondo le
informazioni del DNA così che l’uomo non avrebbe effettivi spazi di libertà.
64 – Teorie degli istinti: l’orientamento istintivistico e quello ambientalistico
L’antica questione mai risolta è se delinquenti si nasce o si diventa. Poiché gli istinti
sono innati vi è l’opportunità di affrontare la questione secondo gli insegnamenti
che derivano dalla biologia.
97
In biologia si sono a lungo contrapposti due antitetici orientamenti per quel che
riguarda le determinanti del comportamento, sia degli animali sia dell’uomo: quello
che privilegia l’istinto (secondo il quale il comportamento è l’effetto delle
predisposizioni congenite) e quello che dà maggiore rilievo all’ambiente (secondo il
quale il comportamento è la conseguenza delle condizioni e degli stimoli
ambientali). Vediamoli:
1) orientamento istintivistico – secondo questo vecchio orientamento per
istinto si intende una serie di spinte ad agire in modo sempre uguale e in
prefisse direzioni per conseguire certi fini senza che l’animale avesse
alcuna consapevolezza dello scopo ultimo cui il suo agire mirava; si
riteneva che gli istinti fossero esclusivamente trasmessi per via ereditaria e
che fossero in numero relativamente scarso. Essi erano concepiti inoltre
come una potenzialità innata, come una forza che spinge all’azione senza la
necessità di alcun apporto proveniente dall’ambiente o meglio l’ambiente
forniva solo dei segnali che scatenavano l’azione istintuale. Questa
concezione è andata successivamente temperandosi con gli studi di Karl
Lorenz e degli altri etologi i quali hanno scoperto che gli istinti vanno intesi
come semplici schemi operativi generali: tendenze innati che devono essere
integrate con l’apprendimento, l’esperienza, l’insegnamento da parte dei
genitori, cioè con fattori che provengono dall’ambiente. La scuola
dell’etologia facente capo a Lorenz, partendo dall’osservazione degli
animali, ha fondato il suo contenuto teorico sul principio secondo cui
qualsiasi essere vivente e il suo ambiente naturale non sono concepibili
separatamente ma si influenzano e si realizzano continuamente in un
reciproco rapporto di stimoli e risposte. L’organismo animale è strutturato in
modo da raccogliere segnali dall’ambiente e le risposte a taluni stimoli sono,
ma solo in parte, congenitamente determinate. Per questo motivo, Lorenz
preferisce chiamare gli istinti “schemi di azione”. Il principi mutuati
dall’etologia naturalmente valgono anche per l’uomo con la differenza però
che nell’uomo, meno condizionato degli animali dai fattori della natura,
l’ambiente è da intendersi come ambiente sociale e come tale è molto più
complesso e mutevole di quello che non sia per gli animali.
2) L’orientamento ambientalistico – secondo questo orientamento non può
distinguersi nella condotta ciò che è determinato congenitamente da ciò che
viene appreso dall’ambiente. La dotazione genetica si manifesterebbe nella
diversa capacità dell’animale di recepire (cioè apprendere) i messaggi
provenienti dall’ambiente che sarebbe, in definitiva, il principale fattore
inducente le varie modalità di condotta. Il comportamento sarebbe solo
genericamente ricollegabile ai geni ereditari mentre la differenziazione
individuale delle condotte viene ritenuto sostanzialmente attribuibile alle
varie circostanze ambientali che gli individui incontrano. Enorme importanza
ha quindi l’apprendimento correlato alle mutevoli stimolazioni e alle
occasioni fornite dall’ambiente.
3) Orientamento correlazionistico – da un po’ di tempo, in biologia, si tenda
superare l’antinomia fra istinto e ambiente per giungere a una visione che
miri invece a sottolineare sempre più la stretta interdipendenza dei due
98
termini. Si è cercato di risolvere il dilemma alla luce di una concezione che
considera da un lato taluni comportamenti fondamentali (basilari e tipici di
ogni specie) come programmi comportamenti di massima condizionati solo
geneticamente; dall’altro vi sarebbero altri programmi di dettaglio dove le
variabili comportamentali si ricollegano più strettamente a fattori ambientali
pur nell’ambito degli schemi generali genetici. L’antinomia fra istinto e
ambiente verrebbe superata, come suggerisce Gottlieb (1971), considerando
due distinti tipi fondamentali di comportamento. Il comportamento innato,
esclusivo degli esseri viventi più semplici (che si può rappresentare con uno
schema del tipo: geni struttura biologica maturazione
comportamento innato) in cui la determinante ereditaria si riflette sulla
struttura biologica individuale la quale, giunta a maturazione e senza
necessità di interventi dell’ambiente, dà luogo al comportamento. Il
comportamento acquisito, tipico degli animali superiori, in cui i fattori
genici, comportando una struttura individuale diversificata, fanno sì che gli
individui interagiscano con l’ambiente in modo differente in quanto agenti
sul diverso modo di apprendere e sul modo con cui i successivi
apprendimenti si traducono in esperienza.
65 – Teorie degli istinti: la sociobiologia
La sociobiologia si è imposta all’attenzione del grande pubblico nel 1975 con
l’opera di Wilson “Sociobiologia. La nuova sintesi” come lo studio sistematico
delle basi biologiche di ogni forma di comportamento sociale. Secondo Wilson
le varie società sarebbero non tanto il frutto dell’evolversi delle specie quanto la
conseguenza di schemi prefissati negli individui che le compongono. Questa
teoria ha preteso di applicare i risultati delle proprie osservazioni anche alle
società umane, sia a quelle meno complesse, sia alla società attuale; anche
l’uomo, poi, essendo il risultato di una evoluzione biologica, porta
inevitabilmente entro di sé una serie di predisposizioni, di costrizioni emotive, di
circuiti cerebrali che confluiscono sul suo comportamento molto pù di quanto
generalmente si ritenga.
Sinteticamente può dirsi che la sociobiologia afferma che anche le società
umane, come quelle animali, devono essere “adattive” devono cioè soddisfare al
massimo il principio di idoneità biologica in senso darwiniano, vale a dire per
tutto quanto attiene ai fini fondamentali dell’evoluzione e sopravvivenza della
specie. Secondo questo assunto, non sono tanto gli individui ad assumere
importanza per tali fini quanto il “gene” cioè il patrimonio genetico ereditario
trasmettitore degli schemi di comportamento che solitamente chiamiamo istinti:
il gene condiziona individui e società proprio per la sua connaturata e specifica
spinta alla sopravvivenza e alla riproduzione; per questo motivo gli sono
estranee considerazioni d’ordine etico o comunque culturale, proprie degli
uomini e delle società , e che nella prospettiva sociobiologia sono anch’essi
subordinati e dominati dal gene. La denominazione di “gene egoista” data da
alcuni sociobiologi trova allora la sua ragione nel fatto che il gene si preoccupa
solo della propria sopravvivenza cui è legata quella della specie.
99
Anche l’altruismo perde in questa prospettiva qualsiasi connotazione di ordine
etico e di merito: il gene, infatti, oltre che egoistico può anche indurre a
comportamenti altruistici ma solo qualora siano funzionali alla sopravvivenza
della specie.
La sociobiologia si pone dunque quale antitesi al principio che vede nella cultura
il motore fondamentale dell’evolversi e del diverso caratterizzarsi del genere
umano attraverso un processo di apprendimento e trasmissione culturale.
Uno dei principi basilari della sociobiologia è dunque l’utilizzazione della teoria
evoluzionistica quale paradigma valido non solo per le scienze biologiche ma
anche per lo studio del comportamento sociale umano.
La sociobiologia ha dato adito a molte critiche, certamente valide nei confronti
degli esponenti più estremisti:
1) per aver arbitrariamente esteso al comportamento umano osservazioni fatte
sugli animali, dimenticando o sottostimando la dimensione culturale
dell’uomo, e svalutando in tal modo le scienze sociali e l’etica;
2) per la visione per la quale le società risulterebbero non tanto il frutto del
lungo evolversi storico e culturale, dei conflitti di potere e del succedersi di
sempre nuovi ideali e valori, ma piuttosto la risultante inevitabile di fattori
insiti nella informazione genetica.
Venendo all’utilizzazione in criminologia dei principi della sociobiologia,
potrebbe ipotizzarsi che i comportamenti aggressivi, le violenze sui più deboli
non sono comportamenti scelti e voluti dai loro autori in spregio all’etica e alle
norme ma sono una sorte di inevitabile conseguenza di una selezione naturale
che è venuta a privilegiare i più forti, i più violenti e i più aggressivi.
Comunque, non può certamente ammettersi che esista un “gene della
criminalità” né potrebbe esistere in quanto nel nostro DNA non è inscritto alcun
destino (delinquenziale o meno) da cui sia impossibile sottrarsi; l’unicità e la
prerogativa della nostra specie risiedono nella sua natura dicotomica, biologica e
culturale, soggette all’influenza di entrambe queste determinanti.
66 - L’aggressività nella prospettiva biologica
Aggressività non vuol dire criminalità anche se molti delitti sono espressione di
motivazioni aggressive. Da un punto di vista strettamente biologico, non può
considerarsi l’istinto come una spinta ineluttabile e non modificabile verso alcuni
tipi di condotta: anche gli istinti aggressivi non possono intendersi come una
disposizione ineluttabile verso la violenza ma si deve ritenere piuttosto che anche i
fattori legati all’ambiente vengono a giocare una parte molto rilevante nel favorire
la condotta aggressiva istintuale, ovvero nell’inibirla.
In biologia è da tempo noto che la pulsione ad assalire e quella a fuggire ovvero a
immobilizzarsi dinnanzi a un pericolo non sono due istinti primari contrapposti.
Questi stati emotivi primordiali di collera o di paura non sono considerati come
entità disgiunte: un animale posto di fronte a una situazione minacciosa esprimerà
rispettivamente con la fuga o con l’attacco il suo stato interiore di paura o di rabbia
100
ma ciò determina il tipo di reazione motoria (l’attacco oppure la fuga o
l’immobilizzazione) non è solo la natura dello stimolo, ma anche il modo secondo
cui l’animale lo vive e lo percepisce emotivamente in relazione a sé e all’ambiente.
Già a livello proto-emotivo sussiste quindi una stretta correlazione tra due stati
affettivi di segno contrario, in cui indubbiamente processi cognitivi ed esperienze
giocano un ruolo determinante nella motivazione comportamentale.
L’a,ambiente poi esercita un ruolo fondamentale ed è l’interpretazione
dell’ambiente da p arte dell’animale a decidere il tipo di risposta, di aggressione o di
fuga, che non è pertanto legata a schemi di azione esclusivamente dovuto all’istinto.
Passando dal mondo animale a quello umano si ritiene che fattori biologici e
sociologici interagiscano fra loro nel produrre più o meno facilmente un
comportamento violento.
E’ da sottolineare che l’aggressività negli animali non ha nulla a che vedere con ciò
che noi intendiamo per violenza fra gli uomini. Esiste poi una profonda differenza
fra l’aggressività rivolta verso animali di specie diversa e l’aggressività
intraspecifica cioè tra individui della stessa specie e l’aggressività tra specie
diverse (molto rara salvo quando ricorra il rapporto di predatore/preda).
L’aggressione intraspecifica negli animali oltre a svolgere precise funzioni di
sopravvivenza dell’individuo e della specie, difficilmente ha esiti mortali in quanto
sussiste un insieme di meccanismi di contenimento dell’aggressività atti a inibire o
bloccare l’aggressività del rivale ma si tratta di una vera e propria ritualizzazione
della lotta condotta con scopi ben precisi (selezione sessuale, difesa del territorio,
regolamento degli schemi elementari di condotta e dei rapporti sociali). In
definitiva, quindi, nel comportamento animale pur essendo generalizzata e
determinante, l’aggressività risulta quasi sempre funzionale e in armonia con le
finalità biologiche e non mette in pericolo la specie perché frenata da meccanismi
spontanei di auto-contenimento: meccanismi che nell’uomo sono andati perduti o
vengono rifiutati col risultato che egli è divenuto l’essere vivente più aggressivo che
mai sia comparso sulla faccia della terra.
67 – Aggressività e neuroscienze
Sempre in tema di aggressività merita un cenno quel che le scienze
neurofisiologiche hanno consentito di appurare relativamente al rapporto fra
struttura biologica e inclinazione alla violenza di taluni individui.
I recenti studi condotti sul funzionamento del cervello, starebbero ad indicare che
taluni individui sono più violenti di altri proprio per certe caratteristiche organiche
del loro sistema nervoso.
A questo proposito occorre ricordare la teoria triunitaria di MacLean introdotta
nell’ambito criminologia da F. Bruno (1987). Essa fornisce informazioni
sull’organizzazione evolutiva del cervello umano che sarebbe costituito da tre tipi
fondamentali di sistemi:
1. la struttura filogeneticamente più antica ricorda morfologicamente le forme
più rudimentali del cervello dei vertebrati e presiede ad attività di tipo
101
istintuale (difesa del territorio,
organizzazione gerarchica);
caccia,
accoppiamento,
nutrizione,
2. un secondo sistema è deputato al controllo degli stati emozionali (collera,
paura, piacere);
3. il sistema più recente e perfezionato è quello che ha consentito all’uomo il
maggiore e più avanzato sviluppo, rappresentato proprio lo strumento delle
sua peculiari capacità intellettive.
Tale sistema, essendo passato per trasformazioni evolutive più incisive e rapide,
non è riuscito a integrarsi del tutto armonicamente con le strutture cerebrali più
antiche che sono rimaste relativamente immutate. Da questo, la non perfetta
integrazione di un prodigioso sviluppo delle capacità cognitive, operative e
intellettuali, cui non ha corrisposto una analogo progresso nel controllo delle più
antiche funzioni emozionali e istintuali.
La teoria trinitaria può fornire un modello atto a spiegare taluni comportamenti
delittuosi nei quali si può constatare il ricorso di condotte agite sotto la spinta
degli istinti o dell’emotività eludendo transitoriamente i controlli superiori.
Molto interessanti sono le ricerche che hanno messo in luce, in anni recenti, i
rapporti fra difetti neurologici (verificatisi durante lo sviluppo o acquisiti più
tardi) e la p propensione all’aggressività. In questa prospettiva risulterebbe che i
criminali violentemente aggressivi presentano difetti in una proporzione molto
più elevata di quella rilevabile nella popolazione generale.
Sofisticate indagini strumentali hanno consentito poi di rilevare come siano assai
frequenti nei soggetti violenti disturbi minimi cerebrali di varia natura. Soggetti
di questo genere sarebbero più facilmente impulsivi.
68 – La criminalità violenta
Secondo alcuni studiosi, l’aggressività sarebbe una delle pulsioni istintuali o
delle motivazioni psichiche che più frequentemente entrano in gioco nella
criminogenesi.
E’ necessario distinguere tra aggressione, intesa come effettivo comportamento
lesivo di persone e aggressività, che si riferisce invece a una disposizione o
atteggiamento psichico favorevole all’aggressione.
L’aggressività può essere incanalata, mediante processi della dislocazione e
della sublimazione, verso altri obiettivi; infatti, non sempre l’aggressività si
esprime con condotte giuridicamente perseguibili ma frequentemente può
trovare modi di esprimersi socializzati o quanto meno socialmente tollerati: essa
è addirittura necessaria alla sopravvivenza dell’uomo e della sua affermazione
sociale. Sotto questo profilo, audacia, spirito di iniziativa, intraprendenza,
scalata sociale, ambizione, competitività, possono rappresentare altrettante
maniere di indirizzare o sublimare l’aggressività secondo modalità socialmente
accettate o addirittura qualificanti.
102
Ci sono diversi modi di comportarsi aggressivamente e di commettere delitti su
base violenta:
1. aggressività diretta sulle cose e sull’ambiente, con significato
genericamente distruttivo, quando la pulsione aggressiva viene deviata
dalla persona cui è diretta verso gli oggetti;
2. aggressività diretta sulla persona esclusivamente in modo verbale, con
l’ingiuria e la calunnia;
3. aggressività diretta sulle persone, con la violenza sessuale, le percosse, i
maltrattamenti, l’omicidio;
4. aggressività rivolta contro sé stessi fino ad arrivare al suicidio.
5. aggressività rivolta verso sé stessi al solo fine di ottenere detenzione
emotiva nell’impossibilità di rivolgerla su altri (da non confondersi con il
tentativo di suicidio, è tipica delle personalità immature e impulsive e si
manifesta con alta frequenza fra i soggetti in reclusione sotto forma di
lesioni da taglio multiple e superficiali).
69 – Aggressività umana e cultura
L’aggressività umana è assolutamente diversa da quella esistente negli animali.
Per comprendere questa nostra straordinaria aggressività bisogna ritenere o che
l’uomo sia biologicamente diverso da tutti gli altri esseri viventi o che la sua
elevatissima aggressività debba ricollegarsi a fattori diversi da quelli biologici.
In primo luogo è da ricordare che i meccanismi automatici di regolazione
dell’aggressività che nel regno animale consentono, mediante la ritualizzazione e la
ri-direzione, di salvaguardare allo stesso tempo la conservazione della specie e
quella dell’individuo, nell’uomo hanno perduto gran parte della loro significatività:
man mano che egli è evoluto sempre più allontanandosi dallo stato di natura, non è
stato più l’istinto a guidare le fondamentali modalità di comportamento ma piuttosto
l’apprendimento, l’esperienza, gli insegnamenti e tutto l’ingente patrimonio di
conoscenze e nozioni che egli è andato lentamente acquisendo nei millenni.
Nell’uomo, l’aggressività ha finito per essere priva di meccanismi di contenimento
e di autoregolazione, essendo disgiunta dall’istinto e deriva piuttosto dai fattori che
provengono dalla cultura. Quella cultura cioè che ai comportamenti primari informa
e regola nella specie umana ogni tipo di condotta di maggiore complessità.
Dalla perdita dei meccanismi di comportamento istintuale dell’aggressività è
derivato che nell’uomo essa non svolge più quelle funzioni biologiche che la
rendono utili e relativamente innocua ma appare invece come una forza distruttiva
e negativa.
La peculiare aggressività umana è stata denominata da Erich Fromm (1975),
proprio per differenziarla da quella degli animali superiori, aggressività maligna o
distruttiva. Egli ha distinto infatti due tipi di aggressività:
1. l’aggressività benigna-difensiva – comune a tutte le specie di animali
superiori, quale impulso istintuale programmato verso l’attacco o verso la
103
fuga quando sono in gioco gli interessi biologici vitali, aggressività pertanto
non necessariamente nociva e che non minaccia ma anzi favorisce la
sopravvivenza della specie;
2. l’aggressività maligna o distruttiva – propria dell’uomo che non è
istintuale ma dipende dalla struttura sociale, è appresa attraverso i rapporti
interpersonali e da questi sostenuta, venendo a far parte della cultura delle
diverse società. Non è rivolta alla conservazione degli interessi biologici
vitali ma è frutto della più evoluta e complessa organizzazione sociale tipica
dell’uomo.
I comportamenti fondamentali che negli anomali sono trasmessi per via naturale,
nell’uomo sono invece trasmessi mediante forme sociali di apprendimento: non
sono pertanto istintivi ma culturali e fra ciò che la cultura trasmette vi è anche la
valorizzazione dell’aggressività.
L’aggressività è quindi diventata “valore culturale” essendosi dimostrata
vantaggiosa per soddisfare la sua volontà di potenza; d’altra parte, proprio la
cultura rappresenta nell’uomo e nella società umana lo strumento fondamentale
di regolazione del comportamento, essendosi globalmente sostituita ai
meccanismi biologicamente determinati.
La società umana poggia fondamentalmente sulla violenza, che è lo strumento di
regolazione di tutti i rapporti di potere e la sua intera storia si è sviluppata sulla
lotta.E anche i valori culturali, pur positivi (relativi al successo, alla forza, al
coraggio, al sacrificio di sé per il trionfo della propria causa, al patriottismo)
sono legati all’aggressività per quanto sublimata e quindi non da intendersi solo
in accezione negativa, che ha permeato così fin dalle più profonde radici la
cultura dell’uomo.
Da millenni l’uomo vive in un clima di valori e di ideali che lo spingono a
essere violento, coerentemente con la propria cultura anche se spesso non si ha
consapevolezza delle sottostanti pulsionalità violente, perché appunto sono state
sublimate, mascherate e razionalizzate quali condotte positive dalle ideologie,
dalla morale, dai costumi.
I contenuti della cultura hanno però anche sempre tentato di contenere la
violenza con le leggi, con le regole morali, con gli ideali, con le religioni. Ciò ha
creato una situazione contraddittoria e ambivalente che rende conto della minore
efficacia di questi strumenti di contenimento e regolamentazione
dell’aggressività rispetto a quelli esistenti nel mondo animale. I messaggi
culturali non violenti e i sistemi di controllo della violenza sono poi dotati di
ambivalenza perché nello stesso momento per certi ambiti di comportamento
sollecitano la violenza, mentre per altri suggeriscono la non-violenza. I molti
strumenti normativi e i valori anti-aggrssivi che sono stati via via proposti nel
corso della storia si sono spesso dimostrati troppo deboli proprio per la
contraddittorietà e l’ambivalenza insita alla loro radice: bastano situazioni
particolari di fragilità delle istituzioni o di crisi per vedere riaffiorare la
distruttività insita negli uomini. Di conseguenza, se è illusorio pensare che la
violenza cessi di essere uno dei fondamentali strumenti nel regolare i rapporti di
potere tra gli uomini è anche vero che essa può essere contenuta solo mediante
104
una sempre maggiore efficacia degli unici mezzi disponibili, cioè quelli delle
norme e dei valori della cultura perché se dalla cultura la violenza deriva, ancora
e solo nella cultura può trovarsi lo strumento per contrastarla.
70 – Struttura biologica e libertà.
Se dai geni dipendono talune qualità psichiche come oggi alcuni studiosi
prospettano, se le sempre maggiori conoscenze sul funzionamento cerebrale
sembrano indicare la presenza di circuiti innati nei quali l’uomo è
biologicamente costretto, dove va a finire la sua libertà?
Il patrimonio delle informazioni trasmesse dal DNA di ciascun essere vivente è
identico per quanto attiene alle qualità fondamentali comuni a tutti gli
appartenenti a una stessa specie ma si diversifica per aspetti secondari dall’uno
all’altro soggetto. Ciò rende conto della variabilità genetica individuale dal
momento che ciascuno pur nell’ambito dello schema generale tipico della sua
specie è diverso ed irripetibile per altri aspetti. Tali variabili comprendono oltre
a qualità fisiche anche aspetti psichici così che venendo al problema
dell’aggressività possono darsi individui con maggior aggressività
biologicamente determinata e altri con una carica pulsionale aggressiva meno
intensa.
Sempre nell’ambito delle sole condotte aggressive, esse non possono in ogni
caso essere spiegate solo in base alle differenze del patrimonio dei geni ma
devono essere viste anche in rapporto al tipo di esperienze, di ambiente e di
sollecitazioni che il singolo individuo ha incontrato nel corso della sua vita.
In definitiva, gli uomini possono comportarsi in modo variabilmente aggressivo
sia perché è in assoluto diversa la loro dotazione biologica sia perché a cagione
delle variabili caratteristiche dell’ambiente sociale nel quale sono vissuti,
diverse sono state le sollecitazioni o le inibizioni ad agire in modo aggressivo
sia perché in ogni individuo è diverso il grado di recettività nei confronti delle
sollecitazioni alla violenza che gli provengono dalla cultura e dalla società.
La sempre più raffinata conoscenza del funzionamento del cervello, da cui
dipende l’attività mentale, non contraddice affatto l’assunto della libertà e quindi
della responsabilità: anzi, proprio i dati acquisiti sul funzionamento cerebrale ci
portano a una migliore comprensione dell’individuo in quanto agente
responsabile, e in tal modo ci chiariscono i problemi di corpo/mente e di
responsabilità/determinismo.
Quanto oggi si sa sul funzionamento del cervello consente di verificare che il
singolo individuo è pur sempre in grado di scegliere e di orientare gli infiniti
programmi e circuiti che sono insiti nella sua organizzazione cerebrale. La sua
struttura innata costituisce semplicemente “lo strumento” per organizzare il
pensiero, senza che il tipo dei processi iscritti nella struttura cerebrale lo
obblighi a certi piuttosto che ad altri pensieri. Così, la libertà non è negata e
rimane pur sempre lo spazio per nuovi pensieri e nuovi progetti anche se tale
spazio non è illimitato perché circoscritto dalla struttura biologica del cervello.
105
Non esistono in tutti gli animali superiori e in modo particolare per l’uomo,
moduli comportamentali fissi e perciò meccanicisticamente vincolanti la
condotta: la moderna scienza biologica ha pertanto accantonato il determinismo
fatale, e da essa derivano addirittura indicazioni su come la scelta e la nondeterminazione del comportamento siano peculiarmente umani in funzione della
plasticità del cervello.
106