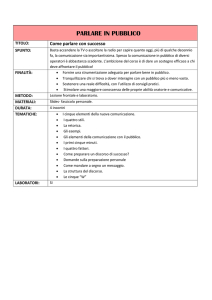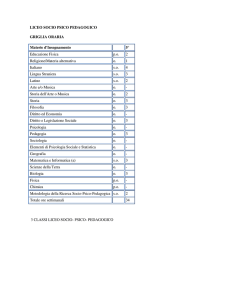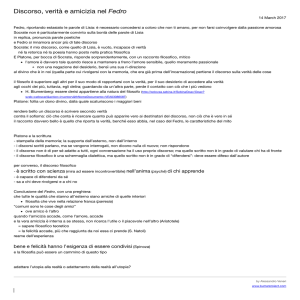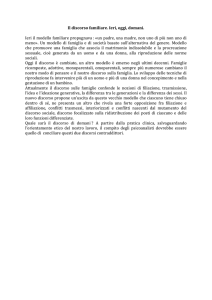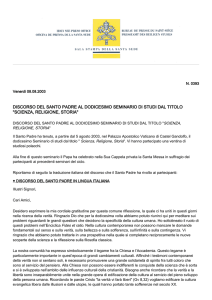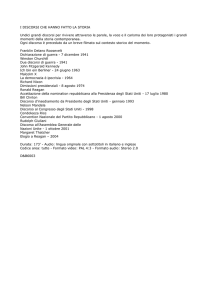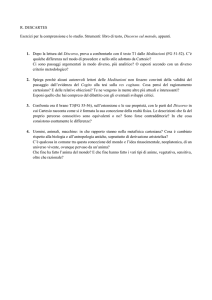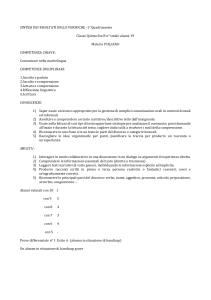Discorso pedagogico
e riflessione epistemologica
Francesco Mattei
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Via dei Mille, 23 - 00185 Roma
Università Roma Tre - [email protected]
1. Destrutturazioni istituzionali e riflessione pedagogica
Le emicranie sono passate. O forse, sono soltanto
momentaneamente sopite. Mi riferisco naturalmente
alle emicranie epistemologiche. E non già perché reputi poco rilevante la riflessione epistemologica sul lessico educativo e sul discorso pedagogico, quanto piuttosto perché abbiamo recentemente attraversato, in anni
non lontani, tempi in cui molto si discuteva di epistemologia, epistemologie e formalizzazioni (necessariamente astratte, ma non sempre asfitticamente formalistiche) e poco si dissodavano i terreni canonici tipici
della storia della ricerca educativa. E dunque, non era
infrequente la messa in ombra dei processi reali tipici
dell’azione educativa: la storia dei fenomeni educativi, la
grande opera sociale dell’istruzione, gli sfondi storicofilosofici entro cui si formano e si strutturano gli eventi
socio-educativi, i mutamenti non sempre fecondi delle
istituzioni pubbliche e private che attorno all’educazione
si sono formate. Direi insomma, senza enfasi di pessimismo irreversibile, che è sembrato prendere corpo un
potente meccanismo di destrutturazione (teorico-pratiEDUCAZIONE. Giornale di pedagogia critica, I, 1 (2012), pp. 7-27
ISSN 2280 - 7837 © 2012 Edizioni Anicia, Roma, Italia
Francesco Mattei
ca) di quelle istituzioni, per lo più pubbliche, che hanno permesso l’alfabetizzazione e la culturalizzazione del
paese e che hanno favorito l’adozione di prassi certo
perfettibili, ma sicuramente non degne del disprezzo o
dell’oblio in cui le si vorrebbe oggi confinare. Infatti,
una certa forma di compiaciuta iper-riflessione epistemologica, tutta intenta a descrivere i guasti nefasti delle
ideologie pedagogiche, ha finito per produrre essa stessa macerie: senza vietarsi, però, la descrizione (compiaciuta) di quelle lande deserte alla cui realizzazione
essa aveva colpevolmente partecipato. Dunque, siamo
in presenza di uno sterile labirinto endogamico da cui
appare sempre più necessario e urgente fuoriuscire.
Questo il clima che respira chi, per professione o
per passione, ha le mani in pasta nel fenomeno educazione. Il che potrebbe spingere verso ricordi di un passato
più accettabile – di per sé sempre più felice del triste presente, ma sempre sterilmente consolatorio –, o saggiamente astenersi da fughe nostalgiche e ineffettuali, vista
l’urgenza dei problemi e i troppi disagi che affliggono
ormai il pianeta istruzione-educazione.
I cahiers de doléances, in materia, potrebbero essere corposi, e altre volte vi ho accennato1. Ciò che più
colpisce, però, e che lascia attoniti e sconcertati, è il
mutato clima rispetto alle esperienze vissute da studenti e da docenti nella seconda metà del secolo scorso. Se
la scuola costituiva allora, dagli anni ’60 agli ’80 del
Novecento, quello che con poca fantasia si è chiamato
l’ascensore sociale, e che consentiva, insieme all’origine
culturale ed economica della famiglia, la mobilità sociale ascendente, oggi quel meccanismo si è purtroppo
1
Cfr. F. Mattei, Sfibrata paideia, Roma, Anicia, 2009, p. 95 e sgg.;
Id., «Una testa ben fatta. E le mani?», in Id., (a cura di), La formazione
professionale. Scorci storici e problemi aperti, Roma, Anicia, 2012, pp.
15-56.
8
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
appesantito. O forse, si è più semplicemente rotto2. Il
sistema di istruzione (pubblica) ha perso capacità di
modellamento civico, di produzione di standard di istruzione comparabili con i migliori paesi OCSE, di accrescimento di quella educazione “umana” il cui canone
la tradizione occidentale ha depositato nel sistema di
istruzione. E sarà inutile, allora, aggiungere che il mutato
scenario socio-economico ha progressivamente spinto
governi e famiglie a forzare le giovani generazioni verso un accesso quasi obbligato all’istruzione universitaria. Ma le statistiche le conosciamo, e sappiamo che le
percentuali dei laureati italiani sono ancora lontane
dalla media dei paesi industriali sviluppati3.
Un altro aspetto, non meno inquietante, va ancora
sottolineato. Ed è il fatto che il mutato scenario economico-produttivo spinge oggi il sistema di istruzione
verso un sapere prevalentemente “utilitaristico”4, unicamente spendibile in quel “saper fare” tanto caro a
Bruxelles. Ma ciò rischia di ridurre il significato della
2
Lo ricordava Michele Salvati in un intervento sul “Corriere
della Sera” (14.08. 2008): «Se l’ascensore non sale». E citando gli studi di J. Golthorpe e M. Jackson, e la discussione aperta sulla rivista
“Stato e Mercato”, affermava: «L’istruzione dovrebbe essere il principale ingranaggio dell’ascesa sociale, ma non è così: sia perché i ragazzi provenienti dalle classi sociali più elevate “vanno meglio” a scuola;
sia perché quando “vanno peggio”, molto spesso essi ottengono posti
di lavoro e posizioni sociali migliori di ragazzi provenienti da classi
inferiori, ma con merito accertato maggiore».
3
Per uno sguardo sui risultati delle innovazioni apportate agli
ordinamenti universitari cfr. P. Potestio, Delayed Entry and Mismatch
Problems for Young Italian Diploma and Degree Holders, in F. Mattei,
La formazione professionale. Scorci storici e problemi aperti, cit., pp.
169-192.
4
Segnalo soltanto, pur con i limiti del caso su cui altrove mi sono
soffermato, il testo di M. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Bologna, il Mulino,
2011, soprattutto il cap. 2 («Istruzione per il profitto, istruzione per la
democrazia») e il cap. 7 («L’istruzione democratica alle corde»).
9
Francesco Mattei
scienza ad una scienza-tecnologia – la fiera o deprecata
o salvifica tecno-scienza – come sola fedele ancella
della “produzione” tecnica e di un sapere pratico che si
definisce esclusivamente in funzione della sua utilità.
Ma possono, utilitarismo e funzionalismo, racchiudere
in sé gli scopi esclusivi della conoscenza scientifica? È
veramente sottratta, la cultura umanistica, ad una serietà
scientifica? O le è solo concesso di vagare libera per
sentieri insensati o poetanti?5
Domande pertinenti, credo. E attuali. Che gettano
nuova luce e pesanti conseguenze (anche) sul sapere
pedagogico e sull’analisi della sua legittimazione epistemologica. Giacché questo approccio dubitante vale
anche per il discorso pedagogico. E valgono, se così
stanno le cose, anche le interrogazioni sulla natura delle sue conoscenze e sui concetti teorici che ne garantiscono la legittimità. Questa la natura e la funzione
dell’analisi epistemologica. Infatti, aggirarsi per i sentieri dell’epistemologia pedagogica significa fondamentalmente saggiare le basi attorno a cui si strutturano il
lessico pedagogico, le proposizioni che lo costituiscono in discorso, la capacità descrittiva e predittiva di
quelle proposizioni, l’adeguamento (adaequatio) che esse stabiliscono con l’esperienza educativa, il grado veritativo di quelle proposizioni. Dunque, ancora una volta,
lÒgoj e e•nai, parola e realtà, parola ed esperienza,
5
L’«insensato» (unsinning) è naturalmente riferito alle posizioni
verificazioniste del neopositivismo logico sorto sulle ermeneutiche del
primo Wittgenstein del Tractatus ed è ben definito da M. Schlick: «Il
significato di una proposizione è il metodo della sua verifica, una proposizione è insensata se non esiste un metodo per verificarla». Il “poetante” rinvia invece a Carnap o Ayer e alla metafisica, morale o teologia come “cattiva poesia”. Ma su ciò non mi soffermo e rinvio a miei
studi precedenti, soprattutto a Sapere pedagogico e legittimazione educativa, Roma, Anicia, 20032 e a Scienza Religione Filosofia. Intersezioni pedagogiche, Roma, Anicia, 20032, pp. 15-88.
10
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
parola e verità (in accezione di ¢l»qeia o ÑrqÒthj):
insomma, l’abbecedario del discorso filosofico e gnoseologico e il suo trapianto “scientifico” nel discorso
pedagogico.
2. Esperienza, scienza, epistemologia
Le pagine antiche ci hanno da sempre abituato a
distinguere, nella conoscenza, la dÒxa6 dall’epist»mh.
L’una è sotto il segno della conoscenza opinabile, (forse)
legata alla sensazione; l’altra appartiene al regno della
conoscenza vera, alla vera dizione dell’essere e della
realtà, resa possibile dal noàj che nel lÒgoj si esprime. E
da qui trae origine l’epistemologia in quanto scienza
che saggia i fondamenti scientifici della conoscenza7.
Dunque, dopo aver visto la sua nascita in relazione all’essere e al legame veritativo con esso, l’epistemologia diventa essa stessa scienza, configurandosi come
6
Dico “forse”, perché è ormai presente tra gli studiosi un ricco
movimento che tende a valutare positivamente la dÒxa nel suo tentativo laico di avvicinamento alla verità. E così è anche per la sofistica in
generale. Scrive Manno, ricordando e facendo sue le annotazioni di
Plebe: «(…) questa rivalutazione critica dell’opinione per me è la
condizione generativa per una rivalutazione fondativa della prassi
(proprio in senso marxiano), dove per costruire la pÒlij koin» abbiamo bisogno di dÒxai discutibili, commerciabili, sempre da-rinnovare e
da ri-creare (e la dÒxa si configura in quel perpetuo dokšin che per i
greci era un insieme di speranze, di credenze, di decisioni instabili, di
giudizi parziali e soggettivi, di punti di vista provvisori, e che per i latini sarà tanto un docère quanto un decère)» (M. Manno, Lettere a
Francesco, Roma, Anicia, 2012, pp. 155-156).
7
Per un accenno pur scontato, ma per la grande risonanza che ha
avuto in questi decenni (non esenti da pressapochismo), rinvio a E.
Severino, «Epistéme e destino», in Id., La filosofia futura. Oltre il dominio del divenire, Milano, Bur, 20062, p. 12 e sgg. In ambito pedagogico ricordo M. Manno, La struttura paidetica del discorso filosofico,
Palermo, Edizioni della Fondazione «Vito Fazio-Almayer», 2002.
11
Francesco Mattei
una vera e propria scienza iuxta propria principia. E si
dota allora di una tessitura concettuale autonoma in cui
organizza regole, comportamenti, procedure di validazione: diventando una delle possibili strutturazioni concettuali che, riflettendo sulla natura del fondamento del
sapere (o dei saperi), si determina come scienza della
conoscenza vera di determinati campi dell’esperienza8.
L’esperienza, dunque. Giacché è di essa che si fa
scienza e su di essa si costruiscono le teorie. Come ricordava Hegel nella Fenomenologia, il sapere è la scienza dell’esperienza della coscienza. Ma di quale esperienza si tratta? Di quale esperienza si fa scienza?
Dell’esperienza della natura? Dell’esperienza della coscienza e della soggettività umana? Dell’esperienza di
Dio e dell’esperienza religiosa? Dell’esperienza dell’uomo in relazione a Dio? Tutte domande che evidenziano, se ce ne fosse ancora bisogno, la complessità della
conoscenza quando essa voglia costituirsi come scienza. E, anche, la diretta e inevitabile incidenza dell’oggetto della scienza, e della conseguente metodologia,
nella costituzione di una scienza.
Dunque, ancora una volta la sequenza è la stessa:
soggetto, oggetto, scienza (sapere) e legame veritativo
che leghi cosa e intelletto. E detto così, ci troviamo di
fronte ad una sequenza semplice e lineare, ma sappiamo che quella sequenza lessicale ha da sempre affascinato e dannato l’avventura dell’uomo nella ricerca del
vero. Come sappiamo, del resto, che le varianti di quella
sequenza logica sono state nella storia del pensiero
(scientifico) davvero infinite, oscillando tra idealismo
e realismo, induttivismo e deduttivismo, positivismo…
e fallibilismo popperiano.
8
Per la discussione aperta in campo filosofico su un ritorno a
forme variegate di realismo, cfr. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari, Laterza, 2012.
12
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
Cosa dedurne? Che appare evidente, anzitutto, l’urgenza di una pulizia concettuale e di una definizione
dei termini. Quale esperienza? Quale scienza? Quale
verità? Quali regole e in quale discorso? Varranno, per
le cosiddette scienze umane (le diltheyane Geisteswissenschaften), le stesse regole e procedure di verifica delle
oggi dilaganti ed affermate scienze esatte, quelle Naturwissenschaften che hanno imposto il loro paradigma forte, grazie alla verificabilità, anche ad ambiti sempre più
vasti delle scienze umane? La domanda non è retorica e
ha occupato e inquietato molti studiosi del pianeta-uomo:
dai filosofi ai medici, dai sociologi agli psicologi, dagli
economisti9 ai pedagogisti. Tutti coloro, cioè, che non
possono trarre vantaggio dal fatto di interrogare semplicemente la natura, quella fÚsij che, adeguatamente interrogata, non può che rispondere sempre allo stesso modo. Ed è, questa, l’universalità e necessità di cui parlava
Kant nella Critica della ragion pura, e che gli permetteva, dopo le ambasce dello scetticismo humiano, di “fare
scienza” categorizzando adeguatamente le indispensabili
e ineludibili intuizioni spazio-temporali. Non ricordo qui
Galileo e il suo metodo, ma anche lui ebbe guai non
quando interrogò la fÚsij, ma quando quelle risposte
produssero fratture nel paradigma della “scienza umana”
(filosofico-teologica) allora dominante10.
9
Interessante il dibattito attuale sull’economia come scienza umana
non assimilabile alle scienze esatte. Del resto, le vicende economicofinanziarie di questi anni travagliati hanno acuito la consapevolezza della
“provvisorietà” epistemologica della scienza economica. Le sue capacità predittive si sono rivelate davvero flebili (cfr. in proposito R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio, Bari-Roma, Laterza, 1995). Recentemente è stato l’economista R. Skidelsky a richiamare la posizione di
Keynes («L’economia è una scienza morale, e non naturale») e ad evidenziare la debolezza dell’economia scienza esatta.
10
L’argomentazione non è «di scuola». La recente decisione politica di sottoporre a valutazione le università italiane, attraverso la va-
13
Francesco Mattei
Dunque, per quanto concerne il discorso pedagogico, si tratta di stabilire in quale settore di esperienza ci si
muova e in quale esperienza si collochino l’atto educativo, il fenomeno dell’istruzione, il processo di apprendimento, la dinamica psico-sociale (e didattica) dell’istruire
e dell’educare, il processo di adultità della decisione morale, il profilo educato della libertà… Insomma, un intreccio inestricabile forse debitore di diversi paradigmi
interpretativi ed epistemologici. Non sempre riducibili,
però, queste proposizioni sull’educazione, a comode e facili verifiche (e verificabilità). Un terreno ostico, credo,
per gli ultimi epigoni del neopositivismo logico. Il che
non preclude, naturalmente, che parte non marginale del
discorso pedagogico (e della prassi educativa) possa e
debba essere sottoposta al paradigma classico di ipotesi-esperimento-verifica-legge. L’abbecedario galileiano, insomma, qui come altrove del tutto valido.
Il problema sorge quando l’esperienza educativa
porta in sé, e ne è parte integrante, il peso della libertà,
della determinazione soggettiva, dei valori che fecondano
(o infestano) il processo educativo. Quando religione filosofia libertà atteggiamenti valori… (una vera catena
assiologica) sono presenti in educazione e difficilmente
possono sottostare agli obblighi procedurali ed “esperienziali” delle Naturwissenschaften. Ma allora, come giudicare e valutare quel discorso, quella educazione, quel
profilo di libertà acquisita da prassi educativa? La verità si piegherebbe lì a logiche in-dicibili, in-giudicabili,
in-esprimibili? Non è più possibile, in quel contesto, il
discorso sensato, il discorso vero, il discorso da sottoporre ad analisi logica?
lutazione dei “prodotti” di ricerca dei docenti, ha riaperto l’annosa polemica in seno alla comunità scientifica e all’ANVUR.
14
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
Tornerò sull’argomento, e accenno ora al tema della
verità, giacché ogni discorso sensato ha come sfondo
intenzionale il vero, quel sigillum veri che costituisce e
costruisce qualsivoglia discorso scientifico. Senza quel
traguardo, il discorso dell’uomo segue legittimamente
un itinerario possibile, uno dei tanti in cui egli può dare parola (e concetto) alla sua esperienza. Ma non ogni
esperienza è scientifica, e la realtà dell’uomo è talmente polimorfa e variegata da poter essere espressa in
molte parole, in molti linguaggi, in molte logiche.
Siamo in presenza del discorso poligonico del lÒgoj.
Su di esso molto ha lavorato Mario Manno, nella sua
opera pluridecennale di paziente scavo attorno al rapporto e•nai-lÒgoj e alla dicibilità dell’essere. Ed è anche la riproposizione dell’intuizione aristotelica, che già
aveva affermato dell’e•nai che può essere detto in
molti modi (pollacîj lšgeton) e non in un solo modo (monacîj lšgeton). Wittgenstein aveva ripreso il
tema e l’aveva sviscerato per decenni nella lunga elaborazione delle Ricerche logiche, proprio là dove lui,
partito dalle asperità rarefatte della logica di Frege e
Russell, aveva poi indagato lungamente quel linguaggio ordinario che sta in ordine così com’è, come è detto
dall’uomo (anche nella dizione non-logica ma non perciò meno sensata).
La verità, dunque. Verità è detta nella cultura greca come ¢l»qeia o come ÑrqÒthj. L’una richiama un
dis-velamento progressivo, un’uscita dal nascondimento (lanq£nw), un farsi luce dell’essere che si mostra
progressivamente alla ragione, al noàj che lo dice nel
lÒgoj. Ed è inutile richiamare qui la fortuna ermeneutica, tuttora perdurante, che ha accompagnato la lezione e dizione heideggeriana di questa ermeneusi della
verità. L’altra, l’ÑrqÒthj, presuppone una corrisponden15
Francesco Mattei
za (l’adaequatio di Tommaso e di gran parte dell’empirismo inglese) del concetto all’ente e agli enti. Ma
questi enti sarebbero già una cosificazione-riduzione
dell’essere agli enti. E dunque, un impoverimento dell’essere a cui tutta la conoscenza va ricondotta. E responsabile di questo tradimento riduzionistico sarebbe lo stesso Aristotele (non a caso padre dell’induttivismo!).
Queste le premesse antiche. Ma cosa è successo ai
moderni? Come ha recepito il pensiero moderno, dopo
il positivismo, il concetto di verità che la ragione può
offrire? Come si è modulato il dettato della ragione che
conosce e fa verità? Basterà la corrispondenza di cosa
(realtà) e concetto a restituire la verità alla sua funzione principe, quella cioè di conoscere il “mondo” (e
dunque l’essere) e stabilire tra i due poli (cosa-concetto) una relazione di esattezza? Sarà sufficiente, questa relazione, ad esaurire la complessità del concetto di
vero? O non sarà piuttosto, tale accezione, solo capace
di rispondere ad esigenze di pura funzionalità?
Domande scontate, forse. Ma sappiamo quanto lacerate e variegate siano state, nel moderno e nel postmoderno, le variazioni sul tema della Ragione. E ogni
variante si è trascinata dietro una corrispondente accezione di verità. Perciò, a mero titolo esemplificativo,
riprendo la polemica di Horkheimer con il positivismo.
Dice dunque il filosofo-sociologo francofortese:
come è possibile ridurre il concetto di verità al concetto di esattezza? Chi è responsabile di questo riduzionismo limitante? Chi può limitare fino a tal punto la razionalità? Perché ridurre la scienza a quella pallida
razionalità? Così Horkheimer: «Ma la ragione, in sostanza, può essere promossa e sostenuta soltanto correggendo
ciò che oggi pretende di essere l’unica ragione, cioè la
scienza. La scienza attuale non viene utilizzata, come
sarebbe necessario e ragionevole, in quanto strumento,
16
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
ma viene semplicemente interpretata come la verità. A
tutti è noto che oggi la scienza è giudicata l’unico atteggiamento intellettuale possibile (…). E quell’idea, o meglio, quell’opinione sedicente filosofica che si chiama
positivismo non è altro che l’innalzamento della scienza al rango di verità»11. E icasticamente definisce il positivismo «(…) l’incapacità di capire la differenza tra
verità ed esattezza»12. Una identificazione che restringerebbe molto, per lui, lo spazio della verità (e della
ragione che la ricerca) e che disseccherebbe irrimediabilmente le radici ramificate che nel profondo continuamente la alimentano.
Questa la posizione di Horkheimer. E certamente
non è il solo a sposare queste declinazioni della ragione e della scienza. Mi preme però sottolineare, sulla
scia dei suoi ragionamenti, come le accezioni di scienza,
verità (esattezza), ragione siano tra loro così collegate
da influenzare profondamente i paradigmi semanticoconcettuali con cui si guarda ad essi per pensare la
scienza. Potrei perciò seguire Horkheimer su questi
sentieri e riprendere tali argomentazioni in La nostalgia del totalmente Altro13, là dove egli si sofferma sulla
necessità di non inaridire la vena teologico-religiosa
per mantener viva quella potenza del negativo tanto
necessaria per la teoria critica14. Ma ciò che mi sembra
11
M. Horkheimer, Rivoluzione o libertà?, Milano, Rusconi,
1972, pp. 37-38 (c.m.).
12
Ibid., p. 38 (c.m.).
13
M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente Altro, Brescia,
Queriniana, 1978.
14
Così Horkheimer: «Dirò una frase alquanto audace: senza una
base teologica, l’affermazione che l’amore è migliore dell’odio resta
assolutamente immotivata e priva di senso. Perché l’amore dovrebbe
essere migliore dell’odio?» (Id., Rivoluzione o libertà?, cit., p. 38). E
ancora: «Perciò è necessario riflettere seriamente sulle conseguenze
prodotte dalla liquidazione della religione» (Ibidem). Sulla funzione
critica del lascito religioso per la trasformazione dell’esistente affer-
17
Francesco Mattei
più interessante, nel caso, è il limite che egli tenta di
porre all’assolutismo di un paradigma di scienza onnicomprensivo e troppo determinante (e dunque eo ipso escludente) nella costruzione di significati che eccedono la sua esperienza e la comprensione di quella stessa
esperienza. E la critica che egli rivolge alla razionalità
weberiana, e senza indulgenza, va proprio in quella direzione15. Perché si sta disputando, in definitiva, sulle
forme della ragione, sulle condizioni di possibilità della verità, sugli atteggiamenti che ne conseguono per la
condotta pratica del soggetto.
Questo mi sembra il punto di approdo di Horkheimer: la scienza non è l’unica forma di conoscenza; la
verità non è soltanto l’esattezza offerta dalla conoscenza tecnico-scientifica (che è poi soltanto una declinazione aggiornata della mai dimenticata adaequatio rei
et intellectus); la ragione esplora altre dimensioni e dice altre esperienze non riconducibili o riducibili all’esperienza scientifica misurabile. E così si giunge, seguendo le semantiche della ragione e della verità, su
sponde del tutto opposte a quelle ben delineate ed argomentate da Ayer e dai neopositivisti logici. Sempre invocando, però, la presunzione di aver attinto un significato
ma: «All’ordine esistente, che costituisce l’oggetto della teoria critica,
appartengono non soltanto le forze che tendono a mantenerlo in vita,
ma anche i problematici tentativi di mutarlo. Qualcuno di quei tentativi
merita di essere salvato: per esempio, lo sforzo di ricondurre una moralità
umana naturale a delle radici teologiche (...)» (Rivoluzione o libertà?, cit.,
p. 105 - c. m.). Ma subito (kantianamente) aggiunge: «(...) il che peraltro
non significa affermare la verità di tale origine teologica» (Ibidem).
15
La differenza tra Horkheimer-Adorno e Weber, in merito
all’accezione di razionalità, è evidente e molto insistita. I dioscuri
francofortesi imputano a Weber di aver soggettivizzato e formalizzato
la razionalità, di averle tolto ogni possibilità di dizione in merito agli
“scopi ultimi dell’esistenza umana”. Cfr., in proposito, Eclisse della
ragione. Critica della ragione strumentale, Einaudi, Torino 19696, pp.
13-14n.
18
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
definitivo (e adeguato) di verità. Ma è troppo palese la distonia ermeneutica ed epistemologica: ciò che per Ayer e
per i neopositivisti logici è semplicemente vero, per
Horkheimer e per i francofortesi è più modestamente
esatto. Ma è interessante osservare come ambedue le
posizioni teoriche utilizzino (del tutto legittimamente),
avendoli prima definiti, i termini scienza e verità.
Cosa dedurne? Anzitutto, che non si dà un senso
univoco di ragione, di scienza, di teoria scientifica, di epistemologia. Anche se non è mancato chi ha voluto tentare di unificare i due metodi, i due paradigmi, le due
accezioni di scienza e di significato16.
Il metodo sperimentale (induttivo), come abbiamo
appreso definitivamente da Galileo, necessita di osservazioni, ipotesi, esperimenti, verifiche, formulazioni di
leggi. È la matrice logico-epistemologica delle cosiddette
scienze esatte (o dure), e ad essa farà riferimento, secoli
dopo, lo storicismo tedesco nel riproporre il problema del
metodo. Il metodo ipotetico-deduttivo, invece, ultimo
profeta Popper, ha altra storia e altre caratteristiche, ma
uguale pretesa di attingere il reale nella sua dimensione
veritativa: senza dannarsi, però, con l’experimentum crucis della verifica (o meglio, di una accezione di verifica). Ma sarà proprio questo versante ad attrarre le sim16
Cfr. ad es. D. Antiseri, Teoria unificata del metodo, Torino,
Utet Libreria, 2001; Id. et alii, Epistemologia, clinica medica e la «questione» delle medicine «eretiche», Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
Antiseri ha lavorato soprattutto in un confronto, che personalmente non
condivido del tutto, tra scienze umane e scienza medica. Le mie riserve
derivano dal fatto, quasi scontato, che la classificazione della medicina
tra le scienze esatte è dubbia, vista la particolarità dell’oggetto indagato (l’uomo) e l’impossibilità di pensare oggi, ad esso, come ad un
homme machine. E non sono mancate posizioni contrarie, intente a
depotenziare il paradigma scientifico, assimilandolo a puro strumento
di dominio dell’ideologia, come accade in alcuni autori marxisti (cfr.
ad es. R. Garaudy, Parola di uomo, Assisi, Cittadella, 1975, p. 45).
19
Francesco Mattei
patie della ricerca “umanistica”, anche se la sua “esperienza” appariva troppo composita e troppo frastagliata,
preda di forti ideologie e (necessariamente) deboli filosofie. Insomma, aveva in sé poca forza “esplicativa”. E
mentre la scienza esatta offriva predittività, certezza,
universalità, riproducibilità, le “scienze umane” porgevano comprensioni, descrizioni, analisi, storie, casi, auspici,
naufragi… Tutto ciò che rimaneva nell’ambito di una
comprensione ex post.
Troppo poco, tutto ciò, per identificarsi o sovrapporsi al robusto “nesso causale” (lo scire per causas) della
scienza dura e alla consequenzialità stringente della logica. Ma la tentazione di modellizzazione ed esemplarizzazione era naturalmente presente. Come presente era, nel
pensiero filosofico-umanistico, la consapevolezza che
la scienza esatta non avrebbe offerto sponde comprensive od esplicative alle esaltanti o deprimenti vicende
dell’humana conditio. La società conosceva accelerazioni e conflitti. L’individuo appariva incredulo o inerme (quando non partecipe entusiasta) di fronte agli
assolutismi distruttivi che lo sovrastavano. Non era
dunque facile, date queste premesse, resistere al richiamo attrattivo del paradigma euristico-epistemologico delle scienze della natura.
Ma allora, a che punto siamo? La mia impressione
è che siamo ancora rimasti alla “frattura” kantiana. E,
per quanto mi riguarda, direi alla sana frattura kantiana. Il limite kantiano dell’uomo che fa scienza (Critica
della ragion pura) e dell’uomo che vuole e che spera
(Critica della ragion pratica), nonostante i molti superamenti, non mi sembra ancora valicato. L’uomo che
scientificamente conosce e l’uomo che moralmente agisce stanno ancora vivendo il loro esperimento di coabitazione. E non so se l’uomo del bello o del sublime, o
20
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
quello che “giudica”, riuscirà oggi a tenere in equilibrio l’unità del kantiano soggetto trascendentale. Sembra insomma che l’esperienza “naturale” e l’esperienza
“storico-morale” abbiano alfabeti diversi e diverse teoresi. E non sempre sovrapponibili, come ha splendidamente intuito Goldmann17. Sembra impossibile, in
definitiva, ricomporre in unità l’uomo diviso kantiano.
Il regno della necessità (scientifica) ha ragioni interne
del tutto diverse dal regno della libertà (morale). Nell’uno regnano la necessità e l’oggettività universale.
Nell’altro la ragion pratica (si) dà leggi che devono regolare la somma libertà del soggetto. E a poco valgono,
come noto, le determinazioni delle categorie a priori
che “fanno scienza”. Il sapere (scientifico) del mondo
oggettivo ha poco da dire all’uomo-che-vuole, al soggetto che si trova di fronte al dilemma della libertà.
L’uomo che sa è altro rispetto all’uomo che deve (e
può) volere, perché l’uno è legato a dati oggettivamente ineludibili, l’altro ha come suo limite la sua stessa
libertà e la determinazione di essa18.
Qui giunti, non sfuggirà il motivo di tanta insistenza:
la soluzione del dilemma influisce significativamente
sulla configurazione delle scienze e, ancor più, sull’autocomprensione che esse hanno di sé. Non è mancato, in
proposito, chi ha messo in guardia dagli opposti pericoli
in cui esse possono incorrere. Se privilegiano il lato
misurabile ed ostensibile, enfatizzando l’aspetto quantitativo e producendo risultati nel progresso della conoscenza, rischiano di lasciare impensato il lato qualitati17
1975.
Cfr. L. Goldmann, Introduzione a Kant, Milano, Mondadori,
18
Icastico Colletti: «La scienza, dunque. E su tutt’altro versante –
quando proprio occorra e non se ne possa fare a meno – la fede. Ragion
pura e Ragion pratica. Ecco il vero luogo di nascita della dissociazione tra
Fatti e Valori: due mondi tra cui non c’è comunicazione» (L. Colletti, Fine
della filosofia e altri saggi, Roma, Ideazione, 1996, p. 21).
21
Francesco Mattei
vo, il lato che evidenzia la specificità umana delle
scienze umane. Se si addolorano attorno al lato soggettivo (o soggettivistico) dell’umano, possono facilmente
cadere (o scadere) nel parenetico e nell’esortativo. Il che
può sì risultare indolore o mistificatorio, ma anche, come
il Novecento ha tristemente e crudamente dimostrato, assumere il volto tragico di una devastante ideologia.
È questa situazione di ambivalenza che spinge le
scienze umane a privilegiare ora l’uno ora l’altro versante. Abbiamo così una sociologia qualitativa e una
sociologia statistico-descrittiva; una psicologia umanistica e una psicologia sperimentale o comportamentista;
una pedagogia umanistica e una pedagogia (neutralmente o appassionatamente) sperimentalista. Ma il problema, come abbiamo tentato di evidenziare, esiste anche per le altre discipline umanistiche.
Da che cosa deriva allora questa ambiguità? Mi sembra di poter dire che essa è originata dalla particolarità
dell’oggetto di indagine e dagli strumenti metodologici
dell’indagine stessa. Da una parte, quando ad essere
indagato è il soggetto e il suo mondo, vengono meno (o
possono venir meno) quelle condizioni “oggettive” che
permettono l’uso di strumenti neutrali capaci di osservare, definire ipotesi, fare verifiche, formulare leggi
esplicative e predittive (giacché il soggetto è, nello
stesso tempo, oggetto e attore dell’indagine). Dall’altra, il concetto di “esperienza” appare nei due contesti di
indagine del tutto diverso. L’esperienza umana e l’esperienza naturale non sono esattamente sovrapponibili. Perciò il Lebenswelt non è indagabile con la strumentazione scientifico-naturalistica. Si ricorre ad altre
categorie. E l’ermeneutica, la filosofia morale, la filosofia politica, la filosofia dell’educazione... – insomma,
tutto l’armamentario delle scienze umane, – usano diversa attrezzatura di spiegazione (Erklärung) o di com22
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
prensione (Verstehen). E l’esperienza, allora, è Erfahrung (esperienza misurabile) o Erlebnis (esperienza
vissuta). Ma diversi saranno, necessariamente, i metodi
di indagine e le vie di ricerca della verità.
3. Pedagogia come scienza e discorso pedagogico
Questi i dilemmi che agitano (o agitavano) parte
delle dispute accademiche sullo statuto delle scienze
esatte e delle scienze “umane”. Naturalmente, vi ho
soltanto accennato. E vi ho accennato perché il discorso pedagogico è più di altri “giochi linguistici” (scientifici) sensibile a questi dilemmi e alle perplessità che
ne derivano. Troppo forte, infatti, è il rischio che esso
cada (o scada) nel discorso parenetico, o che parli in
nome di una scientificità presunta ma impossibile da
esibire e giustificare. Se però si va a guardare più da
vicino l’arcipelago linguistico interessato al fenomeno
e alla parola “educazione”, si potrà facilmente costatare che le sotto-organizzazioni verbali che fanno riferimento a quel processo non sono poi infinite. Una parte
di esse ha bisogno, per parlare in modo “sensato”, di
paradigmi scientifico-sperimentali che saggino le proposizioni alla maniera delle discipline “dure”. E in
questa prospettiva, poco è da inventare. Meglio stare al
quia e non svolazzare in generosi slanci esortatori. Infatti, la fantasia linguistico-utopica inficerebbe in modo
irreversibile la validità di quel discorso. Altra organizzazione linguistico-concettuale fa invece riferimento al
paradigma storico o storiografico. E anche qui, poco
spazio è concesso alle perplessità teoretiche o teologico-metafisiche. Le linee di legittimità sono scritte altrove, e quelle norme vanno apprese e utilizzate senza
piegarle ad impossibili salvezze (storiografiche). E ciò
23
Francesco Mattei
vale anche per la costellazione della didattica, che se
non vuole parlare invano ha bisogno di metodi e di verifiche serie.
Più seria e problematica, invece, la ramificazione
dei nessi concettuali che vorrebbe (o dovrebbe) mettere
ordine in quella che si è soliti chiamare pedagogia generale o filosofia dell’educazione. Qui le emicranie o
le illusioni, anche in versione ideologica, non sono rare. Anzi, in qualche modo rappresentano una malattia
endemica di quel linguaggio. Due cose, però, mi sembra si possano dire. Prendendo a prestito l’antica distinzione tra atto e fatto, tra fenomeno ed evento, si
può applicare a questa distinzione una duplice logica di
senso e di verifica. Se si considera infatti l’educazione
come un fatto, come un insieme di pratiche e comportamenti osservabili e misurabili, vale per l’educazione
ciò che osservava Comte per la nascente socio-logia.
Essa va osservata, decodificata e compresa come un
insieme di fatti che formano un corpo strutturato che
non può sottrarsi alle leggi della scienza stricto sensu.
Se invece si tematizza l’educazione come un atto, come
l’atto (educativo) che nell’incontro di due libere alterità
(di educatore ed educando) si fa, alla maniera di Kierkegaard, “edificante”, quell’evento educativo (l’Ereignis
heideggeriano) va compreso e interpretato con criteri
che si sottraggono, credo, ai criteri dell’osservabilità e
verificabilità delle scienze dure. E vale allora il lato interpretante del Verstehen, del comprendere una Erlebnis che si sottrae alla pura verificabilità19. E a questo
19
Non sfugge, naturalmente, la possibile ambiguità dei rispettivi
confini, dalla filosofia analitica chiamati demarcazione. Concludeva
Colletti: «Dopo decenni di ricerche indefesse sul “significato” e sul
“riferimento”, la filosofia analitica non è riuscita a cavare il ragno dal
buco. (…) Quanto poi alla filosofia della scienza (…) si è ormai
all’impossibilità dichiarata di distinguere tra scienza e religione, tra
scienza e magia, salvo riconoscere che si tratta di “stili di pensiero”
24
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
spazio pratico e semantico apparterranno allora la persuasione (il platonico pe…qw), il con-vivere (suz£w toà suzÁn), il con-essere (sune‹nai-sunous…a), il curare, il custodire, l’allevare, il nutrire20, e l’accendere improvviso da scintilla di fuoco (¢pÕ purÕj phd»santoj
™DBGRÉO GÕÀ) della VII lettera di Platone (341 c6-d2).
I passaggi classici, insomma, dell’antica paideia sempre riproposti nella pagina platonica.
Per chiudere, vorrei ricordare alcuni pedagogisti
italiani (non marginali) che hanno arato questi terreni.
Nello sforzo di far uscire dall’ambiguità il senso “scientifico” del termine educazione, credo essi abbiano avuto
limitata fortuna e non sono riusciti a sottrarsi alla necessitata “ambiguità” del concetto di educazione. Anzi,
sarebbe forse più corretto dire che hanno ricercato con
consapevolezza la sfumatura semantica a-scientifica
dell’atto educativo. Penso alla Metelli di Lallo, a De
Giacinto, a Granese, a Edda Ducci. Della prima ricordo
il saggio Analisi del discorso pedagogico21, lavoro antico ma non datato, e troppo poco riletto. Di De Giacinto
è rimasto lo studio Educazione come sistema22, l’analisi
forse più completa e raffinata dell’educazione come
“fatto educativo” e della sua (misurabile) organizzazione.
Ma l’ultimo capitolo del trattato (cap. V) è appunto intitolato “L’evento”, e dell’evento esso conserva l’indecifrabilità e il mistero. Perciò l’autore si abbandona alla
diversi ma parimenti legittimi» (ibid., pp. 36-37). Accadrà così anche
per la pedagogia?
20
«…t…na aÙto‹n ™n nù ›ceij ™pist£thn labe‹n» (Apologia,
20b). Ma la sequenza di questi verbi, legati alla persuasione, alla custodia, alla cura e all’allevamento, è in Platone davvero martellante.
21
C. Metelli di Lallo, Analisi del discorso pedagogico, Venezia,
Marsilio Editore, 1966.
22
S. De Giacinto, Educazione come sistema, Brescia, La Scuola,
1977.
25
Francesco Mattei
metafora del Castello kafkiano. Le teorie pedagogicoscientifiche sono simili alle strade che portano al Castello. Ma come entrare? Come accedere all’evento, se l’evento non si lascia penetrare attraverso la razionalità
delle strade (metodi)? È solo la morale, per lui, che
può permettere l’accesso: perché soltanto piegando (educando) la libertà si può oltrepassare la porta.
Di Granese ricordo Il labirinto e la porta stretta23,
lo studio che ha rappresentato una svolta significativa
nello sviluppo del suo pensiero. E non manca, il pedagogista sardo, di sottolineare una “sconcertante ambiguità” nel marxismo pedagogico (lui che il marxismo
l’aveva a lungo teorizzato), una marcata venatura di
“pedagogismo pelagiano”, una scientificità sui generis
per la pedagogia24, ma anche una «pedagogia scientificoempirica (della quale non vanno dimenticate o sottovalutate le grandi benemerenze)»25. Anche se tali benemerenze, par di capire, non esauriscono la misteriosa apertura e
ricchezza dell’atto educativo, e lasciano a marxismo e
cristianesimo, e ad un loro auspicato incontro, la decifrazione e l’attualizzazione di «esigenze di totalità» ed
«evidenze della finitezza». Ma qui siamo oltre la scientificità. Forse in terra di teologia dell’educazione. Un
terreno non calcato da Edda Ducci. Che, pur rivendicando un margine ineffabile per la paideia26, sempre
sta ferma all’¢nqrop…ne sof…a della pagina platonica27, e sempre cerca di scavare in terra hominis, senza
violare la sof…a toà qeoà. Una pagina, credo, di umanesimo laico non irreligioso e un rispetto autentico per
23
A. Granese, Il labirinto e la porta stretta. Saggio di pedagogia critica, Firenze, La Nuova Italia, 1993.
24
Ibid., p. 38.
25
Ibid., p. 36. Granese la chiama «piccola razionalità efficace».
26
E. Ducci (cura di), Il margine ineffabile della paideia. Un bene da salvaguardare, Roma, Anicia, 2007.
27
Apologia, 20d, 23a.
26
Discorso pedagogico e riflessione epistemologica
la razionalità dell’uomo. Ed è la stessa razionalità che
nella scienza, anche pedagogica, può (e deve) trovare
adeguata espressione.
Riferimenti bibliografici
Antiseri D., Teoria unificata del metodo, Torino, Utet Libreria,
2001.
Cambi, L’epistemologia pedagogica oggi, in «Studi sulla formazione», XI (2008), n. 1, pp. 157-163.
Colicchi E., Per una pedagogia critica, Roma, Carocci, 2009.
Colletti L., Fine della filosofia e altri saggi, Roma, Ideazione, 1996.
De Giacinto S., Educazione come sistema, Brescia, La Scuola,
1977.
Ducci E. (cura di), Il margine ineffabile della paideia. Un bene da
salvaguardare, Roma, Anicia, 2007.
Giosi M., L’epistemologia pedagogica anglosassone, Milano, Unicopli, 2009.
Granese A., Il labirinto e la porta stretta. Saggio di pedagogia critica, Firenze, La Nuova Italia, 1993.
Manno M., Lettere a Francesco, Roma, Anicia, 2012.
Mattei F., Sfibrata paideia, Roma, Anicia, 2009.
Metelli di Lallo C., Analisi del discorso pedagogico, Venezia, Marsilio Editore, 1966.
Nussbaum M., Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Bologna, il Mulino, 2011, (Princeton, 2010).
Sola G. (a cura di), Epistemologia pedagogica. Il dibattito contemporaneo in Italia, Milano, Bompiani, 2002.
27
[Americanismo e fordismo]
Serie di problemi che devono essere esaminati
sotto questa rubrica generale e un po’ convenzionale di «Americanismo e Fordismo», dopo
aver tenuto conto del fatto fondamentale che le
risoluzioni di essi sono necessariamente impostate e tentate nelle condizioni contraddittorie
della società moderna, ciò che determina complicazioni, posizioni assurde, crisi economiche e
morali a tendenza spesso catastrofica, ecc.
(A. Gramsci, Quaderno 22)
28