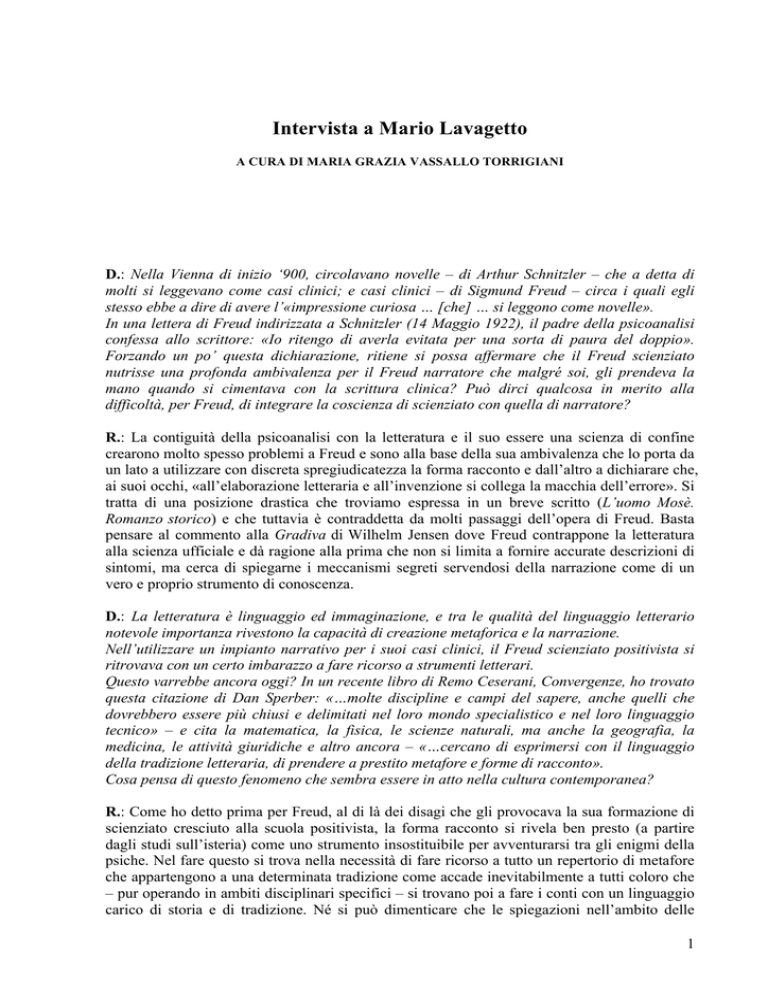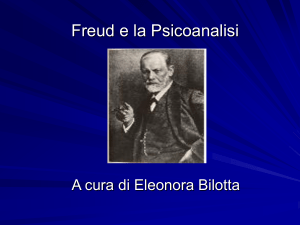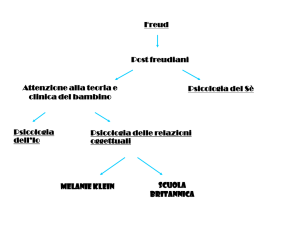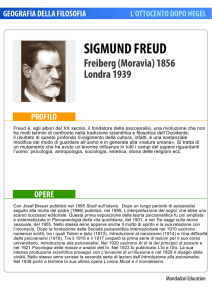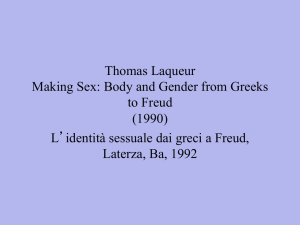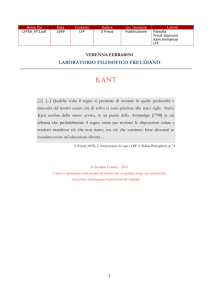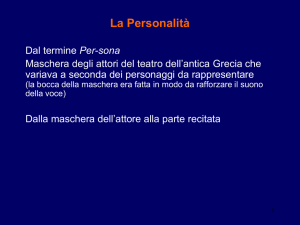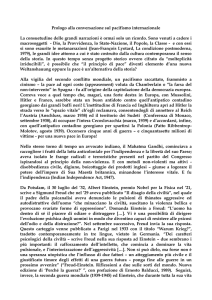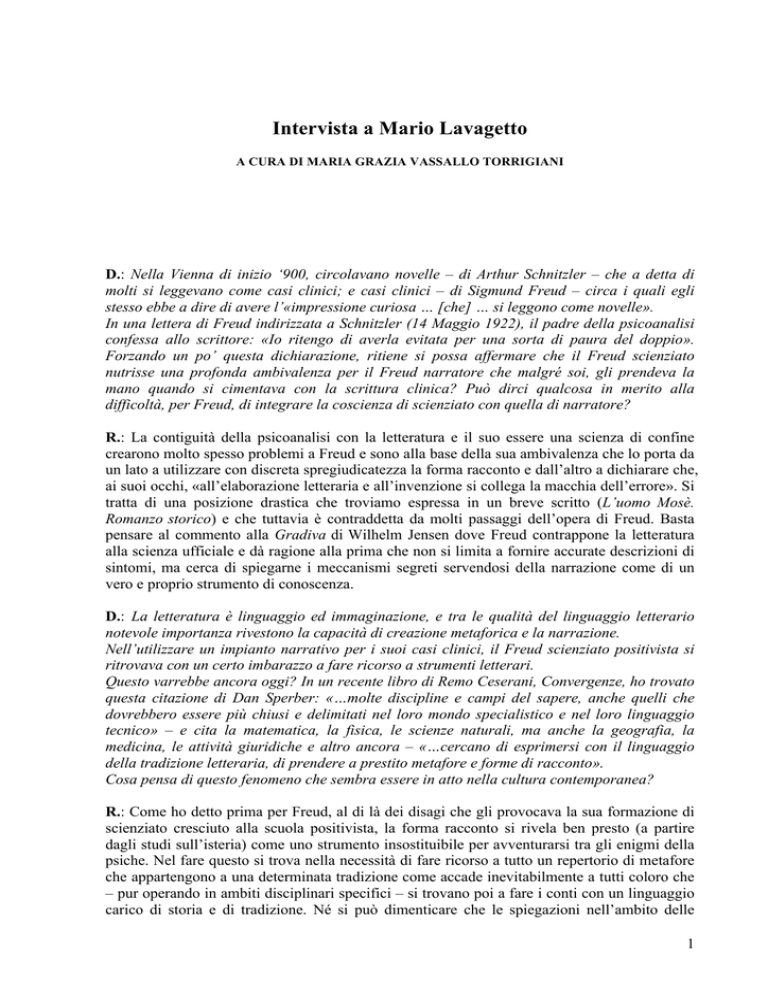
Intervista a Mario Lavagetto
A CURA DI MARIA GRAZIA VASSALLO TORRIGIANI
D.: Nella Vienna di inizio ‘900, circolavano novelle – di Arthur Schnitzler – che a detta di
molti si leggevano come casi clinici; e casi clinici – di Sigmund Freud – circa i quali egli
stesso ebbe a dire di avere l’«impressione curiosa … [che] … si leggono come novelle».
In una lettera di Freud indirizzata a Schnitzler (14 Maggio 1922), il padre della psicoanalisi
confessa allo scrittore: «Io ritengo di averla evitata per una sorta di paura del doppio».
Forzando un po’ questa dichiarazione, ritiene si possa affermare che il Freud scienziato
nutrisse una profonda ambivalenza per il Freud narratore che malgré soi, gli prendeva la
mano quando si cimentava con la scrittura clinica? Può dirci qualcosa in merito alla
difficoltà, per Freud, di integrare la coscienza di scienziato con quella di narratore?
R.: La contiguità della psicoanalisi con la letteratura e il suo essere una scienza di confine
crearono molto spesso problemi a Freud e sono alla base della sua ambivalenza che lo porta da
un lato a utilizzare con discreta spregiudicatezza la forma racconto e dall’altro a dichiarare che,
ai suoi occhi, «all’elaborazione letteraria e all’invenzione si collega la macchia dell’errore». Si
tratta di una posizione drastica che troviamo espressa in un breve scritto (L’uomo Mosè.
Romanzo storico) e che tuttavia è contraddetta da molti passaggi dell’opera di Freud. Basta
pensare al commento alla Gradiva di Wilhelm Jensen dove Freud contrappone la letteratura
alla scienza ufficiale e dà ragione alla prima che non si limita a fornire accurate descrizioni di
sintomi, ma cerca di spiegarne i meccanismi segreti servendosi della narrazione come di un
vero e proprio strumento di conoscenza.
D.: La letteratura è linguaggio ed immaginazione, e tra le qualità del linguaggio letterario
notevole importanza rivestono la capacità di creazione metaforica e la narrazione.
Nell’utilizzare un impianto narrativo per i suoi casi clinici, il Freud scienziato positivista si
ritrovava con un certo imbarazzo a fare ricorso a strumenti letterari.
Questo varrebbe ancora oggi? In un recente libro di Remo Ceserani, Convergenze, ho trovato
questa citazione di Dan Sperber: «…molte discipline e campi del sapere, anche quelli che
dovrebbero essere più chiusi e delimitati nel loro mondo specialistico e nel loro linguaggio
tecnico» – e cita la matematica, la fisica, le scienze naturali, ma anche la geografia, la
medicina, le attività giuridiche e altro ancora – «…cercano di esprimersi con il linguaggio
della tradizione letteraria, di prendere a prestito metafore e forme di racconto».
Cosa pensa di questo fenomeno che sembra essere in atto nella cultura contemporanea?
R.: Come ho detto prima per Freud, al di là dei disagi che gli provocava la sua formazione di
scienziato cresciuto alla scuola positivista, la forma racconto si rivela ben presto (a partire
dagli studi sull’isteria) come uno strumento insostituibile per avventurarsi tra gli enigmi della
psiche. Nel fare questo si trova nella necessità di fare ricorso a tutto un repertorio di metafore
che appartengono a una determinata tradizione come accade inevitabilmente a tutti coloro che
– pur operando in ambiti disciplinari specifici – si trovano poi a fare i conti con un linguaggio
carico di storia e di tradizione. Né si può dimenticare che le spiegazioni nell’ambito delle
1
materie umanistiche hanno necessariamente una forma narrativa e presuppongono un’accorta
messa in intreccio dei dati. Non ho competenze per verificare quanto questo si rifletta anche in
campi del sapere come la fisica, la matematica, la medicina e le scienze naturali in genere, ma
mi sembra che se simili contaminazioni si verificano il loro interesse sia direttamente
proporzionale alla preterintenzionalità del riuso. Credo che in ogni caso sarebbe opportuno
verificare quanto quelle contaminazioni siano rilevabili, oltre che negli scritti a carattere
divulgativo, anche nella ricerca di punta dove mi sembra che possano avere ben poco spazio.
D.: Nella sua densa e illuminante prefazione al recente volume Einaudi che raccoglie i casi
clinici di Freud – significativamente intitolati «Racconti analitici» – lei propone, in una sorta
di esperimento, di mettere tra parentesi «la specificità terapeutica dei casi clinici», e di
considerarli come racconti da attribuire all’autore Freud.
Sempre in una sorta di esperimento, cosa a suo avviso si potrebbe attribuire all’autore
Modello e cosa all’autore Empirico in merito all’intenzione e alla creazione narrativa?
R.: Nella mia proposta non ho fatto altro che attenermi a una indicazione di Freud che
all’inizio dell’epicrisi del caso Elisabeth von R. si sente in dovere di presentare le proprie
credenziali di scienziato che si è regolarmente formato con le diagnosi locali e con
l’elettroprognosi e che è costretto a prendere atto che i suoi casi clinici si leggono «piuttosto
come novelle» e sono apparentemente privi della «rigorosa impronta della scientificità”. Non
solo: ripetutamente Freud appare impegnato a riflettere sulla forma racconto, a metterla alla
prova, a saggiarne i limiti e finalmente a deformala per cercare (invano, dice lui) di restituire
«le grandi opere d'arte della natura psichica». Fare le parti, stabilire quanto è dovuto all’autore
empirico che Freud si trova a impersonare, risulta pressoché impossibile anche sul piano
puramente sperimentale e questo proprio perché Freud accetta di essere un narratore suo
malgrado, costretto (ribadisce in ogni occasione) dalle necessità della materia che è la stessa su
cui per secoli si è esercitato il genio di narratori e drammaturghi. I quali tuttavia erano tenuti a
velare, a nascondere, a ovattare mentre a lui, al medico e allo scienziato, si imponeva il
compito di portare in piena luce, di non nascondere nulla e, al caso, di compromettere
l’equilibrio estetico che sembrava provvisoriamente raggiunto. Se fossi uno scrittore, dirà a un
certo punto nel caso Dora, mi fermerei qui…
D.: Sempre nella sua prefazione, con una suggestione da Bachtin, lei scrive che la coscienza
dell’autore Freud è «“coscienza di una coscienza” in quanto ingloba e porta a compimento la
coscienza dei suoi personaggi e del loro mondo». Ossia l’autore Freud: «…vede e sa non
soltanto quello che vedono e sanno i personaggi singolarmente presi e tutti i personaggi
insieme, ma vede e sa anche più di loro, anzi egli vede e sa qualcosa che ad essi, per principio,
è inaccessibile». Quando al medico impegnato nel lavoro in studio con il paziente si sostituirà
l’autore, questi dovrà raccontare non solo la storia di cui è giunto ad impadronirsi, ma anche
il modo. Dunque alla fine un narratore onnisciente, che tuttavia deve barcamenarsi tra il
sapere e il non sapere, e rivelare anche la tecnica di indagine?
R.: Più che di onniscienza, parlerei di consapevolezza superiore, di consapevolezza acquisita
strada facendo e che al momento della scrittura fornisce una piattaforma, un di più di sapere
grazie a cui il medico può ricostruire le successive fasi dell’analisi, dove era impegnato –
insieme al paziente – nella prima elaborazione di quello che è stato chiamato il «romanzo
analitico». Credo che per comodità si potrebbero distinguere due fasi: nella prima il di più di
sapere dell’analista è riconducibile alla teoria e alla tecnica che lo mettono in una posizione di
vantaggio rispetto al paziente e che tuttavia non gli consentono una risoluzione preliminare dei
numerosi enigmi in cui si imbatte, nella seconda quel di più di sapere risulta da una
costruzione che ha preso progressivamente forma e che permette di realizzare la necessaria
2
(secondo Bachtin) «esotopia». In ogni caso vale la pena di sottolineare che il rapporto tra
l’analista e il paziente è solo parzialmente omologo a quello tra il narratore e il personaggio e
che l’analista-narratore ha il compito di rendere accessibile il suo sapere anche al pazientepersonaggio.
D.: La narrazione psicoanalitica come strategia conoscitiva è stata assimilata ad un genere
letterario ben preciso, al romanzo di investigazione. Lo stesso Freud, in Introduzione alla
psicoanalisi (1915-1916), come indicazione di metodo evoca la figura dell’«agente
investigativo», che lavora su dettagli, «tracce lievi», «piccoli indizi», tra cui includere anche
omissioni, simmetrie, lapsus ecc.
In un recente volume collettaneo, Psicoanalisi in giallo, un gruppo di psicoanalisti italiani ha
letto le trasformazioni e i mutamenti della psicoanalisi contemporanea attraverso la lente
letteraria della evoluzione del poliziesco: dal romanzo di indagine all’hard boiled d’azione.
Rispetto all’investigatore freudiano classico – osservatore esterno alla vicenda – che con
procedimenti induttivi risale alle cause e al «colpevole», l’investigatore-analista di molta
psicoanalisi contemporanea appare più compromesso, più rischiosamente in gioco nel campo
relazionale con le sue proprie passioni ed emozioni, più co-costruttore della storia che si va a
narrare che distaccato ri-costruttore di quanto accaduto. Come sottile conoscitore della
psicoanalisi, e esperto di letteratura, cosa pensa di questa prospettiva dal suo vertice
disciplinare?
R.: In realtà io non credo che il narratore Freud, così come si viene configurando con varie
sfumature nei diversi casi clinici sia riconducibile tout court al modello Holmes a cui lui stesso
sembra riferirsi in alcune circostanze e a cui in molte occasioni è stato assimilato. E non credo
neanche che quel modello ci metta davanti un investigatore totalmente estraneo alla vicenda e
che ricostruisce dall’esterno il disegno di un complicatissimo puzzle. È vero, viceversa, ed era
inevitabile, che l’investigatore-analista, così come ci viene incontro nella psicoanalisi
successiva a Freud, si è evoluto e ha mutuato dalla letteratura contemporanea (non solo dalla
letteratura gialla o noire) un insieme di soluzioni, di modalità e di coinvolgimenti nella storia e
nella narrazione che risultano relativamente nuovi. In particolare mi sembra che sia
definitivamente tramontato lo schema aristotelico (un inizio, un mezzo e una fine) a cui Freud
era sì stato costretto a rinunciare, ma che restava pur sempre – nei suoi casi clinici – come una
irraggiungibile stella polare, come l’esempio di cosa avrebbe dovuto e potuto essere una
perfetta messa in intreccio.
3