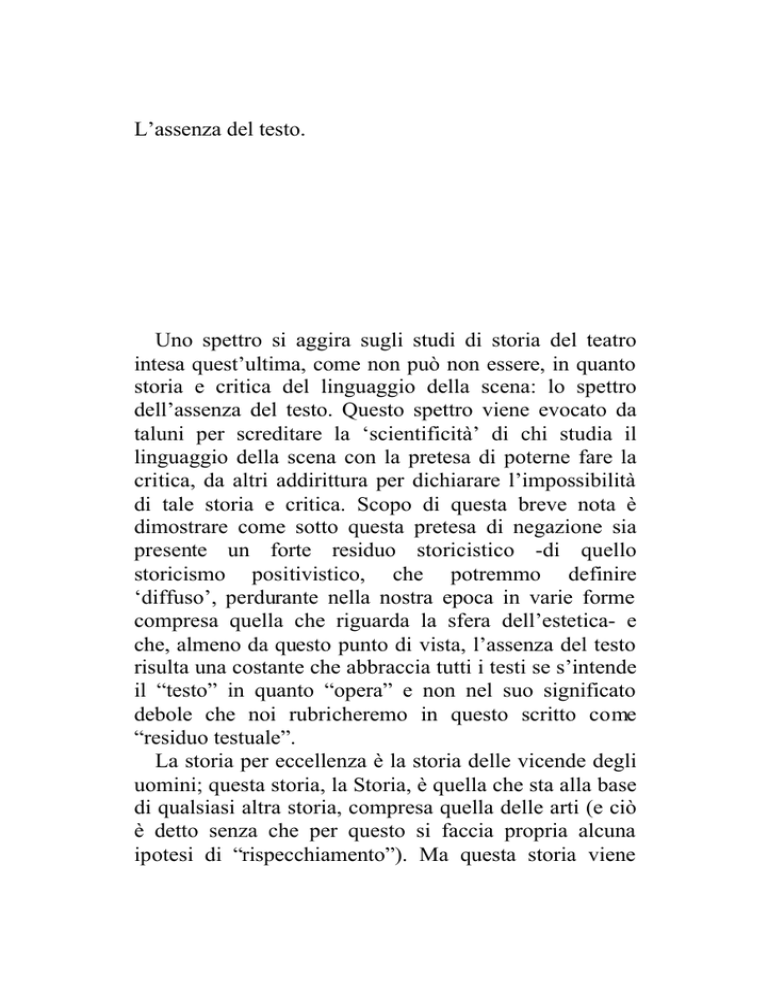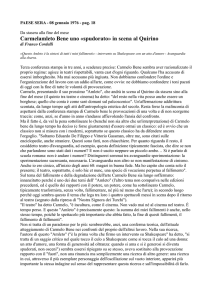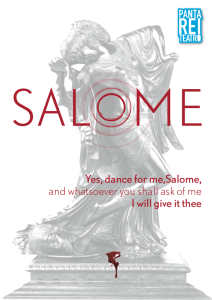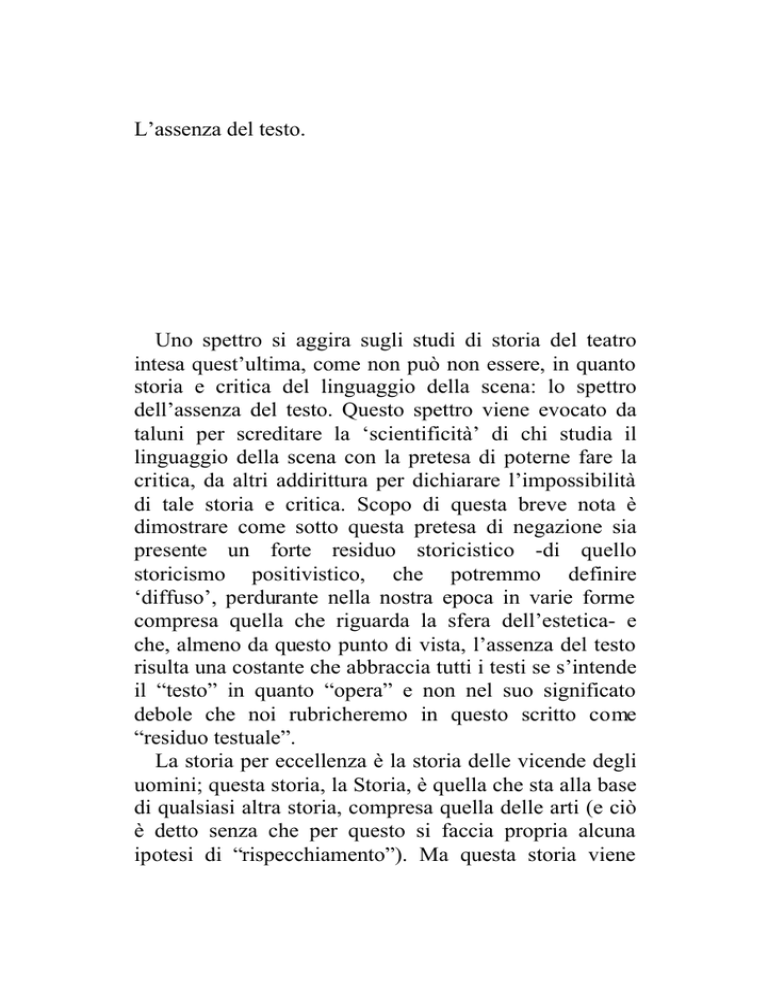
L’assenza del testo.
Uno spettro si aggira sugli studi di storia del teatro
intesa quest’ultima, come non può non essere, in quanto
storia e critica del linguaggio della scena: lo spettro
dell’assenza del testo. Questo spettro viene evocato da
taluni per screditare la ‘scientificità’ di chi studia il
linguaggio della scena con la pretesa di poterne fare la
critica, da altri addirittura per dichiarare l’impossibilità
di tale storia e critica. Scopo di questa breve nota è
dimostrare come sotto questa pretesa di negazione sia
presente un forte residuo storicistico -di quello
storicismo positivistico, che potremmo definire
‘diffuso’, perdurante nella nostra epoca in varie forme
compresa quella che riguarda la sfera dell’estetica- e
che, almeno da questo punto di vista, l’assenza del testo
risulta una costante che abbraccia tutti i testi se s’intende
il “testo” in quanto “opera” e non nel suo significato
debole che noi rubricheremo in questo scritto come
“residuo testuale”.
La storia per eccellenza è la storia delle vicende degli
uomini; questa storia, la Storia, è quella che sta alla base
di qualsiasi altra storia, compresa quella delle arti (e ciò
è detto senza che per questo si faccia propria alcuna
ipotesi di “rispecchiamento”). Ma questa storia viene
ricostruita, e criticata, in assenza del testo: gli uomini di
cui si parla non ci sono più, la falce, che viene definita
“eguagliatrice” e che non eguaglia un bel nulla, ha
compiuto il suo lavoro. Ovviamente ci sono però -in
misura maggiore o minore a seconda delle epoche
dell’uma-nità- i documenti della natura più varia ed è
indagando questi che si ricostruisce la storia;
ricostruitala ne si fa la critica anche se i due momenti
non vanno certo disgiunti poiché‚ già nel modo della
ricostruzione è presente la critica: solo avendo ben
chiara quest’ultima affermazione si può tendere a
fuggire dal “bordello dello storicismo” che
pretenderebbe di conoscere le cose così com’erano
‘veramente’ anziché‚ rendersi conto che “la storia è
oggetto di una costruzione il cui luogo non è il tempo
omogeneo e vuoto, ma quello pieno di ‘tempo-ora’”,
come con estremo nitore scrive Benjamin nelle Tesi di
filosofia della storia. Ricostruzione, quindi, sulla base di
documenti visti però non in modo feticistico ma, al
contrario, altamente problematico: il documento, che
non può essere eluso, deve pertanto essere interpretato
con la precisa coscienza che ogni atto interpretativo è un
atto critico, che nel presente -e cioè nell’unico tempo in
cui ci è dato vivere- si agisce solo per il presente e che
“la più alta come la più meschina forma di critica sono
una sorta di autobiografia”: si tratta di sottolineare, a
proposito di quest’ultima affermazione di Wilde,
quell’“una sorta”: infatti non di autobiografia nel senso
misero e meschino di una forma di rispecchiamento del
piccolo sé‚ nel testo, quale che sia il testo, ma, al
contrario, del grande sé (ci si passi il calco semipirandelliano che è solo linguistico), ineludibilmente
collegato, in una indissolubile catena, a tanti altri sé che
non hanno voce.
Ma per ciò che riguarda l’opera d’arte le cose
sembrerebbero stare in modo diverso: una lirica di
Petrarca o un quadro di Caravaggio sono lì, il testo è
presente. Questo modo di affrontare il problema mostra
subito la sua superficialità non appena si ponga la
questione di dove sia il con-testo e cioè quell’insieme di
relazioni svariate e molteplici grazie alle quali il testo
mostra la sua oggettività e la sua autenticità e si rivela in
quanto “opera”. Ovviamente il contesto, se si vuole
comprendere qualcosa del testo, va ricostruito come
sempre sulla base di documenti che ancora una volta
dovranno essere interpretati con la metodologia di cui si
è appena detto: ma l’oggettività del documento, che
ovviamente esiste, ci sfuggirà, al contrario di quanto
pensano lo storico e il critico storicisti. Heidegger,
nell’Origine dell’opera d’arte è chiaro: “La sottrazione
d’un mondo o la sua scomparsa non sono fenomeni
reversibili. Le opere non sono più ciò che erano. Sono,
sì, esse stesse a venirci incontro, ma come essentistate”; e ancora: “Questo loro star-innanzi è certo ancora
una conseguenza dello stare-in-se-stesse d’un tempo,
ma non è più questo stesso. Lo stare-in-se-stesse è
dileguato”; e altrettanto lo è Gadamer, molti anni dopo,
in Verità e metodo: “Dal punto di vista della storicità del
nostro essere, la ricostruzione delle condizioni
originarie, come ogni altro tipo di restaurazione, si
rivela un’impresa destinata allo scacco. La vita che
viene restaurata, recuperata dal suo stato di estraneità,
non è più la vita originaria”. Ne consegue che ciò che
noi chiamiamo “testo” non esiste più se non nella sua
forma di residuo testuale di un’opera ormai
storicisticamente inconoscibile; il che non vuol dire che
non sia storicamente ri-conoscibile (i termini “storicisticamente” e “storicamente” sono in opposizione come si
oppongono, nel pensiero benjaminiano, “storicismo” e
“filosofia della storia”) ma con la precisa coscienza che
ri-conoscere non è conoscere e che nel ri-conoscere è
implicita l’interpretazione del conoscere là dove
l’attività critica dell’esegeta può essere giudicata
soltanto sulla base della sua attendibilità dal punto di
vista della filosofia della storia unica angolazione che
può evitare le secche del relativismo gadameriano la cui
critica è già stata condotta da Habermas, a suo tempo e
da par suo.
Per ciò che riguarda la storia del teatro (ma, per le
cose dette, meglio sarebbe rubricare questa attività
esegetica come storia e critica del teatro) non c’è
dubbio che ci troviamo di fronte all’assenza di un
residuo testuale proprio come nel caso della storia
dell’umanità: muoiono gli uomini e muoiono anche gli
attori ma restano i documenti che nel caso della storia
del teatro sono più abbondanti che per le altre arti anche se spesso ancor più discutibili, poiché
‘recensioni’, e quindi mediazioni che usano il
metalinguaggio e pertanto necessitanti come sempre, ma
più d’altra sorta di documenti, di una rigorosa e
puntuale analisi- per le stesse qualità intrinseche
dell’oggetto dello studio; e questo permette di
ricostruire, sempre nella visione ‘piena’ del tempo-ora,
l’opera (e il suo residuo testuale) criticamente come solo
è dato fare di qualsiasi altra opera che, come abbiamo
appena visto, in quanto tale è sempre assente privata
della sua “aura” originaria come, ancora una volta, ci
insegna Benjamin. Ma se non potremo raggiungere la
verità dell’autenticità originaria per nessun testo-opera è
fin troppo ovvio che non potremo farlo nemmeno per il
teatro. Solo un irriducibile positivista pretenderebbe di
evocare l’assenza del testo -confondendo questo con
l’opera- come uno svantaggio insuperabile. La verità è
che grazie a quella messe abbondantissima di documenti
-che variano come è ovvio da epoca a epoca e che si
infittiscono, come per tutte le storie, nell’epoca
moderna- l’attività filologico-storica di chi si occupa di
cose teatrali copre uno spazio molto ampio non solo
come mole di lavoro ma anche, e soprattutto, come
spazio intellettuale: è fondamentale il momento della
ricostruzione di ciò che si può ricostruire del residuo
testuale; ma, e questo è quello che più conta, ciò che dà
significato a questa attività
filologico-storica
fondamentale è il modo come viene condotta perché‚ lì,
nel modo, si manifesta il taglio esegetico con cui verrà
poi interpretato l’avvenimento: proprio come succede
allo storico che si occupa delle vicende dell’umanità.
Ma si potrebbe opporre a questo nostro andare
appuntando -e qui l’obiezione parrebbe sensata nel
senso di “dotata di buon senso” che è ciò che nella vita
di tutti i giorni può anche servire ma che nelle cose
dell’arte, e non solo, mostra tutta la sua miseria filisteache la mancanza del residuo testuale esclude la
possibilità di una critica stilistica. La prima risposta
all’obiezione è, a questo punto, abbastanza ovvia: se lo
stile è l’opera e la forma contenuto precipitato, come noi
sulla scorta non solo di Adorno crediamo, allora
qualsiasi tipo di critica stilistica che pretenda di
restituire la verità dell’opera ci sfugge come ci sfugge il
significato storicisticamente inteso dell’opera; là dove
invece una corretta critica stilistica, indispensabile
all’esegesi, si gioca tutta sul presente che si pone in un
corretto rapporto con la storia sempre nella visione
‘piena’ del tempo-ora. Ma c’è ancora da dire, è la
seconda risposta all’obiezione, che un testo residuo è
spesso possibile, nel nostro caso, ricostruire grazie,
come sempre, ai documenti. (E massime a quelli che
denunciano una poetica esplicita del teatrante; anche
questi da sottoporre, ovviamente, a un vaglio critico
rigoroso e attento, come, per altro, è doveroso per
qualsiasi poetica esplicita di qualsivoglia “autore”). Per
non fare che due esempi insieme rapidi e chiari: la Duse
del periodo dannunziano recitava “con voce scomparsa”
(Molinari che cita Kerr) e la Duse giovane “camminava
sui serpenti” (la Schino che cita la Ristori): si tratta di
due notazioni stilistiche che possono essere interpretate
proprio con i criteri della critica stilistica.
A questo punto non resta che abbandonare l’irriducibile positivista ai suoi trastulli nei labirinti inutili e
oziosi di quello che è l’unico campo in cui può illudersi
di potersi esercitare: la sociologia dell’arte.
g.l.
Wilde e Beardsley: “Salomé”
di Mario Domenichelli.
È dai drammi del Maeterlinck (soprattutto La Princesse Maleine, 1889, e Les sept Princesses 1891: il
Maeterlinck divenne famoso dopo un articolo di Mirbeau nel “Figaro” del 24 agosto 1890) che Oscar Wilde
deriverà l’infantile cicalamento col quale i personaggi della sua Salomé (scritta in francese nel 1891,
pubblicata nel 1893) rendono fiabesco l’Oriente lussurioso della Tentation del Flaubert. Fiabesco e anche
umoristico, d’un umorismo che si stenterebbe a credere involontario, tanto il dramma del Wilde arieggia la
parodia di tutta la materia decadentistica e della pretesa tragicità balbettante del Maeterlinck: -e, come parodia,
la Salomé rasenta il capolavoro. Purtroppo pare che il Wilde non mirasse a tanto1.
Ecco, dunque che l’Anglista par excellence, il cui nome fa tremar le vene ai polsi,
definisce in modo sintetico, ma assai preciso, parrebbe, l’intero problema che coinvolge non
solo Wilde, ma, come vedremo, anche la messa in scena della sua tragedia nelle illustrazioni
di Beardsley, che sono delle vere e proprie indicazioni di staging (prossemica, posizioni,
costumi, costumi soprattutto, attualizzazione à la mode del tema, stile visivo, soprattutto
stile), ma che sono in realtà una lettura e un’interpretazione della Salomé. Beardsley aveva
un genio eminentemente caricaturale che si esprimeva al meglio in quelle sue caricature
stilizzate, in quelle elegantissime silhouettes in bianco e nero. Che questo suo tratto
caricaturale andasse d’accordo con il tono di Wilde non si può ovviamente dare per
scontato. Per cominciare a dimostrarlo forse potremmo citare la celeberrima frase dal
Preface a The Picture of Dorian Gray: “L’arte è superficie e simbolo. Chi va oltre la
superficie lo fa a proprio rischio e pericolo”. La silhouette di Beardsley è l’esatta icona di
questa poetica. Noi, comunque, abbiamo l’idea che il grande anglista si sbagliasse, o meglio
avesse ragione nel considerare la Salomé una parodia, e che si sbagliasse invece nel
considerarla una parodia involontaria. In fondo Praz è d’accordo con quello che scrisse il
“Times” il 23 febbraio del 1893 definendo la Salomé come una “bizzarra pubblicazione, una
composizione (arrangement) in sangue e ferocia, morbosità, bizzarria, un prodotto
repellente, e blasfemo che adatta il linguaggio biblico a situazioni che ne rovesciano la
sacralità”2. Anche il recensore del “Times” capisce dunque, senza rendersene conto, che si
tratta di una parodia (quel rovesciamento blasfemo, quel linguaggio biblico rovesciato nella
sua sacralità: gli elenchi tratti, più che da Flaubert, o da Laforgue, dal Cantico dei Cantici;
le profezie common place di Jokanaan). Insomma il giudizio di Praz, che Wilde avesse
composto una parodia involontaria, fa davvero torto all’intelligenza, e all’eleganza raffinata
della scrittura di Wilde, e, oltretutto, non tiene conto del fatto che -come deve avere scritto
lo stesso Wilde da qualche parte- “delle cose importanti ci si deve occupare con la massima
leggerezza, mentre invece le cose leggere si devono trattare con la dovuta gravità”, per
un’ovvia questione di equilibrio estetico. Così dunque a noi pare che la Salomé, proprio nel
suo tratto parodistico, come capita con le grandi opere, faccia i conti con tutta la decadenza
e in realtà la liquidi in una concezione diciamo più avanzata di moderno che evidentemente
Wilde condivideva con Beardsley. Sicché questa è la tesi che tenterò di dimostrare: la
Salomé va considerata come uno dei traits d’union che dalla decadenza tramutano
1
M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930), Firenze, Sansoni, 1966, p. 274.
Cit. da R. Pine, Oscar Wilde, Dublin, Gill and Macmillan, 1983, p. 91. Si veda anche K. Beckson (a cura di),
Oscar Wilde. The Critical Heritage, London, Macmillan, 1970, p. 133.
2
all’avanguardia, ed essa stessa, anzi, come le stilizzazioni di Beardsley, prodotto di una
protoavanguardia che, proprio come Giovanni il Battista, precede gridando e aprendo la
strada nel deserto, per averne di conseguenza il capo mozzato.
L’opera di Wilde fu messa in prova, e provata anche dalla grande Sarah Bernardht per la
quale, a quanto pare, era stata scritta. Le prove tuttavia furono sospese nel 1892 per ordine
della censura e con la motivazione che la pièce era scandalosa e immorale. Wilde annunciò
l’intenzione di diventare cittadino francese (cosa che certo, col senno di poi, gli sarebbe
convenuta). E, insomma, continua ad avere ragione G.B. Shaw che in un pezzo per la
“Saturday Review” scrisse di come il genio di Wilde fosse giocoso e giocasse con tutto, e
che proprio questa sua giocosità era quello che scandalizzava gli inglesi3, e non c’è dubbio
che il riso sia un’arma davvero letale per un establishment, come quello vittoriano, così
ferocemente serioso, e poco, come dire, gay4. Del resto, altra testimonianza, o altra
avvertenza, a proposito del teatro di Wilde è quella secondo la quale Wilde preferiva i
burattini, o le marionette agli attori e diceva che almeno non litigano, le marionette, e non
hanno idee volgari su cosa possa essere l’arte, e nemmeno hanno vita privata, e riconoscono,
le marionette, il superiore intelletto del drammaturgo e, grazie a Dio, non hanno personalità, le
marionette5. Con questo programma cosa ci si può aspettare se non del grottesco?
“Salomé è un mosaico di citazioni. Il signor Wilde ha molti maestri (…) Maeterlinck,
Flaubert (…) E Salomé è figlia di molti padri, e vittima di tare ereditarie”6. E ancora quella
sentenza del recensore del “Times”, “ una composizione (arrangement) in sangue e
ferocia”, nella quale affiora malignamente e molto a proposito il linguaggio di certi titoli dei
quadri di Whistler. Stroncature, che dovettero strappare a Wilde un semicompiaciuto: “Oh
my God!”. A noi invece queste citazioni fanno capire come dopotutto la Salomé non poteva
che essere una parodia generale del decadentismo, con il colpo, divertito e partecipe, vibrato
contro uno dei topoi più frequentati dell’epoca. Se si va a leggere La Princesse Maleine del
resto, con tutte quelle ripetizioni che Maeterlinck probabilmente intendeva come musicali, si
capisce bene il senso e la portata dell’operazione en travesti di Wilde. Nel delirio, morente
(siamo all’epilogo), la Princesse Maleine vaneggia: “Il y a quelqu’un dans ma chambre, il
doit y avoir quelqu’un dans ma chambre, ils m’ont enfermée dans ma chambre”7 e così via.
Wilde se ne sarebbe ben ricordato con quei suoi personaggi che, come vedremo non fanno
che ripetere in variazione la stessa cosa, il che non vuol dire che hanno un rapporto
tragico, o nevrotico con il linguaggio, come si è anche detto8, vuol dire soltanto che fanno
della parodia.
Procediamo dunque su questa strada, ardua quanto basta, prendendo in esame due aspetti.
Il primo riguarda un breve excursus sugli antecedenti, soprattutto su quelli parodisticocaricaturali dell’opera di Wilde, e su quello che definiremo tono generale della decadenza. Si
tratta del tono semiserio, o serio-ironico-patetico, quello, per intendersi del Pauvre Lelian in
cui per pathos e autoironia Verlaine anagramma il proprio nome nell’antologia dei Poètes
maudits (1884, 1888)9. Un tono non di rado apertamente parodistico e autoparodistico a cui
Wilde dunque aderisce forse senza troppa originalità, ma certo con estrema eleganza. Il
secondo riguarda un percorso generale di questa protoavanguardia art nouveau
nell’Inghilterra degli anni ’90, il che implicherà, magari tangenzialmente, una breve storia
3
R. Pine, Oscar Wilde, cit., p. 95.
Si veda al proposito S. Hynes, The Edwardian Turn of Mind, Princeton, Princeton University Press, 1968
(London, Pimlico, 1991), con particolare riferimento ai cap. V, VII, VIII, e X.
5
Letters of Oscar Wilde, a cura di R. Hart-Davis, London, Nonesuch Press, 1962, p. 319. Cit. anche da R. Pine,
Oscar Wilde, cit., p. 93.
6
“Pall Mall Gazette”, 27 febbraio 1893.
7
M. Maeterlinck, La Princesse Maleine, Paris, Labor, 1998, p. 86.
8
G. Silvani, Il cerchio di Narciso, Napoli, Liguori, 1998.
9
P. Verlaine, I poeti maledetti, trad. it. con testo a fronte a cura di C. Rendina, Roma, Newton Compton, 1980.
4
dei rapporti sempre problematici fra Wilde e Beardsley. Il punto focale di tutto questo
discorso è la mise en scène grafica di Beardsley, le sue ‘didascalie’ disegnate, e la forza
innovativa che esse indovinano nello stessa scrittura, ‘fiabesca’, ‘infantile’ e ‘cicalante’ di
Wilde.
Per la breve storia degli antecedenti della Salomé, a dire il vero, non c’è che fare
riferimento a due capitoli nella Carne, la morte e il diavolo (“Belle Dame sans Merci” e
“Bisanzio”). In Praz ci sono tutte le informazioni che ci occorrono. Quello che è davvero
strano è che l’intera dimostrazione del maestro pare mirata a dimostrare che quella di Wilde
è davvero una parodia. Ma questa conclusione, che parrebbe implicita e ovvia, viene negata
a priori, proprio prima che l’intera dimostrazione inizi. Si deve dunque riprendere il discorso
per dargli altra piega. A noi pare che se Maeterlinck è il modello, quella di Wilde non può
che essere una parodia. Ma Salomé è una parodia certo più complessa. L’opera di Wilde non
si accontenta di rifare il verso a Maeterlinck, ma attraverso Maeterlinck, vuole rifare il
verso, il birignao a tutta la gran decadenza. Non c’è solo Maeterlinck, dunque, ma tutta la
storia di un motivo ricorrente fra Otto e Novecento. E non è in primo luogo la Tentation
flaubertiana il punto di riferimento, ma, di Flaubert, l’Hérodias dei Trois Contes. E, a partire
da Flaubert, che è serio, e passando ancor prima attraverso l’Atta Troll di Heine, che era già
una parodia, si giunge direttamente a Laforgue. Laforgue in una delle sue Moralités
légendaires (pubblicata su “La Vogue”, giugno-luglio 1886, e poi su “Revue Indipendente”,
1887) fa della propria Salomé dunque, come dice ancora benissimo Praz: “una Salomé
squisitamente caricaturale, - quasi come nell’operetta di un Offenbach che si compiacesse di
sfumature sinistre, o come nelle belle illustrazioni che il Beardsley doveva poi immaginare
pel dramma di Wilde”10. Si tratta di una definizione, geniale, che secondo noi si attaglia
perfettamente anche alla scrittura di Wilde, ed è una perfetta descrizione della Salomé
wildiana. Intanto, comunque, è evidente che intorno agli anni ‘90 questo tono umoristicopatetico-tragico-parodistico-caricaturale, insomma grot-tesco, di un grottesco quanto mai
raffinato ed elegante, è già affermato. Esso è già, come dire, il ‘bon ton’ del vero
connoisseur, del vero dandy littéraire fin-de-siècle. Questo a noi pare evidente se solo
pensiamo a certi prodotti della decadenza, come negli Amours Jaunes di Corbière “Le poète
contumace”, o, proprio negli anni che ci interessano, a un pezzo di bravura ironica, di
quell’ironia che è tanto sottile che, quando viene vibrato il fendente, la testa, pure tagliata,
rimane al suo posto. Ci riferiamo alla Sixtine di Remy de Gourmont che racconta di un
romanziere simbolista lasciato dalla donna che egli ama (invero assai narcisisticamente) per
un bel romanziere naturalista russo e tolstoiano; il romanzo che Entrague scrive racconta di
un tizio che, prigioniero di una torre, in totale isolamento, si innamora dell’immagine della
madonna che può vedere sul rosone della Chiesa di fronte a lui, e finisce per suicidarsi
gettandosi a capofitto dall’alto della torre verso quel-l’immagine. Una storia di una comicità
e di un’ironia di tale eleganza sottile da tagliare proprio come quella affilata lama di rasoio
che lascia la testa al suo posto, avendola però recisa. Così a noi pare che The Picture of
Dorian Gray dello stesso Wilde sia in questa identica chiave; la stessa
dell’héautontimoruménos baudelairiano, “plaie et couteau, torture et bourreau”. La stessa
segnalata dal nome di un protagonista gozzaniano come Totò Merumeni. Dovrei offrire una
lunga spiegazione, ma mi accontento di dire che se The Picture di Dorian Gray non è un
pessimo romanzo d’appendice, non lo è proprio grazie a quella impercettibile ma
efficacissima ironia, a quel bon ton che lo riscatta e ne fa un grande libro. E il gesto finale di
Dorian che accoltella il proprio marcescente ritratto è una memorabile icona di quel
moderno in cui, e per cui, come dice Adorno in Ästhetische Theorie, il mito dell’arte si
10
M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, cit., p. 278.
volge contro se stesso11. Lo humour è un territorio molto battuto dalla finesse d’esprit,
dall’estrema raffinatezza degli anni della belle époque letteraria, e questo sarebbe bene, io
credo, non dimenticarlo mai, a meno che non si parli di uno come D’Annunzio che certo si
prendeva molto sul serio mentre Wilde, io credo, si prendeva con tutta leggerezza, con la
‘sprezzatura’ che caratterizza il personaggio del dandy da lui incarnato. Eppure, scrive Praz,
“prima che lo stesso Wilde trattasse la storia di Salomé, il Heine e il Laforgue l’avevano
svuotata di contenuto tragico ironizzandola. Ma fu, come suole accadere nelle opere
speciose di seconda mano, proprio la Salomé di Wilde a diventare popolare […] La Salomé
del Flaubert, del Moreau, del Laforgue e del Mallarmé sono note solo ai letterati e agli
squisiti, ma la Salomé del geniale istrione Wilde la conoscono tutti”12. Noi non riusciamo a
capire come Praz potesse pensare che Wilde volesse davvero fare ‘sul serio’; che quel genio
del paradosso che è Wilde potesse mai prendere sul serio quella storia già svuotata di senso
tragico, che egli invece compone chiaramente in chiave di grottesco, di un grottesco analogo
a quello che caratterizza il disegno di Beardsley. E ci domandiamo come seriamente si possa
pensare a un impianto tragico nella Salomé di Wilde con un passo come questo in cui
Salomé chiede la testa di Jokanaan e si sente così rispondere dal Tetrarca:
Voyons, Salomé, il faut être raisonnable, n’est-ce-pas? N’est-ce-pas qu’il faut être raisonnable?…. Au fond,
je ne crois pas que vous soyez sériuse. La tête d’un homme décapité c’est une chose laide, n’est-ce-pas? Ce
n’est pas une chose qu’une vierge doive regarder. Quel plaisir cela pourrait-il vous donner? Aucun. Non, non,
vous ne voulez pas cela…13
Questa formulazione che in francese ha risonanze da commedia borghese, in cui Salomé è
la capricciosa che pretende l’impossibile dal maturo spasimante, e lo spolpa alla maniera di
un qualche angelo azzurro, nell’inglese di Douglas (in realtà di Wilde, il testo fu tradotto nel
1894 e pubblicato nello stesso anno, ma su questo tornerò), pare essere meno marcata, anche
se sempre segnata da un ‘reasonable’: “Come, Salomé, be reasonable”. Però poi quel: “je ne
crois pas que vous soyez serieuse” diventa un seriosissimo: “Surely, I think you are jesting”,
visto che “jesting” è di registro assai più alto che non “joking” … “you must be joking”
(“ma vuoi scherzare!”), certo avrebbe fatto un altro effetto. Ma si pensi anche a quell’altro
passo di uno humour nero e irresistibile in cui, parlando della cisterna in cui sta rinchiuso
Jokanaan, il Cappadocien dice all’altro soldato: “Une ancienne citerne! Cela doit être très
malsaine”. Il secondo soldato risponde: “Mais non. Par exemple, le frère du têtrarque, son
frère aîné, le premier mari de la reine Hérodias, a été enfermé là-dedans pendant douze
années. Il n’est pas mort. A la fin il a fallu l’étrangler”14. Possibile che Wilde, uno con il suo
genio paradossale e ironico, non si rendesse conto di quel che veniva scrivendo? A noi pare
davvero improbabile che Wilde non capisse tutte le potenzialità comiche, grottesche degli
effetti incongrui del dialogo che si svolge fra Salomé e Jokanaan, entrambi maniacalmente
fissati: Salomé sul corpo prima, poi sui capelli, poi sulla bocca di Jokanaan, e giustamente
perché in realtà Jokanaan alla fine non è che voce, voce scorporata; e Jokanaan mentre viene
11
Cfr. T. W. Adorno, Ästhetische Theorie, a cura di G. Adorno e R. Tiedemann, Frankfurt am Main, Suhrkamp
Verlag, 1970; Teoria Estetica, trad. it. di E. De Angelis, Torino, Einaudi, 1975, p. 40.
12
M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, cit., p. 279.
13
Per la versione originale in francese della Salomé, rinvio a O. Wilde, Oeuvres, a cura di J. de Langlade, 2
voll., Paris, Stock, 1977, vol. 2, pp. 498-499. L’edizione inglese, tradotta da A. Douglas (in realtà dallo stesso
Wilde), si trova nei Complete Works of Oscar Wilde, introduzione di V. Holland, London and Glasgow, Collins
(1948), 1984, pp. 552-575. In italiano c’è la versione di Domenico Porzio, con introduzione di Alberto
Arbasino, Milano, Rizzoli, 1974. Questa edizione contiene anche tutte le illustrazioni di Beardsley per la prima
edizione inglese, London, John Lane, 1894, oltre ad altre illustrazioni sullo stesso soggetto non incluse per
ragioni di censura nell’edizione originale, e incluse invece nell’edizione Dover. I numeri romani seguiti
dall’indicazione di pagina con cui indichiamo ogni illustrazione fanno riferimento all’edizione italiana. In nota si
trovano invece i riferimenti a Aubrey Beardsley, Opere scelte, a cura di A. Boetti (Roma, Savelli, 1979) che
contiene tutte le illustrazioni in questione.
14
O. Wilde, Oevres, cit., p. 464.
così ammirato, anzi guatato, anatomizzato, rimane fissato nel suo mondo apocalittico e
palingenetico.
Iokanaan: Où est celui dont la coupe d’abomination est dejà pleine? Où est celui qui en robe d’argent mourra
un jour devant tout le peuple? Dites-lui de venir, afin qu’il puisse entendre la voix de celui qui a crié dans les
déserts et dans les palais des rois.
Salomé: De qui parle-t-il?
Le jeune syrien: On ne sait jamais, princesse.
Jokanaan: Où est celle qui ayant vu des hommes peints sur la muraille, des images de Chaldéens tracées avec
des couleurs, s’est laissée emporter à la cuncupiscence de ses yeux, et a envoyé des ambassadeurs en Chaldée?
Salomé: C’est de ma mère qu’il parle.
Le jeune syrien: Mais, non, princesse.
Salomé: Si, c’est de ma mère15.
Non occorre spiegare il funzionamento umoristico, la comicità implicita di passi come
questo. Né conviene continuare a citare per far rilevare come vi sia comunque uno stacco,
una distanza fra il discorso di Jokanaan e quello di Salomé e come, così, anche, o
soprattutto, nell’echeggiare dei registri alti della Bibbia di Re Giacomo, sia evidente il tasso
di incongruità fra soggetto della conversazione e modi della stessa. Quello stesso tasso di
incongruità che rende la conversazione fra Salomé e il Teatrarca davvero surreale, e
caricaturale, per via dell’effetto di decontestualizzazione di quella conversazione fra un
amante disperato, e anziano, e la sua capricciosa amante. Quel tipo di discorso sarebbe nel
proprio contesto solo in un boudoir parigino, o nella drawing room di un pied-à-terre o di
una garçonniere londinese, ma non nella reggia di Erode Antipate, Tetraca di Giudea.
Certo, l’ironia, la caricatura sono assai più evidenti in Laforgue che rifà apertamente il
verso al Flaubert di Hérodias, e però probabilmente anche meno eleganti, proprio perché
così palesi. L’effetto ‘fiabesco’, per così dire è là subito, con l’attivazione del principio di
indeterminazione e dunque di attualizzazione che del resto caratterizza anche il testo di
Wilde. Vediamo dunque Laforgue nella buona traduzione di Ivos Margoni16:
Quel giorno eran passate duemila canicole da quando una semplice rivoluzione ritmica dei Mandarini del
Palazzo aveva portato il primo Tetrarca, un infimo proconsole romano, sul trono, da allora ereditario per
selezione sorvegliata, delle isole Bianche esoteriche, da allora perdute per la storia… (p.346).
E anche altrove si sente quell’effetto di “Offenbach sinistro” descritto da Praz avendo negli
occhi proprio le illustrazioni di Beardsley, quegli strani figurini di moda messi là a interpretare
una tragedia antica e senza tempo:
La fanciulla serpente, smilza, a squame viscose, turchine, verdi e gialle, con il petto e il ventre color rosa
tenero; scivolava e si contorceva, insaziabile di Contatti personali, mentre con voce blesa diceva l’inno che
inizia così’: “Biblide, Biblide, sorella mia, ti sei mutata in fonte, tu” (p. 359).
E ci sono pagliacci musicanti che accompagnano la danza, e che si ritrovano proprio
come tratto di stile e di poetica anche nelle illustrazioni di Beardsley. Si pensi alla numero
VIII (p. 41)17, Un lamento platonico, con un buffone accoccolato sotto l’invisibile letto che
regge il corpo in levitazione non sai più se di Jokanaan nell’immaginazione di Salomé,
mentre sulla sinistra a tre quarti in alto spunta il faccione di Wilde, ancora come luna. E
ancora pagliacci in chiave di grottesco ad accompagnare l’entrata in scena di Erodiade con il
pagliaccio in basso a destra che è proprio una caricatura di Wilde (IX, p. 45)18. Ed è
evidente l’impostazione ironica alla X illustrazione (p. 49) quando gli occhi di Erode sono
nient’altro che gli occhi socchiusi e un po’ scesi sul faccione dello stesso Wilde in
15
Op. cit., pp. 470-71.
J. Laforgue, Poesie e prose, a cura di I. Margoni, Milano, Mondadori, 1971.
17
Si veda A. Beardsley, Opere scelte, 383 incisioni, cit., p. 226.
18
Op. cit., p. 223.
16
caricatura, mentre dalla cornice bassa della rappresentazione si levano rami e colli di pavone
che più fallici di come sono non potrebbero essere19. E, al momento clou della danza dei
sette veli (XII, p. 71)20, Salomé è accompagnata da un buffone maligno che strimpella un
qualche improbabile liuto anch’esso dalla tastiera assai evidentemente fallica. Mentre lune
si perdono nel corpetto che fascia il torace ma non il seno né il ventre di Salomé; e mezze
lune Salomé lascia come impronte oltre a rose che paiono però crisantemi sul fondo nero della
illustrazione, impronte di un piedino che pare la testa, la seducente testina triangolare e
velenosa di una vipera. Ancora un buffoncello con maschera da Arlecchino si occupa della
toilette di Salomé alla figura XIII (p. 73), e poi alla figura XIV(p. 77)21. Ma leggiamo ancora
Laforgue:
Ermeticamente avvolta nella mussola aracnea color giunchiglia a pallini neri che, agganciandosi qua e là a
varie fibule, lasciava alle braccia la loro angelica nudità, e formava, fra i due accenni dei seni dei capezzoli
appuntati da un garofano, una sciarpa ricamata dai diciott’anni di lei, e attaccandosi un po’ più su dell’adorabile
fossetta umbilicale a una cintura di sboffi d’un giallo intenso e geloso, s’adombrava al bacino d’inviolabilità nella
stretta delle anche magre e andava a fermarsi alle caviglie, per tornar su di dietro in due fluttuanti sciarpe separate
e finalmente riattaccate alle spalline di madreperla della ruota di pavone nano dal fondo cangiante, marezzato
d’azzurro, di smeraldo e d’oro, alone di quel candido volto superiore, ella vacillava sui piedi, sui piedi esangui,
dalle dita scostate, unicamente calzati d’un anello alle caviglie, donde spiovevano abbacinanti certe frange di
moer giallo (…) Chi poteva averle crocifisso il sorriso, a quella piccola Immacolata Concezione? (p. 361).
La quale “piccola Immacolata Concezione” in men che non si dica esige dal Tetrarca il
prezzo della danza che ha appena eseguito, e ordina che le si porti la testa di Jokanaan su di
un bacile qualsiasi. Poi tenta qualche esperimento scientifico elettrico post-decollazione che
però, deludentemente, non produce sul volto di Jokanaan che qualche smorfia. Così Salomé
“baisa cette bouche miséricordieusement et hérmetiquement, et scella cette bouche de son
cachet corrosif” (siamo ovviamente alla chiusa). Poi, gettando in mare la testa di Jokanaan
da un promontorio, Salomé perde l’equilibrio e precipita essa stessa nell’abisso.
È evidente che si tratta, fra Wilde e Laforgue di strategie diverse, ma di una stessa
intenzione ironica, parodistica. È altrettanto evidente che l’ironia del tratto di Beardsley
nasce da un’esigenza, anzi forse da una diretta influenza laforguiana. Chi conosce anche
solo un poco le illustrazioni di Beardsley vi ritrova Laforgue, magari un Laforgue, se
possibile, anche più acido. Tenendo a mente i passi che abbiamo citato da Laforgue, si
pensi, per esempio, alla V illustrazione, Il kimono di pavone (p. 21)22. Vi si rappresenta il
dialogo di una crudelissima Salomé con il giovane siriaco, il quale ha ovviamente tratti
fortemente efebici e che anzi, è di fatto un’immagine speculare della stessa Salomé che
dunque vi si specchia. Salomé è tutta en pavon: piume di pavone in capo come un serto,
piume di pavone che scendono lungo il kimono, e il fondo del kimono è di per sé una sorta
di grande piuma di pavone con motivi ornamentali orientaleggianti, nipponizzanti, secondo
le moda del tempo inaugurata da Whistler (ma Beardsley conosceva direttamente l’arte di
Kitagawa Utamaro, il grande maestro del Settecento giapponese e i cui disegni arrivarono in
Inghilterra alla fine del secolo)23. Ma quello che inizia qui a colpire come tipico, come
caratteristico, come nota in chiave è ancora il segno della mezza luna in questo play così
lunare, così levitante, così lunatico, anzi, e che ha proprio la luna come nota in chiave. Sullo
sfondo un pavone stilizzato come un ideogramma che ci dà l’esatta misura della poetica di
Beardsley, per l’appunto la silhouette decadente. Oppure, più ancora, proprio l’ideogramma,
19
Op. cit., p. 229.
Op. cit., p. 222.
21
Op. cit., pp. 219-220.
22
Op. cit., p. 217.
23
In una lettera del 20 novembre 1893 comunque (siamo nell’anno delle illustrazioni a Salomé) Beardsley fa
riferimento a un Book of Love, un libro di stampe erotiche giapponesi che Beardsley appese alle pareti in
camera sua (The Letters of Aubrey Beardsley, ed. by H. Maas, J.L. Duncan, W.G. Good, London, Cassel, 1970,
p. 56).
20
poiché ogni sua figura ha esattamente questa tendenza ideogrammatica. Così possiamo
affermare con forza che la Salomé di Wilde solo per parodia è tratta dalla descrizione dei
quadri di Moreau che Wilde poté trovare in A rebours. In realtà la sua Salomé è proprio
questa filiforme, lineare, nipponizzante Salomé immaginata da Beardsley, oppure, forse
meglio, a cui Beardsley, sulla scorta del testo di Wilde riesce a dare figura.
Salomé fu scritta direttamente in francese con l’aiuto di Pierre Louÿs e André Gide, e fu
poi tradotta dall’amatissimo Bosie, Lord Alfred Douglas. La traduzione di Bosie non valeva
niente. Si propose dunque a Beardsley, tramite i buoni uffici di Ross, il discepolo fedele e
prediletto di Wilde, di farne un nuova traduzione. A Wilde non piaceva Beardsley, e non gli
piacque nemmeno la sua traduzione. Per la pubblicazione inglese Wilde lavorò dunque sulla
traduzione di Bosie, e la riscrisse integralmente. Oggi la traduzione porta il nome di Lord
Alfred Douglas; in realtà essa è certamente a cura dello stesso autore, e quasi certamente se
ne può parlare come di autotraduzione. Questo aneddoto può servirci per capire come in
realtà ci sia certamente uno iato fra l’intenzione di Wilde e l’attuazione di Beardsley, e
come la messa in scena grafica di Beardsley vada nella direzione in cui indubbiamente
andava anche la sua traduzione, una direzione che abbiamo già definito come
ideogrammatica e con un’intenzione parodica quanto mai esplicita. Si pensi all’illustrazione
VI24, La cappa nera (p. 29), che è non sai più se un pagoda, una silhouette … oppure un
figurino di haute couture -la qual cosa certamente è- oppure un ideogramma. La figura
femminile è ancora disegnata ‘a coda di pavone’ o ‘a piume di pavone’ ed è interamente
nera. La gonna è a strascisco con tre fiori, o tre stelle che spiccano sul fondo nero. La cappa,
molto giapponese, è a pagoda, l’acconciatura riprende il motivo del fondo della gonna. La
figura porta un cappellino presumibilmente di paglia appiccicato, piccolissimo, in cima al
capo. Ci sono rose sulla cappa, che però continuano a sembrare crisantemi. Esce del
merletto, forse, dalla gonna. Una mano esce dalla cappa e regge un ventaglio, l’altra mano
scende lungo il fianco, e quelle due mani sono davvero come le tenere, bianche colombelle
indicate dal testo di Wilde. E insomma non c’è nulla di realistico, è una pura figura di stile,
un ideogramma, se non una esplicita dichiarazione di poetica. Molto alla maniera di
Laforgue è anche la figura che illustra l’incontro fra Salomé e Jokanaan tirato fuori dalla
cisterna (VII, p. 37)25. Ancora la coda del pavone, e ancora le rose che il tratto giapponese
trasforma in crisantemi. I seni di Salomé, dalla testa armata di mezza luna e aculei di varia
natura, escono dall’abito sotto un motivo decorativo in nero che le si chiude sotto la gola.
Anche l’ombelico è scoperto e pare una piccola piuma nera sul ventre. Farfalle e lune a
ripetizione sul fondo a pavone della gonna. Ancora sono simmetrici i profili di Jokanaan e
di Salomé. Paiono la stessa faccia, anzi sono la stessa faccia. Ed è comunque Salomé a
riconoscersi con qualche meraviglia nella faccia imbronciata del profeta. Ma la cosa che
pare più caratteristica è la sospensione indeterminata di queste figure che non si appoggiano
su nulla, escono direttamente dalla cornice in basso, o lievitano a mezz’aria accompagnate
da figure di mera decorazione floreale sempre a crisantemi. Si pensi all’illustrazione VIII (p.
41)26, con una figura distesa quasi in levitazione; si pensi all’ultima figura (XVI, p. 83)27,
con Salomé che svolazza per l’aria sostenendo con entrambe le mani il capo mozzato di
Jokanaan, mentre dal lago di sangue che scende dalla testa di Jokanaan nasce un fiore,
narciso diremmo, più che ninfea. E ancora si veda la figura XV (p. 79)28 in cui un
lunghissimo braccio nero, quello del boia, si alza dal basso come lo stelo di un fiore,
reggendo il bacile d’argento su cui sta la testa mozzata di Jokanaan. E pare che l’insieme sia
24
A. Beardsley, Opere scelte, cit., p. 218.
Op. cit., p. 225.
26
Op. cit., p. 226.
27
Op. cit., p. 224.
28
Op. cit., p. 228.
25
un tavolino certo di gusto un po’ kitsch. Nera è la veste di lei, nero il sangue di lui, nero il
braccio che regge dal basso il bacile. Le figure non hanno base, sono come sospese su non
sai che. I volti, come sempre, sono speculari, il volto di Salomé è esattamente il volto di
Jokanaan e Salomé si specchia in quel bacile, con un effetto assai evidentemente cercato. Si
pensi ancora alla figura VIII, Un lamento platonico, già menzionata, alla simmetria, alla
geometria della composizione, molto stile nuovo, o liberty, una geometria fra verticale e
orizzontale, con quella costruzione a fiori, rosa-crisantemi ascendenti e rampicanti su tre
aste, con un albero altrettanto geometrico che pare una pagoda a tre balze, e ancora il
faccione di Wilde che spunta come luna dalla cornice a tre quarti in alto sotto una nube, con
un sorriso enigmatico ripreso a metà. Che ci sia non solo qui una deriva verso l’informale e
l’avanguardia attraverso le forme di simbolismo già trascolorante al surrealismo, non c’è per
noi alcun dubbio, così come non c’è dubbio che questo capiti con Laforgue. Per Wilde le
cose stanno nello stesso, e in diverso modo. Nello stesso modo perché sicuramente in Wilde
c’è la stessa tensione verso una forma di autotelismo in cui la parola, l’opera fa riferimento a
sé e a null’altro, l’opera vuole farsi oggetto d’arte, segno estetico che non vuole significare
altro da sé. Ma è anche vero che in Wilde l’arte, contrariamente a tutto quello che lo stesso
Wilde a tratti dice e contraddice, mantiene la sua funzione di rappresentazione della realtà, e
con ciò la funzione educativa, profetica persino. Le modalità rappresentative di Wilde non
sono comunque quelle ideogrammatiche di Beardsley, né l’ironia così patente e dichiarata,
ma invece dissimulata, con una diversa, ma certo non inferiore eleganza.
Wilde non amava Beardsley e non ne era riamato. Nell’estate del 1893, Robert Ross, il
discepolo fedele di tanto maestro, che aveva fatto amicizia con Beardsley e ne frequentava
la casa, in vista della pubblicazione in inglese della Salomé, riuscì a convincere Wilde a
farla illustrare proprio da Beardsley. Beardsley, che aveva una sua malignità acidella,
ringraziò inserendo una serie di caricature di Wilde mascherato da Luna (i già citati The
woman in the Moon, I; Un lamento platonico, VIII; Entra Erodiade, IX; Gli occhi di Erode,
X). Wilde non la prese bene, ma non è detto che l’intenzione fosse malvagia, anzi, in fondo
si direbbe più un omaggio divertito, un ammiccamento; l’ideogramma del faccione wildiano
diventa come un sigillo dello stile, opposto e in fondo uguale al filiforme Beardsley. E si
potrebbe anche dire che si tratta anche del riconoscimento di un intento comune. Ma se
Beardsley, via Laforgue, interpreta in modo davvero avanguardistico il testo di Wilde, il
testo di Wilde sopporta quella interpretazione? O non si tratta piuttosto di un’intrusione
indebita, di una interpretazione incongrua e straniante del testo di Wilde? Se così fosse
sarebbe solo Beardsley il genio satirico e Wilde, in fondo, solo la vittima. Il rifiuto di
Wilde della traduzione di Beardsley sembrerebbe condurre su questa pista, che però a noi
pare sbagliata. Wilde non amava Beardsley, è vero, ma gli scrisse che lui era l’unico ad
avere capito il significato vero della danza di Salomé29. Non so se questa frase vada
interpretata come si fa spesso, nel senso della doppiezza sessuale, per cui Salomé in
fondo, sarebbe un maschio travestito, sicché il motivo ascendente del velo che sorge fra le
cosce e si rizza verso l’alto sarebbe un motivo fallico (XII, p. 71). Può benissimo essere
che qui stia tutto il segreto di questa Salomé per Drag Queens. Ma, io credo che più la
comprensione di Beardsley stia tutta in quel clown orrendo che suona quel liuto fallico, e
che è una parodia di Moreau, del Moreau riscritto da Huysmans. Huysmans/DesEs-seintes
scrive dunque sulla Salomé che Danza, il grande acquerello composto intorno al 1890
(Moreau compose ovviamente anche il grande olio su Salomé che danza davanti a Erode e
29
Si tratta della celebre dedica sulla copia di Salomé per Beardsley: “Per Aubrey che è l’unico artista che, oltre
me, conosce ciò che significa la danza dei sette veli, e può vedere quell’invisibile danza”; in una lettera del
febbraio 1894 indirizzata a Mrs Campbell comunque Wilde definisce i disegni di Beardsley “Quite wonderful”
(Letters, cit., p. 353); R. Ellmann, Oscar Wilde, London, Penguin, 1987, trova testimonianze dirette in cui
Wilde pubblicamente si vantava di aver lui creato Beardsley come artista (p.290).
poi, naturalmente, L’apparizione, con Salomé che molto melodrammaticamente indica la
testa del Battista sospesa per aria e aureolata di luce)30: “Tra gli effluvi perversi, nell’aria
surriscaldata del tempio, Salomé, disteso il braccio sinistro in un segno imperioso, regge
nella mano destra un gran fiore di loto, e avanza piano sulle punte, si muove sugli accordi
d’una chitarra pizzicata da una donna accoccolata […] I seni ondeggiano […] i capezzoli
s’ergono […] i diamanti scintillano […] il busto stretto in una maglia gemmata arde e
dardeggia serpi sottili di fuoco […] Non era più solo la danzatrice che, con una torsione
lasciva delle reni, strappa a un vecchio un grido di foia, colei che spezza la volontà del re
facendo roteare i seni, torcendo il ventre, muovendo le cosce […] No, era il simbolo della
lussuria stessa, la dea dell’immortale isteria, la beltà maledetta […] la bestia mostruosa,
indifferente, irresponsabile che, come Elena di Troia avvelena tutto ciò che accosta, tutto ciò
che vede, tutto ciò che tocca” (A Rebours, cfr. cap. V)31. A Wilde tutto questo doveva
apparire eccessivo, e di tutto quest’eccesso decadente che pure doveva mandarlo in visibilio,
Wilde poteva godere soltanto en travesti, e attraverso la parodia. E, insomma, a noi pare che
non siano l’esotismo e l’orientalismo di Moreau, quei suoi aloni di luce confusa, quei suoi
fantasmi di palinsensto sotto o sopra il dipinto, quel che ci vuole per mettere in scena la
Salomé di Wilde, ma proprio il tratto giapponese, preciso, tagliente, affilato di Beardsley. Così
nell’acquerello di Moreau c’è una gentile donzella, aggraziata dolce e gentile a suonare per
Salomé. Nell’illustrazione di Beardsley, invece, tutto il senso dell’opera sta non nella
figura campeggiante di Salomé, fallica o meno, sta in quel ‘fool’, in quel buffone, brutto,
osceno, con quei capelli fiammeggianti e la lingua fuori dal ceffo demoniaco.
FiguraVIII
30
Posso rinviare al catalogo della mostra fiorentina del marzo-giugno del 1989, Gustave Moreau, Firenze,
Artificio, 1989; si vedano i nn. 31 (Salomé che danza, 1890 ca.), 30 (Salomé danzante davanti a Erode, 1875
ca.), 28 (L’apparizione, 1876 ca.).
31
Cit. anche da M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, cit., pp. 267-8. È nostra la
traduzione.
È la rappresentazione del satiro in persona che inverte il segno musicale di Moreau nel
segno evidente della parodia. Certo Beardsley, come Wilde non mancò di riconoscergli,
aveva ben capito. E forse vale la pena di analizzare il testo di Wilde avendo in mente questa
intenzione che abbiamo appena pronunciato, quella secondo cui la Salomé di Wilde è un
testo della protoavanguardia degli anni ’90, quella distrutta dalla stessa sentenza che
distrusse Wilde al processo per ‘gross acts of indecency between males’ nel 1895, con, di
seguito, la chiusura di “The Yellow Book” (e il ‘licenziamento’ di Beardsley responsabile in
primo luogo di quelle scandalose illustrazioni), e poi anche di “Savoy”. Erano queste le due
riviste che più di altre portavano il messaggio del rinnovamento32 così potentemente
esemplificato dalle figure di Beardsley e dalla sua ideogrammatica per silhouettes, di figure
in bianco e nero che facilmente si incontrano con il trionfo di bianco e nero e rosso che
troviamo nel testo di Wilde in cui bianche sono le mani, bianchi i piedi, come colombe,
come fiori d’argento, un fiore d’argento la stessa Salomé, e Jokanaan è una statua d’avorio,
neri i capelli, però, e certo rossa la bocca, rossa del rosso del sangue.
Wilde, dunque, il suo testo, come testo ironico, umoristico, grottesco, autoironico. Non a caso
Beardsley riconosceva il faccione di Wilde nella luna che campeggia in apertura e che è così
importante in questo play che si definisce ‘lunatico’ nel suo stesso incipit (e lunatic in
inglese vuol dire proprio pazzo).
FiguraIX
32
Si veda al proposito I. Fletcher, Decadence and the little magazines in Decadence and the 1890s, a cura dello
stesso autore, London, Arnold, 1979, pp. 173-202.
Prendiamo in esame l’incipit, il dialogo fra le guardie, non senza avere notato, en passant,
che la situazione è analoga a quella che si trova all’inizio dell’Amleto:
Le jeune syrien: Comme la princesse Salomé est belle ce soir!
Le page d’Hérodias: Regardez la lune. La lune a l’air très étrange. On dirait une femme qui sort d’un tombeau.
Elle ressemble à une femme morte. On dirait qu’elle cherche des morts.
Le jeune syrien: Elle a l’air très étrange. Elle ressemble à une petite princesse qui porte une voile jaune, et a
des pieds d’argent. Elle ressemble à une princesse qui a des pieds comme des petites colombes blanches … On
dirait qu’elle danse.
Le Page d’Hérodias: Elle est comme une femme morte. Elle va très lentement. (Bruit dans la salle du festin)
(…)
Le jeune syrien: Comme la princesse Salomé est belle ce soir.
Le page: Vous la regardez toujours. Vous la regardez trop. Il ne faut pas regarder le gens de cette façon … Il peut
arriver un malheur.
Le jeune syrien: Elle est très belle ce soir.
Prémier soldat: Le tétrarque a l’air sombre
Second soldat: Oui, il a l’air sombre.
Prémier soldat: Il regarde quelque chose.
Second soldat: Il regarde quelque’un.
Prémier soldat: Qui regarde-t-il?
Second soldat: Je ne sais pas.
Le jeune syrien: Comme la princesse est pâle! Jamais je ne l’ai vue si pâle. Elle ressemble au reflet d’une rose
blanche dans un miroir d’argent.
Le page: Il ne faut pas la regarder. Vous la regardez trop33.
Figura X
33
O. Wilde, Oevres, cit., pp. 459-60.
Che tipo di scrittura è questa? Sicuramente non è la scrittura che Wilde usa nei suoi Poems
in prose in cui rifà il verso al linguaggio biblico; e nemmeno si tratta del linguaggio delle sue
fiabe così fragili e così atroci, così forti anche in cui sta forse il messaggio più profondo di
Wilde. Qui si tratta davvero d’altro. A tratti viene in mente che si tratti di una sorta di
scrittura cubista come quella di Gertrude Stein, con tutte quelle ripetizioni, con tutte quelle
frasi che girano lentamente di scatto in scatto intorno a un oggetto che spesso così non viene
descritto direttamente, ma attraverso una forma di indirezione del discorso. Viene anche in
mente che Wilde, a voler essere cattivi, e nonostante l’aiuto di Pierre Louÿs, stesse facendo
un esercizio di scrittura in una lingua per lui non del tutto agevole. Sì, degli esercizi di
grammatica e di conversazione. Ma, secondo una testimonianza di Gide, Wilde “savait
admirablement le français (…) il n’avait presque pas d’accent”34 o solo aveva accento
quando voleva far suonare strane, bizzarre certe parole. Così tutto l’accento inglese di questa
sua Salomé è all’interno del gioco, della Salomé en travesti che veniva componendo come
pièce, in fondo, da Drag Queen. Lo stesso Wilde del resto si fece fotografare vestito da
Salomé. L’abbigliamento non gli stava benissimo, si deve dire. E forse, dopo tutto ha ragione
chi, come Lindsay Kemp, ha fatto di Salomé un pezzo forte dello spettacolo camp, gay. È
proprio il grande mimo a fare Salomé nella sua produzione alla Round House di Londra nel
1977 (ma la prima c’era già stata a Sydney nel 1976), ed è lui, Lindsay Kemp, a fare la
danza dei sette veli, e rimanere nudo, esibendo il sesso (fra l’altro nella prima del 1896, con
Wilde in galera, al Théâtre de l’Oeuvre di Parigi, con Lina Munte che faceva Salomé, il
giovane siriano veniva recitato da una ragazza, e Wilde, a quanto pare, anche dal carcere
Reading, non apprezzò affatto. Un’altra versione en travesti, e maudite è quella di Ken
Russell del 1987 (in cui Wilde e Bosie vanno al bordello a vedere una Salomé messa in
scena come farsa)35.
Figura XII
34
A. Gide, In Memoriam, Paris, Gallimard, 1947, p. 15.
Sulle messe in scena di Salomé, compresa anche la transcodificazione di Beardsley e quella musicale di
Strauss, si veda la bella tesi di laurea di F. Sarti, La danza delle passioni: ‘Salomé’ di Oscar Wilde, relatore
Keir Elam, Università di Firenze a.a. 1998-99.
35
Si diceva dell’accento inglese nel francese di Wilde. E allora risentiamo in inglese: “He is
looking at something. He is looking at some one. At whom is he loooking? I cannot tell”; “Il
regarde quelque chose, il regarde quelqu’un, Qui regarde-t-il? Je ne sais pas”. Insomma,
inglese o francese, pare proprio un esercizio di grammatica sul verbo guardare, con tutta la
lentezza ripetitiva e ridondante della scrittura di Maeterlinck a cui viene rifatto
evidentemente il verso (questa pulsione scopica così segnalata è davvero disseminata per
tutto il dramma. Salomé che vuole guardare, vedere Jokanaan, Erode che vuole guardare
Salomé, il giovane siriano che guarda Salomé, e a cui Salomé promette un fiore verde, il
famoso garofano verde degli uraniani -così si diceva- parigini e anche londinesi. Insomma un
incrociarsi di sguardi, ma mai scambiati, mai che si incontrino, per così dire. Si guarda
sempre chi guarda qualcun altro). Ma qui se quella lingua è così, elementare, lineare come
la lingua di un libro di grammatica per stranieri, lo è perché Wilde sta provando lo stesso
tratto lineare, semplice, giapponese, zen che usa Beardsley. Si deve dunque apprezzare, per
apprezzare questo Wilde, un tratto di stile che è assai importante anche nel disegno di
Beardsley, la linearità, la stilizzazione, quella stessa che trasforma nel testo di Wilde i corpi
in tratti grafici, in volumi lineari da statuine d’avorio à la japonaise: “Comme il est maigre
aussi!
Figura XIII
Il ressemble à une mince image d’ivoire, on dirait une image d’argent. Je suis sûre qu’il est
chaste, autant que la lune, il ressemble à un rayon d’argent, sa chair doit être froide, comme
de l’ivoire”36. E insomma quello stesso tratto ideogrammatico della silhouette, perché
questo, nella semplificazione, è quello che fa anche la scrittura di Wilde. Una
semplificazione estrema del dettato, e una proliferazione di elementi uguali in diminuendo o
in crescendo come capita con certi tratti della decorazione in Beardsley (ad esempio la
36
O. Wilde, Oevres, cit., p. 472.
proliferazione simmetrica delle mezze lune in tutte le sue code di pavone). Questa estrema
stilizzazione wildiana che Beardsley così bene pare comprendere, tuttavia non corrisponde
affatto alla parodia laforguiana del proliferare orientaleggiante o fantastico della scrittura di
Flaubert nei Trois Contes (ed Hérodias), e dunque all’impostazione caricaturale di
Beardsley. Ma riascoltiamo quello che dice la voce di Jokanaan dal fondo della cisterna, un
po’, ancora, come la voce del fantasma in Amleto:
Après moi viendra un autre encore plus puissant que moi. Je ne suis pas digne même de délier la courroie des
ses sandales. Quand il viendra, la terre déserte se réjouira. Elle fleurira comme le lys.
Figura XIV
Les yeux des aveugles verront le jour, et les oreilles des sourds seront ouvertes … Le nouveau-né mettra sa
main sur le nid des dragons, et ménera les lions par leurs crinières37.
Non dobbiamo dimenticare che Wilde nel 1891 aveva pubblicato il suo testo utopico
sull’avvenire dell’indivi-dualismo attraverso il socialismo, L’Anima dell’uomo sotto il
socialismo. Così è chiaro che Beardsley doveva in una certa misura sbagliarsi: Wilde non
era la luna, o la donna nella luna, o non solo quella. Wilde era sicuramente anche almeno
Jokanaan il profeta alle prese con una qualche voglia femminile evidentemente a lui non
gradita, il profeta che va pertanto incontro a un crudele destino. Il testo che abbiamo appena
riportato è quello del Vangelo, anche se semplificato e ravvivato da qualche tratto decadente
(il giglio), e rimpannucciato con qualche tratto profetico. Così i ciechi vedranno, i sordi
udranno… Evidentemente vedranno e udranno la verità che il philosophe della leggerezza38
gli sta paradossalmente dicendo, profondo, in superficie, quanto Nietzsche, precipite nei suoi
abissi, o perduto nelle vertiginose altezze. E fa come se nulla fosse, il philosophe, come per
37
Op. cit., p. 462.
Su questo si veda la tesi di dottorato di D. Velluti, Il filosofo delle superfici, relatore Mario Domenichelli,
Università di Firenze, a.a. 1995.
38
scherzo. I ciechi vedranno continuando a non vederci affatto e i sordi udranno rimanendo
peraltro sordi come campane. E così il testo si consuma in autoparodia. Si pensi per esempio
al dialogo quasi in apertura fra il primo e il secondo soldato che parlano di Jokanaan, il profeta
che nessuno capisce, e che dice cose ‘ridicole’, ‘assurde’, e anche ‘spaventose’: “Quelquefois
il dit des choses épouvantables, mais il est impossible de le comprendre”39, e cioè,
traducendo con qualche brutalità: “E chi lo capisce? A volte dice cose tremende, ma non ci
si capisce niente”.
Ma come avrà fatto Praz a pensare a forme di umorismo involontario, laddove è invece
chiaro che tutto qui è estremamente volontario e mirato a ottenere un effetto.
Figura V
A partire da quel profeta rinchiuso nella cisterna e le cui tremende parole nessuno pare
capire. Ripetitività, ridondanza simmetrica con la parola che vuole avvicinarsi alla condizione
della musica. Sì, Salomé è davvero una sorta di Offenbach convertito all’atroce e al sinistro, o
più semplicemente al grottesco. Ed è anche Bibbia, discorso evangelico ma nei modi della
scrittura zen, attraverso una serie di immagini nipponizzanti assai alla Whistler. Oppure,
proviamo un’altra definizione, si tratta di una sorta di Rocky Horror Picture Show della
decadenza.
È evidente nel rapporto fra Salomé e Jokanaan un contrasto fra due altrettanto
narcisistiche contemplazioni di sé. Se Salomé è totalmente presa di sé, mentre contempla la
luna che la rispecchia interamente (ed è evidente questo nel momento in cui il pallore di
Salomé diventa il pallore della luna, e quando dalla luna si passa a parlare di Salomé proprio
nell’incipit), la voce di Jokanaan, dal fondo della cisterna in cui è rinchiuso, invece pare
echeggiare la voce di Nietzsche in persona, e annuncia la fine, l’apocalisse. Ma la sua è
39
O. Wilde, Oevres, cit., p. 462.
parola chiusa in sé, incomprensibile. Si capisce dunque perché Salomé ne voglia la morte:
perché, da un lato, Jokanaan, nella sua totale chiusura, le si nega, e in modo
enigmatico; d’altra parte ella intende bene che ciò che egli annuncia è, con il mutamento del
tempo, anche il di lei desiderio di violazione.
Figura VI
Sicché quella morte deve avvenire, non tanto per decapitazione, ma per la castrazione
simbolica che vi è implicata, a richiesta di una vergine che solamente vuole baciare la bocca
di Jokanaan, e suggellarne dunque il silenzio. Ella deve metterlo a tacere, perché Jokanaan è
venuto ad annunciare la morte del mondo virginale, casto di Salomé. Ed è il tasso di
incongruità a colpire, fra le due voci e le due qualità di discorso, i due toni. Tanto da
provocare il grottesco, per l’appunto, quel registro così ben compreso nella mise en scène di
Beardsley. E si deve pur notare che è proprio su richiesta di Salomé che la cisterna viene
scoperchiata e il profeta incompreso viene fatto uscire. In un certo senso è grazie a Salomé
che la cisterna viene aperta e il profeta fatto parlare. Il fatto è che Giovanni Battista e
Salomé danno corpo e figura di ideogramma a due istanze complementari e contrastanti
dell’arte di Wilde. L’arte di Wilde è la danza di Salomé, ed è anche la profezia di Jokanaan.
Così non è un caso che in Beardsley quelle due facce siano sempre le due facce di una stessa
medaglia. È solo grazie alla danza di Salomé, alla sua seduttività che Jokanaan può parlare,
profetizzare, affascinare anche senza essere compreso, vedersi comunque aperta la porta
della cisterna, e alla fine essere decapitato, come cifra ideogrammatica dello stesso destino
dell’artista.
Dopo averne apprezzato gli occhi che sono “terribili”, “due buchi neri”, “due caverne nere di
dragoni”, “due laghi neri agitati da fantastiche lune” (e si pensi a quale fertile terreno poté
trovare Beardsley in questo fantastico decoro wildiano), Salomé vede Jokanaan magro come
una statua d’avorio orientale, come una statuina d’argento.
Figura VII
Ella è certa che egli sia casto, come la luna, e come la stessa Salomé che dunque riconosce
Jokanaan identico a sé, “gelido”, dice la stessa Salomé, come l’avorio, come l’argento. E
sottolineiamo ancora che Beardsley dà a Jokanaan e a Salomé esattamente lo stesso volto,
fino all’illustrazione finale, che è anche quella d’apertura e che ha come titolo “J’ai baisé ta
bouche, Jokanaan, j’ai baisé ta bouche”. Fu la prima delle illustrazioni pubblicata su The
Studio nell’aprile del 1893 (poi modificata, resa un po’ più forte e meno ornata e chiamata
The Climax). Grazie a questa illustrazione Wilde fu convinto e a Beardsley venne
commissionata l’illustrazione del libro. Salomé levita per l’aria e fissa la testa mozzata di
Jokanaan che tiene fra le mani, mentre dal collo reciso scende del sangue a formare lo
stagno su cui levita la figura, e da cui nascono narcisi e ninfee. Salomé non può non
riconoscersi in quella testa, poiché è il suo stesso volto quello che lei vede in quello del capo
mozzato. E deve essere questo dunque il narcisistico mistero dell’innamoramento di Salomé
per la bocca di Jokanaan : “voglio baciare la tua bocca”. È lo stesso mistero del resto che si
trova anche nell’Orfeo di Moreau40 (presentato al Salon del 1866, ma Beardsley certo
l’aveva in mente così come aveva in mente sempre di Moreau, L’apparizione con Salomé
di fronte alla testa -levitante- del Battista, presentato al Salon del 1876). Nell’Orfeo la
baccante ha raccolto la testa di Orfeo sulla stessa cetra di lui; come la testa di Jokanaan
posata per Salomé sul bacile d’argento. La baccante guarda quel volto e non può che
riconoscervi il suo stesso volto, nel senso che l’effetto è esattamente speculare.
40
Cfr. il già citato catalogo fiorentino, p. 15, fig. 3. Il quadro è riprodotto nel contesto del saggio di R. Monti,
L’assembleur de rêves (pp. 10-17).
Figura XVI
È lo stesso mistero che si legge anche nel Discepolo di Wilde (Poems in Prose), in cui si parla
di Narciso che si innamora dell’immagine nella pozza, ma gli occhi di quell’immagine nella
pozza rimandano a Narciso un’altra simmetrica, modulare, proliferante immagine, sempre la
stessa, ripetuta all’infinito nel riflettersi degli occhi nella sorgente, della sorgente negli occhi.
Ma, nel caso di Wilde, quanta ironia in quel moltiplicarsi e proliferare di immagini tutte una
dentro l’altra, senza mai fine. Ecco la nostra traduzione del passo:
Quando Narciso morì, l’acqua nella fonte del suo piacere si trasformò da dolce in salata, e vennero piangendo
le oreadi dei boschi per cantare canzoni alla fonte e consolarla della sua disperazione. E quando videro che
l’acqua della fonte era divenuta salata per le lacrime versate, le oreadi sciolsero le trecce virenti e piansero
dicendo alla fonte: “Si capisce che così tu pianga Narciso che era così bello!” “Ma era così bello Narciso?”
Rispose la fonte. “E chi meglio di te può saperlo? -risposero le oreadi- noi, ci passava accanto senza nemmeno
vederci, ma te ti cercava e si coricava sulle tue sponde e verso di te abbassava lo sguardo e, nello specchio delle
tue acque, ammirava la sua beltà”. E rispose la fonte. “Ma io amavo Narciso perché quando si coricava sulle mie
sponde e abbassava lo sguardo verso di me, nello specchio dei suoi occhi sempre vedevo il riflesso della mia
bellezza”41.
41
È il terzo passo, la traduzione è nostra. Poems in Prose fu pubblicato su “The Fortnightly Review” nel luglio
del 1894. The Disciple era già stato pubblicato nel giugno del 1893 in “The Spirit Lamp”. L’unica traduzione
italiana che conosciamo è quella curata da D. Velluti, Oscar Wilde, Poesie in prosa, Pisa, ETS, 1994.
Questa prospettiva di Narciso alla fonte ha certamente compreso Beardsley della scrittura
wildiana. Questo è anche il segreto di Narciso in Salomé. Ma questo è anche
Figura XV
tutto lo humour ‘macabre’ che ne scaturisce e che già a partire dagli anni ’90 liquida la
decadenza chiamandola modernità, alla maniera del Burne-Jones che Wilde evoca nel suo
dolente De Profundis dal carcere di Reading42. Il riferimento a Burne-Jones ci richiama alla
mente il suo celebre quadro sul mito di Narciso alla fonte in un’interpretazione
medievaleggiante. Ma perché questa figura che parrebbe così decadente deve essere presa
come cifra della prima modernità? E c’è veramente un’opposizione fra decadenza e
modernità o non costituiscono piuttosto un continuum? Quel che è certo è che questa figura
della specularità, che abbiamo visto così efficacemente all’opera nell’interpretazione che
Beardsley dà di Wilde è una figura importante nella deriva che dalla fine dell’Ottocento
porta al Novecento, e all’Avanguardia. C’è un bel libro che citiamo volentieri venendo a
parlare di queste cose, un libro scritto a otto mani, da Betrand, Biron, Dubois, Janine Paque,
il cui titolo è Le roman célibataire 43. Vi si sostiene con grande fervore, e in modo
convincente che dalla crisi simbolista del naturalismo si sviluppa una scrittura autoscopica,
caratterizzata proprio dall’insularità del soggetto e dalla chiusura. La specularità è una delle
forme della chiusura (si pensi al Ritratto di Dorian Gray, per esempio).
42
Complete Works of Oscar Wilde, con introduzione di V. Holland, cit., cfr. p. 936 (contiene anche la versione
inglese di Salomé).
43
Paris, Corti, 1996. Ma si veda anche M. Perrot, En marge: célibataires et solitaires in P. Ariès e J. Duby,
Histoire de la vie privée IV, Paris, Seuil, 1987.
Protagonisti rinchiusi, una qualche torre, in mezzo a paludi (Paludes di Gide o la già citata
Sixtine di Remy de Gourmont) opere comunque caratterizzate
Figura I
da una fissità autoscopica, da una parola inesorabilmente rinchiusa e prigioniera di una
coscienza patologica (Soi di Paul Adam, 1886; Très Russe di Jean Lorraine, 1886; Eve
Future di Villiers de L’Isle Adam, 1886; Les lauriers sont coupés, 1887, di Du Jardin che è
uno dei modelli di Joyce; Une femme libre di Barrès, 1889; Albert di Wyzewa; La Monelle
di Marcel Schwob, 1895. E poi Proust, naturalmente autoriflessivo, e rinchiuso quanto
nessun altro, anche nella realtà biografica). Insomma romanzi autoscopici spesso
caratterizzati da una forma di humour rivolto contro sé. Questo a noi pare interamente
descrivere non solo The Picture of Dorian Gray, ma anche, ci pare, a modo suo, e
diversamente, Salomé. Sicché il faccione di Wilde, che campeggia in almeno quattro delle
illustrazioni di Beardsley per la Salomé in questa chiave è estremamente significativo. Si
capisce poi bene, sempre in questa chiave, perché le figurine di Beardsley si assomiglino un
po’ tutte, e anche perché Salomé e Jokanaan abbiano la stessa faccia.
Il Modernismo anglo-americano non è sicuramente la prima fase della modernità,
l’Avanguardia futurista certo non è la prima fase della modernità. La prima fase è quella che
chiamiamo decadenza, o decadentismo. E Wilde ne è il protomartire, il vero Jokanaan a cui
fu mozzato il capo. Non è questa la più indifferente delle ironie in gioco a proposito di
Salomé, poiché ciò di cui crediamo d’avere parlato, è il potente movimento introversivo
attraverso cui l’arte affonda verso sé, spesso contro di sé, contro il proprio mito, come
dicevamo, in una deriva che va verso l’informale. È questo movimento che abbiamo
tentato di catturare nella sua origine in una belle époque che veniva tramutando alla
modernità.
Benassi e Amleto.
Lo studioso che nel corso della sua pratica esegetica,
avendo deciso di occuparsi della carriera artistica di
Memo Benassi, si trovi di fronte, all’alba del 1935, al
primo incontro dell’attore col personaggio di Amleto
non può non porsi diverse domande se pure con la
chiara coscienza che alcune potranno rimanere -dato
l’oggetto dello studio che è poi il linguaggio della scena,
testo fortissimo nell’atto del suo esplicarsi ma assai
labile e evanescente nel momento della sua
ricostruzione e indagine nel tempo a venire- senza
risposta o con risposte che mettono in campo ipotesi
difficilmente verificabili se non sul piano della pura
coerenza logica o, magari, con la speranza che nuovi
documenti -e questi sempre possono venire alla luce
quando si tratti di una ricostruzione a struttura e
impianto archeologici e ciò è a dire proprio,
etimologicamente, di discorso sull’antico (e già ‘ieri’
per il tipo di indagine che stiamo conducendo è ‘antico’)
che, tradizionalmente, basa i suoi studi su reperti di
diversa consistenza comunque s’intenda quest’ultimo
termine sia in senso quantitativo che qualitativopermettano una più articolata ricostruzione storico
critica; e, infine, con la coscienza netta che ciò che
conta nella pratica esegetica è porsi le domande giuste
al di là delle possibilità di risposta che pure vanno
esperite fino in fondo. E, dunque: come mai Benassi
affronta per la prima volta l’Amleto a 44 anni? E, poi:
perché lo fa con una compagnia di cui non è
capocomico, quella di Kiki Palmer, pur essendo già
stato capocomico fin dal ‘29? Ancora: come mai si
affida alla regia di Anton Giulio Bragaglia, egli che i
registi non li ama affatto? (Corollario alla domanda che
immediatamente precede: a cosa si deve la scelta
proprio di Bragaglia?) Inoltre: perché questo Amleto
viene subito abbandonato malgrado non sia per nulla un
insuccesso né di pubblico né di critica? Infine: come
mai riprenderà una sola volta nella sua lunga carriera il
testo shakespeariano e il personaggio di Amleto e anche
in questo caso, come vedremo, non senza problemi nelle
repliche?
Intanto, e per tentare di formulare ipotesi a proposito
della prima domanda, bisognerà subito notare che
Benassi matura relativamente tardi e con una certa
lentezza: e qui “relativamente” vuol dire in rapporto ai
grandi attori dell’ottocento che lo precedono ma non nei
confronti dei suoi contemporanei, o quasi: lo stesso
Ruggeri arriva anch’egli non presto al capocomicato. E
questo fa pensare che, dopo e durante il periodo
naturalistico (anche Zacconi diviene solo a trentasette
anni capocomico, dopo una lunga storia in quella che si
chiamava allora “guittalemme”), le cose cambino nei
2
confronti dell’epo-ca precedente: in fondo già Emanuel
e la Pezzana vivono una storia diversa da quella dei loro
predecessori: ambedue si rivelano presto ma poi la loro
carriera artistica diviene difficile, le loro scelte
contrastate o dal pubblico o dalla critica, conoscono alti
e bassi nella popolarità; infine Emanuel muore nella
piena maturità quando però già pubblico e critica lo
stanno abbandonando e la Pezzana chiude la sua vita in
povertà e dimenticata da tutti. Quella che venne
chiamata la “rivoluzione” naturalistica -e che tale, e ciò
è a dire “rivoluzione”, non fu- segnò però certamente un
cambiamento nel modo di intendere il teatro (e non solo,
ovviamente, ma noi di questo qui ci occupiamo) e la
recitazione, l’arte dell’attore. E per cominciare, e tenuto
conto che quello del grande attore fu un teatro basato sul
personaggio, è proprio la concezione di questa entità
stilistica che viene mutando almeno in due direzioni che
sono poi la struttura del personaggio e la
problematizzazione con cui questo personaggio, già
concepito in modo diverso, viene ora affrontato proprio
in quanto entità stilistica. Per ciò che riguarda la
struttura: il personaggio del grande attore è connotato in
senso fortemente mitico (inteso nel senso che qui si
evince dal contesto e non in tutti gli altri in cui questo
termine può essere declinato): la triade grand’attorica
frequenta Amleto, Otello, lady Macbeth e quando si
rivolge alla drammaturgia contemporanea sempre dà
vita a personaggi avvolti nel mistero della loro arcaicità
come Francesca da Rimini e Paolo e Lanciotto e le varie
regali donne ristoriane (Elisabetta, Maria Stuarda,
Medea, Mirra...) o i ‘giganti’ salviniani (Sansone,
Ingomaro del Figlio delle selve, Il gladiatore, oltre a
3
Oreste, Saul...) o i titani romantici di Rossi (Boccaccio,
Shakespeare, Faust, Kean, oltre ai soliti Oreste, Saul,
Filippo...): ora i personaggi sono invece tratti dalla vita
di tutti i giorni; e Emanuel, che aveva già ridotto a cifra
naturalistica per esempio Amleto 1, reciterà L’assomoir
di Zola come la Pezzana, dello stesso autore, farà
un’esemplare Teresa Raquin in cui lascerà la parte della
giovane protagonista alla giovanissima Duse rivelando
un grande fiuto di capocomica oltre che d’artista. La
Duse poi conoscerà una galleria di personaggi (Lionette,
Margherita Gautier, Cesarina, Froufrou, Fedora, Odette,
Denise, Silvia della Gioconda, Anna della Città morta,
Nora Helmer, Hedda Gabler, Elida Wangel) tutti
contemporanei con eccezioni minime quali la Cleopatra
shakespeariana per lei tradotta e ridotta da Boito o la
Francesca da Rimini di D’Annunzio che però, e non
sarà un caso, malgrado la sua dedizione, non avrà
successo. È abbastanza ovvio, ma non del tutto, che il
mutamento della struttura del personaggio abbia dovuto
portare con sé un mutamento nella sua concezione
stilistica: i personaggi, un tempo granitici monumenti a
tutto tondo, ora diventano problematici e ambigui: le
famose eroine della Duse ammalate della nevrosi
contemporanea -che solo lei sa rendere a quel livellostanno proprio lì a dimostrare questo e cioè
un’espressione stilistica tormentata e elusiva; al
troneggiare tonante del grande attore si sostituisce il
tremore da delirio alcolico di Copeau, il protagonista
dell’Assomoir di Zola, recitato da Emanuel e quello
dell’Osvaldo zacconiano, forse ancora reboanti,
1
Si veda: G. Livio, La scena italiana, Milano, Mursia, 1989, pp.62-74.
4
soprattutto quest’ultimo, ma che già trascolorano nel
sussurrato dusiano, nel suo recitare, almeno nel periodo
dannunziano, “con voce scomparsa”2. Nel passaggio dal
romanticismo al naturalismo l’attore, certamente
debitore a quel mitologema roma ntico che si suole
definire come “titanismo”, tende ora a restituire sul
palcoscenico il tormento dell’uomo moderno
combattuto tra progressivo ottimismo positivistico e
malinconico pessimismo idealistico-simbolistico che
risultano poi le due facce della stessa medaglia. Dal
punto di vista tecnico si può dire che a una recitazione
basata sui toni ne segue ora una che si fonda sui timbri;
arido schema questo che abbiamo proposto se la tecnica
non fosse debitrice all’arte non risolvendo questa in
quella ma, al contrario, da questa traendo nutrimento:
solo così, e non altrimenti come tanti vorrebbero, una
notazione tecnica può illuminare un fatto d’arte e,
pertanto, rivelarsi non arida.
E dunque, se ciò che è detto sopra è vero come
sembrerebbe proprio dovesse essere, questa concezione
inedita del personaggio comporta difficoltà di genere
inconsueto all’attore della nuova generazione dal
mome nto che il suo ‘studio’ necessiterà di elementi
diversi confronto a quelli che erano propri delle
generazioni precedenti. Non che questi non avessero
avuto bisogno di studiare -e basterebbe ricordare l’anno
in cui Salvini, già celebre, cessò di recitare per studiare
quello Shakespeare che Gustavo Modena, pur con tutto
il suo prestigio, non era riuscito a fare accettare al
pubblico-, ma, in qualche modo e per così dire, il loro
2
C. Molinari, L’attrice divina, Roma, Bulzoni, 1985, p.179.
5
studio correva su binari già tracciati dalla cultura del
tempo: e, in questo senso, Salvini e Rossi tradirono il
loro grande maestro, appunto Modena, che aveva aperto
una strada diversa, quella della rappresentazione
‘grottesca’3 del personaggio, per imboccare quella assai
più agevole che, come abbiamo appena detto, si
richiamava al titanismo romantico mitologema ormai
ampiamente partecipato dalla cultura, e da alcuni
decenni, quando iniziò la loro attività. Per non fermarsi
che a un aspetto di quella che fu la cultura di questi
attori basterà notare come sia la Ristori che Rossi che
Salvini non ebbero mai dubbi –e anche in questo sta il
loro tradire il proprio maestro- sulla possibilità di
rappresentare il ‘tragico’, almeno nella prima parte della
loro carriera artistica, proprio in quanto tale in un’età in
cui la cultura alta già registrava più di un testimone
dell’impossibilità del tragico nel mondo moderno quali
Hoffmann, Leopardi4, Poe e Gogol’; ma il pubblico non
partecipava, nel suo insieme, della cultura alta bensì di
un altro tipo di cultura, meno nobile e assai più diffusa:
e così la cultura dell’attore, in quel torno di tempo,
coincidette con quella del proprio pubblico. La Ristori,
3
Sul grottesco di Modena si veda G. Livio, La scena italiana, cit., pp.29-50.
Leopardi, con la solita straordinaria lucidità, ha ben presente il
problema; ecco un brano dello Zibaldone alla data 27 luglio 1821:
“A volere che il ridicolo primieramente giovi, secondariamente
piaccia vivamente, e durevolmente, cioè la sua continuazione non
annoi, deve cadere sopra qualcosa di serio, e d’importante. Se il
ridicolo cade sopra bagattelle, e sopra, dirò quasi, lo stesso ridicolo,
oltre che nulla giova, poco diletta, e presto annoia. Quanto più la
materia del ridicolo è seria, quanto più importa, tanto il ridicolo è
più dilettevole, anche per il contrasto ec. Né miei dialoghi io
cercherò di portar la commedia a quello che finora è stato proprio
della tragedia [...]”; G. Leopardi, Zibaldone, a c. di R. Damiani,
Milano, Mondadori, 1999, tomo I, p.1004; nostro il corsivo.
4
6
Rossi e Salvini furono acclamati dalle platee di tutto il
mondo e non conobbero mai flessioni significative nella
loro popolarità: questo fu forse il periodo dell’epoca
moderna in cui più costantemente l’attore ebbe un
rapporto di complicità col proprio pubblico. Ora, invece,
l’attore dell’epoca naturalistica deve affrontare la
decadenza del tragico e, ineluttabilmente connessa,
quella del sublime, deve rivolgersi a un repertorio
‘borghese’ (e lo troverà là dove la borghesia prende il
potere cronologicamente prima e cioè in Francia) alla
ricerca di personaggi altrettanto ‘borghesi’ e dove al
tragico si sostituisce il ‘drammatico’ pur intriso ancora ma questa è l’ambiguità di tutta una cultura- di quel
sublime cui nessuno, scrittori drammatici e attori, vuole
rinunciare nel cercare di nobilitare l’atteggia-mento
gretto e meschino che pure è proprio del sentire
‘borghese’. Campione di questo tentativo di nobilitare
ciò che nobile non è risulta essere D’Annunzio con la
sua opera drammatica e letteraria; un tentativo che
oggi appare -a chi ha mente lucida e sguardo chiaro- 5
5
Nel maggio del 1984 si tenne a Bologna un convegno su Il sublime:
creazione e catastrofe nella poesia i cui atti vennero pubblicati l’anno
seguente in “Studi di estetica”, 1984. Paolo Valesio tenne una relazione
dal titolo Declinazioni: D’Annunzio dopo il sublime che, nella
pubblicazione, è preceduta da una lunga nota che vale la spesa di
riportare quasi per intero: “Nessuno esagererà dicendo che l’opera di
questo scrittore [...] è stata, dopo la sua morte, oggetto di una
cospirazione del silenzio. Un silenzio che sembra talvolta essere
approvato come una sorta di vendetta contro la trionfalistica ricezione
che l’opera di D’Annunzio (e D’Annunzio) hanno avuto, vivente
l’autore [...]. Almeno due fili principali s’intrecciano in questa congiura
silenziaria; e per ben comprendere l’ironia del loro annodarsi occorre
distinguere [...] tra il destino dell’opera poetica di D’Annunzio e quello
della sua opera in prosa (dal punto di vista di questa fortunosa ‘fortuna’,
l’opera drammatica - sia o no in versi - va per la stessa strada della prosa
7
narrativa. L’opera poetica è il bersaglio del timore ansioso dei giovani
leoni [...] della lirica italiana degli anni Trenta; i quali spazzan via dalla
rena a gran colpi di coda le tracce di colui che li aveva preceduti (in tutti i
sensi), con una genialità addirittura oppressiva. Molto più grave è il fatto
dell’opera in prosa: la quale cade vittima dei sinistri ideologismi
dell’establishment di sinistra che attualmente domina la critica italiana.
E, a costo di rispolverare un luogo comune, occorre dire che le eccezioni
[...] confermano la regola. Nel senso che: il conformismo della sinistra
non è disturbato dal riesame dell’opera poetica [...], poiché le
implicazioni della poesia sono per lor natura sottili e indirette; ma
oppone l’’altolà!’ alla rivalutazione di quelle opere che (per
caratteristiche essenziali di ogni discorso in prosa) causano maggiori
ansietà ideologiche [...]. La via da percorrere è lunga, ma da qualche
tempo ha avuto inizio un serio lavoro di revisione [...]. Sarà di lunga lena,
ma fecondo, questo lavoro di rivendicazione che deve por fine a una
vendetta” (pp.167-168). È stata necessaria questa lunga citazione perché
risulta assai utile a fotografare una situazione quale si andrà poi
delineando negli anni che seguono: e infatti oggi siamo in piena
‘rinascita’ dannunziana. E ciò avviene proprio per le ragioni qui delineate
da Valesio che non a caso usa il termine “revisione”: quello che da
qualche tempo si definisce “revisionismo storico” non risparmia certo il
campo letterario: e la rinascenza dannunziana fa parte di questo aspetto
della nostra cultura. Il fatto che si tenda a dimenticare che l’opera di
D’Annunzio (e non solo la sua vita “inimitabile” che pure egli intese
elevare a opera d’arte) è permeata di pulsioni che troveranno conferma e
realizzazione nel fascismo è cosa decisamente significativa nella
direzione appunto revisionistica che non nasce certo alla metà degli anni
ottanta ma che conosce un deciso impulso proprio in quel decennio e in
quello successivo con tutto ciò che è capitato e capita; non ultima cosa la
decadenza del gusto. E, infatti, di questo si tratta dal momento che, al
contrario di quanto scrive Valesio, l’opposizione a D’Annunzio non è
certo dovuta a un supposto establishment di sinistra ma ha, anche questo,
radici assai lontane dal momento che il più efficace critico di
D’Annunzio e del dannunzianesimo risulta ancor oggi essere stato
Petrolini che non sopportava -questioni di gusto- il falso di cui è tutto
intriso lo stile dannunziano (dove lo stile è l’uomo e la forma è contenuto
precipitato, petrolinianamente e adornianamente): il suo grottesco
implacabile e cattivo (la cattiveria è una virtù, se praticata sul
palcoscenico s’intende) colpiva al cuore tutta l’opera dannunziana non
risparmiando certo la poesia e ne svelava il falso concentrato in uno stile
sontuoso e inutilmente (falsamente, appunto) pomposo e,
contemporaneamente, si indirizzava contro i pallidi seguaci del “vate” di
cui creò uno splendido esemplare con Gastone. Ma ancora: Gozzano
8
ridicolo e miserabile insieme (miserabilmente arreso al
mercato) ma che allora piacque talmente al pubblico sia
dei teatri che della letteratura da divenire una moda che
coinvolse diversi aspetti, e forse tutti, di una società
contro cui si scagliò con furore e serenità -la serenità
dello stoico che sa già che non verrà capito- Petrolini
col suo grottesco. E l’operazione dannunziana risultò
anche un’ottima cartina al tornasole per rivelare le
contraddizioni della Duse (della cultura della Duse).
Ma, insomma, un periodo molto indeciso e confuso, per
l’attore, fu questo: un momento storico di scelte difficili
e, a volte, è il caso appunto della Duse, contraddittorie.
Un periodo in cui l’attore non doveva più studiare secondo il significato che una prassi consolidata
attribuisce a questo termine- come rendere al meglio un
determinato personaggio ma in cui a questo problema si
aggiungeva quello di che personaggio recitare, come
recitarlo e ancora quello di cosa volesse dire recitare un
muore nel 1916 e ciò dimostra che ben prima degli anni trenta un poeta
(ma non fu il solo né il primo, anche se certamente il più grande) si
opponeva a D’Annunzio. Oggi si tende a dimenticare tutto e si pretende
di delibare D’Annunzio rimanendo alla sua opera libera e soluta da
qualsiasi implicazione storica, di storia della critica e di storia della
letteratura; ma, ancora una volta si tratterà di una questione di gusto dal
momento che questa operazione è possibile solo a patto di non rendersi
conto del falso intessuto nel ciarpame del suo stile e, qui ha certamente
ragione Valesio, questa risulta un’operazione più agevole nel prendere in
esame l’opera in prosa (e la scrittura drammatica) che quella poetica; ma
di una falsa coscienza si tratta, di quella forma di ideologia che, come si è
detto, oggi prende il nome di revisionismo. E in questo ancora ha
implicitamente ragione Valesio: che se non è vero che fu un’operazione
di sinistra (sempre a non ammettere che solo chi è di sinistra abbia gusto)
il liquidare D’Annunzio è certamente, al contrario, un’operazione di
destra -di questa destra dilagante nell’epoca in cui viviamo “debolistica”
o “revisionistica” che sia-, la rinascenza dannunziana attualmente in
corso.
9
personaggio: lo studio dell’attore diviene assai più
articolato e complesso, difficile e tormentato.
E allora, a questo punto, viene opportuno porre
attenzione a un altro fenomeno che strettamente si lega
a quelli che abbiamo cercato di argomentare fino a qui.
Ed è quello che riguarda il talento, la sua qualità e la sua
quantità, sempre che così si possa dire. E dunque
sembrerebbe proprio che il talento in quanto tale, e
soprattutto se grande, sia alla base di per sé della
struttura che noi storicamente definiamo grand’attorica.
Modena, che dominava altrettanto bene la scrittura
come il linguaggio della scena 6, definisce la giovane
Ristori come “attrice divina d’intuito” 7: Modena con
assoluta precisione usa il termine che rende al meglio la
qualità attorica della Ristori essendo l’intuito un
attributo del talento.
Si tratta quindi di vedere, sulla scorta delle
osservazioni fatte sopra, quanto contasse il talento nel
rivelare come attore grande un attore al tempo del
grande attore: e l’impressione è che, tranne per Modena
il quale ovviamente però non appartiene ancora del tutto
all’epoca grand’attorica, il talento contasse molto al
6
Modena non era un attore “che anche scriveva”: era uno scrittore
a pieno titolo, unico fra i nostri, e non solo, attori dell’ottocento. Se
per un caso che solo la fantasia può prospettare dovesse scomparire
la sua memoria d’attore e rimanessero invece i suoi scritti, egli
verrebbe annoverato tra i nostri più grandi scrittori di quel secolo
come già dovrebbe essere avvenuto se non fosse che il perdurante
pregiudizio contro gli attori che scrivono non ha ancora permesso
agli italianisti di scoprire questo grande scrittore e di sistemarlo
nelle storie letterarie al posto che gli compete.
7
Epistolario di Gustavo Modena, a c. di T. Grandi, Roma,
Vittoriano, 1955, p.69; si tratta di una lettera, indirizzata a Giacinto
Battaglia, del 25 aprile 1845: la Ristori ha 23 anni.
10
punto da costituire la base di quel tipo di recitazione e
da fornire l’unità di misura per considerare la grandezza
di un attore: e poiché il talento si rivela assai presto,
altrettanto presto verrà riconosciuta la grandezza di
quell’attore che lo possiede: “divino d’intuito”,
appunto. Ma ora, e anche in questo, le cose cambiano:
il talento, che comunque non era mai stato sufficiente
da solo, adesso però costituisce solamente un punto di
partenza, qualcosa di indispensabile, come il coraggio
per il torero (l’accostamento non vuole essere né
capzioso né casuale -matador è l’etimologia più
accreditata per “matta-tore”), ma nemmeno così
fondamentale dal momento che, per esempio ma è un
esempio pregnante, Emanuel non sembra poi tanto
dotato in questo senso: ora lo studio fa aggio sul talento
così come quest’ultimo per la generazione precedente
risultava decisamente più importante del primo.
Lo sconcerto dell’attore di fronte a questa scoperta
che gli pone problemi ignoti a quelli della generazione
grand’attorica corrisponde a un altrettale sconcerto del
pubblico che stenta a capire gli sforzi che l’attore nuovo
fa nella direzione di aprire le porte a un teatro diverso
da quello dell’epoca precedente: e spesso rifiuta queste
innovazioni. Di qui i problemi che devono affrontare sia
Emanuel che la Pezzana, di qui il ‘ripiegamento’ su
posizioni grand’attoriche del mattatore (Novelli e
Zacconi, in diverso modo, in testa), di qui le
contraddizioni di chi eredita dalla generazione di mezzo
questo modo difficile di lavorare e tenta di portarlo il
più in alto possibile pur tra le contraddizioni della
cultura propria e di quella del proprio pubblico:
pensiamo ovviamente, ancora una volta, alla Duse. Di
11
qui anche un rivelarsi tardivo dell’attore grande: il
talento si riconosce a prima vista, lo studio no: e poi,
nelle epoche di trapasso quale fu quella tra la fine del
secolo e la prima guerra mondiale, l’effetto di volano
dei gusti del periodo storico precedente è molto forte al
punto tale da poter far rifiutare al pubblico l’attore che
recita in modo diverso; oppure accettarlo, e addirittura
appellarlo “divino”, se sa contemperare, consciamente o
inconsciamente (e magari, ancora una volta, per un
difetto di cultura), le esigenze della nuova epoca
stilistica con quelle della vecchia: il pensiero corre,
come sempre, alla Duse.
Inoltre ma non ancora infine: l’epoca naturalistica è
anche, et pour cause, l’epoca della regia: il fatto che
questa stenti a affermarsi in Italia proprio per la
persistenza del grande attore vuole dire poco dal
momento che il teatro è, per sua intima essenza,
internazionale assai più di quanto lo siano altre forme di
espressione artistica come la letteratura; per fare un solo
esempio che strettamente ci pertiene: il verismo italiano
in letteratura non conosce il problema dell’ereditarietà
della malattia, ma Zacconi, utilizzando in quel suo
modo liberissimo Ibsen, porta sulle scene il dramma di
Osvaldo incentrandolo, almeno fino a un certo punto,
sulla “tabe ereditaria”. D’altro canto l’attore italiano
recita più frequentemente all’estero che in Italia e
recepisce quindi ciò che sta maturando al di fuori del
proprio paese, magari rifiutandolo ma certo non per
ignoranza. E comunque un’esigenza che sarà propria del
teatro di regia è ben presente in Italia ed è quella dello
spettacolo di complesso. La storia è lunga e risale alla
prima metà degli anni quaranta con Modena, al solito,
12
che, ancora una volta al solito, verrà tradito anche in
questo dai suoi allievi-successori. Ma già alla
formazione della Zacconi-Pilotto (1894) il problema
viene riproposto; per non parlare poi della fondazione
della Casa di Goldoni (1900) a opera di quello che
sembrerebbe il più mattatore dei mattatori e cioè Novelli
le cui ragioni artistiche non sono ancora state indagate a
fondo. D’altro canto questo problema è ben presente a
Talli proprio in quegli anni: e la sua messinscena della
Figlia di Iorio è del 1904. Certamente l’attore italiano,
abituato a far troneggiare la propria grandezza su un
esercito di “pertichini”, anche in questo caso deve
affrontare nuovi problemi: quelli che pone, appunto, il
continuare a essere grande in uno spettacolo corale o,
almeno, duale: il sodalizio Emanuel-Pezzana non potrà
realizzarsi per persistenze grand’attoriche ma quello
Duse-Zacconi, vent’anni dopo, invece sì. E ancora la
Duse, quando deciderà di tornare alle scene -ma siamo
già nel 1921-, si appoggerà a Zacconi e scritturerà come
“attor giovane” proprio il trentenne Benassi, il più
promettente degli attori di quella generazione che, dopo
il distacco della Duse da Zacconi, diverrà “primo attore”
e che, pur nella venerazione che lo accompagnerà tutta
la vita per la “divina”, gareggerà con lei in bravura8.
8
Chaplin ci ha lasciato un’interessante testimonianza: “ [...] quando
la Duse venne a Los Angeles nemmeno l’età e la fine incombente
poterono offuscare il fulgore del suo genio. L’accompagnava
un’eccellente compagnia italiana. Prima della sua entrata in scena
un giovane e bell’attore fornì una prestazione superba, tenendo
magnificamente il palcoscenico. Come avrebbe fatto la Duse a
superare la straordinaria prestazione di questo giovanotto? Poi, dal
fondo del palcoscenico, all’estrema sinistra, la Duse entrò in scena
sbucando da un archivolto, piano piano, quasi senza farsi notare. Si
fermò dietro un cestello di crisantemi bianchi che troneggiava su un
13
Ma Benassi, che era nato nel 1891 e che dopo un
esordio non proprio felice come cantante intorno ai suoi
vent’anni aveva iniziato a frequentare il palcoscenico, si
trovò in una temperie culturale e teatrale ancora una
volta, e sempre di più, mutata: sono, quelli del suo
esordio e dei suoi primi passi in palcoscenico, gli anni
in cui il linguaggio della scena inizia a frequentare
quello stile che verrà poi, quando questi stilemi
confluiranno nella scrittura drammatica, definito come
“teatro del grottesco”. Ma i mutamenti del linguaggio
della scena precedono sempre la loro registrazione nella
scrittura drammatica9 e, quindi, Benassi non poté non
avvertire quel clima proprio nel periodo della sua
formazione: come bene dimostrerà poi il suo modo di
recitare della maturità e della vecchiaia quando,
divenuto totalmente padrone dei propri mezzi,
imposterà una recitazione fortemente intrisa di venature
pianoforte a coda e, silenziosamente, cominciò a rimetterli a posto.
Un mormorio percorse la platea, e la mia attenzione lasciò
immediatamente il giovane attore per concentrarsi sulla Duse”; C.
Chaplin, La mia autobiografia, Milano, Mondadori, 1977, p.206.
9
È questa una tesi che si basa sull’osservazione dei fatti e che è ben
lontana dall’essere un’ipotesi teorica: non si tratta di un’opposizione tra “spettacolisti” e “testualisti”, opposizione speciosa,
superficiale e che nasconde una buona dose di pigrizia non solo
intellettuale, ma, al contrario, di una opposizione tra storia e critica
del teatro e storia e critica della letteratura (la specificazione
“drammatica” è persino eccessiva), stante il fatto che la storia (e
critica) del teatro risulta sempre essere storia (e critica) del
linguaggio della scena; o, se no, non è. Ci siamo soffermati più
volte su questo problema dal punto di vista teorico; si veda ora: G.
Livio, Letteratura e teatro in G. Livio-R. Campari-G. Simonelli,
Letteratura e spettacolo, Roma, Marzorati-Editalia, 2000, pp.7-81.
Per ciò riguarda la pratica esegetica, in riferimento in particolare
agli anni di cui stiamo parlando, il nostro La scena italiana, cit.,
alle pp.148-232; in particolare, l’esemplificazione su Giovannini e
Talli è alle pp.164-170.
14
grottesche. Inoltre, sempre nel periodo della sua
formazione d’attore, si troverà a recitare -dopo essere
già stato elevato da Praga al ruolo di protagonista della
Candida di Shaw alla Stabile di Milano- nella
compagnia di Ermete Novelli, della triade mattatorica
l’unico promiscuo, e cioè l’unico che eccelleva sia nel
comico che, più tardi, nel tragico: ulteriore declinazione,
se pure di tipo particolare, della prefigurazione del
grottesco, se pure non certo coscientemente praticato,
nel linguaggio della scena: lo stato attuale degli studi su
Novelli non permette di aggiungere molto di più a
quanto sopra detto; ma un’ipotesi è pur possibile
prospettarla; e questa è che Novelli, la cui ascesa inizia
negli anni ottanta dell’ottocento, tenesse in qualche
modo discosto il comico dal tragico, almeno idealmente;
ma poi, dal momento che era lui a recitare queste parti
tragiche è logico pensare che qualcosa del comico
passasse comunque nel tragico: un grottesco, appunto
come abbiamo scritto, inconscio. D’altro canto non
eccelleva proprio, per ciò che riguarda il tragico, nel
personaggio di Shylock? E Shylock, almeno nella
particolare angolazione che gli è stata attribuita nel
teatro italiano dell’otto e novecento, non è già di per sé
un personaggio grottesco? E Benassi non risulterà
particolarmente efficace, pur nella galleria di personaggi
che lo resero famoso, proprio in questo? (A quest’ultima
domanda, che ricollega Benassi a Novelli, come scolaro a
maestro, bisognerà pure che prima o poi qualcuno azzardi
una risposta).
Il periodo in cui Benassi sta in compagnia Novelli è
breve: tre mesi; poi viene chiamato alle armi. Tornerà e
verrà scritturato da Lyda Borelli, Emma Gramatica,
15
Luigi Carini e Irma Gramatica; infine sarà la volta di
Eleonora Duse. Ma, Duse a parte -che col grottesco non
aveva proprio nulla a che fare-, Benassi dovette, in
questa sua stagione che va dai venti ai trent’anni, pur
costretto a recitare “commedie di un livello molto e poi
molto commerciale”10, vivere comunque quel momento
di ‘rivolta’ teatrale11 che era nell’aria: e il suo
temperamento d’attore ne fu segnato ma, probabilmente,
tutto ciò -e si aggiunga pure l’esperienza con la Duseportò anche a una sua oggettiva difficoltà di messa a
punto della propria poetica attorica e, infine, a un suo
ritardo a rivelarsi come attore grande e grande attore
insieme, ormai, in quanto “grande attore”, fuori di
chiave col suo tempo.
Per ciò che riguarda Amleto, infine -e sempre in
relazione a Benassi- sarà necessario un’ulteriore
approfondimento. L’impressione, per dirla con parole
semplici, è che il personaggio di Amleto a quel punto
della sua carriera fosse un personaggio che Benassi
doveva affrontare come banco di prova della sua
raggiunta maturità di grande attore, ma che non fosse
poi del tutto nelle sue corde essendo egli ormai giunto a
quello stile attorale che gli permette di esprimere -unico
della sua generazione- lo sconcerto di chi ha piena
coscienza di essere e mostrare un io frantumato e
alienato nella società dei rapporti amministrati e
reificati: Amleto si presta certamente anche a una lettura
10
Questa citazione come le notizie che precedono sono tratte da M.
Benassi, Anticipo alle mie memorie. IV. Tempo di guerra, in “film”,
16 settembre 1944, p.6.
11
Per l’aspetto letterario di questa ‘rivolta’ si veda il nostro libro
giovanile Il teatro in rivolta. Futurismo, grottesco, Pirandello e
pirandellismo, Milano, Mursia, 1976.
16
di questo genere, ma senza permettere quei toni cupi,
straziati e contemporaneamente parodici che invece
consente un personaggio come quello di Shylock, per
non fare che un esempio ancora una volta legato al
nome di Shakespeare, che l’attore aveva recitato l’anno
precedente e che resterà saldamente nel suo repertorio.
Più tardi, e lo vedremo, Benassi troverà un’altra chiave
di lettura per affrontare il personaggio; ma intanto ora si
affida a Anton Giulio Bragaglia.
E qui sarà il caso di porsi anche il quesito se la scelta
di Bragaglia sia stata di Benassi o della Palmer che
aveva su di sé, in quanto capocomica, la responsabilità
della compagnia. E sembra di poter dire che, in fondo,
un teatrante come Bragaglia giovasse all’uno e all’altra
anche se Benassi, in quanto protagonista assoluto
dell’operazione spettacolare, dovette avere un peso
determinante nella scelta del regista. Ma, in effetti, un
giovamento non poté non averlo anche la Palmer. Infatti
Bragaglia, come si sa, propugnava, tra le altre cose, uno
spettacolo che risultasse attento a tutte le componenti
del linguaggio della scena e quindi, ma è una costante
della regia, ai personaggi per così dire secondari anche
se tali non sono come è il caso di Ofelia nel testo
shakespeariano. E, infatti, alla vigilia della prima di
Amleto che si tenne a Torino, al teatro Alfieri, il 2
gennaio del 1935, Bragaglia rilascia un’intervista alla
“Stampa” in cui parla della sua impostazione dell’opera.
La sua polemica è, come sempre, puntata contro la
visione che egli definisce “romantica” a favore di
un’impostazione invece “epica”. Aveva scritto pochi
giorni prima, e quindi durante le prove dell’Amleto
benassiano:
17
Oggi siamo contro il sentimentalismo, contro l’enfasi e la
declamazione. La tendenza moderna mira all’epico e non al
romantico. Noi preferiamo ‘Coriolano’ e ‘Machbeth’ [sic], storie
obbiettive, a ‘Romeo e Giulietta’ e all’‘Otello’, nei quali il
sentimento sopraffà la favola12.
Dove, come si vede, la polemica di Bragaglia si
appunta contemporaneamente contro il sentimentalismo
e contro lo psicologismo del dramma borghese
(Coriolano e Macbeth sono per lui “storie obbiettive” e,
dunque, né sentimentalistiche né psicologistiche
essendo le due cose strettamente congiunte) e
ovviamente contro la riduzione di Shakespeare a
qualcosa che assomigli appunto a un dramma borghese
(e qui c’è certamente una polemica con l’Amleto di
Ruggeri non esplicitata; ma su questo argomento sarà
doveroso tornare). Ecco, pertanto, Ofelia:
I capocomici, per convenzionalismo male acconcio, nelle
edizioni romantiche, mutilavano completamente dall’edizione
originale le due prime scene di Ofelia e presentavano una creatura
triste, dolorante, che non contribuiva, a mio avviso, al successo e
che non perveniva ad altro scopo che a falsare il personaggio e a
scocciare enormemente13.
Ora invece
La mia Ofelia, che è quella vera, di Shakespeare, è, nelle prime
scene, allegra, spensierata, vivace come si conviene ad una creatura
di 18 anni. È una creatura umana un tantino bizzarra e ambiziosa a
cui Amleto rimprovera di truccarsi troppo, di troppo ballare, di
essere troppo scanzonata14.
E lasciamo stare l’affermazione che l’Ofelia di
Bragaglia sarebbe “quella vera di Shakespeare”
12
A.G. Bragaglia, I Classici del Teatro ringiovaniti dalla
messinscena,
in “Il giornale d’Italia”, 8 dicembre 1934.
13
Gim, Bragaglia la radio e Amleto, in “La stampa”, 29 dicembre 1934.
14
Ibidem.
18
limitandoci a notare come il “corago”, così amava
definirsi, non sfugga alla pretesa di tutti i registi di
essere l’interprete fedele delle intenzioni dell’autore del
testo letterario; quello che qui interessa è vedere come
Bragaglia tenda a una messa in scena del personaggio,
appunto, “epica” e “antiromantica” e, fatto non
secondario, a promuovere uno spettacolo d’insieme in
cui Ofelia abbia la sua parte. Altrettanto vale per le
figure del re e di Polonio, resa epica la prima e comica
la seconda (“un buffone [assai simile a Pantalone]”15)
con un omaggio alla da lui molto amata Commedia
dell’arte che gli vale il plauso beffardamente complice
di Petrolini, in quei giorni presente anch’egli nei teatri
torinesi quando il regista, il 31 dicembre, illustra questa
sua impostazione del personaggio nel Salone della
“Stampa” 16. Un’impostazione, quindi, che non poteva
non essere gradita alla capocomica che già aveva
mostrato, nelle sue precedenti prove, di apprezzare la
collaborazione di quella che allora era la novità registica
e che vedeva così valorizzati, oltre al suo, anche gli altri
personaggi dello spettacolo.
Ma anche Benassi, per il suo verso, dovette avere
buoni motivi per cercare (o accettare) la collaborazione
di Bragaglia. Intanto non poteva certo dispiacergli la
disposizione del corago per l’epico a scapito del
sentime ntalismo non senza una tendenza, più forte da
parte dell’attore ma comunque comune a ambedue,
verso il grottesco. Si trattava poi di avere a propria
disposizione un testo tradotto in modo confacente: e
15
16
Ibidem.
s.i.a., Bragaglia e Petrolini parlano dell’“Amleto”, in “La
stampa”, 1 gennaio 1935.
19
Bragaglia proprio a questo si era dedicato certamente
anche sulla base della sua teoria per cui la scrittura
drammatica dovrebbe nascere direttamente sulle e dalle
assi del palcoscenico. Parole come quelle che stiamo per
trascrivere dovevano suonare come musica agli orecchi
di Benassi ben conscio, come già abbiamo visto 17, del
primato del linguaggio della scena sulla scrittura
drammatica: “Vediamo infatti oggi il decadimento della
scena di prosa, causato dalla superbia dei letterati, i
quali han preteso che a teatro la loro ‘parola è tutto’” 18.
E la traduzione di Bragaglia dovette seguire proprio i
criteri di cui si diceva prima, criteri di adattabilità al
linguaggio della scena:
Sto dunque rifacendo il testo senza in nulla alterarlo, ma
portandolo soltanto in espressioni viventi e in forme “da dire”, che
non ricordino mai il libresco e lo scritto19.
Ma non solo dal momento che Bragaglia pretese
certamente di fare qualcosa di più, come risulta da
alcune cose che disse il 31 dicembre nella conferenza
che già abbiamo ricordata:
Bragaglia ha parlato del suo lavoro, delle sue intenzioni, della
sua maniera di vedere l’“Amleto”. La sua preoccupazione grande,
nell’allestimento del lavoro shakespeariano, è stata quella di
17
Poiché questo su Benassi è un lavoro in progress è necessario il
rimando agli altri articoli che precedono questo: G. Livio, L’attore
moderno: frantumazione e alienazione del soggetto. Benassi e
Pirandello, in La passione teatrale. Studi per Alessandro d’Amico, a c. di
A. Tinterri, Roma, Bulzoni, 1997, pp.183-196 e Schegge benassiane.
Esperimenti cinematografici: Il caso Haller (1933), in “L’asino di B.”,
settembre 1998, pp.25-50.
18
A.G. Bragaglia, Del Teatro Teatrale ossia del Teatro, Roma,
Tiber,
1929, p.144.
19
A.G. Bragaglia, I classici del Teatro ringiovaniti dalla
messinscena, cit.
20
riportare [sic] il testo originale che (ha detto) “non risponde più alle
esigenze dei nostri tempi in cui la vita e la poesia sono espresse in
forme sintetiche”20.
E intanto bisognerà subito notare un particolare
curioso: a quella conferenza ci sono Petrolini, Giachetti
(che farà Polonio), Tamberlani (che farà Claudio),
persino il regista Carlo Piccinato che in quel torno di
tempo collabora con la compagnia Palmer; ma Benassi
non c’è (e, da quanto si può capire dalla cronaca,
nemmeno la Palmer). E questo fa immediatamente
pensare -dal mome nto che siamo alla vigilia della
“prima” e già sappiamo che quell’Amleto durerà due
giorni per essere poi abbandonato- che gli screzi che
porteranno a quell’ab-bandono fossero già iniziati (la
presenza di Giachetti e Tamberlani esclude un’eventuale
prova generale). Un abbandono, come abbiamo ormai
detto, non spiegabile nei soliti termini quando sia
dovuto a un insuccesso, ma per cui devono essere
ricercati altri motivi che non sono, appunto, quelli per
così dire ‘normali’.
E, infatti, quell’Amleto fu, soprattutto per Benassi, un
successo sia di pubblico che di critica. Quest’ultima è
però rappresentata da tre recensioni in tutto dal
mome nto che lo spettacolo si svolse solamente a Torino.
Ma è gran fortuna che una di queste critiche, quella
della “Gazzetta del popolo”, sia di Eugenio Bertuetti
autore di commedie (una verrà recitata quattro anni
dopo proprio da Benassi ai tempi della Benassi-Carli),
critico di vaglia che in un periodo storico in cui tutta
l’importanza di chi si occupa di cronaca teatrale -nella
20
s.i.a., Bragaglia e Petrolini parlano dell’“Amleto”, cit.
21
linea d’Amico-Simoni- è attribuita al testo accentra
invece la sua attenzione sull’evento scenico e quindi,
soprattutto, quando fosse il caso come qui era il caso,
sugli attori. Ed ecco che già in apertura di cronaca
Bertuetti pone la questione nei suoi retti termini:
Uscendo ieri sera dall’“Alfieri” con l’anima in tumulto [...] ,
dopo questa edizione d’Amleto, la domanda che rivolgevo a me
stesso era: “Abbiamo sì o no un grande attore?” (E quel grande
aveva dentro di me un valore assoluto). “Lasciando da parte gli
esempi insigni che la nostra generazione non conobbe,
infischiandoci di tutto quanto può essere tradizione regola sistema,
chiudendo gli occhi della mente sul nostro [?] ultimo e per noi
quasi unico bell’ [?] Amleto ruggeriano, questo di Memo Benassi è
un Amleto ‘vivo e vitale’? Ci ha dato egli il nostro Amleto?”. La
domanda era imbarazzante perché oltre ogni dire impegnativa.
Eppure lui, Benassi, con la sua recitazione elettrizzante, tesa,
sempre sempre innalzata a potenza, con quel suo “buttarsi” in
blocco, che pareva essere uscito di sé -che era uscito di sé- per
annullarsi e insieme moltiplicarsi nei mille e uno enigmi in cui
s’incarna via via il principe sciagurato, ci ha imposto la domanda ed ecco la sua prima vi ttoria21.
Bertuetti dunque imposta la sua cronaca, ponendo la
questione nei suoi retti termini, proprio su quello che
può essere definito il pernio su cui gira questo Amleto
particolare: la consacrazione, cercata da Benassi
attraverso il testo canonico a questa consacrazione, a
grande attore: il fatto che Benassi abbia costretto critica
e pubblico a porsi quella domanda, in anni di assoluto
dominio ruggeriano, è “la sua prima vittoria”. In anni di
assoluto dominio di Ruggeri s’è appena scritto: e,
infatti, il grande attore degli anni tra le due guerre sarà
21
e. bert., “Amleto” all’Alfieri nell’interpretazione di Benassi, in
“Gazzetta del popolo”, 3 gennaio 1935; i corsivi sono dell’autore,
mentre i due punti interrogativi segnalano una falla del giornale che
determina la lettura delle due parole cui si riferiscono dubbia.
22
proprio lui, di vent’anni più vecchio di Benassi e nel
pieno fulgore della sua gloria: e quindi, come lascia
intendere Bertuetti, il paragone dovette imporsi proprio
con lui e con la particolare angolatura che volle dare al
personaggio di Amleto cui non poteva non opporsi quella
di Benassi data la diversa e divergente sensibilità dei due
attori.
Si sa che l’Amleto di Ruggeri, recitato a partire dal
1915 e rimasto nel suo repertorio fino al 1933, risultava
una commistione, tipica di Ruggeri e non solo di lui, tra
estetizzazione liberty e riduzione al quotidiano (dove,
sia detto tra parentesi in attesa di più approfondite
riflessioni, l’estetizzazione liberty-simbolistica rinvia
alla sua matrice naturalistica), al punto che Gobetti
arrivò, nel ‘24, a parlare di “dramma borghese”:
L’Amleto di Ruggeri è più riflessivo che lirico, più interrotto che
canoro, più ragionatore che melanconico, più analitico e
intimamente contrastato che giocoliere e finto pazzo come succede
al suo fratello shakespeariano. È un latino, non un anglosassone. La
tragedia inglese è regale, c’è di mezzo tutto un popolo che si fa; per
il latino prendono il sopravvento i fatti familiari e personali.
L’episodio d’amore sembra addirittura la chiave per intendere: c’è
modo di cantare un inno a Ofelia, di commuoversi e seguirne il
destino. Perciò l’Amleto di Ruggeri deve essere qua e là morbido e
decadente; la tragedia si fa più interessante quando è più indecisa e
tutto lo scenariofantastico e regale serve soltanto a dare rilievo al
dramma borghese22.
Due anni dopo è ancora più radicale un critico francese:
Le Hamlet que nous montre M. Ruggero Ruggeri est un Hamlet
aussi clair, aussi solide, aussi classique qu’il se peut, un Hamlet
latin. L’acteur le joue très simplement; il le dépouille du mieux
22
P. Gobetti, Ruggero Ruggeri, in “Il lavoro”, 3 gennaio 1924; ora
in P. Gobetti, Scritti di critica teatrale, Torino, Einaudi, 1974,
p.619.
23
possible de ce mystère romantique, de cette brume lyrique qui
l’enveloppe et le voile. Il ne nous montre pas un jeune homme en
proie à l’on ne sait quel “mal du siècle”, à une doleur obscure et
métaphysique, mais un brave jeune homme triste pour des causes
bien précises et humaines23.
È chiaro che qualcosa sfugge al critico francese dal
momento che risulta evidente una sua mancanza di
articolazione del discorso confronto a quello ben più
ricco di Gobetti (e pur tenendo conto di un contesto
culturale e teatrale diverso da nazione a nazione); resta
comunque il fatto della sottolineatura presente in
ambedue gli scritti del temperamento latino che Ruggeri
attribuisce a Amleto e, quindi, della conseguente
riduzione al quotidiano -che sta poi a indicare una tipica
operazione di matrice naturalistica- della vicenda
shakespeariana. Ma, appunto, Ruggeri non è solo questo
è anche “morbido e decadente” come ci dice Gobetti,
possiede una sensibilità liberty come dimostra il
“soggetto” che inserisce dopo il funerale di Ofelia
quando, solo, torna sulla sua tomba e la cosparge di fiori
certamente memore dell’episodio dusiano tramandatoci
da D’Annunzio nel Fuoco24. Il suo modo di recitare
23
J. Boulenger, Ruggero Ruggeri dans Hamlet, in “Le Nouveau
Siècle”, 9 aprile 1926.
24
G. D’Annunzio, Il fuoco, Milano, Mondadori, 1967 [1900], p.243.
Inutile dire che la testimonianza dannunziana –anticipata, per altro, da
Joseph Primoli tre anni prima sulla “Revue de Paris”- se pure si possa
immaginare dovuta alla Duse, risulta certamente poco storica dal
momento che mancano altri documenti a confermarla e che, in ogni caso,
si tratta di una trasfigurazione letteraria che non può essere ritenuta in
alcun caso una testimonianza; ma la cosa, per ciò che riguarda il nostro
discorso risulta irrilevante dal momento che Ruggeri attinge certamente
alla fonte dannunziana, indipendentemente dalla sua attendibilità storica
e critica, per ovvie ragioni di affinità culturale e di poetica essendo egli in
quel momento -il suo primo Amleto è del 1915- l’attore dannunziano per
eccellenza.
24
estetizzante ma non estetistico, manieristico ma non
manierato costituisce per Benassi una pietra di paragone
non scontata visto che lui, che manieristico non fu mai,
doveva opporre il suo dandysmo estetico, ma non
estetizzante, all’estetiz-zazione manieristica di Ruggeri,
un dandysmo estetico che era però stranamente e
contemporaneamente intriso di quel grottesco che già si
era affacciato prepotente in certi personaggi creati
precedentemente a quell’Amleto e che poi risulterà
tematico e centrale nella creazione di quello di Shylock
e di tanti altri che verranno poi. Perché Benassi fu un
attore straordinario e assolutamente unico nel panorama
del nostro teatro nel periodo tra le due guerre e nel
decennio immediatamente successivo al secondo
dopoguerra dal momento che rappresentò un perfetto
equilibrio -perfetto dal punto di vista della poetica ma
assolutamente instabile nella prassi del palcoscenico al
punto da poter risultare il motore vero di tante bizzarie
che le cronache del tempo ci hanno tramandato- tra
estetismo e grottesco là dove il primo termine rimanda a
una tendenza viva nel nostro teatro di prosa della prima
metà del novecento e il secondo a una poetica assai
meno presente e decisamente poco frequentata.
L’eccezione è costituita ovviamente da Petrolini; ma
egli agiva nel teatro di varietà e quando si mise a
recitare anche cose di altri mai si dimenticò di dove
veniva: e la sua violenza parodica che si scatena in
Gastone e in tante altre sue splendide invenzioni
riguarda non solo ciò che denuncia a chiare lettere (il
bel divo del varietà...) ma anche Ruggeri con i suoi
pallidi seguaci e in genere tutta l’estetizzazione del
mondo di matrice dannunziana che veniva da lui
25
vivisezionata con quella spietatezza e crudeltà che sono
proprie di chi possiede un gusto implacabile e che
pertanto non può tollerare ciò che è falso. Ma Petrolini
rappresenta un unicum del tutto irripetibile. La
crudeltà di Benassi risulta, invece, ammorbidita proprio
da quell’estetismo simbolistico di cui non è del tutto
libero anche se costantemente, come s’è detto, il suo
grottesco nega il primo termine o, meglio, vi si
contrappone dall’interno: e la sua recitazione risulta
pertanto una recitazione straziata in cui assistiamo alla
creazione del personaggio e contemporaneamente al suo
smontaggio, sempre dall’interno: in lui la finzione, che
non diventa mai falsità, è esibita al massimo grado per
ciò che riguarda il teatro cosiddetto di prosa (ma
Benassi era un poeta) nel periodo storico in cui operò; il
teatro di varietà fu un’altra cosa, come si è detto.
Ma un altro elemento della recitazione poneva
Benassi in posizione diversa confronto a Ruggeri. E qui
sarà utile ricorrere al Gramsci cronista teatrale: come si
sa, egli frequenta una metodologia tendente a vedere
nella scrittura drammatica il fulcro dell’avvenimento
teatrale; e questo non è proprio ciò che oggi la critica più
avvertita sarebbe disposta a tollerare non fosse poi che,
come sempre e come tutti ben sanno, solo i leoni sanno
ruggire:
Ruggeri non sa abbandonarsi all’autore, all’espressione verbale;
egli vi si sovrappone. E lo fa sempre allo stesso modo. La duttilità
dell’ingegno gli serve magnificamente. È adusato a tutti i lenocini
dell’arte: possiede la tecnica a perfezione. Ma la pura tecnica è
esteriorità: se non si fonde con gli altri elementi che contribuiscono
alla creazione, se non diventa spontaneità, essa è un impaccio, è
una deficienza più che una qualità buona. Crea, come appunto in
26
Ruggeri, il conguagliamento, l’indistinto, mentre l’arte è sempre
diversità, distinzione, individuazione 25.
E, infatti: enucleiamo da questa citazione quello che
qui ci interessa e cioè la meditazione sulla tecnica e
sull’uso che ne fa Ruggeri. L’affermazione “la pura
tecnica è esteriorità” potrebbe ancora ricordare Croce
che distingue tra “espressione e comunicazione”
affidando la tecnica a quest’ultimo campo che riguarda
“la pratica” e non l’intuizione che è là dove avrebbe
concepimento l’arte: la tecnica “non è già cosa
intrinseca all’arte ma si lega appunto al concetto della
comunicazione” 26: ma Gramsci, senza rovesciarlo,
inclina però il concetto crociano verso altre dimensioni
quali quelle che saranno proprie delle estetiche non
idealistiche (o antiidealistiche come quella di Adorno,
per fare l’esempio più illustre) dove la tecnica è letta
invece come intrinseca -per usare un termine crocianoall’arte proprio in opposizione alla concezione dell’arte
come intuizione ‘pura’. (Inutile sottolineare, e questa
notazione è limitata dalla forma parentetica, che ciò non
vuol dire giungere al feticismo della tecnica e risolvere
quindi l’arte tutta in questa, come recentemente è stato
fatto e si continua a fare: significa soltanto riconoscere
alla tecnica ciò che più propriamente le pertiene e cioè
lo svelare come l’opera d’arte risulti un’operazione
perfettamente cosciente e riccamente composita in cui il
‘lavoro’ e lo ‘studio’ svolgono una parte fondamentale).
E infatti Gramsci, dopo l’affermazione iniziale del suo
discorso, articola ulteriormente il suo pensiero: “se non
25
A. Gramsci, Ruggero Ruggeri, in “Avanti!”, 25 novembre 1917
ora in Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1952, p.304.
26
B. Croce, Aestetica in nuce, II ed., Bari, Laterza, 1952, pp.23-24.
27
diventa spontaneità”, e quindi proprio qui si tratta di un
critico (il quale, è il caso di ricordarlo?, non faceva
proprio questo per mestiere ma che nel fare questo
vedeva una delle possibilità del suo lavoro politico cui il
suo coraggio riservava mete ben più tragicamente alte)
che sa leggere in modo acutissimo la cifra profonda
della recitazione di Ruggeri: quella superficialità
manieristico-estetizzante, di cui s’è detto, che piaceva
tanto ai contemporanei critici e spettatori, tutti, con rare
eccezioni, come lui, ‘leggeri’ e pronti a farsi incantare
dall’esi-bizione della tecnica. Perché di questo qui si
tratta e di questo ci parla Gramsci: dell’esibizione della
tecnica che è poi un modo, forse più frequente nella
recitazione che nelle altre forme di espressione
artistiche, per farsi riconoscere come bravi nel mostrare
quel lavoro -ineludibile all’arte- che dovrebbe invece
diventare
“spontaneità”,
essere
totalmente
metabolizzato dall’arti-sta (dall’attore per ciò che qui ci
interessa) per potergli permettere di esprimere altro, il
cuore vero e profondo dell’arte, e ciascuno secondo la
propria poetica. Il mostrare e esibire la tecnica vuol dire
quindi anche e soprattutto non ‘prendere posizione’,
limitarsi proprio alla superficie di quel problema che
costituisce il nucleo fondante dell’arte, eludere ciò che
di più sostanziale l’arte realizza che è insieme coscienza
e, nell’epoca di cui ci occupiamo, strazio per mancanza
di autenticità; in una parola, che già più volte abbiamo
usato, proporsi in modo ‘estetizzante’ e cioè con una
tendenza al bello che è un bello formale, senza il
problematico contenuto etico proprio dell’estetismo
autentico, in una previsione dell’orrida società cosiddeta
estetica -dove l’estetismo sconta le sue ambiguità fino
28
all’ultima goccia delle lacrime di Oscar Wilde nel
carcere di Reading- in un mondo in cui non per nostra
scelta stiamo vivendo.
Benassi, al contrario, estetistico non era e tanto meno
estetizzante, termine quest’ultimo che designa un’ulteriore degenerazione dell’estetico indirizzato verso la
società estetica, e, quindi, di conseguenza, nemmeno
dannunziano anche se recitò testi di D’Annunzio. E il
suo modo di recitare non prevedeva il mostrare la
tecnica poiché, al contrario, nel caso suo questa era
divenuta appunto “spontaneità”: se mai egli riservava a
alcuni momenti, momenti di autocompiacimento in cui
si scatenava la sua gioia di recitare e il suo piacere di
stabilire con il suo pubblico un rapporto di complicità, il
far sfoggio della propria tecnica; ma erano solo
momenti di altissimo gigionismo, veri e propri
“slittamenti” come li aveva definiti Petrolini, che non
intaccano certo il cuore della sua arte profondamente
intrisa al suo essere e che altrettanto profondamente
toccava l’essere degli spettatori in grado di capirlo.
Quanto all’Amleto, riprendendo il discorso accennato
precedentemente sulla scorta di Gobetti, la riduzione a
“dramma borghese” -dove “prendono il sopravvento i
fatti familiari e personali”, tutte cose che rientravano,
almeno fino a un certo punto, nella poetica di Ruggerinon poteva risultare invece costitutiva di quella di
Benassi. La recitazione di quest’ultimo, infatti e invece,
affondava le sue radici in una cultura diversa, più ariosa
e tendente al grande, al sublime e al mitico: se mai è
proprio dalla coscienza di non poter raggiungere queste
dimensioni che scaturisce la sua rabbia grottesca, la sua
cosciente autodegradazione -così evidente in tanti
29
personaggi della maturità e dell’inizio della sua
vecchiaia (vecchio veramente non divenne mai né per
questioni
anagrafiche
né
per
atteggiamento
psicologico)- che però non nega la dimensione cui tende
ma la manifesta e manifestandola la riconosce come
impossibile: per questo alcuni critici, sbagliando ma con
errore comprensibile, per lui parlarono di recitazione
barocca. Il taedium vitae morbido e languido, in una
parola ancora una volta estetizzante, di Ruggeri in
Benassi diventa rabbia, una rabbia che si contorce su se
stessa perché non trova alcun punto di sfogo dato il
pessimismo che le è intrinseco. Infatti Benassi non
smise mai “di camminare sui serpenti” come con grande
penetrazione, che è propria di un attore che parli di un
altro attore, disse la Ristori della giovane Duse.
Bisognerà subito chiarire però che non di una notazione
squisitamente tecnica si tratta come vorrebbe la studiosa
che ha il merito di averla trovata e citata 27 ma di
qualcosa che comprende sia la tecnica sia il sentire
artistico dell’attrice in quel momento della sua carriera.
E ciò vuol dire che quel “camminare sui serpenti” oltre
a “accenna[re] al rapporto crudo tra piede e
palcoscenico”, come appunto sottolinea la Schino,
rimanda anche a qualcosa di ben più rilevante per la
storia di attrice della Duse e per il nostro (e non solo
nostro) teatro tutto: a quell’energia nervosa che in
questo torno di tempo tende a mutare il modo di recitare
del grande attore basato sulla monumentalità e sulla
possanza statuaria di cui furono maestri proprio la
27
M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, Bologna, Il mulino, 1992,
p.231 e anche alle pp.57-58; si tratta di un colloquio a firma
“Iugali”, pubblicato sull’“Arte drammatica” del 26 luglio 1884, p.1.
30
Ristori e Salvini sostituendo queste qualità con un altro
tipo di qualità che è quello del sentire nervoso e
nervosamente esprimere -e la cosa si realizza al
massimo grado, negli anni ottanta dell’ottocento,
proprio nella Duse ma certo un’anticipazione autorevole
l’abbiamo già in Emanuel almeno- portando la
recitazione a una tensione straordinaria, a un’energia
indirizzata verso una mobilità tesa e instabile che serve
a esprimere, come si disse della Duse, la nevrosi
dell’uomo moderno e cioè la sua coscienza della
frantumazione del proprio io e della sofferta
impossibilità di consistere. Come poi si modificò nella
maturità e nella vecchiaia la recitazione della Duse,
sotto il nocivo influsso dannunziano che non venne
meno neanche nell’ultima stagione della sua vita, è cosa
che non riguarda queste note e che rimandiamo a un più
riposato momento di meditazione sulla Duse, se più
riposato momento avrà da esserci. Ora, e qui, si tratta di
Benassi: per lui “camminare sui serpenti”, nel senso in
cui abbiamo appena interpretato questo dire della
Ristori, fu una costante di tutta la sua carriera artistica e
mai venne meno: chi vede una continuità tra la Duse e
Ruggeri, non fossero gli studi teatrali tuttora ancorati a
pregiudizi e superstizioni che tengono conto solamente
di luoghi comuni, dovrebbe chiarire come questa
continuità si stabilisce, ammesso che debba stabilirsi, tra
la Duse del periodo dannunziano e del ‘21-’24 e non
certo con la Duse del primo periodo cui invece, anche se
non la conobbe per evidenti ragioni anagrafiche,
accadde a Benassi che, come sappiamo, fu in compagnia
con lei nell’ultimo periodo della sua arte e della sua
vita. E, certo, questo vuole anche dire che determinate
31
qualità non si perdono mai e che pure nel mutare di
poetica la Duse dovette mantenere anche più tardi
qualcosa di quell’energia nervosa che la caratterizzò da
giovane e forse lì Benassi attinse: ma sia ben chiaro che
questo non vuol dire -come vorrebbe una vulgata tanto
fastidiosa quanto persistente nella sua superficialità- che
Benassi sia stato “allievo” della Duse visto che quando la
incontrò aveva già trent’anni e era ormai un attore con
una sua poetica ampiamente impostata: semmai sta a
significare che anch’egli, come tutti i grandi, seppe
guardare ai propri predecessori e da loro imparare per
potersi costruire una strada solamente sua pur nella
coscienza che solo chi sa riconoscere i propri debiti col
passato può innovare, rilanciare il gioco, e non come
vorrebbe chi intende partire dalla tabula rasa, tutto teso
alla ‘novità’ e a negare la tradizione; al contrario
quest’ultima, quando riconosciuta e valorizzata proprio in
quanto trasmissione di saperi e di abilità, può divenire
fermento di nuova linfa: negli altri casi, quelli della
tabula rasa che è propria di tutte le avanguardie, la
tradizione continua a agire ma senza che coloro che
pretendono innovare totalmente lo sappiano o fingano,
cinicamente, di non saperlo.
L’accostamento a Ruggeri non sembri specioso: è
testimoniato in vario modo e da diverse fonti anche se
qualcuno intese invece apparentare l’Amleto di Benassi
a quello di Moissi. Wanda Capodaglio, che era stata
Ofelia con Ruggeri e Gertrude con Moissi, dice
Leonardo Bragaglia “nega assolutamente ogni possibile
accostamento fra i due artisti: fra l’estroverso e
genialissimo Benassi ed il mistico ed introverso
32
Moissi”28; mentre un’altra testimonianza di prima mano
-oltre ovviamente all’oggettività delle cose della storia
del nostro teatro del novecento- ci riporta a Ruggeri.
Carlo Tamberlani, che fu Claudio in quell’Amleto del
1935, rilascia un’interessante “intervista personale” a
Gianfranco Bartalotta riportata in un libro vivace anche
se discontinuo sulla fortuna scenica di Amleto nelle
rappresentazioni italiane del novecento; e dice: “Benassi
è più sonoro di Ruggeri, c’è nella sua interpretazione
più dolore, più disperazione, e non s’avverte quel senso
di annullamento, tipico della rappresentazione
ruggeriana”; e ancora, questa volta a proposito di
Claudio ma sempre insistendo sul raffronto tra Ruggeri
e Benassi: “Mentre nell’esecuzione di Ruggeri è molto
interiore [la confessione di Claudio di fronte al
crocifisso], in quella di Benassi, proprio perché Amleto
è esagitato, per unità di stile anche essa è disperata”29.
Anche questo, e cioè l’intenzione palese di contrapporsi
a Ruggeri, dovette portare Benassi a Anton Giulio
Bragaglia che Ruggeri non amava per nulla al punto da
definirlo, come ci testimonia ancora Leonardo
Bragaglia, “il sacro fioco”30; ma, si sa, non tutte le cose,
se pure ben programmate e nate sotto i migliori auspici,
vanno per il verso giusto.
Un altro elemento poi dovette entrare in gioco in
questo Amleto; ed è il rapporto del protagonista con
Ofelia e lo spazio che deve avere quest’ultimo
personaggio nella rappresentazione. Abbiamo già scritto
28
L. Bragaglia, Shakespeare in Italia, Roma, Trevi, 1973, p.80.
G. Bartalotta, Amleto in Italia nel novecento, Bari, Adriatica,
1986, p.58.
30
L. Bragaglia, Shakespeare in Italia, cit., p.80.
29
33
altra volta che Benassi è attore “solo”: e lì lo si diceva
dal punto di vista della sua poetica, solo in quanto fu
l’unico a interpretare, a quel livello artistico, il
determinato tipo di poetica attorica che qui stiamo
cercando di delineare; ma egli fu anche attore solo in
quanto portato a recitare personaggi che campeggiassero
da soli sul palcoscenico (e la sua propensione per i
monologhi nell’ultima parte della vita testimoniano
questo) com’era di Shylock o di Tartufo o ancora di
Saul e via di questo passo. Ma in Amleto c’è Ofelia che
risulta tutt’altro che un personaggio secondario (e che,
ancora una volta, Ruggeri aveva elevato a personaggio
tematico). E qui interviene uno di quei fatti ‘pratici’ -e
ne abbiamo già accennato- di cui è tutta intessuta la vita
del teatro: Ofelia sarà Kiki Palmer che è anche la
capocomica di questa compagnia dove Benassi è
‘soltanto’ primo attore. Il fatto però è che il rapporto
con Ofelia, se non si vuole o non si sa o non si può
piegare il testo letterario alle proprie esigenze, spinge
Amleto, almeno per come viene interpretato in quel
tempo (Laforgue, Lucini...), verso il simbolismo 31: e
Benassi certamente vuole, sempre in contrapposizione a
Ruggeri ma certamente, per questo aspetto, anche a
Moissi, prendere le distanze dal simbolismo attraverso
l’allegoria (in questo caso non necessariamente
grottesca): il suo Amleto non sarà il solito “pallido
prence” estenuato o mistico che sia ma un personaggio,
appunto come ci dice Tamberlani, disperato e tesissimo,
ricco di quell’energia nervosa che fu la sua peculiarità
31
Per questo discorso si veda: R. Tessari, All’estuario del Simbolismo: il
corpo di Ofelia, in AA.VV., Cantami o Diva, a c. di S. Sinisi, Cava de’
Tirreni, Avagliano, 1999, pp.27-42.
34
testimoniata, e non sarà un caso, da Bragaglia che il
primo febbraio di quell’anno, a proposito della prevista
messa in scena del Savonarola di Alessi con la regia di
Copeau, dice essere inutile pensare a Moissi visto che
“in Italia c’è Memo Benassi, con una figura atletica e
mezzi nervosi formidabili”32: appunto “mezzi nervosi
formidabili”, capacità di “camminare sui serpenti”,
tensione verso l’allegoria per esprimere fino in fondo
l’angoscia dell’uomo moderno dilaniato dalla
reificazione: il “pallido prence” ruggeriano non è
angosciato, è triste, di quella tristezza tipicamente
intimistica contro cui scagliava i suoi strali come
sempre Petrolini: non cammina sui serpenti ma si
trascina, cauto e appunto “fioco”, su una nuvola.
Ed ecco quindi Bragaglia che presenta la propria regia
sulla “Gazzetta del popolo”:
I nuovi caratteri del personaggio shakespeariano, affidati alla
potente sensibilità di Memo Benassi, secondo la mia regia
presentano un Amleto leggero e profondo, ironico e amaro,
tagliente e pur tenero, scettico e pure appassionato, antiromantico e
pure umano33.
Sembra un ritratto della poetica recitativa di Benassi
(con l’eccezione di quel “leggero” ma che qui, legato e
opposto a “profondo” potrebbe ancora funzionare) al
punto che sarebbe giusto, ed è giusto, pensare che il
regista si fosse messo al servizio dell’attore. E, infatti,
l’articolista anonimo (ma potrebbe essere Bertuetti) che
32
s.i.a., Se non lo sapete, in “Il dramma”, 1 febbraio 1935, p.47.
s.i.a., Un “Amleto” nella regia di A.G. Bragaglia. Interpretato da
Benassi e Kiki Palmer, in “La gazzatta del popolo”, 28 dicembre
1934.
33
35
presenta le riflessioni del corago commenta a sua volta
in modo assai pertinente:
La sua regia ci darà così un nuovo Amleto che soltanto Benassi,
fra i moderni attori italiani, poteva essere in grado di portare alla
ribalta34.
Eppure proprio nelle note di regia di Bragaglia, rese
pubbliche dai giornali torinesi di quei giorni, si annida
probabilmente il pomo della discordia -se discordia ci
fu, ovviamente- tra il regista e l’attore. Ecco ciò che
dice il giorno seguente:
Amleto non è un debole [...]. Il suo dubbio non è scarsa
convinzione e mal ferma credenza, ma nasce dal non voler prendere
sul grave le cose. Egli ha il buon gusto dell’umana ironia, ha la
mano leggera fin nelle sue vicende più crudeli e tragiche. [...]
Malinconico e ironico, aggressivo e ironico, egli investe sua
madre più con lo scherno che con la violenza. [...]
La ragione per cui il nostro eroe si lascia andare, e non compie la
propria vendetta, è tutta nella sua filosofia di scettico raffinato [...].
Tutta la sua tragedia si agita in questo contrasto e nel dubbio che
ha di prendere le cose per il verso feroce, oppure di condurle nel
senso moderno 35.
E qui Bragaglia insiste sulla “leggerezza”;
evidentemente preoccupato di opporsi al reboante
romanticismo ottocentesco del grande attore-mattatore,
cui evidentemente lui guarda come elemento oppositivo
al contrario di Benassi che ha in mente invece come
abbiamo visto l’eleganza soffice di Ruggeri, definisce
Amleto uno “scettico raffinato” mostrandosi così non
poi tanto lontano da quel Ruggeri che pure non amava;
34
35
Ibidem.
Gim, Bragaglia la radio e Amleto, cit.
36
la sua interpretazione del “senso moderno” va tutta in
direzione dell’ironia: ma Benassi non era né ironico né
scettico: era violentemente e spavaldamente sprezzatore
stoico della falsità naturalistica e simbolistica, e fosse
pure che il suo sprezzo si rivolgesse verso il
personaggio che in quel momento stava recitando e
quindi verso se stesso. La citazione che abbiamo
riportata solo in un punto coincide, questa volta, con la
poetica recitativa di Benassi là dove si dice che Amleto
“investe sua madre più con lo scherno che con la
violenza”. Ma questo riguarda una sola scena, anche se
capitale; il che, come ben si vede, è un po’ poco.
Ma un altro elemento dovette contrapporre Benassi a
Bragaglia. Quest’ultimo, lo si sa, genericamente e senza
approfondire troppo l’argomento, ché sarebbe troppo
esorbitare da queste note, può essere rubricato come
“spettacolista” e non solo nel modo in cui lo furono, e lo
sono, tutti i registi ma proprio nel senso in cui s’intende
l’essere “spettacolista” e cioè nel dare un’importanza
fondamentale agli elementi spettacolari spesso a scapito
della recitazione e della parola. Benassi, al contrario, fu
un attore “di parola”. Questa definizione pretende però
un approfondimento. Il termine “teatro di parola” è stato
usato per lungo tempo e fino a oggi in un senso che non
è quello che noi qui intendiamo: si è detto cioè teatro di
parola per teatro del testo in opposizione sia allo
spettacolismo sia alla supposta invadenza e
prevaricazione dell’attore sul testo. Non questo è il caso,
come ormai sappiamo, di Benassi che rispettoso del
testo letterario, nel senso scolastico e meschino dell’uso
corrente, non fu mai ben conscio di essere lui, l’attore a
costituire il “testo spettacolare”. Ma nel suo modo di
37
recitare -come per altro in quello di qualsiasi attore
grande- le parole ebbero uno spazio importantissimo
proprio in quanto parole, essendo irrilevante da chi
fossero state scritte: egli costruì dei capolavori di
recitazione (il “linguaggio della scena”, appunto)
partendo da copioni mediocrissimi. La sua dizione era
perfetta, non nel senso banalmente tecnico, ma per come
pronunciava il significato delle parole usando il
significante in quanto veicolo indispensabile per cui la
sua voce meravigliosa e perfettamente educata a
conoscere tutti i toni e tutti i ritmi costruiva una musica
vera e propria: musica di parole, appunto.
Ancora una volta ricorriamo a Bertuetti che si rese
perfettamente conto di questo:
Memo Benassi ha scavato nella materia sublime con ingegno
acuto, con lucido intuito, con forza. Non s’è limitato, come tanti, ad
ascoltare le parole che cantano per farle ricantare in sé, ma le ha
interrogate una a una con pazienza tormentosa, di ognuna ha voluto
conoscere il mistero, l’anima riposta, dirò così, l’intenzione36.
È chiaro che non si potrebbe dir meglio di Benassi
attore di parola. Questo rifiuto da parte dell’attore di una
recitazione cantata -che era propria di Ruggeri: ma qui
Bertuetti, tranne che non si contraddica volendosi
contraddire date le premesse poste nel brano di questa
recensione citato più sopra, pensa a altri: a tutti quelli
che non essendo Ruggeri ne portavano però avanti la
maniera, probabilmente- per proporre invece un modo
del dire che è tormentato e sofferto, non credendo più
nel valore della parola (e, quindi della comunicazione)
ma ponendosi, in modo assolutamente “moderno” -nel
36
E. Bertuetti, “Amleto” all’Alfieri nell’interpretazione di Benassi, cit.
38
senso che Benjamin attribuiva a questo termine-, il
problema del cosa sta dicendo e del come e scavando e
avvolgendo la parola su se stessa (e qui torna l’equivoco
del suo barocchismo), cercare di tirarne fuori
l’intenzione (che Bertuetti scrive in corsivo)
un’intenzione che forse -e qui l’attore è più scaltrito del
suo pur bravissimo critico- non c’è o non c’è più del
tutto e di cui rimane un residuo forse per chi la ‘dice’,
questa parola, ma che non serve a comunicare: l’Amleto
di Benassi, questo come quello che seguirà, non
comunica con nessuno e stenta a comprendere anche se
stesso, autentico uomo preso nel vortice di una
modernità alienante dove la finzione scenica può
permettersi solamente la critica di se stessa. Ma tutto
questo che ora è detto attraverso il metalinguaggio,
forse un po’ arido, della prosa critica, Benassi lo
esprimeva usando il linguaggio dell’arte della
recitazione; e qui si vuole dire che non è perché Benassi
avesse, nei confronti della parola, questo atteggiamento
che egli si limitasse a “dire”, magari in modo altissimo:
il suo tipo di recitazione, per riallacciarsi a ciò che
abbiamo scritto poche righe sopra, è quello che, nel
linguaggio teatrale, si definisce il “recitar cantando”: e
ciò significa recitare con estrema attenzione al
significante che così risulta quello che deve essere e ciò
è a dire l’autentico veicolo attraverso cui attingere al
significato: tecnicamente la voce viene usata in senso
musicale non diversamente da quello che accade nella
poesia: e, infatti, stiamo parlando di un teatro di poesia
che si oppone al prosastico porgere dell’attore del teatro
di prosa (il bisticcio è voluto). Ma questo modo di
recitare non può essere confuso con quello di chi
39
“canta” (e si ricordi ciò che abbiamo appena letto di
Bertuetti: “Non s’è limitato, come tanti, ad ascoltare le
parole che cantano per farle ricantare in sé”) elevando il
significante a valore assoluto e autonomo e tutto
appiattendo sui valori vocali di una voce spesso
straordinaria (è il caso, ovviamente, di Ruggeri); il che
porta a equiparare battute di nessun conto, puramente
necessarie all’ordito della vicenda, con battute di
estrema importanza in quanto portatrici, appunto, di
valori altamente poetici. E già sappiamo che Benassi
spesso “buttava via” la battuta, la superava a ritmo
velocissimo, per giungere a quello che gli interessava
veramente e che costituiva il fulcro del personaggio
così come se l’era figurato e l’aveva costruito al di là
delle intenzioni dello scrittore del testo: il suo “recitar
cantando” conosceva ritmi e toni che gli servivano
proprio a interrogare e svelare l’intenzione delle parole
che pronunciava, elevandole, grazie a questa sua
straordinaria bravura, allo statuto di poesia. È ancora
Bertuetti che ci descrive, con estremo nitore, lo stile
recitativo benassiano:
I pensieri, i dubbi, gli slanci, le rivelazioni, le viltà, tutti i
rivolgimenti improvvisi e quasi impercettibili dell’anima d’Amleto
si sono impadroniti di lui con la qualità della musica, così che la
sua recitazione aveva di questa le possibilità infinite. Bastava avere
cuore aperto perché l’onda lo colmasse. Accidia, pusillanimità,
orgoglio di principe, amore di figlio, amore d’amante, sentimento
dell’onore (?) gusto lirico del soffrire, che formano il groppo
doloroso, inestricabile della psicologia dell’eroe, s’insinuavano
scomparivano ritornavano nella recitazione del Benassi con la
fluidità e la sorprendente brillantezza di temi musicali37.
37
Ibidem; per il punto interrogativo v. n.21.
40
In quest’ultima citazione s’insinua, al di là della
notazione stilistica straordinariamente preziosa per chi
intende fare storia e critica della scrittura scenica
benassiana, un vago, molto vago invero, sospetto di
psicologismo -e, si sa, psicologismo e naturalismo sono
strettamente congiunti. E qui ci soccorre l’altra cronaca
(della terza, un articolino non firmato del “Popolo
d’Italia” non mette conto parlare se non, come faremo,
per constatazioni, per così dire, statistiche) della serata,
quella di Francesco Bernardelli pubblicata sulla
“Stampa”. Qui, dopo aver notato come tutta la
rappresentazione fosse divenuta un po’ “schematic[a] e
semplicisticame nte teatrale”, il critico (che si allinea con
tutti quelli -e sono la stragrande maggioranza- che
leggono il testo come base dello spettacolo e che non
comprendono le ragioni del testo spettacolare) scrive:
Semplicista è stato anche Memo Benassi - la serata era in suo
onore - nella visione del grandioso personaggio. I caratteri
d’Amleto ch’egli ha con maggior efficacia ricavati sono quelli della
selvatichezza e della finta follìa, con un che di fanciullesco e di
ingenuo nello sfondo. Le stessa truccatura, con una parrucca che a
tratti, con quel gran ciuffo rossigno, appariva quasi clownesca, e il
bianco del volto, e il largo colletto di pizzi bianco, favoriva
l’illusione: bizzaria, funambolismo dai gesti decisi, passetti,
atteggiamenti repentini, quasi di danza, di una plasticità soffice ma
lievemente eccentrica38.
Lasciando perdere il fatto che queste notazioni
vengono fatte da Bernardelli non certo a titolo positivo
ma per ‘dar consigli’, come sogliono fare i cronisti
dell’epoca che giunge fino a noi, a Benassi su come
dovrebbe concepire il personaggio (non è vero che i
38
f.b., Un’edizione dell’“Amleto” all’Alfieri, in “La stampa”, 3
gennaio 1935.
41
cosiddetti ‘critici’ siano tutti scrittori di commedie
falliti; al contrario, sono quasi tutti registi in pectore),
quello che a noi interessa qui è mettere in luce come
questa nota descriva uno stile proprio non psicologistico
(e, forse, antipsicologistico) di Benassi: uno stile che
tende, per restare alle parole del cronista, alla
schematicità e alla semplificazione strutturale e a
inclinare il personaggio in una direzione grottesca.
Quella parrucca col “gran ciuffo rossigno”, “quasi
clownesca”, il volto bianco, eccetera, risultano elementi
assolutamente non “eccen-trici”, come vorrebbe
Bernardelli, ma, al contrario, ben allineati a una precisa
poetica che è quella di svelare prima di tutto a se stesso,
e in secondo luogo allo spettatore, la contraddizione di
un personaggio tragico nell’epoca dell’assenza del
tragico: cosa che Bragaglia ha solo parzialmente
presente ma che sembra invece sia molto chiara a Benassi
che rilancerà la posta, e questa volta lo spettacolo sarà
interamente suo, dieci anni dopo.
Resta abbastanza inspiegabile, allo stato attuale della
ricerca, il motivo per cui questo Amleto venne subito
abbandonato: e degno di nota è il fatto che tutti i
cronisti 39 siano d’accordo nel registrare un ottimo
successo di pubblico: applausi a ogni atto, addirittura a
ogni quadro (Bernardelli), e “feste particolari al
protagonista” (Bertuetti). L’unica osservazione in
proposito che siamo riusciti a scovare è una nota
comparsa sul “Dramma” nella rubrica Se non lo sapete
in cui si dice che Benassi abbandonerà la compagnia
39
Il terzo: s.i.a., “Amleto” interpretato a Torino da Memo Benassi,
in “Il popolo d’Italia”, 3 gennaio 1935.
42
Palmer “nonostante che per lui abbia messo in iscena
l’‘Amleto’. Anzi pare che la lasci appunto per
questo!” 40: e questo ci permette di capire che qualcosa,
come per altro abbiamo già anticipato, dovette non
funzionare in quell’Amleto ma col forte sospetto che
qualcosa non funzionasse per Benassi tout-court nel
personaggio di Amleto; come subito vedremo.
***
Quasi undici anni dopo, il primo dicembre del 1945,
Benassi recita per la seconda volta il personaggio di
Amleto con una compagnia di cui è capocomico, la
Benassi-Torrieri, e con la sua regia, sempre che per la
sua attività di “direttore artistico” sia lecito usare il
termine “regia”; ma questo è un altro discorso: ciò che
qui interessa è constatare come questo Amleto sia tutto e
solo interamente suo. E l’idea viene da lontano: infatti,
più di un anno prima, nelle Memorie, Benassi dice, a
proposito dei suoi progetti: “ho intenzione di
presentarmi al mio pubblico con una edizione piuttosto
personale dell’Amleto di Shakespeare. Su quest’ultimo
lavoro punto in particolare le mie risorse ed i miei
intendime nti” 41. Una dichiarazione, come si vede, netta
ed esplicita; e, infatti, quello di Benassi fu un Amleto
molto particolare, probabilmente in anticipo sui tempi
(nel modo in cui un artista grande e profondo sa scavare
nel proprio tempo e leggervi qualcosa che sfugge agli
altri e che solo dopo verrà scoperto e realizzato), certo
spiazzante sia per la critica che per il pubblico aduso, in
40
41
s.i.a., Se non lo sapete, in “Il dramma”, 1 febbraio 1935, p.47.
M. Benassi, Anticipo alle mie memorie. VIII. Questo
cinematografo, in “film”, 14 ottobre 1944, p.3.
43
quel torno di tempo, a ben altro tipo di esperienze
teatrali e non solo: in pieno trionfo del neorealismo
Benassi, come sempre in controtendenza, imposta un
discorso che con quella temperie storico-artisticaculturale nulla ha a che fare42 e che si inscrive semmai
nella sperimentazione continua di modi e di forme che
sono proprie di questo attore per restituire sul
palcoscenico la coscienza dilacerata dell’uomo
moderno, al di là di quelle che sono le mode stilistiche
che di volta in volta la sua lunga carriera artistica
attraversa. Ma, ancora una volta, le cose non andarono
come Benassi avrebbe voluto: e, in questo caso, a una
critica fredda quando non apertamente ostile (le
eccezioni, come vedremo, servono come sempre a
confermare la regola), corrispose anche, almeno alla
prima, un’accoglienza da parte del pubblico meno
calorosa del solito; e questo si spiega fin troppo bene: è
dai tempi di Leopardi che sappiamo che chi va contro il
proprio tempo deve essere pronto a pagarne le
conseguenze. Non possiamo sapere se Benassi avesse
messo questo nel conto, non ci rimangono -allo stato
attuale della ricerca- né diari né lettere che ci possano
essere utili a chiarire il punto in questione: ma la sua
ben nota irrequietudine nell’arte e nella vita sta proprio
lì a dimostrare come egli si rendesse conto di essere
fuori di chiave col proprio tempo -fuori di chiave,
poundianemente, per gli altri, quindi ‘oggettivamente’
non certo soggettivamente- e questo lo portasse a una
42
Tranne che coi capolavori che pure quell’epoca produsse; certo
pochi, ma comunque incentrati ancora una volta, al di là della
forma in cui si espressero, sugli stessi temi che sono poi quelli
propri della cultura e dell’arte moderne.
44
forma di rabbia impotente molto concretamente radicata
nelle cose che era facile, superficialmente, attribuire a
bizzarria e volubilità di carattere.
La cronaca reagì, come si è detto, in modo freddo e
ostile a questa impresa artistica dell’attore certamente
più discusso di quel periodo storico: e Benassi ne tenne
conto, come prese anche atto del tiepido successo di
pubblico, e dimenticò ben presto quell’Amleto al punto
da non replicarlo nemmeno a Roma dove la compagnia
abbrevia il corso delle recite per l’ostilità della critica: e
il testo che salta è proprio Amleto43. Ma, in tanta ostilità,
la cronaca risulta compatta nel rilevare alcuni dati che ci
sono estremamente utili per comprendere quale fosse la
tendenza, e la tensione, dell’operazione benassiana.
Intanto l’aver reso questo Amleto in modo lieve ma
tormentato, ironico ma grottesco, utilizzando una
struttura scenica molto vicina a quella della pochade.
Cominciamo da un cronista superficiale e malevolo:
La tragedia di Shakespeare è un’indomabile seminatrice di
zizzania. Tutti persuasi, gli interpreti, di essere fedeli: e tutti, sulla
fedeltà, discordi e baruffanti. Discorde Salvini dal protagonista
modellato da Rossi, discorde il floreale Ruggeri dal protagonista
modellato da Zacconi. E discorde, naturalmente, Benassi: che placido e remissivo come è - va insegnando adesso agli antichi e ai
moderni, a Sarah e a Giacinta, l’Amleto esemplare. E tagliatissimo. E
sfornito di Spettro visibile. E corredato di musichette. E dialogante
four del sipario, alla maniera delle riviste. E illuminato dai riflettori.
43
“A Roma [...] né il pubblico né la critica hanno fatto buon viso
alla formazione [la Benassi-Torrieri], anzi la critica si è mostrata
talmente compatta nell’ostilità che la compagnia ha dovuto
abbreviare di una settimana la sua stagione romana”; Florindo,
Ribalte e quinte, in “Platee”, 31 marzo-15 aprile 1946, p.93.
45
Un’edizione per Vanda Osiris44.
La malevolenza è evidente e la superficialità pure in
quell’accostare l’Amleto benassiano al teatro di rivista
nella sua versione più spettacolistica e gastronomica là
dove, invece e al contrario, è forse giusto avvicinare
questa rappresentazione a altre esperienze, sempre in
qualche modo vicine a quelle del teatro di rivista, dove
la parodia grottesca diviene autentica arte: è abbastanza
evidente che mentre scriviamo pensiamo a Petrolini; e,
infatti, qualcosa dell’Amleto petroliniano dovette pur
essere alla base dell’ispirazione di quest’altro Amleto,
ma ciò sia detto senza esagerare nei confronti dal
momento che Petrolini godeva di una libertà, quella
appunto del teatro di varietà, di cui non poteva fruire
Benassi e di una capacità di scriversi da sé i propri testi
che Benassi non ebbe mai.
Daniele D’Anza, anch’egli in una recensione non del
tutto favorevole a Benassi, parla di “un senso del
balletto che esalterebbe un Clair”45: e con il richiamo al
regista francese, così bravo a esprimere questioni
importanti e nodali in uno stile leggero e frizzante con
un continuo richiamo a quel surrealismo da cui
prendeva spunti pur non identificandovisi come farà
nello stesso torno di tempo Buñuel, forse ci avviciniamo
di più a quello che dovette essere il fulcro
dell’operazione benassiana che intese contrapporre alla
pesantezza monumentale del grande attore ottocentesco
e agli estenuati lirismi ruggeriani che si prolungano in
44
Polonio, Commento umile a lettere superbe, in “Le scimmie e lo
specchio”,
gennaio-febbraio 1946, p.90.
45
D. D’Anza, Palcoscenico , in “Platee”, 15 dicembre 1945-15
gennaio 1946, p.61.
46
quelli di Ricci, un Amleto inquieto ma brillante e
decisamente antimelodrammatico. Su questo punto, sul
rifiuto di quella tendenza al melodramma che permea di
sé l’operato del grande attore ottocentesco e ancora
novecentesco, tutta la cronaca è concorde tanto dovette
risultare evidente dal testo spettacolare benassiano: “Un
Amleto però, questo di Benassi, finalmente libero da
ogni sapore melodrammatico: senza romanze e senza
strofette canore”, è ancora Daniele D’Anza nell’articolo
appena citato. Paolo Grassi scrive sull’“Avanti!”:
[...] interessante [...] notare come Benassi abbia ricercato, in questa
edizione, motivi diversi e più sottili dei soliti allacciandosi
particolarmente, per l’impostazione tutta del personaggio, a quella
“debolezza e malinconia” che Amleto stesso denuncia per sé e
ricavandone quindi, all’infuori di stilizzazioni plastiche e di
illazioni liriche come altri attori hanno ricercato, una creatura
inquieta ed ansiosa, pervasa già di tutti i problemi e in ogni parola
ricercante una luce o un quesito, lontana da romanticismi, secondo
un’interpretazione per intenderci più vicina a Moissi che a Ruggeri
o a Ricci, interpretazione di carattere “nordico” se così possiamo
dire, scevra della liricità abituale cara ai latini46.
Qui è denunciato, in modo chiaro, l’antiromanticismo
dell’Amleto di Benassi e anche il suo porsi in una
posizione che contrasta il lirismo di tutta una scuola che
fa capo a Ruggeri, come abbiamo visto Amleto “latino”
quant’altri mai.
Ma la critica -e qui scriviamo “critica” e non
“cronaca” dal momento che l’articolo di cui stiamo per
occuparci è pubblicato su una rivista che esce alcuni
giorni dopo la prima e che quindi permette a chi scrive
46
P.G., “Amleto” di Shakespeare, all’Odeon, in “Avanti!”, 2
dicembre 1945.
47
una maggiore possibilità di riflessione- più convincente
e interessante è quella di Carlo Terron:
Dopo l’Amleto naturalistico di Zacconi [...] dopo l’Amleto
amletico di Ruggeri, dopo l’Amleto studente di ginnasio di Moissi,
dopo l’Amleto romantico di Ricci, l’Amleto di Benassi è
pantomimico, plastico, decorativo e strawinskiano. L’Amleto più
discutibile che io abbia mai visto, ma anche l’Amleto più geniale.
Fin troppo. Come è troppo geniale, talora a suo svantaggio,
Benassi, quando sbandiera impetuosamente e splendidamente tutta
la smagliante fantasia dalla quale è affetto47.
C’è in questo critico, che a noi risulta essere il più
acuto fra quanti si sono occupati di Benassi -l’unico in
fondo non turbato dalle a volte strabilianti innovazioni
benassiane come abbiamo visto spesso scompensate
confronto ai tempi in cui appaiono-, una profondità di
visione che sorprende, soprattutto se lo si confronta con
i suoi colleghi dell’epoca stupiti, per esempio, dal modo
in cui Benassi recita il monologo del terzo atto. Uno per
tutti: Possenti, sull’autorevole “Corriere d’informazione” -che sostituisce temporaneamente l’epurato
“Corriere della sera”- opta per un tono paterno, ma
anche prudente, di fronte a un ragazzo un po’ discolo:
Ora, la parola ha sempre il suo peso, specialmente quando è di
Shakespeare: essa possiede un valore e una musica di cui s’ha da
tener conto, altrimenti si corre pericolo, ad esempio, di non scavare
in profondità il celebre Essere o non essere, che il Benassi
pronuncia, invece, con levità, accompagnandosi, per giunta, con un
nervoso muovere di pedine su una scacchiera: Ma dov’è, nel
monologo, il concetto di giuoco? Nessun giuoco, ma una profonda
angoscia del nostro destino in rapporto con la nostra coscienza48.
47
C. Terron, Amleto al telescopio, in “La lettura”, 6 dicembre 1945,
p.13.
48
e.p., Benassi nell’“Amleto” all’Odeon, in “Corriere d’informazione”, 4 dicembre 1945.
48
Sfugge del tutto a Possenti, come è evidente, la
poetica d’attore di Benassi che non si occupa dei valori
del testo ma di quelli realizzati nei testi spettacolari
precedenti il suo: il recitare in quel modo l’Essere o non
essere mostra in modo molto chiaro e netto il suo rifiuto
di usare lo spartito shakespeariano come la traccia su
cui impostare un testo spettacolare melodrammatico
intessuto di recitativi e di ‘arie’ tra cui, proprio quella
canonica e attesa dal pubblico, è quella del monologo in
questione 49. Il tamburellare sulla tastiera degli scacchi è
quello che si suole definire un effetto di straniamento,
inteso proprio a “buttar via” -per usare ancora una volta
il gergo teatrale- un ‘pezzo’ forte della tradizione
spettacolare italiana con l’intenzione di scuotere il
pubblico dalla sua apatia digestiva e di cercare
(sappiamo che l’esperimento non ebbe esito
soddisfacente) di far concentrare la sua attenzione su
qualche cosa di più importante della “profonda angoscia
del nostro destino in rapporto con la nostra coscienza” e
ciò è a dire della profonda coscienza di trovarci di fronte
a un teatro alienato e reificato proprio nel suo persistere
romanticamente melodrammatico e liricheggiante, a un
teatro che rinvia a un mondo altrettanto alienato e
reificato. Ma tutto ciò non avrebbe potuto capirlo
Possenti mentre invece sembra risultare chiaro a Terron:
Tutte le moderne interpretazioni di questo personaggio
[Amleto], anche grandi, anche grandissime, tendono a preoccuparsi
di renderlo quanto più possibile vicino all’umanità comune, di
49
“I monologhi [dell’Amleto], in effetti, sono l’equivalente teatrale
delle arie operistiche”; L. Kitchin, Per una valutazione della messa
in scena di Hamlet, in AA.VV., Hamlet dal testo alla scena, a c. di
M. Tempera, Bologna, CLUEB, 1990, p.133.
49
vivisezionare a attualizzare la sua psicologia sacrificando l’eroe
all’uomo, col risultato di minimizzare le sue proporzioni rendendo
il personaggio sempre più “vero” e sempre più piccino, e
l’intellettualità capillare di Alessandro Moissi giunse a farne un
fanciullo. Benassi ha proceduto al contrario; dove gli altri hanno
messo questo gigante psicastenico sotto un microscopio egli ci ha
puntato davanti un telescopio.
Interpretazione enorme, incontinente e forsennata, che si scuote
dalla schiena ogni schema e ogni incrostazione romantica, veristica,
intellettualistica e psicologica. Tutto nuovo, tutto diverso dagli altri,
tutto e sempre un dito sopra le righe. Fin troppo50.
Certo le affermazioni di Terron appena citate sono
sconvolgenti sempre che non ci dimentichiamo che
siamo in piena epoca neorealistica: Benassi puntando un
telescopio sul suo personaggio -efficacissima la
metafora- compie un’operazione antiromantica,
antiveristica, antiintelletualistica e antipsicologica; in
una parola fa piazza pulita di tutta una tradizione
naturalistica per rilanciare il personaggio di Amleto
verso mete ben più in sintonia con i tempi, un Amleto
forsennato, disperato e esasperato, ma, proprio per
questo anche comico e grottesco (“Ricordo
quell’Amleto in cui Benassi recitava il monologo
giocando a scacchi, e delle volte ti faceva venire i
brividi, la pelle d’oca [...]; né mancavano quei momenti,
auspicati da Palazzeschi, in cui si scoppiava a ridere”51)
nel denunciare la falsità del teatro, l’incapacità di
fingere dell’attore moderno tutto teso a restituire la
realtà, in un modo o nell’altro, e a negare proprio la
finzione: quella finzione che stava a cuore a Benassi
mostrare e, addirittura, ingigantire per mettere in luce
50
51
C. Terron, Amleto al telescopio, cit.
E. Pagliarani, Quando Amleto è solo una comparsa, in Il fiato
dello spettatore, Padova, Marsilio, 1972, p.36.
50
come attraverso questa si possa raggiungere il nocciolo
profondo della nostra umanità dolente di uomini che
non hanno scelto di nascere in un’epoca dove vivere una
vita autentica -e quindi non falsa- risulta impossibile e
dove l’unica possibilità per un attore che sia anche un
artista è denunciare, attraverso la finzione, questa
impossibilità.
E tutto questo Benassi sa rendere al massimo grado:
“Fin troppo”, dice Terron. E, per il rispetto che si deve a
questo critico, l’argomento va approfondito.
Abbiamo un altro scritto di Terron: è un “coccodrillo”
pubblicato all’indomani della morte dell’attore (24
febbraio 1957) che non fu improvvisa ma che fu causata
da una trombosi cerebrale seguita a un’altra che lo
aveva colpito il 9 novembre del 1956 durante una prova
del Re Lear. Si tratta quindi di uno scritto meditato e
articolato dove Terron fa il punto su Benassi,
sull’interpretazione di ciò che era stata la sua arte anche
raffrontandola a quella dei suoi contemporanei: e, dopo
aver detto di Zacconi, Ruggeri, Ricci, Gassman e
Randone e aver dato dell’arte di ciascuno di questi una
sintetica definizione, conclude:
[...] il favoloso Benassi, artista scarso, vorrei dire privo di
sentimento e, viceversa, sovraccarico dell’interiore dinamismo di
una eccezionale capricciosità ed autosuggestionabilità nevrotica e,
perciò, tendente alle soluzioni di stile appoggiate alle sorprese
emozionanti ed eccentriche, fu l’autore barocco della nostra
scena52.
Ecco quindi il termine “barocco” che compare a
definire la recitazione di Benassi che lo stesso Terron,
52
C. Terron, Fece un personaggio anche di se stesso, in “Corriere
lombardo”, 25-26 febbraio 1957.
51
nella recensione citata all’Amleto del ‘45, aveva definito
“il meno veristico e perciò il più poetico degli attori
nostri”. Le due affermazioni potrebbero sembrare
contradditorie, anche se sono passati, tra l’una e l’altra,
quasi dodici anni. Ma Terron che ha il pregio della
profondità di pensiero, appunto, approfondisce. E qui
sarà necessaria una citazione un po’ lunga ma, come
subito vedremo, di deciso interesse per il nostro
tentativo di ricostruire la poetica attorica benassiana:
Su questo equivoco termine “barocco” è bene intendersi subito.
Esso va riportato al suo significato originario, spoglio, cioè, dalle
variazioni aggettivate e spregiative assunte nella sua accezione
corrente: quella di un’arte che ha per caratteristica espressiva
l’interna, energetica, inconciliabile e drammatica dialettica fra
vortici di contenuti tumultuosi, contraddittori e in perpetuo
movimento, e una forma definitiva atta a comunicarli nella loro
dinamica instabilità. Come non pensare, infatti, davanti
all’esasperazione espressiva, alle sconcertanti dissonanze, alla
cangiante volubilità, ai gonfi decorativismi, alle sorprendenti
spezzature, alle turgide violenze e alle polemiche provocazioni,
adunate per fare di ogni sua interpretazione una perpetua
meraviglia, come non pensare a certe spettacolose statue del
Bernini o del Borromini impetuosamente librate in assurdi
equilibri, contro ogni legge di statica, apparentemente prive di un
centro di gravità, impegnate ad imporre allo spazio il loro
movimento e il loro ritmo; teatralmente atteggiate, tutte smorfie e
svolazzi, sempre sul punto di precipitare e sempre vittoriose delle
comuni leggi fisiche53.
Va subito notato come qui si parli, con profonda
sapienza è il caso di ripeterlo, di stile, dello stile
recitativo di Benassi; quei “vortici di contenuti
tumultuosi, contraddittori e in perpetuo movimento”,
attribuiti al barocco e all’attore contemporaneamente,
53
Ibidem.
52
stanno proprio lì a esprimere ciò che ormai stiamo
affermando da quando abbiamo iniziato a studiare l’arte
di Benassi: la coscienza della frantumazione e
dell’alienazione del soggetto nel mondo dei rapporti
reificati: ma come poi questo grumo tormentoso e
tormentato -e così straordinariamente moderno in un
teatro che si sta ormai arrendendo all’industria dello
spettacolo- diventi stile viene decisamente chiarito da
questa meditazione di Terron. Le statue di Bernini e di
Borromini servono molto bene a rendere l’idea di una
recitazione basata, in opposizione allo stile dei
contemporanei tutto compostezza e naturalezza
‘accademica’, sullo squilibrio e sull’instabilità del corpo
dell’attore di cui fa parte, ed è parte importantissima e
fondamentale, la voce. Come Petrolini, Benassi
sfruttava fino in fondo le sue straordinarie capacità di
muoversi e dire in un perpetuo equilibrio instabile,
spostando il baricentro del corpo e i toni e ritmi della
voce in funzione antinaturalistica e svelante, ci
ripetiamo ma è un elemento fondante della sua poetica
attorica, il disequilibrio e l’instabilità dell’essere: egli
seppe come nessuno nel teatro cosiddetto di prosa
esprimere stilisticamente la sua e nostra profonda
inquietudine; e il suo grottesco si realizzò proprio in
questo modo così bene e così nettamente descritto da
quello che fu il suo critico più intelligente.
Il quale critico, però, anche in questo “coccodrillo”
volle esprimere le sue riserve a inverare quel “fin
troppo” dell’articolo di dodici anni precedente; e, infatti:
Più di ogni altra, quest’arte del doppio, del triplo salto mortale,
del salto mortale a vita, naturalmente e continuamente affacciata
sull’esagerazione e l’artificio, presenta i suoi pericoli. E il
53
principale di essi si chiama barocchismo. Dal barocco al
barocchismo, purtroppo, il passo è sempre stato breve. Che
Benassi, spesso e volentieri l’abbia compiuto, non si può negare.
Ma non si può nemmeno, per converso, negare che in questa
disarmonia fosse la sua grandezza54.
C’è una leggera contraddizione in queste righe tra la
“grandezza” riconosciuta a Benassi e l’accusa di
“barocchismo”; ma, a mettere da parte la pietas nei
confronti
dell’attore
appena
morto,
questa
contraddizione è spiegabile se si tiene conto che quello
che qui Terron definisce “barocchismo” di Benassi fu il
suo gigionismo: e cioè quei momenti che “spesso e
volentieri” l’attore concesse a sé, al suo narcisismo, e al
suo pubblico in cui mostrava, stupendamente come solo
lui seppe fare (sempre nel “teatro di prosa”, quella di
Petrolini è un’altra storia) il prodigioso talento e la
tecnica sopraffina di cui era padrone. E il pubblico
amava molto queste sue variazioni che interrompevano
e rendevano godibile una trama -il teatro di prosa, a
differenza di quello di varietà, è anche trama- spesso
pesante e noiosa: è probabile che Benassi abbia
ecceduto in questa sua capacità di “meravigliare” per
vanità (e vogliamo qui concedere che non si trattasse di
narcisismo ma di questa sua declinazione meno nobile),
per gusto della sfida, per piacere anticonformistico o,
meglio, non conformistico in opposizione ai suoi
compagni di avventura artisticamente tanto inferiori a
lui, per dare piacere al suo pubblico che amava e
disprezzava nello stesso tempo, per sfogare una
tensione, difficilmente sopportabile in altro modo,
dovuta all’angoscia di cui abbiamo ormai più volte
54
Ibidem.
54
detto; ma tutti questi eccessi servono solamente poi a
confermarci nell’idea che si sia trattato di uno stile di
recitazione unico e inimitabile che seppe fare dello
squilibrio spudoratamente finto la sua cifra profonda e
nobilissima.
Conclude Terron il suo articolo per la morte di Benassi:
Sul letto dell’ospedale di Bologna non giace l’attore Memo
Benassi, giace il Te atro55.
Non è chi non veda, in queste righe, un cedimento
alla retorica e allo stile gazzettistico da parte di un
critico pur così stilisticamente sorvegliato; ma non è
anche chi non veda che, al di là di questo stile reboante
e retorico (ma forse ancora una volta dettato dalla
pietas), Terron anche in questo caso dica una cosa
verissima: il teatro dei decenni centrali del novecento,
anche se Ricci e Randone gli sopravvissero, si chiude,
dal punto di vista artistico, con la morte di Benassi: chi
verrà dopo scriverà un’altra storia che già Benassi
preannuncia: con la chiusura dell’epoca del grande
attore si aprirà pochi anni più tardi quella dell’attoreartifex che già presenta la recitazione di Benassi, come
abbiamo avuto modo di indicare altrove.
E qui finirebbe la storia degli Amleto di Benassi non
fosse che a questo discorso è necessaria una coda
particolare e, come subito vedremo, non priva di
interesse.
***
Il 28 ottobre del 1955 va in onda, alla televisione per i
venerdì dedicati alla prosa, l’Amleto di Gassman.
55
Ibidem.
55
Questo spettacolo, in cui Benassi fa la parte di Claudio,
è registrato su un -allora si chiamava così-“vidigrafo”. E
questa registrazione, come tutte le altre registrazioni di
eventi artistici in qualsiasi modo realizzate, pone dei
problemi a chi questo evento voglia analizzare. Infatti
oggi notiamo più che una discussione teorica
approfondita piuttosto un’opinione diffusa per cui la
registrazione tecnica e elettronica dell’evento può
sostituire l’evento stesso; per converso c’è chi dice che
sarebbe meglio che la possibilità della registrazione non
fosse mai stata inventata tanto risulta distorcente nei
confronti dell’evento originario. Tra la prima posizione,
ingenua e totalmente arresa all’esistente (e l’esistente è
ciò che giova al mercato), e la seconda estremistica e, a
suo modo, luddistica c’è da proporre una alternativa
dialettica che tende a non rifiutare quello che di buono
può esserci nello sviluppo della modernità. Infatti a chi
sostiene che ne sapremmo tanto di più sul teatro greco
del quinto secolo avanti Cristo se possedessimo una
registrazione tecnologica di quegli spettacoli è agevole,
anche se per nulla scontato, opporre che in questo caso
ci troveremmo di fronte a un documento di
difficilissima
decifrazione,
diciamo
pure
incomprensibile; ma, per converso, quale documento
risulta allo storico-critico di facile decifrazione? Certo
ne sapremmo qualcosa di più ma quali sarebbero i
pericoli che si correrebbero per comprendere che cosa
ne sapremmo di più? È agevole ricorrere a un esempio:
oggi ci troviamo di fronte a registrazioni di spettacoli
degli scorsi decenni e capita frequentemente di
osservare fenomeni apparentemente strani quali quelli di
non capire più le reazioni del pubblico: il pubblico ride,
56
ma noi non ridiamo; il pubblico applaude a scena aperta,
ma noi non ci sentiremmo di applaudire; il pubblico
mormora e noi non capiamo perché lo faccia: eppure
sono passati solo pochi anni. Ovviamente questo
dimostra solamente qualcosa che tutti sanno o
dovrebbero sapere e ciò è a dire che la riproduzione
tecnica e elettronica di una manifestazione artistica non
potrà mai in alcun modo sostituire l’originale dal
momento che il teatro vive nell’attimo in cui si realizza,
nell’attimo in cui tra l’attore e il pubblico si stabilisce
un certo tipo di complicità o, al contrario, una
contrapposizione: per noi che studiamo l’arte dell’attore
da un punto di vista estetico la sociologia del pubblico,
in fondo, non ci interessa ma certo non al punto tale da
doverla ignorare: infatti solo tenendo conto di quella
relazione sono poi spiegabili fenomeni squisitamente
teatrali che riguardano meno le altre arti dal momento
che il teatro, come si sa, ha bisogno del consenso del
pubblico per vivere, almeno prima dell’epoca delle
sovvenzioni quando cambia il tipo di consenso: un
tempo il consenso, un certo tipo di consenso, risultava
vitale all’’impresa’ (e quella teatrale è sempre
un’impresa) per poter esistere; poi il consenso del
pubblico diviene importante per giustificare le enormi
spese che richiedono determinati allestimenti anche se, a
differenza di ciò che succedeva prima, queste spese non
vengono affatto coperte dall’incasso delle recite: manca
ancora uno studio, per esempio, di come sia stato
organizzato il consenso intorno al linguaggio della
scena degli stabili e come l’opinione del pubblico sia
stata pilotata a scambiare per arte ciò che arte non è ed è
solo industria culturale che, come si sa, risulta, oggi, la
57
più grande nemica dell’arte56. (Ma questo, ovviamente,
non vale solo per il teatro). In conclusione: per
comprendere un documento così distorcente come la
registrazione di un evento teatrale risulta necessaria
un’attenta sociologia del pubblico: e, allora, per tornare
alla possibilità teorica di avere un documento registrato
del teatro greco del quinto secolo è evidente che ci
troveremmo di fronte a un documento di cui non
capiremmo nulla se non ricostruendo con estrema
attenzione, e ricorrendo ovviamente a altri documenti di
varia natura, la sociologia di quel pubblico: e lo stesso
evento estetico, la recitazione, ci risulterebbe di
difficilissima decifrazione dal momento che non si è
sempre recitato allo stesso modo né allo stesso modo è
stata concepita l’arte dell’attore come ovviamente non
allo stesso modo si è inteso il concetto di arte: muta il
concetto di letterarietà e muta anche quello di attoralità.
Stabilite queste premesse dobbiamo però distiguere
ancora tra due tipi di registrazione di eventi teatrali:
quello della registrazione di uno spettacolo che si sta
regolarmente svolgendo in un teatro e davanti a un
56
Bruno Sanguanini nel suo libro dal titolo Il pubblico all’italiana
(Milano, Franco Angeli, 1989) tratta anche del teatro di stato e
degli stabili (pp.275-284): le osservazioni sono di deciso interesse
ma, data l’impostazione sociologica dello studioso, prescindono del
tutto da questioni estetiche. Sarebbe necessario uno studio che
mettesse insieme competenze diverse, appunto quelle estetiche e
quelle sociologiche, per portare alla luce le motivazioni del
cambiamento del gusto del pubblico; e ciò è a dire, ellitticamente,
riuscire a comprendere come mai un pubblico abituato a apprezzare
a teatro soprattutto l’arte dell’attore diventi, a un certo punto,
pregiatore di uno spettacolo di regia che è tutt’altra cosa e accetti, e
anzi approvi e promuova col suo consenso, quel particolare
linguaggio della scena che è possibile rubricare, appunto, come
linguaggio da stabile.
58
pubblico e quello che viene invece registrato in un
luogo determinato senza il pubblico (o con un pubblico
che recita la parte del pubblico, come è il caso di
Petrolineide) e con un attore che sa di recitare per la
macchina da presa o la telecamera: in quest’ultimo caso,
ovviamente, le cose stanno in modo diverso che nel
primo dal momento che la consapevolezza dell’attore di
stare recitando in assenza di pubblico fanno sì che egli
calibri il proprio modo di recitare diversamente di ciò
che farebbe in teatro. E questo risulta un primo effetto
di distorsione, per così dire, alla fonte; ma ce ne sono
altri. E ora lasciamo la teoria per passare alla pratica
esegetica.
Nel nostro caso ci troviamo di fronte a uno spettacolo
particolare e decisamente composito. Infatti questo
Amleto con la regia di Gassman è una derivazione da un
altro Amleto di qualche anno precedente che si avvaleva
della regia dello stesso Gassman e di Luigi Squarzina.
Non interessa a queste note l’esegesi dei due testi
spettacolari: basterà notare che quello con la regia di
Gassman e Squarzina dovette risultare meno composito
e più determinatamente allineato sulla direttrice che
potremmo definire “accademica” intendendo qui, con
questo termine, dire che fu il frutto forse più rilevante di
quell’Accademia d’arte drammatica, fondata nel 1935
da Silvio d’Amico e oggi a lui intitolata, che tanta parte
ebbe nella storia del nostro teatro di prosa degli anni
centrali del secolo appena scorso e la cui impostazione
teorica e pratica giunge fino a noi. La versione
televisiva, che mantiene la traduzione di Squarzina,
mostra il proprio essere composita articolandosi in
almeno quattro componenti per ciò che riguarda la
59
recitazione: quella accademica rappresentata dallo
stesso Gassman, da Luigi Vannucchi che è Laerte, da
Giulio Bosetti che è Orazio e, almeno in parte, da Elena
Zareschi che recita la parte di Gertrude; quella più
bassamente naturalistica rappresentata da Anna Maria
Ferrero
nel
personaggio
di
Ofelia,
attrice
cinematografica evidentemente utilizzata da Gassman
più per la sua avvenenza che per la sua bravura
d’attrice; quella che potremmo definire, sulla scorta di
Tòfano, “all’antica italiana” incarnata da Augusto
Mastrantoni che è Polonio e, infine, quella del tutto
estravagante dalle altre e dissonante che è rappresentata
da Benassi. Bisogna subito dire che la presenza di
Benassi nel cast sembra non essere stata prevista, come
risulta da un ampio articolo di Roberto De Monticelli
pubblicato su “Epoca” che anticipa la registrazione 57:
Gassman forse aveva pensato a Mario Luciani perché
probabilmente più funzionale al suo disegno registico disegno che, sia detto per inciso, non appare limpido ma
piuttosto abborracciato-: Benassi, a questo disegno
registico, è assai poco funzionale e dovette essere
57
R. De Monticelli, Vittorio Gassman centro attacco del teatro, in
“Epoca”, 16 ottobre 1955, pp.42-45. L’affermazione che ci
interessa è all’inizio dell’articolo: “Vittorio Gassman è venuto a
Milano [...] per preparare, con Annamaria Ferrero, Elena Zareschi e
Mario Luciani, l’edizione televisiva dell’Amleto” (p.42). Risulta un
po’ strano che un attore di secondo piano come Mario Luciani -di
cui si sa molto poco dal momento che non è presente né nell’Enciclopedia dello spettacolo né altrove ma è solamente ricordato in
alcune cronache del dopoguerra come quelle di Simoni o dello
stesso De Monticelli e mai con parti di rilievo- dovesse recitare nel
ruolo di Claudio; d’altro canto risulterebbe ancora più strano che un
critico fine e avvertito come De Monticelli si possa essere
dimenticato di Benassi cui pure, negli anni precedenti, aveva
dedicato notevole attenzione.
60
scritturato all’ultimo momento. Non sappiamo perché
abbia accettato, ma è molto probabile che, data la sua
scarsa considerazione della riproduzione tecnica, filmica
o televisiva che fosse, l’abbia fatto per le solite ovvie
ragioni economiche anche tenuto conto che le sue cose
televisive più belle sono ineluttabilmente, dato tutto ciò
che si è detto fin qui, quelle in cui egli è attore solista e
solo come abbiamo già notato per l’Enrico IV
pirandelliano e come ancora è per Shylock e per i
monologhi cechoviani (Tragico contro voglia e Il canto
del cigno). Poste queste premesse risulta chiaro che la
prestazione di Benassi nella parte di Claudio non ci
restituisce affatto la stupenda presenza scenica
dell’attore; e purtuttavia qualcosa su di lui, e sullo
spettacolo cui partecipa, ci dice.
L’impostazione che Benassi dà al suo personaggio
non può non tenere conto dell’insieme: qui non si
presenta il caso di una compagnia sua in cui egli è del
tutto libero ma si tratta di quella che si suole definire
una “partecipazione straordinaria” e ciò è a dire,
appunto, fuori dall’ordinario: e l’ordinario per Benassi è
di essere capocomico. Così si sente immediatamente, al
di là della questione della riproduzione tecnica e
elettronica di cui s’è detto, un certo disagio: disagio per
i compagni (tranne Mastrantoni con cui doveva sentirsi
in una qualche forma di sintonia non foss’altro perché
quest’ultimo recitava in un modo a lui familiare anche
se non era certo il suo: e, infatti, la controscena della
seconda scena dell’atto secondo di Claudio al racconto
di Polonio che crede di avere scoperto il motivo della
‘pazzia’ di Amleto nell’amore per Ofelia risulta un
‘pezzo’ magistrale di bravura), disagio per le scene: non
61
bisogna dimenticare che i suoi due Amleto si avvalevano
l’uno della scenografia di Bragaglia e l’altro di quella di
Virgilio Marchi, l’una e l’altra, e ciascuna a suo modo,
stilizzate, mentre qui siamo di fronte al gusto -si fa per
dire- televisivo dominante in questa prima fase di quello
che diventerà il mezzo di comunicazione di massa per
eccellenza e che si risolve in un basso naturalismo di
cartapesta tanto falso quanto bolso e inutilmente
ridondante. In questa situazione ancora una volta
Benassi sceglie per il proprio personaggio una
particolare declinazione del grottesco: il disprezzo.
Il disprezzo, si sa, può avere almeno due valenze: la
prima è quella filistea e miserabile, di chi disprezza tutto
e tutti tranne se stesso: in questo caso abbiamo una
posizione che Petrolini ha al solito mirabilmente
sintetizzata con la consueta lucidissima crudeltà nel
“senza orrore di se stesso”; la seconda, al contrario, è
una declinazione del sentimento del disprezzo
rappresentata da chi, con profondo dolore, si rende
conto che questo modo di sentire va rivolto innanzi tutto
a se stesso perché se non è colpa di nessuno l’essere
capitati in un mondo da disprezzare è certamente
sciocco disprezzare gli altri senza rendersi conto che noi
di questo mondo siamo parte che lo vogliamo o no: la
reificazione e l’alienazione del soggetto non colpiscono
certamente solo chi di queste cose non si rende conto
ma anche -e, in un certo senso, di più- chi conosce
queste cose. Capire il mondo vuol dire, innanzi tutto,
capire che di questo mondo si è parte e l’esserne
coscienti non ci assolve dal peccato originale di farne
parte; l’esserne coscienti arreca dolore. Il disprezzo di
Benassi colpisce innanzi tutto il proprio personaggio e lo
62
colpisce con dolore: la perfidia di Claudio diventa la
perfidia del mondo e dell’attore stesso che lo recita e che
lo recita, appunto, con dolore: la scena terza del terzo
atto, quello dell’impossibile preghiera del re, risulta un
vero capolavoro di sapienza attorica: qui Benassi utilizza
l’eccezionale gamma musicale della sua voce in un
variare di timbri ricchissimo con rallentamenti,
sottolineature, improvvisi arresti tesi proprio a mostrare
il disprezzo per il personaggio ma anche la pietà che
questo re delittuoso ha nei confronti del proprio essere
malvagio e anche roso dal rimorso per ciò che ha fatto,
un rimorso che non giunge a fargli rinunciare al potere
conseguito grazie al suo delitto, ma che pure lo mostra
come un povero essere in preda alla paura che più che la
paura della morte, nella recitazione di Benassi, diventa
la paura di vivere in un mondo corrotto della cui
malvagità egli è gran parte ma con un aspetto di sé che
tende paradossalmente all’innocenza: mostruosa
macchina dialettica che l’arte di Benassi esalta in modo
mirabile.
Ma c’è una battuta di Claudio che risulta una vera e
propria mise en abîme di questo testo recitativo di
Benassi (di questo testo, che ora stiamo prendendo in
considerazione, non della poetica recitativa di Benassi
in teatro). È la scena prima del quarto atto; Claudio, a
un certo punto del colloquio con Laerte appena tornato
in Danimarca, dice: “La maestà è avvolta da un’aura
divina [...]”58: Benassi pronuncia questa battuta in modo
particolare, conseguente a come ha impostato tutto il
58
W. Shakespeare, Amleto, trad. di L. Squarzina, Rocca San
Casciano, Cappelli, 1953, p.167.
63
personaggio, quasi in sottotono pur facendo un gesto,
per altro non particolarmente ampio, col braccio destro
e, cosa veramente strana, egli che ha un dire limpido e
chiarissimo articola male, in modo decisamente
incomprensibile, la parola “aura”. Risulta subito chiaro
che qui la sua intenzione è proprio quella di denunciare,
al di là e al di sopra del personaggio, una sua angoscia
profonda che possiamo riassumere nella perdita d’aura
della recitazione, dell’arte, nell’epoca moderna e ancora
più nell’atto della sua riproduzione tecnica; in quella
battuta c’è proprio tutto, compresa la rassegnazione
stoica: il senso di disagio nel trovarsi immerso in una
struttura accademico-naturalistica che gli è estranea, il
sentimento della decadenza dell’aura dell’attore non
solo nell’epoca della riproduzione tecnica ma anche
nell’epoca della regia, l’accettazione rassegnata -e,
ancora una volta, sottolineiamo, stoica- del trovarsi
spaesato in un mondo e in un teatro che non è più il suo
(e che forse non lo è mai stato), il disprezzo sofferto per
sé e per quel mondo, la consapevolezza che l’auraticità
dell’attore, dell’artista, pur da lui perseguita con
pervicacia, dolore e disperazione per tutta la vita,
diviene ora addirittura impronunciabile come parola.
E su questa altissima consapevolezza d’attore,
consapevolezza dell’esercitare un’arte in un mondo che
sotto la spinta dell’industrializzazione della cultura sta
divenendo sordo all’arte e indifferente all’“aura”, si
chiude la storia degli Amleto di Benassi: non senza
notare che in questo 1955 Benassi ha sessantaquattro
anni, la stessa età in cui Ernesto Rossi recitò per
l’ultima
volta
la
parte
di
Romeo.
Ma
l’industrializzazione deve andare incontro ai gusti del
64
pubblico e contemporaneamente promuoverli nella
direzione che giovi a questa struttura economica così
precisamente connotata dall’essere consustanziale
all’epoca della borghesia: e il naturalismo, in tutte le sue
varie declinazioni e fino a oggi, è l’espressione tipica
della borghesia trionfante: Benassi anche questa volta si
trova in controtendenza, se pure nella parte un po’
riposta di Claudio, e risulta pertanto “anacronistico”,
parola terribilmente liquidatoria per chi persegue la
novità a scopi chiaramente mercantili, e lo sa: la sua
grandezza, grandezza di sconfitto che in teatro sapeva
travolgere
le
platee,
è
anche
qui 59.
59
Nel reperire il materiale su cui si fonda questo scritto sono stato aiutato
da Alberto Bentoglio, Paola Farinetti, Armando Petrini e Elisabetta
Randaccio che qui ringrazio.
65
66
Materiali per una storia del teatro italiano di contraddizione. “Aspettando Godot”,
Teatrostudio, Genova 1964
a cura di Donatella Orecchia e Armando Petrini.
In questo numero:
Premessa
Introduzione
Cronologia (1959-1967)
Programma di sala
Recensioni
Nel prossimo numero:
Colloquio con Rino Sudano (Torino, 28 novembre 2000)
Colloquio con Carlo Quartucci (Roma, 3 dicembre 2000)
Colloquio con Claudio Remondi (Roma, 3 dicembre 2000)
Colloquio con Maria Grazia Grassini (Roma, 27 dicembre 2000)
Colloquio con Luigi Squarzina (Roma, 28 dicembre 2000)
Colloquio con Valeriano Gialli (Aosta, 7 gennaio 2001)
Il testo dell’introduzione è da p.127 a p.135 di Armando Petrini, da p.135 a p.145 di Donatella Orecchia. La
cronologia è a cura di Donatella Orecchia, le recensioni a cura di Armando Petrini.
Nota
La fotografia n.1 è riprodotta in E. Fadini, C. Quartucci, Viaggio nel Camion dentro l’avanguardia, ovvero la
lunga cinematografia teatrale 1960-1976, Torino, Cooperativa editoriale Studio Forma, 1976, p.28. Le
fotografie n.2, 3, 4 e 6 sono di Lisetta Carmi (Archivio del Teatro stabile di Genova), le fotografie 5, 7, 8, 9, 10
e 11 sono di Francesco Leoni (Ibidem). A parte la prima immagine, tutte le altre si riferiscono alle prove.
Premessa.
Sul numero precedente di questa rivista -maggio 2000- sono stati pubblicati, a ricordare la
nascita del teatro di contraddizione, un articolo di Roberto Tessari sul primo Caligola di
Carmelo Bene, che è del 1959, e un colloquio con Claudio Remondi sulla sua Moschetta ancora
del 1959. Ci è sembrato importante riportare alla memoria quella data dal momento che la
nostra impostazione di discorso, per ciò che riguarda il teatro del secondo novecento italiano,
non è certo equivoca né equivocabile. Dalla stessa matrice ideale nasce l’idea di voler
documentare alcuni degli eventi di quel teatro che a noi paiono fondamentali e basilari. E così
abbiamo iniziato, senza dare volutamente un ordine cronologico preciso a questo progetto, da
Aspettando Godot (1964) del Teatrostudio.
A nostro parere, e a quasi quarant’anni da quegli eventi, si impone la necessità di salvarne
la memoria storica attraverso documenti di vario genere: ed è per questo che ci proponiamo di
metterci al servizio di questo teatro che abbiamo amato -e che continuiamo a amare nelle sue
non numerose attuali manifestazioni- perché non se ne disperda del tutto la memoria. Dal
momento che così sembrerebbe dovesse avvenire visto che il teatro di contraddizione,
conosciuto da pochi per motivi oggettivi e amato da pochissimi per ragioni non difficili a
spiegarsi, è risultato certamente perdente sulla piazza del mercato (dove, ci ricorda Pound, tò
kalón verrà giudicato) là dove si sono affermati, negli stessi anni, prima il teatro di regia -che
vuol poi dire il teatro degli Stabili e cioè il regno del conformismo naturalistico e del testo
letterario “a monte” (dice bene, anche se non ‘bello’, Carmelo Bene)- e, poco più tardi, il
teatro che si definisce “terzo” al cui simbolismo naturalistico, con tanto di ormai ineluttabile
“uso del corpo” non stranamente mischiato a istanze misticheggianti, aderisce la quasi totalità
dei gruppi di giovani che si definiscono, e vengono definiti, ‘sperimentali’. Nulla di
‘sperimentale’, in questo senso, nel teatro di contraddizione, ma solo vero e grande teatro (e si
veda ciò che dice quello spettatore particolare, che fu anche il patrocinatore di quello
spettacolo che qui si prende in considerazione, che è Luigi Squarzina, regista sì ma anche, e
per lunghi anni, docente universitario): quel vero e grande teatro che solo personalità
eccezionali possono realizzare al di là delle istanze miserabilmente democraticistiche di chi
vorrebbe che tutti potessero fare gli attori. La confusione tra neoavanguardia letteraria (il
“Gruppo 63”) e neoavanguardia teatrale in cui verrebbe compreso questo tipo di teatro è
ancora viva e, in qualche modo, e per ora, consegnata alla storia: questo renderà necessaria,
prima o poi, una revisione anche delle operazioni critiche che sono state condotte in questa
direzione. Se le considerazioni appena fatte sono vere, come sono vere, si impone una critica
della critica sul teatro di contraddizione che serva a mettere in luce quale sia stato l’apporto
dell’attività esegetica nello spostare nell’alveo dell’avanguardia ciò che come tale non era
nato e che con quella aveva semmai solamente coincidenze formali. E questo potrebbe essere
un buon motivo per incominciare a scrivere quella storia della critica che, materia addirittura
statutaria per ciò che riguarda la letteratura, è ancora poco praticata per ciò che riguarda la
storia del teatro.
g.l.
Introduzione.
Lo spettacolo che qui si prende in esame è Aspettando Godot recitato dal gruppo
Quartucci a Genova il 31 marzo 1964. I materiali raccolti sono di diverso tipo: innanzi tutto
il programma di sala, firmato da Carlo Quartucci ma che sappiamo dai colloqui qui
pubblicati essere il frutto di un lavoro almeno in parte collettivo, poi le recensioni più
importanti alla recita genovese, quindi i colloqui con i protagonisti di quell’evento (Sudano,
Quartucci, Remondi, Grassini) e con due testimoni del tutto particolari (Squarzina e Gialli),
trascritti seguendo l’ordine dei nostri incontri con loro; infine una serie di fotografie che in
parte vennero scattate durante le prove della recita e in parte documentano lo spettacolo così
come andò in scena. Non ci è stato purtroppo possibile incontrare Leo de Berardinis.
Completa la documentazione una cronologia del teatro di contraddizione che ha la
funzione di collocare ciò che qui presentiamo in una prospettiva di possibile indagine più
ampia. Abbiamo scelto di fermare per ora la cronologia al 1967, e cioè all’anno in cui si è
svolto quel Convegno di Ivrea che è stato per molti aspetti un momento di svolta nella storia
del teatro di contraddizione e dei suoi protagonisti.
***
La scelta dell’oggetto dei propri studi, come dei propri interessi, non è ovviamente mai del tutto
casuale. Ancor meno lo è in questa circostanza, dal momento che l’individuazione del percorso di
ricerca che qui si intende avviare comporta già di per sé l’assunzione di un punto di vista molto
particolare, evidentemente voluto.
1. Maria Grazia Grassini, Claudio Remondi, Rino Sudano, Leo de Berardinis.
Scegliere questo Aspettando Godot significa decidere di porre l’attenzione su un modo di
concepire il teatro che, apparentemente in posizione quasi defilata o addirittura in conflitto
rispetto alla tradizione della scena italiana, ne costituisce in realtà l’autentica e più profonda
continuazione, ricollegandosi per un verso alla scuola del teatro d’attore -e del grand’attore
in particolare- e per un altro agli esperimenti registici più interessanti del primo novecento
italiano, da Ricciardi a Bragaglia. Significa scegliere di concentrarsi su un evento che è stato,
insieme a pochi altri, uno dei punti di partenza di un percorso estremamente ricco e
affascinante, quello del teatro di contraddizione, che, oltre ai lavori realizzati negli anni
sessanta da Carmelo Bene, da Mario Ricci e ovviamente dallo stesso gruppo Quartucci,
dischiuderà di lì a poco le strade a esperienze altrettanto interessanti e ricche, come quella di
Leo de Berardinis e Perla Peragallo, di Rino Sudano e Anna d’Offizi, di Claudio Remondi e
Riccardo Caporossi, dello stesso Carlo Quartucci insieme a Carla Tatò, e poi ancora di Carlo
Cecchi, il cui lavoro, pur se di poco successivo, si pone per molti aspetti in contiguità con
quei percorsi. Esperienze dopo le quali, al di là di alcune isolate eccezioni (per esempio il
teatro di Santagata e Morganti), non si è avuto praticamente più nulla di paragonabile tanto
per il rigore quanto per l’intensità della poetica espressa.
A chi studierà con maggiore distanza storica questo passaggio chiave delle vicende del
teatro del novecento il compito di comprendere perché proprio nel momento in cui si
manifestava l’eccezionale forza artistica di que-sti attori, proprio in quel punto si è interrotta
una linea di continuità -quella a cui facevamo riferimento più sopra- senza che nello stesso
tempo si determinasse né una continuazione in attori più giovani né, tanto meno, una
“scuola”, intendendo questo termine nella sua accezione più nobile e alta.
2. Rino Sudano, Leo de Berardinis.
Una prima risposta, a cui però ne dovranno seguire delle altre, più circostanziate e
contestuali, è che la “società dello spettacolo”, quella di cui scriverà con estrema lucidità
Guy Debord pochi anni più tardi ma che proprio in quel torno di tempo stava prendendo
forma, ha reso nella sostanza molto difficile se non impossibile il rivelarsi di ciò che pertiene
alla grandezza, in ogni sua forma. Avvicinarsi a quel teatro significa anche perciò esperire,
come può farlo lo storico -e lo storico del teatro in specie, che è anche un particolarissimo
spettatore di ciò che studia- la grandezza che è propria dell’arte, seppure di quella
particolare forma d’arte, di contraddizione appunto, che si è manifestata e si manifesta in
forme lacerate e disarmoniche.
Significa infine, e forse prima di ogni altra cosa, compiere una scelta di gusto. Scelta che,
al di là del luogo comune che vorrebbe la relatività di ogni giudizio di questo tipo, comporta
invece, per ciò che riguarda l’arte, una qualche forma di oggettività. La scelta di gusto,
infatti, così come implica un giudizio, allo stesso modo lo pretende; ambisce a staccarsi dal
puro e semplice soggettivismo, pur restando intimamente legata alle determinazioni e alle
pulsioni del soggetto (“In deciso contrasto con il normale ideale di scienza, -scriveva Adorno
con grande nitore- l’oggettività della conoscenza dialettica ha bisogno di più, non di meno
soggetto, altrimenti l’esperienza filosofica s’immiserisce”).
3. Rino Sudano, Leo de Berardinis.
La scelta di gusto esprime così un valore e un senso, coincidendo o comunque facendo parte
di uno sguardo complessivo sulle cose -non solo sulle cose dell’arte ovviamente- che non si
pone come semplice opinione, una fra le altre cioè, ma si presenta heideggerianamente come
un discorso, seppure dotato di sue specifiche caratteristiche.
È dunque anche una precisa scelta di gusto che ci ha portati a questo spettacolo. Il che,
detto qui in estrema sintesi, significa innanzi tutto vicinanza a quelle scelte poetiche e
stilistiche (a quella sensibilità, a quei toni, a quei colori, a quella nettezza di tratto...); più in
generale, a un modo di frequentare il teatro che si inserisce di fatto nella grande tradizione
della scena italiana ed europea. Tanto dal punto di vista della recitazione, con quei richiami
impliciti per esempio a Petrolini, come è stato notato da alcuni spettatori, e per altri versi a
una certa tradizione scenica che ha fatto dire a Squarzina di aver trovato per nulla “strano”
quel modo di recitare Beckett, sia perché “giusto” per Beckett, sia perché in fondo non
estraneo alla tradizione o meglio a uno dei filoni della tradizione del teatro italiano. Tanto
dal punto di vista della concezione registica nel suo insieme, con quel considerare l’evento
teatrale un’opera della scena in cui confluiscono e si integrano perfettamente in un gioco di
rimandi reciproci i vari codici linguistici. Un’opera complessiva, che in questo senso può
richiamare per esempio alcuni aspetti del lavoro di Mejerchol’d, frutto di una particolare
sinergia fra regista e attori, ciascuno espressione di un unico raffinatissimo progetto di
poetica teatrale.
4. Maria Grazia Grassini, Carlo Quartucci, Rino Sudano, Claudio
Remondi, Leo de Berardinis, Mario Rodriguez.
Infine la vicinanza per un’opera “di contraddizione” che fa del rifiuto del teatro così
com’è -della sua falsità e del suo pacificante ruolo di semplice intrattenimento- e della
centralità di un lavorìo sul linguaggio mai fine a se stesso la propria più autentica ragione
d’essere.
***
Consapevoli che la poetica esplicita di un artista è spesso altra cosa rispetto alla poetica
implicita dell’opera, ma persuasi anche di quanto siano preziose nel lavoro di ricostruzione
storica ed esegetica di uno spettacolo le testimonianze dirette di un teatrante, proponiamo
qualche nota di riflessione sul materiale raccolto che prende l’avvio proprio da alcune
affermazioni dei protagonisti di quella recita.
- “Se non incontravamo Beckett noi non avremmo scoperto nessuna forma teatrale nuova,
assolutamente […] nessun modo di essere in teatro” (Rino Sudano).
Se l’espressione “per fare Shakespeare bisogna essere Shakespeare” dice in forma di
paradosso uno dei nodi essenziali del complesso rapporto fra linguaggio della scena e
scrittura drammatica, la pressione di un fatto artistico come quello qui preso in esame rivela
poi un altro aspetto della questione, al primo dialetticamente congiunto: l’essere non è già
dato, ma, talvolta, si dà e si matura nell’incontro delle forme espressive. Accade infatti
talvolta che sia proprio il confronto autentico con una particolare scrittura drammatica a
segnare in profondità il percorso artistico di un teatrante (attore o regista che sia) tanto da
contribuire alla definizione della sua identità stilistica e poetica, infine, del suo essere.
5. Leo de Berardinis, Claudio Remondi, Maria Grazia Grassini, Rino Sudano.
Qualora poi la scrittura drammatica sia di un certo tipo, di quel tipo cioè che si pone nei
confronti del linguaggio della scena del proprio tempo con la precisa intenzione di incidere
su di esso, di influenzarlo e di metterlo in discussione, il rapporto dialettico con essa non
potrà che incidere nel senso di un’autentica trasformazione del linguaggio della scena: nel
novecento fu, almeno in parte, il caso di Brecht, di certo Pirandello e di certo Majakovskij e
poi, soprattutto, di Beckett. Proprio per la radicalità, il rigore assoluto e la profondità con cui
penetra nell’inferno del mondo (a noi) contemporaneo e del suo linguaggio, la scrittura di
Beckett costringe chi la frequenta autenticamente a un altrettanto radicale confronto con la
complessità delle problematiche ch’essa pone in campo e, in qualche modo e a qualche
livello, ad assumersene la responsabilità.
Beckett fu per il gruppo Quartucci (e le parole di Sudano, ma non solo le sue, sono lì a
testimoniarlo) l’incontro determinante: un pensiero (“tutto il pensiero di Beckett” come
afferma il programma di sala dello spettacolo), un linguaggio, un modo di essere nell’arte
che segnarono in profondità un percorso artistico allora agli esordi e in ricerca di definizione.
“A me il testo piaceva da morire, senza essere preparato, senza aver conosciuto Beckett,
però era un fatto, una sensibilità che mi sono trovato e che mi sembra… Questo è… il teatro,
cioè fu per me una scoperta…” (Claudio Remondi); “se ero partito che non sapevo niente di
Beckett, poi invece proprio scenicamente me lo sono sposato... e insieme a me è stato forte
Rino che ha contribuito fortemente... e Leo... ormai eravamo in tre dentro questa cosa di
Beckett” (Carlo Quartucci).
6. Maria Grazia Grassini, Claudio Remondi, Rino Sudano, Leo
de Berardinis.
Di qui la scoperta di un modo, il loro modo, di essere in teatro, di opporsi al teatro allora
dominante con uno stile che apparve subito diverso perché a una differente idea del teatro e
dell’arte faceva riferimento: “un modo di recitare che era assolutamente... assolutamente
diverso, nuovo rispetto agli altri, a quello che si era visto” (Rino Sudano).
In un momento in cui in Italia l’opera di Beckett era ancora poco frequentata, stretta nella
lettura fatta da Esslin che l’aveva troppo frettolosamente inclusa nella generica categoria del
teatro dell’assurdo, assimilandola a drammaturgie poeticamente distanti, oppure soffocata in
un’interpretazione che insisteva a sottolineare le “risonanze tragiche” del testo senza
coglierne il lavoro sul linguaggio e la forza parodica, la recita di Aspettando Godot del 1964
e forse, ancora prima, quella di Finale di partita, rappresentano certamente un nodo
importante per la comprensione del percorso di artisti che, fin dal principio, si segnalarono
per la loro diversità anche nel modo di restituire sulla scena lo spirito della scrittura
beckettiana.
-
“Si trattava di considerare tutto il pensiero di Beckett, da intendersi però non come
sistema filosofico, ma come problematica dell’esistenza sganciata da ogni
significazione storica” (dal programma di sala). Come a dire: il profondo radicamento
dell’opera di Beckett nelle problematiche proprie dell’arte contemporanea, il suo
essere come ogni autentica opera d’arte “storiografia a se stessa inconscia, della [sua]
epoca” (Adorno, Teoria estetica) è proprio ciò che determina l’assenza nella sua
scrittura di qualunque riferimento diretto alla storia (individuale e collettiva) e,
insieme, la negazione di ogni compiuto discorso filosofico -compreso quello
esistenzialista- se non nella sua forma parodiata.
7. Leo de Berardinis, Rino Sudano.
Resta, sono ancora parole del programma di sala, il “grande gioco del teatro”: gioco in cui la
parola “dice solo quello che dice e non va oltre” (Beckett), in cui cioè ogni elemento,
situazione, dialogo, gesto vengono spogliati di qualunque nesso psicologico e razionale che
li riconduca a una totalità carica di significato. Usati come materiale grezzo, lontani
dall’essere metafora di alcunché di altro da ciò che sono, appaiono come resti di un mondo
(e di un’arte) in rovina. È il grande gioco della finzione del teatro che si rivela “espressione
dell’orrore” (Adorno), dove anche la clownerie è non solo e non tanto “veicolo scenico di
divertimento” (programma di sala), ma piuttosto espressione del non senso della condizione
umana resa come una “disperata e inutile danza di morte” (B. Schacher, Aspettando Godot in
un teatrino di legno, in “Rinascita”, 24 luglio 1965, p.30).
- Mettere in scena Beckett.
“Quindi non è gratuita una messinscena che tenga conto quasi esclusivamente di rapporti
gestici […], rapporti sonori […], rapporti spaziali” (programma di sala). Alla fedeltà allo
spirito del testo corrispose un’assoluta fedeltà alla sua lettera.
Resta qui aperta la questione se sia possibile, nel caso particolare di un’opera di Beckett,
un’autentica alternativa alla “messinscena”.
- “Beckett era uno spartito, con i suoi tempi, le sue pause, i suoi ritmi... noi restituivamo questo,
con la voce, con i gesti, con tutto” (Rino Sudano).
8. Leo de Berardinis, Rino Sudano, Claudio Remondi (sullo sfondo).
Il marcato antipsicologismo della recitazione, i bruschi e spiazzanti mutamenti di tono, di
volume e di registro delle voci, la mimica stilizzata e tipizzata, la scenografia essenziale e
astratta, l’attenzione al gioco dei chiari e degli scuri, delle linee e dei punti, tutto nella
finzione spettacolare, come testimoniano anche le recensioni e le fotografie, rispondeva a
una logica assolutamente antinaturalistica, ritmica e mai narrativa o descrittiva. Come uno
spartito, la scrittura di Beckett aveva dato i tempi: il tempo congelato e sospeso dell’attesa e i
tempi delle battute, dei gesti, delle pause che lo scandiscono in un danza, appunto, di morte,
non potendo restituirgli, pena la falsità dell’intrattenimento, il senso e la prospettiva di una
vita. Netto si evidenziava il ritmo in una scansione insieme evidentemente finta (non
naturalisticamente occultata in un flusso di cose), eppure carica di autentico pathos. La
“rabbia” di cui parla Claudio Remondi, l’“emozione” che ricorda Maria Grazia Grassini, la
“densità calda” che indica Quartucci, sono modi diversi di dire la stessa cosa, di affermare
cioè, a distanza di anni, la forza utopica di contraddire la naturalità delle cose di allora (e di
oggi) e del linguaggio dato sulla base di un gusto (“a noi piaceva quel teatro lì” Claudio
Remondi) raffinatissimo e autenticamente vissuto. Se il tarlo di parte della neoavanguardia
di quegli anni fu proprio il non aver saputo assumere la piena consapevolezza poetica che
dall’attenzione verso la forma al formalismo vuoto non c’è che un passo, ecco che questo
Aspettando Godot denuncia già il pericolo ma, insieme, offre una soluzione.
9. Rino Sudano, Leo de Berardinis.
Tutto era in quello straordinario equilibrio fra altissima formalizzazione del dettaglio e sua
concretissima e viva presenza; fra evidenza della finzione e autenticità del gioco nella
finzione; fra un teatro che mirava continuamente allo straniamento e un teatro che si
autodefiniva “emozionale”; fra melodia ed evidenza della partitura formale. Un’ “operina
musicale” (Valeriano Gialli) in cui la finzione esplicita non nega l’intensità e la “densità
calda” (Carlo Quartucci) che percorre il tutto; perché in fine -ed è qui uno dei segni che
ricollega questa ad altre autentiche espressioni dell’arte moderna-, pur nella sua forma
stilizzata, così essenziale e quasi geometrica, un’autentica intenzione parodica (e il
riferimento esplicito a Petrolini lo conferma) doveva informare di sé tutto lo spettacolo.
d.o. e a.p.
10. Di spalle: Mario Rodriguez, Leo de Berardinis, Rino Sudano; Claudio Remondi.
Cronologia (1959-1967)∗.
1959
Carmelo Bene
Compagnia Teatro
Vocazione
Caligola di Albert Camus, versione italiana di Carmelo Bene e Alberto Ruggiero;
regia di Alberto Ruggiero; scene e costumi di Titus Vossberg; attori principali:
Carmelo Bene, Antonio Salines, Flavia Milanta.
Roma, Teatro delle Arti.
La Moschetta di Angelo Beolco detto Ruzante; regia di Claudio Remondi; attori:
Claudio Remondi, Antonio Barbieri, Giulia Mongiovino, Salvatore Salomone, Piero
Lanciani.
Roma, Teatro La Tenda
6 giugno.
Compagnia Universitaria
Latino-Metronio
Aspettando Godot di Samuel Beckett; regia, scene e costumi di Carlo Quartucci;
musiche di Fabrizio Meloni; attori: Carlo Quartucci, René Monti, Maurizio Navarra,
Ernesto De Vito.
Roma, Teatro Brancaccio
settembre.
1960
Carmelo Bene
Spettacolo-concerto Majakovskij di Carmelo Bene; regia di Carmelo Bene; musiche
di Sylvano Bussotti; attore: Carmelo Bene.
Bologna, Teatro alla Ribalta.
Compagnia Universitaria
Latino-Metronio
C’era folla al castello di Jean Tardieu; regia, scene e costumi di Carlo Quartucci;
musiche di Fabrizio Meloni; attori: Carlo Quartucci, René Monti, Maurizio Navarra,
Ernesto De Vito, Celeste Benedetti, Gina Greco, Coretta Pasqualotta.
Roma, Teatro Latino-Metronio.
Compagnia Universitaria
Latino-Metronio
Noi tutti ce ne andremo di Vittorio Calvino; regia, scene e costumi di Carlo
Quartucci; musiche di Fabrizio Meloni; attori: Carlo Quartucci, René Monti,
Maurizio Navarra, Ernesto De Vito, Celeste Benedetti, Gina Greco, Coretta
Pasqualotta.
Roma, Teatro di via Gallia
marzo.
∗
La cronologia è stata compilata sulla base dei dati presenti in E. Fadini, C. Quartucci, Viaggio nel Camion dentro
l’avanguardia, ovvero la lunga cinematografia teatrale 1960-1976, Torino, Cooperativa editoriale Studio Forma, 1976; F.
Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia (materiali 1960-1976), vol. I, Torino, Einaudi, 1977; la Zattera di Babele 19811991. 10 anni di parola, immagine, musica, teatro, Firenze, Tipografia Press 80, 1991 e C. G. Saba, Carmelo Bene, Milano,
Editrice Il castoro, 1999.
1961
Compagnia
del Leopardo
Le sedie di Eugène Ionesco; regia, scene, costumi e colonna sonora di Carlo
Quartucci; attori: Claudio Remondi, Zanida Lodi, Carlo Quartucci.
Roma, Teatro Goldoni
13 aprile.
Carmelo Bene
Caligola di Albert Camus; regia di Carmelo Bene; scene di Giancarlo Bignardi;
attore principale: Carmelo Bene.
Genova, Teatro Politeama.
Compagnia T.61
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, di Carmelo Bene da Robert
Louis Stevenson; regia di Carmelo Bene; scene di Giancarlo Bignardi; attore
principale: Carmelo Bene.
Genova, Borsa d’Arlecchino.
Carmelo Bene
Tre atti unici di Marcello Barlocco; regia di Carmelo Bene; attore principale:
Carmelo Bene.
Genova, Teatro Duse.
Carmelo Bene
Gregorio: cabaret dell’800 di Carmelo Bene; regia di Carmelo Bene; scene di
Salvatore Vendittelli; attori: Carmelo Bene, Rosa Bianca Scerrino, Nino Casale,
Manlio Nevastri, Paola Faloja.
Roma, Ridotto dell’Eliseo.
Carmelo Bene
Pinocchio di Carlo Collodi; adattamento, regia, scene e costumi di Carmelo Bene;
attori principali: Carmelo Bene,
Rosa Bianca Scerrino, Gino Lavagetto.
Roma, Teatro Laboratorio.
Carmelo Bene
Amleto da William Shakespeare; regia, scene e costumi di Carmelo Bene; attori:
Carmelo Bene, Rosa Bianca Scerrino, Corrado Sonni, Luigi Mezzanotte.
Roma, Teatro Laboratorio.
1962
Compagnia
della Ripresa
Me e Me su testi di Luciano di Samosata, Jacopone, Giacomo Leopardi e Samuel
Beckett; regia, scene e costumi di Carlo Quartucci; musiche di Alvaro Galindo;
attori: Leo de Berardinis, Rino Sudano, Anna d’Offizi, Sabina de
Guida, Pier
Luigi Zolto, Carlo Quartucci, Maurizio Navarra.
Roma, Teatro Goldoni
13 ottobre.
Mario Ricci
Movimento numero uno per marionetta sola di Mario Ricci; collaboratori: Ninì
Santoro, Nato Frascà.
Roma, casa di Nello Ponente
31 dicembre.
Carmelo Bene
Spettacolo-concerto Majakovskij; regia di Carmelo Bene; musiche di Amelia
Rosselli; attore: Carmelo Bene.
Roma, Teatro Laboratorio.
Carmelo Bene
Spettacolo-concerto Majakovskij; regia di Carmelo Bene; musiche di Giuseppe
Lenti; attore: Carmelo Bene.
Roma, Teatro Laboratorio.
1963
Compagnia
della Ripresa
Finale di partita di Samuel Beckett. Una gru al tramonto di Jurij Kinoshita; regia,
scene e costumi di Carlo Quartucci; musiche di Alvaro Galindo; attori: Leo de
Berardinis, Rino Sudano, Anna d’Offizi, Cosimo Cinieri, Sabina de Guida, Carlo
Quartucci.
Roma, Teatro Ateneo
4 febbraio.
Carmelo Bene
Addio porco di Carmelo Bene; regia di Carmelo Bene; attori: Carmelo Bene, Rosa
Bianca Scerrino, Luigi Mezzanotte.
Roma, Teatro Laboratorio.
Carmelo Bene
Cristo ’63 di Carmelo Bene; regia di Carmelo
Carmelo Bene, Alberto Greco.
Roma, Teatro Laboratorio.
Carmelo Bene
Edoardo II da Christopher Marlowe; regia, scene e costumi di Carmelo Bene; attori
principali: Carmelo Bene, Luigi Mezzanotte, Michele Francis, Helen Cameron,
Giacomo Ricci.
Roma, Teatro Arlecchino.
Compagnia ABC
per un teatro migliore
Bene;
attori
principali:
I Polacchi (Ubu roi) di Alfred Jarry; regia, scene e costumi di Carmelo Bene; attori
principali: Carmelo Bene, Luigi Mezzanotte, Edoardo Torricella, Alfiero Vincenti.
Roma, Teatro dei Satiri.
1964
Mario Ricci
Compagnia Teatrostudio
del Teatro stabile
di Genova
Spettacolo di tre pezzi di Mario Ricci; collaboratori: Pasquale Santoro, Remo
Remotti.
Roma, Galleria Arco d’Alibert
gennaio.
costumi di Carlo Quartucci;
Aspettando Godot di Samuel Beckett; scene e
musiche di Leopoldo Gamberini; attori: Rino Sudano, Leo de Berardinis, Claudio
Remondi, Maria Grazia Grassini, Mario Rodriguez.
Genova, Teatro Duse
31 marzo.
Carmelo Bene
Salomé di e da Oscar Wilde; regia di Carmelo Bene; scene di Salvatore Vendittelli;
costumi di Carmelo Bene; attori principali: Carmelo Bene, Rosa Bianca Scerrino,
Alfiero Vincenti, Franco Citti.
Roma, Teatro delle Muse.
Carmelo Bene
La storia di Sawney Bean di Roberto Lerici; regiascene e costumi di Carmelo Bene;
attori principali: Carmelo Bene, Lydia Mancinelli, Luigi Mezzanotte.
Roma, Teatro delle Arti.
Carmelo Bene
Manon dal romanzo dell’Abate Prévost; regia,scene e costumi di Carmelo Bene;
attori: Alfiero Vincenti, Rosa Bianca Scerrino, Lydia Mancinelli.
Roma, Teatro Arlecchino.
Mario Ricci
Movimento per marionetta sola numero due di Mario Ricci in collaborazione con
Gastone Novelli. Movimento uno e due di Mario Ricci.
Roma, Teatro Orsoline 15
26 dicembre.
1965
Mario Ricci
Movimento uno e due (nuova versione) di Mario Ricci. A di Gianni Novak. Pelle
d’asino di Elio Pagliarani e Alfredo Giuliani; materiale scenico di Gastone Novelli.
Roma, Teatro Orsoline 15
febbraio.
Mario Ricci
Balletto a due di Mario Ricci in collaborazione con Franco Libertucci. Flash fiction
di Mario Ricci. Por no di Achille Perilli; materiali scenici di Achille Perilli; regia di
Marcello Aste.
Roma, Teatro Orsoline 15
maggio.
Compagnia del Teatro
Universitario di Genova Cartoteca di Tadeusz Rosewicz; immagini fotografiche e filmiche, diapositive, colonna
sonora, scene e costumi del collettivo universitario; attori: studenti, gente di strada,
filodrammatici del circolo Italsider di Genova (complessivamente trenta persone).
Genova, Teatro della Fiera del Mare
20 maggio.
Compagnia del
Teatro della Ripresa
Compagnia del
Teatro della Ripresa
Festival di Samuel Beckett (Aspettando Godot, Finale di partita, Atto senza parole
II); regia, scene e costumi di Carlo Quartucci; attori: Leo de Berardinis, Rino Sudano,
Cosimo Cinieri, Maria Grazia Grassini, Sabina de Guida, Anna d’Offizi.
Roma, Teatro Mobile al chilometro 13 della via Flaminia
16 luglio.
Furfanti di Gaetano Testa. Gioco con la scimmia di Enrico Filippini. I sigari di
Jupiter di Germano Lombardi; regia di Carlo Quartucci; scene e costumi di
Emiliano Tolve; musiche di Vittorio Gelmetti; attori: Leo de Berardinis, Rino
Sudano, Claudio Remondi, Cosimo Cinieri, Edoardo Torricella, Luigi Castejon,
Giampiero Fortebraccio, Sabina de Guida, Anna d’Offizi, Maria Grazia Grassini.
Palermo, Teatro Biondo
settembre.
Compagnia Teatrostudio
del Teatro stabile
di Genova
Zip Lap Tip Vap Mam Crep Scap Plip Trip Scrap e la Grande Mam di Giuliano
Scabia e Carlo Quartucci; regia di Carlo Quartucci; scene e costumi di Emanuele
Luzzati; film di Romano Scandini; diapositive di Giorgio Bergami e Giancalo
Bignardi; attori: Leo de Berardinis, Rino Sudano, Claudio Remondi, Cosimo Cinieri,
Edoardo Torricella, Luigi Castejon, Giampiero Fortebraccio, Sabina de Guida, Anna
d’Offizi, Maria Grazia Grassini, Mirella Falco.
Venezia, Teatro del Ridotto
30 settembre.
Mario Ricci
Varietà di Mario Ricci. Tanto fragili non si entra nell’ufficio del capitano di
Giuliano Zincone.
Roma, Teatro Orsoline 15
dicembre.
1966
Carmelo Bene
Compagnia
Filodrammatica
dell’Italsider
Mario Ricci
Faust o Margherita di Carmelo Bene e Franco Cuomo; regia di Carmelo Bene;
scene di Salvatore Vendittelli; costumi di Carmelo Bene; attori: Carmelo Bene,
Lydia Mancinelli, Mario Tempesta, Piero Vida, Angela Angelucci, Manuela
Kustermann, Valeria Nardone, Rosaria Vadacea.
Roma, Teatro dei Satiri
4 gennaio.
La mucca parlò a Pasquale spettacolo collage su testi di Ruzante, Plauto,
Aristofane, Brecht, Cervantes, Rabelais, Pirandello, Mrozek; regia di Carlo
Quartucci; scene e costumi di Giancarlo Bignardi; attori: operai e impiegati dell’Italsider.
Genova, Italsider
febbraio.
Salomè di Mario Ricci; regia di Mario Ricci; materiale scenico di Claudio Previtera;
attori: Claudio Previtera. Sacrificio edilizio di Mario Ricci; regia di Mario Ricci;
materiali scenici di Corrado Cego; attori: Angela Diana, Claudio Previtera, Gabriella
Toppani, Tonino Campanelli, Deborah Hayes, Sara Di Nepi.
Parma, Festival Internazionale del Teatro Universitario
marzo.
Compagnia Teatrostudio
del Teatro stabile
di Genova
La Fantesca di Giambattista Della Porta, adattamento di Vico Faggi; regia di Carlo
Quartucci; scene e costumi di Carlo Quartucci e Giancarlo Bignardi; attori: Anna
d’Offizi, Leo de Berardinis, Maria Grazia Grassini, Maggiorino Porta, Rino Sudano,
Giorgio De Virgilis, Ennio Gagiotti, Piero Domenicaccio, Sabina de Guida, Cosimo
Cinieri, Luigi Castejon, Giampiero Fortebraccio, Sandro del Buono.
Genova, Teatro Duse
5 maggio.
Teatro Gruppo
Il giornale a pista centrale, spettacolo per attori, pupazzi, burattini e immagini
cinefotografiche su testi di Garcia Lorca, Brecht, Calvino, Rabelais; dispositivo
scenico e materiale cinefotografico di Carlo Quartucci, Giancarlo Bignardi e Giorgio
Bergami; musica di Renato Falavigna; attori: Marco Parodi, Piero Domenicaccio,
Giampiero Fortebraccio, Carlo Quartucci.
Genova, Teatro del Parco di Nervi
31 agosto.
Carmelo Bene
Pinocchio ’66 da Carlo Collodi; regia di Carmelo Bene; attore principale: Carmelo
Bene.
Roma, Teatro Centrale.
Carmelo Bene
Il rosa e il nero, invenzione da Il monaco di M. G. Lewis; regia di Carmelo Bene;
scene di Salvatore Vendittelli; costumi di Carmelo Bene; musiche di Sylvano Bussotti e
Vittorio Gelmetti; attori: Carmelo Bene, Maria Monti, Lydia Mancinelli, Silvano
Spadaccino, Ornella Ferrari, Max Spaccialbelli, Rossana Rovere.
Roma, Teatro delle Muse
12 ottobre.
Mario Ricci
I viaggi di Gulliver di Mario Ricci (da Jonathan Swift); regia di Mario Ricci; scene
di Claudio Previtera; attori: Deborah Hayes, Sabina de Guida, Angela Diana,
Claudio Previtera, Tonino Campanelli, Piero Panza.
Roma, Teatro Orsoline 15
18 ottobre.
Carmelo Bene
Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene; regia di Carmelo Bene; attori: Carmelo
Bene, Lydia Mancinelli, Margherita Puratich.
Roma, Teatro Beat 72
1 dicembre.
Teatro Gruppo
Libere stanze (Il gioco dei quattro cantoni – Un fatto di assassinio) di Roberto
Lerici; regia di Carlo Quartucci; scene e costumi di Giancarlo Bignardi; musiche di
Oscar Prudenti e Renato Falavigna; attori: Edoardo Torricella, Giampiero
Fortebraccio, Roberto Vezzosi, Laura Panti, Rachele Ghersi, Nestor Garay, Cosimo
Cinieri, Piero Domenicaccio, Antonio Manganaro.
Torino, Teatro Gobetti
4 dicembre.
Teatro Gruppo
Intervento al Piper di Torino di Carlo Quartucci e Roberto Lerici; attori: Edoardo
Torricella, Roberto Vezzosi, Giampiero Fortebraccio, Laura Panti, Rachele Ghersi,
Nestore Garay, Cosimo Cinieri, Piero Domenicaccio, Antonio Manganaro.
Torino, Piper
dicembre.
Teatro Gruppo
Letture-spettacolo per la storia del teatro contemporaneo (Vitrac, Dada e i
surrealisti, Teatro di guerriglia spagnolo, espressionismo, Teatro della crudeltà,
Teatro del New Deal); regia, scene e costumi di Carlo Quartucci; attori: Laura Panti,
Marco Parodi, Giampiero Fortebraccio, Piero Domenicaccio, Roberto Vezzosi, Luigi
Castejon.
Torino, Unione culturale
inverno ’66 / giugno ’67.
1967
Compagnia
Filodrammatica
dell’Italsider
George Dandin di Molière; regia di Carlo Quartucci.
Genova, Italsider.
Carmelo Bene
Amleto o le conseguenze della pietà filiale da William Shakespeare e Jules
Laforgue; regia di Carmelo Bene; attori: Carmelo Bene, Adriano Bocchetta, Pietro
Napolitano, Pino Prete, Andrea Moroni, Luigi Mezzanotte, Edoardo Florio, Carla
Tatò, Lydia Mancinelli, Margherita Puratich, Manlio Nevastri.
Roma, Teatro Beat 72
marzo.
Teatro Gruppo
A proposito del Teatro della crudeltà su testi di Jarry, Artaud, Genet, Weiss; regia e
impianto scenico di Carlo Quartucci; attori: Laura Panti, Marco Parodi, Saviana
Scalfi, Vittorio Artesi.
Palermo, Teatro Club
14 marzo.
Carmelo Bene
Salvatore Giuliano, vita di una rosa; regia di Carmelo Bene; attori: Lydia Mancinelli,
Carla Tatò, Luigi Mezzanotte.
Roma, Teatro Beat 72
aprile.
Mario Ricci
Edgar Allan Poe di Mario Ricci; regia di Mario Ricci; scene di Claudio Previtera;
attori: Sabina de Guida, Angela Diana, Sara di Nepi, Deborah Hayes, Tonino
Campanelli, Claudio Previtera.
Roma, Teatro Orsoline 15
maggio.
Teatro Gruppo
Majakovskij & C. alla rivoluzione d’ottobre; montaggio scenico a cura di Ettore
Capriolo, Edoardo Fadini, Roberto Lerici, Marco Parodi e Carlo Quartucci; regia di Carlo
Quartucci; elementi scenici di Magdalo Mussio; consulenza musicale di Luigi
Pestalozza; attori: Laura Panti, Roberto Vezzosi, Marco Parodi, Piero Domenicaccio,
Luigi Castejon, Massimo Castri, Nestor Garay.
Torino, Teatro Alfieri
30 settembre.
Mario Ricci
Illuminazione di Nanni Balestrini; regia di Mario Ricci; scene di Giancarlo Bignardi;
attori: Deborah Hayes, Angela Diana, Claudio Previtera, Marilù Gleyeses, Vivian
Lombroso, Tonino Campanelli, Franco Cataldi, Marco Romizi.
Roma, Teatro alla Ringhiera
26 ottobre.
Claudio Remondi
Voulez vous jouer avec moi? di Marcel Achard; regia di Claudio Remondi e Renato
Frontini; scene e costumi di Silvana Silvestri; attori: Francesco Gerbasio, Federica Giulietti,
Marcel Rayez, Claudio Remondi.
Roma, Teatro del Leopardo
4 novembre.
Claudio Remondi
Una cronaca borghese – Come una rondine – I figli di Dio di Renato Frontini; regia di
Claudio Remondi e Renato Frontini; attori: Marina Yaru, Federica Giulietti, Claudio
Remondi, Marcel Rayez, Gianfranco Mazzoni, Guido Garfin.
Roma, Teatro del Leopardo
29 dicembre.
11. Maria Grazia Grassini, Leo de Berardinis, Claudio Remondi, Rino
Programma di sala:
Note di regìa
Proporre oggi un testo di Beckett, soprattutto Aspettando Godot, oramai gia
«ufficializzato», dovrebbe significare L’apertura di un discorso non limitato al testo in
questione, ma comprendente tutta la tematica beckcttiana.
Questo ha tentato di fare la regia; si trattava di considerare tutto il pensiero di Beckett,
da intendersi però non come sistema filosofico, ma come problematica dell’esistenza
sganciata da ogni significazione storica. Quindi non è gratuita una messinscena che tenga
conto quasi esclusivamente di rapporti gestici (le complementarietà di Vladimiro-Estragone
da una parte, Pozzo-Lucky dall’altra, risolte in complementarietà figurative: Vladimiro una
linea che avvolge il corpo di Estragone tendente ad atteggiarsi come massa, e legame di
forze fisiche in continuo contrasto per Pozzo e Lucky), rapporti sonori (i personaggi
cambiano voce tenendo conto di compensi e scompensi ritmici) e rapporti spaziali
(scenografia non indicativa di ambienti, ma evocativa di zone mentali, l’unico luogo
rappresentante l’esistenza). Non troviamo altra estrinsecazione che questa in termini teatrali,
dei concetti di tempo e spazio del pensiero dell’autore.
Per «mostrare» allo spettatore questo pensiero si è creduta necessaria una presa estetica
e non «dell’anima », una finzione (di emotività di carattere puramente teatrale: che però non
restasse tale ma fosse recuperabile razionalmente. Ed è per questo che si è tentato di agire in
modo che il comportamento da clown degli attori non si esaurisse solo come veicolo scenico
di divertimento atto a rendere più agevole la tematica di Beckett, ma si considerasse anche
come condizione umana in quanto l’uomo beckettiano è espressione di formule fisse stantie,
di luoghi comuni vecchi di secoli nella fissità della maschera clownesca.
CARLO QUARTUCCI
Di Beckett e di Godot
Rien ne se passe, personne ne vient,
personne s’en va, c’est terrible.
Perchè Beckett. perché a « Godot »? La domanda è retorica. Bisognerebbe chiedersi,
semmai, perché la commedia (testo chiave della « drammaturgia dell’assurdo », sia come
dichiarazione, implicita, di poetica, sia come realizzazione, inequivoca, di poesia) non sia
giunta prima al pubblico genovese. Nel frattempo la pièce ha fatto il giro del mondo e, strada
facendo, ha raccolto una messe di definizioni: « _I pensieri di Pascal messi in scena dai
Fratellini » (Anouilh), « Farce métaphysique » (Rosette Lamont), « L’humour et le néant a
(Maurice Nadeau), «Una lucida testimonianza sul nulla » (Alfonso Sastre).
« En attendant Gadot » è, secondo una prima approssimazione, il dramma dell’attesa.
Due vagabondi aspettano Godot, che non appare, e la loro attesa, intrisa di noia e
disperazione, è eterna. Ricordiamo che in un racconto di Kafka, anteriore al 1919, si narra di
un campagnolo che attende, per giorni e settimane e anni, pazientemente attende di « entrare
nella legge »; sicché, nel momento della morte, il guardiano gli comunica che l’ingresso
destinato a lui viene chiuso per sempre. Il racconto è indubbiamente (per non parlare del «
Castello ») una delle fonti della commedia di Beckett. L’attesa di Vladimniro ed Estragone è
dunque attesa della morte? Godot è la morte?
Nessuno può rispondere con certezza. « Avessi saputo chi è Godot - ha detto Beckett l’avrei detto nella commedia ». Possiamo fare delle ipotesi, nell’ordine del verosimile.
Vladimiro ed Estragone attendono non soltanto la liberazione dalla vita, ma anche la
rivelazione di un significato della vita, e dunque Godot è qualcosa di più della morte. Godot
è la legge, la salvezza, la speranza cui l’uomo non può rinunciare. E’ Dio? Forse, ma un Dio
lontano e irraggiungibile, sordo e indifferente.
L’opera di Beckett è aperta a molteplici prospettive. Vladimiro ed Estragone aspettano
Godot; ma se Godot fosse già venuto? senza che gli uomini, per loro colpa, se ne
accorgessero? Ecco i lineamenti di una interpretazione cristiana, che è stata proposta da
Charles Mc Coy. Ma l’esegesi del testo consente anche di rovesciare la conclusione: la
funzione di Godot — scrive Eva Metman, seguace di Jung — è quella di mantenere
nell’incoscenza gli uomini che dipendono da lui; e la speranza in Godot è l’ultima illusione
che impedisce a Vladimiro ed Estragone di affrontare la condizione umana e se stessi, nella
luce della coscienza. Non è questo, probabilmente, che Beckett voleva dirci, e non è questo
che ci ha detto: ma l’interpretazione della Metman mette il dito sulla piaga, voglio dire sulla
Weltanschauung dello scrittore irlandese.
Al centro della scena sorge un albero. Ancora un simbolo ambiguo. E’ l’albero della
vita, è la croce, o un patibolo? In un paesaggio vuoto, presso l’albero, si svolge la vicenda (o
non-vicenda) della commedia. Vladimiro ed Estragone, gli uomini cime attendono Godot,
che discutono del nulla, che ingannano con le parole l’angoscia e l’assurdità dell’esistenza,
non sono che due clochards, due clowns irresistibili: con la loro bombetta, le scarpe
sfondate, la mimica e i capitomboli, i calambours e le ripetizioni, e tutte le risorse del circo e
del music-hall. Quest’incontro di farsa e filosofia ha, di per sè, un significato: l’uomo è
caduto tanto in basso, i suoi gesti sono così inetti e futili, che la reazione più appropriata è il
riso.
I due clochards si sono detti tutto, ognuno conosce tutto, sino i pensieri del’altro; e la
noia, il fastidio di vedersi, il desiderio di cambiare inducono all’idea della separazione. Ma
separarsi non possono, perchè sono uniti da una solidarietà profonda, toccante, cioè dal
riconoscimento del comune destino. Nec tecum nec sine te, secondo il paradossale rapporto
che congiunge, più indietro, i coniugi strindberghiani di Danza di morte.
Alla solidarietà che unisce Vladimiro ed Estragone si contrappone il rapporto tra Pozzo e
Lucky, che costituisce un altro dei motivi (forse il più arduo) di ambiguità della commedia.
Pozzo è il padrone, Luckv lo schiavo. Quello lo sfruttatore, questo lo sfruttato. Nel primo
atto forte e trionfante, Pozzo nel secondo è cieco e debole, indifeso. Ma Lucky è sempre con
lui, sempre schiavo. Chi è, veramente, Lucky? Par certo che Beckett abbia voluto
contrapporre la solidarietà di Vladimiro ed Estragone al legame sado-masochistico che
unisce Lucky a Pozzo. L’avvilente rapporto da padrone a schiavo — ha scritto Leonard C.
Pronko — riduce sia Pozzo sia Lucky alla animalità e all’impotenza. Ma perché Vladimiro
ed Estragone, che sono più consapevoli e umani, non aiutano Lucky a liberarsi? Perché
aiutano, invece, Pozzo? Forse perchè sono, come qualcuno ha proposto, l’immagine della
piccola borghesia che non sa prendere posizione nella lotta di classe? Ma altri ha voluto
indentificare in Lucky l’uomo crocefisso di fronte a testimoni indifferenti. E altri ha visto in
Pozzo e Lueky il simbolo del corpo e dell’anima e della loro inscindibile unione. Altri
ancora ha supposto in Lucky e Pozzo la raffigurazione di un cieco attivismo, che li oppone
alla passiva attesa di Vladimiro ed Estragone: due modi, insomma, di concepire e affrontare
la vita, diversi ma ugualmente insensati, posto che la vita per Beckett non ha senso.
VICO FAGGI
TEATRO STABILE DI GENOVA
TEATROSTUDIO
Sotto l’insegna « Teatro-studio », il Teatro Stabile di Genova inizia quest’anno
un’attività di ricerca sia nell’ambito della drammaturgia (repertorio) sia nell’ambito dei
mezzi espressivi scenici (regia, recitazione, scenografia): un’attività collaterale a quella primaria, ma in nessun modo e minore o né per importanza né per cura di allestimenti, come
vuole dimostrare la rappresentazione di Aspettando Godot.
Definita da Brecht e da Sartre come la più importante commedia scritta nel dopoguerra,
la grande clownerie di Beckett ha proposto a un intera leva di autori, registi, scenografi e
attori un modo diverso di fare teatro. Quantunque la nostra ricerca non sia orientata esclusivamente né precipuamente in questa direzione, il fatto che Aspettando Godot sia una novità
assoluta per Genova (dove pure ebbe vita non breve il gruppo della o Borsa di Arlecchino »
cui si devono a]cune importanti prime rappresentazioni italiane del e teatro dell’assurdo o) ci
ha persuasi non poter esservi occasione migliore per iniziare l’attività del « Teatrostudio ».
Carlo Quartucci e i suoi compagni costituivano un gruppo di lavoro ben affiatato anche
prima di essere scritturati a Genova, dove alcuni di loro sono apparsi in Corte Savella e in
Danza di morte e dove Quartucci insegna Teoria e Tecnica del movimento alla Scuola
d’Arte Drammatica; essi hanno al loro attivo l’allestimento a Roma di uno Jonesco (Le
sedie) e di un Beckett (Finale di partita) lodati dalla critica.
*
Stagione 1963-1964
Recensioni∗ .
T. Viziano, Teatro Sperimentale dello Stabile Genovese, in “Il lavoro nuovo”, 27 marzo 1964.
Siamo stati, in questi giorni, ad assistere ad alcune prove della Compagnia del Teatro Sperimentale dello Stabile
Genovese. Tale Compagnia, formata di giovani dagli assunti ben chiari e precisi, fu notata, a suo tempo, a Roma mentre
rappresentava “Fin de partie” di Samuel Beckett, dal regista Luigi Squarzina il quale, appunto, la indicò allo Stabile di
Genova. Ed il loro primo lavoro “genovese” andrà in scena il 31 di questo mese e sarà, sempre di Beckett, “En attendant
Godot”.
Potrebbe sembrare, a tutta prima, che Carlo Quartucci, il regista del gruppo, e gli attori Leo de Berardinis, Rino
Sudano, Maria Grazia Grassini, Claudio Remondi, vogliano specializzarsi in autori teatrali contemporanei. La loro scelta
ha, invece, un respiro assai più vasto e vuole utilizzare quei testi, di qualsiasi epoca essi siano, che si appuntano sulla
condizione totale ed universale dell’uomo.
Non drammi psicologici o sociali che si centralizzino e limitino la loro visuale a fattori di carattere tipologicoindividuale o di natura temporale, quindi.
La preferenza data a Beckett quale primo autore da presentare, oltre che derivare da questo impegno, trova la sua
spiegazione dal fatto che questi si presti sommamente ad una rappresentazione affatto di tipo natural-veristico; e che sia
“En attendant Godot” piuttosto che qualsiasi altro lavoro di Beckett dal fatto che questo testo, meglio di ogni altro,
riassume tutta quanta la produzione del drammaturgo irlandese.
Del resto gia [sic] la stessa scenografia, ideata da Quartucci, elimina ogni identificazione ad un preciso paesaggio,
mentre con le sue linee costantemente curve, chiuse, senza possibilità d’aperture, suggerisce la rappresentazione del
mondo.
La figura fisica degli attori viene ad essere circolare essa stessa, complementare l’una all’altra: la coppia VladimiroEstragone, Vladimiro alto e magro, solitamente inarcato all’indietro, Estragone più basso e robusto, piegato in avanti; la
coppia Pozzo-Laki [sic], la figura di Pozzo ritta e in movimento, quella di Laki come quella di Estragone, ma ancora più
inerte e inespressiva.
Ed insieme Vladimiro, Estragone, Pozzo, Laki non sono la rappresentazione di personaggi psicologicamente definiti,
ma di tutta quanta un’umanità. In questo senso va valutato il loro continuo cambiamento di toni di voce, e la loro
recitazione clownesca perché tale per Beckett viene ad essere la condizione dell’uomo, svuotato d’ogni individualità da
un bagaglio di tradizioni borghesi che gli impediscono, col vuoto di frasi fermate nel tempo, una propria personalità,
piegato da una sorta di fatalità che rende maggiormente impossibile, anche perché dolorosa, ogni presa di coscienza. E
l’uomo è fermo in una immobilità senza senso, atemporale, nell’ansia di un’attesa vana d’un padrone invisibile ed
inaccessibile, quale potrebbe essere Godot. Appunto per questo il ragazzo (interpretato da Mario Rodriguez) che dovrebbe
servire da legame tra l’uomo che aspetta Godot e Godot stesso, è stato reso da Quartucci, ora buono ora cattivo e sempre
inspiegabilmente, perché ogni determinazione di Godot è impossibile come impossibile la certezza della sua esistenza.
Queste poche parole, senza altro insufficienti ad un discorso puntuale sia sul testo Beckettiano che sulla Compagnia
che in questo lavoro si sta impegnando, vogliono servire semplicemente d’introduzione ad un discorso più ampio che si
farà sicuramente dopo che “En attendant Godot” sarà rappresentato al Duse.
O. F., I giovani dello Stabile di Genova hanno fondato il centro sperimentale, in “Stampa sera”, 29 marzo 1964.
Il “Teatro Studio”, centro sperimentale del “Duse”, inizierà la sua attività a fine mese. L’intendimento è impegnare
attori giovani, incoraggiando le loro energie. Primo testo in programma è Aspettando Godot di Samuel Beckett,
interpreti Leo de Berardinis, Grazia Grassini, Claudio Remondi e Rino Sudano, regia scene e costumi di Carlo
Quartucci. Questo gruppo di ragazzi è insieme da anni e da anni ciascuno di essi è legato agli altri da identici interessi e
problemi, d’arte e di vita. Provengono dal Teatro Universitario Romano, di qui passarono al “Goldoni” ed infine, sotto
gli auspici della “Compagnia dei Quattro”, al “Quirino”. Ora sono diventati il “centro sperimentale” dello Stabile
Genovese; hanno programmi, progetti, ambizioni e fiducia. Tema centrale di ogni loro spettacolo – durante la
precedente attività recitarono Jonesco, Jacopone da Todi, Leopardi e Beckett – è stato sempre l’uomo, beffato da forze
avverse e imprevedibili. La messa in scena non è realistica, ma vagamente surreale. Il fatto che regia, costumi e scena
sono sempre firmati da un’unica persona – Carlo Quartucci – consente di realizzare un equilibrio delle varie parti. “Il
teatro, dice Quartucci, deve essere un fatto essenzialmente umano, che affronti problemi umani. In teatro due esseri
umani discutono della loro esistenza: uno è l’attore e l’altro lo spettatore. Due sfere, due mondi: uno si assume la
responsabilità di rappresentare – e non “vivere” – un concetto della vita e l’altro di assimilare e di riflettere. Lo spettatore
passivo non deve esistere, come non deve e non può esistere l’attore che non ha in sé una coscienza umana, altrimenti
non avrebbe senso che un essere umano stia a ripetere cento, cinquecento, mille volte la stessa cosa”.
∗
Le recensioni pubblicate sono conservate presso l’Archivio del Teatro stabile di Genova.
Dopo questo testo di Beckett, le cui repliche continueranno fino a metà aprile per poi essere presentato fuori Genova,
il Centro Sperimentale allestirà Il clown in ginocchio, spettacolo che comprenderà il secondo “Atto senza parole” di
Beckett, “Bilora” del Ruzzante, “Don Perlimplino” di Garcia Lorca e “I ciechi” di Ghelderode. Parallelamente dovrebbe
concretarsi l’altra sezione del Centro Sperimentale, dedicata al Teatro Cabaret. Questa verrà affidata ad Anna Laura
Messeri, una ragazza energica e intelligente che è stata assistente di Squarzina negli spettacoli di questa stagione e che
ora insegna dizione e recitazione alla Scuola d’Arte Drammatica del “Duse”.
Vice, Aspettando Godot, in “Il lavoro nuovo”, 1 aprile 1964.
Ieri sera, al Duse, “via” ufficiale all’attività del Teatro-studio promosso dalla Stabile genovese. Il gruppo dei giovani
guidato da Carlo Quartucci ha presentato, in “prima” per la nostra città, quell’“Aspettando Godot” di Samuel Beckett in
cui si vuole vedere la più riuscita esemplificazione del teatro dell’assurdo, la più trasparente parabola di una società
disintegrata nei suoi valori e nei suoi significati. Un testo che, nella sua sequela di discorsi scuciti, di situazioni
frammentate e senza senso, di suggerimenti clowneschi, dovrebbe fotografare i mali del nostro secolo: l’inquietudine,
l’inaridimento, lo squilibrio interiore, l’incomunicabilità. Un’occasione sempre allettante, per chi intende dedicarsi ad un
lavoro di ricerca sia nel campo del repertorio che nell’ambito dei mezzi espressivi. E va dato atto a Quartucci regista e
scenografo, e ai suoi compagni interpreti, di una scelta consapevole e di uno sforzo realizzativo non comune.
Entro una dimensione scenica volutamente rarefatta (e al raggiungimento della atmosfera hanno contribuito, oltre alla
scena e ai costumi, le appropriate musiche di Gamberini), gli attori Rino Sudano (Estragone), Leo de Bernardinis [sic]
(Vladimiro), Maria Grazia Grassini (Lucky), Claudio Remondi (Pozzo), Mario Rodriguez (il ragazzo) hanno espresso,
attraverso una vasta gamma di atteggiamenti mimici e di rapporti sonori, la grottesca disarmonia dell’uomo
contemporaneo. Lo spettacolo è stato applaudito. Da stasera, repliche.
G. Striglia, Aspettando Godot arriva il Teatrostudio, in “Corriere mercantile”, 1 aprile 1964.
La sala “E. Duse” del Teatro Stabile ha ospitato ieri sera il debutto del “Teatrostudio”, o, per essere più precisi, di
quel gruppo di giovani che lo stesso Stabile ha avviato ad un’attività di ricerca, sia nell’ambito della drammaturgia
(repertorio), sia in quello dei mezzi espressivi scenici (regia, recitazione, scenografia), come afferma, del resto,
l’etichetta sociale.
Il debutto, occorre avvertirlo subito, è stato felice e positivo, non tanto per la entità del pubblico (che forse risentiva
ancora della stanchezza del piovoso “week-end” pasquale) quanto per la calorosa partecipazione con la quale i pochi
hanno accolto “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, prima realizzazione del gruppo stesso. Sono convinto però che
gli applausi siano andati tutti al regista Carlo Quartucci, autore anche delle scene e dei costumi, ed al quintetto
vivacissimo degli attori, Rino Sudano, Leo De Bernardinis [sic], Maria Grazia Grassini, Claudio Remondi e Mario
Rodriguez, che hanno dimostrato una preparazione tecnica ed una sensibilità interpretativa di gran lunga superiore al
livello, per così dire, sperimentale.
Non altrettanto gradita (e penso così di giustificare la scarsità degli spettatori) la scelta del testo. Per quanto nuova per
Genova, la “piéce” di Beckett è troppo conosciuta dagli amatori del teatro e, in particolare, dagli esperti nelle forme di
avanguardia, perché possa rappresentare, per taluni, una curiosità e per altri un motivo di grande interesse: tutti sanno
come Jonesco - tanto per fare un esempio - abbia stentato moltissimo ad entrare nel “repertorio” del pubblico genovese;
e se oggi si può dire che vi sia parzialmente riuscito, lo si deve soprattutto all’opera di ottime compagnie professionali
che l’hanno inserito, quasi a tradimento, nelle loro stagioni tra noi. Fino a tanto che Jonesco è rimasto patrimonio
esclusivo di quell’ottimo gruppo sperimentale che fu “La Borsa di Arlecchino”, la rispondenza locale fu davvero
sconfortante.
Per questo motivo, forse, volendo presentare ai genovesi non il teatro dell’assurdo, ma il “Teatrostudio”, lo Stabile
avrebbe meglio operato affidandogli un testo che non costituisse, già di per sé, un grosso problema di comprensione e di
assimilazione, per lasciare così al pubblico tutto il modo di dedicarsi solo all’osservazione del grado di bravura e di
partecipazione degli interpreti.
S’intende che il discorsetto è puramente locale, e certo non varrebbe per città teatralmente più preparate.
Carlo Quartucci, invero, ha affrontato la desolata farsa di Beckett – farsa al suo incontro con la filosofia – con l’animo
sgombro dalla poderosa e nutrita letteratura critica ed esegetica esistente sullo autore irlandese e, soprattutto, su questa
sua particolare opera: non è andato, cioè, alla ricerca della validità di una qualunque delle infinite interpretazioni che
sono state date ai suoi significati, non ha voluto sollevare il velame sulle infinite simbologie, non si è chiesto se questo
signor Godot, che i due “clochards” attendono e che non arriva mai, ammesso poi che debba un giorno arrivare, sia la
morte, oppure sia la salvezza, oppure sia la felicità, e non piuttosto sia ancora il nulla, come è nulla la vita di chi lo
attende. Non ha, neppure, calcato la mano sulla evidente contrapposizione delle due coppie di personaggi, WladimiroEstragone [sic] da una parte, e Pozzo-Lucky dall’altra, accentuando la solidarietà disperata dei primi due e il rapporto
differenziato degli altri. Ha cioè sfumato l’eventuale allegoria sociale che molti invece hanno voluto vedervi. Quartucci
ha lavorato piuttosto sulla forma esteriore della interpretazione, sublimando il carattere clownesco dell’opera, insistendo
forse eccessivamente su quel tipo di mimica che ha addirittura elevato a chiave interpretativa con il risultato di
aggiungere spesso effetti ballettistici.
La stessa impostazione fonica della recitazione, con i frequentissimi improvvisi e rapidi passaggi dalla voce coperta
al falsetto, con gli ossessivi aumenti di ritmo e di velocità, con gli studiati rallentamenti cantilenanti hanno creato una
specie di sottofondo musicale, su cui sono state orientate la tecnica del gesto e accordata la mimica facciale: in sostanza
il tentativo è egregio, ma faticoso e, vorrei dire, ad un certo momento, sembra tradire la fiducia stessa nel testo.
Veramente la verbosa e torrentizia pagina beckettiana aveva bisogno di questa accentuazione mimica, o non piuttosto
ha già in sé un suo valore estetico, anche se logicamente riflesso ed estrinsecato nella suggestione dell’informale?
Le musiche di Leopoldo Gamberini hanno punteggiato efficacemente le scene, che lo stesso Quartucci aveva
essenzializzato in una ambigua linearità, ricca di ogni significato, o del tutto priva di significato, così come la vita per
Beckett e per tutti quelli che, a torto o a ragione, aspettano Godot.
man, Aspettando Godot, in “Il secolo XIX”, 1 aprile 1964.
Posto che per Samuel Beckett, e quasi tutti i critici sono concordi su questo, la vita non ha il minimo senso, è perfino
singolare come ciascuno si sia impegnato in una sorta di gara ideale per escogitare un senso al suo teatro. Vediamo
“Aspettando Godot”. Due disgraziati, specie di larve umane consumate dal tedio della vita, spendono i momenti che
restano loro nella vana attesa di un personaggio che non verrà mai. Anzi, per la verità, nessuno ha garantito ai due che
Godot non sia già venuto e la loro attesa diventi inutile, come nessuno li ha mai rassicurati sul fatto che dovrà venire. I
due sembrano persuasi e fiduciosi. E mentre l’attesa cresce disperata, angosciosa, assurda, senza fine, loro la riempono
di vuoti discorsi, di futili pensieri, di domande e risposte ridicole, ubriacandosi in un vortice di parole insensate e di gesti
inopinati sotto la cui superficie senti rigarsi la follia e il terrore. Di che cosa ? si domandano gli esegeti di Beckett. E il
commediografo irlandese è stato il primo ad intorbidare le acque dando risposte evasive e poco convinte. Forse della
tragica assurdità della vita, del nulla che vi si nasconde, della cosmica noia e inettitudine che trasuda. E Godot cosa
rappresenta? La salvezza, la conoscenza, l’illusione, la speranza, la morte, la mistificazione del sentimento che annulla la
coscienza, o anche un macabro, irridente scherzo del Beckett più acre e irritato? Tutto è possibile, ogni significato è
proponibile in questa tetra farsa che non è metafisica in quanto proponga più o meno attendibili immagini filosofiche,
bensì in quanto è talmente svincolata da ogni riferimento realistico da poter venir rovesciata quasi ad ogni momento
come un guanto e significare esattamente il contrario di quanto pareva asserire in precedenza.
È, comunque, un testo ghiotto per un regista che si proponga di compiere particolari esperimenti interpretativi, di
realizzare forme spettacolari non comuni. L’esca clownesca si fa sentire qui in massimo grado, se è vero che Anouilh
definì la “piéce”: “I pensieri di Pascal messi in scena dai Fratellini”. E avrà magari esagerato. Ma quanto a Pascal non
quanto ai Fratellini. Così Carlo Quartucci, che è un giovane regista particolarmente inclinato verso un linguaggio
espressivo mimico e ritmico, ha avuto buon gioco a scorgervi gli estremi per una definita stilizzazione clownesca.
Resterebbe, caso mai, da obiettare se, data per ammessa la profondità delle intenzioni lirico-drammatiche beckettiane,
non sia questa una maniera per limitare e alleggerire la risonanza tragica del lavoro trasferendole nel clima
tardoromantico del pagliaccio. Tuttavia, restando alla pratica realizzazione di questa prima prova del “Teatrostudio”
dello Stabile genovese non si può fare a meno di segnalare la serietà e la profondità della preparazione svolta dal regista
(anche costumista e scenografo) e dagli interpreti nonché la maturità tecnica e professionale palesata nello spettacolo:
dinamicamente efficace e scattante, preciso nei toni e nei movimenti. Ricordiamo gli interpreti: Rino Sudano, Leo De
Berardinis, Claudio Remondi, Mario Rodriguez, Maria Grazia Grassini e le funzionali musiche di scena di Leopoldo
Gamberini. Applausi, successo, repliche.
s.i.a., Teatro-studio a Genova, in “Piemonte sera”, 1 aprile 1964.
Con “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, il teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa, ha dato stasera inizio
all’attività del “Teatro Studio”. Si tratta di un complesso sperimentale di giovani attori e registi che lo “Stabile” genovese
ha istituito per offrire al pubblico una rassegna di spettacoli che rivestano particolare significato culturale.
Un ottimo successo ha riscosso stasera “Aspettando Godot”, considerata l’opera più interessante del cosidetto [sic]
“Teatro dell’Assurdo” che va dallo stesso Beckett a Jonesco. Lo ha messo in scena il regista Carlo Quartucci, di 25 anni,
con un gruppo di giovani attori: Rino Sudano, Leo De Berardinis, Maria Grazia Grassini, Claudio Remondi e Mario
Rodriguez.
Dopo una permanenza a Genova di una ventina di giorni, il “Teatro Studio” andrà in altre città italiane.
e.b., Il “Teatrostudio” inaugurato con un’opera di Beckett, in “Il nuovo cittadino”, 2 aprile 1964.
Certamente Samuel Beckett, drammaturgo irlandese alla cui opera e alla cui tecnica si rifà una gran parte dei teatranti
dell’ultima ondata (d’ogni paese), non ha mai conosciuto il teatro di Ettore Petrolini; eppure v’è proprio nel grande
comico e sottile umorista romanesco la genesi del teatro beckettiano (e derivati).
Petrolini in uno dei suoi dialoghi assurdi affidato ad una “macchietta” che nulla più aveva della fragilità
macchiettistica e già s’era collocata fra i personaggi di una grande opera incompresa dal pubblico (e segnalata per primo
da Ettore Romagnoli) alle domande: perché si vive? Perché si muore? Aveva dato questa risposta: “perché sì”.
Niente altro; “perché sì”. E il pubblico rideva, senza capire la grandezza, e insieme la spaventosa vacuità, di quella
battuta che un filosofo avrebbe affidato ad un intero “discorso” o ad un ponderoso volume, e che Petrolini, sprovveduto
di studio come un bruco ma straricco di amarissima umanità e di scottante poesia, gettava dal palcoscenico con la
noncuranza e la tremenda illogicità che avevano aizzato la sua arte nobile e sottilissima.
Dal “perché sì” petrolinesco si può far derivare tutta l’ansia e la nullità dell’“attesa” dei miseri eroi di Beckett: di
Gogo e Didi, di Pozzo e particolarmente di Lucky (la cui filastrocca verso il finale di “Aspettando Godot” è la più vuota
di senso e quindi la più tragica di significati!).
Forse, se Petrolini fosse ancora in vita, un posto in quest’opera (come interprete-creatore) non gli sarebbe mancato.
Scomparso lui, si cimentano particolarmente i giovani, saggiando le loro forze con personaggi irraggiungibili quali i
clowns di questa “entrata tragica” che ammette l’uso d’ogni mezzo per tentare di solidificarsi in una sorta di “spettacolo”
che potrebbe essere accolto – senza dispersioni di sorta – da una pista odorosa di segatura e sommerso dalle sventole di
un’intera banda di attori.
Il neo regista Carlo Quartucci inaugurando con i suoi giovanissimi compagni (la loro “scoperta” l’ha fatta Luigi
Squarzina, a Roma, tirandoli via da una cave dove recitavano, appunto, Beckett) il “Teatrostudio” con cui il nostro
Stabile intende valorizzare nuovi elementi e nuovi testi teatrali, si è presentato con l’edizione di “Aspettando Godot”,
l’ormai famosa (mai rappresentata a Genova) clownerie drammatica di Samuel Beckett. Il regista ha imposto ai suoi
giovanissimi compagni una interpretazione in gran parte affidata ad un violento gioco mimico, e in quanto alla
recitazione ha chiesto il massimo delle variazioni vocali, passando dai toni altissimi di testa a quelli più bruniti di petto,
non escludendo quella timbratura chioccia e rarefatta che i clowns del circo usano per tentare di rendere logiche,
attraverso l’infantilità dei toni vocali, le loro illogiche trovate.
Il testo di Beckett, in sé violentemente assurdo, ma anche segnato di un’amarezza fonda e disperata, può sollecitare
ogni estro, ogni sconfinamento dai pacifici canoni della recitazione; ma in Quartucci l’eccitante richiamo non ha
trasmodato: il dramma umano dei quattro eroi dell’attesa vana di una qualsiasi liberazione, terrestre o metafisica, ha
potuto imporsi attraverso una somma di espressioni dosata attentamente in ogni sua parte.
Una fatica non lieve, sopportata anche con mezzi fisici rilevanti; e una gamma variata, toccante agli estremi i limiti
d’ogni possibilità espressiva. I giovani guidati da Carlo Quartucci sono: Rino Sudano, Leo De Berardinis, Maria Grazia
Grassini, Claudio Remondi e Mario Rodriguez (quest’ultimo, crediamo, allievi della Scuola del Teatro stabile
genovese). Il pubblico, iersera, li ha chiamati a gran voce alla ribalta, salutandoli, con il loro regista, con vivissimi
applausi. Il Teatrostudio ha avuto così un riconoscimento da parte del pubblico: la comprensione, se non di tutti i valori
del testo, di una tesa volontà e di una greve fatica.
g.g., In buona salute il neonato Teatro-studio, in “L’unità”, 2 aprile 1964.
Genova, 1 aprile.
L’altra sera al “Duse” un cordialissimo successo (applausi convinti ed acclamazioni al regista e agli attori) ha
battezzato il “Teatro studio” dello Stabile genovese, un nuovo organismo che intende rivolgersi in particolar modo alla
ricerca ed agli esperimenti sul terreno del repertorio odierno (eliminiamo, per carità, l’abusata ed equivoca definizione di
“teatro d’avanguardia”). Una volta tanto, fin dal battesimo, si può dire che il neonato è sano, e senza fare i profeti, che
avrà un buon avvenire.
C’era bisogno di qualcosa di nuovo, dopo una stagione, come quella attuale, scarsa di interesse e discutibile nei
risultati, una stagione tutta rivolta allo sfruttamento di vecchi successi, una stagione che confermava il giudizio corrente
sul teatro Stabile di Genova: il teatro più “conservatore” d’Italia.
Il “Teatro-studio” si presenta ora, calato il sipario sull’opera di Samuel Beckett, come un elemento vitale che non
chiede altro che di svilupparsi. Sta ora alla direzione dello Stabile farne non uno strumento secondario, snobistico o di
puro decoro (e tanto meno, nei confronti della compagnia dei “grandi”, una squadra di serie B): vogliamo avere fiducia e
ci impegnamo a sperare.
Prima di tutto il “Teatro-studio” ha trovato “il suo uomo”. Dato che non è una firma autorevole, uno di quegli
infallibili registi della prosa, del cinema e del melodramma, ve lo presentiamo. Carlo Quartucci, architetto,
improvvisamente folgorato dalla grazia teatrale, come un Martin Lutero dal fulmine.
Abbandonato tecnigrafo e inchiostro di china, un paio d’anni fa, apre a Roma un teatro ioneschiano e beckettiano.
Lotta durissima, fame. Poi finalmente i primi riconoscimenti. Qualche giornalista si accorge di lui. Il pubblico comincia
a non scarseggiare. Luigi Squarzina e Franco Enriquez lo “scoprono”. Squarzina si porta a Genova Quartucci a tutta la
sua “troupe”.
Adesso mi chiederete: che razza d’un regista è questo Quartucci? Di personale vena, di forte e sicura “costituzione”
tecnica. Leggete nel programma la presentazione che egli fa del suo spettacolo: ebbene, tutte le sue intenzioni sono
trasferite nettamente, senza incertezze sulla scena. È un caso raro, credete. Tra il dire e il fare, sul palcoscenico, c’è il più
delle volte un oceano di compromessi e di soluzioni lasciate a metà. Qui, in “Aspettando Godot”, c’è la esattezza
geometrica e l’onestà matematica d’un progetto d’architettura. Sia lodato il cielo che ha regalato al teatro italiano un
architetto invece d’uno dei soliti uomini di cultura e di incultura che infestano le scene nazionali.
Carlo Quartucci con i suoi esemplari attori (Rino Sudano, Leo De Bernardinis [sic], Maria Grazia Grassini, Claudio
Remondi, Mario Rodriguez) ha interpretato “Aspettando Godot” senza volere in alcun modo “spiegare” l’opera.
Questo “nessun luogo” e questo “nessun tempo” di Beckett, questi personaggi larvali, queste amebe umane, vivono,
si muovono e parlano – e soprattutto aspettano – secondo le linee d’una interiore geometria, che disegna figure di astratta
bellezza teatrale.
Chi è Godot, chi è Pozzo, chi sono Estragone e Vladimiro?
Beckett risponde che se lo avesse saputo, lo avrebbe detto. Quartucci, a sua volta, che i personaggi siamo noi stessi,
come noi li possiamo comprendere, giudicare, amare o rifiutare. Gli ultimi testimoni d’un “prima del diluvio”, oppure le
nuove creature, gli Adami e le Eve, “dopo il diluvio”, di una età insomma senza illusioni ed errori, pulita e vera.
Scegliete voi.
Sir., Debutta il “Teatro-studio” con “Aspettando Godot”, in “Corriere del pomeriggio”, 6 aprile 1964, p. 6.
Ha debuttato il “teatro studio”. Iniziativa coraggiosa del nostro “Stabile” che vuole dar avvio ad un’attività di ricerca
sia nell’ambito della drammaturgia (repertorio), sia in quello dei mezzi espressivi scenici (regia, recitazione,
scenografia). Attività di altissimo livello, impegno assoluto per testi ed interpreti.
Ed eccoli qui, attorno a noi, i giovani del “teatro studio”; hanno finito da poco le prove e chiacchierano volentieri del
loro nuovo lavoro (quell’“Aspettando Godot” che tante polemiche ha suscitato e non solo in Italia) dei loro interessi, dei
loro orientamenti teatrali.
Sono cinque: quattro attori e un regista. Rino Sudano, Leo De Berardinis, Claudio Remondi e Maria Grazia Grassini;
si affianca loro un giovane della nostra scuola d’arte drammatica, Mario Rodriguez.
Regista Carlo Quartucci. Un tipo alto, nervoso, che vive di teatro e non pensa ad altro che al teatro. Insegna Teoria e
Tecnica del movimento alla scuola d’arte drammatica genovese, è apparso in Corte Savella e in Danza di morte.
Cinque giovani che credono in questo teatro. Loro lo chiamano “teatro emozionale” e ne parlano con tanta
convinzione che non si può non credere alla loro buona fede. Il testo di Beckett che hanno messo in scena è senza
dubbio una delle cose più difficili dell’autore irlandese. E c’è voluto il coraggio di Quartucci a realizzare una simile
impresa.
– È possibile – chiediamo al regista – proporre ad un pubblico di massa, se così si può dire, un testo di tale difficoltà?
– È chiaro – risponde – che il pubblico deve essere preparato. Ma lo si prepara proprio proponendogli sempre testi di
questo tipo. Il mio problema di regia era quello di considerare tutto il pensiero di Beckett, da intendersi però non come
sistema filosofico, ma come problematica dell’esistenza sganciata da ogni significazione storica.
Ecco allora che per “mostrare” allo spettatore questo pensiero si è creduta necessaria una presa estetica e non
“dell’anima”, una finzione di emotività di carattere puramente teatrale: che però non restasse tale ma fosse recuperabile
razionalmente. Quartucci parlerebbe per giornate intere di queste cose e tutti gli altri gli terrebbero corda con uguale
piacere. Questi ragazzi sono insieme da due anni. A Roma ebbero il loro primo vero successo con Enriquez al
“Quirino”: fu proprio lì che Squarzina li scoprì e se li portò a Genova. – Il nostro è stato un incontro di idee – dicono –
per questo siamo uniti e ci è possibile lavorare compatti. Siamo tutti convinti di quello che facciamo e riteniamo che la
nostra strada sia quella giusta.
È indubbio che per arrivare a certi risultati sono necessari sacrifici non comuni, coscienza professionale ben radicata,
serietà assoluta: tutte qualità che essi hanno, e basta parlargli insieme per qualche tempo per rendersene perfettamente
conto. – Il pubblico genovese – chiediamo – come ha reagito? – Ha “reagito” – dicono – e questo è importante. Alla
fine ha detto “Mah!” e questo significa molto, significa che qualcosa si è posto nel cercare una spiegazione a quello che
ha visto. È Sudano che si diverte in queste sottili disquisizioni. E De Bernardinis [sic], Claudio Re- [errore di stampa:
alla riga successiva il testo prosegue] nostro, insomma, è un problema di stile non di contenuto”. E Quartucci conclude:
“Il nostro vuole essere un dialogo il più vicino possibile al pubblico, recitiamo tutti in avanti…”
Bene. Per quest’anno il “teatro-studio” si fermerà a Beckett: ma per la prossima stagione sono già in cantiere alcuni
testi interessanti. Un’antologia di pezzi visti naturalmente sotto questa dimensione “emozionale”, ancora Beckett e poi
un’idea attorno alla “Cavalleria rusticana” che è bene per ora non approfondire.
Insomma, questi giovani si sono affermati con indubbie capacità. La regia di Quartucci in questo “Aspettando
Godot” ha toccato dimensioni artistico-culturali notevolissime, la recitazione degli attori ha dimostrato la loro seria,
precisa, attenta preparazione.
– Per noi è un passo importante – dicono – speriamo di proseguire così.
E lo dicono con estrema sincerità. La loro vita è fatta ormai di queste cose: le sole importanti. E ci sembra molto
serio tutto ciò, con i tempi che corrono.
s.i.a., “Aspettando Godot” di Samuel Beckett (Teatro Duse), in “Gazzetta del lunedì”, 6 aprile 1964, p. 2.
Con la presentazione dell’opera più significativa di Beckett e del “teatro dell’assurdo”, è nato il “Teatro-studio”, una
delle attività più interessanti del nostro Teatro Stabile, che salutiamo con soddisfazione per il suo valido contributo a
quella “politica dei testi” che ci sta tanto a cuore.
Per cominciare, i ragazzi del “Teatro-studio” hanno proposto allo spettatore “Aspettando Godot”, un testo che non si
poteva ignorare dopo il rodaggio compiuto, nel “teatro dell’assurdo”, dalla “Borsa di Arlecchino”. Viene fatto di
pensare, di fronte all’interrogativo che Beckett si pone sull’utilità del vivere, ai saggisti che hanno definito Pirandello un
“disperato”. E tuttavia, anche discutendo la forma, non si può negare a Beckett una prospettiva filosofica. Sotto questo
profilo saremmo tentati di chiamarlo, più che teatro dell’assurdo, “teatro del buio”. Ma il discorso porterebbe lontano e
non è il caso – mancando lo spazio – di cominciarlo neppure.
Venendo alla realizzazione, troviamo che una semplicità estrema e convinta avrebbe giovato più del rapporto vocaleballettistico-mimico adottato. Manca, con questa sovrastruttura, l’evidenza dell’assurdo, e sorge il dubbio che la regìa
l’abbia adottata per evitare, nel risultato, quelle estreme conseguenze che Beckett dichiara.
Il risultato c’è, comunque, ed è notevole se si considera il criterio della regìa e la pesantezza della commedia. In
quanto alla versione clownesca dei due “clochards”, non sarà male dire che i clown divertono proprio perché compaiono
a intervalli e per “numeri” di breve durata. La fatica di Carlo Quartucci, che ha firmato regìa, scene e costumi, è
indicativa di una profonda intuizione e di una bella preparazione. Gli interpreti, bravi e sicuri, meritano di essere tutti
ricordati, da Rino Sudano e Leo de Bernardinis [sic] a Claudio Remondi a Maria Grazia Grassini a Mario Rodriguez.
s.i.a., “Aspettando Godot” per gli studenti, in “Il lavoro nuovo”, 7 aprile 1964.
Allo scopo di avvicinare i giovani al teatro contemporaneo e di interessarli all’attività di “Teatrostudio”, la direzione
del Teatro Stabile organizza giovedì 9 p.v. alle ore 15 una rappresentazione diurna di “Aspettando Godot” di Beckett,
l’interessantissimo spettacolo che ha già riscosso un lusinghiero successo di critica e che ha destato vivi consensi tra il
pubblico, dedicata agli studenti universitari e delle ultime classi della scuola media.
La rappresentazione sarà preceduta da un’introduzione che illustrerà il significato del cosiddetto teatro dell’assurdo,
traccerà un profilo di Beckett.
Allo spettacolo seguirà un libero dibattito.
s.i.a., Tournée in tutta Italia del Teatro-Studio dello Stabile, in “Corriere mercantile”, 13 aprile 1964.
La compagnia del teatro-studio della “Stabile” genovese, diretta da Carlo Quartucci – che rappresenta in questi giorni
al teatro “Duse” la commedia “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, porterà il suo spettacolo in tournée in varie città
italiane tra le quali Roma, Milano e Torino.
L’inizio del giro è previsto per la fine di aprile. La novità dell’iniziativa presa da Ivo Chiesa e Luigi Squarzina,
direttori della “Stabile”, consiste nell’avere voluto affiancare una attività di ricerca nella nuova drammaturgia a quella
svolta dalle due compagnie già esistenti nel teatro. Fino ad oggi, infatti, i testi del teatro cosìddetto “di avanguardia”
erano sempre stati esclusi dal cartello delle “Stabili” italiane. Dopo 15 giorni dall’inizio delle rappresentazioni,
l’affluenza del pubblico ha superato spesso il 50 per cento della capacità complessiva del teatro, realizzando notevoli
incassi, sebbene i biglietti abbiano un prezzo molto inferiore a quello normale (da 200 a 1.400 lire, anziché da 600 a
2.400).
Prima di essere chiamati alla “Stabile” genovese, gli attori del teatro-studio (tutti di un’età compresa tra i 23 e i 33
anni) hanno dovuto superare molte difficoltà, ma dopo recensioni favorevoli dei maggiori critici, erano riusciti nel 1963
a portare i loro spettacoli al teatro “Quirino” di Roma, arrivando così al grande pubblico.
“Noi ci siamo conosciuti nel 1960 all’Università, ed abbiamo incominciato subito con testi di Jonesco e di Beckett –
ha detto il regista Quartucci – e viviamo in comunità, seguendo una regola che vorrei definire “monastico-teatrale”.
Studiamo insieme i testi e li proviamo minuziosamente per vari mesi. Mangiamo insieme e passiamo quasi sempre
insieme anche il tempo libero. Infatti, il nostro intento è di realizzare, con assoluta serietà di impegno, una coscienza
professionale che ci permetta un dialogo senza riserve col pubblico. Così – ha ancora detto Quartucci – potremo
rappresentare la condizione dell’uomo rispetto alla società, conservandogli tutti i rapporti filosofici, artistici e sociali che
lo legano alla realtà quotidiana”.
Per molti mesi, prima di venire a Genova, Quartucci assieme agli attori Rino Sudano, Leo De Bernardis [sic], Maria
Grazia Grassini e Claudio Remondi, si sono fatti da soli, artigianalmente, costumi e scene, e si sono persino trasformati
in “uomini-sandwich” per la pubblicità. Ogni spettacolo è venuto così a costare tra 200 e 300 mila lire, anziché qualche
milione.
s.i.a., Compagnia “studio” dello Stabile di Genova, in “L’avvenire d’Italia”, 14 aprile 1964.
La compagnia del teatro-studio della “Stabile” genovese, diretta da Carlo Quartucci – che rappresenta in questi giorni
al Teatro “Duse” la commedia “Aspettando Godot” di Samuel Beckett – porterà il suo spettacolo in “tournée” in varie
città italiane tra le quali Roma, Milano e Torino. L’inizio del giro è previsto per la fine di aprile. La novità dell’iniziativa,
presa da Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, direttori della “Stabile”, consiste nell’avere voluto affiancare una attività di ricerca
nella nuova drammaturgia a quella svolta dalle due compagnie già esistenti nel teatro. Fino ad oggi, infatti, i testi del
teatro cosiddetto “d’avanguardia” erano sempre stati esclusi dal cartello delle “Stabili” italiane.
Dopo 15 giorni dall’inizio delle rappresentazioni, l’affluenza del pubblico ha superato spesso il 50 per cento della
capacità complessiva del teatro, realizzando notevoli incassi, sebbene i biglietti abbiano un prezzo molto inferiore a
quello normale (da 200 a 1.400 lire, anziché da 600 a 2.400). Prima di essere chiamati alla “Stabile” genovese, gli attori
del teatro-studio (tutti di un’età compresa tra i 23 ed i 33 anni) hanno dovuto superare molte difficoltà, ma dopo
recensioni favorevoli dei maggiori critici, erano riusciti nel 1963 a portare i loro spettacoli al Teatro “Quirino” di Roma,
arrivando così al grande pubblico. “Noi ci siamo conosciuti nel 1960 all’università, ed abbiamo incominciato subito con
testi di Jonesco e di Beckett – ha detto il regista Quartucci -. Studiamo insieme i testi e li proviamo minuziosamente per
vari mesi. Mangiamo insieme e passiamo quasi sempre insieme anche il tempo libero. Infatti, il nostro intento è di
realizzare, con assoluta serietà d’impegno, una coscienza professionale che ci permetta un dialogo senza riserve col
pubblico”. “Così – ha detto ancora Quartucci – potremo rappresentare la condizione dell’uomo rispetto alla società,
conservandogli tutti i rapporti filosofici, artistici e sociali che lo legano alla realtà quotidiana”.
Per molti mesi, prima di venire a Genova, Quartucci assieme agli attori Rino Sudano, Leo De Berardinis, Maria
Grazia Grassini e Claudio Remondi, si sono fatti da soli, artigianalmente, costumi e scene, e si sono persino trasformati in
“uomini-sandwich”.