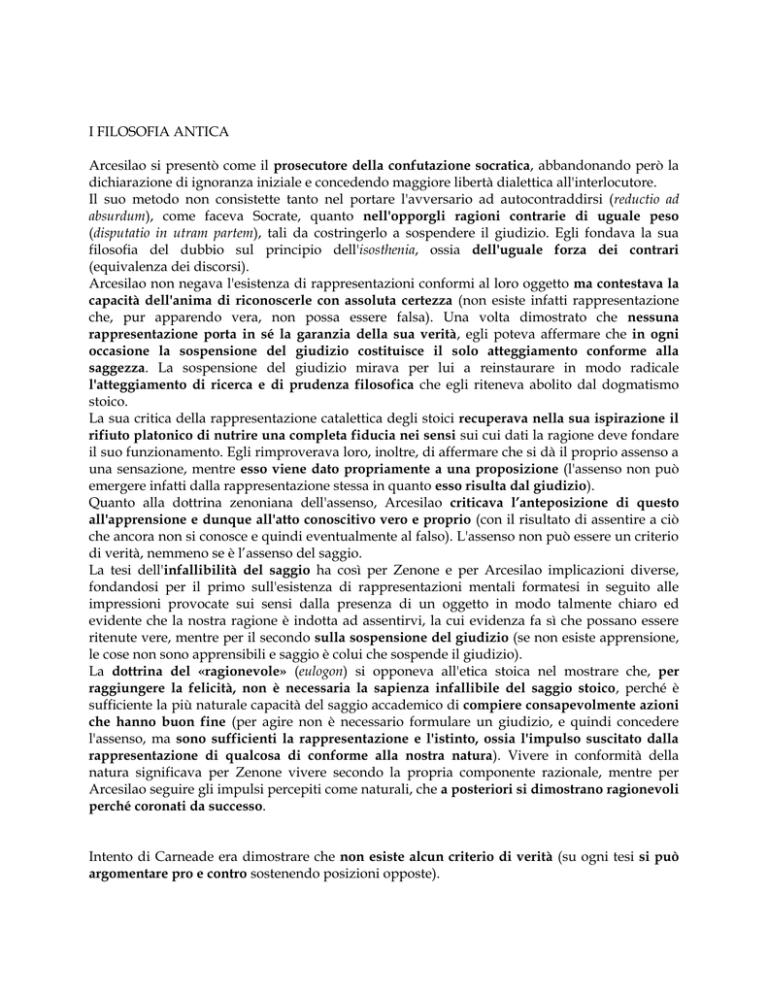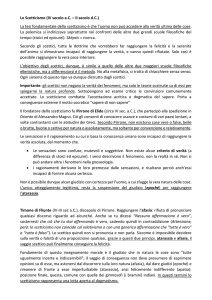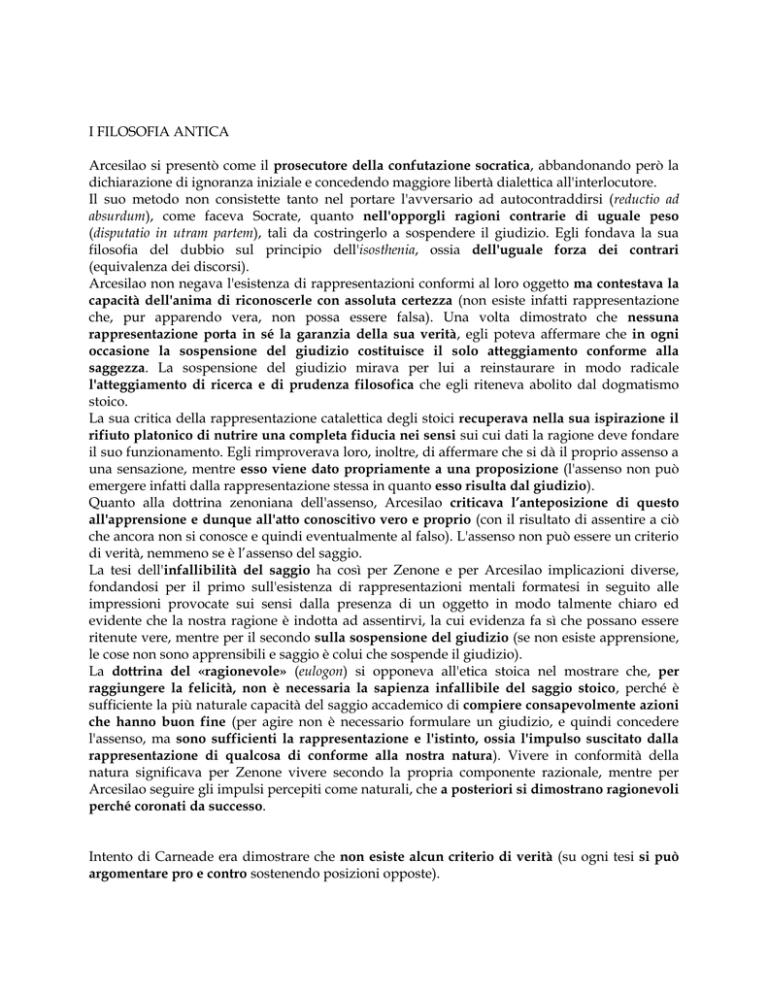
I FILOSOFIA ANTICA
Arcesilao si presentò come il prosecutore della confutazione socratica, abbandonando però la
dichiarazione di ignoranza iniziale e concedendo maggiore libertà dialettica all'interlocutore.
Il suo metodo non consistette tanto nel portare l'avversario ad autocontraddirsi (reductio ad
absurdum), come faceva Socrate, quanto nell'opporgli ragioni contrarie di uguale peso
(disputatio in utram partem), tali da costringerlo a sospendere il giudizio. Egli fondava la sua
filosofia del dubbio sul principio dell'isosthenia, ossia dell'uguale forza dei contrari
(equivalenza dei discorsi).
Arcesilao non negava l'esistenza di rappresentazioni conformi al loro oggetto ma contestava la
capacità dell'anima di riconoscerle con assoluta certezza (non esiste infatti rappresentazione
che, pur apparendo vera, non possa essere falsa). Una volta dimostrato che nessuna
rappresentazione porta in sé la garanzia della sua verità, egli poteva affermare che in ogni
occasione la sospensione del giudizio costituisce il solo atteggiamento conforme alla
saggezza. La sospensione del giudizio mirava per lui a reinstaurare in modo radicale
l'atteggiamento di ricerca e di prudenza filosofica che egli riteneva abolito dal dogmatismo
stoico.
La sua critica della rappresentazione catalettica degli stoici recuperava nella sua ispirazione il
rifiuto platonico di nutrire una completa fiducia nei sensi sui cui dati la ragione deve fondare
il suo funzionamento. Egli rimproverava loro, inoltre, di affermare che si dà il proprio assenso a
una sensazione, mentre esso viene dato propriamente a una proposizione (l'assenso non può
emergere infatti dalla rappresentazione stessa in quanto esso risulta dal giudizio).
Quanto alla dottrina zenoniana dell'assenso, Arcesilao criticava l’anteposizione di questo
all'apprensione e dunque all'atto conoscitivo vero e proprio (con il risultato di assentire a ciò
che ancora non si conosce e quindi eventualmente al falso). L'assenso non può essere un criterio
di verità, nemmeno se è l’assenso del saggio.
La tesi dell'infallibilità del saggio ha così per Zenone e per Arcesilao implicazioni diverse,
fondandosi per il primo sull'esistenza di rappresentazioni mentali formatesi in seguito alle
impressioni provocate sui sensi dalla presenza di un oggetto in modo talmente chiaro ed
evidente che la nostra ragione è indotta ad assentirvi, la cui evidenza fa sì che possano essere
ritenute vere, mentre per il secondo sulla sospensione del giudizio (se non esiste apprensione,
le cose non sono apprensibili e saggio è colui che sospende il giudizio).
La dottrina del «ragionevole» (eulogon) si opponeva all'etica stoica nel mostrare che, per
raggiungere la felicità, non è necessaria la sapienza infallibile del saggio stoico, perché è
sufficiente la più naturale capacità del saggio accademico di compiere consapevolmente azioni
che hanno buon fine (per agire non è necessario formulare un giudizio, e quindi concedere
l'assenso, ma sono sufficienti la rappresentazione e l'istinto, ossia l'impulso suscitato dalla
rappresentazione di qualcosa di conforme alla nostra natura). Vivere in conformità della
natura significava per Zenone vivere secondo la propria componente razionale, mentre per
Arcesilao seguire gli impulsi percepiti come naturali, che a posteriori si dimostrano ragionevoli
perché coronati da successo.
Intento di Carneade era dimostrare che non esiste alcun criterio di verità (su ogni tesi si può
argomentare pro e contro sostenendo posizioni opposte).
V'è inoltre da chiedersi per lui in rapporto ad una rappresentazione apprensiva (catalettica) e
perciò vera: cosa la distingue da un'altra che non lo è? (argomento del sorite del megarico
Eubulide di Mileto, tendente a rendere indeterminato da un punto di vista quantitativo il
confine tra gli opposti, ad esempio un grano e un mucchio, un calvo e uno che non lo è).
L'obiezione da muovere agli Stoici, secondo i quali la rappresentazione è rivelatrice nello stesso
tempo dell'oggetto che la suscita e dello stato del soggetto, è di dire che in quanto mentale essa
è qualcosa di interno al soggetto stesso da cui all'oggetto rimane escluso.
Perché sia possibile seguire una rappresentazione senza giudicarla vera occorre che essa sia
giudicata quanto meno persuasiva. Ciò impone la distinzione tra quanto è momentaneamente
oscuro e quanto è inapprensibile per natura (se nulla dunque può essere appreso con certezza,
non tutto invece è completamente oscuro). Esistono, infatti, rappresentazioni di cui non si può
dire con certezza che sono vere ma di cui si può ammettere che sono persuasive (pitanà).
Il sembrare vero di ciò che si presenta non fa venire meno il carattere soggettivo del verosimile,
rimanendo in piedi l'opposizione tra verità e falsità delle rappresentazioni e il loro apparire tali
al soggetto che le rappresenta.
Esistono in ultimo vari gradi di persuasività (verosimiglianza) delle rappresentazioni,
determinati dalla situazione favorevole o meno delle circostanze e dal maggiore o minor tempo
di ponderazione a disposizione (rappresentazioni, oltre che verosimili, non smentite dai fatti e
oggetto di esame dettagliato).
Enesidemo tenne a tracciare una distinzione tra la posizione di Pirrone e quella degli
Accademici, da lui accusati di autocontraddirsi per il fatto di fare affermazioni e negazioni
categoriche e insieme di sostenere l’inapprensibilità delle cose.
A differenza loro, il seguace di Pirrone sa di non poter apprendere nulla con certezza, e anche
riguardo a questo sapere la sua posizione si distingue per il fatto di non pronunciarsi né in
senso affermativo né in senso negativo, perché niente può essere affermato o negato in modo
definitivo (egli è consapevole del problema posto da una forma di dogmatismo negativo).
Scopo della riflessione sembra essere dunque quello di porre fine alle ansie di sapere dei
dogmatici – scopo che, una volta conseguito, comporta il venir meno della necessità dello
stesso esercizio della filosofia. In tal senso, il pirronismo si presenta come una terapia contro la
malattia del dogmatismo, rispetto alla quale esso vale da purgante che viene eliminato insieme a
ciò di cui riesce a liberare.
Il tema dei limiti delle facoltà conoscitive umane viene affrontato ricorrendo a degli schemi di
ragionamento (tropi), i quali mostrano che non è possibile pronunciarsi in modo definitivo
sulle cose dal momento che essi ci appaiono in modo diverso (dieci tropi riguardanti il
soggetto, l’oggetto e la relazione tra i due; ad essi Agrippa aggiungerà in seguito altri cinque, tra
cui il regresso all’infinito della prova, l’introduzione indebita di ipotesi indimostrate, e il circolo
vizioso).
Se il disaccordo e la relatività delle sensazioni ci consentono di dire e parlare solo di come un
oggetto appare ai sensi di ognuno in un dato momento e in una data condizione,
l’inconsistenza delle astrazioni concettuali utilizzate dai dogmatici mostrano un indebito
passaggio dal piano concettuale a quello ontologico (le cause, ad esempio, in quanto relative
ad un effetto, esistono come tali solo a livello mentale, dato che nessuna cosa può realmente
“produrne” un’altra: l’esistenza della prima non implica l’esistenza della seconda). È negata
così la possibilità della scienza come conoscenza delle cause.
Le conclusioni di Enesidemo si fondano sulla convinzione che mentre le sensazioni sono reali
perché sono reali gli oggetti che le suscitano, i contenuti del pensiero non hanno esistenza
reale perché sono astrazioni immateriali (i pensieri non sono infatti che relazioni instaurate tra
le sensazioni).
L’evidenza sensibile rappresenta nondimeno una guida per la vita quotidiana, laddove il
sommo bene è posto nell’imperturbabilità che il sapiente raggiunge nella sospensione di ogni
assenso.
Sesto Empirico ha equiparato in maniera problematica il pirronismo a una filosofia e a una
ricerca continua, in opposizione con l’idea che l’esito del pirronismo sia l’uscita dalla filosofia.
Come già Enesidemo, anche Sesto Empirico riferiva al pirronismo il termine agogè
(orientamento di pensiero) e non quello di airesis (scuola, setta filosofica).
L’uso nuovo del termine “scettico” per pirroniano indica che quest’ultimo si distingue dal
dogmatico per l’atteggiamento di ricerca continua (lo scettico in quanto zetetico, efettico e
aporetico è aperto alla ricerca, mantiene la sospensione dell’assenso e non prende posizione né
in un senso né nell’altro di fronte a soluzioni reciprocamente incompatibili che si fronteggiano
presentandosi come parimenti solide).
A quello scettico egli opponeva l’atteggiamento dogmatico di chi assente a cose non evidenti,
oscure sia ai sensi che all’intelletto. Lo scettico si attiene a ciò che appare, rilevando la
contrapposizione tra il fenomeno e la realtà o natura oggettiva delle cose, indipendente dal
soggetto che le percepisce. Non si può sapere, infatti, se e in quale misura i sensi diano accesso
al mondo esterno perché essi rivelano solo l’impressione soggettiva (le sensazioni non sono in
alcun modo rivelative della realtà esterna come intendeva invece Enesidemo).
Nemmeno le affermazioni del tipo: le cose non sono più questo che quello, le cose sono
indeterminate, non sono apprensibili, sono asserzioni riguardanti la realtà delle cose, in quanto
sono la registrazione delle semplici impressioni soggettive provocate dall’equipollenza dei
diversi modi di apparire delle cose.
Come per Enesidemo, anche per Sesto Empirico la vita guidata dalle apparenze si conforma al
rispetto delle regole di vita, senza che ciò stabilisca una relazione necessaria tra la sospensione
dell’assenso e l’atarassia.
II FILOSOFIA DEL MEDIOEVO
Agostino (354-430), che ha accolto all’inizio le posizioni scettiche in funzione antimanichea, ha
contestato in seguito nel Contra academicos che questi possiedono la sapienza per il fatto di
rinnegare l’assenso ad essa (qual è la sapienza di coloro che affermano che il sapiente non sa
nulla?). Quello descritto dagli Accademici è dunque un sapiente che la ragione con contempla: è
più duro, infatti, che il sapiente non sappia la sapienza del fatto che l’uomo non possa
raggiungerla, così come è più incredibile che il sapiente non approvi la sapienza del fatto che
egli non sappia la medesima. La questione da cui egli muove nello scritto è quella della felicità,
la quale ha la sua premessa nell’assunto che vivere felicemente è il vivere secondo quella che è
la parte migliore dell’uomo, la ragione. Chiedendo se si possa vivere felicemente soltanto
cercando la verità senza trovarla, la risposta di Agostino è che certamente erra chi non vive
secondo ragione, mentre non erra chi ritiene che la verità sia in assoluto da cercare. Non solo,
erra sia chi segue una via falsa sia chi non segue quella vera (come mostra l’esempio dei due
viandanti).
Le obiezioni che egli muove agli Accademici riguardano da un lato le sensazioni – le quali
possono essere difformi quanto al contenuto ma non quanto al loro essere tali, possono dare
informazioni sbagliate sul mondo che presuppongono tuttavia una relazione con il medesimo, e
infine sono sottoposte a determinate condizioni che non possono inficiate dal richiamo a
condizioni anomale – dall’altro le verità matematiche, che non possono essere messe in
discussione perché indipendenti dalla loro apprensione.
Nel De vita beata ritorna sulla questione della felicità, assumendo che ottenere ciò che si vuole
non è condizione sufficiente di essa poiché occorre che l’oggetto del volere sia sempre
disponibile al volere stesso, definendosi come qualcosa di permanente, non legato alla fortuna.
Felice è solo chi possiede Dio in quanto lo ha trovato. Da ciò consegue che gli Accademici non
possono che infelici in quanto cercano continuamente la verità senza trovarla, né possono
essere ritenuti sapienti, considerato che il sapiente è felice per definizione. La felicità consiste
propriamente nel raggiungere per mezzo della verità la misura suprema, ossia l’equilibrio in cui
consiste la sapienza.
Per Agostino (Soliloquia) il sapere non è opposto al credere ma si colloca all’interno della
credenza quale conoscenza specifica e ben distinta di ciò che è già oggetto di fede. Non solo
dunque la fides è cosa ben diversa dalla credulitas come pure dalla opinio, ma è un tipo di
conoscenza più ampio della scientia: 1) perché dà impulso ed è di guida al sapere,
sorreggendo la ragione, arrecando alla mente una sanità altrimenti difficile da ottenere,
facendole guardare con attenzione l’oggetto che dovrà essere successivamente conosciuto in
modo evidente, nonché mantenendo fermo l’assenso contro i dubbi e le incertezze provenienti
dai sensi e dalle passioni; 2) perché il sapere si riflette nel credere ma il credere è preliminare
al sapere (nisi credideritis non intelligetis)
La questione è allora: perché vi è bisogno di sapere e non ci si accontenta di credere? La
risposta è: per il desiderio di apprendere con la ragione le verità ultime dalle quali dipende
tutta l’esistenza umana, la conoscenza di Dio e dell’anima; e ancora, per il fatto stesso di
possedere alcune verità indubitabili (quelle della matematica), in quanto è per il fatto di sapere
qualcosa in modo indubitabile che si vuol sapere nello stesso modo tutto il resto. La conoscenza
della verità rappresenta così l’unica via per arrivare a conoscere Dio e l’anima. Per questo, v’è
bisogno di dimostrare l’esistenza di una verità assoluta, sia cogliendo l’evidenza del cogito (il
comprendere umano presuppone tanto l’esistere di ciò che è puramente inerte, come le pietre,
quanto il vivere degli animali), sia seguendo un ragionamento volto a dimostrare che la verità
è condizione di ogni giudizio.
Agostino ha stabilito in proposito una differenza tra il vero e la verità, la quale permane anche
quando questo scompare. Niente può essere vero se la verità non esiste. Anzi, essa esisterebbe
anche se per ipotesi finisse il mondo, perché in tal caso resterebbe paradossalmente vero che il
mondo è finito. La verità pertanto non può venire a mancare perché, se anche ciò fosse, sarebbe
vero che essa è venuta a mancare (al pari della verità che non può perire, l’anima in cui essa
alberga è immortale).
Vi sono delle definizioni di vero da considerare problematiche: 1) quella di vero come ciò che
appare così come è (il che porta a concludere che il vero non esiste per se stesso); 2) quella di
vero come ciò che è (il che porta a concludere che, a rigore, il falso non esiste).
La strada per giungere alla definizione di vero può essere quella che analizza il concetto di falso
come ciò che si presenta o cerca di essere ciò che non è. E questo, perché, se qualcosa è vero
perché non è falso, allora vero è ciò che realizza la somiglianza perfetta con la verità.
La verità è quella che fa vedere ciò che è, in quanto legge di simmetria, di armonia, di
proporzione delle parti, che trova il suo fondamento nell’Uno: quello stesso cui si riferisce
ogni giudizio, vuoi estetico (perché l’unità è il criterio della bellezza), vuoi conoscitivo (perché
vero è ciò che realizza l’Uno), vuoi ontologico (perché l’Uno è il principio dell’essere), vuoi
infine morale (perché l’errore e il vizio sono l’allontanamento volontario dall’Uno). Per questo
motivo la verità è la legge sopra la nostra mente, immutabile a differenza di questa, superiore a
colui che giudica (allo stesso modo che questi è superiore a ciò di cui giudica): ciò a cui tendono
coloro che ragionano, i quali appunto vi tendono in quanto riconoscono di non essere ciò che
essa è, pur sapendo che essa dimora nell’uomo interiore.
Se la verità rimane nascosta all’uomo è solo perché egli non conosce il modo di cercarla, un
modo che va preso anzitutto dall’autorità divina, la quale esige la fede e prepara l’uomo alla
ragione (questo significa che la vera religione non può essere raggiunta senza la fede, che
permette di apprendere ciò che in seguito si riesce a comprendere, anche in conseguenza di una
struttura di vita e di pensiero rinnovata). Così, se questa conduce all’intelligenza e alla
conoscenza, la fede precede in ordine di tempo il sapere perché all’inizio siamo presi dalle cose
temporali e siamo distolti da quelle eterne. La via più salutare è quella di divenire anzitutto
capaci di comprendere la verità, ponendo fede a ciò che è stato stabilito da Dio, e dunque
ammettendo qualcosa che si sa di non sapere e di non poter sapere, almeno per il momento.
Come, in generale, la fede richiede di accogliere la testimonianza di un altro che si pone per
questo come auctoritas, così, nell’ambito religioso, essa comporta il rimando alla sauberissima
auctoritas costituita dalla Sapienza di Dio incarnatasi in un uomo (questa è poi l’unica e
universale strada della vera religione e della salvezza di ogni uomo, dato che credere in Cristo
significa accogliere la definitiva trasformazione della natura umana che il Dio fattosi uomo ha
operato e continua ad operare).
La fede, massimamente richiesta dalla religione cristiana perché “in essa non si presenta un
oggetto che si vede”, è utile infine per vivere, indispensabile com’è per riconoscere le relazioni
parentali e per fondare quelle di amicizia, nonché per dare l’assenso a quella molteplice serie
di cose che si presentano nella vita come probabili: ed è saggio possederla perché toglie
dall’ignoranza e dall’incertezza e istrada alla conoscenza.
Rapporto tra fede e sapere in alcuni dei maggiori filosofi del Medioevo.
Agostino (354-430): fede e ragione si trovano in una prospettiva di convergenza, in quanto la
verità non è fine a se stessa ma la si ricerca per avere quella felicità che solo la vera religione
può conseguire. In sintesi, non solo la fede sostenuta dalla comprensione è al termine della
ricerca pur essendone la condizione in quanto sorretta dall’autorità, ma la ricerca impegna
tutto l’uomo e non il solo intelletto, perché la verità cui si tende è nello stesso tempo la via e la
vita. Nella verità l’uomo si rigenera.
Giovanni Scoto Eriugena (810-877?): esiste un accordo intrinseco tra ragione e fede, tra la verità
cui giunge la ricerca libera e la verità rivelata all’uomo dall’autorità della Sacra Scrittura. Se è
vero che l’autorità di quest’ultima è indispensabile alla ragione, in quanto la nostra ragione è
una ragione istruita dalla rivelazione, bisogna però riconoscere che la dignità maggiore e la
priorità di natura spettano alla ragione, in quanto la ragione è nata all’inizio dei tempi insieme
con la natura e l’autorità dopo. Da un lato la religione non s’identifica con l’autorità ma con la
ricerca, dall’altro l’autorità della Chiesa segna i limiti dell’interpretazione razionale.
Anselmo (1033-1109): la fede è il presupposto della ricerca (credo ut intelligam), la quale
assegna alla ragione il compito di tradurre la certezza della fede in evidenza razionale. Di
conseguenza, se non si può intendere nulla senza la fede, questa da sola non basta in quanto ha
bisogno di conferma da parte della ragione. Tra ragione e fede non può esservi vero contrasto
perché entrambe sono illuminate dalla luce divina (il che non significa però che le ragioni più
alte dei misteri possano essere rischiarati).
Abelardo (1079-1142): bisogna affidarsi all’autorità solo finché la ragione rimane nascosta, ma
essa diventa inutile quando la ragione ha modo si accertare da sé la verità. La ragione tuttavia
non è misura sufficiente per intendere le cose divine (ad es. il mistero della Trinità), rispetto alle
quali non resta che proporre una soluzione verosimile e non contraria alla fede (il che non
significa che non si debba raggiungere e difendere la fede con la ragione). Una fede cieca,
prestata con leggerezza, non ha alcuna stabilità ed è incauta e priva di discernimento (è almeno
da discutere se bisogna prestare fede).
Non si può credere davvero se non ciò che si intende: anche la verità rivelata non è verità per
l’uomo se questi non fa appello alla sua razionalità (con ciò non egli non intende screditare
l’autorità o sottomettere la fede alla ragione, ma invoca la dialettica per definire le questioni
controverse della Sacra Scrittura).
Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274): la certezza relativa alle verità di fede va distinta dalla
certezza delle verità. Rispetto alle verità religiose, la fede è più certa della scienza (il suo
oggetto, Dio, è il primum cognitum per l’uomo, nella cui mente è innata una qualche nozione o
idea di Dio, che, seppure perfezionabile attraverso la riflessione, è sufficiente per affermare la
sua necessaria esistenza), mentre rispetto alle altre verità la fede possiede una certezza di
adesione maggiore della scienza, la quale ha dal canto suo una certezza di speculazione
maggiore della fede (dunque, la scienza può eliminare il dubbio, ma è la fede a far aderire il
credente alla verità).
Se sforzo precipuo dell’uomo deve essere il ritorno a Dio, esso non può compiersi solo
mediante la conoscenza filosofica in quanto comporta la riduzione di tutte le scienze alla
teologia: sotto le apparenze del sapere profano si cela infatti un sapere più profondo cui bisogna
ricondursi per vedere nelle cose sensibili un’immagine di quella vera realtà che è il Dio biblico.
Alberto Magno (1206-1207-1280): il dominio della filosofia va separato da quello della
teologia, da cui il sapere filosofico e scientifico è autonomo. Le dottrine teologiche non
coincidono nei loro principi con quelle filosofiche in quanto queste procedono per ragioni e
sillogismi, mentre quelle si fondano sulla fede. Il dominio della filosofia, ristretto a quello della
dimostrazione necessaria, ammette al di là di sé un dominio che deriva la sua validità
dall’assenso alla verità rivelata. Ciò non esclude la possibilità di una teologia razionale, che egli
pratica elaborando le prove dell’esistenza di Dio a partire dall’esperienza sensibile, mediante il
principio di causa.
Tommaso d’Aquino (1225-1273): all’uomo, che ha come suo fine ultimo Dio (eccedente la
comprensione della ragione), non basta la sola ricerca filosofica fondata sulla ragione; egli
abbisogna della sua istruzione attraverso la rivelazione divina. La ragione non può dimostrare
ciò che è di pertinenza della fede ma può servire ad essa, dimostrandone i preamboli,
chiarendone le verità mediante similitudini e controbattendo le obiezioni ad essa. Per suo conto,
la ragione può elevarsi a Dio, ma solo partendo dalle cose sensibili, dall’effetto per risalire alla
causa prima (il riconoscimento dell’esistenza di Dio non conduce però alla conoscenza della sua
essenza, i cui misteri costituiscono quegli articoli di fede che la ragione può sì difendere ma non
dimostrare).
L’assenso implicito nella fede, simile per la sua fermezza a quello implicito nella scienza, è
diverso nel suo movente in quanto non è prodotto dall’oggetto ma da una scelta volontaria che
inclina l’uomo.
Alla teologia va riconosciuto carattere di scienza, che le compete in virtù del principio di
subalternazione: i ragionamenti del teologo hanno le loro premesse nella rivelazione,
premesse che, pur non essendo evidenti all’intelletto del credente, risultano evidenti alla mente
di Dio che le ha rivelate. In tal modo, la teologia è scienza subalterna alla scienza divina, in
quanto ha per oggetto il rivelabile e possiede un’unità intrinseca che le deriva dal suo stesso
oggetto: Dio come principio e fine dell’universo. La filosofia poi gode di una propria
autonomia, garantita dalla struttura della mente umana, capace di giungere alla verità per
volontà del creatore. Teologia e filosofia sono pertanto due vie d’accesso all’unica verità,
trovando un punto d’incontro nella teologia razionale.
Duns Scoto (1266-1274-1308): esiste un contrasto tra la verità razionale della metafisica, che è
propria della ragione umana e quindi valida per tutti gli uomini, e la verità della fede, alla
quale la ragione può essere solo attratta e che ha una certezza solo per i credenti. Tutto ciò che
trascende i limiti della ragione umana non è scienza ma azione e conoscenza pratica,
concernente i fini cui l’uomo deve tendere, i mezzi per raggiungerli e le norme da seguire.
Non c’è connessione tra il fine sopranaturale dell’uomo e la natura umana quale ci è dato
cogliere; si tratta di un fine che Dio ha voluto liberamente assegnare all’uomo e che non può
essere dimostrato come proprio della sua natura. Da ciò scaturisce la separazione tra il teorico e
il pratico: l’uno, dominio della necessità e quindi della dimostrazione razionale, l’altro,
dominio della libertà, sottratto a ogni dimostrazione, e perciò della fede.
La teologia 1) non può dirsi una scienza in senso proprio, in virtù del suo carattere pratico, di
tipo educativo (suo scopo, infatti, è di persuadere ad agire per la propria salvezza); 2) merita
una considerazione a sé, in quanto non subordinata a nessuna altra scienza, così come non ne
subordina a sé nessuna.
Ockham (1280-1348-1349): se il fondamento d’ogni conoscenza è da porre nell’esperienza,
occorre allora rigettare al di fuori d’ogni conoscenza possibile tutto ciò che trascende i limiti
dell’esperienza stessa. Ciò posto, la fede religiosa potrebbe essere dimostrata solo se si avesse
una conoscenza intuitiva di Dio e della realtà soprannaturale, il che è però impossibile
all’uomo.
I miracoli e la predicazione possono produrre la fede ma non anche la conoscenza evidente delle
sue verità, le quali, come non sono evidenti per se stesse (come lo sono i principi della
dimostrazione) così non sono nemmeno probabili perché possono apparire false a coloro che si
servono della ragione naturale.
Sul piano teologico, il principio di verificazione empirica trova riscontro nel continuo richiamo
al testo rivelato, che garantisce la teologia da ogni eccesso di razionalità astratta.
Giovanni da Salisbury (1110-1180): il richiamo alla setta degli accademici non ha significato per
lui la professione di un completo scetticismo, in quanto dubitare di tutto sarebbe un’assurdità
(non c’è niente di più ridicolo che essere incerti di tutto e tuttavia pretendersi filosofi).
Non solo gli animali danno prova di una certa intelligenza, ma l’uomo è più intelligente
dell’animale, sicché è falso ritenere che non siamo capaci di conoscere niente. Noi possiamo
attingere delle conoscenze sicure a tre differenti fonti: i sensi (del resto, colui che non avesse un
minimo di fiducia nei suoi sensi sarebbe inferiore agli animali), la ragione (in caso contrario,
colui che non credesse in alcun modo alla sua ragione e dubitasse di tutto arriverebbe a non
sapere più neanche se dubita) e la fede (colui che rifiutasse di acconsentire alla conoscenza
oscura ma certa della fede ricuserebbe il fondamento e il punto di partenza di ogni sapienza).
Bisogna tuttavia confessare che la modestia degli accademici è nella maggior parte dei casi
l’esempio più saggio che possiamo imitare, ossia quello di accontentarsi di arrivare alla
probabilità. I filosofi hanno confidato in maniera eccessiva nelle forze della ragione, sicché
bisogna dubitare di tutti gli argomenti di cui né i sensi, né la ragione, né la fede ci danno una
sicurezza incontestabile.
Il tipo di problema insolubile è quello degli universali, rispetto al quale si può dire come ne
veniamo a conoscenza (per astrazione) ma non cercare il modo della loro esistenza.
Guglielmo di Ockham (1300?-1349-1350): occorre riconoscere valido un solo genere di
dimostrazione, quella immediatamente evidente (provare una dimostrazione consiste nel
mostrare la sua evidenza immediata o derivata di necessità da una proposizione
immediatamente evidente). Se si vuole una proposizione che ci garantisca contemporaneamente
la sua verità e la realtà di ciò che afferma, occorre che essa abbia un’evidenza immediata, di tipo
intuitivo, posto che la conoscenza intuitiva è la sola che verte sull’esistenza e fa raggiungere i
fatti.
La conoscenza intuitiva è da associare alla conoscenza sperimentale che ci permette di
formulare in seguito, con una generalizzazione della conoscenza particolare, quelle proposizioni
universali che sono i principi dell’arte e della scienza.
L’universale non ha nessuna specie di esistenza fuori dal pensiero (in qualunque modo si
pretenda di concepire un universale realizzato nelle cose si arriva alla medesima assurdità di
non capire come possa esso possa essersi moltiplicato restando nello stesso tempo uno). Non è
possibile ritrovare con il pensiero, nelle cose, una natura comune reale, unica e medesima sotto
le sue determinazioni individuali (le ecceità di Duns Scoto).
Le proposizioni che nelle loro relazioni intessono il sapere si compongono di termini, i quali
possono entrare in proposizioni oggetto di scienza solo in quanto hanno un significato nel
rappresentare sia altre parole (es. “uomo” è una parola), sia delle cose (es. l’uomo corre), sia dei
concetti (es. l’uomo è un animale).
Mentre i termini che designano i concetti significano degli oggetti conosciuti in maniera
confusa, quelli che designano le cose significano gli oggetti conosciuti in maniera distinta.
L’esperienza non ci insegna peraltro nulla delle cosiddette specie, riportandosi sempre ad
un’intuizione sensibile che lascia nell’intelletto una traccia del suo passaggio divenendo
immagine (in presenza di cose simili si formano immagini comuni, la cui universalità si riduce
a questa comunanza e perciò si genera nel pensiero sotto l’azione delle cose individuali).
Roberto di Holkot (-1349): poiché il mistero della Trinità è inconciliabile con le esigenze della
logica, bisogna dedurne l’esistenza di un’altra logica, propria della teologia e sconosciuta ai
filosofi. Aristotele, infatti, in quanto scopritore del principio di contraddizione, non ha capito
che lo stesso può essere contemporaneamente uno e tre. Questo non significa che la teologia
rinunci alla ragione o alla logica, ma che essa adotta una logica della fede, a suo modo
razionale, benché i suoi principi siano differenti in quanto valida su di un piano di
intelligibilità superiore a quello della ragione filosofica.
Nicola d’Autrecourt (133-1350): non v’è da ammettere che un solo ordine di conoscenze
assolutamente certe, quelle che sono immediatamente evidenti attraverso la constatazione
sperimentale o per l’affermazione dell’identità di una cosa con se stessa.
Il principio di contraddizione è il principio primo al quale vanno riportate le conoscenze (dal
fatto che una cosa è non se ne può dedurre con è evidenza che ne esiste un’altra).
Di qui risulta che il legame che unisce la causa all’effetto non è né necessario né evidente: esso
non è analitico, in quanto il rapporto causale può esserci dato solo nell’esperienza, la quale è
l’unica ad autorizzarci a fare delle affermazioni di causa. Può esserci conoscenza diretta della
causalità, ma essa dura quanto l’esperienza sensibile per la quale noi constatiamo la
coesistenza della causa e dell’effetto. Una volta acquisita la constatazione sperimentale, resta la
semplice probabilità che si riproducano in futuro gli stessi effetti a parità di condizioni (il valore
delle inferenze logiche è pertanto meramente presuntivo).
Ciò vale anche per la sostanza, in rapporto alla quale si può dire che un accidente è in una
sostanza ogni volta che è dato nell’esperienza contemporaneamente ad essa.
Ponendo la conoscenza intuitiva, ossia l’esperienza immediata, all’origine di ogni nostra
certezza, viene garantito un numero minimo di conoscenze che nessun dubbio può mai
scuotere (lo sperimentalismo diviene così rifugio contro lo scetticismo).
III FILOSOFIA MODERNA
Sanchez (1552-1623) prende avvio nel suo Quod nihil scitur (1581) da una critica intellettuale
dell’aristotelismo, sostenendo che, posto che le scienze si basano su definizioni, queste sono
tutte esclusivamente nominalistiche, non contenendo altro che nomi imposti arbitrariamente e
capricciosamente alle cose, privi dunque di rapporto con le cose stesse e, oltre a ciò, soggetti a
mutamento.
Se poi si ritiene che i nomi assegnati ad un oggetto non mutano di significato, questo prova solo
la loro superfluità e incapacità di spiegare l’essenza del medesimo. Diversamente, se si assume
che i nomi significano qualcosa di diverso dall’oggetto, si viene a negare qualsiasi
corrispondenza tra loro (essi non nominano l’oggetto).
Anche la nozione aristotelica di scienza come «disposizione acquisita mediante dimostrazione»
presta il fianco alla critica, considerato che i particolari che si cerca di spiegare con questa
scienza sono più chiari delle idee astratte con cui si intende chiarirli (si comprende meglio un
particolare come Socrate che una realtà come quella indicata dall’espressione “animale
razionale”).
Quanto al metodo dimostrativo adottato dalla scienza aristotelica, è da dire per Sanchez che il
metodo sillogistico, lungi dal produrre informazioni nuove, implica un circolo vizioso (per
dimostrare infatti che Socrate è mortale, ci si fonda sulle due premesse che tutti gli uomini sono
mortali e che Socrate è un uomo). Di conseguenza, è un metodo inutile e artificiale che non ha
nulla da spartire con l’acquisizione del sapere.
Se da un lato la scienza non può essere certezza acquisita per il tramite di definizioni, dall’altro
essa non può essere nemmeno studio delle cause, in quanto questo porta inevitabilmente a un
regresso all’infinito.
Vera scienza si raggiunge solo con la perfetta conoscenza di una cosa, apprensione immediata
e intuitiva delle qualità reali di un oggetto; per questo essa si occupa dei particolari, ognuno da
comprendere individualmente (le generalizzazioni vanno oltre questo livello di conoscenza
scientifica, introducendo astrazioni).
In verità, gli esseri umani sono incapaci di pervenire alla certezza, dal momento che non solo
la natura degli oggetti ma anche quella dell’uomo è tale da impedire la piena conoscenza degli
oggetti individualmente considerati. Se per un verso, quindi, le cose non possono venire
conosciute individualmente per il fatto di essere tutte legate tra loro, ma, ciò che è peggio, per il
loro mutare continuo senza conseguire uno stato finale o completo, per l’altro le nostre idee
dipendono dai sensi, e delle cose i sensi percepiscono solo gli aspetti superficiali, gli
accidenti, non la sostanza (le imperfezioni e i limiti che Dio ha ritenuto opportuno lasciarci
sono tali da impedire ai nostri sensi e alle nostre facoltà di raggiungere la conoscenza vera).
L’uomo non può andare al di là di una conoscenza limitata e imperfetta di alcune delle cose che
rientrano nella sua esperienza, sempre che faccia uso dell’osservazione e del giudizio (il fatto è
però che pochi uomini di scienza fanno esperienza, così come pochi uomini sanno giudicare).
In generale, la conclusione negativa di Sanchez, lungi dall’essere una riedizione dello
scetticismo pirroniano e della sospensione del giudizio sulla possibilità della conoscenza, è in
buona parte una riedizione del più compiuto dogmatismo negativo degli accademici.
Michel de Montaigne (1533-1592) sembra essere l’autore che ha maggiormente risentito del
nuovo influsso di Sesto empirico, tanto che il suo pirronismo ha contribuito a creare la crisi
pirroniana dei primi decenni del Seicento. Egli si è reso pienamente conto della sua rilevanza
per i dibattiti religiosi del tempo.
Nella riscoperta della Grecia e di Roma e nella scoperta ed esplorazione del nuovo mondo egli
ha colto un significato vitale per la storia degli uomini, ravvisandovi la prova della relatività
delle conquiste intellettuali, culturali e sociali degli uomini.
Tema dominante dell’Apologia di Raymond Sebond, contenuta nei suoi Saggi, è rappresentata dalla
difesa di quella nuova forma di fideismo che va sotto il nome di pirronismo cattolico.
Delle due obiezioni alla tesi di Sebond che tutti gli articoli della religione cristiana possono
essere dimostrati dalla religione naturale – ossia che: 1) la religione deve fondarsi sulla fede e
non sulla ragione, e 2) le ragioni da lui proposte non erano corrette né convincenti – la prima
spinse Montaigne a svolgere il suo tema fideistico, e la seconda ad avanzare il suo scetticismo.
Nonostante la religione si basi solo sulla fede che ci è data dalla grazia divina, non c’è nulla di
male nell’usare la ragione a sostegno della fede (fa parte della debolezza della religione il fatto
di poggiare su fattori umani come il costume e la collocazione geografica). La funzione
sussidiaria della ragione va posta però dopo l’accettazione di Dio attraverso la fede.
L’affermazione di un atteggiamento scettico nei confronti delle pretese intellettuali dell’uomo
mira a colpire la presunzione di pensare di poter comprendere il cosmo anche senza l’aiuto
della luce divina (le glorie del regno animale vengono contrapposte alla vanità, alla stupidità e
all’immoralità del mondo umano).
L’attacco scettico di Montaigne, mirante a coltivare l’ignoranza (opposta alla presunta saggezza)
e a spingere alla fede, ripropone in forma accentuata l’anti-intellettualismo dell’Elogio della follia
di Erasmo. Egli richiama quello che sarebbe diventato il passo scritturale preferito dei “nouveau
pyrroniens”: la declamazione di S. Paolo nel primo capitolo della prima Lettera ai Corinzi
(Distruggerò la sapienza dei sapienti, annienterò l’intelligenza dei dotti”).
Montaigne tiene a distinguere il pirronismo dal dogmatismo negativo dello scetticismo
accademico: i pirroniani dubitano di ogni proposizione e sospendono il giudizio su ogni
proposizioni, anche su quella che afferma che tutto è dubbio. L’atteggiamento pirroniano
consente di vivere secondo la natura e il costume, mostrandosi come la conquista umana più
alta e compatibile con la religione (non solo, non avendo nessuna opinione positiva, lo scettico
non può avere opinioni sbagliate sulla religione, ma accettando le leggi e i costumi della
comunità a cui appartiene, egli aderisce al cattolicesimo difendendola dalla Riforma).
Se gli stessi pirroniani corrono però il rischio di perdersi asserendo qualcosa di positivo in
contrasto con i loro dubbi, ciò si deve al carattere assertivo del nostro linguaggio.
Non solo l’appello all’esperienza dei sensi è tenuto a mostrare che cosa si sperimenta e
insieme a provare la realtà di ciò che si pensa di sperimentare (perché il funzionamento dei
sensi è ingannevole), ma il richiamo alla facoltà razionale impone di stabilire
preventivamente la sua essenza (la sola via atta a consentirci di conoscere noi stessi è invero la
rivelazione di Dio, così come è la grazia divina a consentirci un contatto con la realtà). Né vale
affermare che alcuni giudizi sono più probabili di altri, perché il dissenso è generale, sia nella
storia di ciascuno che tra noi e gli altri (anche questo deve spingere al conservatorismo
pirroniano).
L’Apologia tratta delle tre forme di crisi scettica destinate a turbare gli intellettuali del primo
Seicento: teologica, conoscitiva e scientifica. In primo luogo lo scetticismo appare la sola difesa
possibile della regula fidei cattolica, posto che l’impossibilità di stabilire con mezzi razionali
quale sia il criterio valido impone di restare nel dubbio e di accettare l’autorità della tradizione.
In secondo luogo esso è il risultato della riscoperta della grande varietà di punti di vista dei
pensatori antichi seguita all’Umanesimo, nonché della scoperta del Mondo Nuovo. In terzo
luogo esso è il frutto maturo della revisione della revisione del modello aristotelico di scienza
come un insieme di verità certe concernenti il mondo.
Lo scetticismo nelle dispute religiose tra riformatori e controriformatori.
Attraverso la disputa sulla natura e sul valore della conoscenza religiosa le posizioni scettiche
dell’antichità si affacciano nel pensiero del tardo Rinascimento. Nelle dispute di tipo teologico
torna infatti il problema della individuazione di un criterio di verità che, in riferimento alla
conoscenza della natura, ha innescato la crisi pirroniana del primo Seicento.
Se per riconoscere la vera fede occorre un criterio, come si riconosce il vero criterio? La volontà
di difendere il cattolicesimo apre la strada ad un atteggiamento scettico. L’esempio è dato da
Erasmo che avanza l’idea dell’opportunità di una difesa scettica della chiesa (il disprezzo per le
imprese intellettuali si sposa nell’Elogio della follia con la difesa di una pietà cristiana semplice e
non teologica). La Scrittura non è così trasparente come Lutero vuole e anzi certi passi sono
troppo oscuri perché gli esseri umani possano penetrarne il significato (per convincersene, basta
pensare alle interminabili dispute dei teologi).
Lutero: un cristiano non può essere scettico, in quanto deve essere certo di ciò che afferma
(essere cristiani vuol dire affermare certe verità a motivo del fatto che la propria coscienza ne è
completamente convinta). Secondo la sua regula fidei è vero ciò che la coscienza è costretta a
credere alla lettura della Scrittura.
Posto che la regula fidei dei riformatori sembra identificarsi con la certezza soggettiva, si
comprende perché, a dispetto dell’enfasi con cui Lutero criticò lo scetticismo di Erasmo,
l’affermazione che i riformatori non erano altro che scettici travestiti divenne un motivo
ricorrente dei controriformatori.
Qual è il criterio atto a distinguere la fede vera da quella falsa? Non appena si ammette, come
fanno i riformatori che la chiesa può sbagliare, non si può evitare la disperazione scettica,
perché nessuno può identificare il messaggio o il significato della Scrittura sulla base della sola
Scrittura (la Riforma non può offrirci che le dubbie opinioni di Lutero, Calvino e di Zwingli).
Il metodo di François Veron (La victorieuse methode pour combattere tous les ministres: par la seule
Bible, 1621) consiste in proposito nel mettere in luce che: a) i calvinisti non avevano nessuna
ragione per presentare le proprie tesi come articoli di fede; b) l’applicazione sistematica di una
serie di obiezioni scettiche alla regula fidei dei riformatori non poteva che farli approdare ad un
completo pirronismo. Non che le facoltà razionali siano dubbie, ma esse non possono fungere
da fondamento o da sostegno della fede. Inoltre, per poter elevare a regola della Scrittura la
persuasione interiore occorre esser certi che essa sia causata dallo Spirito Santo e non sia un
prodotto dell’immaginazione. La Bibbia non enuncia peraltro nessun canone interpretativo e
nessuna regola logica; sicché la tesi che le verità della religione debbano fondarsi su procedure
logiche è priva di ogni garanzia.
Lo scetticismo invocato da Veron non si rivolge contro i sensi o la ragione ma contro il loro uso
nelle questioni religiose (i criteri di conoscenza adottati dai riformatori non si addicono alle
questioni di fede, ma non per questo sono necessariamente dubbi in altri campi e per altri
scopi).
Per quanto i protestanti protestassero che l’approccio scettico proposto da Veron poteva
applicarsi anche al suo inventore con i medesimi risultati, i cattolici non risultavano invero
danneggiati dal bombardamento scettico poiché la loro posizione era fondata sulla fede
accertata e indiscussa nella tradizione cattolica (la sicurezza e la salvezza sono da cercare nella
rinuncia ad ogni teoria).
Anche per la figura di maggior spicco tra i “libertini eruditi”, François de la Mothe Le Vayer, lo
scetticismo radicale presenta il vantaggio, oltre che di minare l’orgoglio e la fiducia in sé dei
dogmatici, di essere la posizione più vicina al vero cristianesimo (il perfetto pirroniano è colui
che, sbarazzandosi di tutti gli errori, è pronto ad accogliere la parola di Dio; diversamente egli
causerebbe da sé la propria rovina). In realtà lo scetticismo radicale è una strada a doppio
senso da cui si può uscire sia in direzione della ragionevolezza dell’Illuminismo che in
direzione della fede cieca del fideista.
Accanto agli scettici umanisti vi furono anche pensatori di orientamento scettico che
presentarono il loro punto di vista nell’ottica del pensiero scientifico. Tra questi è da
annoverare Pierre Gassendi (Exercitatines paradoxiae adversus Aristoteleos, 1624), per il quale il
tentativo di scoprire le verità scientifiche alla maniera di Aristotele è destinato al fallimento
perché principi e definizioni possono essere derivati solo dall’esperienza da cui proviene ogni
informazione (anche il ragionamento sillogistico non fa guadagnare conoscenza in quanto
presume il ricorso a tale fonte, posto che le sue premesse sono vere solo se abbiamo appreso
empiricamente la verità della conclusione).
Con Sesto Empirico Gassendi ripete: non possiamo dire come le cose sono in se stesse ma solo
come ci appaiono (la distinzione da lui operata tra qualità apparenti e qualità reali è una delle
prime formulazioni della distinzione tra qualità primarie e secondarie nella filosofia dell’età
moderna).
La sua argomentazione non era volta tuttavia a mettere in discussione la verità divina,
accettata in un’ottica fideistica, né le informazioni del senso comune, rivolgendosi contro ogni
tentativo di costruire una scienza necessaria della natura che trascenda le apparenze e le spieghi
nei termini di cause non evidenti, e negando l’esistenza di concetti innati in base ai quali il
sapere possa essere costruito su basi razionali (tanto l’essenza profonda della natura è
conosciuta solo da Dio, quanto gli universali sono nozioni astratte, costruite dagli uomini per
comodità linguistica, e perciò prive di ogni validità ontologica).
Sviluppando poi la teoria atomistica di Epicureo sotto forma di ipotesi i di modello
meccanicistico atto a spiegare le apparenze e a predire i fenomeni futuri, Gassendi (Syntagma
philosophicum, 1658) tentò di mitigare il suo iniziale pirronismo fino a modificarlo in una sorta di
“scetticismo costruttivo”, portato a dubitare esclusivamente della possibilità di fornire ragioni
necessarie e sufficienti delle nostre conoscenze e credenze (le idee chiare e distinte
dell’intelletto non ci fanno attingere conoscenze vere).
L’ammissione della possibilità di verità convincenti e probabili sulle apparenze fondate
sulla conoscenza empirica ha rappresentato dunque un modo di affrontare la crisi scettica in
sintonia con l’affermarsi della prospettiva scientifica. Secondo Mersenne (La vérité des sciences
contre les sceptiques ou pyrrhoniens, 1625), anche ammesso che non sia possibile refutare le tesi
degli scettici, nondimeno si può avere un tipo di conoscenza al riparo dal dubbio e adeguato
ai bisogni della vita (naturalmente non si tratta della conoscenza concernente la reale natura
delle cose di cui andavano alla ricerca i filosofi dogmatici, ma delle informazioni concernenti le
apparenze, di ipotesi e predizioni sui legami tra gli eventi e sul corso futuro dell’esperienza).
Non a caso nel testo de La vérité si affrontano le posizioni di un alchimista, di uno scettico e di
un filosofo cristiano, per dimostrare che le difficoltà sollevate dal pirroniano (per il quale le
essenze vere delle cose non possono essere oggetto di conoscenza, da limitare perciò agli effetti
e non alle cause ultime e alla natura profonda della realtà) non dimostrano che non è possibile
conoscere nulla, in quanto le conoscenze, seppure limitate agli effetti, hanno un valore di tipo
pragmatico (è vero, infatti, che possiamo conoscere qualcosa riguardo alle apparenze, e che tali
conoscenze sono adeguate alle necessità della vita). Non solo non è dato dubitare di tutto,
perché ciò porterebbe all’infelicità, ma v’è la possibilità di dare risposta a determinate questioni
ricorrendo a mezzi di misurazione. Oltre a ciò, esistono conoscenze autoevidenti che possono
essere usate come massime su cui costruire il sapere scientifico, impedendo che la spiegazione
cada in un regresso all’infinito (basta impiegare correttamente le nostre facoltà, usando i sensi,
le regole, gli strumenti, per vedere che le conoscenze hanno un sufficiente grado di affidabilità
e che la loro utilità non dipende dalla scoperta dei fondamenti di tutte le certezze); il che non
giustifica la possibilità di giungere ad una fondazione metafisica della fisica, alla maniera di
Cartesio, perché la scienza deve limitarsi alla descrizione dei fenomeni.
Cartesio (1596-1650): le nostre rappresentazioni si fondano su nozioni originarie (ad es. quella
di verità), quali modalità fondamentali del rappresentare che il nostro spirito possiede in forza
della sua basilare costituzione. Queste nozioni ci sono chiare in maniera intuitiva (ad es.
l’essere del pensiero nel cogito ci è dato in una conoscenza chiara e intuitiva). Le nozioni
originarie sono in primo luogo percepite intuitivamente dalla facoltà conoscitiva e in secondo
luogo elaborate concettualmente, ossia concepite (oltre che forme del pensiero, esse sono forme
del rappresentare).
Le nozioni originarie “materiali” sono nozioni dell’essere e delle sue proprietà; in tale tipo di
nozioni originarie vanno distinte quelle che rappresentano determinazioni fondamentali
(essere, pensiero, estensione) e quelle che possono essere intese come determinazioni ulteriori di
queste sostanze (ad es. l’intelletto e la volontà a proposito del pensiero). Pensiero ed estensione
non possono a loro volta essere attributi ad una sostanza superiore (Dio). Possiamo spiegare le
nozioni primarie, gli attributi o i modi, soltanto come determinazioni ulteriori di nozioni
superiori.
Nelle nozioni originarie “formali” sono invece da comprendere rappresentazioni di rapporti
mediante cui sono date relazioni tra le cose (i “vincula” che esprimono tali relazioni sono
soltanto nel pensiero nel senso che essi non sono sostanze).
Compresa tra le nozioni originarie “metafisiche”, insieme alla verità e all’ordine, la perfezione
intende la completezza dell’essere da attribuire a Dio in quanto sostanza infinita comprendente
ogni perfezione.
Tra le nozioni originarie, due si distinguono per il fatto di rendere immediatamente evidente
l’essere: la cogitatio nell’atto del cogito e Dio, il verum-perfectum, mediante l’idea di lui (l’idea di
Dio rivela il suo essere come idea originaria, non come concetto riflessivo secondario, rinviando
a qualcosa che può essere riconosciuto solo a partire da se stesso).
Delle tre sostanze ammesse da Cartesio: pensiero, estensione e Dio, quest’ultima si distingue
dunque dalle altre due perché il suo essere viene colto mediante una nozione originaria
“metafisica”. Essa è accessibile al nostro conoscere solo attraverso la coscienza, nel senso che
mediante l’idea di Dio abbiamo accesso all’essere di Dio.
Tra le nozioni originarie, il pensiero ha la prerogativa dell’assoluta immediatezza,
manifestandosi anzitutto in una percezione (introspezione, intellezione), a partire dalla quale il
concetto del cogitare viene svolto nelle sue determinazioni essenziali attraverso operazioni
dell’intelletto. Tutto quanto non è cogito è mediato dalle idee del pensiero (quest’assoluta
precedenza del pensiero rispetto ad ogni conoscenza di un’altra cosa conferisce al cogitare una
precisa priorità e una dignità primaria in quanto nozione primaria).
La semplice intuizione mi dà il mio essere come cogitans (se cerco, infatti, di negare che il mio
pensare è, devo constatare che nel negare già sempre lo attuo), di cui posso percepire
immediatamente anche i modi nei differenti atti del pensare (dubitare, comprendere, volere,
immaginare, sentire ecc.). Il nostro conoscere scopre anche deficienze della cogitatio, il cui
essere è assicurato soltanto dall’atto del cogito e non una volta per tutte (di qui anche
l’impossibilità di stabilire una continuità tra l’atto presente e l’essere futuro), e non dà garanzie
in rapporto alla corrispondenza delle rappresentazioni con la realtà esterna (le cose sono
come le concepiamo?). In ultimo, essa ci conduce alla conoscenza di Dio senza farci
comprendere come egli sia (la sua potenza ci è incomprensibile). L’idea di Dio, in quanto idea,
non può venire considerata come principiata in maniera sufficiente dal cogito in quanto
primo principio.
Con il verbo cogitare Cartesio non esprime soltanto il pensiero contrapposto all’estensione, ma
designa un’azione del pensare che prende le mosse da una fondamentale insicurezza e che
accade per produrre qualcosa di sicuro e costante (ciò risulta riconoscibile dal fatto che il
pensiero non viene solo determinato dai modi dell’intelletto e della volontà, ma viene suddiviso
in cognitio, dubium e ignorantia).
Nell’originario affermarsi del cogito non si vede ancora chiaramente dove sicuramente
sappiamo qualcosa e che cosa esso sia. Per questo, nel pensiero che seriamente inizia è all’opera
il dubbio universale. Nel suo iniziare il pensiero non è solo insicuro rispetto a ciò che esso
pensa ma è insicuro anche rispetto al suo proprio modo del pensare. (In quanto il dubbio è nel
cogito veramente tale, è esame della verità o della non verità di ciò che si dubita.)
È solo l’idea della verità come corrispondenza conosciuta di una rappresentazione con il suo
oggetto a conferire al pensiero il suo proprio carattere di ricerca della verità (la sua idea è da
anteporre al “vero” che viene predicato in rapporto a qualcosa).
L'idea di Dio è un momento che rende possibile il cogito in quanto tale, il cui tratto essenziale è
di essere orientato intenzionalmente alla perfetta verità e alla perfetta bontà (là dove il cogito
è pensato come ciò che è nella sua sostanza spirituale, lì è insieme pensato Dio come
principiatore).
L'idea di Dio non può essere intesa come qualcosa di principiato del cogito, dato che
quest'ultimo non può essere la ragion sufficiente dell'esserci in se stesso di questa idea. Bisogna
pensare il cogito come necessariamente principiato da Dio, in quanto ciò che per essenza
desidera, dubita, domanda, ossia ciò che è infirme, può avere una natura siffatta solo in
rapporto a un essere perfectum e firmum, ovvero a un vero conoscere e a una vera volontà
buona. Del resto, se il cogito non soltanto è tale ma si comprende come tale, ogni cogitare non è
necessariamente in relazione alla verità in quanto tale (solo a partire dalla verità esso può
cogliersi come difettibile e instabile, quale ente che non è e né si conosce come il perfetto). Da
ciò consegue che il cogito non risulta essere un principio supremo, dato che non è principio
della sua esistenza (la conoscenza della sua difettività è condizione di possibilità dell’idea della
sovrana indipendenza di Dio, la cui potenza ci è incomprensibile)
In quanto viene riconosciuto nell’autoafferrarsi del cogito come ciò assolutamente rende
possibile il cogito stesso, orientandolo alla domanda della verità, Dio non è una
rappresentazione escogitata in modo arbitrario o comparsa soltanto a posteriori, dal momento
poi che lo spirito finito non può essere la ragione sufficiente della sua idea in lui.
Cartesio ha applicato il metodo del dubbio sistematico all'intero edificio della conoscenza
umana allo scopo di scoprire un fondamento certo per tutto il sapere (tale metodo prende
avvio sotto forma di applicazione sistematica dei dubbi di Montaigne e Charron).
La regola seguita è di tenere per vero solo ciò che presenta il carattere dell'evidenza, evitando
ogni precipitazione di giudizio così come un atteggiamento prevenuto, e accogliendo nel
proprio giudizio solo ciò che si presenta in modo chiaro e distinto.
I livelli di dubbio sono molto più numerosi e profondi di quelli semplici e blandi introdotti
finora dagli scettici (i quali investono la veracità della comune esperienza sensoriale e la stessa
realtà del mondo), dovendosi ammettere anche la possibilità che le nostre stesse facoltà siano
ingannevoli (ipotesi del demone). In tal caso, la scrupolosità d'analisi con cui sono vagliate le
conoscenze non basta, in quanto sono gli stessi strumenti di conoscenza ad essere fuorviati.
Mentre nelle Regole per la guida dell'intelligenza (1628), in un momento in cui Cartesio non aveva
ancora concepito il progetto di misurarsi con la crise pyrrhonienne, matematica e geometria
offrivano un punto saldo contro ogni falsità e incertezza, successivamente anche queste sono
investite del dubbio quando alla critica della conoscenza si sostituisce la critica dei mezzi della
conoscenza.
La differenza tra la procedura degli scettici e quella di Cartesio consiste nell'obiettivo
dell'applicazione del metodo e nel suo sbocco: mentre i primi dubitano solo per ostinazione, egli
esercita il dubbio per raggiungere la certezza. Suo intento è di individuare nella mente stessa
le verità fondamentali e indubitabili, i fondamenti della conoscenza umana, nascosti da
pregiudizi e opinioni. Il fatto stesso di spingere lo scetticismo fino al limite fa incontrare una
verità che non si può mettere in discussione in nessun modo (il dubbio costringe infatti la
persona a riconoscere la consapevolezza di sé, a rendersi conto di dubitare o di pensare, e di
essere qui, nell'esistenza). Tuttavia, la sola certezza acquisita dal metodo del dubbio non è una
premessa; essa è semplicemente un fondamento del discorso razionale cui possano derivare la
verità delle conoscenze riguardanti la natura delle cose.
Solo se si conosce una verità si può procedere alla costruzione di una teoria della verità. Il
cogito è tale verità, perché ci colpisce a tal punto con la sua chiarezza e distinzione da impedirci
di dubitarne (con chiarezza va intesa la proprietà di ciò che è presente e manifesto a una mente
attenta, mentre con distinzione la chiarezza che distingue questa consapevolezza da tutte le
altre). L'idea è che, una volta in possesso di un criterio di verità, si possono cogliere con esso le
premesse di un sistema metafisico di conoscenze vere che a sua volta dà fondamento a un
sistema fisico di conoscenze vere.
L'assioma che la realtà oggettiva delle nostre idee esige una causa in cui sia contenuta la
stessa realtà, non oggettivamente ma formalmente o eminentemente, costituisce il primo ponte
cruciale dalle verità della mente alle verità concernenti cose che vanno al di là delle nostre dee,
ossia dalla consapevolezza soggettiva di una verità concernente le nostre idee alla conoscenza
della realtà.
L'idea di Dio esige una causa che abbia, formalmente o eminentemente, almeno le stesse sue
proprietà; questo significa che la causa, come oggetto reale indipendente, ha almeno le stesse
caratteristiche dell'idea (in tal senso, le perfezioni contenute nell'idea di Dio devono essere nello
stesso tempo perfezioni di Dio). La divinità onnipotente deve diventare il fondamento ultimo e
la garanzia definitiva della nostra certezza, perché se la certezza interiore sulle nostre idee ci
convince dell'esistenza oggettiva di un Dio da cui siamo totalmente dipendenti per il nostro
essere e per il nostro conoscere, occorre poi che tale certezza sia giustificata oggettivamente da
Dio (in modo da essere in rapporto con il mondo reale).
La possibilità che Dio abbia tratti demoniaci è esclusa in virtù delle stesse caratteristiche
dell'idea chiara e distinta che gli uomini ne hanno. Poiché Dio, loro creatore, non può
ingannare, e la facoltà di cui li ha dotati fa giudicare vero tutto ciò che essi concepiscono in
maniera chiara e distinta, allora la loro facoltà di giudicare è garantita.
G. Berkeley (1685-1753): la direzione principale della sua indagine, di cui è premessa la critica
del concetto di percezione, si annuncia nel problema formulato nel Saggio di una nuova teoria
della visione (1709), ossia quello della distanza che non è un oggetto dell’impressione sensoriale.
Se con percezione intendiamo unicamente il contenuto isolato di un’impressione, allora risulta
che essa non può darci testimonianza dell’oggetto nella sua interezza. La realtà oggettiva sorge
di fronte a noi solo in virtù di un’interpretazione dei segni sensibili (attraverso la connessione
tra le diverse classi di impressioni sensibili e la considerazione della loro dipendenza reciproca
avviene il primo passo nella costruzione della realtà). In tal senso, l’indagine di Berkeley ha per
riferimento il principio fissato da Cartesio nella Diottrica (1637) secondo cui a vedere non è
propriamente l’occhio ma lo spirito.
Nel Trattato sui principi della conoscenza umana (1710) Berkeley ha distinto la sua prospettiva
rigorosamente psicologica dagli altri metodi con cui la fisica e la fisiologia affrontano il
problema della percezione, in quanto nel processo di associazione la coscienza non è dominata
da leggi razionali ma è guidata dall’esercizio e dalla consuetudine (la connessione tra i diversi
contenuti non è dedotta ma “suggerita”). Il contenuto della coscienza non si esaurisce
comunque nei dati particolari dell’impressione sensibile della rappresentazione, ma sorge
attraverso la loro reciproca connessione (ad attribuire valore di realtà ad un complesso
rappresentativo non è il rapporto con un mondo di sostanze materiali ma la costanza e la
compiutezza che mostra il gruppo di sensazioni corrispondente a tale complesso).
Nessuna delle differenti sfere di impressioni sensoriali può vantare una preminenza rispetto alle
altre, quando si consideri il problema dell’oggettività (solo nella loro totalità esse possono
realizzare il vero concetto di oggetto). La separazione tra qualità primarie e secondarie è solo
un’astrazione metodologica che non può essere elevata al grado di una realtà metafisica (se le
qualità secondarie sono idee, oggetti mentali, con esse sono inestricabilmente connesse quelle
primarie, anch’esse idee). Quanto a tale realtà, se la si concepisce come sostanza, si fa fatica ad
ammettere accanto a questa degli attributi distinguibili da essa e senza i quali dovrebbe essere
pensata la sostanzialità della sostanza (il senso degli attributi è pertanto il significato dei termini
che indicano una certa sostanza).
La rappresentazione in quanto tale è e rimane individuale: la sua universalità nel concetto non
comporta un accrescimento di contenuto, bensì una nuova qualità particolare che essa acquista
attraverso la considerazione dello spirito. Ad essere negata così non è la teoria dei concetti
generali secondo cui vi sono concetti di carattere universale composti dalle proprietà essenziali
degli oggetti di cui il concetto è concetto, ma quella dell’astrazione che pone un’idea come
distinta dalle idee particolari (la generalità è da intendere come una funzione relazionale delle
idee in cui un’idea, sempre particolare, viene posta a rappresentare le altre dopo che si è
spostato l’attenzione dalla sua particolarità).
Se non va negata l’esistenza delle cose sensibili, va chiarito tuttavia il concetto di esistenza, una
volta messo in primo piano la stabilità e connessione regolare dei contenuti rappresentativi, così
da riporre la garanzia della realtà non già nella materia dell’impressione sensibile ma nella
connessione necessaria che tale materia acquista nella considerazione scientifica, giusta
l’impossibilità di pensare a qualcosa di esistente indipendentemente da una mente che la
percepisca.
Se problema centrale del sapere è il superamento dello scetticismo, termine costante di
paragone non può che essere la certezza immediata del senso comune, non scalfita da dubbi né
dal senso di disfatta tipico di chi abbandona le sicurezze del buon senso per indagare i
fondamenti e la verità della realtà. Lungi dal confortare nella conoscenza, la filosofia ne
risulta l’unico ostacolo, sollevando difficoltà laddove la conoscenza umana si dimostra
comunemente in grado di accedere alla realtà.
La difesa delle posizioni della religione passa attraverso la critica della nozione di sostanza
materiale (per definizione inattingibile) cui hanno fatto ricorso tutti quei filosofi che hanno
operato nella direzione di una progressiva laicizzazione della concezione del mondo. La
contraddittoria presupposizione di un qualcosa di esterno alla mente che, pur opposto e
dissimile alle impressioni sensibili, e quindi alle idee, ne garantisca l’oggettività presentandole
come copie di modelli differenti, porta allo scetticismo (questo ha la sua base nella
duplicazione di piani per cui l’esperienza è la copia di una realtà esterna all’esperienza stessa e
da questa indipendente). Se tutta la realtà trova il suo essere nell’essere percepita, se essa
consiste e si esaurisce nelle idee nelle menti che le percepiscono, allora la nostra conoscenza è in
grado di coglierla in quanto essa coincide con i contenuti della mente.
L’affermazione del primo principio (esse est percepi) quale risolutore di tutta la realtà nell’ordine
delle idee, nel loro essere esclusivamente realtà percettive, mette in luce un secondo ordine di
realtà: quello dei percettori, degli spiriti (le menti). Le idee, il cui carattere è passivo, rimandano
infatti ad una sostanza eminentemente attiva che le supporta e le giustifica: la sostanza
pensante, il cui carattere e quello dell’attività (del pensiero, della percezione, della volizione).
Ciò significa che solo gli spiriti, ossia le menti, le anime, se stessi, sono sostanze nel senso
scolastico del termine come ciò che sussiste per sé. Il primo principio non si limita però a
spazzare via il concetto di sostanza materiale, ma fornisce una nuova prova dell’esistenza di
Dio, fondata sulla sua manifestazione tramite l’insieme ordinato e coerente delle idee che
costituiscono la nostra esperienza quotidiana del mondo (da questo punto di vista, si fa delle
idee, degli oggetti delle percezione sensibile, i segni dell’esistenza divina). Questo si spiega
perché le idee sono le cose reali e pur dipendendo da una mente non dipendono dalla nostra
mente ma da quella di Dio, il quale percepisce costantemente la totalità della realtà, come un
percepire che è produzione di idee.
La conoscenza umana è sottomessa alla funzione di momento necessario ad una fondazione
della fede, posto che anche la ricerca delle leggi naturali finisce per apparire come la ricerca
della regolarità dei segni della manifestazione di Dio giustificata dalla sua bontà (la produzione
di idee da parte di Dio non avviene in base a un arbitrio privo di regole, ma è organizzata al fine
di garantire tale ordine e regolarità secondo metodi che si riflettono nelle leggi di natura).
In verità, è da dire però che non potremmo intendere né leggere i segni offertici dalle
impressioni particolari e non potremmo raccoglierli in un testo unitario, se sin dal principio
non fossimo sicuri che essi nascondono in sé un significato (il postulato razionale di un’intima
uniformità del processo naturale rimanda ancora all’intuizione religiosa dell’attività divina
come garanzia dell’intima connessione razionale dei fenomeni).
Hume (1711-1776): la generalità non è una caratteristica psicologica che possa essere posseduta
immediatamente o acquistata da un contenuto rappresentativo nel corso dell’esperienza, ma
spetta unicamente alla parola che, nella sua indeterminatezza, non può comprendere in sé e
riprodurre tutti i tratti particolari dell’immagine della percezione. Con quest’ultimo termine
Hume ha inteso ogni contenuto psichico, distinguendo poi le percezioni in impressioni, quali
passioni e immagini immediatamente presenti alla mente, e idee, quali copie illanguidite delle
impressioni (questa differenza fondata sulla vivacità e sulla forza è posta al riparo dal mutare
degli stati del soggetto, permanendo anche quando l’uso della mente è offuscato dalla malattia o
impedito dalla pazzia). La percezione non è una semplice rappresentazione di oggetti, bensì una
vera e propria manifestazione di significato che implica come condizione del suo stesso svelarsi
l’impegno del soggetto quale attivo teatro d’esperienza.
Se si vogliono comprendere i meccanismi di formazione e articolazione dei concetti, occorre
riconoscere che essi sono guidati da un’abitudine di natura linguistica. Anche se, da un lato
sembra che le idee traggano il loro valore universale da una certa generalizzazione di natura
linguistica; dall’altro è affermato che il vero significato di una parola risiede nell’idea a cui
viene abitualmente riferita, la quale ha come radice ultima l’impressione che essa rispecchia con
minore vivacità. Hume condivide il nominalismo di Berkeley: anche per lui l’idea astratta non è
altro che un’idea particolare assunta come rappresentativa di un insieme di individui tra loro
somiglianti. Esistono quindi solo idee particolari assunte per abitudine come segni di altre
idee particolari ad esse simili (il nome adoperato per riunirle risveglia in noi nient’altro che
l’abitudine di considerarle assieme e quindi l’una o l’altra, a seconda dell’occasione). Lavorando
sulla somiglianza tra le idee, la mente umana è in grado di costruire artificialmente sistemi di
idee complesse (questa composizione delle idee da parte della mente non conosce quasi limiti
slanciandosi verso mondi fantastici).
Se la conoscenza è un insieme di percezioni che si distinguono tra loro in impressioni e idee
sulla base sia della loro successione nella mente sia della loro differente forza e vivacità, è
l’immaginazione ad avere in essa un ruolo centrale come capacità associativa nella vita della
mente. Ciò non giustifica la convinzione che la mente percepisca direttamente le cose stesse o le
sostanze, siano esse concepite come corporee o come spirituali, o ancora le connessioni reali tra
le cose.
Alla memoria, cui spetta poi riprodurre le relazioni e le successioni di impressioni e idee,
bisogna aggiungere infatti l’immaginazione che può associare le idee più o meno liberamente,
componendole e componendole, fino a produrre quelle idee complesse i cui nessi presentano
indubbiamente ordine e regolarità senza più rispecchiare l’ordine che le impressioni avevano al
loro presentarsi alla mente (questa associazione e connessione di idee si regola in base ai
principi della somiglianza, della contiguità nel tempo e nello spazio e della causalità).
Tra le idee complesse va menzionata quella di sostanza, con la quale i filosofi hanno inteso
un’entità fittizia dietro la quale si nasconde un puro nome col quale si designa un aggregato di
idee semplici (ma analoga ipostatizzazione può essere scorta in relazione allo spazio e al tempo,
erroneamente intese come entità distinte dalle singole esperienze spazio-temporali).
Posto che le possibili relazioni possono riguardare le relazioni tra le idee e le relazioni con
l’esperienza, va detto che solo alle prime spetta una certezza apodittica (quella delle verità
matematiche, la cui negazione implica contraddizione), mentre alle seconde va attribuita una
conoscenza soltanto probabile, non dipendendo esse dal principio di contraddizione (perché
il contrario di un fatto è sempre possibile). Con ciò è stabilita una gerarchia di tipi di verità o di
certezza, in quanto alle verità «evidenti», indubitabili, della matematica, sono da ritenere
inferiori quelle «provate», derivanti da constate connessioni causali, e quelle «probabili», il cui
grado di certezza è ancora minore. La relazione causale su cui si fondano tutti i ragionamenti
che riguardano realtà o fatti si fondano è pertanto del secondo tipo, in quanto non possiede a
priori validità (non può essere conosciuta per via puramente razionale) né è dotata di necessità
logica (causa ed effetto sono due fatti interamente diversi, ognuno dei quali non ha nulla che
richiami necessariamente l’altro) ma è ricavata esclusivamente dall’esperienza, assumendo
carattere di necessità in virtù di un processo inferenziale della mente che, in virtù dell’abitudine,
concepisce la successione di due fenomeni nei termini di una concatenazione stretta (anche il
motivo dell’uniformità della natura è viziato dall’abitudine a veder seguire determinati
fenomeni da altri; questa esperienza riguarda però sempre il passato e mai il futuro).
Il fondamento di tale relazione non può essere che psicologico, nel dar luogo ad una credenza
formatasi appunto per il ripetersi costante di casi simili, la quale è alla base delle azioni e del
comportamento umano e pertanto non può essere rimossa anche dopo essere divenuti
consapevoli della sua infondatezza. La sua necessità è quindi puramente soggettiva e va
cercata in una disposizione della natura umana: l’abitudine; la quale, com’è ovvio, spiega
perché noi crediamo alla necessità delle legami causali, ma non giustifica anche questa
necessità.
Hume ha fatto oggetto di riflessione anche l’idea dell’esistenza e della permanenza degli oggetti
esterni e della sostanza pensante, mostrando in quest’ultimo caso come sia impossibile avere
percezione di sé indipendentemente da un contenuto mentale (questo ha ripetuto a suo modo
Kant con l’affermare che il soggetto conoscente e non solo l’oggetto dell’esperienza è
fenomeno). L’esperienza dell’io va ridotto pertanto al flusso del proprio percepire, al cui interno
i rapporti di somiglianza e causalità determinano il legame tra le diverse percezioni.
Anche in questo caso, lo scetticismo teorico che è al fondo di queste riflessioni – quello per cui la
credenza nell’esistenza della realtà esterna è ingiustificabile, perché la sola realtà di cui siamo
certi è costituita dalle percezioni – non è spinto al punto da modificare l’atteggiamento pratico
del vivere quotidiano, dal momento che le credenze del senso comune hanno una
legittimazione extrateorica che le pone al riparo dall’assalto dello scetticismo radicale. Non
intendendo annullare la differenza tra finzione e credenza, Hume ha concepito quest’ultima
come un sentimento naturale decritto come «una concezione più vivace, intensa e potente di
quella che accompagna le pure funzioni dell’immaginazione, concezione che sorge da una
congiunzione abituale del suo oggetto con qualcosa di presente alla memoria e ai sensi».
In quanto “filosofo della natura umana”, quella a cui si riallaccia ogni scienza, dalla matematica
alla religione, Hume ha rivolto la sua attenzione al sentimento e all’istinto ancor più che alla
ragione, alla quale spetta semmai di chiarire ciò che comunemente si accetta e si crede,
mostrando come verità ritenute oggettive perché fondate sulla natura stessa delle cose sono in
realtà soggettive in quanto dettate appunto dall’istinto e dall’abitudine. Seppure guidata dalla
ragione, anche l’attività del filosofo non fa che seguire l’istinto: quello di indagare i principi
su cui si fondano le credenze e che informa il comportamento degli uomini (e questo significa in
definitiva che la stessa filosofia ha la sua legittimazione nella natura umana).
Hume ha esteso infine la sua riflessione al campo della religione, evidenziando l’impossibilità di
sostenere razionalmente con argomenti a priori (attraverso la deduzione dell’esistenza dalla
semplice analisi del concetto) o con argomenti a posteriori (attraversa la risalita dall’esistenza
del mondo, constatabile empiricamente, a quella del suo artefice) la credenza nell’esistenza di
Dio (Dialoghi sulla religione naturale, 1779 postumi), e denunciando così le pretese della ragione
che, lungi dal farci raggiungere maggiori certezze, ci portano a conclusioni di totale
scetticismo.
Come nel Trattato sulla natura umana (1739-1740), così anche qui l’obiettivo polemico di Hume
non è la fede, ma la pretesa della ragione di superare i limiti dell’esperienza e dei poteri
conoscitivi connessi a questa, nel tentativo di dare una fondazione sul piano della conoscenza a
ciò che può essere esclusivamente oggetto di fede. Questa rimane anche per lui l’unico
fondamento sicuro delle religioni, dal momento che le argomentazioni che pretendono di
trovare un fondamento razionale non resistono all’analisi critica che ne dimostra
l’insostenibilità (perché ad es. all’argomento a posteriori del «progetto», presente nella teologia
scolastica (Tommaso d’Aquino) e che pure si presenta fondato sull’esperienza quotidiana, può
essere opposta l’obiezione della necessaria proporzione fra le cause e gli effetti, la quale riduce
la validità di tale argomento alle sole cose umane; sicché, se lo si estende alle cose divine, è
perché si è caduti nell’antropomorfismo).
Nessun tipo di ragionamento teologico può risultare pertanto un sicuro fondamento delle
credenze religiose, perché in tale materia la ragione non ci dà né l’evidenza con l’argomento a
priori né la prova con quello a posteriori, ma ci dà solo la probabilità, e su questa non si può
fondare la religione, giacché alla probabilità è connesso lo scetticismo (probabilità e scetticismo
che appaiono a questo punto elementi di maggior saggezza che non le erronee pretese di
evidenza e di prova).
Ponendosi in ultimo il problema delle origini della religione nella natura umana, Hume ha
respinto anzitutto l’ipotesi che essa sia il risultato dell’operare di un istinto primario della
medesima. La sua Storia naturale della religione (1757) ha dunque lo scopo di rispondere alla
domanda relativa al tipo di istinti o principi secondari della natura umana dai quali essa ha
avuto origine, nel presupposto che la risposta sia da ricercare nell’esperienza storica
dell’umanità.
Kant (1724-1804)
Critica della ragion pura (II edizione, 1787) – Dottrina trascendentale del metodo: Intorno
all’impossibilità di un appagamento scettico della ragion pura in conflitto con se stessa
La coscienza della propria ignoranza, laddove questa non è necessaria ma contingente, è motivo
di risveglio delle ricerche. L’ignoranza è di due tipi: ignoranza delle cose e ignoranza della
determinazione e dei limiti e della conoscenza. In quanto accidentale, l’ignoranza spinge nel
primo caso ad indagare dogmaticamente le cose e nel secondo caso ad indagare criticamente i
limiti della conoscenza possibile in base a principi a priori.
Il fatto che la nostra sia una ignoranza assolutamente necessaria, esonerandomi da ogni
ulteriore indagine, è determinabile criticamente e non empiricamente (attraverso
l’osservazione), ponendo in questione le fonti della conoscenza umana.
La conoscenza della nostra ignoranza, resa possibile dalla stessa critica, è essa stessa scienza.
Si chiama censura della ragione un procedimento come quello di Hume, consistente nel
sottoporre ad esame i prodotti della ragione e tesa a porre in dubbio qualsiasi uso trascendente
dei principi. Nel campo della ragion pura il primo passo è dogmatico, mentre il secondo è
scettico e mostra la cautela di un giudizio scaltrito dall’esperienza. Ad esso deve seguire un
passo ulteriore, conveniente ad un giudizio che abbia il suo fondamento in massime sicure e di
provata universalità, e consistente nell’esame della ragione stessa e non più dei solo fatti della
medesima, in tutta la sua capacità e idoneità in ordine alle conoscenze pure a priori (il che
equivale alla critica della ragione). Mediante questa critica si forniscono le prove fondate su
principi, oltre che dei precisi confini della ragione (e non semplicemente di alcuni termini),
della nostra ignoranza rispetto a tutte le possibili questioni di un certo tipo (e non solo
rispetto a questioni limitate).
Lo scetticismo rappresenta un momento transitorio e non un punto d’arrivo per la ragione
umana, quello in cui essa giunge a riflettere sulle posizioni dogmatiche. Queste come quelle
scettiche non offrono una residenza stabile alla ragione, rintracciabile soltanto in una totale
certezza così della conoscenza degli oggetti come della conoscenza dei limiti nei quali è chiusa
la medesima.
Lo scettico è pertanto il precettore che guida il ragionatore dogmatico verso una sana critica
dell’intelletto e della stessa ragione, e il suo metodo, non soddisfacente in se stesso, si risolve in
una specie di esercizio preliminare per risvegliare la cautela della ragione e segnalarle quei
mezzi sicuri che la possono garantire nei suoi legittimi possessi.
Nessun appello alla nostra impotenza dà il diritto di respingere i problemi postici dalla ragione,
come se la loro soluzione stesse realmente nella natura delle cose, perché solo la ragione suscita
dal suo seno questi problemi e tocca dunque ad essa dar conto della loro validità o della loro
parvenza dialettica.
L’errore di Hume è stato quello di concludere dalla contingenza della nostra determinazione
secondo la legge (quella che ci porta a inferire nell’esperienza da un fenomeno qualcosa che lo
ha determinato) la contingenza della legge stessa, senza comprendere che il principio della
permanenza è, al pari degli altri (tra cui quello di causalità), un principio che anticipa
l’esperienza stessa. Inoltre Hume non si è reso conto della differenza tra le richieste
dell’intelletto, fornite di fondamento, e le presunzioni dialettiche della ragione.
Progressi della metafisica (postumo 1804)
Per avere un metro utile a cogliere ciò che negli ultimi tempi si è verificato nella metafisica
occorre considerare quel che in essa si è fatto da sempre, mettendo poi a confronto entrambi i
risultati con ciò che in essa avrebbe dovuto essere fatto in quanto scienza.
Si può tuttavia considerare come un avanzamento il ponderato e intenzionale ritorno sui propri
passi seguendo le massime del modo di pensare, anche se come un avanzare negativo, perché
tale è da considerare quello che ci consente di eliminare errori (il suo beneficio è quello di non
continuare a errare per una falsa strada una volta accortisi dell’errore, ma di tornare indietro sul
luogo di partenza per orientarsi).
I primi e più antichi passi nella metafisica non furono semplicemente arrischiati ma compiuti
con la massima sicurezza senza eseguire preventivamente accurate indagini sulla possibilità
della conoscenza a priori.
Il secondo passo della metafisica, antico quasi quanto il primo, fu invece un regresso che
sarebbe stato vantaggioso per la metafisica se si fosse limitato a tornare al punto di partenza per
intraprendere di nuovo il cammino nella direzione giusta, anziché per fermarvisi con la
risoluzione di non tentare più alcun passo. La motivazione data a questo regresso è stato il
fallimento di tutti i tentativi compiuti in metafisica di progredire mediante la ragione dalla
conoscenza sensibile a quella del soprasensibile. L’estensione della dottrina del dubbio anche ai
principi della conoscenza del sensibile e alla stessa esperienza da parte degli scettici è consistita
forse in un invito ai dogmatici a dimostrare quei principi a priori sui quali poggia la possibilità
stessa dell’esperienza.
Il terzo e più recente passo compiuto dalla metafisica, quello che deve decidere del suo destino,
è dato dalla stessa critica della ragion pura in merito al suo potere di estendere a priori la
conoscenza umana in generale, riguardo sia al sensibile che al soprasensibile. Per mezzo di tale
critica del potere della ragione la metafisica è posta in una condizione di stabilità, senza aver più
bisogno in avvenire di essere ampliata o ristretta.
L’ordine cronologico in cui sono collocati il dogmatismo, lo scetticismo e il criticismo trova
fondamento nella natura della facoltà conoscitiva dell’uomo.
Critica della ragion pura (I edizione, 1781) – Quarto paralogismo della psicologia trascendentale (della
idealità o del rapporto esterno)
Ciò di cui si può inferire l’esistenza solo come causa di percezioni date ha un’esistenza dubbia –
tutti i fenomeni esterni sono tali che la loro esistenza non è percepita immediatamente ma è
inferita come causa di percezioni date – l’esistenza di tutti gli oggetti esterni è incerta (idealità
dei fenomeni esterni).
Critica del quarto paralogismo
Solo la nostra esistenza può essere è suscettibile di semplice percezione, non già l’esistenza di
un oggetto reale fuori di me che deve essere pensata in aggiunta alla percezione come sua causa
esterna. Non mi è possibile percepire immediatamente le cose esterne, mentre posso desumerne
l’esistenza dalla mia percezione interna (supposto che questa sia un effetto che la sua causa
prossima in qualcosa di esterno). Ma l’esistenza di siffatti oggetti, in quanto inferita, è esposta si
rischi di tutte le inferenze, a differenza dell’oggetto interno (io stesso) che è percepito in maniera
immediata (come lo è il cogito per Cartesio).
Idealista non è chi nega l’esistenza degli oggetti esterni dei sensi, ma chi non ammette che la
loro esistenza venga conosciuta mediante una percezione immediata, traendo la conclusione
che nessuna esperienza è in grado di garantirci la realtà di tali oggetti.
Esistono due forme di idealismo: quello trascendentale e quello empirico.
Per idealismo trascendentale di tutti i fenomeni va intesa la concezione secondo cui tutti i
fenomeni sono semplici rappresentazioni e non cose in sé. Ad esso si contrappone un realismo
trascendentale che vede nei fenomeni esterni cose in sé, esistenti indipendentemente da noi e
dalla nostra sensibilità (questo realismo trascendentale è quello che in seguito si presenta come
idealismo empirico che trae da quella premessa la conseguenza che le rappresentazioni dei
sensi sono insufficienti a rendere certa la realtà dei loro oggetti). L’idealista trascendentale può
essere invece un realista empirico in quanto ammette l’esistenza della materia, ma la intende
in forma di rappresentazioni esterne che derivano il loro essere tali dal riferimento delle
percezioni allo spazio (di cui abbiamo l’intuizione pura) e non ad oggetti esterni.
Le cose esterne esistono dunque per lui allo stesso modo che esisto io stesso, sulla base
dell’immediata testimonianza della mia autocoscienza, seppure con la differenza che la
rappresentazione di me stesso quale soggetto pensante si riferisce esclusivamente al senso
interno (tempo), mentre quelle rappresentazioni si riferiscono altresì al senso esterno (spazio).
Infine, tanto gli oggetti esterni quanto quello del senso interno non sono altro che
rappresentazioni, la cui percezione immediata (coscienza) offre ad un tempo una prova
sufficiente della loro realtà.
Una volta che si sono considerati gli oggetti come cose in sé, diviene assolutamente impossibile
comprendere in qual modo ci sia dato giungere alla conoscenza della loro realtà fuori di noi,
visto che non è possibile sentire fuori di noi ma solo in noi e che l’intera autocoscienza non ci
fornisce che nostre determinazioni. L’idealista scettico, quello che pone in dubbio l’esistenza
della materia (ma non la nega in modo preventivo, come fa invece l’idealista dogmatico) perché
la ritiene indimostrabile, ci costringe a ricorrere all’estremo rimedio rappresentato
dall’ammissione dell’idealità di tutti i fenomeni qual è introdotta nell’Estetica trascendentale.
L’oggetto trascendentale che funge da fondamento dei fenomeni esterni, al pari di quello che
sta a fondamento dell’intuizione interna, non è in se stesso una materia come neppure l’altro è
un essere pensante, ma semplicemente un fondamento a noi ignoto dei fenomeni.
Prolegomeni ad ogni futura metafisica (1783) – § 13 Osservazione II
L’idealismo consiste nell’affermazione che vi sono unicamente esseri pensanti, mentre le altre
cose che noi crediamo di percepire sarebbero solo rappresentazioni negli esseri pensanti alle
quali non corrisponderebbe nessun oggetto esistente fuori di essi. Diversamente l’idealismo
trascendentale afferma: le cose ci sono date come oggetti dei nostri sensi, esistenti fuori di noi,
seppure non sappiamo nulla di ciò che esse siano in sé (ciò che noi conosciamo sono soltanto i
fenomeni, cioè le rappresentazioni che esse producono in noi affettando i sensi). La parola
“corpo” significa soltanto il fenomeno di quell’oggetto che a noi è sconosciuto ma che non per
questo è meno reale.
Oltre alle qualità come calore, colore, sapore, ecc., sono da annoverate tra i semplici fenomeni
anche le rimanenti qualità dei corpi che si dicono primarie (estensione, luogo, spazio e tutto ciò
che vi è annesso: impenetrabilità, materialità, forma, ecc.). Quanto poco può dirsi idealista colui
che vuol far valere il colore non come una qualità che inerisce all’oggetto in sé ma soltanto come
modificazione inerente al senso della vista, tanto poco può dirsi idealista la dottrina secondo cui
tutte le proprietà che costituiscono l’intuizione di un corpo appartengono soltanto al fenomeno.,
dal momento che non viene eliminata l’esistenza della cosa che appare (come nel vero
idealismo), ma soltanto si mostra che non è possibile conoscerla come è in sé attraverso i sensi.
Critica della ragion pura – Dottrina trascendentale degli elementi: Confutazione dell’idealismo
L’idealismo (quello materiale) è la teoria che considera l’esistenza degli oggetti nello spazio
fuori di noi come dubbia e indimostrabile o come falsa e impossibile. Il primo caso definisce
l’idealismo problematico di Cartesio, il quale ha ritenuto indubitabile solo un’asserzione
empirica (io sono); mentre il secondo è l’idealismo dogmatico di Berkeley, il quale ha ritenuto
che lo spazio, assieme a tutte le cose cui esso inerisce come condizione inseparabile sia alcunché
di impossibile in se stesso.
Se circa le cose esterne noi siamo in possesso di un’esperienza e non di una semplice
immaginazione, va dimostrato che la nostra stessa esperienza interna, posta da Cartesio al
riparo da ogni dubbio, non è possibile che presupponendo un’esperienza esterna.
Teorema: la semplice coscienza, ma empiricamente determinata, della mia propria esistenza
prova l’esistenza degli oggetti nello spazio fuori di me.
Dimostrazione: se nella coscienza della mia esistenza mi colgo come determinato nel tempo e se
ogni determinazione temporale presuppone alcunché di permanente nella percezione, allora la
percezione di questo permanente non è possibile se non in base alla semplice
rappresentazione di una cosa fuori di me. Non solo quindi la determinazione della mia
esistenza nel tempo presuppone l’esistenza di cose reali da me percepite come fuori di me, ma la
coscienza della mia propria esistenza è nel contempo immediata coscienza dell’esistenza di altre
cose fuori di me. Da questa dimostrazione risulta chiaro come il gioco fatto dall’idealismo nel
supporre che l’unica esperienza immediata sia quella interna si ritorca ai suoi danni.
Diversamente, è da ammettere che l’esperienza esterna è propriamente immediata, e che solo
per suo mezzo è possibile non già la conoscenza della nostra esistenza ma la sua
determinazione nel tempo ossia l’esperienza interna.
Hegel (1770-1831)
Rapporto dello scetticismo con la filosofia (1802): non si riscontrano differenze tra i vari sistemi
filosofici, come affermava Schulze per contestare che la filosofia possa mai raggiungere la
stabilita di una scienza, ma solo tra filosofia e antifilosofia (quando sono veri sistemi filosofici
a contrastare tra loro, esiste sempre accordo nei principi).
L’incapacità dello scetticismo di comprendere ciò si spiega con l’incapacità di avere un’idea
adeguata della filosofia e del razionale, entrambi concepiti come rinchiusi nella sfera empirica
della certezza innegabile dei fatti della coscienza.
A differenza dello scetticismo antico, che rappresenta l’iniziale gradino verso la filosofia
perché, opponendo finito a finito e finito ad infinito, mostra la finitezza nel finito, quello
moderno è semplicemente dogmatico perché, ponendo alla base del razionale i fatti della
coscienza, attribuisce una certezza immediata al finito.
Il Parmenide di Platone è esempio di uno scetticismo genuino, per il fatto di negare la verità del
conoscere secondo i concetti astratti dell’intelletto e di porsi esso stesso come il lato negativo
della conoscenza dell’Assoluto (anche per Schelling il sapere negativo dello scetticismo, per
elevarsi a scetticismo «scientifico», deve coincidere con la «intuizione positiva dell’Assoluto»).
L’impostazione scettica di quel dialogo è vista come un’introduzione alla platonica unità dei
contrari, realizzata attraverso la comunanza dei generi supremi dell’essere e del non essere. Lo
scetticismo quale compare in forma esplicita nel Parmenide può essere rinvenuto in forma
implicita in ogni genuino sistema filosofico, qualora in qualsiasi proposizione esprimente una
conoscenza di ragione sono isolati i concetti contenutivi e si considera il modo in cui sono
collegati, mostrando come questi concetti siano nel contempo anche “tolti”, ossia uniti nella
loro contraddizione. Il principio di contraddizione ha per la ragione scarsa verità, anche dal
punto di vista formale, dal momento che ogni proposizione di ragione deve contenere una
trasgressione di esso riguardo ai concetti.
Schulze non ha compreso come, oltre al dogmatismo e allo scetticismo, esista ancora la
filosofia come terzo termine (questo schema tripartito deve correggere quello introdotto da
Sesto Empirico che divideva i filosofi in dogmatici, accademici e scettici, fautori di un
atteggiamento di apertura alla ricerca). Ad ogni modo, nella ricerca della massima coerenza lo
scetticismo antico diventava inevitabilmente incoerente, posto che la pura negatività o
soggettività o è nulla annullandosi nel suo estremo (dato che un estremo non mantenersi senza
il suo opposto) o deve diventare sommamente oggettiva.
Nell’operare una scissione del razionale, opponendo pensiero ed essere mantenuti nella loro
contrapposizione, lo scetticismo moderno ha reso assoluto l’intelletto. Secondo questo
scetticismo la capacità conoscitiva umana, in quanto fornita solo di concetti, non può uscire ad
incontrare le cose che sono dall’esterno.
La convinzione che le posizioni scettiche siano solo un passaggio obbligato verso la ragione
concepita come autocoscienza speculativa diviene più avanti operante, in alcuni punti nodali
della Fenomenologia dello spirito (1807), dove all’inizio le tappe della dialettica della coscienza
sensibile descritte e il superamento delle aporie della medesima devono soddisfare l’esigenza di
stabilire che la coscienza apprende gli oggetti come in sé identici con lei così da ritrovare se
stessa nel divenire autocoscienza.
Lo scetticismo compare propriamente nella sezione sull’autocoscienza, come “figura” situata
tra l’autocoscienza stoica, i cui la libertà del pensiero è meramente astratta, e la figura della
«coscienza infelice» che, nella propria infelicità, porta a consapevolezza la scissione totale cui
giunge appunto lo scetticismo. Lo sviluppo va dunque dallo stoicismo, in cui si manifesta un
concetto ancora astratto dell’autocoscienza libera, alla coscienza infelice attraverso la coscienza
scettica quale esperienza del movimento dialettico che ora avviene come opera della coscienza
stessa.
Fra l’autocoscienza storica e la coscienza scettica corre lo stesso rapporto che corre fra il
signore e il servo, laddove il primo è solo il concetto dell’autocoscienza indipendente mentre il
secondo ne era l’attuazione effettiva. Tanto lo stoico innalza l’autocoscienza al pensiero nel
concepire l’uomo veramente libero come al di sopra di tutte le accidentalità e le determinazioni
della vita (allo stesso modo in cui il signore affermava la sua indipendenza senza riuscire ad
attuarla all’interno della vita), quanto lo scettico penetra in tutte le determinazioni
dell’esperienza, ne mostra il nulla e le dissolve nell’autocoscienza (così come il lavoro del servo
riusciva a penetrare la sostanza della vita per darle l’impronta dell’io). Per questo, nello
scetticismo la forma non è più la semplice positività assoluta del pensiero ma la sua
negatività onnipotente («lo scetticismo è la realizzazione di ciò di cui lo stoicismo è soltanto il
concetto: è l’esperienza effettuale di ciò che è la libertà del pensiero» in quanto «essa è in sé il
negativo e deve così presentarsi»).
In tal senso lo scetticismo rappresenta un momento dell’autocoscienza alla quale «non già
accade che, senza saper come, le si dilegui ciò che essa ha di vero e di reale», proprio perché,
«nella certezza della sua libertà, lascia dileguare questa alterità che si pone come reale». La
coscienza si procura da sé così la certezza incrollabile della propria libertà, facendo sì che
nulla sussista all’infuori della autocertezza assoluta, ma questo significa da una prospettiva
più alta che l’infinità dell’autocoscienza si rivela anzitutto nel suo operare nullificante. Lo
scetticismo come tale non si è ancora innalzato alla coscienza di se stesso, restando legato al
piacere di distruggere e concependo l’operazione dialettica nella sua pura negatività.
Connettendo la certezza di se stessa alla negazione di ciò che è altro, la coscienza scettica
finisce tuttavia per palesarsi nella sua duplicità, ma senza averne vera consapevolezza perché
in tal caso sarebbe già lei la coscienza infelice: l’autocoscienza che è il dolore della coscienza
della vita, il quale affonda nella vita e insieme la trascende.
Fenomenologia dello spirito (dalla certezza sensibile alla coscienza infelice)
Il sapere immediato della certezza sensibile è il sapere dell’immediato (questa certezza che sa
l’essere e sa soltanto questo manifesta la verità più astratta e più povera che in quanto tale è
ineffabile). Ciò che si prova senza poterlo esprimere non ha verità in quanto ci si limita a
sentirlo nella sua unicità ineffabile. La sua determinazione nel «qui» e nell’«ora» è quanto di più
vago, in quanto quell’essere che è immediato è esso stesso ogni essere e nessuno (l’universale
più astratto).
La verità della certezza sensibile è l’essere, lo spazio universale, il tempo universale, ma questi
non sono dei dai immediati: sono perché qualcos’altro non è. Essi sono soltanto attraverso la
negazione del loro essere-altro.
Anche dal lato del soggetto questa immediatezza, che si manifesta ora nell’opinare (dove la
verità è nell’oggetto in quanto io so di esso), la medesima dialettica in quanto ciò che sa il mio io
si oppone a quanto sa non meno immediatamente un altro io, lasciando spazio non a questo io
individuale irripetibile ma all’io universale (perché ciascuno si figura di essere un individuo
irripetibile, un io immediato, ma ogni io ne dice altrettanto). In questo caso però l’universale è
meno giustapposto al singolare, la cui compenetrazione è più profonda essendo la verità
concreta verso cui tendiamo.
Il punto di vista della percezione è quello della coscienza comune e delle varie scienze
empiriche che innalzano il sensibile all’universale. Ormai non abbiamo più a che fare con un ora
o un qui singoli, irripetibili e ineffabili, ma con un ora e un qui che hanno in sé la mediazione,
che sono cose aventi in sé l’unità dell’universalità e insieme la molteplicità dei singoli termini.
Percepire non è più fermarsi all’ineffabile della certezza sensibile ma oltrepassare tale sensibile
per raggiungere l’universale della cosa (tutto è una cosa, al di là delle sue proprietà). Qui
l’universale non è altro che la cosalità, un mezzo che è un insieme semplice di molti termini, ma
proprio per questo una determinazione del pensiero la quale non si dà mai a sentire (la pretesa è
di percepire una cosa determinata in sé e per sé). Ciò che vale per la cosa percepita vale anche
per la coscienza percipiente, in quanto accade che l’anima sia percepita come un insieme di
facoltà. Nella prospettiva della coscienza percipiente l’essenza è attribuita all’oggetto e la nonessenza alla coscienza stessa.
Se da un lato questa cosa, uguale a se stessa e per sé una, è tale soltanto nella sua differenza
assoluta da tutte le altre, dall’altro questa differenza implica una relazione con le altre cose con
cui cessa il suo essere per sé. Questa dialettica, che fa passare dalla cosa uguale a sé alla
relazione, dal cosalismo della percezione alla relatività dell’intelletto.
L’intelletto si innalza dalla sostanza alla causa, dalla cosa alla forza, e da questa al fenomeno
come manifestazione di una forza che agisce secondo un legge determinata, la quale dà la sua
unità al fenomeno, pur non essendo il fenomeno stesso perché al di là di esso, quale fondamento
unitario che non è nell’oggetto ma nel soggetto sesso che lo pensa. Per l’intelletto, infatti, tutto è
da prima una forza, ma la forza non è altro che il concetto, il pensiero del mondo sensibile:
pensiero che, manifestatesi da principio alla coscienza come il vuoto al di là di questo mondo,
diviene l’interno di tale mondo in un sistema di leggi. Nel suo oggetto la coscienza raggiunge
così se stessa ed è, nella sua verità, certezza di sé, autocoscienza (questa è da prima coscienza
singola, negazione di ogni alterità nel suo puro rapporto a sé).
Nel sapere la natura l’intelletto sa dunque se stesso; il suo sapere l’Altro è un sapere sé, un
sapere il sapere: autocoscienza. In quanto dapprima appetito, ossia desiderio di possedere la
natura, poi tendenza all’autoconservazione e lotta per la vita e per la morte, l’autocoscienza
giunge alla sua verità solo quando trova un’altra autocoscienza vivente come lei (nella dualità
delle autocoscienze viventi si mostra la duplicazione dell’autocoscienza all’interno di sé).
L’indipendenza del signore e la severa educazione del servo divengono la padronanza di sé
dello stoico (sempre libero quali che siano le circostanze e i casi della sorte) o l’esperienza della
libertà assoluta dello scettico, il quale dissolve ogni posizione diversa da quella dell’io stesso.
Infine la verità di tale libertà stoica e scettica si esprime nella coscienza infelice, sempre divisa in
se stessa: coscienza dell’assoluta certezza di sé e insieme del nulla di questa certezza (la
coscienza infelice è la verità di tutta questa dialettica, la sofferenza provata dalla pura
soggettività che non ha più in se stessa la sua sostanza).
Anche nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830, 3° ed. riv.) lo scetticismo è
considerato non già in sé ma come una “figura” che esemplifica il momento dialettico grazie
al quale le determinazioni finite si superano nel passare nelle determinazioni loro opposte: il
momento che l’intelletto prende come in sé separato e in cui la ragione speculativa ravvisa
invece la negazione come momento del movimento dialettico in cui «ogni finito è il superare se
stesso» in quanto «non viene semplicemente limitato dal di fuori, ma, mediante la sua propria
natura, si supera e passa mediante se stesso nel suo contrario».
Da questo punto di vista, lo scetticismo non può essere considerato come quella dottrina che
esalta l’elemento del dubbio, ma come quella in cui si esprime, in maniera ben più drastica, la
convinzione «della nullità di ogni finito». L’esercizio del dubbio non elimina e anzi include la
speranza che esso possa essere risolto fino a giungere a qualcosa di saldo e di vero, mentre
l’autentico scetticismo «è l’autentica disperazione rispetto ad ogni termine fisso dell’intelletto»
(da intendersi in senso filosofico e non psicologico), accompagnata da uno stato d’animo di
imperturbabilità e di quiete serena. Da questo autentico scetticismo va distinto quello più
recente volto a negare la verità e certezza del soprasensibile e che assume il sensibile dato nella
sensazione come ciò a cui si deve attenere la conoscenza.
Ciò posto, solo il pensiero finito, astrattamente intellettivo, deve temere lo scetticismo (che è
incapace di contrastare), dato che la filosofia lo contiene in sé come un momento, senza
fermarsi al risultato solo negativo della dialettica, come avviene nel caso dello scetticismo
storico, il quale misconosce il proprio risultato per il fatto di assumerlo come semplice
negazione. Sta infatti alla filosofia cogliere nel negativo, come risultato, il positivo.
IV FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Peirce (1836-1914): la critica dell’intuizione deve portare a chiedersi se l’esistenza delle verità
evidenti, qual era sostenuta da Cartesio, è intuita (il che significa ammettere l’esistenza di un
primum assoluto, qualcosa di completamente inconoscibile che saremmo in grado di conoscere
grazie a una fantomatica capacità intuitiva) o invece inferita. Non solo la psicologia esclude
che si abbia mai un’autocoscienza intuitiva, ma il processo cognitivo manca di un inizio
determinabile in assoluto, seppure si chiede che il sapere si fondi su un’intuizione (ogni nostra
conoscenza, infatti, è sempre mediata da altre cognizioni, e l’oggetto non è un primum che sta al
di fuori del pensiero semiotico, ma è un termine ideale, la cui conoscenza coincide con la
rappresentazione che ne abbiamo). In breve, la conoscenza non coglie le cose come si mostrano
e si presume che siano, ma procede per approssimazioni ipotetiche e sulla base di precedenti
conoscenze.
Quando pensiamo, abbiamo presente alla coscienza un sentimento, un’immagine o altro che
funge da segno; talché ogni cosa è una manifestazione di noi stessi senza che ciò impedisca che
essa sia il fenomeno di una esterna (un segno è tale per un pensiero che lo interpreta, lo è in
luogo di un oggetto a cui in quel pensiero è equivalente o per qualche qualità che lo mette in
relazione al suo oggetto).
Ogni azione mentale ha una natura inferenziale e le percezioni non sono determinate e
singolari come credono i nominalisti (la cognizione è una catena dove ogni conoscenza è
sempre preceduta da un’altra e non dà luogo ad una definitiva). Non che le cose non esistono
anche al di là della relazione con la mente, ma il reale consiste propriamente in ciò in cui prima
o poi si risolvono le informazioni e il ragionamento, indipendentemente dagli errori dei singoli.
La realtà delle cose è dunque ciò che si mostra nello stato ideale di una conoscenza completa
e dipende dalla decisione finale di una comunità. Il reale non dipende dai pensieri dei singoli
ma dal pensiero in generale, posto che «l’opinione su cui tutti coloro che indagano sono
destinati a trovarsi d’accordo è ciò che concepiamo come verità e il reale è l’oggetto che v’è
rappresentato».
Il pensiero non ha altro scopo che la formazione di un’opinione che acquieti il dubbio che
nasce dalla pratica della vita, laddove a spingere e alimentare la ricerca non è il dubbio teorico
ma il dubbio che nasce dalla crisi di una precedente credenza nella quale il pensiero già si
trova immerso. La ricerca nasce pertanto all’interno delle problematiche concrete che sorgono
dentro l’agire, nella pratica (è questo, infatti, il principio che dà vita al pragmatismo: il pensiero
nasce dalla pratica e finisce con la pratica). La funzione del pensiero è quella di trovare
qualcosa che prima è sconosciuto a partire da ciò che è conosciuto (importante è qui il
procedimento del ragionamento, ancor più del contenuto che emerge in maniera diversa a
seconda del problema da affrontare). Si tratta di un processo in perenne movimento perché il
contenuto dei pensieri è già frutto di precedenti pensieri ed è già sempre intessuto di credenze.
In senso relativo, il fine del pensiero è di raggiungere una diversa credenza nella quale il
dubbio sia rimosso e si sia di nuovo in grado di agire secondo un abito razionale. Se il
pensiero trova così esito in un atto del volere, la credenza in quanto operazione mentale rimane
il punto di partenza di un nuovo processo di pensiero volto a influenzare la formazione di una
nuova credenza. In senso assoluto, il fine del pensiero non può che essere puramente ideale,
segnalando il punto in cui le credenze finiscono per coincidere con la realtà, posto che la
credenza è regola dell’agire.
Il principio guida dell’analisi del ragionamento va visto quindi nell’abito, che è buono se
ottiene conseguenze vere da premesse vere, e non si intende senza gli stati mentali del dubbio e
della credenza, senza il passaggio dall’uno all’altra. Posto che è la credenza a sospendere il
dubbio, non c’è un solo metodo per conseguirla, in quanto al metodo della tenacia di chi non
vuole essere contraddetto va aggiunto quello dell’autorità, in grado di rendere stabili le
opinioni degli individui senza sottrarle tuttavia all’incertezza nel confronto con altre culture,
quello della ragione a priori e infine quello della scienza, la cui ipotesi rimanda a cose che
agiscono sui nostri sensi secondo leggi regolari e trova conferma nell’esperienza. In particolare,
se con l’induzione concludiamo che fatti simili a quelli osservati sono veri in casi non
esaminati, con l’ipotesi supponiamo qualcosa di diverso da ciò che accertiamo o ci sarebbe
possibile accertare direttamente, in quanto la prima è un ragionamento volto a classificare che
va dai particolari alle leggi generali mentre la seconda è il ragionamento volto a spiegare che
va dall’effetto alla causa.
Per quanto tutti e quattro i metodi soddisfano l’esigenza dell’azione pratica, nessuno raggiunge
tuttavia il fissarsi ultimo e definitivo di una credenza. La superiorità del metodo scientifico è
dato dalla capacità di revisione interna e di soddisfare il dubbio da cui muove la ricerca (le
sue credenze portano alla lunga a conclusioni indipendenti dal pensiero del singolo e aderenti
ai fatti). In questa prospettiva, la verità non è altro che una credenza sulla quale da ultimo si
troveranno d’accordo tutti i ricercatori e il cui contenuto non può che essere la realtà (la verità
è l’opinione generale, nel senso scolastico del termine, un ens rationis dotato di indipendenza
dal pensiero soggettivo e di effetti riscontrabili, laddove la realtà coincide con essa perché la
realtà è il pensiero generale, l’insieme riscontrato degli effetti e la totalità di ciò che si può
conoscere).
Quine (1908-2000): l’epistemologia tradizionale è stata dominata dal programma
fondazionalista cartesiano, e dunque dall’intenzione di isolare una classe di credenze certe e
sufficienti per giustificare il resto delle nostre credenze. La storia dell’epistemologia mostra
come questo programma sia stato fallimentare, da Cartesio in poi. Non che i fondazionalisti
abbiano sbagliato a rispondere alla questione di come dovremmo conseguire le nostre credenze,
semplicemente essi si sono posti la domanda sbagliata, chiedendosi a lungo come sia possibile
la conoscenza e respingere i dubbi dello scettico (evitando di ricorrere a contenuti di quella
stessa scienza che era messa in discussione, e fondando l’epistemologia come «filosofia prima»).
Essi non hanno capito che la domanda sulla possibilità della conoscenza deve essere
interpretata come una domanda sollevata dalla stessa crescita della scienza (la quale ha
palesato l’erroneità delle credenze passate e la propensione all’illusione delle presenti).
Nella misura in cui tale domanda (se le credenze cui perveniamolo abbiano diritto ad essere
considerate vere) è nata all’interno della scienza, è alle risorse della scienza che bisogna
appellarsi per darvi risposta, e ciò significa rendere l’epistemologia continua con l’impresa
scientifica. Le risposte alla questione di come conseguiamo le conoscenze non solo sono
rilevanti per quella di come dovremmo conseguirle ma la esauriscono (naturalizzazione
dell’epistemologia). Per quanto però abbiamo ragione a ritenere che i processi di acquisizione
delle credenze siano affidabili, almeno approssimativamente, vi sono buone ragioni per ritenere
anche che talvolta vi sono processi che conducono sistematicamente a credenze sbagliate, per
cui è necessario scegliere e raccomandare correttivi (la natura empirica dell’impresa
epistemologica non può esimerci da una necessità normativa).
Putnam (1926): l’epistemologia naturalizzata è inestricabilmente compromessa con l’assunzione
di una sorta di realismo metafisico per il quale la scienza ci porta sempre più vicini alla
«verità», e la verità consiste in una corrispondenza particolare e unica tra la teoria e i fatti. Alla
posizione secondo cui il mondo consiste di una totalità determinata di oggetti indipendenti
dalla mente e c’è una sola descrizione vera e completa di come è il mondo (realismo metafisico),
va opposta quella per cui ogni domanda sul mondo ha senso all’interno e dal punto di vista di
una teoria e ogni affermazione è “vera” nella misura in cui è giustificato accreditarla come
tale in “condizioni epistemicamente accettabili” che ne garantiscono l’asseribilità (realismo
interno o “teoria epistemica della verità”). Al realista metafisico, il quale adotta il punto di
vista dell’«occhio di Dio» ritenendo che la verità implichi una corrispondenza, il realista interno
obietta che non c’è qualcosa come il punto di vista dell’«occhio di Dio», in quanto non sarebbe
per noi riconoscibile da che punto di vista verrebbero raccontate storie vere sul mondo e sulla
parte che vi hanno le nostre credenze e azioni. Vi è più di una descrizione “vera” del mondo,
posto che la verità risulta da una sorta di idealizzazione dell’accettabilità razionale. Non c’è,
infatti, un mondo concepibile al di là dei linguaggi che usiamo per parlarne, sicché le nostre
verità sono tutte «interne» ai nostri schemi concettuali (anche se permane un senso in
possiamo continuare a dirci realisti, visto che le storie raccontate sono “vere”). Non vi sono cose
come i «fatti», gli «stati di cose» e simili, come non vi è una sola descrizione corretta del mondo,
e tanto meno vi può essere un modo neutrale di descrivere le cose o un «occhio di Dio» a noi
accessibile, che le coglie indipendentemente da ogni concettualizzazione. Ciò che vi è si
presenta come una varietà di punti di vista di persone reali, nel tempo, che riflettono una
varietà essenziale di interessi e scopi, sottesi alle loro descrizioni e teorie.
Ciò non comporta l’affermazione di una posizione relativistica, perché anzi la tesi del
relativista si confuta da sé, com’è il caso dell’esempio descritto dei «cervelli in una vasca». La
nostra concezione della verità presuppone quella della razionalità e questa presuppone un
qualche insieme di valori. Una soddisfacente concezione della razionalità richiede un’indagine
sulle precondizioni del nostro essere e il fatto che ci riconosciamo come parlanti e pensanti (in
tanto ci impegniamo a credere in un qualche tipo di razionalità in quanto prendiamo sul
serio il fatto che ci accade di discutere). Immaginare una forma di vita, fisicamente e
logicamente possibile, in cui esseri apparentemente simili a noi non diano importanza alla
discussione, non sarebbe per noi concettualmente possibile dal momento che sarebbe una
finzione, non una storia vera (laddove questo criterio non definisce la corrispondenza a fatti ma
l’essere accreditata da parte di un essere razionale).
Davidson (1917-2003): è la possibilità che si diano errori a fornire le condizioni di un processo
di comunicazione in cui una persona dotata di concetti interagisce con l’ambiente e con
un’altra persona di cui osserva le reazioni venendone a sua volta osservata. Ciò definisce il
“triangolo di base” parlante-interprete-mondo che pone l’oggettività del pensiero, ossia il
fatto che una credenza (il cui concetto è essenziale per il pensiero stesso) può essere vera o falsa.
Tanto l’oggettivo non sarebbe raggiungibile se pensassimo di partire, come gli empiristi, da un
soggettivo che non lo contiene, quanto non si potrebbe parlare di una vita soggettiva se il
pensiero non esercitasse fin dall’inizio il suo potere di connettersi a qualcosa nel mondo reale
(questo potere non può essere compreso però in termini di corrispondenza ai fatti, realismo o
riferimento). Non resta che partire dalla “apertura al mondo” che accomuna pensiero e
linguaggio. Posto che tutti noi abbiamo una conoscenza diretta dei nostri stati mentali, che
ognuno conosce un notevole numero di cose sul mondo esterno e che infine sa abbastanza
spesso che cosa avviene nella mente di altre persone (forme di conoscenza, queste, di natura
empirica, riguardanti aspetti di una medesima realtà), si pone l’esigenza di «un’immagine
generale che non solo metta d’accordo i tre modi della conoscenza, ma che dia senso alle loro
relazioni reciproche».
Quando si parla del ruolo della conoscenza nella nostra generale immagine del mondo, il
problema non è di spiegare come sia possibile la conoscenza. Persino gli scettici che negano la
possibilità della conoscenza del mondo esterno devono accettare l’oggettività del pensiero, in
quanto anche i loro dubbi, per avere un senso, devono essere oggettivamente veri o falsi. Il
passaggio all’oggettività del pensiero ci impedisce di pensare che tutte le nostre credenze
possano essere false. Ciò è infatti semplicemente impossibile, sia per il fatto che una
credenza è identificata dal posto che occupa all’interno di una rete di credenze che si
sostengono reciprocamente, sia in quanto le nostre credenze risultano per lo più vere perché
ci vengono attribuite da interpreti che applicano standard di correttezza pubblicamente
riconosciuti (il metodo dell’interpretazione radicale stabilisce in proposito che i principi di
carità – principio di coerenza e di corrispondenza – investono i parlanti di uno standard
intersoggettivo di correttezza).
Per avere dubbi o interrogarsi sulla provenienza delle proprie credenze, occorre già sapere
che cosa è una credenza; pertanto, «la domanda “Come faccio a sapere che le mie credenze sono
generalmente vere?” contiene già la risposta, per il semplice fatto che le credenze sono
generalmente vere per natura».
Nozick (1938-2002): l’argomento del cervello in una vasca – il quale deve indurci a reputare
impossibile stabilire se si è soggetti reali, con tutti i nostri attributi, o soltanto cervelli in una
vasca, sulla base del fatto che la nostra esperienza è per ipotesi identica a quella del cervello in
una vasca – è fondato sul cosiddetto «principio di chiusura». Esprimibile nella forma di un
condizionale soggiuntivo: se una persona sapesse che p e sapesse anche che p implica q, allora
saprebbe che q, questo principio presuppone che tale persona effettui l’inferenza che q. Pertanto,
una persona che sa che il suo essere un cervello in una vasca implica il suo non essere nel
luogo di cui ha apparente percezione, sa anche che, per contrapposizione, il suo essere in tale
luogo implica il non essere un cervello in una vasca. In quanto però la persona non sa
quest’ultima cosa se ne inferisce che non sa neppure la prima. Non è possibile distinguere la
situazione di un cervello in una vasca da quella di un essere umano, laddove queste non siano
già poste in relazione tra loro (ciò significa che la condizione di un cervello in una vasca sarebbe
vissuta come normale nel caso in cui non avesse modo di confrontarsi con l’altra).
Questo genere d’argomento scettico è globale in quanto mina tutte le pretese di conoscenza (o
almeno quelle empiriche), poiché, se non possiamo sapere se siamo cervelli in una vasca,
neppure possiamo conoscere alcuna proposizione della quale bisogna supporre che, se fosse
vera, contraddirebbe la nostra condizione di cervelli in una vasca.
È necessario sostituire la condizione della giustificazione con qualcosa di più vincolante che può
essere così formulato: a conosce che p solo se 1) p è vero 2) a crede che p 3) se p non fosse vero, a
non crederebbe che p (condizione della variazione) 4) se, in circostanze diverse, p fosse ancora
vero, a crederebbe ancora che p (condizione di aderenza). Questa quarta condizione può essere
anche formulata diversamente dicendo che, se p fosse vero e le cose stessero in maniera un poco
diversa da come effettivamente stanno, a crederebbe ancora che p). Si ha conoscenza della
proposizione p se la proposizione è vera e se la credenza è stata acquisita per mezzo di un
metodo m tale che se la proposizione p non fosse vera, il metodo ci porterebbe a credere non-p,
mentre se p fosse vera ci porterebbe a credere p.
Esiste un’asimmetria tra l’affermazione dell’assolutista (secondo cui c’è una verità assoluta), la
quale può esser abbracciata e compresa nella propria posizione dal relativista, e quella di
quest’ultimo (secondo cui la verità è relativa), la quale può essere negata dall’assolutista ma non
anche compresa nella sua posizione. A dispetto di quanti propongono una verità onnitemporale (una verità assoluta, vera per chiunque) ogni verità va collocata entro lo spaziotempo, presentandosi sia come «debolmente spazio-temporale» in occasione di
un’affermazione che, in quanto specificata, risulta vera in una porzione di spazio-tempo, ma
non in ogni dimensione spazio-temporale, sia come «fortemente spazio-temporale» in assenza
di alcun punto o luogo in cui tutte le verità siano registrate e siano valide. Ciò non significa
sostenere che la verità debba essere relativa in senso spazio-temporale, e tuttavia deve indurre a
riflettere su quanto siano forti e impegnative le condizioni da soddisfare perché la verità sia
a-temporale e non spaziale. La verità trascende il suo radicamento spazio-temporale solo
quando sia registrata in ogni altra parte dello spazio-tempo («soltanto allora la verità sussiste
nel proprio regno platonico»).
Moore (1873-1958): il suo sforzo è stato di accreditare, contro le argomentazioni filosofiche
tradizionali, le “ovvietà” (truismi) del senso comune, la cui indubbia certezza lascia
nondimeno aperto il problema della loro analisi (che cosa si vuol dire quando si afferma ad es.
che ciascuno di noi ha un corpo o che la Terra esisteva già prima della nostra nascita?). Nei suoi
saggi più famosi (La confutazione dell’idealismo, 1903; La difesa del senso comune, 1925) egli si è
proposto di attaccare le due dottrine che sentiva come antitetiche al senso comune:
l’idealismo e lo scetticismo, sostenendo contro la tesi idealistica di Berkeley (esse est percipi) che
si deve distinguere, nel senso del realismo, l’atto del percepire dall’oggetto percepito (benché
l’atto di percepire una macchia blu dipenda dalla mente, non c’è ragione di credere che ne
dipenda la macchia stessa o il suo colore).
La sua “visione del mondo del senso comune” si contrappone poi ad ogni forma di scetticismo
radicale, attraverso l’indicazione di un elenco di proposizioni che si sostiene di sapere con
certezza essere vere (riguardanti sia l’esistenza del proprio corpo, la sua origine e continuità
temporale segnata da mutamenti, il suo svolgimento terreno, la preesistenza del pianeta, sia le
diverse esperienze avute nel corso della propria esistenza in conformità con le condizioni fissate
nel primo gruppo di proposizioni); proposizioni che ogni essere umano può quindi
confermare in quanto quel che esse significano è ciò che si intende comunemente. In quanto
comportano l’esistenza degli oggetti fisici e la realtà dello spazio fisico esse sono vere, togliendo
la possibilità di sostenere coerentemente una posizione incompatibile con esse. Sapere che esse
abbisognano di altre proposizioni per essere provate non comporta sapere altresì quale sia la
prova richiesta, e questo significa sapere che molte proposizioni sono vere senza sapere come
comunemente lo sappiamo.
Lo scetticismo radicale si presenta come contraddittorio, perché quando uno scettico nega che
si dia qualsivoglia conoscenza, sta facendo un’asserzione sulla conoscenza umana in generale
(una tale asserzione comporta infatti che lo scettico sappia ciò di cui nega l’esistenza).
È da dire però che Moore presuppone proprio ciò che è in discussione, ossia la verità di un
gruppo di proposizioni di cui egli si limita a dire di sapere che sono vere. La sua resta perciò
una mera asserzione, non sostenuta da alcun argomento; tanto più sospetta, se si considera la
sua ammissione di non conoscerne la verità direttamente ma solo sulla base di altre
proposizioni che, di fatto, non sa indicare.
Wittgenstein (1889-1951): diversamente da quanti sono convinti che lo scettico dice qualcosa di
ragionevole eppure falso, ossia che la conoscenza e la certezza sono inattingibili, l’obiezione da
muovere allo scetticismo è che tenta di dire ciò che non si può dire mostrandosi non già
inconfutabile ma apertamente insensato, posto che il dubbio può sussistere solo in presenza di
una domanda e la domanda solo quando si suppone che si dia risposta, così come infine la
risposta «solo dove qualcosa può essere detto» (Tractatus logico-philosophicus, § 6.5.1).
Nelle Ricerche filosofiche (§§ 243-275) egli ha riformulato la critica allo scetticismo, osservando
che il modello cartesiano della mente e lo scetticismo che esso suggerisce incarnano una
nozione di linguaggio privato, che è un tipo speciale di nonsenso. Secondo tale modello ogni
essere umano è direttamente consapevole delle proprie sensazioni, come dei propri pensieri e
desideri, mentre quelli degli altri vengono appresi solo indirettamente per analogia con i propri.
Una concezione siffatta è incomprensibile per il fatto che non descrive un vero e proprio
linguaggio, dato che questo richiede che le sue regole possano essere apprese comunemente in
quanto è pubblico. Per questo l’idea che possa esistere un tale linguaggio privato non è
sostenibile, come irragionevole è l’idea scettica secondo cui ognuno sarebbe rinchiuso
completamente nell’ambito delle proprie idee. Questo significa che nell’ottica dello scettico, non
si potrebbe mai spiegare come sia possibile la comunicazione sociale attraverso il linguaggio,
quando invece lo stesso linguaggio delle sensazioni è pubblico ed è capito dagli altri.
Considerato infatti che le persone comunicano fra loro su una varietà infinita di cose e che tale
comunicazione ha luogo all’interno di un gioco linguistico che si manifesta come un’”attività” o
una “forma di vita” (Ricerche filosofiche, § 23) a cui noi tutti prendiamo parte, il modello
cartesiano appare inadeguato nell’incapacità di spiegare tutti questi diversi usi interpersonali
del linguaggio, ipersemplificando come tutte le teorie le complessità della vita quotidiana.
Nel suo ultimo scritto, Della certezza, si trova una confutazione ancora più generale dello
scetticismo, laddove si presenta lo scettico come un dubitatore ossessivo e si mostra che quel
che questi chiama “dubbio” non è in realtà un dubbio proprio perché è dubbio di tutto e
senza fine.
Dubitare non può essere considerato uno stato psicologico interiore, poiché il dubbio fa parte di
un insieme di pratiche simili a quelle dei giochi linguistici. In questa prospettiva, il gioco del
dubbio potrebbe consistere concretamente in una serie di atti come esaminare documenti, fare
domande a persone, controllare dati e via dicendo. L’attività insensata che manifesta lo scettico
è paragonabile a quella di chi apre ripetutamente lo stesso cassetto senza trovarvi ciò che cerca,
vittima della sua incapacità di riconoscere niente come una prova (per quante prove si
producano, egli continua infatti a dubitare). A differenza del dubbio ossessivo che continua a
rigirarsi su se stesso (ciò che lo fa apparire privo di senso), il vero dubbio, come già aveva
intuito Peirce, deve pervenire a una fine.
Wittgenstein obiettava che i cosiddetti truismi di Moore sono in realtà enunciati particolari in
cui si evidenzia un modo sbagliato di usare l’espressione “so” (come in “so che questa è una
mano”), così da assumere come enunciati d’esperienza (enunciati conoscitivi, di tipo fattuale)
una classe di asserzioni aventi una funzione grammaticale. La caratteristica dell’evidenza
accordata loro da Moore dipende non da una relazione di tipo conoscitivo istituita tra un
soggetto conoscente e un fatto, ma dalla funzione paradigmatica di cui tali enunciati investiti
entro una forma di vita, entro il sistema delle convenzioni che risultano incorporate al mondo
delle istituzioni e delle consuetudini di una comunità umana. Alla base delle giustificazioni che
si possono invocare per assegnare le ragioni dell’evidenza di quegli enunciati si trova un
fondamento che non è costituito a sua volta di enunciati forniti di certezza assoluta, ma è da
rinvenire nella modalità dell’azione umana che sta alla base del gioco linguistico.
In generale poi, usati per dire qualcosa che già tutti sanno e in merito al quale il parlante è
consapevole del fatto che essi sanno, essi non possono che apparire un tipo speciale di
nonsenso (come lo è affermare “quello è un cane” in compagnia di persone che hanno davanti
un animale che sanno essere un cane). Perché un’asserzione abbia significato v’è bisogno che
trovi contesto in una situazione in cui chi parla comunica a chi ascolta qualcosa che egli
suppone che l’altro non conosca. Per questo i truismi, non dicendo niente di sensato, non
valgono a confutare lo scetticismo; senza tenere conto del fatto che dire di sapere che un
enunciato è vero non costituisce un metodo accettabile di provarlo (la prova esige qualcosa di
più della semplice affermazione che si è convinti della sua verità), così come dire che non si può
essere in errore nell’accettarlo (segno della convinzione personale) non è la stessa cosa che
dire che esso non può essere falso (segno della sua verità oggettiva).