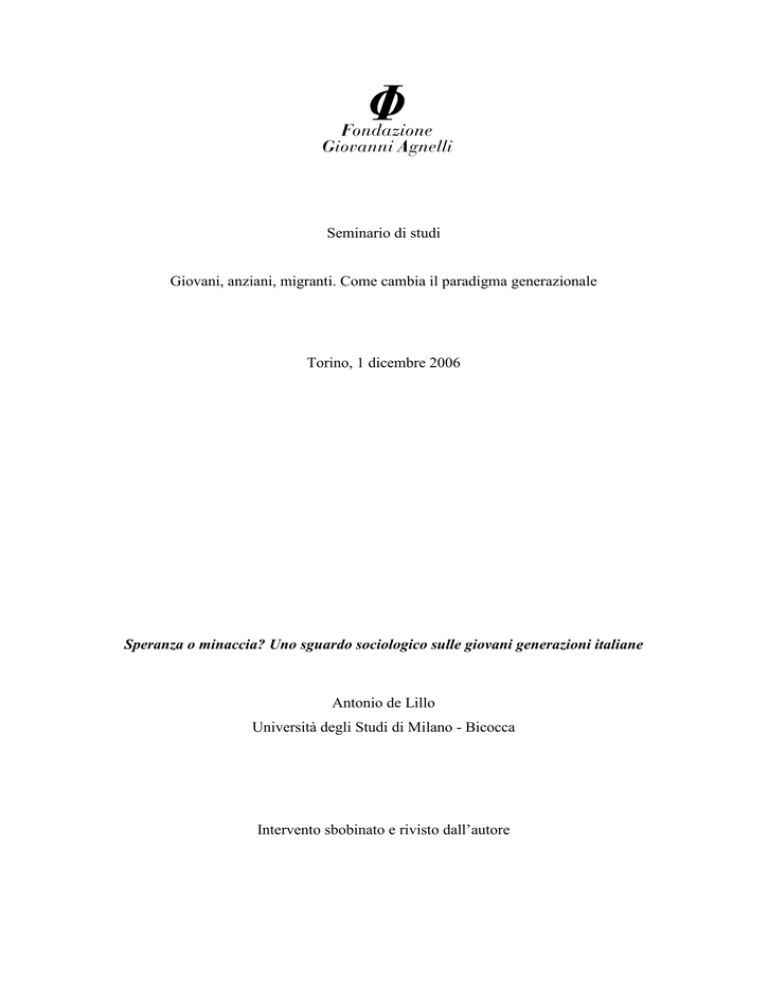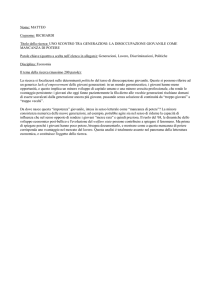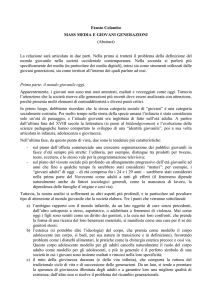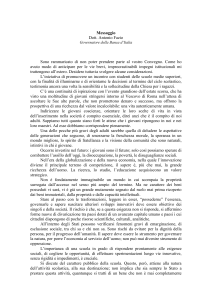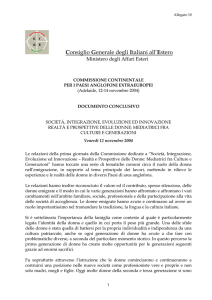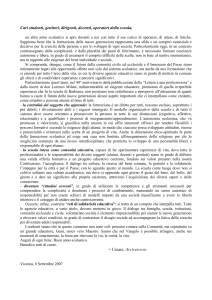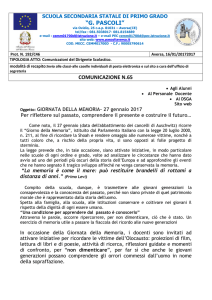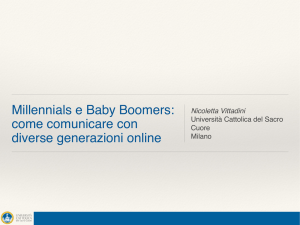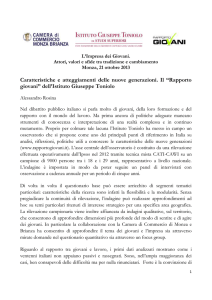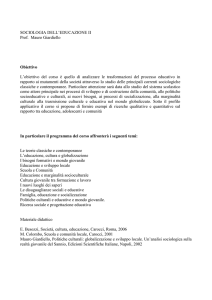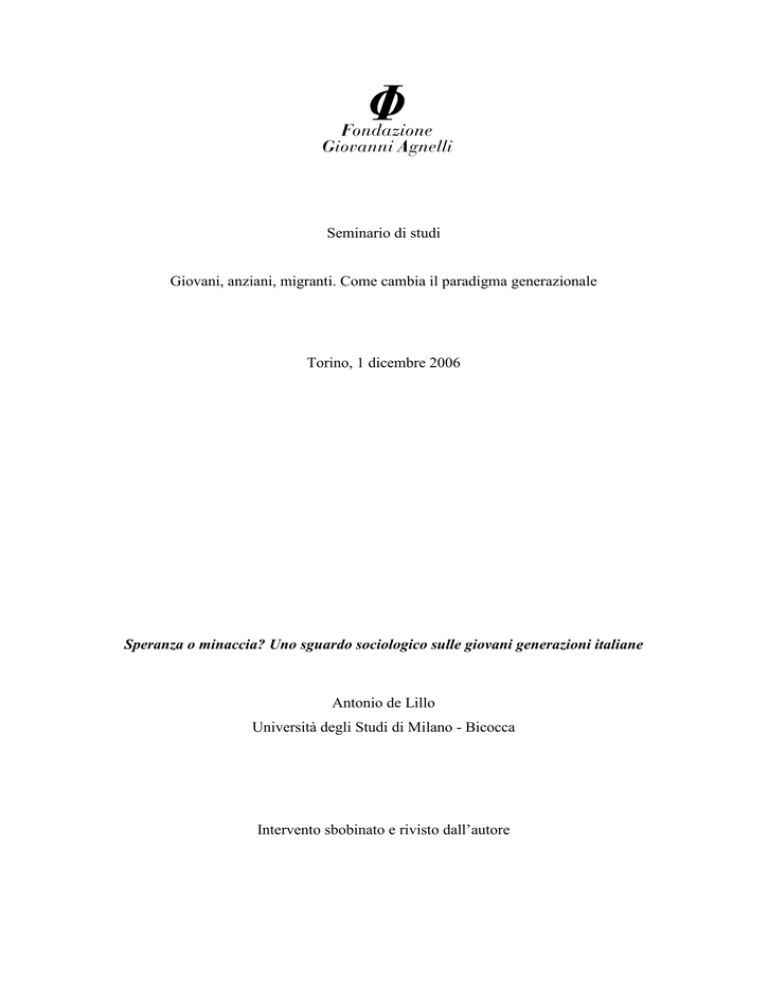
Seminario di studi
Giovani, anziani, migranti. Come cambia il paradigma generazionale
Torino, 1 dicembre 2006
Speranza o minaccia? Uno sguardo sociologico sulle giovani generazioni italiane
Antonio de Lillo
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Intervento sbobinato e rivisto dall’autore
Desidero anzitutto ringraziare per questo invito. Occasioni come questa sono molto importanti per
chi lavora su queste tematiche, per le opportunità di confronto che offrono. La relazione della
Prof.ssa Attias-Donfut è stata molto ricca di spunti, suggestioni e piste di sviluppo. Il tema che mi è
stato affidato (I giovani: speranza o minaccia) si ricollega a quanto fin qui detto e, in particolare,
alla questione dei rapporti fra le generazioni. Per comprendere cosa significhi essere giovani e quali
relazioni leghino i giovani agli adulti, occorre fare una premessa su cosa debba intendersi per gruppi
di età. Come è stato già detto dalla Prof.ssa Attias-Donfut, l’età intesa nella semplice accezione
biologica è un concetto che non ha molta rilevanza per l’analisi sociologica. Ciò che interessa è una
definizione sociale dell’età. Quando noi parliamo di generazioni, in realtà non stiamo parlando di
un concetto che può essere usato come criterio di classificazione della popolazione in termini
univoci. L’età non è una proprietà che l’attore sociale possiede in misura maggiore o minore come
il reddito, il prestigio, una propensione, un atteggiamento. L’età è un concetto eminentemente
relazionale. Vale a dire: si è giovani in rapporto agli adulti, così come si è genitore perché si hanno
dei figli. Esiste, dunque, una forte interconnessione tra l’età biologica e l’età sociale, così come tra
il mutamento sociale e il cambiamento individuale, tra la storia e la biografia. È su queste
considerazioni che si fonda il concetto di generazione. Perché, quando parliamo di generazione,
dobbiamo tenere conto di una dimensione culturale, di una dimensione storica e, solo in via
subordinata, della dimensione strettamente biologica. Ciò rende assai complesso sia il concetto di
generazione sia l’analisi dei rapporti tra le generazioni. Questi ultimi cambiano nel corso del tempo
e nel corso della vita di ciascun individuo. Tutto ciò comporta che non vi sia una definizione del
concetto di generazione operativamente facile da utilizzare nella ricerca sociale. Suddividere gli
individui per gruppi di età, come si fa solitamente nelle analisi dei dati socio-demografici, è
un’operazione semplice ma spesso rischiosa. L’età è una variabile che contiene in sé molti altri
aspetti di una persona. Non è la stessa cosa avere venti anni oggi o averli avuti negli anni ’60 del
secolo scorso. Ciò significa che confrontare i ventenni di oggi con quelli di quaranta o cinquanta
2
anni fa, o anche solo di dieci anni fa è un’operazione priva di senso, perché sono cambiate le
condizioni economiche, sociali, culturali in cui si è cresciuti e nelle quali ci si è formati.
Il concetto di generazione è dunque un concetto multidimensionale. Tutto sommato, la definizione
di generazione che io trovo valida ancora oggi è quella data quasi cento anni fa da Karl Mannheim1,
il quale sosteneva che si possono dire appartenenti ad una stessa generazione coloro che sono stati
adolescenti negli stessi anni e nello stesso paese. È infatti durante l’adolescenza che si costruisce
gran parte della nostra identità. Ciò che accomuna una generazione è l’aver condiviso le stesse
esperienze, aver vissuto lo stesso clima storico e culturale, essersi formati in maniera simile. Questa
definizione di generazione mette in luce anche il carattere multidimensionale del concetto. Se alla
base di esso vi è la condivisione di esperienze storiche, sociali e culturali, ne consegue che parlare
di “giovani generazioni” ha senso solo in quanto evoca il fatto che l’avere la stessa età non è
sufficiente per catalogare tutti allo stesso modo. Se l’ambiente è fondamentale, non tutti vivono
nello stesso ambiente sociale e dunque si può dire che contemporaneamente vi sono più generazioni
di coetanei. Anche all’interno di un solo Paese coesistono situazioni sociali, economiche e culturali
notevolmente difformi. Essere nato al Nord o al Sud, in una famiglia di laureati o di analfabeti, fa
certamente differenza. In questo senso diciamo che il termine “giovani” richiama un concetto di
natura relazionale, in quanto fa riferimento a persone che sono differenti tra di loro, perché vivono
e sono cresciute in contesti esperienziali e culturali diversi.
Del resto la “gioventù” come categoria sociale nel senso in cui la intendiamo oggi è nata
storicamente con la società industriale e con la posizione di predominio nella società conquistata
dalla borghesia a scapito della nobiltà. Ad esempio nell’Inghilterra della prima industrializzazione
la legge stabiliva che chi lavorava aveva tutti i doveri e tutti i diritti di un adulto, indipendentemente
dall’età. E quindi, siccome in quel periodo si andava a lavorare a 10-11 anni, un ragazzino di 10-11
anni che rubava veniva punito allo stesso modo di un adulto che rubava, e talvolta la pena era
anche l’impiccagione. Ci sono resoconti dell’epoca che parlano, appunto, di impiccagioni di
3
bambini di 10-11 anni. Non esisteva la gioventù, esisteva l’infanzia e da questa si passava
immediatamente all’età adulta. Lo sviluppo dell’industrializzazione ha fatto nascere un ceto di
industriali, banchieri, commercianti, amministratori, esperti legali, cioè quella che oggi chiamiamo
borghesia. Per legittimare la propria ascesa al potere, la borghesia ha affermato il primato della
competenza e dell’istruzione, in opposizione al diritto di nascita, sul quale la nobiltà fondava il
proprio primato. Sappiamo che i nobili si vantavano di essere ignoranti; a loro l’istruzione non
serviva per legittimarsi, poteva al massimo essere un hobby, un’attività liberale e accessoria e
comunque non serviva a definire il loro status sociale. Per contro la società borghese, nata con la
modernizzazione e con la società industriale ha fatto della formazione e dell’educazione un punto
qualificante. I figli della borghesia dovevano quindi dedicare una parte della loro vita ad istruirsi,
prima di entrare nella vita attiva, preparandosi così a far parte della società adulta. Naturalmente
questo ha fatto sì che si cominciasse ad avere una parte della popolazione in una condizione di
liminalità, di separatezza dalla società degli adulti.
La gioventù è dunque un portato della società industriale borghese fondata sul lavoro, cioè di una
società acquisitiva, che ha sostituito la vecchia società di ceto fondata sui diritti ascritti ed ereditati
al momento della nascita. Tutto ciò ovviamente comporta delle conseguenze sul piano sociale e
culturale. Ed anche dei problemi di governo del consenso sociale. L’esistenza di una parte della
popolazione che non è ancora nella vita attiva, quindi non ha il carico di responsabilità della
popolazione adulta, ma che comunque è adulta dal punto di vista biologico, crea un problema
sociale. Se i tempi e gli spazi sociali sono fortemente regolamentati, e quindi le fasi della vita sono
scandite in modo chiaro e ci si può avvicinare a quelli che gli antropologi chiamano i riti di
passaggio – la società borghese dell’Ottocento aveva i suoi riti di passaggio – è possibile tenere
sotto controllo una fascia della popolazione che è certamente la più forte, ma può essere portatrice
tanto di innovazione quanto di turbamento sociale. La parola “giovane” ha la stessa radice in tutte le
1
Mannheim K. 1923, Essays on the Sociology of Knowledge, tr. it. Sociologia della conoscenza, Bologna, il Mulino,
2000.
4
lingue, derivando dal sanscrito “yùvan” che ha il significato di “forte” “eccellente”2 , quindi i
giovani sono “quelli forti”. Come si fa a controllare quelli forti? Attraverso il controllo del tempo
sociale, la scansione delle fasi della vita e dello spazio sociale, i luoghi deputati per i giovani: le
scuole, le università, le organizzazioni giovanili messe in piedi dagli adulti.
Moltissime società, del presente e del passato, hanno affrontato il problema posto dai giovani, dai
più forti, con ambivalenza. I giovani, infatti, sono una risorsa e quindi una speranza della società
perché sono il futuro della società stessa, ma nello stesso tempo sono anche una minaccia per
l’ordine costituito. Essi infatti sono portatori comunque di cambiamento, sono coloro che non hanno
ancora completato il processo di acquisizione dei modi di comportamento, delle regole della vita
collettiva perché li stanno imparando e quindi possono essere pericolosi. Vi sono moltissimi esempi
storici dei modi con i quali le società hanno cercato di risolvere tale ambivalenza. Nell’antica
Sparta, ad esempio, i giovani avevano il compito di sorvegliare i confini della Polis. Non stavano
dentro la città perché potevano essere fattore di disturbo, ma maschi e femmine venivano mandati a
sorvegliare i confini della città: con il duplice scopo di acquisire coscienza civica e nello stesso
tempo stare lontano dai centri del potere. Un altro esempio è quello della cavalleria nel Medio Evo.
Tutte le regole della cavalleria erano finalizzate al controllo dei cadetti delle famigli nobili, che non
ereditavano le ricchezze paterne e venivano incoraggiati ad andarsene via per il mondo a cercare
fortuna. Si creavano così gruppi di armati che giravano per campagne e paesi in cerca di mezzi di
sostentamento. Quindi potenzialmente pericolosi. Si instaurò il codice cavalleresco, che imponeva
regole di condotta basate sulla lealtà, l’onore, il rispetto delle donne (soprattutto quelle di nobile
origine). E si potrebbero fare molti altri esempi, che dimostrano tutti come le varie culture abbiano
elaborato norme e principi per controllare il tempo sociale e lo spazio sociale dei più giovani.
Nelle nostre società contemporanee possiamo però osservare che tale regolamentazione del tempo
e dello spazio è saltata. E’ saltata perché i life markers che regolavano i percorsi di vita delle
persone sono saltati e le tradizionali tappe, costitutive del processo di entrata nella società adulta, si
2
Si veda al proposito Pianigiani O. 1991, Dizionario etimologico della lingua italiana, Genova, Edizioni Polaris.
5
sono molto confuse3. E questo è dovuto ad un insieme di fattori tanto di natura strutturale quanto di
carattere culturale. Anzitutto vi è l’invecchiamento: è stato prima osservato dal nostro moderatore
che la tradizionale piramide della popolazione ormai non è più una piramide, semmai un
parallelogramma. Se osserviamo, ad esempio, la proiezione della popolazione di Trieste al 2050
vediamo una piramide rovesciata: la parte superiore costituita dagli anziani è molto più larga di
quella inferiore dei ragazzi e dei giovani. Trieste è un caso emblematico, però tutte le grandi città
invecchiano. L’invecchiamento generale della popolazione porta a una conseguenza che alcuni
hanno definito come passaggio dalla famiglia orizzontale alla famiglia verticale. La famiglia
orizzontale è quella in cui ci sono tanti fratelli, gli anziani sono pochi, i cugini sono molti; le
relazioni sociali nell’età giovanile sono appunto di tipo orizzontale, prevalentemente fondate sui
rapporti tra pari. Le forme di socializzazione e di acquisizione dei modi di relazionarsi con gli
adulti e con i coetanei sono assai diverse da quelle che osserviamo nella famiglia verticale: cioè
nella famiglia nella quale si è spesso figli unici, e si convive o si hanno comunque intense relazioni
con padre, madre, nonni e bisnonni. Molto spesso la famiglia verticale si compone di quattro
generazioni. Non che nel passato non ci fosse la possibilità (anche se piuttosto rara) della
coesistenza di quattro generazioni, ma è cambiato il tipo di relazioni interne alla famiglia, anche a
causa del forte calo della natalità.
È abbastanza diffuso tra sociologi e psicologi che si occupano di questi temi, una schematizzazione
storica che interpreta le trasformazioni della famiglia attraverso quattro fasi. Un tempo vi era la
famiglia autoritaria nella quale i ruoli erano ben definiti, le regole certe, i rapporti tra i genitori e i
figli in gran parte codificati. È la famiglia dei primi decenni del secolo scorso in cui l’autorità dei
genitori è incontestata. La gestione della famiglia che è composta anche da molti figli è, tutto
sommato, semplice perché fondata su regole che non vengono mai messe in discussione. Dalla
famiglia autoritaria si è passati alla famiglia autorevole, tipica degli anni ’50 e ‘60, in cui il rapporto
genitori-figli è basato sul “buon esempio” dato dai primi e l’ubbidienza che i figli riservano ai
3
Come è noto tradizionalmente l’entrata nella vita adulta era scandita da una sequenza in cinque tappe: finire gli studi,
6
genitori è fondata sull’autorevolezza di questi ultimi. E’ un modello di socializzazione in cui non
c’è più la regola cogente, ma c’è il rispetto del genitore. Le cose poi si sono accelerate in questi
ultimi decenni, per cui nell’arco delle ultime generazioni si è passati alla famiglia negoziale, la
famiglia nella quale si contratta tra padre e figlio: è la famiglia in cui sono cresciuti gli attuali
trentenni, i trentacinquenni, forse anche i quarantenni. Una famiglia in cui vi è l’abitudine a
negoziare (“se sei promosso, ti compro il motorino”) e a discutere tutto, dall’orario di rientro a casa
la sera fino ai premi e alle punizioni. Alla famiglia negoziale ha fatto seguito la famiglia affettiva.
In questo caso le relazioni tra genitori e figli sono regolati dalla iperprotettività dei primi verso i
secondi. I padri e le madri sono disposti a perdonare quasi tutto, in nome dell’affetto e del
sentimento. Si è trattato, dunque, di un processo di attenuazione continua del sistema delle regole.
Da regole fisse, immutabili e appunto non negoziabili, si è passati ad un sistema di regole sempre
più allentato; dal genitore che, picchiando il figlio per una mancanza diceva “Credimi, fa più male a
me che a te” si è arrivati al genitore che dice “non dovresti farlo, ma te lo lascio fare per dimostrarti
che ti voglio bene”. In tal modo si prolunga l’adolescenza, cioè il periodo dell’irresponsabilità.
A ciò si aggiungano, poi, quando i figli diventano più grandi, le difficoltà di trovare un lavoro e di
costruirsi un proprio progetto di vita. Si arriva dunque alla cosiddetta “famiglia lunga”, alla
dilatazione dell’adolescenza, intesa come fase della vita in cui non si è ancora nulla, non si è ancora
definiti. Ma la contraddizione sta nel fatto che, mentre non si è ancora adulti nel senso pieno del
termine, non si è neppure più psicologicamente dipendenti dai genitori. La famiglia si trasforma da
luogo di socializzazione, di apprendimento delle regole del vivere civile, in luogo degli affetti, in
cui non c’è più un ordine
gerarchico tra adulti e giovani. La famiglia diventa un luogo di
coabitazione tra pari ed assume il ruolo di rete di protezione.
Io sono sempre stato molto critico nei confronti dell’interpretazione secondo la quale la famiglia
lunga è dovuta al tradizionale mammismo della nostra cultura. Anche perché il fenomeno della
lunga permanenza nella casa parentale si va diffondendo in tutta Europa. E’ un fenomeno dovuto ad
trovarsi un lavoro, andare via di casa, sposarsi, avere dei figli.
7
un’esigenza di tipo economico e di vita; la famiglia è la rete di protezione, è il luogo dove si vive o
si torna a vivere: perché assistiamo anche al fenomeno del ritorno in casa. Dopo un’esperienza di
separazione, di divorzio, di convivenza fallita, si torna nella casa dei genitori, perché è lì che si
trova la possibilità di mantenere lo stile di vita al quale si è abituati o che si giudica comunque più
soddisfacente rispetto al vivere da soli. Tutto ciò fa sì che il rapporto delle generazioni adulte con
quelle giovani sia un rapporto molto complesso e articolato. Il motivo principale sta nella
frammentazione e nell’intersecarsi delle fasi della vita; il vecchio ordine dei tempi e degli spazi
sociali è saltato. Un tale stato di cose si riflette poi sulle politiche sociali. Uno studio dell’Unione
Europea condotto nel 2000 divideva le politiche nei confronti dei giovani adottati dai diversi paesi
dell’Unione in due categorie. Da un lato le politiche attive, che vedono la popolazione giovanile
come una risorsa – le politiche della casa, le politiche di aiuto a trovare lavoro e simili – tipiche di
alcuni Paesi, soprattutto quelli scandinavi. Dall’altro lato vi sono Paesi – tra i quali l’Italia – che
adottano politiche volte al contrasto o alla eliminazione di problemi sociali, e quindi rivolte solo ad
alcune categorie, considerate “ rischio”; politiche che non hanno carattere generale, ma cercano di
tamponare situazioni. Ancora una volta troviamo l’ambivalenza della società adulta tra giovani
come risorsa e giovani come minaccia.
Stiamo dunque assistendo a modificazioni profonde nel rapporto tra le generazioni, accompagnate
dal sorgere di nuove frammentazioni. Le vecchie differenze – maschio e femmina, città e
campagna, centro e periferia – che tradizionalmente dividevano e fondavano le disuguaglianze
sociali, vanno non tanto scomparendo quanto intersecandosi con nuove frammentazioni che sono di
tipo culturale, all’interno della stessa popolazione giovanile. Assistiamo quindi all’intersecarsi di
disuguaglianze di ordine strutturale con disuguaglianze di tipo culturale che nascono dal fatto che
gli ambienti culturali sono diversi, i capitali culturali familiari di cui dispone ognuno di noi sono
differenti, le esperienze e le opportunità sono assai varie. Non posso approfondire questo punto
perché mi allontanerei troppo dal tema, ma si potrebbe fare, ad esempio, un’analisi delle attuali
differenze di genere proprio in questi termini. Le differenze di genere, infatti,
8
si sono assai
complicate perché accanto a quelle tradizionali – sul lavoro, sulle retribuzioni, sulla divisione dei
compiti domestici, – si vanno aggiungendo e componendo delle differenze di tipo culturale: essere
donna al nord non è la stessa cosa che essere donna al sud, essere donna casalinga al nord non è la
stessa cosa che essere casalinga al Sud.
Tutto questo comporta che se dobbiamo ragionare in termini di condizione giovanile, vediamo che
vi è una serie di contraddizioni. La contraddizione più forte secondo me è quella tra crescente
scolarizzazione e aumento della precarietà del mercato del lavoro. Noi abbiamo ancora un modello
culturale, che chiamerei di tradizione funzionalista, per cui un certo titolo di studio equivale a una
certa collocazione sul mercato del lavoro e a una certa retribuzione. Ma non è più così. Eppure nelle
attese di chi ha investito denaro (la famiglia) e tempo (il giovane) per acquisire un titolo di studio,
questa è un’aspettativa molto forte. Di conseguenza chi progetta il proprio percorso formativo, si
trova poi in difficoltà a progettare il proprio percorso di vita lavorativa. Difficoltà a progettare il
proprio percorso di vita lavorativa significa anche difficoltà, se non impossibilità, di progettare tutta
la propria vita: mettere su famiglia, avere dei figli, assumersi delle responsabilità verso gli altri.
Le nuove generazioni si trovano nella condizione di non poter più costruire un progetto di vita
perché i marcatori della vita non sono più in sequenza, sono cambiati, si sono confusi: avere un
lavoro oggi non vuol dire essere entrati nella vita lavorativa, vuol dire solo avere un lavoro oggi e
poi magari domani non averlo più. Questo fa sì che la condizione giovanile stia diventando sempre
più una condizione che caratterizza una vasta fascia di popolazione che una volta si definiva adulta.
Le ricerche sui giovani sono emblematiche da questo punto di vista. Negli anni Ottanta la
popolazione di riferimento era compresa tra i 15 e i 24 anni; negli anni novanta le ricerche sui
giovani prendevano in considerazione le persone tra i 15 ed i 29 anni; adesso siamo alla fascia tra i
15 ed i 34 anni e in un recente convegno al quale ho partecipato, si è discusso dei “giovani” fino a
39 anni. È evidente che non stiamo più parlando di popolazione giovanile, stiamo parlando di
popolazione in generale. Quella che oggi definiamo come “condizione giovanile” sta sempre più
9
diventando condizione di tutta la popolazione in età lavorativa. Una popolazione che si caratterizza
sempre più per una serie di elementi:
-
Caduta dei modelli di riferimento forti: non abbiamo più miti collettivi, non abbiamo
memoria collettiva; forse altri Paesi, come la Francia, stanno meglio di noi, ma è certo che
in Italia stiamo perdendo tutta la memoria del nostro passato; e la memoria collettiva è
importante – ce lo ha insegnato Gérard Namer4 - perché fa non solo l’identità di un popolo,
ma anche quella dei singoli cittadini.
-
Canali a doppia moralità: nella vita dei giovani vi è spesso una dicotomia: bravi ragazzi di
giorno e di sera “sfascio” nelle discoteche o ai rave party. Lo stesso può dirsi del fenomeno
degli ultras nello sport: persone che durante la settimana sono distinti impiegati e tranquilli
cittadini, si scatenano la domenica negli stadi.
-
Diffusione dell’accettabilità del rischio: perché viviamo – come dice Ulrich Beck5 – in una
società che corre molti rischi collettivi, e questa condizione generale sta diventando anche
accettabilità del rischio individuale: nei modi di guida, nell’assunzione di sostanze, in
comportamenti che comunque mettono a repentaglio la salute o l’integrità fisica.
-
Reversibilità delle scelte: proprio perché non si riesce più a progettare si diffonde un
atteggiamento di precarietà e di reversibilità delle scelte.
-
Infine, rinuncia all’assunzione di responsabilità: è un’altra caratteristica della popolazione
giovanile, tipica delle situazioni di incertezza.
Non è mia intenzione tracciare un quadro drammatico della situazione, ma siamo partiti dal
problema delle politiche sociali e mi sembra che la Fondazione Agnelli abbia ben presente
questo punto, e quando parliamo di politiche sociali dobbiamo parlare anche di politiche che
cerchino di recuperare il senso di una identità collettiva che portino ad evitare i rischi di
disgregazione e frammentazione sociale che stiamo correndo. Oggi le nostre identità individuali
Si veda ad esempio Namer G. 1993, Memorie d’Europa: identità europea e memoria collettiva, Soveria Mannelli
(CZ), Rubbettino Editore.
5
Si veda, tra gli altri, Beck U. 2000, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci.
4
10
sono pericolosamente chiuse nell’ambito del privato. Cito, al riguardo, solo un dato: un terzo
dei giovani intervistati recentemente (nel 2004), afferma che tutto sommato degli altri ci si può
fidare; ciò significa che due terzi dei giovani tra i 15 ed i 34 anni sono diffidenti nei confronti
degli altri: l’altro, se ne ha l’occasione, mi può danneggiare. È questo che intendo per chiusura
nel privato. Le identità vengono costruite nel
ristretto ambito familiare, identità fragili e
precarie, mentre io credo che oggi noi, in questa epoca di globalizzazione, abbiamo bisogno di
forti identità collettive.
Grazie.
11