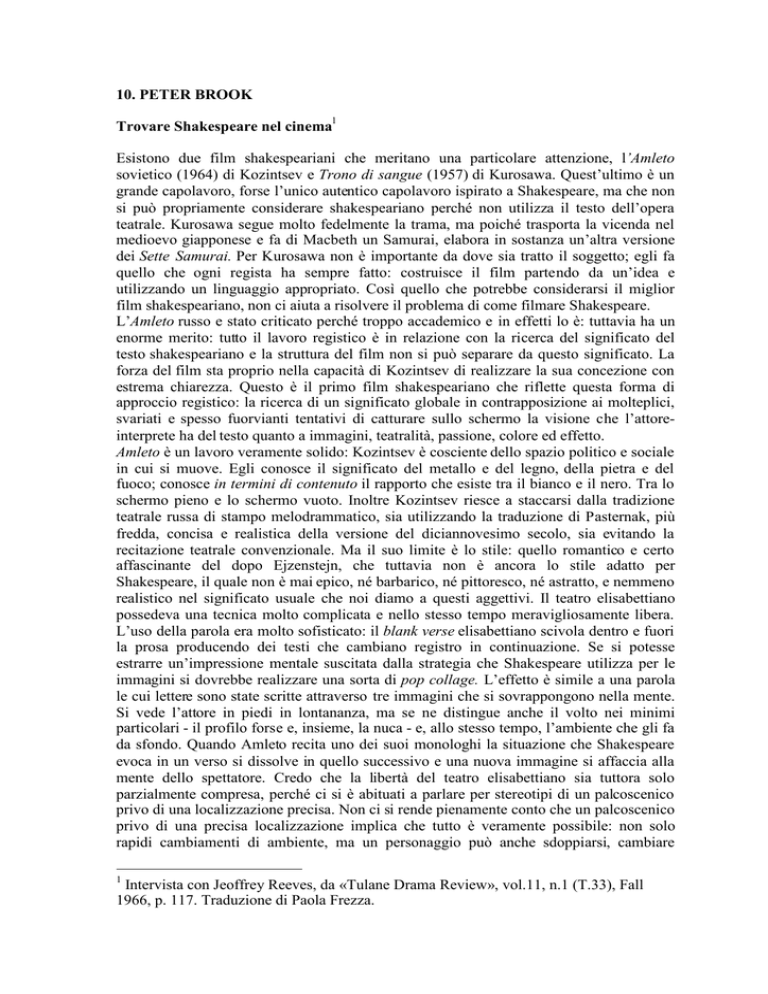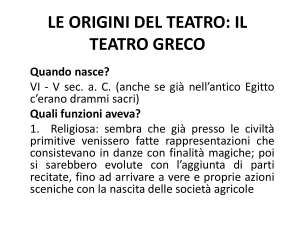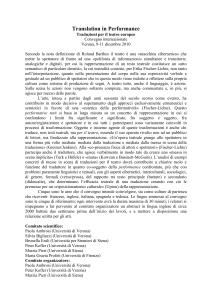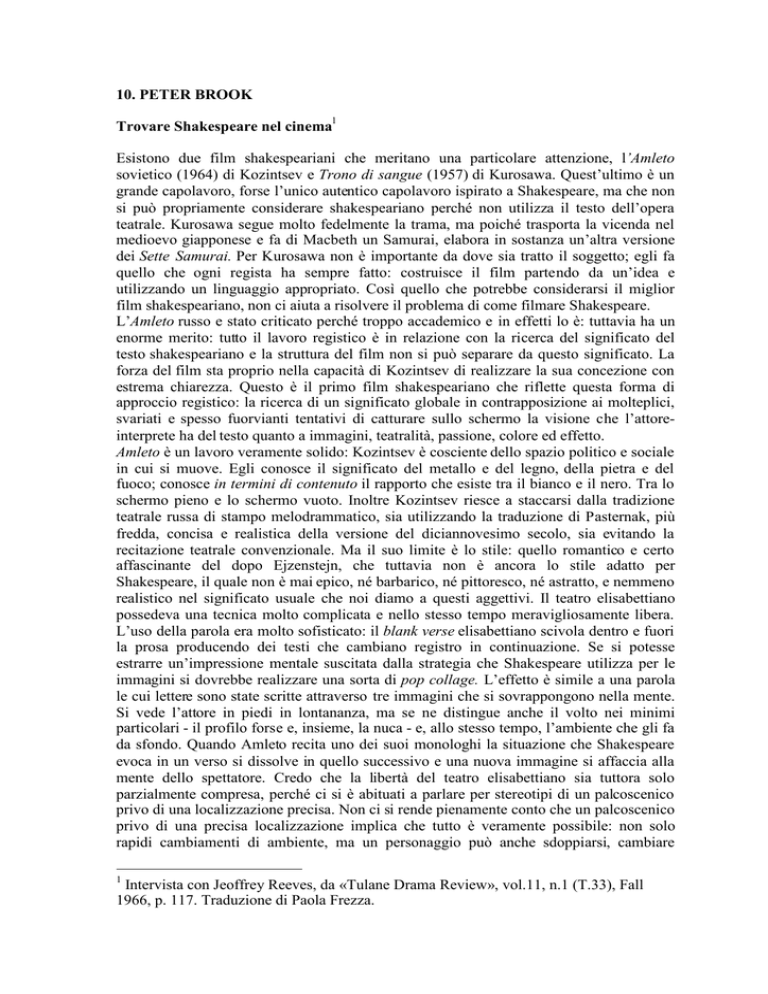
10. PETER BROOK
Trovare Shakespeare nel cinema1
Esistono due film shakespeariani che meritano una particolare attenzione, l’Amleto
sovietico (1964) di Kozintsev e Trono di sangue (1957) di Kurosawa. Quest’ultimo è un
grande capolavoro, forse l’unico autentico capolavoro ispirato a Shakespeare, ma che non
si può propriamente considerare shakespeariano perché non utilizza il testo dell’opera
teatrale. Kurosawa segue molto fedelmente la trama, ma poiché trasporta la vicenda nel
medioevo giapponese e fa di Macbeth un Samurai, elabora in sostanza un’altra versione
dei Sette Samurai. Per Kurosawa non è importante da dove sia tratto il soggetto; egli fa
quello che ogni regista ha sempre fatto: costruisce il film partendo da un’idea e
utilizzando un linguaggio appropriato. Così quello che potrebbe considerarsi il miglior
film shakespeariano, non ci aiuta a risolvere il problema di come filmare Shakespeare.
L’Amleto russo e stato criticato perché troppo accademico e in effetti lo è: tuttavia ha un
enorme merito: tutto il lavoro registico è in relazione con la ricerca del significato del
testo shakespeariano e la struttura del film non si può separare da questo significato. La
forza del film sta proprio nella capacità di Kozintsev di realizzare la sua concezione con
estrema chiarezza. Questo è il primo film shakespeariano che riflette questa forma di
approccio registico: la ricerca di un significato globale in contrapposizione ai molteplici,
svariati e spesso fuorvianti tentativi di catturare sullo schermo la visione che l’attoreinterprete ha del testo quanto a immagini, teatralità, passione, colore ed effetto.
Amleto è un lavoro veramente solido: Kozintsev è cosciente dello spazio politico e sociale
in cui si muove. Egli conosce il significato del metallo e del legno, della pietra e del
fuoco; conosce in termini di contenuto il rapporto che esiste tra il bianco e il nero. Tra lo
schermo pieno e lo schermo vuoto. Inoltre Kozintsev riesce a staccarsi dalla tradizione
teatrale russa di stampo melodrammatico, sia utilizzando la traduzione di Pasternak, più
fredda, concisa e realistica della versione del diciannovesimo secolo, sia evitando la
recitazione teatrale convenzionale. Ma il suo limite è lo stile: quello romantico e certo
affascinante del dopo Ejzenstejn, che tuttavia non è ancora lo stile adatto per
Shakespeare, il quale non è mai epico, né barbarico, né pittoresco, né astratto, e nemmeno
realistico nel significato usuale che noi diamo a questi aggettivi. Il teatro elisabettiano
possedeva una tecnica molto complicata e nello stesso tempo meravigliosamente libera.
L’uso della parola era molto sofisticato: il blank verse elisabettiano scivola dentro e fuori
la prosa producendo dei testi che cambiano registro in continuazione. Se si potesse
estrarre un’impressione mentale suscitata dalla strategia che Shakespeare utilizza per le
immagini si dovrebbe realizzare una sorta di pop collage. L’effetto è simile a una parola
le cui lettere sono state scritte attraverso tre immagini che si sovrappongono nella mente.
Si vede l’attore in piedi in lontananza, ma se ne distingue anche il volto nei minimi
particolari - il profilo forse e, insieme, la nuca - e, allo stesso tempo, l’ambiente che gli fa
da sfondo. Quando Amleto recita uno dei suoi monologhi la situazione che Shakespeare
evoca in un verso si dissolve in quello successivo e una nuova immagine si affaccia alla
mente dello spettatore. Credo che la libertà del teatro elisabettiano sia tuttora solo
parzialmente compresa, perché ci si è abituati a parlare per stereotipi di un palcoscenico
privo di una localizzazione precisa. Non ci si rende pienamente conto che un palcoscenico
privo di una precisa localizzazione implica che tutto è veramente possibile: non solo
rapidi cambiamenti di ambiente, ma un personaggio può anche sdoppiarsi, cambiare
1
Intervista con Jeoffrey Reeves, da «Tulane Drama Review», vol.11, n.1 (T.33), Fall
1966, p. 117. Traduzione di Paola Frezza.
sesso, vivere il suo passato, il suo presente, il suo futuro, essere la versione comica di se
stesso e quella tragica, non essere nessuna di queste cose e tutte contemporaneamente. Il
grande saggio di Kott sul suicidio di Gloucester evidenzia come il gesto di saltare da una
rupe immaginaria acquista il suo completo valore solo se realizzato su un palcoscenico
vuoto. Solo allora egli è un personaggio che sta facendo un salto che non significa niente,
e nello stesso tempo è un attore che sta facendo un salto pieno di significato, ed entrambi
contemporaneamente contengono tutte e due le implicazioni, sia quella concreta che
quella immaginaria. Al cinema, per lo meno in tutti i film da Shakespeare che abbiamo
visto, Gloucester è costretto a stare al centro di una ventosa brughiera che si può vedere e
descrivere, mentre il cinquanta per cento della staordinarietà di questa scena consiste nel
fatto che si svolge in una brughiera immaginaria, ai confini dell’inesistente. Il senso è
dato dalla doppia natura dell’azione, al contrario se si isola un solo aspetto si perde tutto il
significato della scena. Un salto su un palcoscenico vuoto può essere fatto da chiunque,
un salto in una brughiera è altrettanto facile. Ma Lear, quando viene rappresentato a
teatro, ci dà le due cose contemporaneamente. In questo modo è come se l’idea stessa
colpisse lo spettatore nella sua pura forma. Dall’altro lato, nell’ Amleto di Kozintsev lo
stesso stile usato dal regista diventa alla fine la sua prigione. Il film crea un mondo
plausibile nel quale ogni azione può essere ragionevolmente spiegata. Ma il prezzo che
noi paghiamo per questo mondo plausibile è che la complessità di cui prima ho parlato
non viene rivelata né dimostrata. Il problema di filmare Shakespeare consiste nel
cambiare sullo schermo registro, stile e convenzioni con la stessa leggerezza e agilità di
quanto avviene nello schermo del pensiero grazie al processo mentale che il blank verse
elisabettiano riesce a stimolare. La pesantezza del cinema deriva dal fatto che ciascun
particolare all’interno di ogni singola immagine tende a una durevole consistenza. E noi
una volta pensavamo al cinema come movimento!
L’effetto che l’invenzione del suono ha avuto sul cinema in generale e su questo
problema in particolare è curioso e cruciale. Il suono ha impedito al cinema di continuare
il suo percorso. Si pensò all’inizio che il suono avrebbe privato la cinepresa della sua
mobilità. E così è stato, ma solo per un breve periodo; poi i nuovi microfoni a gru hanno
cominciato a muoversi e ad essere orientabili, e per anni tutti hanno ingenuamente
pensato che il cinema fosse diventato di nuovo mobile. Ma la mobilità di pensiero, che il
cinema muto aveva avuto, è stata riconquistata solo dalle tecniche che si sono sviluppate
dopo Godard. Per quanto riguarda la sperimentazione (se non per i soggetti), Godard è
uno tra i più grandi registi dei nostri giorni. Continuamente egli libera le immagini dalla
loro stessa consistenza. Un momento lo spettatore guarda semplicemente la fotografia di
due persone in un bar, un momento dopo si sente estraniato per metà, poi per tre quarti,
poi si trova a guardare il film da regista, poi si ricorda che esso è stato realizzato da attori
e subito dopo è di nuovo trascinato a credere ciecamente nella finzione. Tutto ciò ha
qualcosa a che fare con lo straniamento teatrale e in modo più diretto con quel teatro
libero-cinema libero che lo Shakespeare del periodo elisabettiano deve essere stato.
Un uomo seduto ripreso oggettivamente da una cinepresa non costituisce di per sé
nessuna realtà oggettiva. Noi ci siamo trovati per anni di fronte a questo cul de sac.
Gradualmente ci stiamo rendendo conto che la fotografia non e obiettiva, non è realistica;
la realtà del film esiste - nel momento della proiezione, nel momento in cui l’immagine è
proiettata sullo schermo - se c’è uno spettatore che la guarda. L’interazione tra immagine
e spettatore è l’unica realtà possibile al cinema. La realtà di sei settimane prima o di sei
mesi prima - un uomo seduto in una stanza - non è più reale; non c’è alcuna “virtù” nel
cosiddetto “naturalismo” del processo fotografico. Un’immagine sarebbe reale se fosse in
grado di fornire la totalità delle informazioni, ma la semplice registrazione di un evento
non può assolutamente realizzare una funzione così complessa.
A questo proposito nello studio di Stratford ho realizzato un esperimento molto
interessante. Ho fatto sedere un attore di fronte al gruppo dei suoi colleghi, gli ho
domandato di pensare a una situazione complicata per lui e quindi di vivere, come attore,
le emozioni interiori che questa situazione gli procurava. Poi gli altri del gruppo gli
ponevano delle domande per scoprire che cosa stava succedendo. Ma lui non poteva
rispondere. Naturalmente si creava una situazione assurda: si vedeva un uomo che aveva
qualche travaglio interiore. Ma questo era tutto. Qualche volta, alla fine, egli rivelava la
sua storia personale - per esempio che stava aspettando che la sua ragazza andasse dal
dottore per sapere se era rimasta incinta, questo avrebbe significato decidere un aborto,
trovare il denaro necessario, la possibilità che la moglie scoprisse la relazione e così via,
ma, ovviamente niente di tutto questo era emerso durante l’esperimento. Questo esercizio
mette in luce con chiarezza il fatto che quello che gli occhi guardano non ha di per sé
nessun valore narrativo. L’attore stava immobile, senza mostrare alcuna espressione. Le
interpretazioni variavano dall’ipotesi che l’interprete fosse in attesa nell’anticamera di un
dentista a ogni genere di situazione tragica. La frustrazione cresceva poiché il gruppo non
poteva raggiungere l’attore e viceversa il silenzio immobile di quest’ultimo non poteva
raggiungere il gruppo, così si è potuto sperimentare come le apparenze esteriori non
producono nessuna comunicazione.
Questa considerazione ci induce ad analizzare due casi estremi: Antonioni e Godard, e a
confrontare due modi di lavorare molto differenti tra loro. Antonioni accetta la solidità e
la rigidità dell’immagine cinematografica e utilizza poi tutta una serie di accorgimenti nel
tentativo di catturare l’invisibile. Al contrario Godard attacca la rigidità dell’immagine e
prova a catturarne i molteplici aspetti. Entrambi rifiutano il concetto che l’inquadratura
presa da sola o in sequenza temporale giunga a produrre significato e che l’inquadratura
sia un’unità fondamentale completa e conchiusa in se stessa. La teoria classica del
montaggio, che si fonda sulla convinzione che il regista componga delle unità che hanno
in sé un certo grado di completezza – l’inquadratura come unità minima, come parola,
come mattone - è falsa. Moderato cantabile è stato un mio personale esperimento per
scoprire se era possibile fotografare una realtà invisibile, se era possibile, semplicemente
fotografando le apparenze esteriori, andare oltre queste apparenze.
Il mio proposito è ambizioso: a teatro e specialmente al cinema voglio catturare tutte le
informazioni possibili. Questo mi fa sospettare della perfetta coerenza imposta da un
unico stile, perché questo impedisce allo spettatore di scoprire qualcosa che potrebbe
voler conoscere. Se abbiamo una storia che è solo una vicenda intima tra due persone, ci
potrebbe essere qualcuno interessato all’aspetto sociale: se si tratta di un soggetto epico, è
possibile che qualcuno voglia conoscere la vita interiore dei personaggi. È solo in
Shakespeare che si riesce a trovare l’equilibrio di tutte le componenti: niente è sacrificato,
niente è trascurato, e nonostante questo la coesione dell’opera non viene assolutamente
danneggiata. Tutti gli elementi sono presenti al completo senza neutralizzarsi
reciprocamente.
Per rappresentare il suicidio di Gloucester in un film secondo me sarebbe necessario
ricorrere allo straniamento. Lo straniamento fornisce infinite possibilità ed è questa
l’unica strada che ci permette di riprodurre le infinite possibilità del blank verse. Le
immagini evocate dai versi pongono constantemente persone e cose in una nuova
prospettiva, e si ottiene lo stesso effetto utilizzando la tecnica dello straniamento. Il
fotogramma fisso, la didascalia, il sottotitolo, ecc.. sono tutti esempi molto rozzi di
straniamento applicato al film. Ma la complessità di un testo Shakespeariano pone il
regista davanti a un problema di tutt’altra dimensione. I film di Godard potrebbero
costituire lo spunto per la ricerca di un nuovo stile, ma questo stile non potrebbe mai
tenere il confronto con le enormi risorse, la scala e lo spettro d’azione richiesti dall’opera
di Shakespeare. Una tecnica con un grande potenziale per rappresentare Shakespeare al
cinema è stata utilizzata nel documentario di Francis Thompson per la Johnson Wax al
World’s Fair di New York. La gente faceva a pugni per venire a vedere questo piccolo
studio sulla crescita di alcuni ragazzi in diverse parti del mondo. Il film usava
brillantemente la vecchia tecnica dello schermo multiplo di Abel Gance e ne rivelava le
straordinarie possibilità. Si tratta di tre schermi affiancati sui quali avvengono tre
proiezioni simultanee. Questa tecnica richiede uno spazio grande come quello di uno
schermo da Cinerama, ma mentre il Cinerama finge che si tratti di una sola grande
immagine, simile a una vasta finestra affacciata sul mondo, la tecnica di Thompson è
molto più brechtiana. La sottile striscia nera che separa gli schermi non fa mai
dimenticare allo spettatore che sta guardando tre fotogrammi separati. Qualche volta gli
schermi sono usati in modo unitario, come nel caso della grande sequenza del canottaggio
realizzata su vasti scenari: le canoe passano velocemente e saltano le interruzioni tra uno
schermo e l’altro. La situazione è simile a quella di uno spettatore che sta seduto dietro
una colonna in un vecchio cinematografo. Ma quelle interruzioni ricordano costantemente
che nel momento in cui il regista non vuole più utilizzare tutto lo spazio del Cinerama, ha
la possibilità di frammentare l’immagine per ottenere un effetto completamente diverso.
Ed è proprio questa la strategia di Thompson: un momento i tre schermi mostrano il
flusso del traffico in America, un matrimonio in Italia, un paesaggio africano; un
momento dopo la composizione cambia e lo schermo ci mostra un ragazzo africano
mentre negli altri due siamo ancora a New York; la ripresa successiva mostra tre
differenti vedute di un medesimo oggetto; quella ancora successiva, tre identici primi
piani; poi uno schermo potrebbe conservare la stessa immagine, e gli altri evidenziare
aspetti e angolature diversi, e così via. Qui la tecnica non è impiegata a fini estetici:
l’opera di Thompson non richiede uno sforzo di immaginazione più grande di quello
richiesto dai film normali, ma esso consente al suo pubblico di cambiare prospettiva
passando da tre schermi che raccontano la stessa cosa, a tre schermi che raccontano tre
cose diverse, come modalità connaturata al suo linguaggio, un linguaggio che
potenzialmente è flessibile quanto il verso.
Il grande vantaggio di questa strategia è la sua possibilità di rompere la consistenza
interna di ogni inquadratura, aprendo una sfera di infinite possibili variazioni. Il regista
potrebbe mostrare Amleto sugli spalti del castello di Elsinore utilizzando lo schermo di
destra mentre sugli altri due verrebbero ripresi un bastione e il mare. Oppure, tornando a
Gloucester, si potrebbe vedere la brughiera e poi, nel momento in cui inizia il soliloquio,
eliminarla immediatamente e concentrare l’interesse dello spettatore su diverse
inquadrature di Gloucester. Si potrebbe anche utilizzare uno schermo per una didascalia,
o un verso o un sottotitolo. Nel mezzo di un’azione realistica a colori se ne potrebbe avere
un’altra in bianco e nero e una terza con la didascalia. Si potrebbe inserire un dato
statistico o un cartone animato che parodizzi l’azione fotografata. Questa tecnica
cinematografica ha esattamente le stesse possibilità del palcoscenico brechtiano e di
quello elisabettiano. Io credo che lo schermo multiplo offra una reale oppurtunità di
innovazione e costituisca una via attraverso la quale sarebbe possibile rappresentare
Shakespeare nel linguaggio del cinema. Ma questa è solo un’idea, economicamente molto
difficile da realizzare.
L’unica cosa che conta oggi è definire i termini del problema. L’immagine filmica di un
attore su un palcoscenico vuoto è un’affermazione estetica ben più limitata e ristretta
della semplice presenza di un attore su un palcoscenico vuoto. Ma in linea di principio il
palcoscenico vuoto e lo schermo bianco hanno le stesse potenzialità espressive. Come
può lo schermo liberarsi dalla sua rigida solidità, così da riflettere quella mobilità di
pensiero che è necessaria per la rappresentazione cinematografica del blank verse?
A proposito del Re Lear e del Marat-Sade2
Se permettete, cercherò di riflettere ad alta voce. In un certo senso la ragione per cui
in questo momento sono molto preoccupato — e ho pochissimo tempo — è legata al
vostro tema: contemporaneamente sto provando a teatro e lavorando al montaggio di
un film. È molto interessante perché, me ne rendo conto, ho sempre lavorato in questa
maniera, il mio lavoro è sempre stato a cavallo fra questi due generi di spettacolo.
All’inizio avevo l’impressione che ci fosse un rapporto molto stretto fra il cinema e il
teatro e che passare dall’uno all’altro fosse una cosa molto tonificante, molto
arricchente. Era vero, resta vero. Ma attraverso questo lavoro vado scoprendo, sempre
più chiaramente, che in fondo questi due generi non hanno assolutamente niente in
comune. Apparentemente, in entrambi (naturalmente se escludiamo il cinema
documentario) ci sono degli attori, qualcosa che è stato concepito, predisposto,
preparato prima, che si esprime per immagini, attraverso l’azione di persone che
hanno ricevuto una preparazione apposita, che esprimono la realtà attraverso una certa
tecnica e un certo mestiere; c’è qualcuno che funge da “regista” e questo avviene in
entrambe le arti. Ma in verità, profondamente, sono arrivato alla conclusione che la
loro relazione sia dello stesso tipo di quella che si ritrova in un fenomeno assai
curioso: la maggior parte dei medici, per una ragione che finora nessuno ha saputo
spiegare, ama molto la musica. Ho conosciuto un ottimo medico che suonava il corno
inglese, c’è un gran numero di medici che passano il loro tempo libero ascoltando
Mozart e si vede che all’interno della stessa persona i due interessi coesistono. Ma
allo stesso tempo non si può scoprire alcuna relazione reale fra medicina e musica.
Forse esagero, ma mi pare che qualcosa del genere avvenga nel rapporto fra cinema e
teatro.
Filmare il teatro: credo che non esista un terzo genere che sarebbe il teatro filmato
[...], così come non si può dire che il cinema destinato alla televisione sia realmente
diverso dal cinema. Il cinema fatto alle condizioni della televisione è un cinema
realizzato con minori possibilità del solito: si gira più in fretta, si dispone di un minor
numero di inquadrature, ecc. Nello stesso modo il cinema fondato su dati teatrali è
forse utile, per lo studio e la ricerca, ma non può possedere un reale valore, una vera
esistenza indipendente.
Io stesso ho filmato diverse volte degli spettacoli che avevo già messo in scena e si è
trattato ogni volta di esperimenti molto diversi, che ho tentato per motivi molto
diversi. Talvolta mi è capitato di fare un film dopo aver allestito lo spettacolo a teatro,
cercando di ricrearne completamente il senso. Si trattava di approfittare di una
conoscenza del soggetto acquisita durante il lavoro a teatro per cercare di ricrearla in
modo diverso. [...] È in questa prospettiva che abbiamo fatto un film dal Re Lear sette
o otto anni dopo aver allestito la pièce a teatro.3 Fare il film senza restare attaccati
2
L’intervento e la discussione che seguono sono tratti dal volume Filmer le théâtre,
une table ronde internationale du CNRS dirigée par Denis Bablet (29 nov.-1° déc.
1977). Ivry-sur-Seine – CNRS – Cerdavv), «Cahiers Théâtre Louvain», n. 46, 1981,
Louvain-la Neuve. La traduzione è di Paola Quarenghi. Il testo è stato parzialmente
pubblicato nel volume Peter Brook, Il punto in movimento. 1946-1987, Ubulibri,
Milano 1988, pp. 171-74, la cui traduzione è qui utilizzata con piccole modifiche.
3
Lo spettacolo è stato messo in scena a Stratford-on-Avon nel 1962, con Paul
Scofield nel ruolo del titolo. Il film, con lo stesso protagonista, è del 1970.
all’esperienza teatrale è stata una sfida molto interessante. Ed è stato interessante per
me cercare di capire in che modo fosse possibile o impossibile portare Shakespeare
sullo schermo.
Il caso di Marat-Sade fu molto diverso. Peter Weiss ed io considerammo a lungo
l’ipotesi di fare un film vero e proprio, ricominciando da zero;4 la nostra idea era che
dovesse iniziare con alcuni parigini che, in preda alla noia e non sapendo come
trascorrere la serata, decidono di andare al manicomio di Charenton a dare
un’occhiata ai pazzi. Cominciammo a lavorare a una sceneggiatura molto elaborata ed
estrosa, ma poi ci rendemmo conto che quello che stavamo inventando con tanto
entusiasmo avrebbe richiesto costi tanto elevati che sarebbe stato impossibile
realizzare il film.
Un giorno David Picker, direttore della United Artists, offrì a Michael Birkett, un
produttore inglese dotato di grande inventiva, e a me un finanziamento molto modesto
di duecentocinquantamila dollari per fare il film del Marat-Sade, lasciandoci piena
libertà di farlo come meglio volevamo, purché terminassimo la lavorazione entro la
data stabilita. Dopo un rapido calcolo ci rendemmo conto che questo significava fare
il film in quindici giorni. Era una sfida stimolante, ma era chiaro che dovevamo
concepire il film in un modo del tutto diverso e attenerci quanto più possibile alla
versione teatrale che era stata già provata ed era pronta. Nello stesso tempo cercavo di
individuare un linguaggio che fosse proprio del cinema, che evitasse la noia mortale
del teatro filmato e cogliesse in un modo del tutto autonomo quel tipo di atmosfera
eccitante e coinvolgente dello spettacolo.
È stata un’esperienza molto rivelatrice, molto eccitante per chi l’ha vissuta. Credo che
a quelli che hanno visto il film senza vedere lo spettacolo una gran parte
dell’esperienza teatrale sia stata comunicata. Ma tutti quelli che hanno viso lo
spettacolo in scena e ne hanno ricavato un’impressione molto forte, tutti, senza
eccezione, credo, hanno trovato che il film non era all’altezza dello spettacolo.
C’erano la stessa scenografia, gli stessi attori, lo stesso regista, la stessa conoscenza
del soggetto da parte di tutti. Durante le riprese ho analizzato inquadratura per
inquadratura, procedendo a piccoli cambiamenti, modificando l’asse in modo che
l’azione fosse più raccolta, più adatta alla macchina da presa.
Le riprese dello spettacolo furono fatte come se si trattasse di un incontro di boxe,
cioè con tre o quattro cineprese che lavoravano senza interruzione, divorando
chilometri di pellicola. Le macchine avanzavano e indietreggiavano, giravano e
rigiravano quasi facendosi interpreti dei movimenti del pensiero di un presunto
spettatore, simulando l’esperienza che questi avrebbe fatto seguendo i frammenti dei
pensieri contraddittori dei pazzi e incassando i pugni sullo stomaco che Peter Weiss
dava con tutto ciò che aveva messo nel “suo” manicomio. Penso, dopotutto, di essere
riuscito a dare una visione molto soggettiva dell’azione; soltanto più tardi mi resi
conto che è proprio nella soggettività la differenza reale tra un film e uno spettacolo
teatrale.
Quando avevo curato la regia del dramma di Weiss in teatro, non avevo fatto il
benché minimo tentativo di imporre il mio punto di vista sul testo; al contrario, avevo
cercato di fare in modo che ci fossero più punti prospettici possibile. Di conseguenza
gli spettatori erano sempre liberi, in ogni scena e in ogni momento, di concentrare la
propria attenzione sugli aspetti che li interessavano di più. Certo, come spettatoreregista avevo anch’io le mie preferenze; nel film infatti feci ciò che un regista
4
La messa in scena del Marat-Sade di Peter Weiss (Aldwich Theatre, Royal
Shakespeare Company) è del 1964, il film del 1967.
cinematografico non può evitare di fare e cioè far vedere quello che vedono i suoi
occhi. In apparenza sembra non esserci alcuna differenza fra la realizzazione
cinematografica e ciò che si vede a teatro. Ma in realtà ho verificato ancora una volta
fino a che punto una illusione soggettiva è un impoverimento, cosa che è confermata
dall’impressione di tutti quelli che hanno potuto confrontare le due esperienze,
spettacolo teatrale e film. Il film era la stessa cosa, ma vista attraverso gli occhi di
qualcun altro. A teatro l’immagine era più completa perché nella sala mille persone
vedevano ad un tempo la stessa cosa e insieme qualcosa di diverso, qualcosa che
rappresentava e costituiva la partecipazione attiva di ciascuno.
Sia nel cinema sia nel teatro, il pubblico riceve, più o meno passivamente, impulsi e
suggestioni. Questo è un aspetto fondamentale nel cinema, perché il potere
dell’immagine è così forte che assorbe del tutto lo spettatore. Egli può riflettere su
quello che sta vedendo o subito prima che l’impressione si sia formata dentro di lui o
subito dopo, mai nello stesso momento. Quando l’immagine è lì, in tutta la sua forza,
nell’attimo preciso in cui viene percepita, non si può né pensare, né sentire, né
immaginare altro.
In teatro si è seduti a una distanza fissa dall’azione, ma tale distanza cambia di
continuo: basta che una persona sulla scena ci convinca a credere in lei e la distanza si
riduce, perché in quel momento si vive l’esperienza di entrare in contatto con quella
qualità della recitazione nota come “presenza”, che è in grado di far nascere una sorta
di intimità. Poi vi è il movimento contrario: quando la distanza aumenta, qualcosa si
allenta, si distende, ci si ritrova un po’ più lontani. Una relazione teatrale autentica è
simile al rapporto umano tra due persone: il grado di coinvolgimento cambia
continuamente. Ma è molto raro che questa distanza sia abolita, come avviene col
primo piano cinematografico. Per questa ragione il teatro ci permette di vivere
qualcosa in modo molto intenso e al tempo stesso di salvaguardare una certa libertà.
Questa doppia illusione è il fondamento stesso dell’esperienza teatrale e della stessa
forma drammatica. Il fatto è che se sono abbastanza convincente, con un solo gesto,
facendo così (Peter Brook punta due dita della mano destra verso Denis Bablet [a
imitare la minaccia di una pistola]) posso creare qui davanti a voi una doppia
immagine. L’immagine di qualcuno con un maglione arancione che fa questo, e
contemporaneamente l’intenzione che sono pronto a mettere nel gesto e che voi siete
pronti a ricevere, a percepire attraverso il mio gesto. L’immagine evocata
dall’intenzione è alla base del gioco infantile. Io minaccio Denis. Se egli sorride, il
suo sorriso è la prova che in quello stesso momento lui ha visto una doppia immagine,
ha visto due dita e la pistola e tutto il contesto individuale e sociale, potremmo quasi
dire politico e psicologico. La persona che sta laggiù nella sala ci scatta una foto e
vediamo fino a che punto una foto, che dovrebbe essere un documento, sia invece un
falso documento. Perché tutti gli aspetti che ho appena evocato, se non c’è una
descrizione del contesto, non sono rappresentati. La fotografia non rappresenta la
realtà, ma un piccolissimo aspetto della realtà, il suo aspetto puramente visivo. Una
cinepresa che, cominciando da qui, mostrasse i due movimenti, darebbe una parte un
po’ più grande di questa informazione. Ma questa immagine creata dalla cinepresa
sonora non offrirebbe comunque una informazione completa, offrirebbe
un’informazione molto parziale, perché sarebbe sottolineato in modo eccessivo il
primo grado, con un’immagine che, per la sua forza invadente, darebbe a chi la vede
minori possibilità di chi vede la realtà qui nella sala, di completare l’informazione
percependo la faccia nascosta del gesto. Per questo sono sempre stato affascinato da
certi vecchi film di teatro, per esempio i film sui grandi attori del passato (le brevi
sequenze che abbiamo visto su Sarah Bernhardt). Mi ha colpito vedere come la
macchina da presa sia incapace di produrre ciò che dovremmo essere in grado di
produrre, cioè dei documenti. Documento significa codice, maniera di tradurre in cifre
esattamente ciò che è avvenuto. Se oggi guardiamo un pezzo di pellicola che mostra
Sarah Bernhardt, l’impressione che ne ricaviamo è comica. [...] Nel momento in cui
venivano effettuate le riprese, non credo che i cineasti ridessero di nascosto, al
contrario: erano impressionati e commossi. Eppure il pattern è lo stesso, la pellicola è
proprio quella che è passata dietro gli obiettivi nel momento in cui Sarah Bernhardt si
muoveva davanti alla macchina da presa. Dunque il documento passa da un’epoca
all’altra. E questo documento [...] non solo è incompleto, ma è molto falso perché non
è in grado di comunicarci la totalità di quel che è successo, non ci presenta che una
realtà parziale, ci trasmette solo l’aspetto esteriore di Sarah Bernhardt senza
permetterci di comprendere come i suoi gesti venivano ricevuti. [...]
Il problema è sempre lo stesso. Nel Marat-Sade l’azione sul palcoscenico evocava per
tutto il tempo immagini complementari che integravano nella mente dello spettatore
ciò che egli vedeva: c’era l’immagine dei pazzi che recitavano e che imitavano scene
della Rivoluzione; le illustravano in modo parziale, ma ciò che facevano era
abbastanza suggestivo e quindi il pubblico con l’immaginazione poteva completare il
quadro. Abbiamo cercato di ottenere questo effetto anche nella versione
cinematografica e credo che in certe scene ci siamo riusciti. Per esempio, Charlotte
Corday bussa alla porta di Marat. In scena avevamo risolto nella maniera più semplice
e più teatrale: un attore tendeva un braccio — che diventava il simbolo di una porta —
lei bussava, un altro faceva il rumore del toc toc sulla porta e un altro ancora imitava
il rumore della porta che si apriva. Era puro teatro. Durante le riprese decisi di provare
se sarebbe stato possibile consentire allo spettatore questa doppia visione pur nella
spietata letteralità della fotografia. Questo era il tipo di problemi che veniva fuori a
ogni piè sospinto mentre giravamo.
Problemi analoghi ci si presentarono nel caso del Re Lear. La pregnanza di un
dramma shakespeariano sulla scena è dovuta al fatto che l’azione avviene in luoghi
imprecisati. Un’opera di Shakespeare non ha una sua ambientazione; ogni tentativo,
sia esso più o meno sostenuto da ragioni estetiche o politiche, di situarla in una
precisa cornice è un’imposizione che rischia di sminuirlo. I suoi drammi possono
cantare, vivere e respirare soltanto in uno spazio vuoto.
Uno spazio vuoto consente allo spettatore di evocare nella sua fantasia un mondo
molto complesso, ricco di tutti gli elementi del mondo reale, in cui coesistono e
interagiscono rapporti di ogni tipo: sociali, politici, metafisici, individuali. Un mondo
che viene creato e ricreato a ogni istante un tocco dopo l’altro, un tema dopo l’altro,
un’interazione dopo l’altra fra i personaggi, così da far svelare a poco a poco il
dramma. In qualsiasi opera di Shakespeare è essenziale che l’immaginazione dello
spettatore, come quella dell’attore, sia in uno stato che gli permetta di spaziare in
libertà, perché deve muoversi in un labirinto assai complesso; il valore dello spazio
scenico vuoto, quindi, assume una grande importanza perché permetterà allo
spettatore di avere, ogni due o tre secondi, l’occasione di liberare il campo della sua
mente dalle tante impressioni che riceve; in questo modo gli si darà l’opportunità di
perderle proprio perché possa meglio conservarne il sapore.
È un principio del tutto analogo a quello su cui si fonda la televisione. In essa
l’immagine e la continuità dell’immagine sono del tutto inseparabili dal principio
elettronico del ritorno costante, punto dopo punto, allo schermo neutro. Se lo schermo
potesse trattenere per un certo tempo la stessa immagine, dopo un sessantesimo di
secondo non si vedrebbe più nulla; esattamente la stessa cosa avviene al cinema. Al
cinema la visione è possibile perché ogni immagine dopo un venticinquesimo di
secondo viene cancellata e si torna allo schermo bianco per poter vedere una nuova
immagine. E questo è proprio quello che accade a teatro. Messo a confronto con un
palcoscenico del tutto neutro, lo spettatore riceve nel tempo di un secondo, un
impulso che gli consente di situare l’immagine: per esempio, ode la parola “foresta”
nel Sogno di una notte di mezza estate ed è sufficiente: essa evoca l’intera scena e
questo processo di evocazione deve restare presente e attivo nei minuti che seguono.
Suscitata da una frase soltanto, l’immagine è percepita subito in tutta la sua globalità;
in seguito si sposta dal primo livello della mente, da cui è stata captata, a un altro e
rimane con discrezione in sottofondo, come un ricordo che ha il ruolo di guida nella
comprensione di tutta la scena; poi può essere quasi del tutto obliterata fino al
momento in cui, duecento battute più tardi, occorrerà far riemergere l’immagine della
foresta. Nell’intervallo fra questi due momenti l’immagine è scomparsa, liberando lo
spazio mentale in cui impressioni di tipo diverso possono emergere, suscitate, per
esempio, da acute osservazioni dei pensieri e dei sentimenti nascosti sotto la
superficie del dramma.
Nel cinema, il processo è del tutto diverso. Vi è un problema costante contro cui si
deve sempre lottare: l’eccessivo potere intrusivo dell’immagine, i cui dettagli
rimangono nel campo visivo per un tempo molto superiore al necessario. Se una scena
di dieci minuti si svolge in una foresta, non riusciamo mai a eliminare gli alberi.
È chiaro che vi sono delle tecniche equivalenti a quelle del teatro: il montaggio, l’uso
di lenti che mettono in risalto il primo piano e lasciano il resto fuori fuoco, ma non è
affatto la stessa cosa. La realtà dell’immagine è la forza del film ma è anche il suo
limite. Nel caso di un film tratto da un’opera shakespeariana vi è un ulteriore
problema: bisogna stabilire un legame fra due ritmi diversi. In Shakespeare il ritmo è
dato dalle parole del dramma; ha inizio con la prima battuta e continua fino all’ultima
e ha bisogno di essere variato e sostenuto in continuazione. È un ritmo del tutto
diverso da quello dato dal flusso e riflusso delle immagini su cui si basa il cinema. Far
coincidere questi due ritmi è difficile, anzi, direi quasi impossibile — e dico quasi
impossibile perché vi sono dei momenti di grazia in cui, in modo fugace, si riesce a
sfiorare l’ideale.
Volevo solo tentare di impostare questi problemi, per come li vedo. Altri, senza
dubbio, cercheranno di penetrare in questa strano territorio in cui cinema e teatro si
incontrano.
Discussione
O. Aslan. Sul piano vocale, come recitano gli attori nel film in rapporto a quanto
facevano nella rappresentazione teatrale?
P. Brook. Meno forte.
O. Aslan. Solamente, oppure c’è un lavoro di trasposizione?
P. Brook. Molto poco. Gli attori avevano recitato a teatro dopo un lungo periodo di
prove. Nelle prove si comincia recitando molto piano e poi arriva il momento in cui si
deve raggiungere la forza necessaria per far arrivare la voce al pubblico. Quando si
filma o anche quando si fanno delle riprese brevi per la televisione, è un esercizio
molto difficile per l’attore, perché l’attore sente che c’è qualcosa di inautentico che a
teatro non si percepisce a causa della distanza. Poiché con la macchina da presa la
distanza è ridotta, egli è obbligato a tornare a un impulso interiore più adatto, che si
ottiene sempre riducendo il livello. Per questo dico: recita meno forte. Ben inteso, non
si può immediatamente prendere un altro tono per la macchina da presa o recitare con
un naturalismo che non ha niente a che vedere col soggetto. Ma la recitazione è più
contenuta, così come lo spazio. L’impianto è diverso. Non si può vedere in dettaglio
come queste differenze influiscano sulla messa in scena, ma in realtà ogni cosa è
disposta in modo diverso. In un momento avete un’immagine, il ragazzo con la
maglia gialla che fa un annuncio, qualche commento, entra immediatamente
nell’inquadratura, mentre in realtà si trovava dall’altra parte della scena. Perché si
guarda soltanto da quella parte, e hop, arriva una voce e gli spettatori voltano la testa.
Al cinema si dimentica completamente l’impatto perché immediatamente ci si
relaziona con i primi piani. Al cinema, continuamente, inquadratura dopo
inquadratura, si opera un cambiamento che consente di ridurre lo spazio, perché tutto
rientri in quel piccolo quadro.
O. Aslan. In effetti alcuni piani sonori sono stati modificati, ma gli attori hanno
comunque conservato una recitazione molto forte. È una cosa che mi ha colpito in
questa registrazione: i piani sonori restano molto marcati e il suono non è affatto
appiattito come talvolta accade nei film.
P. Brook. Fare tutto questo in quindici giorni di riprese è stata una vera sfida. Altro
aspetto tecnico: si è fatto tutto con un solo tipo di illuminazione, sfidando qualunque
principio e norma dell’illuminazione per la macchina da presa. Ho trovato un
operatore che ha accettato di illuminare in modo da dare l’impressione di luci diverse,
senza che in realtà ci fosse alcun cambio di illuminazione, e ho trovato un fonico
disposto a fare un lavoro di mixage direttamente sul posto. C’erano infatti dei
microfoni dappertutto, ma nessun missaggio alla maniera tradizionale del cinema, in
cui tutto si fa mesi e mesi dopo. È stato un problema per il produttore che avrebbe
voluto delle versioni in altre lingue, ma non si è potuto fare, perché tutto è stato
registrato contemporaneamente: le canzoni, i diversi piani dei dialoghi, i rumori di
fondo, gli effetti sonori. È per questa ragion che si ha un risultato molto più vivo di
quello che si avrebbe se si fosse proceduto secondo la maniera abituale del cinema.
O. Veillon. Nel suo intervento Peter Brook ha parlato del lato nascosto del gesto
esattamente come si parlerebbe del lato nascosto di un segno. Trovo questo molto
interessante. Si ha l’impressione che, nelle sue spiegazioni e nel suo lavoro per il
Marat-Sade, egli abbia fissato in un primo tempo solo la traccia significante del
fenomeno teatrale, la sua manifestazione più immediata, e che in seguito il lavoro di
montaggio, il lavoro propriamente cinematografico sia consistito nel restituire un
significato globale analogo a quello dello spettacolo teatrale, come se ci fosse una
specie di scarto — questo termine è stato usato anche da Peter Brook [...] — fra la
manifestazione significante dello spettacolo teatrale e il risultato significato, che è in
definitiva prodotto dal film. [...] Vorrei dunque domandare a Peter Brook in che modo
renda sul piano cinematografico quel che c’è di nascosto nel gesto, poiché ha detto
che c’è sempre un lato nascosto del gesto in ciò che viene filmato.
P. Brook. Sì, il problema è proprio come colmare questo scarto: nei due film si vede
questo problema e forse in certi momenti sono più vicino a risolverlo che in altri. Quel
che mi colpisce rivedendo questo estratto dopo quindici anni [...] è che perché fosse
vivo, la struttura era fondata su un montaggio nel quale nessuna inquadratura era
casuale: si era cercato di inserire in ogni immagine il massimo di elementi, e di far
venir fuori il significato dalla composizione delle immagini. Ma per me è chiarissimo,
riguardando il film, che ci sono sempre queste due facce – quando si dice gesto, non
so se si dice bene, ma chiamiamolo gesto per ora –, c’è il gesto che si vede e, dietro,
qualche cosa che si può chiamare la sua faccia nascosta. Lo stesso avviene per un
suono, per una smorfia, per un gioco. [...] Durante le prove, si lavora su una scena fra
due persone perché ci sia un inizio, un passaggio, un’evoluzione. Queste lunghe linee
in cui la scena si sviluppa sono ciò che dà allo spettatore l’impressione di partecipare
a qualcosa di vivo. L’effetto di presenza che si ha a teatro, certo è legato in maniera
mistica alla presenza fisica dell’attore, ma di più, molto di più, a questa partecipazione
a qualcosa che si sviluppa nel tempo, non soltanto a uno svolgimento secondo per
secondo (il fascino della televisione, nei rari momenti in cui è sopportabile, è legato a
questo).
[...] Col Marat-Sade mi trovo di fronte a questo problema: perché quelli che l’hanno
visto a teatro, pur riconoscendo nel film quello che avevano visto sulla scena, hanno
preferito il teatro dicendo: «Manca qualcosa»? Ciò che manca, per me è molto chiaro,
è la lunga vita che collegava le piccole linee. [...] Essendo obbligato a prevedere un
montaggio, ho reso la vita in maniera cinematografica, ma ho perduto quel qualcosa
che avveniva in scena, dove si vedeva allo stesso tempo l’uomo col coltello, tutti i
personaggi, dei movimenti e questo finale che si preparava, come una pulsione che
sfociava in un momento di parossismo in cui si rompeva tutto. Questo momento era
incredibilmente forte per noi, sul set. L’abbiamo girato l’ultimo giorno, alle nove di
sera, dovevamo terminare alle sei. L’ultimo giorno, non avevamo finito e allora
abbiamo pranzato, portato parecchie cose da bere in scena e tutti erano pronti a
continuare fino a mezzanotte. Alle nove di sera ho detto: «Facciamo quest’ultima
scena». Abbiamo preso tutti delle macchine da presa, io ne ho presa una, gli assistenti,
tutti ne avevano una, e ho detto agli attori che avevano recitato in questo spettacolo
per due o tre anni – e che recitavano per l’ultima volta – : «Questa volta fate quel che
avete sempre avuto voglia di fare, rompete tutto, date fuoco». È tutto vero, per due ore
è stato un happening per tutti noi: abbiamo ricominciato, è stato una specie di delirio
collettivo. Alla fine, il set era incredibile, pieno di cose che bruciavano, con alcuni
pompieri attoniti che si aggiravano. Nel film (a teatro era diverso), volevo
un’impressione di movimento. Un gran movimento animava il set durante le riprese,
ma neanche in questo modo sono riuscito a renderlo [...].
D. Bablet. Vorrei fare una precisazione, o piuttosto esprimere un’opinione. Peter ha
insistito molto sull’impulso (ha usato questo termine a più riprese nella prima parte
del suo intervento) e io credo che si tratti di un elemento molto importante, un
elemento che spiega certe divisioni nel campo dell’analisi teatrale, certi insuccessi in
alcuni procedimenti, e che spiega anche le difficoltà che si incontrano nel filmare il
teatro. Un’analisi che fa riferimento ai segni (significante-significato) è un’analisi
terribilmente riduttiva del fenomeno teatrale e le analisi semiologiche attuali lo
provano; si riferiscono solo alla superficie delle cose, escludono il vissuto teatrale che
invece si basa sugli impulsi, e sono proprio questi impulsi i più difficili da far passare
quando si filma il teatro, sia che il film sia un’opera cinematografica propriamente
detta, sia che si tratti di un documento di teatro destinato alla ricerca.
P. Brook. Ricevo continuamente articoli o proposte che sono scritti con questa
terminologia e devo dire che, dal punto di vista artigianale, è quasi impossibile
servirsi di analisi così schematiche. Non c’è relazione, non si possono riconoscere
questioni che si fondano esclusivamente su separazioni rigide e teoriche. Esse non
hanno alcun riflesso su quel che avviene nella realtà.
M. Koleva. [...] Nel suo teatro, la parte sonora, le parole del dialogo scambiate dagli
attori, giocano un ruolo molto importante. Quando dico la parte sonora, parlo delle
sfumature, di tutta quella musica sonora che è lo spettacolo. Al cinema, quando vedo
il Marat-Sade, per esempio l’happening finale, non corrisponde a quel che si sarebbe
potuto trovare a teatro. Per lo meno io non lo trovo.
P. Brook. È esattamente di questo che si parlava stamattina. Per esempio, nel Re Lear
ciò che lei vede è una ricerca attorno a questo problema. Se si recitano le scene che
abbiamo appena visto nel contesto realistico del cinema, lo si può fare solo alla
condizione di eliminare tutto il testo. La ragione per cui il Macbeth di Kurosawa è
molto più forte per me di tutti gli altri film da Shakespeare è che non ne ha conservato
nemmeno una battuta. Lavorando in giapponese, ha potuto fare un dialogo che
corrispondesse al ritmo necessario: il ritmo di base era il ritmo delle immagini. Ma
quello che lei dice è assolutamente vero. Tutti i problemi iniziano nel momento in cui
si ha un soggetto con due ritmi. Quando ho cominciato il lavoro per il Re Lear, a un
certo punto avevo deciso di farlo senza il testo, mi rendevo conto che si sarebbe
potuto fare un film molto più giusto, più vero, più forte se si fosse potuti partire dal
tema, dagli elementi. Abbiamo anche lavorato tre mesi con Ted Hugues cercando di
costruire dei dialoghi molto condensati, di concentrare una frase di Shakespeare in tre
parole, di prendere, per esempio, la scena in cui parla con Cordelia quando è fermo
accanto alla nave: si era cercato di trovare ciò che era giusto, ciò che rientrava in un
ritmo cinematografico giusto, ma dopo tre mesi siamo stati costretti ad abbandonare
questo lavoro, impossibile per degli inglesi: un giapponese potrebbe farlo e forse
anche un francese, perché non sarebbero obbligati ad ammettere che il testo di
Shakespeare in inglese è una tale meraviglia che è ridicolo cercare di adattarlo. Ted
Hugues, che è un grande poeta, che ha la più grande ammirazione, il più grande
rispetto per Shakespeare, cercava di trovare una frase molto spoglia e poi ci siamo
vergognati. Quel che lui trovava, e che era molto bello, era comunque ridicolo a
confronto di ciò che stavamo scartando. Allora siamo stati obbligati a rinunciare e a
metterci di fronte a un problema che è, sono d’accordo con lei, quasi insolubile. Tutto
questo lavoro, questo sottrarre gli elementi decorativi, questo passaggio da
un’inquadratura molto ravvicinata a una molto larga, girata in un luogo in cui gli
accessori, i costumi, i dettagli che entrano nel campo sono ridotti al minimo, è in
questa direzione che abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che permettessero ai
due movimenti, quello dell’immagine e quello sonoro, di coesistere. Io credo che
talvolta si trovi una coesistenza possibile, altre volte no. In teoria, se si ha abbastanza
materiale, se l’immagine si rinnova abbastanza, si può, con un montaggio perfetto,
arrivare a questi due ritmi, ma non sono sicuro che questo possa avvenire con un
dramma di Shakespeare, che contiene dei momenti in cui cose di capitale importanza
sono espresse con troppe parole per permettere al ritmo naturale dell’immagine di
svilupparsi. [...]
D. Bablet. Nei due estratti di film che abbiamo visto, Peter Brook ha cercato in tutti i
modi di evadere dalla scena ma questo non impedisce che da un lato ci sia il MaratSade che è filmato a partire dalle realtà sceniche e dal gioco scenico, mentre il King
Lear non è affatto la trasposizione cinematografica o la riproduzione cinematografica
di un Re Lear messo in scena. È un film a sé stante, che utilizza come “sceneggiatura”
fra virgolette — in realtà la cosa è più complessa — lo stesso Shakespeare, cioè non
c’è alcun lavoro che parta dalla recita degli attori sulla scena. Odette Aslan ha detto
che si resta colpiti dalla scomparsa della scenografia, o per così dire dalla riduzione di
tutti gli elementi decorativi e lei ha detto invece che noi avevamo tutti i riferimenti in
testa. Noi pensiamo al suo King Lear sulla scena del Théâtre des Nations. La mia
impressione è molto diversa. Mi sembra che il film del King Lear abbia fatto ricorso
in modo molto maggiore, direi enorme, alla scenografia, attraverso i paesaggi, le
cavalcate, i passaggi da un castello all’altro, quei castelli di cui, personalmente, mi
dispiace un po’ il carattere fittizio, molto accentuato, che Wakhevitch ha dato loro. Ho
l’impressione che il lavoro di spoliazione avvenga piano piano. Alla fine, nella
sequenza che abbiamo visto, è totale, ma prima no. Si effettua solo a poco a poco. Nel
film, l’apporto molto consistente dell’elemento scenografico, che siano gli esterni dei
castelli, le pianure, le lande, o che siano gli interni, con le grandi lampade pesanti, le
costruzioni, ecc..., è qualcosa che mi ha disturbato, che mi è parso falso, in
contraddizione con l’interpretazione degli attori e con l’interpretazione generale, con
la messa in scena nel suo insieme. E sono stato anche disturbato da una scena (forse
perché non sono abbastanza sensibile ai mezzi del cinema), una scena fondamentale:
la scena della tempesta che, se mi ricordo bene, nella versione teatrale era una specie
di percorso a zig-zag su un palcoscenico completamente nudo con solo una specie di
lamiera che vibrava al di sopra della scena. Nel film, al contrario, si ricorre a un sacco
di effetti di pioggia, di figure che scompaiono, di ombre, ecc. Non è che volessi
risentire la stessa cosa del teatro al cinema; ovviamente volevo qualcosa di
cinematografico e non di teatrale. Ma la scena non ha avuto su di me lo stesso effetto.
Diciamo che certi mezzi cinematografici, le scenografie che avrebbero potuto essere
diverse da come erano, mi hanno disturbato invece di supportare l’azione.
P. Brook. La capisco molto bene perché cerco di tornare, come dieci anni fa, al punto
di partenza. Una delle possibilità sarebbe stata quella di girare il film all’interno di
scenografie teatrali, come uno spettacolo di teatro. È la soluzione che ha adottato
Bergman col Flauto magico e credo che forse sia la sola soluzione se non si vuole allo
stesso tempo cambiare il testo. D’altra parte si tratta di una pièce molto lunga. Prima
di tutto mi sono domandato cosa sarebbe successo se avessi preso un set e ci avessi
messo dentro tutti gli oggetti. Avevo anche una proposta per fare Il sogno di una notte
di mezza estate e in quel caso ero assolutamente deciso a fare in questo modo: mettere
in un set gli elementi che avevo sulla scena, cioè quelli teatrali e artificiali e, in questo
caso, la scena della tempesta sarebbe stata fatta nello stesso modo. Ma mi sono reso
conto che così facendo, non avrei avuto lo stesso risultato, perché, per le ragioni di cui
abbiamo appena parlato, a teatro si è liberi, si vedono le cose senza dare loro troppa
importanza. Con le immagini cinematografiche l’immaginazione non funziona nella
stessa maniera. Poi mi sono detto: visivamente è troppo noioso, non si può fare in
questo modo. E poi, il gioco appassionante in questa pièce, come in tutto
Shakespeare, si basa su un naturalismo di transizione. È sempre così a teatro: si cerca
continuamente di passare da una cosa che non è collocata da nessuna parte a un
contesto molto quotidiano. Nel Re Lear per esempio, avviene questo: c’è un Re Lear
col quale siamo in una relazione epica e poi tutto si umanizza nella seconda scena,
quando rientra dalla caccia, domanda da mangiare, e si arriva a qualcosa che deve
essere molto concreto e molto quotidiano. È per questo che mi sembra molto
interessante creare un mondo molto realistico e poi lasciarlo cadere a poco a poco. [...]
A teatro, ben inteso, si può farlo così, in un batter d’occhio. Fin dall’inizio, la prima
scena può essere completamente spoglia da ogni apparenza quotidiana, e un secondo
dopo si può evocare il quotidiano e poi lasciarlo cadere, diversamente da quel accade
al cinema.
Ma io credo che in realtà, quando si cerca di collocare questa pièce nella natura, ci si
scontra col problema che è dietro tutte le riduzioni cinematografiche da Shakespeare
che ho visto [...]: o si elimina una gran parte del testo e non è più il caso perché non è
possibile sostituirne le immagini, oppure lo si conserva e il ritmo è troppo lento,
diventa pesante. La sola eccezione è il film giapponese che ha avuto la possibilità di
raccontare la stessa storia, con alcune immagini parallele, gli stessi personaggi, senza
restare prigioniero della forma imposta dal testo. Personalmente questa esperienza mi
ha convinto che non si può veramente uscire da questo problema se si conserva il
testo integrale. [...]
Keresztessy. Una domanda tecnica. Vorrei sapere quanto tempo è stato dedicato al
découpage o al predécoupage, per esempio per Marat-Sade e in che modo la cosa è
avvenuta, prima di tutto da parte dell’operatore (scelta degli obiettivi, ecc.), poiché
nell’estratto che abbiamo visto, c’è un’inquadratura che utilizza un grandangolo molto
speciale, che non è comune, e che non è stato utilizzato per il resto della sequenza che
abbiamo visto. [...] Seconda questione: la lunghezza delle sequenze, dei piani
sequenza. Era previsto l’uso di diverse macchine da presa, come si fa spesso in
televisione, oppure c’era una macchina principale e altre che giravano attorno come si
gira attorno a un avvenimento di attualità? Vorrei anche chiederle quale è stata la
presenza degli attori durante le riprese del Marat-Sade: sono stati presenti per tutto il
tempo? Oppure hanno seguito il découpage come nel cinema tradizionale, con una
pianificazione delle presenze?
P. Brook. Nel caso del Marat-Sade non c’è stato alcun découpage. La preparazione è
stata del tutto diversa. Ho lavorato con un operatore col quale ho un’ottima relazione
umana, che aveva visto con me diverse volte lo spettacolo, e col quale ho parlato a
lungo, lavorato, discusso degli obiettivi, ma mai di découpage. Una domanda
essenziale, prettamente tecnica e pratica: avrebbe accettato di realizzare
un’illuminazione unica e, a partire da quel momento, non modificare mai il
diaframma, non tirare mai fuori il fotometro, non spostare mai i riflettori?
Normalmente, anche gli operatori che lavorano in fretta al cinema, a un certo punto
fanno delle correzioni per ottenere un buon risultato, e io volevo invece che si
lavorasse esattamente come per una trasmissione televisiva, in cui non cambia niente,
ma tutto questo con i mezzi del cinema. L’operatore ha accettato, ha lavorato diversi
giorni per fare un’illuminazione permanente, poi abbiamo fatto delle prove. Io non ero
del tutto felice del risultato perché aveva preso una strada molto facile, quella più
sicura. Aveva messo la stessa luce dappertutto; non c’era niente d’interessante, di
vivo, perché non rischiava. Abbiamo discusso a lungo su questo, lui ha rifatto
un’illuminazione in cui prendeva dei rischi, in cui rifiutava di decidere in anticipo da
dove si sarebbe effettuata la ripresa, bisognava che tutto fosse come nella natura,
come all’aperto, che qualunque posto andasse bene, a qualunque altezza, cosa che ci
avrebbe permesso di servirci dei diversi obiettivi come di una gamma che avevamo
sempre fra le dita. [...] Il primo giorno delle riprese, il direttore della fotografia, cioè
colui che al cinema è responsabile soprattutto delle luci, non aveva niente da fare. Ma
era previsto, e questo gli ha permesso di prendere una seconda macchina da presa, e
abbiamo girato in un modo molto particolare e molto interessante. [...] Tutto era
improvvisato sul posto, si faceva il découpage man mano che l’azione procedeva. Si
facevano sequenze lunghe, si passava immediatamente a dividere in piccole sequenze,
ci ponevamo domande sugli obiettivi e ci rispondevamo, era una cosa del tutto
empirica che veniva decisa in base all’impressione che si voleva cogliere al momento,
e tutto questo avveniva molto rapidamente. Gli attori erano sempre presenti e le
riprese non si sono fermate un secondo, si svolgevano assolutamente senza posa,
continuamente. [...]
Siamo arrivati al montaggio con una gran quantità di materiale. Circa il quaranta per
cento apparentemente era girato in modo casuale, ma non era frutto veramente del
caso. Le due camere avevano cercato di cogliere un tipo di materiale che fosse
conforme alla stessa intenzione di fondo. È capitato molto raramente, come in
quest’ultima sequenza, di lavorare con tre macchine, in uno spirito abbastanza lontano
da quello televisivo. In televisione è molto diverso, si cerca di stabilire dei legami
diretti fra un punto centrale e gli operatori, i quali però non sono mai impegnati in
questo modo nella preparazione. Raramente hanno la libertà di fare delle proposte.
[...] Ho constatato che i rapporti umani sono più importanti di quelli elettronici:
quando si lavora con più camere, in televisione, per esempio con quattro, si vede
spesso che se un solo regista cerca di collegarsi a quattro punti di vista, ciascuno di
essi è diluito. È un vero problema. Molto spesso si può lavorare in modo più rapido,
più intenso, in relazione con una sola persona, pur assumendo la responsabilità di
spostare molto rapidamente tutta la troupe se si vogliono trovare altri punti di vista,
piuttosto che se si utilizza la struttura apparentemente molto pratica e logica della
televisione: una persona in mezzo che cerca di collegarsi a diverse altre. In questo
caso la relazione è molto più evanescente, meno personale, e, credo, meno intensa,
l’inquadratura diventa meno coinvolgente.
O. Veillon. Lei ha introdotto un elemento molto importante parlando di queste due
camere che durante le riprese hanno punti di vista indipendenti, i quali permettono di
produrre un materiale filmato che è possibile montare in seguito avendo degli
elementi che interagiscono insieme secondo due punti di vista che non sono
determinati dalla stessa concezione. E questo permette di costruire e dialettizzare una
interpretazione dello spettacolo teatrale, di andare un po’ più avanti e di uscire dalla
falsa contrapposizione punto di vista soggettivo / punto di vista oggettivo [...]
P. Brook. Avevo già provato qualcosa del genere, in un lavoro che non ha niente a che
fare col teatro, nel film Il signore delle mosche, nel quale abbiamo lavorato sempre in
questo modo. C’era una seconda camera, che però non era seconda gerarchicamente,
perché colui che ci stava dietro era un grande amico, un collaboratore che aveva
partecipato a tutta la preparazione. È stato un film duro, a tutti i livelli (finanziamento,
preparazione, ecc.). Al momento delle riprese l’operatore era completamente libero, il
suo materiale rappresentava un altro punto di vista, e allo stesso tempo questo punto
di vista non era gratuito perché lui perseguiva lo stesso scopo.
L. De Guyencourt. [...] Volevo chiedere qualcosa a Peter Brook a proposito di queste
due camere. Quando dice che non c’era gerarchia fra queste due camere, cosa succede
sul piano della simultaneità? Le due macchine riprendevano contemporaneamente,
quindi una delle due doveva avere la priorità sull’altra riguardo a ciò che sceglievano.
Una delle due doveva per forza fare attenzione, evitare di dare disturbo all’altra,
doveva avere quindi la priorità dello sguardo, anche se l’altra non era semplicemente
un accessorio della prima o il suo complemento.
P. Brook. Certamente. Le due macchine non si trovavano in una relazione identica.
Per le riprese c’era la macchina principale che era quella del regista-operatore, la
nostra, che riprendeva le grandi sequenze, le grandi carrellate e i grandi movimenti
durante i quali si girava a volte tutto attorno all’azione perché era la macchina che
raccontava, che aveva la responsabilità di raccontare la storia. L’altra macchina aveva
tutte le libertà, salvo quella di entrare nel campo della prima. Questo è evidente. Ma in
realtà tutto questo è teorico, perché nel lavoro sul set, se un operatore è veloce e
scattante, ci sono mille modi di lavorare, e a volte capitava che mi domandasse : «Non
potrei mettermi là? Vorrei riprendere questo o quest’altro». Certamente, è così che si
lavora. Certo è indispensabile che ci sia rispetto reciproco fra le due macchine.
L. De Guyencourt. In pratica questo richiede un utilizzo enorme di pellicola?
P. Brook. Sì. È un principio al quale tengo molto. Al cinema ho sempre visto questo
lavorando in film con pochi mezzi, con piccoli budget, ma talvolta anche con grandi
budget. Nello spirito di tutti coloro che sono responsabili della produzione, ogni
spreco è permesso tranne lo spreco di pellicola. È insensato. [...] Al cinema si deve
accettare la pellicola, pur sapendo che quando si arriverà al montaggio questo
rappresenterà un problema. Trovo sorprendente quel che fa Jancso che riesce a girare
dei film nei quali, alla fine, il montaggio dura dieci minuti. Ma non credo che sia una
tecnica che tutti possono usare. [...]