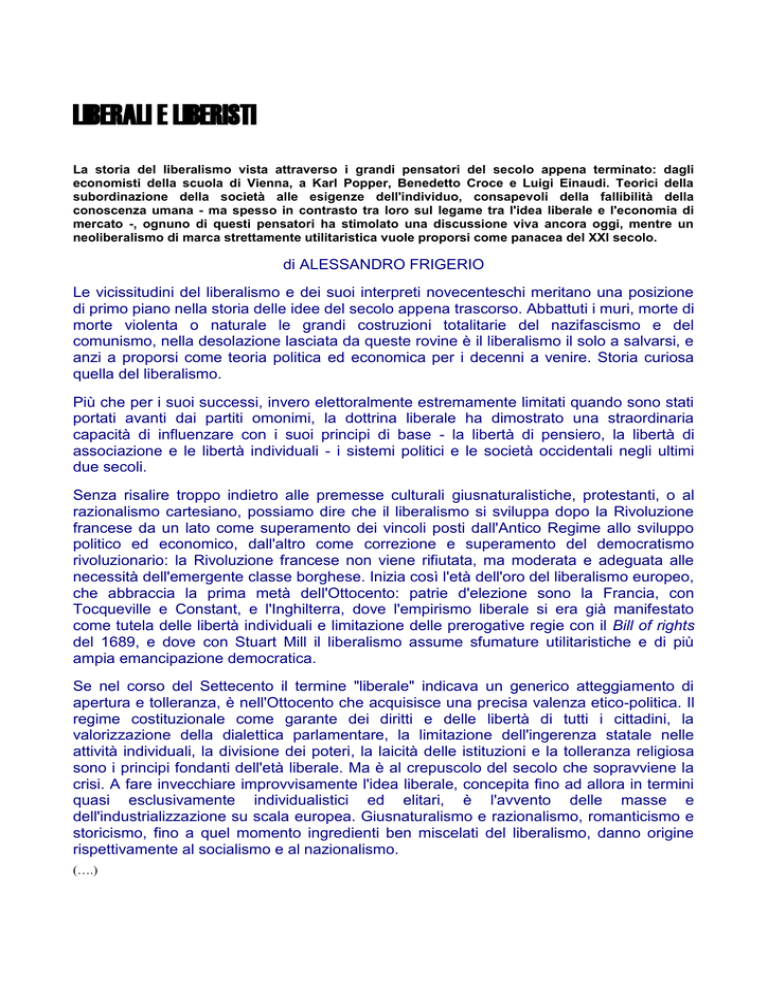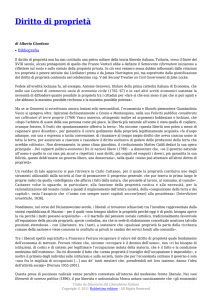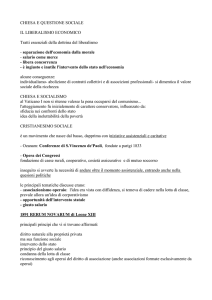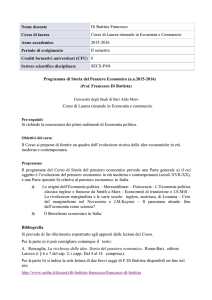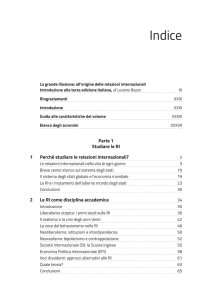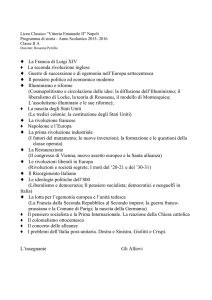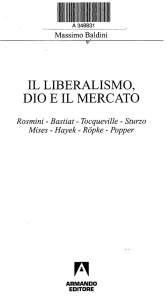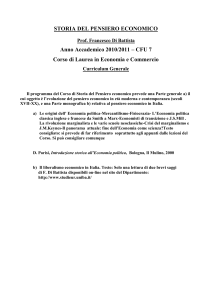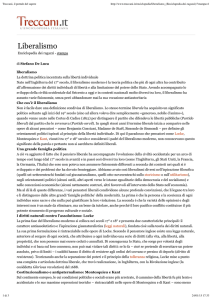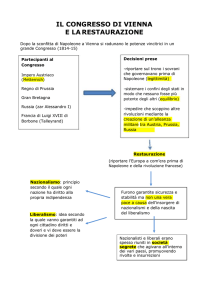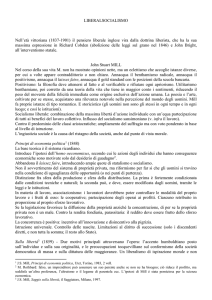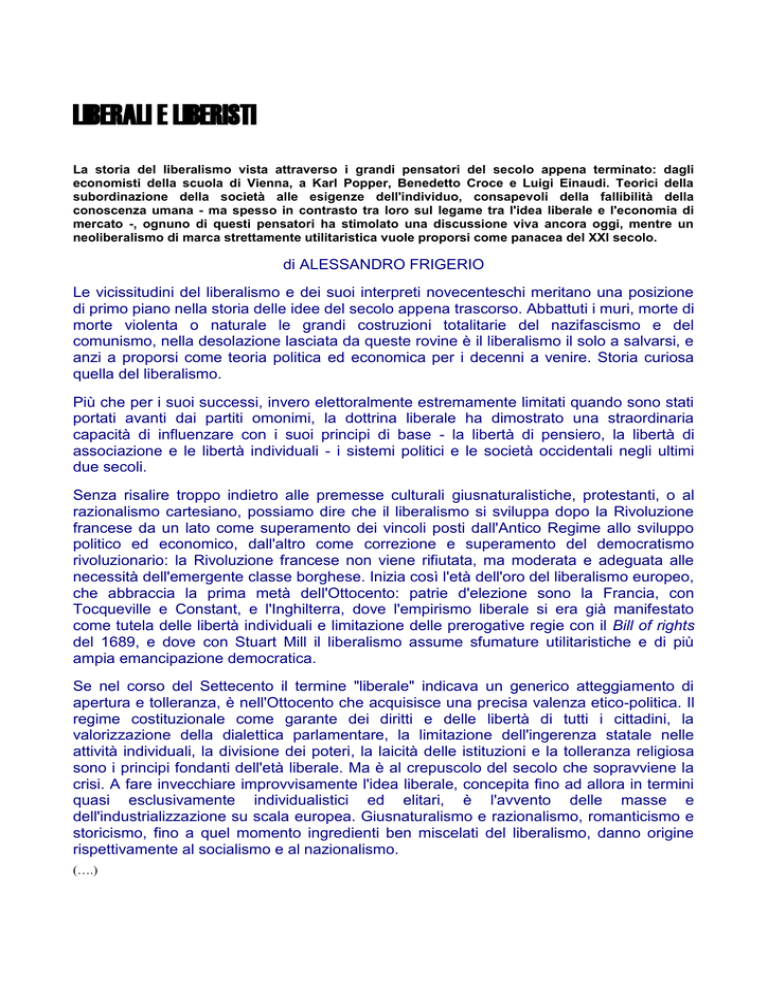
LIBERALI E LIBERISTI
La storia del liberalismo vista attraverso i grandi pensatori del secolo appena terminato: dagli
economisti della scuola di Vienna, a Karl Popper, Benedetto Croce e Luigi Einaudi. Teorici della
subordinazione della società alle esigenze dell'individuo, consapevoli della fallibilità della
conoscenza umana - ma spesso in contrasto tra loro sul legame tra l'idea liberale e l'economia di
mercato -, ognuno di questi pensatori ha stimolato una discussione viva ancora oggi, mentre un
neoliberalismo di marca strettamente utilitaristica vuole proporsi come panacea del XXI secolo.
di ALESSANDRO FRIGERIO
Le vicissitudini del liberalismo e dei suoi interpreti novecenteschi meritano una posizione
di primo piano nella storia delle idee del secolo appena trascorso. Abbattuti i muri, morte di
morte violenta o naturale le grandi costruzioni totalitarie del nazifascismo e del
comunismo, nella desolazione lasciata da queste rovine è il liberalismo il solo a salvarsi, e
anzi a proporsi come teoria politica ed economica per i decenni a venire. Storia curiosa
quella del liberalismo.
Più che per i suoi successi, invero elettoralmente estremamente limitati quando sono stati
portati avanti dai partiti omonimi, la dottrina liberale ha dimostrato una straordinaria
capacità di influenzare con i suoi principi di base - la libertà di pensiero, la libertà di
associazione e le libertà individuali - i sistemi politici e le società occidentali negli ultimi
due secoli.
Senza risalire troppo indietro alle premesse culturali giusnaturalistiche, protestanti, o al
razionalismo cartesiano, possiamo dire che il liberalismo si sviluppa dopo la Rivoluzione
francese da un lato come superamento dei vincoli posti dall'Antico Regime allo sviluppo
politico ed economico, dall'altro come correzione e superamento del democratismo
rivoluzionario: la Rivoluzione francese non viene rifiutata, ma moderata e adeguata alle
necessità dell'emergente classe borghese. Inizia così l'età dell'oro del liberalismo europeo,
che abbraccia la prima metà dell'Ottocento: patrie d'elezione sono la Francia, con
Tocqueville e Constant, e l'Inghilterra, dove l'empirismo liberale si era già manifestato
come tutela delle libertà individuali e limitazione delle prerogative regie con il Bill of rights
del 1689, e dove con Stuart Mill il liberalismo assume sfumature utilitaristiche e di più
ampia emancipazione democratica.
Se nel corso del Settecento il termine "liberale" indicava un generico atteggiamento di
apertura e tolleranza, è nell'Ottocento che acquisisce una precisa valenza etico-politica. Il
regime costituzionale come garante dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini, la
valorizzazione della dialettica parlamentare, la limitazione dell'ingerenza statale nelle
attività individuali, la divisione dei poteri, la laicità delle istituzioni e la tolleranza religiosa
sono i principi fondanti dell'età liberale. Ma è al crepuscolo del secolo che sopravviene la
crisi. A fare invecchiare improvvisamente l'idea liberale, concepita fino ad allora in termini
quasi esclusivamente individualistici ed elitari, è l'avvento delle masse e
dell'industrializzazione su scala europea. Giusnaturalismo e razionalismo, romanticismo e
storicismo, fino a quel momento ingredienti ben miscelati del liberalismo, danno origine
rispettivamente al socialismo e al nazionalismo.
(….)
Il dubbio metodico, di schietta ispirazione cartesiana, che caratterizza il pensiero liberale
viene teorizzato al meglio da KARL POPPER. Epistemologo, filosofo, intellettuale a 360°,
Popper figura tra i maggiori pensatori del secolo appena trascorso (e anche lui è tra i più
tardivamente scoperti: basti pensare che le sue opere principali furono tradotte prima
in turco che in italiano). La consapevolezza dell'impossibilità di conoscere nella sua
interezza anche il più piccolo pezzo di mondo caratterizza la sua visione del sapere
umano. Oltre che parziale, ogni nostra conoscenza è e resta sempre smentibile,
congiunturale.
La fallibilità della conoscenza umana è per lui un tratto antropologico: E la consapevolezza
di questa fallibilità, dell'"incertezza" della ragione, è il primo presupposto della democrazia.
Solo plasmando le nostre istituzioni, le nostre culture e noi stessi sulla base di questi
principi - ha scritto - si potrà sviluppare la "società aperta", cioè una società basata sulla
centralità dell'individuo, sull'apertura mentale e sul confronto con gli altri (confronto inteso
non come scontro ma come arricchimento reciproco).
Popper ha applicato le sue teorie agli ambiti più disparati, primo fra tutti quello politico.
L'uomo è un animale ideologico, spesso preda di dottrine distruttive (nazifascismo,
comunismo) o più semplicemente stupide e vane: tra queste, afferma, ci sono il
socialismo, una dottrina inconciliabile con la libertà perché generatrice di burocrazia, e
l'ecologismo, che è incapace di vedere nella tecnologia lo strumento in grado di risolvere i
problemi creati dalla tecnologia stessa.
Filosofo atipico, Popper - e anche qui sta la sua grandezza - non ha mai esitato a
confrontarsi anche con i grandi temi del giorno: la sua coraggiosa condanna dei movimenti
pacifisti, l'appello per l'intervento militare nella crisi balcanica e la denuncia del potere
televisivo ("… tutti quelli che invocano la libertà, l'indipendenza o il liberalismo per
dire che non si possono introdurre delle limitazioni in un potere pericoloso come
quello della televisione, sono degli idioti"), rappresentano alcuni dei lasciti di un filosofo
liberale del Novecento impegnato a confrontarsi esclusivamente con la ragione.
Fin qui gli interpreti internazionali del liberalismo. Ma anche l'Italia ha dato un importante contributo
nella prima metà del Novecento. Le vicissitudini del liberalismo nostrano sono interpretate al meglio
da BENEDETTO CROCE(1866-1952) e LUIGI EINAUDI (1874-1961).
Il primo, filosofo idealista più interessato alle speculazioni che alla ricerca empirica, si
impegnò tra gli anni Venti e Quaranta nella difesa della concezione liberale dagli attacchi
delle dottrine totalitarie. Per Croce la concezione liberale è una concezione "metapolitica",
che "supera la teoria formale della politica e, in certo senso, anche quella formale
dell'etica, e coincide con la concezione formale del mondo e della realtà. […] in essa si
rispecchia tutta la filosofia e la religione dell'età moderna, incentrata nell'idea della
dialettica ossia dello svolgimento, che, mercé la diversità e l'opposizione delle forze
spirituali, accresce e nobilita di continuo la vita e le conferisce il suo unico e intero
significato. Su questo fondamento teoretico nasce la disposizione pratica liberale di fiducia
e favore verso la varietà delle tendenze, alle quali si vuole piuttosto offrire un campo
aperto perché gareggino e si provino tra loro e cooperino in concorde discordia, che non
porre limiti e freni, e sottoporle a restringimenti e compressioni".
Liberalismo, quindi, come "partito della cultura" in grado di assorbire al suo interno,
secondo le necessità politiche contingenti in cui si trova a vivere lo Stato, il socialismo e
l'autoritarismo. La parziale disponibilità di Croce verso il fascismo nei primissimi anni della
dittatura mussoliniana si spiega appunto con questa visione tollerante e, per certi versi,
utilitaristica. Solo dopo la guerra Croce affermerà con forza l'importanza dei valori della
democrazia. Scrive infatti nel 1946 che "non bisogna dimenticare che il liberalismo
disgiunto dalla democrazia inclina sensibilmente verso il conservatorismo, e che la
democrazia, smarrendo la severità dell'idea liberale, trapassa nella demagogia e, di
là, nella dittatura". In breve, la democrazia, e così pure il socialismo, sono tecniche di
governo (sovranità popolare esercitata attraverso il principio della rappresentanza,
ampliamento degli organi rappresentativi, suffragio universale) come le altre, messe però
a disposizione della suprema idea filosofica liberale.
Ed è proprio su questa concezione che il pensiero di Croce viene a scontrarsi con quello di
un altro grande liberale, l'economista (e primo Presidente della Repubblica) Luigi Einaudi.
Nella sua opera di studioso e in quella di governo - i suoi scritti (Prediche inutili, Il
buongoverno) ci hanno lasciato uno spaccato di come il liberalismo debba applicarsi a
problemi contingenti come le leggi tributarie, la burocrazia, gli scioperi, la scuola, l'unità
europea, la disoccupazione, la libertà di stampa - Einaudi ha fissa davanti a sé la
superiorità dell'economia di mercato e le esigenze di libertà dell'uomo dai vincoli imposti
dallo stato.
"Quel che l'uomo libero non vuole è di essere preso per il naso da taluni uomini, i quali,
per via di elezioni od in altre maniere sono padroni della macchina statale e perciò da sé si
definiscono 'lo stato', e di vedersi insegnare da costoro, i quali certamente, in quello
specifico punto, ne sanno meno di lui, in qual modo egli deve gestire la sua impresa,
seminare i suoi campi, vendere a tale prezzo, associarsi con Caio e Sempronio per
produrre meglio, comprare gli strumenti, le macchine, le sementi di cui ha bisogno in
paese o, se gli converrebbe comprar fuori, acquistare tanto e non più, a prezzo cresciuto
di tanto ecc. ecc." La linea di distinzione, continua, deve porsi non fra chi vuole e chi non
vuole l'intervento dello stato nelle cose economiche, ma tra chi vuole un certo tipo di
intervento e chi ne vuole un altro.
Un tale empirismo non poteva stare bene a Croce, che fu sempre allergico a tutti problemi
di tecnica politico-sociale. Se liberalismo e liberismo economico in parte hanno percorso
strade comuni, dice Croce, ciò non significa che quest'ultimo debba assumere "valore di
regola o legge suprema della vita sociale". Il rischio sarebbe quello di confondere la libertà
con un semplice dato economico, quindi con un dato esclusivamente materialistico. Croce,
al contrario di Einaudi - che in un eccesso di furore polemico arrivò a rinfacciare al filosofo
la disponibilità a tollerare un assetto comunistico purché questo scaturisse da una scelta
etica liberale -, riteneva quindi che la libertà potesse svilupparsi anche con un ordinamento
economico diverso da quello capitalistico.
In fondo, ciò che divideva i due studiosi era la persistente lacerazione tra filosofi ed
economisti liberali.
Da un lato Croce, John Dewey, Ortega y Gasset e Karl Popper, critici nei confronti di un
vincolo troppo stretto tra il liberalismo e l'economia liberista, e dall'altro Einaudi, Hayek, e
Mises convinti dell'indissolubilità dei questo legame. A onore dei "filosofi" occorre però
aggiungere che il loro atteggiamento scaturiva non tanto dal disprezzo verso la politica
pratica quanto dal rifiuto di ogni architettura sociale che pretendesse di rigenerare o di
ricostruire il mondo.
E il capitalismo, o l'economia di mercato, presi come assoluto rischiavano - secondo la
loro interpretazione - di trasformarsi proprio in una rigida architettura della convivenza
civile.
Nell'ultimo scorcio del Novecento il liberalismo, dopo le spinte totalitarie e stataliste
imposte dal predominio delle ideologie del secolo breve, con la morte del comunismo ha
finalmente richiamato l'attenzione su un nuovo liberalismo, forse meno vicino ai grandi
principi ma certamente più pragmatico e alla conquista di nuovi spazi di libertà nella
società postindustriale. Fra gli esponenti più interessanti del pragmatismo neoliberale ci
sono due americani, J. M. Buchanan e G. Tullock, Nobel per l'economia nell'86 il primo,
docente di economia e scienza politica il secondo.
Partendo dall'individualismo metodologico di Hayek i due studiosi hanno dimostrato come,
agendo per il proprio interesse privato, l'individuo contribuisca anche a regolare meglio la
società intera. Preludio fondamentale è la condanna di ogni criminalizzazione dell'utile
individuale. Buchanan e Tullock affermano che il perseguimento dell'interesse personale,
appena tollerato nella sfera privata, nella sfera politica "è stato quasi sempre condannato
come un male dai filosofi morali di diversa tendenza".
Comportamento accettabile per sbarcare il lunario, l'individualismo non lo si è mai ritenuto
capace di funzionare nel sociale, come se le azioni umane dovessero imporsi da sé uno
sdoppiamento di personalità.
È vero invece - continuano - che il criterio dell'utile individuale, fatto valere anche quando
si compiono scelte politiche importanti, come le regole costituzionali, si rivela assai più
fecondo nei risultati degli atteggiamenti ispirati a una generica ricerca dell'utilità pubblica.
Ad un patto, naturalmente: che il "contratto sociale" non si risolva nella vittoria di una
maggioranza sulla minoranza ma riesca invece a conciliare un mutuo vantaggio per tutti.
Buchanan e Tullock lo hanno spiegato con dovizia di particolari in numerosi saggi,
applicando alla categoria della teoria politica - e qui sta la loro intuizione -, le categorie
finora ritenute impure del ragionamento economico.
Certo è però che la società americana è un conto, quella europea un altro. E non sempre
le teorie nate negli Stati Uniti hanno trovato una uguale applicazione sul Vecchio
Continente. Il culto dell'interesse personale ha fatto storcere il naso - e continua a farlo - a
molti sostenitori dell'interpretazione organica della società e agli irremovibili della
democrazia idealista.
Per il filosofo francese MICHEL FOUCAULT contrariamente a Popper e Croce,
liberalismo e liberismo sono sempre andati a braccetto. Il liberalismo delle origini,
sostiene Foucault, ha trovato nel mercato un elemento fondamentale per limitare
l'ingerenza del governo negli affari privati.
Tuttavia, di fronte alle minacce alla libertà portate avanti dal comunismo e dal
nazifascismo nel XX secolo, il liberalismo è stato costretto a promuovere meccanismi di
intervento, come il welfare state.
Meccanismi di intervento sociale che tuttavia ora, aggiunge, vengono dichiarati illiberali dal
neoliberalismo. Ancora più critico nei confronti del nuovo liberalismo è il filosofo italiano
MASSIMO CACCIARI. Nella sua ultima versione il liberalismo tende infatti a confondersi
troppo con l'anarchismo. Secondo Cacciari l'attuale desiderio di affermazione del
singolo non è altro che una volontà di separarsi dal corpo sociale, il rifiuto di ogni
potestà e di ogni tipo di autorità. Naturalmente l'autorità imposta dallo stato è
invece bellamente tollerata, anzi apprezzata, quando torna a vantaggio del proprio
interesse individuale.
L'uomo del tardo liberalismo è per Cacciari un soggetto senza legge, anarchico, che
tuttavia è pronto a reclamare l'ordine e la legge non appena i suoi interessi vengono messi
in discussione. Quale futuro si prospetta quindi al liberalismo? Riuscirà a capitalizzare al
meglio la vittoria sul dispotismo? E se avesse ancora una volta ragione il buon vecchio
Tocqueville, quando ammoniva che una società individualista e frammentata è destinata
a soccombere di fronte al totalitarismo rispetto a una società unita e pluralista, basata su
associazioni e comunità di uomini? Ora che il liberalismo sembra non avere più
avversari, forse, il suo più acerrimo nemico lo potrà trovare solo dentro di sé.
LUIGI EINAUDI
di GIAN LUIGI FALABRINO
Oggi, tutti o quasi tutti si dicono liberali. Berlusconi (i suoi avvocati, gli attori e presentatori
delle sue reti televisive, diventati ministri e autorità) e i politici dell'opposta parte politica,
parlano sempre di liberalismo e liberismo, senza sapere di che si tratta e contraddicendoli nei
fatti.
Il monopolista delle televisioni e della pubblicità si fa paladino della libertà d'impresa dei
cosiddetti quattro milioni di liberi imprenditori, e li vuole difendere da un comunismo che è
fallito dovunque e che in Italia è circoscritto all'ideologia dei sopravvissuti di Rifondazione.
Quanto al liberalismo, ne dà prove ormai quotidiane, sia cercando di metter fine alle inchieste di
Mani pulite, che da anni lo minacciano molto da vicino, sia attaccando duramente un uomo come
Bobbio che aveva accusato Forza Italia di avere dietro o davanti forze fasciste: brutto segno che
conferma proprio la diagnosi bobbiana del fascismo psicologico e politico che si annida in chi
non tollera critiche e confonde il governare col "comandare".
Bisogna tornare a scuola di liberalismo e di liberismo: non c'è maestro migliore di chi viene
citato oggi troppe volte a sproposito, Luigi Einaudi.
Riprendendo una sua vecchia polemica con Croce, e condannando ogni forma di comunismo, nel
1948 Einaudi scriveva sul "Corriere della Sera" un elogio della "libertà dell'uomo comune"
accettando la tesi che la libertà politica debba essere accompagnata dalla libertà economica: "A
che serve la libertà politica a chi dipende da altri per soddisfare i bisogni elementari della vita?
Fa d'uopo dare all'uomo la sicurezza della vita materiale, dargli la libertà dal bisogno, perché egli
sia veramente libero nella vita civile e politica... La libertà economica è la condizione necessaria
della libertà politica... Vi sono due estremi nei quali sembra difficile concepire l'esercizio
effettivo, pratico, della libertà: all'un estremo tutta la ricchezza essendo posseduta da un solo
colossale monopolista privato; ed all'altro estremo dalla collettività. I due estremi si chiamano
comunemente monopolismo e collettivismo: ed ambedue sono fatali alla libertà".
Queste tesi erano l'enunciazione sintetica e giornalistica dei principi che Einaudi aveva dibattuto
con Croce nella lunga discussione che era cominciata in pieno fascismo, nel 1928 e che era
continuata fino al 1949. Era stato un dialogo tra sordi: Croce disprezzava i "sacri principi
dell'89" e credeva nella libertà dello Spirito, che sopravvive anche nelle galere e sul patibolo: il
sistema politico ed economico più opprimente non può impedire all'uomo di pensare, non può
impedire la libertà del suo pensiero. In qualunque condizione si sia e in qualunque azione si
faccia, la decisione e la responsabilità sono soltanto nostre: coacti, tamen volunt. Così, l'uomo è
libero anche davanti al tiranno che lo pone di fronte al dilemma: o ti sottometti, e salvi la vita a
tuo figlio, o ti ribelli e io l'uccido. Sì, la scelta, anche questa scelta, è possibile, ma non è questa
la condizione che la libertà invoca per sé stessa e per l'opera di civiltà, di umanamento che essa è
chiamata a compiere.
Il problema delle condizioni della libertà era invece ben presente a Einaudi, estraneo
all'idealismo filosofico ed erede della tradizione liberale personalistica: la scelta coatta era sentita
da lui come offesa alla dignità dell'uomo, come sottomissione della libertà all'arbitrio e
all'immoralità.
E' curioso che per tutti gli anni della discussione tra Croce ed Einaudi, nessuno dei due accennò
mai ai differenti presupposti liberali cui essi si riferivano: la libertà dello Spirito, la libertà
dell'individuo. In una cosa però concordavano.
Nel 1928, su "La Riforma Sociale", Einaudi accettava la tesi di Croce, secondo il quale il
liberismo è un concetto inferiore e subordinato a quello più ampio di liberalismo: il primo
"Fu la traduzione empirica, applicata ai problemi concreti economici, di una concezione
più vasta ed etica, che è quella del liberalismo".
Lo stabilire la graduatoria dei fini della vita sociale non è compito dell'economista: "Croce ha
su questo punto parole scultorie. Chi deve decidere non può accettare che beni siano
soltanto quelli che soddisfano il libito individuale, e ricchezza solo l'accumulamento dei
mezzi a tal fine; e, più esattamente, non può accettare addirittura, che questi siano beni e
ricchezza, se tutti non si pieghino a strumenti di elevazione umana".
Da Adamo Smith a Marshall questa è sempre stata "la premessa e il fine delle fatiche degli
economisti, non mai il procacciamento dei beni materiali".
Ancora su "La riforma sociale", nel 1931 Einaudi chiarì meglio il suo pensiero, "osservando
essere compito della scienza economica unicamente la ricerca della soluzione
economicamente più conveniente per raggiungere un dato fine. Ma il fatto non è posto dagli
economisti e spesso non è un fine economico, ma politico morale religioso; ma la soluzione
più conveniente non è sempre quella liberistica del lasciar fare e del lasciar passare,
potendo invece essere, caso per caso, di sorveglianza o diretto esercizio statale o comunale o
altro ancora... Di fronte ai problemi concreti, l'economista non può essere mai né liberista
né interventista, né socialista ad ogni costo".
Aggiungeva poi Einaudi che, dalla frequenza dei casi nei quali gli economisti raccomandavano
soluzioni liberiste, è sorto un significato "religioso" della massima liberistica. "Liberisti
sarebbero in questa accezione coloro i quali accolgono la massima del lasciar fare e del
lasciar passare quasi fosse un principio universale. Secondo costoro, l'azione libera
dell'individuo coinciderebbe sempre con l'interesse collettivo". Ma lo stesso Adamo Smith,
maestro di questa "religiosità", si è contraddetto troppe volte, fino a elencare "le ragioni di
intervento dello stato per la consecuzione di fini preclusi all'azione individuale od a questo
contrastanti", e spesso ha insistito sull'opposizione fra classi e classi, fra i singoli e la
collettività.
Molti anni dopo, su "Argomenti" del dicembre 1941, in un saggio su "Liberismo e comunismo",
Einaudi insisteva sul fatto che il liberismo non è il lasciar fare, ma è l'intervento dello stato che
fissa i limiti entro i quali il privato può muoversi, cioè i limiti delle forze che potrebbero
ostacolare la libera concorrenza, e precisava: "L'intervento dello stato limitato a rimuovere
quegli ostacoli che impediscono il funzionamento della libera concorrenza non è perciò
tanto limitato come pare. Esso si distingue in due grandi specie: rivolta la prima a
rimuovere gli ostacoli creati dallo stato medesimo, e l'altra intesa a porre limiti a quelle
forze, chiamiamole naturali, le quali per virtù propria ostacolerebbero l'operare pieno
della libera concorrenza".
In questo secondo caso, la differenza tra l'interventista (o comunista) e il liberista "non sta nella
'quantità' dell'intervento, bensì nel 'tipo' di esso... Il legislatore liberista dice invece: io non
ti dirò affatto, o uomo, quel che devi fare; ma fisserò i limiti entro i quali potrai a tuo
rischio muoverti".
Il regime liberistico appare dunque non come l'assenza di leggi e regole, ma come un sistema di
leggi, fatte osservare da magistrati indipendenti dal governo, per permettere agli uomini e alle
imprese di lavorare nel rispetto degli altri: "essi debbono educarsi da sé e rendersi
moralmente capaci di prendere decisioni sotto la propria responsabilità".
Einaudi sapeva benissimo che liberismo e liberalismo non sempre coincidono. Può accadere,
scriveva, che il liberale sia anche liberista, come Cavour tra il 1850 e il 1860; ma può
accadere che il liberismo doganale di Chevalier coincida con la dittatura monarchica di
Napoleone III.
Tuttavia non era mai accaduto che un paravento liberista venisse usato prima per puntellare un
monopolio traballante, poi per rinforzarlo, evirando il concorrente pubblico, in una confusione
tra interessi privati e potere politico che sarebbe impensabile in qualunque altro paese europeo e
dell'America settentrionale, e che Einaudi non avrebbe potuto neppure immaginare.
Il capitalismo del XX secolo
Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, in conseguenza della "grande depressione"
(1873-1896), il capitalismo monopolistico si era tuttavia affermato nella gran parte dei
paesi industrializzati, determinando una vasta riorganizzazione dei settori produttivi,
nonché della stessa società. Nello stesso periodo i paesi capitalistici operarono per
difendere le proprie industrie innalzando barriere doganali e conquistare nuovi mercati per
le proprie merci, attuando un rilancio di politiche colonialiste e imperialiste che furono alla
base dello scoppio della prima guerra mondiale.
Dopo un breve periodo di ripresa economica seguito alla guerra, le democrazie industriali
dell'Europa e del Nord America vennero investite dalla Grande Depressione degli anni
Trenta, il più grave sconvolgimento economico vissuto dal capitalismo moderno.
Raccogliendo la sfida della depressione, i maggiori sistemi capitalisti dimostrarono
tuttavia spiccate capacità di sopravvivenza e adattamento al cambiamento; i governi
cominciarono allora a intervenire nell'economia per correggere i principali limiti
intrinseci del sistema capitalistico.
Negli Stati Uniti, ad esempio, l'amministrazione del New Deal del presidente Franklin
Delano Roosevelt ristrutturò il sistema finanziario al fine di prevenire il ripetersi di
eccessi speculativi che avevano condotto al crollo di Wall Street nel 1929. Furono
presi provvedimenti per incoraggiare la contrattazione collettiva e costruire un forte
movimento sindacale in grado di controbilanciare il potere dei grandi gruppi
industriali. L'introduzione della previdenza sociale e dell'assicurazione contro la
disoccupazione gettò le basi per la costruzione dello stato sociale.
L'opera di John Maynard Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della
moneta (1936), influenzò profondamente il modo di operare nei paesi capitalisti, dando
origine alla scuola di pensiero conosciuta con il nome di economia keynesiana.
Keynes mostrò che uno stato moderno poteva utilizzare il disavanzo pubblico,
l'imposizione fiscale e l'offerta di moneta in modo da attenuare, se non proprio eliminare, il
vero problema del capitalismo, gli alti e bassi del ciclo economico. Secondo Keynes, in
fase di depressione il governo avrebbe dovuto accrescere la propria spesa, anche a costo
di creare deficit di bilancio, per compensare il calo della spesa privata; avrebbe dovuto
invece seguire una linea opposta qualora l'espansione fosse diventata incontrollabile,
dando luogo a eccessi speculativi e inflazionistici.
Vittoria e crisi del capitalismo
Alla seconda guerra mondiale seguì un trentennio di crescita economica e di tendenziale
piena occupazione dei paesi capitalistici, ma anche di grossi conflitti sociali e di un'estesa
critica al modo di produzione e alla "civiltà capitalistica".
Negli anni Settanta e Ottanta, al riaffacciarsi di una grave e generale
crisi economica, i governi conservatori di Stati Uniti e Gran Bretagna
lanciarono un forte attacco alle politiche economiche keynesiane
adottate fino ad allora, nell'intento di dare vita a un sistema economico
radicalmente alternativo, di ridare slancio all'iniziativa privata (per
esempio riducendo il carico fiscale delle imprese) e di ridurre il ruolo
dello stato (privatizzazioni, taglio generalizzato della spesa dello stato in
favore della sanità, della scuola, dell'occupazione ecc.).
La terapia liberista, benché di breve durata, provocò un'autentica rivoluzione, non solo
economica, ma nei costumi e nella cultura della gran parte dei paesi industriali, e se da un
lato favorì la ripresa economica e in alcuni casi l'occupazione (sebbene in molti casi
precaria e priva di tutele), provocò anche il netto peggioramento delle condizioni di vita
delle classi sociali deboli e marginali. Agli inizi degli anni Novanta, nello stesso momento
in cui il sistema democratico e capitalista occidentale vinceva la sua lunga e aspra
battaglia contro il blocco comunista, i governi artefici della "rivoluzione liberista" venivano
sconfitti.
Il dibattito sul capitalismo è destinato a continuare, anche perché il sistema capitalistico si
è negli ultimi anni profondamente trasformato e continua a trasformare il panorama
mondiale nel quale agisce.