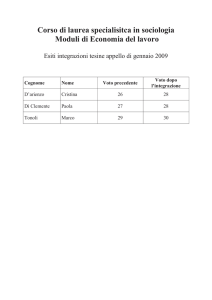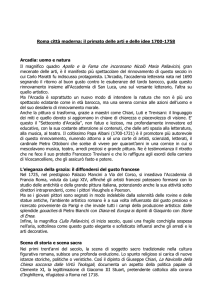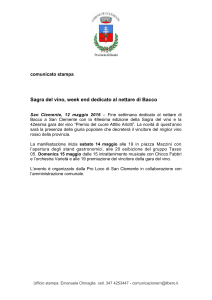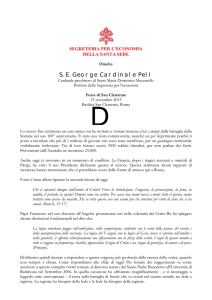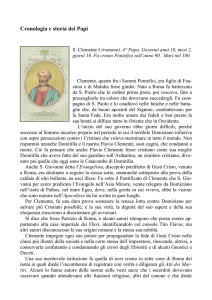FRANCESCO CLEMENTE: FRONTIERA DI IMMAGINI
Achille Bonito Oliva
In un mio testo del 1981 scrivevo che il tesoro dell’arte vive il doppio paradosso della profondità e
della superficie. Da una parte, perché arte esista, è necessario un verticale sprofondamento dentro
la sostanza dell’immaginario: un deposito della memoria individuale e collettiva senza il quale non
c’è immagine, dal momento che all’Arte non è consentita la danza sul vuoto. Dall’altra, affinché
quel tesoro approdi in superficie e giunga al livello degli occhi meravigliati del mondo, è necessario
il suo affioramento alla luce della forma. Infatti, non esiste tesoro senza esercizio di ricchezza, nel
caso dell’arte senza esibizione e possesso. Perciò l’artista vive la doppia condizione dello ctonio e
dell’aereo: attraverso il primo abita sapientemente dentro profondità in cui lo sguardo non può
arrivare, con l’agio del distacco e della distanza; con il secondo mette continuamente alla prova e
verifica la consistenza del proprio deposito. Questa riflessione vale in modo paradigmatico per
l’arte di Francesco Clemente e trova compiuta corrispondenza, in particolare, negli ultimi cicli da lui
realizzati con la tecnica dell’acquarello, che non lascia possibilità di errore né l’agio di
ripensamenti, poiché l’immagine materialmente “si fa” attraverso il movimento della mano quale
diretta espressione di un pensiero vago, fluido sensibile come quello della notte.
Napoletano di nascita e nomade per vocazione, Clemente ha attraversato storia e geografia con
numerosi viaggi in India (e uno in compagnia di Alighiero Boetti in Afghanistan), sviluppando un
felice cortocircuito tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo. Dalle opere post-concettuali
dei Senza titolo del 1973 alla Stanza dei decori del 1975, Coppia d’inganno (murale angolato del
1976) o alle Coppie al lavoro del 1978, via via fino ai ritratti e autoritratti degli anni ottanta e alla
grande opera dedicata alla “Madre mediterranea” del 1998, Clemente ha sempre lavorato su una
catena di assonanze, analogie visive, sincretismi atti a liberare l’immagine da ogni obbligo
referenziale e a immergerla in un nuovo stato contemplativo, una sorta di quiete librata sulle
coordinate cartesiane del Logos greco. Dopo averla sottratta al rumore dei suoi tradizionali
riferimenti, egli la spinge nella posizione di un diverso orientamento imbevuta di una disciplina
orientale immediatamente riscontrabile nella pienezza del vuoto in cui le figure vacillano nello
spazio dell’opera. Nell’unità inestricabile delle proprie forme, Clemente condensa idea e segno
visivo, nell’immagine sintetizza la metamorfosi dell’idea che prende le sembianze di figura.
Clemente opera sull’uso intenzionale di stereotipi e stilizzazioni che portano nell’arte un’apparente
concetto di convenzionalità, ma tale convenzionalità è appena un dono iniziale per lo sguardo del
pubblico, perché l’artista immette sempre variazioni sottili e imprevedibili che creano nella cosa
riprodotta uno spaesamento, una sospensione temporale e uno stato di rallentamento che portano
verso impercettibili differenze. L’immagine di Clemente oscilla tra invenzione e convenzione, intesa
quest’ultima quale momento di assunzione del linguaggio come stile, in cui l’artista recupera non il
senso bensì il segno, il livello di superficie. L’invenzione scatta, invece, attraverso la contiguità e
l’accostamento imprevedibile di differenze linguistiche e di assonanze contrastanti, che non
suscitano dissonanze o lacerazioni, non determinano campi di perturbazione visiva, ma fondano la
possibilità di un’emergenza inattesa, attraversata e movimentata da una sollecita ricettività.
L’opera diventa così il luogo di continui spostamenti del significato, una catena inarrestabile che
segue il suo viaggio attraverso peripezie veloci e intense nel tempo e nello spazio. Dall’uso
ambiguo della convenzionalità, del luogo comune che trova un suo ribaltamento delicato ed
esplicito, scaturisce il comico, come mostra l’ampia produzione degli anni ottanta di immagini
erotiche, natali e prenatali, in cui Clemente riproduce più volte se stesso e la moglie Alba.
L’accento ironico porta l’opera fuori dal rapporto di scontro ambizioso e ingenuo con il mondo, per
metterla al servizio di una microsensibilità che non drammatizza su niente – perché manca ormai
l’energia storica per farlo – ma tutto trasforma in potenziale, irripetibile occasione segnica,
all’interno di un’ottica orizzontale tesa all’uso indifferente di molte tecniche – pittura, fotografia,
disegno, affresco, mosaico – e alla conquista di una rappresentazione in cui astratto e figurativo
definitivamente si pareggiano. L’ironia, che si libera nel distacco, scatta proprio nell’inversione
prodotta da una posizione tradizionalmente metaforica a una più specificamente metonimica,
destituita così della sua valenza simbolica.
Giocando tra ripetizione e differenza, l’iconografia di Clemente è frutto di un linguaggio che punta
sempre il proprio bagliore sull’eccesso dell’immagine. L’opulenza nasce dallo slittamento del
linguaggio che rompe l’impoverita verosimiglianza di figure semplicemente speculari per
presentarsi – come accade nell’opera di Egon Schiele – nel tono lieve dell’affabulazione, di una
cordiale esplicitezza che vuole catturare l’attenzione esterna a sé. Da qui il ricorso alla descrizione
e alla decorazione, che trova nell’astrazione e nella ripetizione di pattern visivi o anche nel
recupero della figura il modo di creare un campo di fascinazione e di indeterminatezza. L’arte di
Clemente, infatti, non cerca una competizione con la realtà ma la possibilità di un ulteriore piacere,
quello di un’opera che non priva lo spettatore della propria presenza e capacità narrativa. Tale
instabilità assicura una sorta di precario erotismo all’immagine, capace di abbandonarsi tanto
all’accento alto dell’arte colta, imbevuta di sufismo, studi antropologici e dottrine esoteriche, quanto
a quello basso e disinvolto della cultura di massa. Accentuando il carattere di seduzione dell’opera
e il riconoscimento della sua interna e intensa qualità, Clemente non solo trova una saldatura tra
queste due dimensioni della cultura, ma favorisce un nuovo rapporto di cordialità tra arte e
pubblico.
Negli anni novanta Clemente dimostra sempre più di possedere il senso della variazione,
dell’accumulo e spostamento continuo dei riferimenti, il sentimento dello stile aperto a slittamenti
che ne modificano continuamente la cifra. A questo assetto mentale libero e nomade fa da
contraltare il teatro domestico della pittura, la pratica quotidiana di una creatività capace di tradurre
la profondità storica dei linguaggi recuperati in un superficialismo disincantato e disinibito, e
rifondare un modulo narrativo che procede per frammenti e messa a fuoco di particolari minimi.
Quest’ottica frammentaria e felicemente precaria è il sintomo di un’estasi della dissociazione (per
la mancanza di punti di vista privilegiati, la frantumazione di una concezione unitaria del mondo e
dell’opera) ma anche, soprattutto, il segno di un desiderio di ovidiana metamorfosi, per realizzare
la quale è necessario disarmarsi da qualsiasi ancoraggio e direzione, muoversi fuori dalle
prerogative di ogni centralità e semmai secondo percorsi laterali, minori, eccentrici. Sul frammento
lavora Clemente, perché privilegia le vibrazioni discontinue della sensibilità. Una sensibilità che
non escludere, però, l’emozione della mente, non taglia fuori la tensione dell’intelligenza, la storia
del pensiero e neppure la memoria culturale e visiva di altre opere. Perché la recettività dell’opera
richiama sempre dentro il campo del linguaggio gli echi dell’esterno, spiegando alla ragione
dell’arte motivi, accidenti, accadimenti spaziali e temporali. Il linguaggio non è mai la spia di una
condizione totalmente soggettiva, bensì il tramite ironico per costruire organismi autonomi di una
visione che trova dentro di sé le ragioni della propria persistenza. Questa sensibilità diventa il
nuovo soggetto dell’opera e l’artista il tramite attraverso cui essa transita e continuamente
trasmuta, trasale, scorre. Centro di irradiazione e punto di confluenza dei suoi misteriosi
movimenti, la pittura di Clemente è un microevento che parte sempre più dall’interno
dell’immagine, come coagulo di flussi molteplici, emergenza delle molte spinte che guidano
l’impulso creativo dell’artista. La discontinuità della sensibilità comporta anche la produzione di
immagini sempre diverse, legate tra loro da una pratica che non è mai ripetitiva. Queste assumono
i travestimenti della figurazione, del segno astratto, la ricchezza della materia e del colore senza
mai assestarsi in una scrittura standardizzata.
L’invenzione di Clemente non è mai esplicita, eclatante, perché non ha carattere linguistico,
piuttosto trova il suo momento di originalità nell’evidenziazione di latenze sentimentali, culturali,
concettuali condensate sotto accostamenti e contiguità di tradizioni iconografiche tra loro distanti.
Per questo le sue immagini non hanno mai caratteri consueti, perché sono sempre il portato di
un’idea che si traveste dietro la figurazione che assume, sono il risultato di una condensazione
simbolica degli sbalzi e degli scarti improvvisi che l’immaginazione dell’artista compie rispetto i
suoi riferimenti originari. Materiali, stili e temi della storia pittorica delle diverse civiltà sono
recuperati da Clemente come una sorta di objet trouvé spaesati dalle loro fonti semantiche così
come da ogni rinvio metaforico, per essere macinati all’interno dell’elaborazione dell’opera: vero e
proprio crogiuolo depurante in cui cucinare elementi inconciliabili tra loro, amalgamare insieme
diverse temperature culturali – caldo e freddo, metrico e astratto, diurno e notturno – con le quali la
soggettività dell’artista ha saputo confrontarsi. Vari climi abitano infatti le opere di Clemente che,
mai prone alla domanda imperiosa dell’attualità, macinano innesti inediti e diverse dislocazioni
lessicali rispetto alla loro collocazione storica. Intrappolate nella morsa del “fare” da una manualità
febbrile non lontana da quella di Cy Twombly e Frank Stella, antinomie e opposte polarità portano
l’opera a slittare verso direzioni multiple, che si incrociano tra loro liberando energie talvolta
contrapposte. Per questo ogni nuovo ciclo di lavori richiede, da parte del pubblico, molti scatti,
molti spostamenti di campo e di assetto mentale. L’immagine, nella sua persistenza finale, è il
frutto di una elaborazione che trova l’etica di un tempo di esecuzione e molteplici modalità di
attuazione. Da qui l’interesse per la posizione fisica assunta dall’artista nei suoi momenti operativi,
per la sua maniera di fronteggiare l’opera durante il suo processo di formazione, crescita e
sviluppo, il tentativo di coglierne il procedimento interno di genesi e proliferazione. L’arte si fonda
infatti sulla processualità e nella velocità di aggregazione del valore d’uso dei materiali (naturali,
artificiali, consistenti, impalpabili) più adatti a sollecitare una risposta sensoriale e a produrla,
secondo un’ottica che non è mai psicologica bensì sempre solo tesa verso la possibilità di
ampliare il senso dell’immagine. Questo sorge progressivamente dall’economia interna del
linguaggio mediante assonanze visive e passaggi di segni che fondano il quadro come “campo”,
che per definizione poggia il proprio valore sulla potenzialità di relazioni mobili grazie all’uso della
metonimia.
Tra persistenza ed emergenze oscillano le immagini nuove create da Clemente in questa prima
decade del XXI secolo, in cui un diffuso policentrismo si va sempre più diffondendo nel sistema
dell’arte: per il tema dell’identità, che ha sviluppato un dibattito internazionale e un movimento
culturale no-global che sconvolgono il centralismo cosmopolita degli anni precedenti; per la ripresa
del concetto di genius loci, la cui revisione fuori da ogni ancoraggio autarchico ha ampliato il
panorama dell’arte internazionale verso territori antichi come la Cina, l’India, i paesi latinoamericani, l’Africa, ora emergenti e ormai partecipi di un confronto iconografico costruttivo e vitale.
Nella sua trentennale stanzialità newyorkese, alleggerita anche da soggiorni in Nuovo Messico,
Clemente continua a praticare, oltre l’opulenza della pittura, i luoghi severi dell’encausto a cera
punica e quelli “minori” del disegno e dell’acquarello, nei quali la ripresa di procedimenti tradizionali
e la presenza di scarti e differenze rispetto agli esiti precedenti portano l’artista a riscoprire il
piacere di una aperta inattualità, fatta di motivi pittorici recuperati da culture locali giocati sulla
ripetizione manuale, di linguaggi, posizioni e metodologie appartenenti al passato. Un passato
rimasticato senza gerarchie e sempre nell’ottica del tempo presente, della cui soggezione alla
riproducibilità meccanica e alla manipolazione digitale dell’immagine massmediale l’artista è ben
consapevole. La sua arte può ormai contare su radici ramificate ed elastiche, che lo portano a
partecipare non solo da protagonista ma da antesignano a un fenomeno di meticciato culturale
senza precedenti, in cui si affermano come vincenti la pratica del nomadismo e la coesistenza
delle differenze, l’attitudine alla esplorazione delle diverse tradizioni e fedi religiose, l’appartenenza
a una antropologia non territoriale ma ampia, complessa e stratificata, questa sì, veramente
sperimentale.
Non bisogna però dimenticare che a monte dell’orizzonte profilato dal nuovo secolo c’è negli anni
ottanta la transavanguardia, calda e fredda, italiana e transnazionale, che nel suo multiculturalismo
ha sfidato la globalizzazione del linguaggio, perseguito fino a quel momento dalle neo-avanguardie
con eroico ottimismo. A monte del panorama no-global di oggi ci sono l’ansia identitaria di artisti
come Alighiero Boetti e Francesco Clemente (per rimanere ai casi italiani) e le collaborazioni
messe a segno da Robert Rauschenberg sin dagli anni settanta e poi all’interno del progetto dei
Rauschenberg Overseas Culture Interchange (ROCI) avviato nel 1984. Queste esperienze-chiave
hanno aperto molti varchi e un’attenzione del tutto nuova verso l’arte di paesi fuori dalla dialettica
Europa-America, preparando la strada a quella mostra seminale che è stata nel 1989 Magicien de
la terre al Centre Georges Pompidou. Nel suo lungo rapporto di scambio con tradizioni antiche
materiali (pratiche artigianali) e immateriali (religione, filosofia, folclore) di territori lontani, Clemente
pratica la memoria come libero scorrimento di superficie capace di adottare molteplici travestimenti
e, così facendo, la salvaguarda come valore di residua del processo di conoscenza, come fattore
di unità antropologica e stabilizzatore di una complessità culturale non più confutabile. A distanza
di quasi quarant’anni, quel lavorio compiuto dentro l’alveo precario dell’eclettismo e della
contaminazione rivela contenere dentro di sé non solo una concreta sperimentazione, misurabile
di volta in volta dall’intensità del risultato, ma anche un modello di trasformazione simbolica del
mondo.
Questo è l’indispensabile valore che le transavanguardie, ormai trans-continentali, trasmettono,
venendo in soccorso a una società globalizzata sempre più sottoposta ai colpi di una crisi
epistemologica, finanziaria, politica e morale. Non dunque una corsa in soccorso del vincitore, ma
piuttosto il tentativo di restituire complessità e nuovi processi di conoscenza a un corpo sociale
anestetizzato e passivizzato dalla spettacolarità mediatica. Come mi è più volte capitato di
affermare, l’Arte rimane sempre una domanda posta silenziosamente dall’artista ai confini tra la
realtà già nota e ciò che ancora è inconosciuto: la parte oscura da rimuovere, la dimensione di una
perenne insicurezza, ma anche lo stato di fervida incertezza che è proprio di ogni libera ricerca.



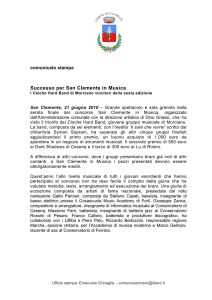
![[TABLOID - 14] TABLOID/PAGINE/PAG](http://s1.studylibit.com/store/data/007544319_1-dcf64e7ef0da311c67807ef029a5c514-300x300.png)