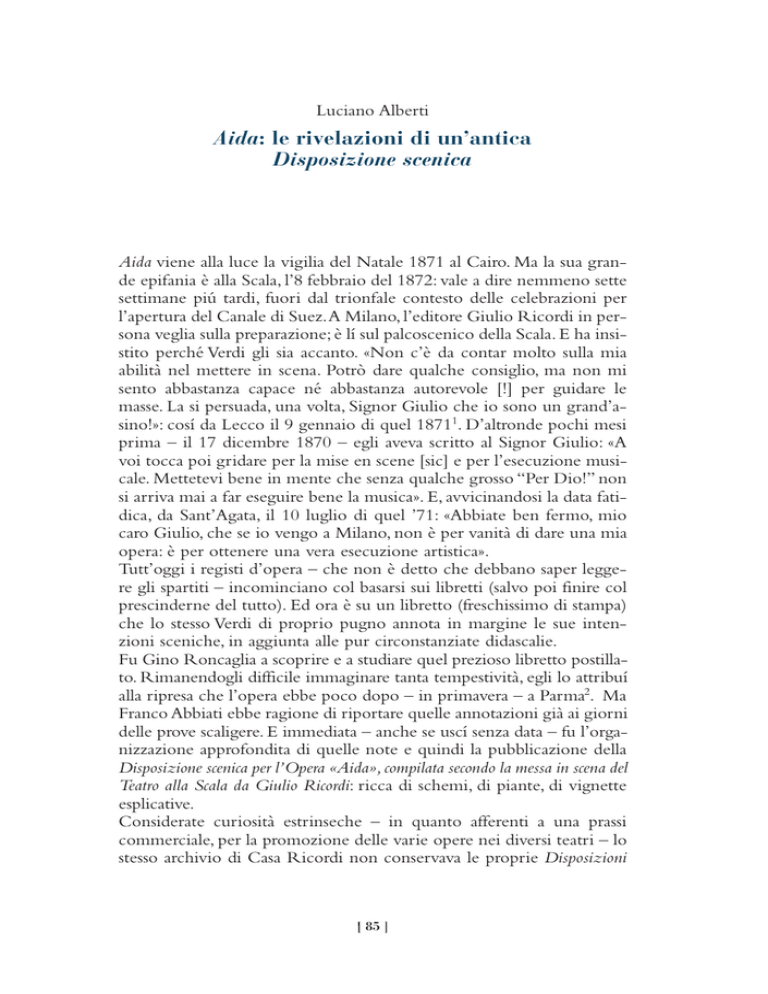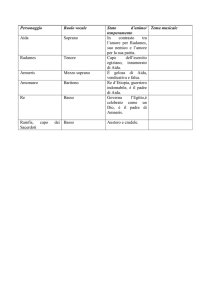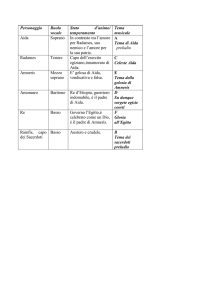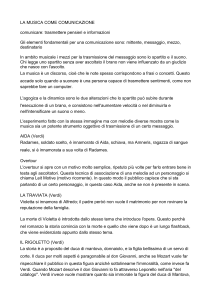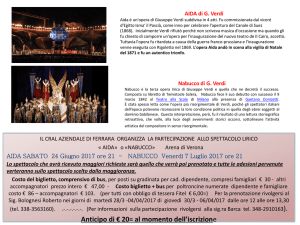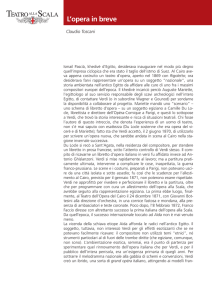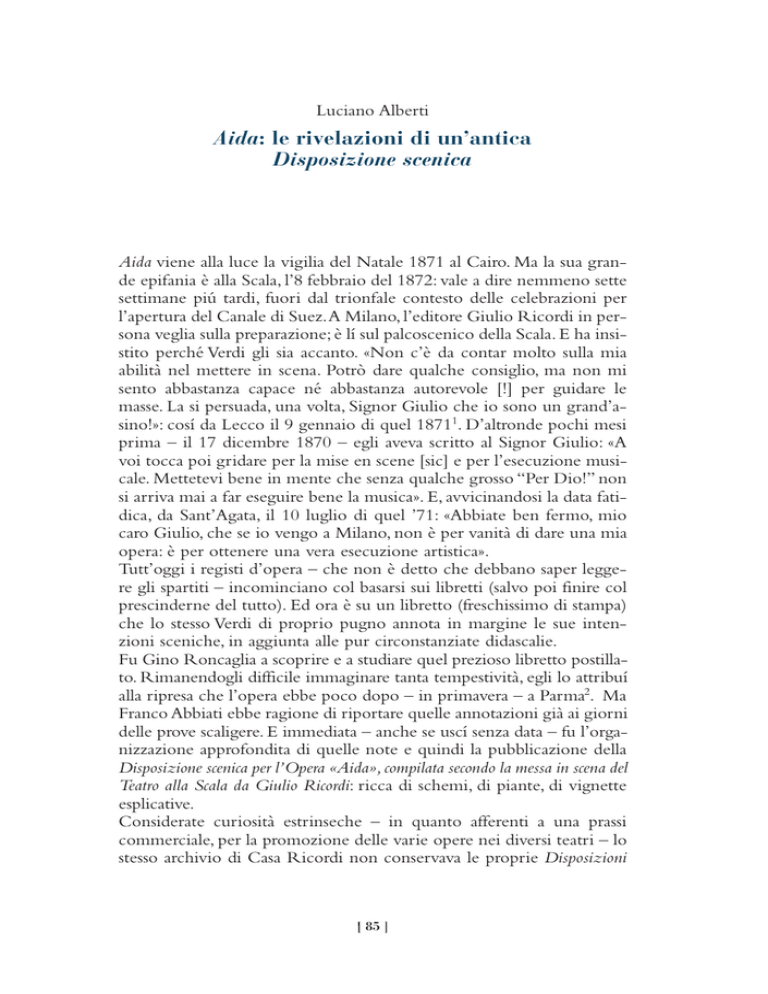
Luciano Alberti
Aida: le rivelazioni di un’antica
Disposizione scenica
Aida viene alla luce la vigilia del Natale 1871 al Cairo. Ma la sua grande epifania è alla Scala, l’8 febbraio del 1872: vale a dire nemmeno sette
settimane piú tardi, fuori dal trionfale contesto delle celebrazioni per
l’apertura del Canale di Suez.A Milano, l’editore Giulio Ricordi in persona veglia sulla preparazione; è lí sul palcoscenico della Scala. E ha insistito perché Verdi gli sia accanto. «Non c’è da contar molto sulla mia
abilità nel mettere in scena. Potrò dare qualche consiglio, ma non mi
sento abbastanza capace né abbastanza autorevole [!] per guidare le
masse. La si persuada, una volta, Signor Giulio che io sono un grand’asino!»: cosí da Lecco il 9 gennaio di quel 18711. D’altronde pochi mesi
prima – il 17 dicembre 1870 – egli aveva scritto al Signor Giulio: «A
voi tocca poi gridare per la mise en scene [sic] e per l’esecuzione musicale. Mettetevi bene in mente che senza qualche grosso “Per Dio!” non
si arriva mai a far eseguire bene la musica». E, avvicinandosi la data fatidica, da Sant’Agata, il 10 luglio di quel ’71: «Abbiate ben fermo, mio
caro Giulio, che se io vengo a Milano, non è per vanità di dare una mia
opera: è per ottenere una vera esecuzione artistica».
Tutt’oggi i registi d’opera – che non è detto che debbano saper leggere gli spartiti – incominciano col basarsi sui libretti (salvo poi finire col
prescinderne del tutto). Ed ora è su un libretto (freschissimo di stampa)
che lo stesso Verdi di proprio pugno annota in margine le sue intenzioni sceniche, in aggiunta alle pur circonstanziate didascalie.
Fu Gino Roncaglia a scoprire e a studiare quel prezioso libretto postillato. Rimanendogli difficile immaginare tanta tempestività, egli lo attribuí
alla ripresa che l’opera ebbe poco dopo – in primavera – a Parma2. Ma
Franco Abbiati ebbe ragione di riportare quelle annotazioni già ai giorni
delle prove scaligere. E immediata – anche se uscí senza data – fu l’organizzazione approfondita di quelle note e quindi la pubblicazione della
Disposizione scenica per l’Opera «Aida», compilata secondo la messa in scena del
Teatro alla Scala da Giulio Ricordi: ricca di schemi, di piante, di vignette
esplicative.
Considerate curiosità estrinseche – in quanto afferenti a una prassi
commerciale, per la promozione delle varie opere nei diversi teatri – lo
stesso archivio di Casa Ricordi non conservava le proprie Disposizioni
85
Luciano Alberti
sceniche, quando ci si cominciò a occupare di tali pubblicazioni: né questa per l’Aida e neanche quelle per le altre opere del Verdi maturo, per
non dire di qualche altra ancora. Questo interesse incominciò a suscitarsi nel mezzo degli anni Settanta del secolo scorso, in Italia: dopo che
in Francia di livrets de mise-en-scène si parlava e si scriveva da qualche
tempo, essendo essi i precedenti e i modelli per gli opuscoli italiani.
Ricordi ne aveva aperto il filone, facendo appunto tradurre il livret pubblicato a Parigi per Les Vêpres siciliennes (1855).
Intanto, già all’inizio di quegli anni Settanta, il centenario di Aida
(1871-1971) era stato l’occasione per una fioritura di studi, a raggio
internazionale, sulla genesi dell’opera3. Ma un’aria di stupita rivelazione ebbe il primo affondo in questo particolarissimo genere di documentazione: in chi l’operò e in chi ne colse la novità. Cioè nel sottoscritto, che di fatti si diede cura di narrare come, per vie tutte contingenti e private, era venuto in possesso della Disposizione scenica di Aida4;
mentre l’eco piú autorevole, a stretto giro di recensione, fu da parte di
Fedele D’Amico5.
Cospicua è ormai la bibliografia che si è squadernata su questo orizzonte: anche a limitarci all’orizzonte italiano, attorno alle Disposizioni
sceniche di Casa Ricordi6 e a quelle di Casa Sonzogno7.
Da Parigi, attraverso Camille Du Locle, direttore del Théâtre des Italiens,
arriva a Verdi la sensazionale commissione per il Cairo. Ed era stato l’illustre egittologo Mariette Bey a designare il Maestro italiano (a preferenza
di Wagner, di Gounod, non che del Principe Poniatowski). È il Mariette
che stende il «programma» della tragedia faraonica insieme con lo stesso
Kedivè d’Egitto: programma che Verdi subito trova «splendido di mise en
scene» [sic]. Ed è sempre il «fameux antiquaire» che a Parigi – una Parigi
assediata dai prussiani, dove egli rimane bloccato per settimane – cura la
realizzazione delle scene e dei costumi da inviare in Egitto.
Nel segno di un’erudizione archeologica procede la stessa composizione musicale: da parte di Verdi continue, intense, instancabili, pluridirezionali sono le consultazioni relative ad antichi strumenti musicali egiziani (l’idea fissa alla «Flûte egiziana» del Museo archeologico di Firenze; la fabbrica appositamente commissionata di trombe lunghe e corte
per la Marcia trionfale; l’ampio uso delle arpe a vista, nel boudoir di
Amneris: «siamo in Egitto e le arpe lavorano molto») e ancora consultazioni relative a costumi e a costumanze, a riti, danze, caste. «Datemi
queste nozioni e pensate seriamente ai costumi. Oh, in questo bisogna
far bene e farli veri, che serviranno anche per l’Europa».
Dunque dal Cairo il vestiario passa a Milano (quanto meno in buona
misura). E pure per gli attrezzi ci si rivolgerà sempre a Parigi; come per
i gioielli della protagonista, Teresa Stolz: li avrà disegnati Granger. E
86
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
francese è il coreografo, Montplaisir, che riscuote tutta la fiducia di Verdi: «So che è un uomo molto cognito dell’Oriente e mi farà certamente
delle cose caratteristiche e originali». L’espressione è quanto mai sintomatica: carattere e originalità dunque; «scrupolosa esattezza storica» e
invenzione. Per tutti i suoi parametri l’Aida conferma la famosa metafora di Bruno Barilli: opera dall’aspetto esotico eppure tutta nostrana;
come, tra i frutti, il cocomero.
La componente nostrana nello spettacolo milanese fu fortemente potenziata dal ricorso, per la scenografia, a Girolamo Magnani, di Parma:
Verdi impone questo suo conterraneo con la piú profonda convinzione: «È un vero artista ed è della razza di quelli cui il razionalismo dell’epoca nostra non ha spento il fuoco sacro. Egli sente. Sente giusto;
ragiona poco e fa molto». Quanto dire della sua stessa razza (per usare
il termine caro a Verdi: e innocentissimo).
Nella storia della scenografia italiana, era da circa un secolo che l’Egitto
aveva cittadinanza: dai tempi, cioè, della sua ancora persistente supremazia a raggio europeo.Anche a lasciare da parte le fantasie massoniche del
Flauto magico (del resto prossime alle documentate evocazioni egizie di
un ‘Maurino’ Tesi, l’amico dell’Algarotti), un forte incremento alle egizianerie da palcoscenico – e da arredamento: arredo urbano, di giardini;
come pure di interni signorili: decorazioni parietali e mobilia – viene
dalle imprese napoleoniche e dalle rilevazioni dello Championnet.
L’Egitto, per l’appunto, insieme con le ‘Indie’ americane (precolombiane) erano state le acquisizioni della piú matura cultura etnologica dell’illuminismo, che sui palcoscenici dei teatri d’opera (e dei balli), con un
impegno programmaticamente didascalico, attuava la propria piú accattivante divulgazione: alquanto dopo le copiose cineserie e turcherie.
Aida sono già ai nostri occhi certe scene faraonico-neoclassiche di Alessandro Sanquirico in una Scala primo Ottocento. Ma in Verdi chiara è
la consapevolezza che con Aida l’Egitto, nel teatro musicale, diventa
rivelazione tutta sua; dunque sua esclusiva. A Tito Ricordi, da Genova,
egli scrive il 25 luglio sempre di quel 1871: «Vedo sui giornali, e Giulio
me lo confermò, che si prepara per la Scala un Ballo egiziano. È questo
un gravissimo errore tutto a danno dell’Impresa, e dello spettacolo che
verrà secondo, […] un errore […] dei piú grossi che si possano commettere in teatro». E da Busseto, il 13 novembre: «Vedo che si parla
ancora della Figlia de’ Faraoni!!! Ciò non può essere; badate bene che
non si facciano pasticci».
Sul palcoscenico della Scala, tra il Mariette (l’egittologo che pure continua a seguire la trasferta dell’Aida dal Cairo all’Italia) e l’editore Giulio
Ricordi, entrambi all’ombra di Verdi, la figura del librettista – cui, per
antica tradizione, era demandata la responsabilità della messa in scena –
87
Luciano Alberti
ora si eclissa.Antonio Ghislanzoni, con la stesura del libretto – amichevolmente tartassatissima dal compositore – aveva chiuso il proprio compito. Si apre invece, sotto quella sorta di autorevole triunvirato, il compito del direttore di scena, per assurgere a nuovissima dignità. Mentre si
ribadisce per questa figura la consueta funzione di ispettore e di responsabile militaresco dell’ordine sul palcoscenico («il direttore di scena badi
soprattutto a che ogni cosa sia regolata militarmente»), si attribuiscono
a essa compiti ulteriori, via via piú alti e piú delicati.
La Disposizione scenica di Aida dà indicazioni precise per le entrate, i
movimenti e le uscite dei cori e delle comparse: problema capitale –
sempre – per i metteurs-en-scène.
Le entrate: tra epistolario e Disposizione scenica (le due fonti sono assolutamente complementari, di lega analoga) il clou della mobilitazione di
Aida in quanto impegno registico di grandi masse – vale a dire la Marcia trionfale – risulta enfatizzare quello che è un antichissimo partito
spettacolare, proprio delle stesse parate militari: la successione di ‘entrate’, cioè di gruppi variamente e vivacemente connotati (le entrées sono
in se stesse una specifica risorsa coreografica, per lo spiegamento del
corpo di ballo, quando se ne dia il caso). Nella lettera al Ghislanzoni, da
Sant’Agata, datata 8 settembre 1870, Verdi aveva scritto:
Dopo la sua partenza […] non ho fatto che la marcia la quale è molto
lunga e dettagliata. L’ingresso del Re, la Corte,Amneris, sacerdoti; il canto del Popolo, delle donne; un canto ancora di sacerdoti (da aggiungere);
l’entrata delle truppe con tutti gli arnesi di guerra, danzatrici che portano
vasi sacri, cose preziose etc.; Almèe che danzano; finalmente Radames
con tutto il bataclan non formano che un pezzo solo, la marcia.
E al Du Locle, a partitura finita, quasi un anno dopo, il Maestro dettaglia le varie fasi della grande parata cosí come saranno fissate nella Disposizione scenica, avvertendo: «La Marcia è lunga molto. Durerà circa 8
minuti!!! Ma non vi spaventate, è frammista di un piccolo ballabile, e
perciò riesce lunga».
Le uscite del coro: il primo, il secondo e il quarto quadro dell’opera
risolvono i rispettivi concertati finali (il quarto è quello che chiude la
scena del trionfo), ricorrendo a un modulo ‘militaresco’ pressoché identico, giocato interamente sulla rapidità e l’ordine: lo spaccarsi in due
della massa corale, già allargatasi parallelamente alla ribalta, dietro le
spalle dei solisti, e il dietro-front dei solisti stessi: i primi a uscire dal
fondo. Si legge nella Disposizione scenica alla chiusa del primo quadro:
Il Coro si divide immediatamente in mezzo, e il Re, presa per la mano
Amneris, monta la scena ed entra nelle quinte di destra, seguito dal
Messaggero, dall’Uffiziale, da tutto il Coro e dalle Guardie: Ramfis fa
88
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
segno a Radames di seguirlo, ed alla testa dei Sacerdoti esce dalla porta
di fondo in modo che la scena resti vuota al finire delle poche battute
strumentali con cui si chiude il pezzo.
Fino a qui, dunque, il direttore di scena adempie al proprio impegno
militaresco. Ma, tra le entrate e le uscite, per la condotta del coro, nel
bel mezzo dei grandi quadri, si fa appello alla sua sensibilità ‘artistica’.
La Disposizione scenica, all’inizio, sotto l’elenco dei personaggi – ciascuno sinteticamente definito nei suoi tratti salienti – per il Coro dà un
precetto fondamentale:
Persuadere i Cori, specialmente uomini, che non devono raffigurare
una massa insignificante di persone, ma che bensí ciascuno rappresenta
un personaggio e come tale deve agire, muoversi per conto proprio,
secondo i propri sentimenti, mantenendo soltanto cogli altri una certa
unità di azione, atta a meglio assicurare l’esecuzione musicale.
In epoca moderna ci sembra di poter dire che quasi soltanto un Felsenstein, tra i registi d’opera, abbia potenziato al massimo le risorse mimiche di ciascuno dei suoi coristi: lo ha fatto soprattutto nei melodrammi alle cui scene di insieme si poteva (si doveva) applicare un’articolazione sostanzialmente realistica; e lo ha fatto in un regime di prove
(innumerevoli), quale era a lui consentito dalla ‘sua’ Komische Oper,
nell’antica Berlino Est. Per lo piú, molto comprensibilmente, i registi
d’opera (di ogni estrazione o scuola) diffidano dello spontaneismo dei
Signori e delle Signore del Coro (oltre tutto disponibili secondo limitati orari di prove di scena), tendendo piuttosto a fissare le masse in
blocchi statici, e ricorrendo magari a piú o meno copiose infiltrazioni
di mimi: questi sí mobilissimi.Tuttavia, l’impegno di storicizzazione, cui
specificamente invita lo studio delle Disposizioni sceniche, non può non
riconoscere in questa istanza verdiana per un’‘espressività’ anche scenica del cori un segno di novità, e dunque di modernità. E sintomatici in
sommo grado risulteranno al proposito precisi riscontri per l’appunto
nel versante wagneriano.
Per tornare alla scena del trionfo di Radamès, «assai artisticamente» deve atteggiarsi il gruppo dei Prigionieri etiopi, i quali irrompono nella
complessiva schematicità marziale del quadro come un vero coup-dethéâtre. E anzi, nella convenzione sovrana del grande finale, in cui l’irto
contrappunto del baritono (Amonasro) e della relativa sezione del coro
maschile costituisce un magnifico partito musicale – come sempre in
Verdi, i congiurati – l’arte scenica è chiamata a coprire l’implausibilità
di questo condottiero etiope, il quale, coram populo – eppure «non visto»
– non desiste dall’ordire trame di riscossa. Non solo: anche nelle scene
sacrali – quelle entro il Tempio di Vulcano: al secondo quadro, il quadro
89
Édouard Despléchin, Ingresso a Tebe,
bozzetto per la prima di Aida al Cairo (atto II, quadro II), 24 dicembre 1871
(1871; Parigi, Bibliothèque Nationale, Département de la Musique)
90
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
della «Consacrazione», come pure, stando alle originarie intenzioni di
Verdi, al finale dell’opera – là dove è imposto al coro dei Sacerdoti una
solenne staticità, questa deve contribuire a quel carattere e a quella «importanza scenica», cui il Maestro teneva profondamente. Le vignette
della Disposizione indicano l’atteggiamento dei coristi (la posizione delle braccia). «Nume, custode e vindice»: nel grande coro religioso affidato alle voci maschili si profondono singolari ambizioni meta-liturgiche da parte del Maestro, e tutto il suo ben dichiarato culto ‘palestriniano’. Se la partitura di Aida, nel suo complesso, è la piú vicina al Requiem, tra le altre del proprio autore, tanto piú lo è per questa scena.
Per l’articolazione a canone del «Nume, custode e vindice» la Disposizione prescrive: «Ciascuna frazione di coro, all’attacco della propria parte farà due passi innanzi, alzando le mani e volgendosi alquanto verso
la statua di Vulcano»; e tutta una pagina contiene l’ideogramma delle
quattro entrate. Il preconcetto palestriniano, dunque, frutta – tanto è
forte e fertile – un inusitato limite registico di astrattezza coreutica.
Semplicità ieratica, assolutamente antiaccademica, in questo quadro, era
già stata richiesta per le danze delle Sacerdotesse (interni la voce solista
e il coro femminile). Ma che il gioco dei flabelli affidato alle ballerine,
raccolte «in gruppi piramidali» ai piedi dei quattro tripodi d’oro ad
apertura di sipario, si componga alla fine nell’assemblaggio monumentale di un unico grandissimo flabello, tableau a sorpresa all’aprirsi in due
(rapido e simmetricissimo) del coro sacerdotale, induce di colpo un
forte sentore di Ballo Excelsior (è quasi alle porte).
E sí che Verdi, per i balli di Aida in genere, aveva scongiurato che non si
andasse a cadere in un mal gusto operettistico: «alla Duchesse de Gérolstein,
alla Belle Hélène, etc. etc.». Per questo aveva censurato i figurini troppo disponibili al nudo. E per le Sacerdotesse danzanti, anzi, aveva prescritto – insistendo – lunghe vesti, secondo le indicazioni del Mariette. D’altra parte
al flabello Verdi teneva molto. Esso evocava infatti pompe vaticanesche, secondo la chiave attualistica che ha presieduto alla concezione di questa
componente drammaturgico-musicale dell’opera: i Sacerdoti in Aida sono
senz’altro «preti», a cominciare dal loro capo: Ramfis «il gran Prete»; «autocrate, crudele»: cosí è indicato nella lista dei personaggi. «I preti non sono
abbastanza preti» è l’appunto al Ghislanzoni durante la travagliata stesura
della scena della consacrazione. «Empia razza», tutti: quando il profondo
anticlericalismo verdiano – l’anticlericalismo diffuso nell’Italia liberale del
tempo – sembrerà approfittare della smagliatura parossistica di Amneris, a
conclusione della scena del giudizio, per lanciarsi in invettiva.
Si è accennato a riscontri nel versante wagneriano; e l’accenno riguardava la condotta scenica dei cori. Verdi non sapeva degli opuscoli che
il giovane Wagner – esule – aveva scritto per le realizzazioni del Vascello
91
Luciano Alberti
fantasma e del Tannhaüser che egli non poteva seguire personalmente: è
in essi che è dato coglier quei riscontri, e, in effetti, embrioni di Disposizioni sceniche sono quegli opuscoli, cosí programmaticamente funzionali; e sono di molto anteriori a esse. Ma intanto Verdi che vediamo sul
palcoscenico della Scala presiedere alle prove di Aida precede di un lustro Wagner che, nella sua Bayreuth, prova la tetralogia, affidando le proprie indicazioni registiche alle note di cui Felix Mottl ha corredato la
partitura. Sono coincidenze legate all’empirica esperienza comune di
palcoscenico, nell’impegno fondamentale di un decoro spettacolare, di
un’autenticità drammatica basata su una nuova coesione: quella per cui
si arrivano a definire, battuta per battuta, i movimenti, i gesti, gli sguardi, gli atteggiamenti dei cantanti, i raggruppamenti armonici e variati
dei cori, l’utilizzo congruo delle comparse.
Inutile dire che la divaricazione tra le rispettive concezioni teatrali, in
Verdi e in Wagner, aumenta quanto piú ci si alzi dalla quota palcoscenico verso formulazioni d’ordine generale. Verdi («homo sanza lettere»)
non ha scritto i trattati che ha scritto Wagner. Tuttavia anch’egli, proprio nei mesi della composizione di Aida, costretto dalle istanze ministeriali dell’Italia da poco unita, ha fermato la propria riflessione su problemi di riforma. Ed è un fatto che anch’egli si appunti per intero sul
teatro – scartando esplicitamente i Conservatori, verso cui non nasconde la propria diffidenza – essendo il teatro, anche per lui, il centro focale della vita musicale della nazione. Il suo pragmatismo di tempra machiavellica («nelle cose, siano grandi o piccole, bisogna riescire o non
intraprenderle»), arriva a esprimersi in questi termini:
Che il ministro rialzi i teatri e non mancheranno né Compositori, né
Cantanti, né Istromentisti. Ne istituisca per esempio tre da servire di
modello a tutti gli altri. Uno nella Capitale, l’altro a Napoli, il terzo a
Milano. Orchestra e Cori stipendiati dal Governo. In ogni teatro, scuola di canto gratis pel popolo, coll’obbligo agli allievi di servire nel teatro per un dato tempo. Per ogni teatro un solo Maestro Concertatore e
Direttore dell’orchestra, e responsabile di tutta la parte musicale. Un
régisseur solo da cui dipende tutto ciò che riguarda la mise en scène.
Alla quota piú alta si chiude cosí il cerchio del ‘direttore di scena’, ovvero (piú riguardosamente) del régisseur : con forti premonizioni, come si
può vedere, nella direzione del futuro regista.
Piú a fondo. Si sa bene che a Verdi la frase piú ‘wagneriana’ era sfuggita quando di Wagner egli non aveva il piú lontano sentore:
In quanto alla distribuzione dei pezzi vi dirò che per me quando mi si
presenta della poesia da potersi mettere in musica, ogni forma, ogni
distribuzione è buona, anzi piú queste sono buone e bizzarre io ne sono
92
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
piú contento. Se nelle opere non vi fossero né Cavatine, né Duetti, né
Terzetti, né Cori, né Finali etc. etc., e che l’opera intera non fosse (sarei
per dire) che un solo pezzo, troverei piú ragionevole e giusto.
La data: Busseto, 4 aprile 1851.Verdi confidava queste sue intenzioni
avveniristiche al Cammarano nella corrispondenza per Il trovatore: per
un’opera, per l’appunto, che segnava piuttosto una riconversione al piú
acceso cabalettismo. Nella diversità profondissima dei venti anni trascorsi, una riconversione in qualche modo analoga è ravvisabile in Aida
rispetto alle opere che la precedevano; e non senza i segni di una conflittualità, nel Maestro: con se stesso e con il librettista, per quella sua
recidiva tendenza a indurlo, proprio, in tentazioni cabalettistiche.
Al Ghislanzoni, da Sant’Agata, il 17 agosto 1970,Verdi aveva espresso
un’altra di quelle sue insofferenze cariche di presagi storici:
So bene che ella mi dirà: E il verso, la rima, la strofa? Non so che dire;
ma io, quando l’azione lo domanda, abbandonerei subito ritmo, rima,
strofa; farei dei versi sciolti per poter dire chiaro e netto quello che l’azione esige. Purtroppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti
e compositori abbiano il talento di non fare né poesia, né musica.
Verdi, per altro, allo stesso librettista, dice di non aver minimamente
paura delle cabalette in sé (in effetti gli hanno sempre dato tanta soddisfazione); purché esse siano drammaticamente appropriate.
In Aida si può ben dire che assistiamo alla riaffermazione della ‘forma
chiusa’, rispetto alle ricorrenti, libere e geniali ‘spezzature’ delle opere
precedenti. In quest’opera la forma mentis del Maestro si ripropone – con
il vigore di una seconda giovinezza – come eminentemente strofica, nel
momento stesso in cui essa si apre piú che mai a quel senso della «parola
scenica» che si enuncia come elemento paradigmatico del teatro verdiano. Ed è proprio nell’epistolario con il Ghislanzoni che la «parola scenica» si viene definendo: sia per le libere parti dialoganti e declamatorie
come per l’accentuazione delle piú tornite melodie strofiche.
Estrinseco alla natura di Verdi l’assillo della ‘continuità’ musicale, come
garanzia e pegno di unità, esso è un portato inquietante dei tempi
nuovi; laddove il genio eminentemente sintetico del Maestro avrebbe
teso a raggiungere – ha sempre raggiunto e raggiungerà – unità granitica in altri modi: per accostamenti, giustapposizioni (nel caso sovrapposizioni) di elementi distinti, ma dotati di un’intrinseca forza di coesione, di una reciproca calamitazione drammatica. E attraverso la funzione unificante della «tinta».
Ora, la tinta, in Aida, è eminentemente luce: luce solare, mediterranea;
o anche – nell’atto del Nilo – luce lunare: senza nubi e senza veli. È,
certo, anche tenebra: all’interno del tempio e nel sotterraneo – tomba,
93
Luciano Alberti
alla fine: una fine in pp. Eppure la rivelazione probabilmente piú sorprendente della Disposizione scenica di Aida fa emergere anche in Verdi
l’assillo di un’altra ‘continuità’: di una continuità a livello scenico.
L’incalzare dei «subito», degli «immediatamente» che scandiscono la
successione delle varie entrate dei personaggi, dei cori, dei figuranti e –
soprattutto – la successione dei quadri, all’interno degli atti bipartiti (il
I, il II e il IV atto) sono raccomandazioni dettate non soltanto dal terrore dei tempi morti – comunque funesti in teatro – ma da una ricerca
assai piú profonda: esse tendono a perseguire una suggestione emozionale di nuovo conio.
Che già il primo quadro si apra con quel dialogo tra Ramfis e Radamès
(«Sí, corre voce») come continuazione di un discorso avviato ‘dietro le
quinte’ è novità abbastanza sorprendente in un’opera eroica; la si direbbe mutuata piuttosto dal teatro drammatico borghese. Ed è novità, per
l’appunto, che risponde a un effetto di ‘continuità’.
Alla fine di quel primo quadro, l’uscita di Aida dopo il «Ritorna vincitor!» si risolve nell’invocazione «Numi pietà», che si perde dietro le
quinte: un do centrale filato, in pp. Dietro le quinte, su un morbido mi
bemolle – in una continuità armonica assoluta – attacca il canto della
Sacerdotessa: «Possente Fthà». Dalla sala luminosa siamo passati al buio
del Tempio di Vulcano. Per questo passaggio la Disposizione scenica ammonisce: «Un ritardo nel cambiamento di scena guasterebbe tutto l’effetto musicale».
Si deve escludere un mutamento a vista, perché la scena del primo quadro non può essere ‘corta’ (ha bisogno dell’agibilità di tutto il palcoscenico, come pure quella del secondo quadro). Quel che si chiede, dunque, è che il sipario (verisimilmente quello supplementare, il ‘comodino’, non il sipario aulico) si chiuda e si apra (ovvero si abbassi e si alzi)
nel minimo tempo possibile: il tempo per gli applausi dopo il «Ritorna
vincitor!» E già gli applausi disturberebbero – semmai gli applausi disturbano – «l’effetto musicale» in sé.
La partitura, dunque, punta su una vera e propria ‘dissolvenza’. E la dissolvenza del «Numi pietà» che si smorza e muore dietro le quinte, ripetendosi ulteriormente, vuol essere tratto caratteristico del personaggio di
Aida: suo Leitmotiv anche scenico. Si ripeterà in piena simmetria, nel II
atto, al passaggio – ancora – dal primo al secondo quadro: dall’appartamento di Amneris a «uno degli ingressi della città di Tebe». È l’itinerario
della principessa; la quale, appunto, seguita dalla schiava, esce per partecipare alla pompa trionfale di cui ora sono risuonati, lontani, gli appelli delle trombe e dei cori. Quella lontananza si fa primo piano; e anche questa
volta rapidamente. «Cambia scena subito»; ma la scena dell’appartamento
di Amneris era corta e a essa può seguire con facilità, interamente predisposta dietro di essa, una scena lunga: la grande scena del trionfo.
94
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
Dopo che i primi due atti erano divisi ciascuno in due quadri, il III è
tutto ‘atto del Nilo’. Il IV torna a riproporre una bipartizione. Ancora
una scena corta – la sala, luogo della disperazione di Amneris – cede alla
grande scena finale «divisa in due piani», orizzontalmente. In essa il
Tempio di Vulcano ricompare, ma sopraelevato sul corrispettivo sotterraneo. E, ancora una volta, «il cambiamento deve aver luogo subito». Ma
ecco che, a questo punto, avviandosi verso la conclusione, la drammaturgia dell’opera approfondisce e complica quell’effetto di continuità
scenica che fino a qui l’ha segnata, facendo corrispondere a essa un singolare senso di ‘contiguità’ logistica: logistica e temporale.
La sala da cui Amneris segue il processo e la condanna di Radamès ha da
pensarsi come un ambulacro del Tempio. Il processo ha luogo nel sotterraneo. I Sacerdoti passano per la sala, insieme con il tenore, per scendervi;
e per la sala essi ripassano, senza di lui, dopo la ferale condanna. L’idea di
far risalire i Sacerdoti in scena dal sotterraneo è tutta di Verdi. Cosí in una
lettera al Ghislanzoni (4 novembre 1870): «Io avrei un’idea che ella troverà forse troppo ardita e violenta… Farei ritornare in scena i sacerdoti,
ed a vederli Amneris come una tigre scaglierebbe contro Ramfis parole
acerbissime».
Radamès è lasciato nel sotterraneo, sepolto vivo. La «fatal pietra» viene
apposta sulla scala. Senza soluzione di continuità i Sacerdoti si raccolgono nel Tempio; dove le Sacerdotesse rinnovano le loro danze e Amneris
segue in preghiera.All’oscurità del Tempio si accorda il buio del sotterraneo, che ora viene rivelato agli occhi del pubblico. Qui Radamès
appare abbandonato sui gradini della scala, al di sotto della pietra che
l’ha chiusa per sempre. Su quei gradini egli e Aida, emersa dalle tenebre piú fitte, intonano il loro addio alla vita.
«Pace, pace»: ad Amneris spetta l’ultima parola dell’opera, su, in alto,
davanti all’altare, fra i tripodi da cui sale il fumo degli incensi. Là dove
la tradizione esecutiva ci ha abituati a un filato in pp su questo re basso
(secondo una suggestione musicale che partecipa quanto piú possibile
della purezza del canto richiesta ad Aida e a Radamès per il loro duetto),Verdi da Amneris, proprio in contrasto con quella purezza vocale, si
aspettava un’esclamazione «colla voce rotta dai singhiozzi e con accento straziante». La continuità temporale con la precedente agitatissima
scena postula il protrarsi della vibrazione drammatica.
Il fatto è che il personaggio di Amneris Verdi lo ha immaginato tutto percorso dalla tensione di una femminilità perennemente inquieta.
Nell’elenco dei personaggi la Disposizione scenica l’aveva indicata ventenne, coetanea di Aida (ma questa dell’età è una delle tante sfide che
dalla pagina scritta sogliono alzarsi alla realtà effettuale del palcoscenico); «molta vivacità, carattere impetuoso, impressionabile» sono i dati
psicologici della principessa. Dotata di «quel certo non so che che si
95
Philippe-Marie Chaperon, Interno del Tempio di Vulcano (fondale),
bozzetto per la prima di Aida al Cairo (atto IV, quadro I), 24 dicembre 1871
(1871; Parigi, Bibliothèque Nationale, Département de la Musique)
96
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
chiama comunemente avere il diavolo addosso» Verdi la dice in un’altra
lettera a Ricordi: è un’idea di donna (se non proprio un ideale) fin du
siècle. Ricordiamo: Tosca, il personaggio di Sardou, sarà tra i progetti
dell’ultimo Verdi; e Amneris vi si approssima di continuo, al limite di
una Sarah Bernhardt. È per Amneris che Verdi a un certo punto pensa –
e l’idea gli si presenta con l’eccitazione della grande trovata – a Teresa
Stolz. E del resto Amneris nasce ‘soprano’. Il passaggio della Stolz al
ruolo di Aida, comportando tra l’altro l’aggiunta di «O cieli azzurri»
(aria già tentata e poi esclusa, quindi portata a levigatissimo compimento in chiave di «idillio», di «odor d’Egitto» ma come «souvenir ai luoghi
natii», come «balsamo»), rientra nella forza delle vecchie convenienze
teatrali, nel preconcetto per cui il puro eroe-vittima sembrava appartenere a un rango piú alto dell’antagonista: ancora per poco.
Attorno al «Pace, pace» in pp di un’Amneris ormai irreversibilmente
mezzosoprano, la storia dell’interpretazione di Aida ha visto la falcidia
di altre originarie indicazioni verdiane. È chiaro: per il finale dell’opera il Maestro puntava su una piena spettacolarità. Non avendo potuto
collaudare la tenuta della sola presenza di Amneris sul piano sopraelevato del Tempio, questo era pensato gremito di sacerdoti e di sacerdotesse: gli uni immobili, le altre sempre danzanti. Della solitudine di
Amneris (vertice del triangolo imminente sulla coppia moribonda nel
sotterraneo-tomba) fa invece tesoro la messa in scena moderna di Aida,
che affida alla suggestione di ‘interni’ il canto dei sacerdoti e delle sacerdotesse.
La piena spettacolarità del finale comportava una massima mobilitazione scenotecnica. Per l’ultima mutazione la Disposizione dà la sezione in
profondità e lo schema frontale dello scenario. La divisione in due piani
comporta l’ingombro di una ‘costruzione’, nel gioco corrente delle tele
dipinte: quinte, principali, fondali; nella cui bidimensionalità si era tranquillamente (prospetticamente) disposta tutta la monumentale volumetria architettonica delle altre scene. Per esse, dunque, la prescrizione categorica – sempre cosí insistita – di mutazioni rapidissime rispondeva
all’ordine di una scenotecnica comune: purché – certo – lubrificata al
massimo.
La concezione scenografica novecentesca – volumetrica,‘costruita’, tridimensionale: sensibile alla nuova illuminotecnica, alla suggestione dei
tagli di luce – ha complicato indefinitamente il destino spettacolare di
Aida; ha finito per fare di quest’opera lo spettacolo da Arene per antonomasia: per teatri, appunto, i quali, per essere en plein air, mancano della
precipua disponibilità scenotecnica della tradizione pittorica ottocentesca: mancano della ‘soffitta’. È chiaro che in questo modo viene tradito
per l’appunto quel principio di continuità scenica (e alla fine anche di
97
Luciano Alberti
contiguità) sul quale l’illuminato e vigoroso riformismo del Verdi maturo contava: tanto piú ora, al punto di acuta sensibilizzazione nel confronto con Wagner.
Di giorno in giorno il confronto va facendosi collusione storica. Il
Lohengrin è rappresentato a Bologna il 1° novembre 1871; l’Aida va in
scena al Cairo il 24 dicembre. Si sa bene che Verdi assistette a una replica dell’opera wagneriana, in incognito solo nelle intenzioni: dal fondo
di un palco, tutt’orecchi e tutt’occhi, munito di spartito e di matita. Il
pubblico di Bologna lo vede e, mescolando al generale tripudio esterofilo clamori patriottici, lo applaude come anti-Wagner. Ancor piú patriottico, comprensibilmente, sarà il pubblico della Scala di lí a poco,
all’attesissima Aida.
In tutta la documentazione relativa alla preparazione di quest’opera –
Disposizione scenica in primis – Verdi appare impegnato nella cura di chi,
prima del duello, verifichi l’efficienza della propria arma: che assolutamente non abbia a incepparsi. «Se l’opera deve far fiasco, voglio che sia
per colpa mia, e non dell’esecuzione»: cosí a Ricordi, all’indomani della
puntata a Bologna. È un duello – Verdi lo sa bene – che trascende le
individualità e coinvolge due culture, due grandi tradizioni musicali,
due «razze».
Da una lettera di questi stessi giorni a Domenico Morelli:
Non dubitate però; l’ora del risveglio verrà, se dimenticheremo la frase
fatale «Noi siamo stati» e ci ricorderemo che siamo d’una razza, ed
abbiamo un sole, non voglio sapere se piú bello o piú brutto, ma diverso da quello che risplende di là dai monti.
Diverso… voi mi capite… Con questa parola voglio dire arte non forestiera, ma nostra, e dell’epoca nostra. L’artista che rappresenta il suo
paese e la sua epoca diventa necessariamente universale, del presente e
dell’avvenire.
Di continuo, gli scritti di Verdi, nella tensione di questi giorni, tendono
a sconfinare dal particolare all’‘universale’.Anche le pagine della Disposizione scenica: con il consueto contrappunto dell’epistolario coevo. E da
queste enunciazioni proprio il Finale di Aida lo vediamo assurgere al
ruolo di summa verdiana musicale-spettacolare.
Al Ghislanzoni, il 3 novembre 1870, il Maestro aveva scritto:
Cosí un cantabile un po’ strano per Radames, un altro a mezz’aria di
Aida, la nenia dei sacerdoti, la danza delle sacerdotesse, l’addio alla vita
degli amanti, l’in pace [sic] di Amneris formerebbero un insieme variato, bene sviluppato; e s’io posso musicalmente arrivare a legar bene il
tutto, avremo fatto una buona cosa, o almeno cosa che non sarà comune; siamo alle frutta; ella almeno.
98
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
Nella Disposizione scenica, per questa scena, a ribadirne il carattere sincretistico (verdiano al massimo: per sovrapposizione di elementi distinti), l’appello dell’ottimismo avveniristico scaturisce dall’aridità di una
nota tutta pratica, impegnata a precisare la dislocazione dei maestri di
palcoscenico per le varie, delicate mansioni:
Per tal modo si potrà assicurare una perfetta esecuzione musicale, per
quanto sembri difficile ottenere un insieme con tante suddivisioni di
parti, sempreché vi sieno persone istrutte, intelligenti ed amanti dell’arte: il che è a sperarsi si verifichi nei nostri teatri.
Infine:
E nel chiudere queste indicazioni sceniche, non posso ristarmi dal raccomandare a tutti coloro che sono preposti alla messa in scena, di non
trascurare ogni benché minimo dettaglio, per quanto sembrar possa
insignificante. Coi progressi attuali del dramma musicale, qualunque
movimento ha la sua ragion d’essere, e non sono permesse le antiche
convenzionalità sceniche.
Dalla Francia all’Italia, dal secondo Ottocento al primo Novecento (in
Italia, da Verdi a Boito, a Puccini, nell’ambito di Casa Ricordi; e da
Giordano a Leoncavallo e a Mascagni, in quello di Casa Sonzogno) le
Disposizioni sceniche rispondono a un assioma: tanto scontato ai loro
tempi quanto flagrantemente smentito ai nostri tempi. L’assioma era
quello secondo cui l’autore di un’opera si attendeva da parte dei metteurs-en-scène totale, tautologica fedeltà ai propri dettami (che erano poi
tutt’uno con i dettami del librettista).
Da questo punto di vista si può dire che il moderno interesse per le
Disposizioni sceniche – da trent’anni in qua – si sia suscitato fuori tempo
massimo: sia dunque tutto retrospettivo, storico, filologico, magari simpaticamente erudito; vivo, in quanto capace di farci penetrare nel cuore
delle idee, delle intenzioni, della poetica del compositore. È interesse
profondamente musicale. Resta pur sempre interesse specificamente
spettacolare; ma afferisce tutto alla storia dello spettacolo; non ha piú
alcuna possibilità di influenzare l’attuale interpretazione scenica, la concreta ‘visualità’ melodrammatica; evaporata la funzione che aveva occasionato i curiosissimi opuscoli.
Il loro primo destinatario – si è visto – era il direttore di scena (o régisseur); che per l’appunto la Disposizione scenica di Aida ci ha mostrato
investito di compiti progressivamente elevati. E tuttavia fatale fu il passaggio da quelle responsabilità ancora sempre al grado indotto – direttamente dal compositore, o comunque dal testo scritto: libretto, spartito, partitura – verso una sempre piú sicura libertà di iniziative persona-
99
Luciano Alberti
li, verso quella autonomia che i registi programmaticamente (quando
non sfrontatamente) via via si sono arrogati. È da tempo che essi aspirano alla ‘titolarità’ dell’evento interpretativo: quanto meno alla pari con
il direttore d’orchestra. Il peso specifico del quale – ancora nel passaggio dal XIX al XX secolo – per parte sua, era cresciuto a dismisura.
Intanto, dalla prima alla seconda metà del XX secolo, la storia dell’opera l’abbiamo vista volgere verso il proprio tramonto; un tramonto
anche ricco di bagliori (come si dice), ma sempre piú frastagliato di
nuovi sperimentalismi drammaturgici e spettacolari. La sintesi sommaria attraverso cui si procede tende semplicemente alla verifica di un’attualità: di un costume esecutivo, se vogliamo, quale ha finito per imporsi nella vita dei nostri teatri. Il regista d’opera moderno trova le maggiori chances alla propria professionalità nel passato; i suoi referenti, dunque, sono fantasmi. E se le partiture fanno sempre testo per i direttori
d’orchestra e per i cantanti, i libretti hanno finito per farne sempre meno; e meno che mai – all’interno di essi – le didascalie: azioni e ambientazioni.
Che lo scardinamento epocale sia stato determinato da Wagner è circostanza che ha imposto rilevazioni e riflessioni alquanto problematiche.
Sempre sommariamente:Wagner – rivoluzionario musicale consapevole
e calcolatissimo, e invece apprenti sorcier sul piano della messa in scena –
pretendeva anch’egli la fedeltà massima dai propri allestitori, nel teatro
che un re gli aveva messo a completa ed esclusiva disposizione. Solo che,
chiedendo loro – letteralmente – l’impossibile, dopo aver messo alle corde la scenotecnica e la sensiblerie spettacolare del suo tempo e ancora del
tempo della generazione a lui successiva (fino a tutta la reggenza di Cosima, nel sacrario di Bayreuth), ha visto la precipitosa fuga per la tangente
dei propri nipoti: per l’appunto registi,Wieland e Wolfgang Wagner, oltre
che reggitori del sacrario per lineare successione dinastica. E con loro, e
dopo di loro, la déluge.
Tuttavia, prima che il diluvio si generalizzasse sui palcoscenici operistici di tutto il mondo, e assai prima che la globalizzazione (ineludibile,
per forza, anche in questo campo) ingenerasse acquiescenze varie – le
piú ingenerose non di rado – proprio la storia della messa in scena
melodrammatica italiana aveva conosciuto un tempo felice di ‘fedeltà’.
Fu fedeltà che, per essere molto profonda, ebbe il grato sapore di novità
e il senso sorprendente di preziosi recuperi. Parliamo di quella che per
qualche lustro – tra gli anni Cinquanta e Sessanta – è potuta apparire e
affermarsi nel mondo come ‘scuola italiana’. Fu la scuola di Luchino
Visconti: per dire un nome in grado di compendiarla nelle sue variegature, nell’assunzione di qualche precedente e nella prospettiva di un
largo seguito. Fu scuola, in quanto partiva da un’idea e in quanto possedeva un metodo. E infatti ebbe molti adepti.
100
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
Né si può tacere il rammarico che l’approssimazione endemica della vita
culturale italiana, e di quella teatrale in specie, abbia impedito che essa
mettesse radici piú profonde e si istituzionalizzasse in vitale organicità. L’idea era di ordine storicistico: ritrovare quella che fu la ‘realtà’ degli antichi
spettacoli per verificarne la possibilità di una riproposta, o quanto meno
la forza di una suggestione che orientasse elaborazioni congrue ed eloquenti alla sensibilità e alla fantasia del nostro tempo. Il metodo era la documentazione: scandagli nel grande patrimonio dell’antica, gloriosissima
scenografia italiana e – oltre – negli orizzonti della storia dell’arte (e del
costume) prossimi nel tempo e nello spazio alle opere da rappresentare.
Né Visconti né i ‘viscontìdi’ ebbero modo di imbattersi in quei documenti capitali che sono le Disposizioni sceniche. Non c’è da dubitare che
le avrebbero lette con molta partecipazione.
Si può ora tornare alla nostra Aida. Nel 1963 Franco Zeffirelli firma lo
spettacolo di una grande Aida alla Scala. Già forte di una personale preparazione antiquaria (fiorentina), egli era partito come scenografo, costumista e aiutoregista di Visconti, ed era diventato ben presto scenografo-costumista-regista ‘in proprio’. Ora, per le scene e per i costumi
di questa Aida si vale di un’artista carissima all’entourage viscontiano:
Lila De Nobili, francese, connotata da un flou impressionistico, non lontano da certi esiti di Christian Bérard. Dirigeva Gianandrea Gavazzeni;
il cast era costituito da Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli e Nikolai Ghiaurov.
Fu uno spettacolo fatto di scene dipinte; che per altro, ovviamente, non
rinunciava ai ‘praticabili’. In particolare, alla scena del trionfo, si issarono alte e ripide tribune sia per la Corte faraonica che per i Sacerdoti.
Ma i volumi quasi si smaterializzavano nel colore: nel prezioso cromatismo dei costumi indossati dagli astanti, che occupavano quelle strutture. Nello scorcio del fondale era addirittura dipinta la folla accalcata
in lontananze polverose e dorate: ammiccamento toccante a un’antica
ingenuità scenica.
Invero, su tutto lo spettacolo aleggiava un garbato sentore ottocentesco:
cosí nei panneggi che incorniciavano le scene, come nei tendaggi di gusto orientale che in qualche caso ne costituivano la copertura; gli abiti
femminili d’alto rango esibivano sontuosi coulissons. Si respirava l’aria di
una pompa piú vicina alla corte di un Kedivè che non a quella di un
qualche remoto Ramsete. Uno straordinario dettaglio: la cosiddetta ‘danza dei Moretti’, nel boudoir di Amneris, suscitò il sussulto di una agnizione stilistica (musicale) esattissima, nello sfarfallio di quei costumi belle époque; a ballare erano ballerine, non piccole allieve della scuola di
danza tinte di nero. Fu quasi un ‘siero della verità’ in rapporto al Verdi
che – s’è visto – tanto sdegnosamente aborriva dal venir confuso con
Offenbach.
101
Luciano Alberti
Soprattutto, nell’Aida di Zeffirelli-De Nobili, l’uso delle scene dipinte
fece giustizia dei ripetuti tradimenti perpetrati dalle scene costruite, nel
senso che recuperò la fluida fedeltà alle intenzioni originarie verdiane,
quali emergono con tanta evidenza dalla nostra Disposizione scenica. Del
tutto indipendentemente dalla conoscenza di essa, dunque, si adempiva
l’imperativo nuovo e moderno di una continuità di rappresentazione.
In particolare, per la scena finale, orizzontalmente bipartita, si ricorse a
una soluzione tanto congrua quanto scenotecnicamente aggiornata: la
contiguità logistica e temporale presupposta in quel cambiamento di
scena si obiettivava con il sollevamento a vista del palcoscenico e con
la conseguente rivelazione del sotterraneo.Visibile anche, ed emozionante, l’operazione di chiusura, per via di argani, della «fatal pietra».
Ripreso trent’anni dopo, con poche varianti, all’Opera di Roma, lo
spettacolo ha riconfermato il proprio fascino: cosa rara, stante il fatto
che la vita naturale di una messa in scena – ancorché nata nel migliore
dei modi – in genere è assai piú breve.
Alle scene e ai costumi dell’Aida scaligera Zeffirelli aveva fatto parziale
ricorso anche nel film Il giovane Toscanini (il passaggio dal posto di primo
violoncello al podio, avvio della formidabile carriera direttoriale, si sa
bene che si verificò proprio in occasione di un’Aida, a Rio de Janeiro,
nel 1886:Toscanini diciannovenne).
Che poi – in tempi piú prossimi – lo stesso regista sia passato, sempre
per Aida, dal formato tascabile del Teatro di Busseto alla dilatazione
dell’Arena di Verona è fatto che dà la misura della sua brillante versatilità. Si accennerà solo che l’Aida di Busseto fu una scommessa al limite, giocata con disinvoltura; mentre l’Aida areniana (necessariamente
volumetrica, anzi modernamente ‘materica’) è entrata autorevolmente
nel destino che ha presieduto fin dal principio alla conversione melodrammatica dell’insigne monumento romano. È storia famosa: quella
fortunatissima conversione avvenne con Aida esattamente novantadue
anni or sono.
1
Fondamentale, per le citazioni dall’epistolario verdiano – per questa come per le altre del presente studio – in quanto organizzate entro l’ampio racconto della genesi di Aida, resta il III volume del Giuseppe Verdi di Franco Abbiati (Ricordi, Milano 1963).
2
Cfr. Gino Roncaglia, Galleria verdiana, Curci, Milano 1959.
Cfr. Saleh Abdoun, a cura di, Genesi dell’«Aida», «Quaderni dell’Istituto di studi verdiani», 4,
Parma 1971; Ursula Günther, Zur Enstehung von Verdis «Aida», «Studi musicali», rivista dell’Accademia di Santa Cecilia, II, Roma 1973, n. 1; Philip Gossett, Verdi, Ghislanzoni and «Aida»:The Uses
of Convention, «Critical Inquiry», rivista della Chicago University, I, n. 2, 1974.
4
Cfr. Luciano Alberti, «I progressi attuali [1872] del dramma musicale». Note sulla Disposizione scenica dell’opera «Aida», in Nino Pirrotta, Marcello Conati, a cura di, Il melodramma italiano
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, Einaudi,Torino 1977.
3
102
Aida: le rivelazioni di un’antica Disposizione scenica
5
Fedele. D’Amico, Sessantacinque anni, che Melodramma, «L’Espresso», 12 giugno 1977; anche in F.
D’Amico, Tutte le cronache musicali, II, «L’Espresso» 1967-1989, Roma 2000.
6
Casa Ricordi, sotto la dizione «Musica e Spettacolo» viene pubblicando una Collana di Disposizioni sceniche diretta da Francesco Degrada e Mercedes Viale Ferrero. Si indicano qui i volumi dedicati a opere di Verdi: James A. Hepokoski, Mercedes Viale Ferrero, Otello, Ricordi, Milano 1990;
Marcello Conati, N. Grilli, «Simon Boccanegra» di Giuseppe Verdi, Ricordi, Milano 1993; David
Rosen, Marinella Pigozzi, Un ballo in maschera, Ricordi, Milano 2002.
7
Casa Sonzogno, nel primo dei due volumi dedicati alla propria storia (Mario Morini, Nandi
Ostali, Piero Ostali jr., a cura di, Casa Sonzogno, I, Testimonianze e Saggi. Cronologie, Casa Musicale
Sonzogno, Milano 1995), ha pubblicato lo studio di Luciano Alberti, Le Messe in Iscena di Casa
Sonzogno.
103