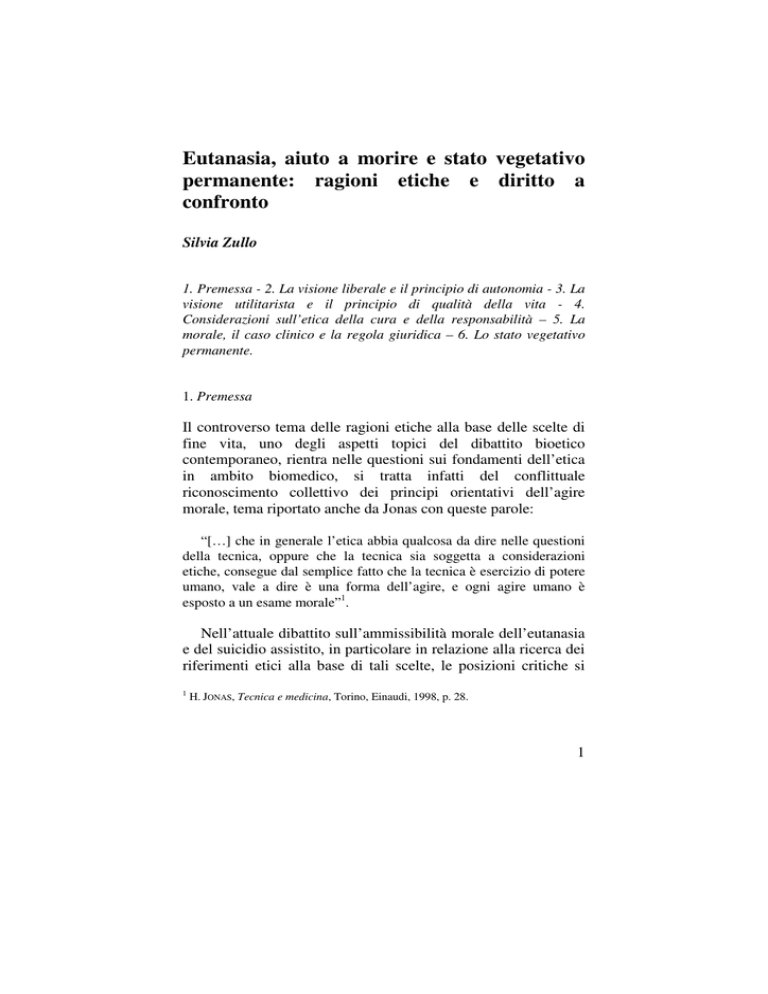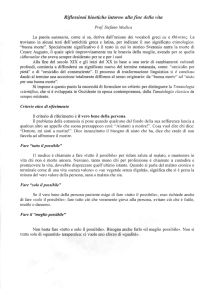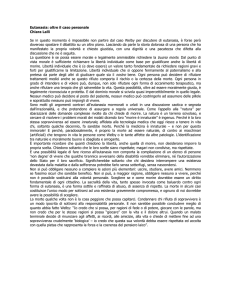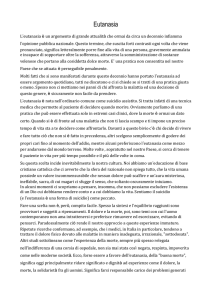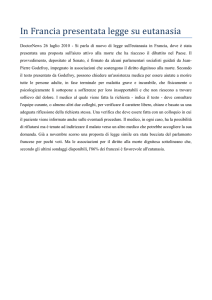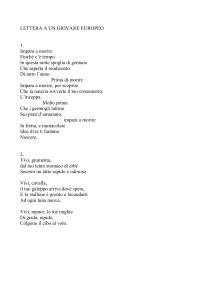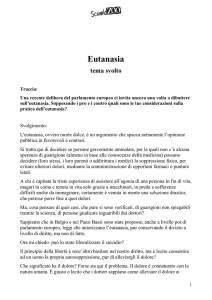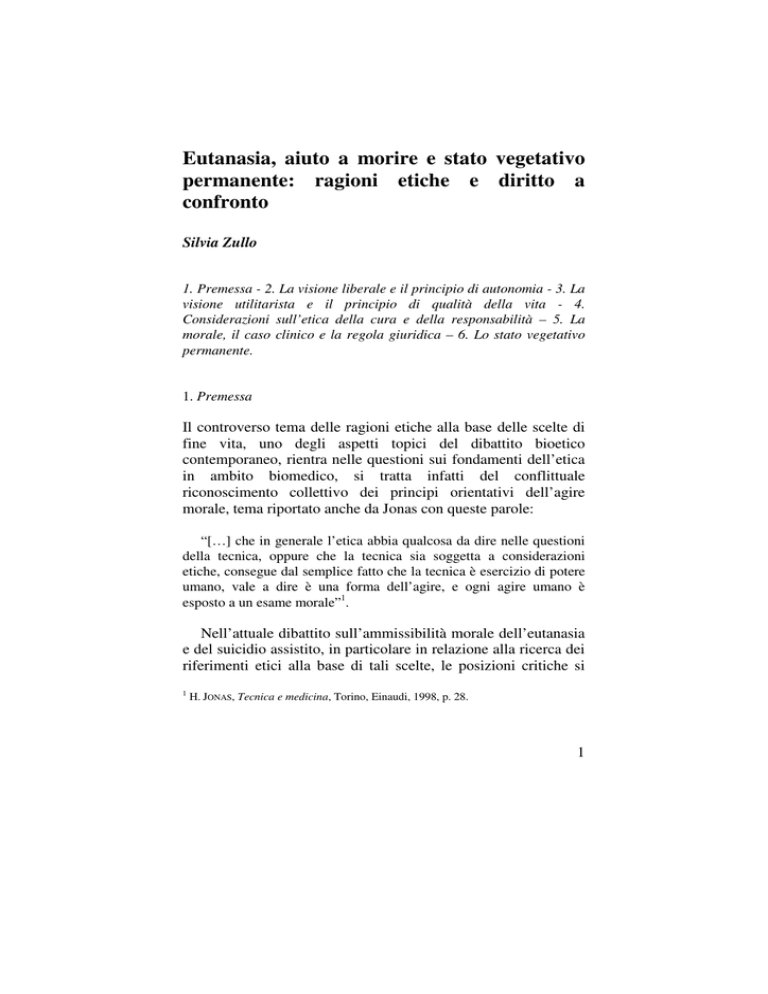
Eutanasia, aiuto a morire e stato vegetativo
permanente: ragioni etiche e diritto a
confronto
Silvia Zullo
1. Premessa - 2. La visione liberale e il principio di autonomia - 3. La
visione utilitarista e il principio di qualità della vita - 4.
Considerazioni sull’etica della cura e della responsabilità – 5. La
morale, il caso clinico e la regola giuridica – 6. Lo stato vegetativo
permanente.
1. Premessa
Il controverso tema delle ragioni etiche alla base delle scelte di
fine vita, uno degli aspetti topici del dibattito bioetico
contemporaneo, rientra nelle questioni sui fondamenti dell’etica
in ambito biomedico, si tratta infatti del conflittuale
riconoscimento collettivo dei principi orientativi dell’agire
morale, tema riportato anche da Jonas con queste parole:
“[…] che in generale l’etica abbia qualcosa da dire nelle questioni
della tecnica, oppure che la tecnica sia soggetta a considerazioni
etiche, consegue dal semplice fatto che la tecnica è esercizio di potere
umano, vale a dire è una forma dell’agire, e ogni agire umano è
esposto a un esame morale”1.
Nell’attuale dibattito sull’ammissibilità morale dell’eutanasia
e del suicidio assistito, in particolare in relazione alla ricerca dei
riferimenti etici alla base di tali scelte, le posizioni critiche si
1
H. JONAS, Tecnica e medicina, Torino, Einaudi, 1998, p. 28.
1
sono pronunciate secondo diversi approcci al problema. In
questa analisi verranno prese in considerazione le teorie liberali,
la visione utilitarista e un ultimo sguardo sarà dedicato alla
prospettiva socio-culturale del “prendersi cura” e all’etica della
cura. Le teorie liberali, seppur divise al loro interno da posizioni
differenti, sono accomunate dalla difesa del principio di
autonomia dell’individuo. Le tesi dell’utilitarismo, che si
ramifica anch’esso in forme diverse e spesso contrastanti, sono
sostenute dal principio di beneficenza, un principio assoluto da
cui dipendono i principi del danno, del rispetto dell’autonomia e
della giustizia. L’etica della cura, incentrata su premesse
psicologiche e sulla relazionalità, ha trovato un terreno fertile
nelle questioni bioetiche di fine vita, nonostante la difficoltà di
questo approccio nel conciliare la parzialità della sua prospettiva
di indagine con linee adottabili in un contesto pluralistico.
Nel dibattito bioetico contemporaneo sulle scelte di fine vita
1'analisi di singoli casi controversi, corre il rischio di diventare
una collezione di opinioni se non si assumono norme, principi o
prospettive di indagine intorno al problema. Se un pericolo è
rappresentato dal decisionismo, che annulla i principi universali
nel pluralismo delle decisioni, l’altro pericolo è quello del
fondamentalismo, che afferma l’unità dei principi sino al punto
da rendere del tutto impossibile la pluralità delle decisioni. La
complessa decifrazione di questo scenario è rafforzata dalla
particolarità delle situazioni concrete, dinanzi alle quali le regole
universali spesso cadono. Si pensi, nella fattispecie, alle
esperienze della sofferenza, della morte e del morire, le più
individuali e meno generalizzabili di tutte.
Il dibattito sulle implicazioni etiche e giuridiche di fine vita è
alquante acceso anche in riferimento ai casi di stato vegetativo
permanente. Tale dibattito è iniziato a partire degli anni ’70 con
il noto caso americano di Karen A. Quinlan, una donna tenuta in
stato vegetativo tramite alimentazione e idratazione artificiali
dal 1975 e che morì nel 1985. Precedentemente, nel 1976, i
genitori della donna avevano ottenuto la sospensione della
ventilazione artificiale, in quanto mezzo straordinario, ma la
paziente aveva iniziato a respirare autonomamente e non era
morta. Alimentazione e idratazione invece vennero considerati
2
mezzi ordinari di sostentamento e così furono erogati fino alla
fine. Nancy Cruzan visse una vicenda analoga: entrata in coma
nel 1983, venne tenuta in vita tramite idratazione e
alimentazione artificiali (la respirazione era autonoma). Nel
1990 lo Stato del Missouri accolse la richiesta di sospendere il
trattamento,in quanto molti amici della donna testimoniarono
che Nancy aveva più volte espresso in vita il desiderio di morire
nel caso in cui si fosse trovata in una situazione del genere. In
Italia il dibattito si è accesso in seguito al caso di Eluana
Englaro, una ragazza entrata in coma nel 1992 e tutt’oggi
alimentata e idratata artificialmente. Il padre ha più volte chiesto
di sospendere i mezzi di prolungamento e consentire alla
ragazza di morire, ma i tribunali si sono sempre opposti.
Tenendo in considerazione i casi sopra menzionati, in questa
riflessione si farà riferimento anche al complesso e problematico
ruolo del diritto nelle decisioni di fine vita: le leggi, nell’attuale
dibattito, sono chiamate a farsi carico dell’imprescindibile
rapporto tra etica e diritto, infatti, nella scelta di dare la morte a
una persona che soffre e chiede di morire si impongono due
volontà ugualmente imperative, il medico, che ha il dovere
fondamentale di tutelare la vita, e il paziente, che reclama la sua
capacità di autodeterminazione.
3
2. La visione liberale e il principio di autonomia
Nella prospettiva liberale, l’attenzione è rivolta al valore della libertà e
dell’autonomia dell’individuo. Il principio di autodeterminazione o di
autonomia è alla base delle scelte etiche di fine vita in quanto garanzia
delle decisioni individuali. Tuttavia, come suggerisce Maffettone, il
principio di autonomia riconosce la capacità delle parti di darsi da sole
la loro norma di comportamento, ma rimane neutrale sulle
conseguenze di questi comportamenti2. Infatti, nonostante l’enfasi
posta sul concetto di autonomia, si riconosce che quest’ultima può
essere violata in alcuni casi, qualora le parti da sole agiscano contro
l’interesse pubblico o quello proprio o di altre parti. Per esempio, nelle
teorie politiche di Rawls3 e di Nozick4, si muove dalla libertà
individuale di scelta e si perviene alle sue limitazioni in nome delle
conseguenze che questa potrebbe generare. Il conflitto interno alla
prospettiva liberale riguarda proprio le diverse visioni che si hanno del
concetto di persona e del concetto di società. Se la libertà, in
quest’ottica, costituisce la qualifica della natura umana, non per
questo è automaticamente etico tutto ciò che favorisce qualsiasi tipo di
libertà solo perché “liberamente scelto”. L’autonomia e la
responsabilità non significano indipendenza da qualsiasi regola
naturale, morale o civile. Vi sono degli obblighi, morali e politici
poiché i casi conflittuali della bioetica dimostrano che il diritto alla
libertà e all’autonomia è condizione necessaria, ma non sempre
sufficiente affinché l’atto sia morale, cioè conforme alla dignità di chi
lo compie e di chi lo subisce. Per esempio, il diritto alla libertà risulta
invalido quando non rispetta la vita e la libertà altrui.
Uno dei tentativi di teorizzare la prospettiva del principio di
autonomia e dell’etica contrattualistica, è dato da Engelhardt.5. Il
principio del permesso di Engelhard fonda la morale dell’autonomia e
del rispetto reciproco. In questo contesto avviene il passaggio da un
2
Per un approfondimento si veda S. MAFFETTONE, Il valore della vita. Una
interpretazione filosofica pluralistica, Milano, Mondadori, 1998.
3
J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982.
4
R. NOZICK, Anarchia, Stato, Utopia. I fondamenti dello Stato minimo, Milano, Il
Saggiatore, 1999.
5
Per un approfondimento della concezione morale di Engelhardt, si rimanda a H.T.
ENGELHARDT, Manuale di bioetica, trad. it. di R. Rini, Milano, Il Saggiatore, 1991.
4
concetto di autonomia, pensato all’interno del soggetto, ad un
permesso esterno al soggetto. Si tratta del passaggio da una libertà
intesa come valore ad una libertà intesa come vincolo. La stessa
concezione della persona di Engelhardt è intesa attraverso la capacità
di intendere e di volere, di dare e di ricevere consenso. Perché ci sia
persona occorre, infatti, che ci sia autocoscienza razionale, libertà e
moralità. In quest’ottica, il ragionamento di Engelhardt legittima il
diritto di non ricevere un trattamento, come pure il diritto di
sospenderlo. Inoltre, in quest’ottica vengono a cadere le distinzioni tra
atti e omissioni, tra uccidere e lasciar morire. Egli sostiene che queste
distinzioni hanno motivo di esistere solo all’interno di dottrine
specifiche, mentre fuori da un particolare contesto religioso o morale,
le differenze tra intenzione e previsione, eutanasia attiva e passiva,
cessano di avere un significato morale intrinseco. Tutti i casi sono
legittimi in una società pluralista, purché rispettino la libera scelta
dell’individuo. Detto questo, diviene irrilevante il modo in cui le
scelte siano soddisfatte, se con l’azione o con l’aiuto di un terzo, se
con un atto o con un’omissione. La libera scelta degli individui
competenti porta alla legittimità dell’eutanasia volontaria, mentre
viene esclusa soltanto l’eutanasia involontaria. Nell’ambito della
visione liberale, si sono espressi alcuni dei massimi esponenti di
questo paradigma: R. Dworkin, T. Nagel, R. Nozick, J. Rawls, T.
Scanlon e J. Thomson (si presentano come gli Amici Curiae). Secondo
tali pensatori, i casi di eutanasia, nella prospettiva della politica
pubblica, non richiedono giudizi morali, etici, o religiosi a proposito
di come le persone dovrebbero affrontare o confrontare con la propria
morte. Ciò che si deve riconoscere, invece, è che ogni individuo ha un
forte interesse, che comporta un corrispondente diritto, affinché gli sia
concesso di esprimere il suo giudizio su questi problemi. Le istituzioni
devono poter limitare la libertà dell’individuo, quando il desiderio di
accelerare la morte sia irrazionale o sia espresso sotto pressione o in
virtù di informazioni sbagliate. Ma costringere a un’ esistenza che i
malati terminali reputano intollerabile può essere giustificato
solamente sulla base di convinzioni etiche a proposito del valore o del
significato della vita stessa: “In una società libera gli individui devono
avere l’opportunità di prendere queste decisioni per se stessi, in
accordo con la propria fede, coscienza e convinzione” (The
5
Philosopher’s Brief)6. Le persone con visioni morali differenti
possono attribuire un diverso valore e significato alla vita e, alla luce
di quanto detto, nessuno di questi punti di vista può essere definito
irrazionale e quindi nessuna costrizione a loro danno può essere
legittima. In tale modo gli Amici Curiae difendono la legittimità
dell’eutanasia e del suicidio assistito. Essi concludono affermando che
lo Stato non può decretare un divieto generalizzato del suicidio
assistito e dell’eutanasia. Come si può vedere la proposta liberale si
riferisce a quella che deve essere una normativa pubblica
sull’eutanasia. Tale approccio è stato esposto e difeso anche dal
filosofo americano contemporaneo Ronald Dworkin. Il filosofo prende
in esame i casi in cui il soggetto in stato di non consapevolezza si
trovano in condizione di poter sopravvivere a lungo anche senza il
supporto medico. La richiesta di sospendere i sostegni alle funzioni
vitali può provenire dai familiari e uno dei problemi morali, che si può
presentare a questo punto, è la discordanza di atteggiamenti tra lo stato
attuale dell’ammalato, privo delle facoltà intellettuali, e il desiderio di
morte espresso nel pieno possesso delle facoltà. Che cosa deve
prevalere? Dworkin, similmente agli Amici Curiae, ritiene che la
preoccupazione per il rispetto dell’autonomia è fondamentale anche
quando le persone non sono in stato cosciente, in questo caso ci si
deve chiedere che cosa avrebbe deciso la persona stessa prima di
perdere coscienza. Nell’opinione di Dworkin, si può risolvere il
problema dell’interpretazione dei desideri di una persona pensando
all’insieme della sua vita. Si tratta di riconoscere come la persona
stessa ha strutturato la sua vita e quindi di permetterle di morire in un
modo coerente con questo modello. Qui, l’argomento che porta
Dworkin a differenziare la sua posizione all’interno del dibattito è
quello inerente al miglior interesse. Per determinare il migliore
interesse di una persona bisogna assegnare la dovuta cura all’effetto
dell’ultima fase della sua vita, sul carattere della sua vita nell’insieme,
così come “assegneremmo la dovuta cura all’effetto dell’ultima scena
6
Il documento degli Amici Curiae, in cui viene sollecitata la Corte Suprema degli
Stati Uniti a riconoscere il diritto del malato terminale di essere aiutato a morire, è
pubblicato nella versione italiana sull’inserto speciale, dal titolo Suicidio assistito: la
memoria dei filosofi, in «La Rivista dei libri», 7/8 luglio-agosto (1997), p.43.
6
di una rappresentazione”7. In una tale prospettiva, la scelta va
concessa a ciascun individuo, poiché diversi sono gli ideali di vita, e
quindi diverse le modalità nelle quali strutturare anche gli ultimi
momenti della propria esistenza. La conclusione di Dworkin è che
“anche il rispetto della beneficenza, oltre a quello dell’autonomia,
sostiene che lo Stato non deve imporre alcuna visione uniforme e
generale per il tramite di una legge sovrana”8. Dunque,
rappresenterebbe un danno alla libertà dell’individuo il fatto di
imporgli un sistema di valori, di obbligarlo a seguire una ragione che
dia valore (renda sacra) alla vita. Anche quando l’individuo ha perso
le proprie facoltà intellettuali, il diritto all’autonomia deve essere
rispettato in relazione alla persona che l’individuo era prima di
perdere le proprie capacità. Come si è visto, agire nei confronti di
questo individuo in modo contrario a quello che era lo schema
complessivo della sua vita, vuol dire intaccare la sua dignità. Da
questa prospettiva, deriva, di conseguenza, il fatto che non si ha
rispetto della dignità della persona se si infrangono i suoi desideri
precedenti alla perdita delle facoltà intellettuali. L’importante è che il
modo di morire sia conforme all’espressione della personalità del
soggetto che si manifesta negli atti finali della sua esistenza. E’ il
concetto di autonomia come integrità.
In generale, una critica rivolta alla visione liberale nel campo
dell’eutanasia e del suicidio assistito, riguarda il concetto di
autonomia invocato che sembra essere fittizio. I soggetti interessati,
infatti, non sarebbero in grado di esercitarla veramente, a causa del
rischio sociale implicito nel concetto di autonomia. Infatti si potrebbe
pensare che l’invocazione dell’autonomia del morente sia guidata
dalla volontà di promuovere una morale orientata ad un certo
funzionalismo, secondo la quale la vita di un individuo, che dipende
dalla cura di altri, diviene non dignitosa. Affinché la scelta sia
autonoma nel senso liberale, una scelta che esprima veramente la
capacità deliberativa della persona, è necessario che questa sia fatta
senza l’oppressione di una società che è condizionata dalla presenza
del morente, sia perchè questi può essere sentito come un peso
emotivo o finanziario, sia perché può intralciare una concezione
7
Per un approfondimento dell’argomento del miglior interesse si rimanda a R.
DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Milano,
Edizioni di Comunità, 1994.
8
Ibidem, p. 212.
7
morale efficientistica. In questo senso il paradigma liberale, secondo
la critica di parte opposta, dovrebbe orientarsi verso una riforma della
giustizia distributiva, grazie alla quale maggiori mezzi vengono
destinati ai malati terminali, quale parziale rimedio alla loro difficile
situazione e affinché abbiano una reale facoltà di scelta.
Emergono in quest’ottica di indagine tutte le difficoltà di fare
dipendere tutta la vita etica da una concezione in cui l’autonomia di
una persona è legata alla capacità di svolgere complicate attività
razionali. Muovendo da questa concezione razionalistica dell’agente
morale, molti studiosi hanno notato che le difficoltà nascono, non solo
quando si tratta di valutare se un soggetto che sottoscrive la carta di
autodeterminazione ha la competenza razionale per farlo, ma ancora di
più quando si tratta di stabilire se in uno stadio successivo la stessa
persona abbia l’autorità per annullare una deroga precedentemente
manifestata. E, in luogo della posizione razionalistica assunta da
Dworkin, si può notare che viene fatta valere una più ridotta
concezione dell’agente morale, assunto nei termini della capacità di
esprimere in modo comprensibile preferenze sulla propria vita. Per
superare le difficoltà a cui va incontro il tentativo di dedurre soluzioni
da un principio di salvaguardia assoluta dell’autonomia razionale
dell’agente (difficoltà dovute al fatto che in molte occasioni le persone
coinvolte non possono essere ricondotte alla descrizione di persona
razionale, presupposto da questa teoria come unico requisito
adeguato), il dibattito attuale è incline a rivolgere l’attenzione
sull’universo dei pazienti morali, verso cui un trattamento morale è
comunque doveroso, anche laddove essi abbiano perso o non abbiano
mai avuto la competenza per essere moralmente responsabili. Tenendo
conto di questo tipo di pazienti morali, viene contestato, dalla critica
contemporanea, il principio di autonomia morale assunto da chi
auspica la diffusione delle carte di autodeterminazione come unico
fondamento di validità etica. Questo genere di contestazione è
riconoscibile nelle critiche di coloro che denunciano le carte di
autodeterminazione, in quanto il loro limite starebbe nel postulare una
forma di autonomia e di indipendenza individuale che è praticamente
irrealizzabile e che comporta una concezione egoistica e ristretta della
vita morale. Critiche più direttamente normative sono mosse poi da
etiche differenti, che denunciano la negatività di una concezione
morale che in realtà ipotizza un agente astratto, privo di relazioni e di
affetti. Va rilevato, d’altro canto, che l’argomento dell’autonomia
raccoglie la maggioranza dei consensi all’interno del dibattito attuale
8
sull’eutanasia e, nonostante i limiti applicativi sopra elencati, è il solo
argomento a soddisfare requisiti minimi di universalità. Tuttavia, è
opinione largamente condivisa, nel tentativo di ovviare ad alcuni dei
suoi limiti applicativi, collocare il principio di autonomia individuale
all’interno di una concezione morale più ampia, che la giustifichi e ne
definisca la natura, non in termini di completa indipendenza, ma di
responsabilità. Si è ormai riconosciuto, infatti, che tale principio, non
può essere considerato come un dato acquisito nella vita etica delle
persone, ma piuttosto una componente di una più ampia prescrizione
etica, che raccomanda di creare le condizioni in cui effettivamente le
persone divengano più autonome.
3. La visione utilitarista e il principio della qualità della vita
Un aspetto ulteriore mediante cui si può rendere conto delle diverse
visioni etiche circa la pratica dell’eutanasia e del suicidio assistito è
dato dallo scontro tra etica utilitaristica ed etica deontologica, tra il
dovere di considerare le conseguenze delle proprie azioni e,
contemporaneamente, gli obblighi dettati dal codice deontologico
della professione medica, per cui è dovere imprescindibile del medico
difendere sempre e comunque la vita. Secondo l’approccio
utilitaristico, non esiste alcun bene assoluto tale da imporre un forte
vincolo al rispetto di esso. Ogni bene possiede sempre un valore
relativo dipendente da circostanze e situazioni. Anche la vita del
singolo individuo non ha un valore tale da impedire, per esempio, la
violazione della regola “non uccidere”, quando la morte possa
costituire un beneficio per un gruppo di soggetti. Completamente
diversi sono gli assunti dell’etica deontologica, dove i principi morali
sono prescrizioni universali, non semplicemente generalizzazioni
descrittive. Il principio di sacralità della vita, ad esempio, si rifà a
componenti di tipo deontologico.
L’argomento utilitarista, a favore dell’eutanasia, si fonda sul
principio di beneficenza o della qualità della vita. Esso riconosce un
ruolo rilevante all’autonomia dell’individuo e alla soddisfazione dei
suoi interessi. Tuttavia, i sostenitori del principio che fa leva sulla
qualità della vita ritengono che il principio di autonomia possa
contrastare con il principio utilitarista. Il problema si pone quando si
esercita la scelta per altri, nei casi di eutanasia non volontaria. In
questo caso, la dottrina della qualità della vita adotta come soluzione il
9
criterio utilitarista più classico. Le decisioni devono essere sempre
motivate dalla massimizzazione dell’utilità. Hare, nella sua opera, Il
pensiero morale, sostiene che la scelta morale ideale è sempre quella
dell’utilitarismo dell’atto9,cioè, in ogni caso specifico, si dovrebbe
fare il calcolo utilitarista delle migliori conseguenze e optare per la
soluzione individuata. Quello che occorre fare, dice Hare, è sviluppare
delle disposizioni che nell’insieme ci portino a massimizzare l’utilità.
Gli utilitaristi, in linea generale, rappresentano i critici più rigorosi del
principio di sacralità della vita in quanto sostengono la liceità morale
dell’interruzione della vita al fine di non arrecare sofferenze inutili
all’individuo. Se è così, vi sono senz’altro casi in cui l’eutanasia
volontaria, ossia richiesta da una persona competente e informata,
appare moralmente non controversa. Infatti:
“I pazienti terminali talvolta soffrono dolori così terribili da essere
a stento compresi da chi non li ha mai provati. Le loro sofferenze
possono essere così terribili che non ci piace nemmeno leggerne o
pensarci; rifuggiamo persino dalla loro descrizione. L’argomento della
pietà dice: l’eutanasia è giustificata perché mette fine a questo”10 .
Questo argomento, nelle sue formulazioni più rigorose, riprende le
idee centrali dell’utilitarismo, alla luce dei suoi sviluppi
contemporanei. Come ad esempio, la seguente formulazione: se
un’azione promuove gli interessi di tutti quelli che vi sono coinvolti,
allora quell’azione è moralmente accettabile; almeno in alcuni casi,
l’eutanasia promuove gli interessi di tutti quelli che vi sono coinvolti;
pertanto, almeno in alcuni casi, l’eutanasia è moralmente accettabile.
La distinzione tra un modo passivo e un modo attivo di soppressione
del paziente costituisce il primo punto di attacco alla posizione
tradizionale, ovvero al principio di sacralità della vita, da parte degli
utilitaristi, i quali affermano che un atto di uccisione diretto è
moralmente equivalente all’omissione di un atto in grado di salvare la
vita. In quest’ottica, non è moralmente rilevante se il medico lasci
morire il paziente sottraendogli delle cure o se gli inietti una sostanza
letale, ma piuttosto se l’esito mortale costituisca un beneficio per il
9
R.M. HARE, Il pensiero morale. Livelli, metodi, scopi, trad. it. di S. Sabattini,
Bologna, Il Mulino, 1989.
10
J. RACHELS, La fine della vita, Torino, Sonda, 1989, p. 160.
10
paziente oppure no. Infatti, la regola che vieta di uccidere non ha lo
scopo di tenere in vita esseri umani innocenti, ma quello di proteggere
le vite e gli interessi che alcuni individui hanno in virtù del fatto che
sono soggetti di una vita. Rachels, ad esempio, distingue, in proposito,
tra “essere vivi” e “avere una vita”; quest’ultima espressione indica la
vita in senso biografico, cioè l’insieme dei progetti, aspirazioni,
relazioni che costituiscono l’esistenza. Pertanto, secondo Rachels, non
tutti i viventi, hanno una vita in senso biografico. Perciò, quando non
vi è più una vita in senso biografico, la morte può costituire un bene
per chi muore e non è importante il modo nel quale l’esito viene
raggiunto. Anzi, una volta ammesso che la morte sia un beneficio,
l’eutanasia attiva è preferibile alla sospensione delle cure, perché
realizza l’obiettivo più rapidamente, minimizzando le sofferenze.
L’autore sostiene che l’intenzione che spinge un soggetto a compiere
un’azione non ha rilevanza nella valutazione della moralità dell’azione
compiuta. Da questa premessa, Rachels deriva la sua teoria
dell’equivalenza morale tra uccidere e lasciar morire. Eutanasia attiva
e eutanasia passiva sono due azioni analoghe dal punto di vista
morale, in quanto egli valuta esclusivamente le conseguenze
rispettivamente dell’azione e dell’omissione. La critica più frequente,
mossa a questo tipo di argomentazione, riguarda proprio l’incoerenza
circa l’aspetto intenzionale. Infatti, la scissione tra valutazione
dell’agente e valutazione dell’atto, conduce ad un’incoerenza di fondo
tra azione e omissione. Se si afferma che un atto non può essere giusto
o sbagliato in rapporto alle diverse intenzioni con cui viene fatto, non
si può poi ricorrere alle motivazioni dell’agente per equiparare azione
e omissione. Questo aspetto dovrebbe essere rilevante per la
valutazione degli agenti, ma irrilevante per la valutazione dell’atto:
infatti, l’intenzione non è rilevante per decidere se l’atto è giusto o
sbagliato, ma invece è rilevante per stabilire il carattere della persona
che lo compie, che è un problema diverso e non può essere invocato
per stabilire l’equivalenza tra azione e omissione.
Sempre a proposito della distinzione tra uccidere e lasciar morire,
un’altra linea di attacco al principio di sacralità della vita è stata
avanzata da Helga Khuse, secondo la quale il lasciar morire è un
omissione intenzionale, si tratta infatti di astenersi volontariamente dal
salvare qualcuno che si ha la capacità e l’opportunità di salvare, per
cui la distinzione tra fare qualcosa e non fare nulla, o tra eseguire certi
11
movimenti e non eseguirli, non sussiste11. Nella distinzione, nota
Khuse, l’unica differenza rilevante tra uccidere e lasciar morire è
quella del differente ruolo causale assunto dall’agente, ma non si trova
alcuna spiegazione ragionevole del perché “far accadere” debba
comportare una responsabilità morale diversa rispetto a “lasciar
accadere”. Pertanto, nelle fasi terminali della malattia, l’interruzione
dei trattamenti è moralmente equivalente alla soppressione
intenzionale del paziente e, quando la morte è un beneficio,
determinarla attivamente risparmia ulteriori sofferenze. Secondo la
critica, Khuse adotta un concetto troppo ampio di causa, che si
confonde con quello di condizione, infatti l’aspetto pertinente della
sua ricostruzione è che per spiegare completamente un evento non
basta individuarne la causa, ma occorre menzionare una serie di altre
condizioni che consentano di determinare gli effetti e lo sfondo su cui
la causa ha agito. Molte di queste condizioni sono necessarie, perché
se venissero a mancare la causa non produrrebbe i suoi effetti, perciò
si può dire che tali condizioni, dice Khuse, con-causano l’evento.
Tuttavia, non distinguendo tra condizioni e cause di un evento, la tesi
di Khuse, a giudizio di molti, aumenta enormemente il numero di
elementi che possono essere citati come cause, rendendo arbitraria la
definizione stessa della causa. Un altro argomento tradizionale per
giustificare atti che determinano effetti negativi, come la morte di un
individuo, è il principio del duplice effetto. L’intenzionalità qui si
identifica con le conseguenze che il soggetto desidera e ricerca come
proprio fine o come mezzi per il proprio fine, ma esclude le
conseguenze che l’agente si limita a prevedere. In base al principio del
duplice effetto, un atto che abbia anche un effetto negativo può essere
giustificato a condizione che vi sia un’adeguata proporzione tra i due,
ossia che l’effetto buono sia sufficientemente desiderabile da
compensare quello cattivo. La critica al principio del duplice effetto è
stata oggetto di particolare attenzione anche da parte di Khuse. In
riferimento ai casi di eutanasia, secondo Khuse, il medico che pratica
un’iniezione letale al proprio paziente lo uccide intenzionalmente non
più di quanto non lo faccia il medico che lo lascia morire sottraendogli
le terapie di sostegno vitale; entrambi i medici intendono alleviare la
11
La distinzione tra uccidere e lasciar morire, di primaria importanza per gli
utilitarista è resa esplicita da Khuse in A Companion to Bioethics, a cura di H. KHUSE,
P. SINGER, Oxford, Blackwell, 1998.
12
sofferenza dei loro pazienti ed evitare trattamenti sproporzionati. Non
si può dire che il medico, che pratichi un’iniezione letale a un paziente
morente, voglia la morte del paziente, mentre quello che gli sottrae
terapie sapendo che ciò lo porterà alla morte non la voglia. Entrambi,
osserva Khuse, la vogliono in senso condizionale: benché nessuno dei
due desideri questo esito di per sé, in entrambi i casi esso si presenta
come conseguenza inevitabile di ciò che essi ritengono preferibile fare
per il loro paziente. Khuse conclude che l’ambito intenzionale non
può essere limitato alle conseguenze desiderate o volute, per cui la
responsabilità si estende anche alle conseguenze che, pur non essendo
desiderabili o desiderate, sono previste come probabili.
L’approccio utilitarista, applicato ai temi dell’eutanasia e del
suicidio assistito, compare anche in diversi scritti di Peter Singer, in
particolare nel volume Pratical Ethics12 e nell’opera Rethinking Life
and Death13.
In quest’ultimo volume, in particolare, Singer giustifica l’eutanasia
in base al concetto di qualità della vita. Secondo Singer, sulla base
della considerazione dei principi utilitaristici, non esistono radicali
differenze tra eutanasia volontaria e non volontaria. La differenza si
rileva solo in rapporto all’ottenimento del consenso o della richiesta
espressi in merito alla possibilità di morire. L’eutanasia volontaria si
distingue da quella non volontaria solo perché la prima consiste
nell’uccisione di una persona, cioè di un essere umano autocosciente,
che ha chiesto di morire, mentre nell’altro caso sono la famiglia o il
medico a decidere per il soggetto che non è in grado di farlo. Secondo
Singer le persone che pianificano la propria esistenza devono poter
pianificare anche la propria morte. Quindi tutelare il proprio diritto
alla vita è, contemporaneamente, possibilità di tutelare il diritto di
concluderla, quando non è più nostro interesse continuare a vivere.
Singer, Khuse e Rachels individuano nell’accettazione dei giudizi di
qualità della vita il discriminante tra il paradigma tradizionale del
principio di sacralità della vita e il criterio della qualità della vita. In
quest’ultima prospettiva, infatti, le decisioni sulla fine della vita
umana non sono necessariamente legate alla volontà di morire da parte
del paziente; il criterio della qualità della vita vuole essere oggettivo
12
P. SINGER, Pratical Ethics, Cambrdige, Cambridge University Press, 1979; trad. it.
di G. Ferranti, Etica pratica, Napoli, Guida, 1989.
13
P. SINGER, Rethinking Life and Death, Melbourne, Text Publishing Co., 1994; trad.
it. di S. Rini, Ripensare la vita, Milano, Il Saggiatore, 1996.
13
perché non si concentra esclusivamente sull’autonomia e sulle
preferenze individuali, ma chiede di agire in vista del miglior interesse
del paziente. Perciò, oltre a riconoscere piena autorità morale ai
giudizi sulla qualità della propria vita espressi da pazienti consapevoli,
l’etica della qualità della vita si applica anche a individui non più in
grado di esprimere le proprie preferenze. Questi casi possono essere
decisi non solo sulla base dell’attestazione delle preferenze da parte
del paziente, ma anche applicando il criterio della qualità della vita,
ossia chiedendosi se il prolungamento della vita sia più o meno
benefico.
14
4. Considerazioni sull’etica della cura e della responsabilità
Una prospettiva etica alternativa alla visione liberale e alla visione
utilitarista è comunque imprescindibile dal considerare l’influenza che
le innovazioni tecnologiche hanno sia sulla qualità della morte sia
sulla tutela della libertà e del rispetto delle scelte individuali. Le linee
etiche alternative di orientamento sulle scelte di fine vita derivano e si
configurano non solo dai già accennati principi di autonomia e di
beneficenza, ma anche dalla configurazione di una sorta di pragmatica
etica situazionale.
In relazione a ciò, la responsabilità e la cura per l’altro, in unione
al principio di giustizia, che pone il problema dell’equità da garantire,
rappresentano le componenti essenziali di una visione etica
contemporanea proiettata verso la considerazione delle ricadute sociali
delle decisioni su cui si è chiamati a pronunciarsi. Le domande etiche
sul diritto di morire stanno diventando sempre più pressanti e
dibattute, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata, e anche se
certe decisioni non possono essere prese a meno che non ci si trovi
obbligati a prenderle, molte questioni legate alla morte e al morire
possono essere consapevolmente anticipate, ponderate e discusse nel
contesto socio-culturale dell’individuo.
Allo stato attuale, il principio di autonomia ha trovato piena
espressione, ed è ormai generalmente riconosciuto, sia nella pratica
legale, sia nella pratica medica, per quel che riguarda il diritto di un
paziente, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, di rifiutare
terapie indesiderate. La visone liberale, che si appella al diritto
personale di autogestione, ossia alla capacità di gestirsi da sé, di essere
liberi e moralmente indipendenti, si spinge oltre e intende riconoscere
la liceità del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, concedendo
al medico il diritto di non agire in contrasto con la propria concezione
degli obblighi professionali. Nei casi di eutanasia non volontaria,
l’accettazione liberale dell’eutanasia deve far ricorso a criteri
decisionali che in qualche modo sostituiscano la soggettività del
paziente (direttive anticipate, fiduciario che agisca come decisore
sostitutivo…). In mancanza di totale informazione, viene meno il
presupposto di neutralità morale della tesi liberale e si procede
15
scegliendo quello che appare il miglior interesse del paziente nella
situazione data14. Tuttavia, l’autonomia personale è limitata dal diritto
che gli altri hanno di esercitare la loro e può essere anche limitata
dalla società, che esercita diritti in nome della comunità.
Occorre dunque sottolineare che l’autonomia personale è un
concetto complesso e spesso ambiguo. Se la bioetica liberale
contemporanea raccoglie consensi in crescendo, non è infatti immune
da importanti obiezioni e controversie circa il modo di sostenere la
liceità dell’eutanasia. Ad esempio, la pratica del suicidio assistito non
potrà mai risultare un accordo meramente privato, dal momento in cui
si inserisce all’interno di strutture pubbliche che coinvolgono, oltre al
medico, anche una serie di figure professionali che forniscono servizi
assistenziali alla cittadinanza. La critica alla concezione individualista
dell’autonomia, che si esprime nella necessità di integrare il rispetto
dei diritti individuali con le componenti proprie dell’etica della cura e
della responsabilità15, fa leva sulla opportunità di mettere in relazione
il principio o la norma generale con il caso singolo. Dunque, ci si
chiede quale dovrebbe essere secondo tale linea di pensiero l’opzione
morale da attuare tra il dovere di vivere e il diritto di morire.
Molti sostenitori dell’etica della cura affermano che la questione di
avviare procedure per accelerare intenzionalmente la morte dovrebbe
essere collocata nel contesto del “bene comune” della società. Ciò
significa che un’eccessiva enfasi sull’importanza delle scelte personali
rischia di far perdere di vista il fatto che nessun aspetto dell’esperienza
umana sia completamente personale e privato.
Charles Dougherty afferma a riguardo che il modo in cui moriamo,
ossia quando e in quali circostanze e per quali cause o motivi, è
condizionato in modo profondo dalle relazioni che abbiamo con gli
14
In questo caso si tratta di una valutazione analoga a quella operata dagli utilitaristi:
individui non più in grado di elaborare un progetto di vita sono al di fuori dell’ambito
di applicazione dell’autonomia, per cui in tali casi si deve applicare il principio di
benevolenza. Ma a differenza dell’approccio utilitaristico, l’approccio liberale esclude
il calcolo degli effetti su altri quando è in questione il diritto alla vita.
15
Per quel che riguarda l’etica della cura, in questa analisi si farà accenno
principalmente alla sua dimensione relazionale ineludibile e fondativa e non riducibile
alle categorie astratte di giustizia, equità e diritto. Da questa componente essenziale
non discende una precisa ontologia di valori o una teoria della normatività, trattandosi
piuttosto di un’etica basata sugli atteggiamenti. Anche l’idea di responsabilità non
dipende da principi ultimi e diritti naturali ma si incentra sulla irriducibilità
dell’esperienza personale.
16
altri e dalle grandi forze sociali e istituzionali16. Se il morire in un
contesto medico è caratterizzato come un’esperienza che implica
sofferenza e dolore, si potrebbe servire meglio il bene comune della
società prendendo misure che aggiungano semplicità e dignità al
processo del morire, come ad esempio l’incremento dell’assistenza
domiciliare e dei programmi hospice.
Questa linea di pensiero non è poi così lontana dal contesto di una
riflessione sull’eutanasia fondata sull’etica della cura, che si oppone
all’isolamento del soggetto, presupposto dall’individualismo liberale,
per porre l’enfasi sui soggetti concreti, sulla loro relazionalità e sulla
dipendenza da altri. In questa ottica, l’etica della cura pone attenzione
non tanto agli atti e alle conseguenze, ma all’attitudine fondamentale
con cui il soggetto si relaziona agli altri e al mondo. In riferimento alla
centralità che riveste questo aspetto, l’etica della cura non
rappresenterebbe una teoria morale in senso stretto, ma piuttosto una
tradizione di ricerca politica, sociale, psicologica e morale, la cui
identità è emersa solo recentemente17. Tuttavia, l’obiettivo comune di
una prospettiva di questo tipo è la contestualizzazione dell’agente
razionale presupposto dalle teorie della decisione all’interno del
processo relazionale mediante cui si è costituita l’identità
dell’individuo. In questa direzione, l’etica della cura ritiene che i
principi considerati validi devono essere compatibili con giudizi
particolari, spesso basati su sentimenti di empatia e su relazioni di
cura. Sul tema controverso dell’eutanasia e dell’aiuto al suicidio, il
diritto all’autodeterminazione è stato letto, in questo ambito, sotto la
luce della responsabilità e della cura per l’altro. Gli argomenti sulla
legalizzazione del suicidio assistito e dell’eutanasia attiva non si
avvalgono del diritto di disporre del proprio corpo, giudicato un
principio astratto, ma si riferiscono al paziente quale soggetto
concreto, inserito in un contesto di relazioni e il cui accesso alle cure è
condizionato dalla società. In questo ambito, si considera la richiesta
16
Si veda C. J. DOUGHERTY, The Common Good, Terminal Illness, and Euthanasia, in
«Issues in Law and Medicine», 9 (1993), pp. 151-166.
17
Alcuni sviluppi contemporanei dell’etica delle cura sono stati ripresi dal
femminismo: l’aspetto maggiormente condiviso riguarda la critica all’astrattezza del
soggetto come individuo privo di relazioni. Sotto il profilo dei contenuti normativi, né
il femminismo né l’etica della cura sono considerati teorie morali sistematiche in
quanto non rientrano nelle etiche deontologiche, consequenzialistiche e nelle etiche
delle virtù.
17
di eutanasia e di aiuto al suicidio come il risultato di certi fattori, per
esempio, il fatto di ricevere cure inadeguate. In questa prospettiva non
si nega l’autonomia dell’individuo bensì si nega la semplice
accettazione dell’eutanasia e della richiesta di assistenza al suicidio,
come atto di affermazione della propria libertà, che non tiene conto
della dimensione della relazionalità. Gli argomenti a favore
dell’eutanasia in questo contesto di riflessioni sono ritenuti sospetti
perché sembrano non tenere conto della vulnerabilità dei soggetti, così
c’è chi sostiene che l’etica della cura non può essere impiegata per
giustificare l’eutanasia come atto benevolo: gli atti di cura non sono
finalizzati a introdurre pratiche che potrebbero danneggiare i soggetti
deboli, le cui richieste di aiuto sono condizionate dal contesto socioculturale.
Sulla base di queste riflessioni, Susan Wolf si associa a Carol
Gilligan nel suggerire di conciliare l’etica della giustizia con l’etica
della cura, rinviando chiaramente alle più recenti versioni della
bioetica dei principi, in cui la specificazione rispetto al contesto
bilancia e compensa l’astrattezza dei principi.
Laddove il guarire è impossibile, la medicina e l’etica divengono
“arte del curare”. Si apre qui il grande capitolo della medicina
palliativa che, approfondendo sempre più nuove terapie per il dolore,
pone particolare attenzione alla dignità della persona, nel suo
momento culmine, ossia alla “dignità del morire”: una dignità che va
salvaguardata nel rispetto dell’autonomia, superando però il rischio
dell’isolamento. E’ compito della medicina palliativa distinguere il
rispetto che la persona ci impone dall’abbandono, a cui “il diritto di
essere lasciati soli” può condurci. Dinanzi alla medicina palliativa, il
morente ha il diritto alla verità sugli effetti e sugli esiti della cura
palliativa, affinché la sua autonomia non sia solo apparente, solo così
il rispetto dell’autonomia si interseca con il grande tema della cura.
L’aspetto più rilevante dell’etica della cura è la compassione, un
“esperire con”, che riguarda “non solo un momento isolato”, ma anche
“il processo” insito nella sofferenza. Nel testo ormai classico di
Elizabeth Kubler-Ross, La morte e il morire18, si può vedere come il
malato terminale attraversi varie fasi: dal rifiuto/ribellione, al
patteggiamento, alla depressione, all’accettazione. Fasi che
scandiscono un itinerario verso la morte in cui l’unico sollievo può e
18
E. K. ROSS, La morte e il morire, Assisi, Cittadella, 1996.
18
deve essere la possibilità di essere ascoltati e assistiti.
L’interpretazione degli atteggiamenti nei confronti delle malattie
mortali, elaborata da Kubler-Ross, è servita da stimolo per
comprendere meglio come le persone affrontano la prospettiva di
morire. Ma si è anche compreso meglio come tali schemi interpretativi
non devono essere applicati indiscriminatamente perché le
circostanze, sempre mutevoli, di una malattia mortale determinano
un’ampia varietà di pensieri e di emozioni.
Alla luce di questi ultimi aspetti, occorre sottolineare che l’etica
della cura ha senza dubbio contribuito a rimettere al centro della
riflessione morale la dimensione della relazionalità come costitutiva
delle decisioni dell’individuo, anche nelle questioni di fine vita, infatti
è proprio in tale contesto che siamo indotti a comportarci moralmente
in quanto ci “prendiamo cura” di qualcuno e non perché ci capita di
interagire con soggetti che ci sono del tutto indifferenti. Tuttavia si
possono riscontrare anche in questa prospettiva atteggiamenti
ambigui, perché la complessa diversità delle circostanze e dei legami
che un soggetto intrattiene con i diversi interlocutori può tradursi in
forme di cura almeno apparentemente contraddittorie: come ad
esempio optare pro o contro l’eutanasia. In questo caso la questione
cruciale diventa quella di individuare come sia possibile per il
soggetto e per i suoi interlocutori discernere forme autentiche della
cura dalla sue degenerazioni. Si tratta della difficoltà dell’etica della
cura di restare fedele al contesto, di evitare, allo stesso tempo, il
situazionismo, e infine di elaborare strategie di cura socialmente equa.
Chiaramente, come sottolinea Roberto Mordacci, tali difficoltà sono
dovute anche al fatto che non vi è un criterio normativo specifico della
cura, ossia un nucleo normativo che indichi come debba essere
correttamente intesa:
“Cura e giustizia, differenza e identità, particolare e universale,
devono certamente essere pensati insieme, ma occorre precisare, per
esempio, in quale modo la cura traduca praticamente il rispetto verso
ogni agente: su quale base, se non l’identità personale o, in modo più
labile, l’appartenenza al mondo vivente, si può esigere il rispetto della
differenza di ciascuno?”19.
19
R. MORDACCI, Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la Bioetica,
Milano, Feltrinelli, 2003, p. 253.
19
Nel prendere in considerazione non solo la cura e l’assistenza al
morente, ma anche le richieste di assistenza al suicidio di chi desidera
morire prima che la sofferenza diventi intollerabile, occorre ammettere
indubbiamente che esse sono influenzate dalle credenze e dalle
tradizioni etiche e culturali che ci caratterizzano e ci appartengono.
Interessante, a questo punto, è l’attenzione che Battin20 rivolge alla
necessità di un cambiamento culturale e sociale per comprendere il
rapporto tra dolore, sofferenze e suicidio. Secondo Battin è proprio di
un cambiamento di prospettiva che il dibattito contemporaneo
necessita per intendere i tratti del processo del morire e della sua
regolazione. L’assistenza al suicidio e la pianificazione di
quest’ultimo, quando il dolore non ha ancora raggiunto livelli estremi
e insopportabili, possono divenire, in un cambiamento di prospettiva,
un passaggio normale del processo del morire. Sarebbe dunque
razionale per qualsiasi individuo avere l’opportunità, se ovviamente lo
desidera, di assicurarsi in vita la pianificazione del suo suicidio. In
questo modo la scelta, preventivata con prudenza, sarebbe sicura
perché riconosciuta dal contesto culturale della società e dei suoi
membri. E ciò sarebbe visto come un corso normale dell’azione e non
come una possibilità estrema, clandestina ed eccezionale. Attualmente
vengono messe in atto altre strategie di accelerazione della morte,
come l’uso della morfina o di altri stupefacenti, l’interruzione della
nutrizione artificiale o la sedazione terminale, ma questi atti sono
attuati solo quando il soggetto ha raggiunto livelli estremi di
sofferenza, mentre l’ideazione del suicidio assistito avrebbe una
funzione preventiva. Il soggetto cosciente potrebbe decidere dove
morire, con quali familiari, assistenti sanitari e il tipo di cerimonia,
religiosa o simbolica, che desidera, unitamente alla possibilità di
pianificare altre pratiche sociali che possono essere implementate dal
contesto culturale. Le attitudini verso la morte sono fortemente
condizionate dalla società e questa componente rappresenta una
precondizione per lo sviluppo dei supporti morali a sostegno delle
scelte di fine vita. Queste ultime possono includere anche un’ampia
gamma di supporti pratici, legali, assicurativi, e altre policies che
20
Si veda Physician Assisted Suicide. Expanding the Debate, a cura di M.P. Battin, R.
Rhodes, A. Silvers, London, Routledge, 1998.
20
contribuirebbero a rendere l’assistenza alla morte come un fenomeno
socialmente accettabile.
In questo processo delineato da Battin, il concetto di autonomia si
evolverebbe nel consenso sociale e culturale sulle modalità del morire
e delle attitudini alla morte. Battin ritiene che l’aiuto a morire, incluso
l’aiuto del medico a morire, possa divenire “raro”e “sicuro” se diretto
dall’autonomia del paziente sulla base del consenso collettivo, perché
se l’individuo ha la possibilità di avere la libertà psicologica e sociale
per riflettere a lungo termine sulle future scelte del processo del suo
morire, vedrà tale pianificazione non come l’ultima scappatoia
disperata dalla vita e dalle pessime circostanze in cui si trova, ma
come un’esperienza prudente, significativa e preventivata.
Anche se l’orientamento prevalente degli ultimi anni è quello di
consentire una maggiore libertà di scelta all’individuo su come e dove
morire, il dibattito etico-filosofico sull’ammissibilità del suicidio
assistito e dell’eutanasia continua e c’è chi sostiene, come John
Pridonoff, direttore della Hemlock Society, che l’assistenza hospice e
l’aiuto a morire non siano incompatibili e che possano essere due
aspetti complementari di un approccio globale alle decisioni di fine
vita21.
5. La morale, il caso clinico e la regola giuridica
In una società, cosiddetta democratica, il dibattito sulla moralità
e sulla legalità delle pratiche di aiuto al suicidio dovrebbe
rimanere aperto per promuovere quelle condizioni di
discussione e di ascolto necessarie a chi si trova in uno stato di
bisogno disperato e desidera morire in pace. Così, la domanda
sulla “buona vita” e sulla “buona morte” è imprescindibile
dall’obbligo di prestare attenzione alle “differenze” per
garantirne il riconoscimento e la tutela. La coscienza sociale, la
giurisprudenza e la legislazione statunitense ed europea, hanno
rivolto un’attenzione crescente negli ultimi trent’anni ai
21
J. A. PRIDONOFF, Introduction, in Hospice and Hemlock: Retaining Dignity,
Integrity, and Self-Respect in End-of-Life Decisions, ed. M.A. TREPKOWSKI, Eugene,
Hemlock Society, 1998.
21
problemi connessi alla fine della vita e hanno accolto in varie
misure le sollecitazioni provenienti dai diversi gruppi e
movimenti impegnati, anche su fronti opposti, nelle dispute e
nelle discussioni sulla normativa e sui referenti morali da
adottare per “regolamentare” tali fenomeni.
Uno dei casi esemplari, che ha scosso la professione medica
negli Stati Uniti, agli inizi degli anni novanta, è rappresentato
dalla storia della paziente del dott. Timothy Quill22. Si tratta
della storia di Diane (1991) e del suo medico, il dott. Quill, che
l’aiutò a procurarsi una morte anticipata e dignitosa seconda
quanto lei aveva chiesto e desiderato23. La storia è
paradigmatica del rapporto di fiducia medico-paziente e di come
l’aiuto al suicidio possa essere un atto di responsabilità,
schivando forme di violenza fisica e psicologica. Il dott. Quill
non è mai stato incriminato e perseguito penalmente per aver
fornito assistenza alla sua paziente perché quest’ultima era sola
al momento della morte. La donna aveva richiesto, infatti, di
morire in solitudine proprio per proteggere la sua famiglia e il
dott. Quill da potenziali accuse. Quill a posteriori confermò che
Diane non sarebbe morta in solitudine se le leggi vigenti
avessero consentito l’assistenza al suicidio.
Come medico a capo di una struttura ospedaliera, Quill conosce
bene l’importanza della promessa dovuta ai pazienti morenti: i
medici non li abbandoneranno quando la loro malattia diverrà
devastante. Di conseguenza, Quill, in questa vicenda, sottolinea
di essere sempre stato unito e vicino alla sua paziente, in
particolare modo dal momento in cui essa ha scoperto di essere
affetta da leucemia. Quill parla, nel suo libro, della sua stretta
unione con Diane, con la sua persona e con la patofisiologia
della sua malattia. Quando la leucemia le venne diagnosticata e
confermata, Diane era ovviamente terrorizzata, arrabbiata e
22
Il Dott. Timothy E. Quill dirige il Center for Palliative Care and Clinical
Ethics all’Istituto Universitario di Rochester.
23
La storia di Diane è raccontata in T. E. Quill, Death and Dignity: A Case of
Individualized Decision Making, in «The New England Journal of
Medicine», 324 (1991), pp. 691-94.
22
devastata dal dolore. Lamentando continuamente la tragedia e
l’ingiustizia della sua vita, Diane arrivò a maturare la decisione
di porre termine alle sue sofferenze. Il suo medico le chiese più
volte di riconsiderare questa decisione, ma Diane era convinta
che sarebbe morta durante il trattamento e avrebbe così sofferto
il processo di ospedalizzazione, il mancato controllo del dolore
sul suo corpo, gli effetti della chemioterapia e cosi via. Sebbene
Quill le avesse offerto il suo totale supporto nel minimizzare e
alleviare la sua sofferenza, e sebbene la sua famiglia si
augurasse che prima o poi ella avrebbe optato per il trattamento
di cura, Diane non si lasciò persuadere. Consultò anche uno
psicologo ma nulla cambiò. Quill gradualmente comprese la
decisione di Diane dal suo punto di vista e si convinse del fatto
che ella aveva il diritto di decidere. Sottolineando come per
Diane fosse importante mantenere il controllo di se stessa e della
sua dignità durante il tempo che le sarebbe rimasto da vivere,
Quill si rende gradualmente complice e partecipe della sua
scelta. Egli aveva avuto modo di esplorare questo desiderio,
assistendo la paziente e la sua famiglia in maniera assidua,
facendo più di quanto fosse previsto abitualmente dalle pratiche
mediche. Nonostante tutto, temeva ancora gli effetti e le
ripercussioni di una morte violenta sulla famiglia di Diane, di un
suicidio non ben compiuto, e temeva che qualche membro della
sua famiglia fosse indotto ad assisterla, con tutte le ripercussioni
legali e personali che ne sarebbero conseguite. Alla luce di
questi dati, Quill indirizzò Diane presso la Hemlock Society24,
dove avrebbe potuto trovare pieno aiuto. Quill continuò ad
assicurarsi della sua volontà fino al momento della sua morte e
si accertò che ella avesse tutto l’occorrente per un buon esito.
Quill era sicuro che Diane non si sentiva abbandonata e che si
faceva forza con le sue relazioni personali, con la sua famiglia e
con i suoi amici più vicini. Nel pubblicare questa vicenda, Quill
24
La Hemlock Society è nata in Oregon (Usa) nel 1987 come organizzazione
no-profit a favore della depenalizzazione del suicidio assistito. Derek
Humphry è tra i suoi fondatori. L’associazione ha sponsorizzato, in Oregon,
nel 1991, una proposta di legge a favore del suicidio assistito.
23
parla dell’importanza della filosofia della cura come dovere
fondamentale del medico per contribuire ad assicurare una
morte dignitosa al paziente. Il suo racconto è attraversato da
molti dubbi e domande, ed è significativo il fatto che Quill non
fosse assolutamente d’accordo con la decisione di Diane, ma
l’ha comunque aiutata a metterla in atto. Quill si chiede quanti
pazienti gravemente ammalati o moribondi, si tolgano
segretamente la vita, morendo da soli e nella disperazione. Per
Quill l’accompagnamento del morente non è un’azione
disonorevole per il medico. Diane aveva vissuto la maggior
parte della sua vita in uno stato di grave sofferenza psicologica e
anche il suo futuro sarebbe stato segnato dal dolore, ma ciò che
temeva maggiormente era la dipendenza e la sedazione. A un
certo punto, dunque, Diane, radunò i suoi amici più intimi per
salutarli e, dopo aver richiamato Quill e verificato che tutto
fosse a posto, morì due giorni più tardi. Quill fu poi informato
dal marito dell’avvenuto decesso. Il marito raccontò al medico
come sua moglie lo salutò quel mattino chiedendo a lui e al
figlio di lasciarla sola (morire da sola faceva parte della
procedura raccomandata dalla Hemlock Society cosicché la
famiglia e gli amici fossero tutelati dalle accuse di aiuto al
suicidio). Così né il marito, né il figlio, né il medico di fiducia
sono stati soggetti a pena25.
25
Dopo la morte di Diane, Quill non venne accusato dal grand jury e il New
York State Department of Health's Board for Professional Misconduct
considerò la sua azione “legale e eticamente appropriata”. Nel 1994 Timothy
Quill, insieme ad altri medici (Caso Vacco v. Quill 1997), fece causa allo
statuto dello Stato di New York sul suicidio assistito, poiché, secondo Quill,
la prescrizione di farmaci letali a persone mentalmente competenti, ad uno
stadio terminale, era in sintonia con il suddetto statuto sulla base della “Equal
Protection Clause”, del XIV Emendamento. Questa clausola, secondo Quill,
prevedeva che lo Stato trattasse casi simili alla stessa maniera. Dal momento
che in America un individuo ha il diritto costituzionale di rifiutare cure
mediche, anche se questo rifiuto porta alla morte, Quill sosteneva che tale
rifiuto non era distinto rispetto alla pratica del suicidio assistito da medici. La
Corte Suprema (1997) respinse la causa di Quill, in quanto lo statuto di New
York riteneva che il rifiuto di trattamenti di sostegno vitale da parte di
24
Quill conclude questa storia sottolineando come dalla vicenda di
Diane egli abbia compreso l’importanza dell’apertura verso i
bisogni dei pazienti, dell’assunzione del rischio e della
responsabilità per l’altro. Quill, assistendo la sua paziente, ha
creduto nella giustizia della sua azione, tuttavia, si è sempre
chiesto perché Diane dovesse essere sola negli ultimi istanti
della sua vita. Il morente non dovrebbe mai essere abbandonato,
proprio a causa della solitudine si rischia di morire troppo
facilmente in uno stato di disperazione. Egli sapeva, inoltre, che
molti medici aiutano clandestinamente i loro pazienti a morire in
circostanze simili. A riguardo, la storia di Diane è significativa,
secondo Quill, perchè è una storia di passione e di fiducia, e
queste sono le storie che possono orientare il dibattito attuale a
liberarsi dalle ideologie. Per i sostenitori del principio di
sacralità della vita il dott. Quill potrebbe aver violato un bene
fondamentale, fornendo assistenza al suicidio della sua paziente
e Diane non sarebbe dovuta morire in quel modo. La sua
famiglia, i suoi amici, il suo medico l’avrebbero dovuta assistere
il più a lungo possibile, per educare la comunità alla sofferenze
e alla vita degna di essere vissuta. Al di là di quanti giudichino
questa vicenda in una tale ottica religiosa, il ruolo e le azioni del
dott. Quill si ritiene debbano essere valutate nell’ottica delle
virtù della responsabilità, della compassione e della fiducia.
I pazienti morenti spesso non hanno scelta, la loro unica cura
possibile è non lasciarli soli davanti alla morte. Quill ha
ammesso, però, che Diane, come tanti altri, non si meritava di
morire sola, sobbarcandosi il peso del suo destino tragico.
Sebbene i rischi legali del caso siano serviti poi a giustificare
tale modo di procedere, Quill, prima, ha dovuto acconsentire che
Diane morisse in solitudine. Confessando il suo atto illegale
sperava che la sua azione fosse riconosciuta come azione
pietosa. In relazione a quanto detto, Quill non può essere dipinto
semplicemente come un medico che aiuta le persone a
perseguire una morte dignitosa, al contrario, come ha dimostrato
persone competenti è ammesso ma l’assistenza al suicidio da parte di un
medico non è concessa.
25
la storia di Diane, l’impegno morale del dott. Quill scoraggia le
pratiche di suicidio medicalmente assistito, quale opzione facile
e veloce. Piuttosto, si tratta dell’ultima tragica possibilità.
Infatti, Quill si sente obbligato, dopo questa vicenda, a
informare la comunità su ciò che significa vivere una “buona
vita” e morire una “buona morte”, affermando, in riferimento
alla sua paziente che sceglie la sua tragica fine, che vi è un
diritto per lei di morire in pace. Il dott. Quill, successivamente, è
stato riconosciuto e apprezzato per i suoi modi di operare
attraverso la consulenza, l’ analisi e l’assunzione di
responsabilità verso il paziente26.
La stesso non si può affermare per i casi di aiuto a morire da
parte di un altro medico, il dott. Kevorkian, che prescriveva dosi
letali ai suoi pazienti sostenendo di agire nel loro interesse. Il
risultato fu che molti di quei pazienti morivano completamente
isolati e nessuno avrebbe potuto testimoniare o assicurare che il
paziente avesse preso una decisione ragionevole, che prima
avesse valutato tutte le opzioni alternative e che il potere del
medico praticante non fosse stato abusivo. Dunque, è evidente
che tali pratiche necessitano, ancor prima dell’intervento della
norma, del requisito etico di fondo, affinché il medico, o chi
altro, sia in grado di distinguere la differenza fra una richiesta di
morte e un grido di aiuto a vivere.
A parte in casi di legislazioni eccezionali come l’Olanda, il
Belgio e lo Stato dell’Oregon in USA27, dove l’aiuto a morire è
26
Sui metodi praticati dal dott. Quill si veda, T. E. Quill, Physician-assisted
dying : the case for palliative care and patient choice, Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 2004.
27
In Olanda il 10 aprile 2001 è stato approvato il provvedimento che
legalizza formalmente l’eutanasia. Il testo è entrato in vigore il 1° aprile
2002. Merito della legislazione olandese è stato quello di aver fatto emergere
una diffusa realtà preesistente. Con la formalizzazione in legge delle lineeguida viene sancita la piena validità della richiesta di eutanasia del paziente,
se in accordo con determinati criteri e procedure. E’ vigente attualmente nello
Stato americano dell’Oregon una legge sull’eutanasia. Vi si stabilisce, in
particolare, che non costituirà reato l’assistenza al suicidio qualora una tale
condotta risulti posta in essere dal medico, in presenza di una serie di
condizioni minuziosamente descritte. La legge, del 1994, è stata confermata
26
legalmente consentito sotto ristrette categorie e rigide linee
guida, il diritto, nella maggior parte degli altri paesi, proibisce
tali pratiche, anche se vi sono stati casi di aiuto al suicidio
rimasti impuniti, seppur in contrasto con l’ordinamento vigente.
Infatti, alcuni paesi, tra i quali la Gran Bretagna28, hanno
recepito i recenti sviluppi del dibattito internazionale sull’aiuto a
morire e segnali di distacco, dei giudizi sociali e morali, dai
confini giuridici tradizionali sono tuttora in atto. In Italia, diversi
casi giudiziari hanno scosso l’opinione pubblica dal disinteresse
per le questioni e le decisioni di fine vita. Dal caso Forzatti,
l’ingegnere di Monza che aveva staccato il ventilatore
meccanico applicato alla moglie in coma (Sentenza n. 23/02
della Corte Assise d’Appello di Milano, I Sez.), conclusosi con
l’assoluzione dall’imputazione di omicidio, per insufficienza
della prova dell’esistenza in vita della vittima, al caso di Eluana
Englaro, tuttora aperto, dopo che la Corte di Appello di Milano,
e in precedenza il Tribunale di Lecco, ha respinto la domanda
del padre, tutore di Eluana, di ottenere l’autorizzazione
all’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali,
che da sedici anni tengono in vita la ragazza che si trova in stato
vegetativo permanente29.
Il testo della Convenzione Europea, riguardo alle decisioni di
fine vita, tenta un’opera di bilanciamento: da una parte, si
afferma il principio di autonomia come base del diritto alla vita
privata, garantito dall’art. 8, poiché nell’ambito di un concetto
più ampio di vita privata si riconosce l’importanza delle scelte
per due volte da referendum popolari ed è entrata definitivamente in vigore il
26 ottobre 1997. Recentemente, altri stati americani hanno avviato procedure
legislative dirette a riconoscere il diritto all’assistenza medica al suicidio.
Così, nello Stato della California, il 22 febbraio 1999, è stato presentato il
Death with Dignity Act, speculare alla legge che vige nell’Oregon.
28
Si rinvia alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 29/4/2002, Pretty v.
United Kingdom. Si tratta della sentenza relativa al caso Pretty, in cui si
concede libertà agli stati di regolamentare le forme di aiuto al suicidio, come
hanno fatto Olanda e Belgio.
29
Si veda S. Fucci, I diritti di Eluana - Prime riflessioni, in «Bioetica», 1
(2004), pp. 95-99.
27
relative alla qualità della vita, e, dall’altra parte, è rigettata la tesi
che, per gli individui mentalmente in grado di intendere, ma
fisicamente incapaci, lo Stato sia obbligato a consentire forme di
aiuto al suicidio in quanto incluse di quel diritto30. Dunque, si
lascia interamente agli Stati la decisione sul modo in cui a
questo diritto si debba conferire un minimo di efficacia, si
approva l’orientamento generale e assoluto assunto in materia
dalla legislazione nazionale ma si autorizzano gli Stati a
decidere con una certa flessibilità e a posteriori quali reati
debbano essere perseguiti e puniti.
In questa fase di reazioni e di cambiamenti morali e sociogiuridici sul grande tema delle decisioni di fine vita, il rischio
più temuto, sul piano delle ragioni di carattere di etico, è quello
di una giuridicizzazione delle questioni sociali e, in particolare,
di una normalizzazione delle pratiche delle forme di aiuto a
morire. Si teme che questo processo spinga gli individui ad
abdicare dalle loro responsabilità sociali e collettive per
ricercare soluzioni mutuamente accettabili e itinerari formali,
trasformando questioni di giustizia sociale in questioni tecniche
e legali, disconnesse dall’ intimità e dalle relazioni sociali da cui
sono emerse. La definizione di strategie etico-giuridiche
congiunte e percorribili diviene allora indispensabile affinché la
medicina contemporanea possa comprendere se e come sia
possibile l’incontro della norma con la morte e il morire, nel
perseguire l’obiettivo comune di propiziare una buona morte
(pursuing a peaceful death).
30
Articolo 8, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: “ 1. Ogni persona
ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di
un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o
della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
28
6. Lo stato vegetativo permanente
La condizione di chi non può decidere perché non si trova più in
uno stato di coscienza, rappresenta attualmente una delle
questioni più problematiche del dibattito etico e giuridico di fine
vita. Vi sono storie al limite e sono le storie delle persone in
stato vegetativo permanente, che continuano a vivere grazie alle
tecnologie di sostegno vitale. Proprio queste storie spesso
diventano casi mediatici perché attorno ad esse si scatenano
conflitti morali e giuridici31, dovuti al gioco delle ipocrisie e alla
31
Di recente, il caso Terri Schiavo. La giovane donna americana in stato
vegetativo permanente è morta dopo che la Corte Suprema statunitense aveva
autorizzato l’interruzione dei trattamenti su richiesta del marito, in netto
disaccordo con il volere dei familiari. In Italia è stato ed è tuttora in
discussione il caso di Eluana Englaro, in cui il giudice, al contrario di ciò che
aveva autorizzato la Corte Suprema degli Stati Uniti, ha respinto più volte la
richiesta del padre di Eluana di poter sospendere i trattamenti di sostegno
vitale alla figlia, in qualità di tutore, legale rappresentante, dai quali dipende
da sedici anni. La sentenza della Cassazione civile n. 21748 del 16 ottobre
2007 ha segnato però un incisivo cambiamento. Tale sentenza ha, infatti,
riconosciuto che prestare il consenso al trattamento destinato all’incapace
rientra tra i doveri di cura, in capo al tutore, previsti dall’art. 357 del codice
civile. Al tempo stesso, la sentenza ha, però, anche precisato i criteri ai quali
deve essere improntata l’attività di cura del rappresentante: «Il carattere
personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il
riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce al tutore …
un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di
totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel
dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la
rappresentanza del tutore è sottoposta ad un duplice ordine di vincoli». Se il
primo vincolo è rappresentato dal perseguimento dell’«esclusivo interesse
dell’incapace», il secondo vincolo, funzionale alla ricerca e alla
determinazione del «best interest», va ravvisato – usando le efficaci parole
della sentenza - nel «decidere non “al posto” dell’incapace né “per”
l’incapace, ma “con” l’incapace». Il caso di Karen Quinlan, invece
rappresenta il primo vero caso discusso in America. Karen Quinlan (NJ,
1976), era entrata in coma dopo un incidente. Suo padre chiese il permesso
legale di rimuovere il respiratore. Le affermazioni che la donna aveva fatto
davanti agli amici e alla famiglia, con cui si rifiutava di essere mantenuta in
vita attraverso delle macchine, furono rigettate in quanto rappresentavano una
«ripugnanza» o un «desiderio» «remoto e impersonale», emotivo e non una
29
mancata intesa tra posizioni che si fronteggiano, per esempio i
familiari da una parte e il contesto clinico dall’altra. Allora
l’intervento del giudice si rende necessario. E’ accaduto per
Nancy Cruzan, una delle figure protagoniste del dibattito
sull’aiuto a morire, quando il suo caso (1988) rappresentò il
primo caso di diritto di morire davanti alla Corte Suprema degli
Stati Uniti32. La giovane Nancy, in seguito ad un grave incidente
automobilistico, rimase in stato vegetativo permanente. Fu
alimentata attraverso una gastrostomia, prima che le venisse
sospesa l’alimentazione. Nancy, nello stato in cui si trovava, non
avrebbe più potuto muovere il suo corpo e la sua corteccia
cerebrale era in stato irrimediabilmente compromesso. Con la
nutrizione artificiale essa poteva comunque avere un’aspettativa
di vita di almeno altri trent’anni. Tuttavia, dopo tre anni di
esistenza in una condizione di “morte vivente”, i genitori fecero
conclusione razionale. Nel 1976, il sig. Quinlan si rivolse alla Corte Suprema
del New Jersey, la quale sentenziò che Karen aveva il diritto costituzionale di
morire. La Corte dichiarò che in casi extra-ordinari si poteva applicare un
parere extra-legale «in quanto chiunque si fosse trovato in una simile
situazione avrebbe voluto morire». In casi simili a questo, né la comunità
scientifica, né la società dispongono di criteri morali certi per definire se i
pazienti in questione sono o non sono persone e se sono vivi o se sono morti.
La difficoltà risiede nel dare giudizi morali rispetto ai bisogni, ai desideri,
alle aspettative dei protagonisti del caso e, anche in virtù del principio di
autonomia, appare problematico giustificare una decisione estrema quando,
ad esempio, le condizioni del paziente sono tali da impedire il suo consenso
all’interruzione di un trattamento. Quindi, anche se la scelta di morire
dovesse essere corrispondente alla richiesta del paziente avanzata settimane
prima, ciò non potrebbe costituire una sufficiente garanzia per l’agire
moralmente giusto; va comunque valutata la consapevolezza, l’autenticità e
la congruenza con le circostanze. Appare evidente che tali questioni tocchino
tre ambiti interconnessi: le leggi, la deontologia medica e i principi etici.
32
Si veda G. Ponzanelli, Nancy Cruzan, la Corte degli Stati Uniti e il right to
die, entrambi in «Foro italiano», IV (1991) pp.66; A. Puca, Il caso Nancy
Beth Cruzan, in «Medicina e Morale», 5 (1992), pp. 911-932.
30
richiesta di sospendere i trattamenti di sostegno vitale, senza
ottenere parere favorevole dalla Corte del Missouri. I genitori si
appellarono alla Corte Suprema degli Stati Uniti che si
pronunciò nel 1990 per la prima volta sulla questione del diritto
di morire. Seguirono due giudizi: la trial court autorizzava
l'interruzione, ma la Corte Suprema del Missouri la negava. La
famiglia Cruzan perse la causa. La Corte proclamò la libertà
degli individui di accettare o rifiutare le cure mediche, tra cui
anche l’idratazione e la nutrizione artificiale, ma dichiarò anche
che lo Stato ha l’autorità di richiedere prove convincenti su
come i pazienti in stato competente hanno espresso il proprio
parere su come dover essere trattati in caso di stato vegetativo.
Così i coniugi Cruzan tornarono dinanzi al tribunale al quale si
erano originariamente rivolti portando testimonianze circa la
volontà della figlia, dalle quali si ricavava che essa non avrebbe
voluto essere mantenuta in uno stato di incoscienza permanente.
Ed è proprio sulla base di queste nuove deposizioni che, dopo la
sentenza della Corte Suprema, i genitori Cruzan ottennero da un
tribunale del Missouri l'autorizzazione a interrompere
l'alimentazione della figlia.
Il caso Cruzan, nel suo riesame, risulta estremamente
emblematico e interessante ai fini di questa indagine, soprattutto
per i due diversi pareri che sono stati formulati dai giudici delle
due Corti sulla responsabilità superiore dello Stato di decidere
nell’interesse dell’individuo. Nella difesa delle ragioni etiche a
sostegno della loro decisione, i giudici si sono differenziati sulla
base di un’opinione impersonale e di un’opinione personale. Per
quel che riguarda il giudizio impersonale della Corte Suprema, i
giudici si sono appellati alle questioni del consenso informato,
del grado di competenza del paziente, dell’interesse dello Stato
di tutelare la libertà dell’individuo, dell’uso etico delle nuove
tecnologie e della costituzionalità del diritto dei genitori a
sostituire il giudizio della figlia. Questi sono stati i criteri di
giudizio adottati dalla maggioranza, dove, come si può notare,
non si fa riferimento ai dettagli circa lo storia personale di
Nancy Cruzan.
Il giudice Rehnquist, rappresentante della maggioranza e
dell’opinione impersonale, in tal senso, argomenta affermando
31
l’interesse prevalente dello Stato su quello degli individui nel
difendere la vita dei cittadini, a prescindere dalla sua “qualità”.
Ma la risposta del giudice Brennan a questa dichiarazione segna
un passaggio significativo circa il ruolo delle responsabilità in
casi come questo: “Lo Stato non ha alcun interesse ‘astratto’ e
legittimo alla vita di qualcuno che non sia quello della persona
che vive quella vita e che possa aver più peso della sua scelta di
rinunciare alle cure mediche”33. Secondo la sua visione del caso,
per comprendere realmente la storia di Nancy e della sua
famiglia occorre scavare ulteriormente e congiungere gli ambiti
di competenza dello Stato con i dettagli personali del caso. Ma i
giudici della maggioranza non si sono sentiti obbligati a farlo. Il
loro discorso, infatti, è stato costruito in conformità con quanto
prescriveva la legge, trascurando la sfera delle emozioni e della
intimità personale. La minoranza, invece, ha ritenuto opportuno
considerare e maturare un’opinione “personale” sul caso, sulla
base di una più approfondita conoscenza delle sue componenti
empatiche. I giudici, in questo modo, hanno dichiarato che
Nancy Cruzan aveva il diritto di credere di morire con dignità. Il
loro discorso contrasta con l’indifferenza e l’astrattezza del
discorso impersonale presentato dalla maggioranza. Il giudice
Brennan, della minoranza, sottolinea, a riguardo, il fatto che
l’ottanta per cento degli americani, che muoiono in ospedale
sedati e in stato comatoso, sono trattati più come oggetti
piuttosto che come soggetti morali. Brennan parla a favore di
questi soggetti, che hanno diritti inalienabili garantiti dalla
Costituzione. La reale questione davanti alla Corte, secondo
Brennan, non riguarda il diritto dello Stato ma il diritto
dell’individuo. Egli si chiede perché lo Stato può pensare di
poter compiere delle scelte che il paziente avrebbe fatto, se in
vita, piuttosto che consentire di compierle a qualcuno che ha
conosciuto molto bene il paziente. Lo Stato ha un interesse
generale e legittimo a preservare la vita dei cittadini, ma lo Stato
33
Cfr. F. I. Michelman, La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma
costituzionale e il giudice Brennan, a cura di G. Bongiovanni e G.
Palombella, Bari, Ed. Dedalo, 2004, p. 164.
32
non deve legittimare questo generale interesse nella vita di
qualcuno, in maniera completamente astratta dall’interesse della
persona che vive “quella” vita.
La Corte del Missouri aveva anche dichiarato che la società,
nell’insieme, avrebbe potuto beneficiare dei trattamenti
somministrati a Nancy Cruzan, infatti, come sostiene anche
Leon Kass, dimostrare coraggio e perseveranza dinanzi alla
morte e al morire rappresenta un’opportunità per promuovere il
senso di umanità e di dignità tra i membri della comunità
sociale. In questo dovrebbe consistere l’eroismo della famiglia
Cruzan, in un atto di sacrificio, al fine di essere un modello per
la moralità degli altri.
In riferimento anche a quest’ultima interpretazione, Brennan
non esita ad accusare la Corte del Missouri di falso
comunitarismo e di ignorare i dettagli personali di questa storia,
dettagli che hanno giocato un ruolo marginale nei colleghi della
Corte Suprema. Questi ultimi, infatti, si sono avvalsi più delle
categorie giuridiche astratte piuttosto che dei fatti e delle
circostanze del caso in questione. Secondo Brennan, il giudice è
chiamato al faccia a faccia con la dimensione esistenziale di quei
dettagli e deve confrontarsi con la prova della loro forza
“decostruttiva”. La famiglia Cruzan è stata “forzata” a
rispondere al potere dello Stato, con i suoi standard di evidenza
chiara e convincente, e i suoi membri non hanno avuto voce.
Brennan sottolinea questo aspetto, ad esempio, quando lo Stato,
con i suoi standard giuridici prefissati, ritiene non rilevante ciò
che sostiene di sapere la sorella di Nancy. Continua a
sottolineare che tutto ciò che lo Stato ha scartato come
irrilevante al caso, è una prova di come esso si sia rifiutato di
trattare il paziente come persona, facendo così di Nancy un
simbolo della causa. Lo Stato, argomenta Brennan, è rimasto
volutamente estraneo al paziente e quindi dovrebbe ammettere
che la sua conoscenza di Nancy non è equiparabile a quella dei
genitori. Brennan ritiene prioritario il rispetto dei principi
costituzionali, tuttavia, la sua retorica è costruita in modo tale
che, prima del riferimento alla Costituzione, il caso sia radicato
nella tradizione e nella coscienza dei cittadini che hanno
sacrificato a lungo la loro vita per proteggere la libertà di scelta
33
e la storia personale delle loro famiglie. Anche il giudice
Stevens aggiunge la sua dissenting opinion a quella di Brennan.
Parlando di Nancy Cruzan, Stevens sottolinea come l’attuale
sviluppo medico e tecnologico ha trasformato le condizioni
sociali e politiche della morte e del morire: gli individui hanno
sempre meno certezze di morire a casa e molto più
verosimilmente muoiono in strutture pubbliche, come ospedali o
case di cura. Di conseguenza, parlare di Nancy Cruzan è parlare
anche della sua vita in famiglia, è conoscere quelli che sono stati
vicini a lei per consentire alla comunità di approvare scelte che
toccano il cuore della libertà e della dignità umana e che si
basano su motivazioni irreprensibili. Brennan sostiene che la
vita non procede in astratto dalle persone e pretendere altrimenti
non è onorare ma sconsacrare la responsabilità dello Stato nel
proteggere la vita dei cittadini. Stevens, allo stesso modo, parla
di persone e non di astrazioni e ci incita ad avvicinarci alla realtà
del dolore e della sofferenza.
Il richiamo alle emozioni e alle zone di vulnerabilità sta
acquistando sempre più rilevanza nei processi decisionali, in
determinate situazioni emotive, in ambito giuridico, dove si
inizia a riconoscere che un certo tipo di compassione è
“ragionevole”34, anche come circostanza attenuante. Brennan e
Stevens hanno ammesso ciò, raccontando le emozioni e
sviluppando argomenti sul significato delle decisioni estreme in
uno specifico caso, davanti al quale lo Stato deve
controbilanciare il suo generico interesse alla difesa della vita
con quello del singolo. Anche le emozioni e gli aspetti peculiari
alle vicende della famiglia Cruzan rappresentano una forte
testimonianza per la comunità sociale: si tratta di un caso che ha
avuto ripercussioni sulla coscienza di ognuno nel momento in
cui i dettagli personali e “specifici” legati alla decisione finale
sono emersi, al di là delle ideologie e delle derive laiche o
clericali che molto spesso investono casi come questo.
34
Sul tema dell’accordo delle emozioni con la norma giuridica si veda M. C.
Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma,
Carocci, 2005, pp. 37-94.
34