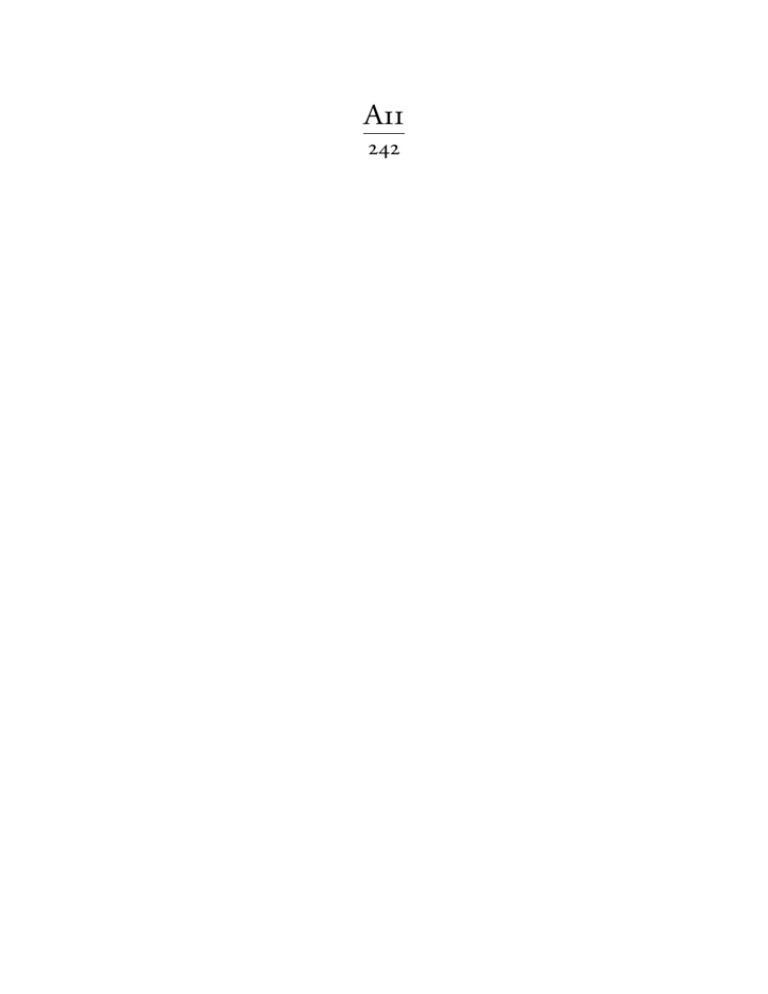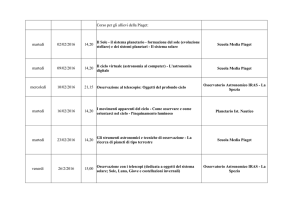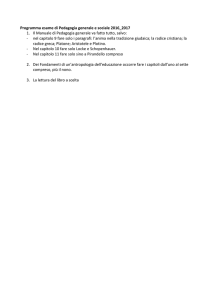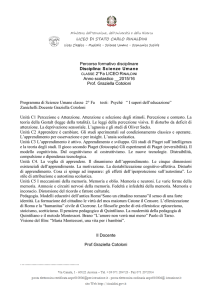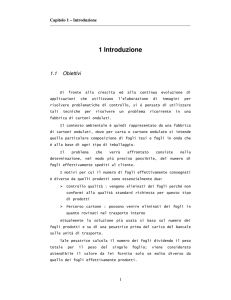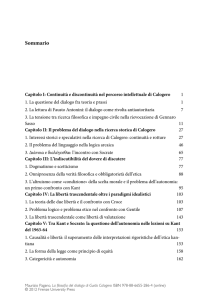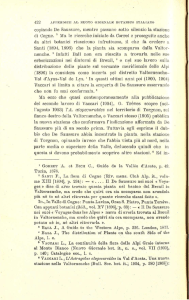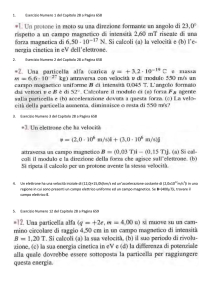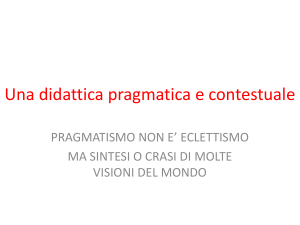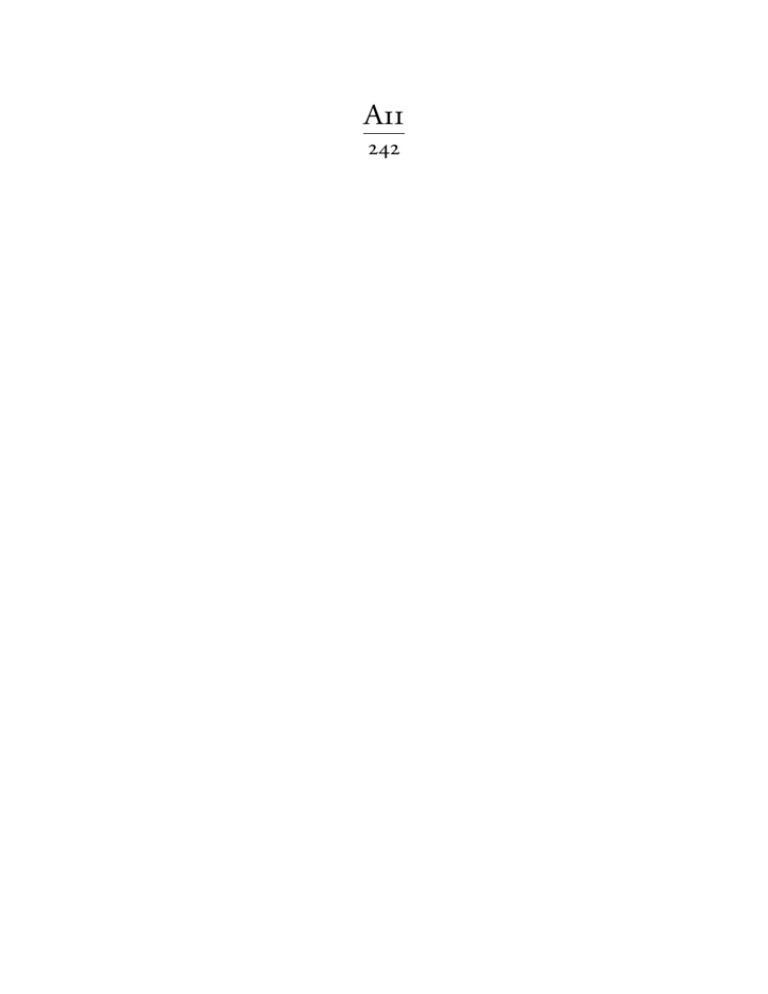
A11
242
Francesco Aqueci
Introduzione alla semioetica
Copyright © MMVII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–1267–3
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: luglio 2007
Indice
5
Premessa
I.
11
15
16
19
21
23
26
Strutture normative e volontà del soggetto
1. La ragione antimonista di Vailati
2. Il volontarismo dialogico di Calogero
2.1. La teoria del dialogo
2.2. La teoria linguistica
2.3. Ritorno al dialogo
2.3.1. Excursus: Calogero e Vico
3. Le trasformazioni morali di Piaget
II.
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
31
37
39
41
44
1.
2.
3.
4.
5.
Della Volpe: il nesso dialogico degli eterogenei
Scarpelli e Piaget: la natura linguistica della morale
Mayr: i prodromi evolutivi del rispetto
Lacan: il simbolico e il normativo
Dalla costrizione della lingua alla libertà del discorso
47
III.
49
50
1.
2.
Sistema linguistico e eccedenza normativa
Mayr: processi teleomatici e processi teleonomici
La morfogenesi del segno
1
2
Indice
52
53
58
59
60
61
63
65
2.1. I mediatori morfogenetici
2.2. L’imitazione come mediatore morfogenetico
3. Tipologia dei segni e natura semiotica dell’intelligenza
3.1. La tipologia dei segni in Peirce e Saussure
3.2. La natura semiotica dell’intelligenza: Piaget
3.3. La natura semiotica dell’intelligenza: Peirce
3.4. La performatività adattiva del segno
4. Peirce, Saussure, Piaget: una analitica del vivente
69
IV.
71
77
83
85
87
1. La mente tra dovere e segno
2. L’intelligenza al lavoro: Peirce e Lukács
2.1. Digressione sull’ideologia in Lukács
2.2. Ripresa: le radici ontologiche del dover essere
3. Per l’unità del pensiero critico: Popper, Piaget, Lukács
91
V.
92
94
95
96
97
98
101
102
104
1. Interrogazioni saussuriane
2. Dal linguaggio alla cognizione
3. La mente in Saussure
3.1. Una distanza apparente
3.2. Combinare e associare
3.3. La lingua regno del caso
3.4. La mente grammaticale collettiva
3.5. Lingua e mente sociale
3.6. Il grado zero della libertà del segno
107
VI.
108
114
1. Locke: genesi politica della semiotica moderna
2. Da Locke a Hobbes: libertà dell’individuo e astrazione
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
Mente collettiva e naturalità del segno
Mente moderna e libertà politica
ciale
so-
Indice
3
117
123
3. Hobbes: genesi semiotica della politica moderna
4. Compimento e crisi della modernità: l’individuo
129
Frege
5. L’ideologia contemporanea e la ricostruzione dell’essere
sociale
135
Conclusione
141
Bibliografia
tragico di
Premessa
Le tante cose che facciamo nella nostra vita quotidiana comportano delle conoscenze, di cui però non abbiamo alcuna consapevolezza
teorica. Parliamo, ma non conosciamo o ricordiamo a fatica qualche
principio grammaticale della nostra lingua. Facciamo i nostri affari,
me non conosciamo le leggi dell’economia, sulle quali del resto neanche gli economisti si intendono, analogamente a quanto accade in
linguistica con le infinite controversie dei grammatici sui principi del
comportamento linguistico. Eseguiamo dei compiti tecnici, dal far
leva con un asse sotto un oggetto particolarmente pesante al far lievitare una ciambella al cacao, senza per questo saper dire tutta la fisica o la chimica che in quei compiti è implicata. E, infine, ci comportiamo moralmente in maniera tale che a volte qualcuno, anche
senza invocare il perdono di un padre onnipotente, di cui non tutti disponiamo, ha potuto esclamare: “dio, non sanno quello che fanno!”
Se ci si riflette, il risvolto cognitivo di questa più che giustificata
esclamazione morale è la formula con cui Karl Marx (1818–1883)
compendiava il problema della separazione tra prassi e conoscenza, e
cioè “gli uomini non lo sanno, ma lo fanno”, una formula che avrebbe anche potuto essere la divisa di Vilfredo Pareto (1848–1923),
quando rilevò la predominanza della dimensione non logica nei
comportamenti sociali, e che poi György Lukács (1885–1971) mise
al centro della sua estetica ed ontologia quando, con un sorprendente
moto sintetico rispetto alle parcellizzate ricerche cognitive contem-
5
6
Premessa
poranee, si riferiva a quel complesso di pratiche economiche, sociali,
culturali con le quali gli uomini costruiscono il loro essere sociale,
senza perciò essere guidati da principi espliciti, dei quali anzi prendono coscienza parzialmente solo a posteriori o post festum, come
egli preferiva dire nelle sue astute glosse a Marx.
Ma questa separazione si è imposta anche a teorici della conoscenza, oggi diremmo della mente, come Jean Piaget (1896–1980),
che distingueva l’inconscio affettivo freudiano dall’inconscio cognitivo, riscontrabile ontogeneticamente sul piano sensorio–motorio o
pratico (Piaget, 1971). La nozione di inconscio cognitivo riemerge
oggi nelle scienze cognitive contemporanee, che gli attribuiscono una funzione di classificazione rispetto ad una serie di principi soggiacenti a svariati comportamenti, con la caratteristica comune che il
soggetto non ne ha coscienza. Tuttavia, Piaget ne indagava un aspetto che resta alquanto in ombra nelle scienze cognitive odierne, e
cioè il fatto della presa di coscienza dei principi soggiacenti al comportamento, nel momento in cui si produce un disadattamento. Egli
mostrava che si procede, allora, ad una ricostruzione concettuale di
tali principi, evidenziata dalla scelta intenzionale da parte del soggetto tra due o più possibilità (Piaget, 1974).
Tutte queste suggestioni, che concerno tanto il piano sociogenetico, quanto quello ontogenetico e strutturale, incoraggiano a porre un
inconscio morale che, per dirla con Piaget, non ha le maliziose profondità dall’inconscio affettivo, né possiede la vocazione logico–manipolatoria dell’inconscio cogntivo, ma che è soggetto
anch’esso a presa di coscienza quando si produce un disadattamento
o “crisi”.
In particolare, l’inconscio morale sarebbe costituito da ciò che
potremmo chiamare il principio normativo, cioè la tendenza spontanea della nostra mente a rappresentarsi l’ordine e a trascurare il disordine. In altri termini, la nostra mente morale funzionerebbe secondo l’articolazione figura–sfondo: le informazioni relative
all’ordine spiccano, mentre quelle relative al disordine restano sullo
sfondo. Un indice e contrario di tale funzionamento lo troviamo
nell’attenzione che riserviamo alle “cattive notizie” o al “male”, e
che nei media alimenta il genere infinito della cronaca nera: se la nostra mente non focalizzasse normalmente l’ordine, probabilmente la
Premessa
7
“novità” costituita dal disordine delle “cattive notizie” non avrebbe
alcuna attrattiva su di noi.
Dal punto di vista dell’azione, il principio normativo non è altro
che la capacità di apprendere e seguire una regola di comportamento.
Infatti, esso non è un principio epistemico, poiché nell’inconscio morale non si manipolano solo conoscenze relative a stati di ordine o di
disordine, ma tali conoscenze sono al tempo stesso motivi di azione.
Insomma, rispetto all’inconscio cognitivo, l’inconscio morale ha una
sua peculiare dimensione pragmatica. E questo spiega l’importanza
del problema della genesi del principio normativo. La domanda che
si pone è se esso derivi dall’elargizione di ricompense e punizioni, e
quindi dalla ricerca del piacere e dall’evitamento del dolore, oppure
comporti la creazione di una rappresentazione di se stessi in cui è incorporata la concezione e il rispetto della regola. Quale che sia la risposta, in entrambi i casi abbiamo però a che fare con una asimmetria di base costituita da chi può elargire ricompense e punizioni, o
imporre delle regole, e chi deve evitare punizioni e ricercare ricompense, o seguire delle regole. È in questa asimmetria, se vogliamo,
che consiste la peculiare dimensione pragmatica del principio normativo cui accennavo prima.
Quanto al momento del disadattamento o crisi che innesca la presa di coscienza, sul piano ontogenetico la crisi è prevedibile e determinata, in quanto legata a circuiti di feedback tra maturazioni neurocerebrali e pressioni dell’ambiente. È così che, nelle indagini psicogenetiche di Piaget, sulle quali torneremo spesso nel corso di questo
libro, il bambino passa, ad un certo punto del suo sviluppo morale,
dal rispetto unilaterale al rispetto reciproco, anche se la necessità di
questo passaggio è tutt’altro che assoluta, come dimostra il fatto che
in mancanza di un corretto funzionamento di quei circuiti di feedback, l’acquisizione del principio normativo può fallire o risultare
parziale, impedendo o rendendo più difficile al soggetto l’accesso a
determinati assetti morali.
Questa forte prevedibilità del passaggio da una fase morale
all’altra sul piano ontogenetico, ha indotto teorici post–piagettiani
come Lawrence Kohlberg (1927–1987) a concepire i codici morali
come altrettante specie naturali disposte secondo una gerarchia evolutiva. Ma questa concezione irrigidisce la rappresentazione della
8
Premessa
vita morale, quando si consideri che ogni assetto morale, compreso
quello supererogatorio, resta per noi accessibile a seconda delle concrete esperienze che facciamo. Il che significa, d’altra parte, che il
disadattamento o crisi che può innescare la presa di coscienza non è
prevedibile secondo tipologie e classificazioni più o meno psicologiche (“è molto probabile che un individuo colpito da un lutto entro un
anno sviluppi una depressione, o abbia un grave incidente d’auto, o
sia colpito da infarto”), ma è una condizione latente della vita morale, dalla quale deriva la possibilità del suo rinnovamento (e non solo
di sedute psicanalitiche, di incidenti d’auto, o di applicazioni di bypass sia pure in day hospital).
Abbiamo abbozzato sin qui ciò che potremmo chiamare un modello naturalistico di mente morale, fondato sul carattere inconsapevole dei nostri meccanismi morali, che formano un inconscio morale
retto dal principio normativo. Ciò che, tuttavia, questo modello ancora non coglie, è che l’esperienza della crisi e della conseguente presa
di coscienza, trasformazione e ricostruzione dei propri assetti morali,
è esperita soggettivamente in un vissuto affettivo caratterizzato dal
disagio e dalla sofferenza, così come dal sollievo e dalla soddisfazione di essere pervenuti ad una nuova meta. Un vissuto che ha il
suo corrispettivo nella rottura del discorso monologico entro cui si era inseriti, e nell’apertura di un dialogo. Ciò, tuttavia, non deve far
pensare alla vita morale come ad un colloquio ben condotto che, di
stadio in stadio, conduce alle verità della saggezza. Il dialogo è il
sintomo della trasformazione dei rapporti morali entro cui
l’individuo è inserito, i quali, come abbiamo notato, sono sempre caratterizzati da un comandare e da un obbedire più o meno generici e
impersonali. Si tratta quindi di una situazione di conflitto che il dialogo traduce in simboli carichi di dolore e di gioia, di sofferenza e di
sollievo.
La conseguenza metodologica della soggettività con cui sono vissute le trasformazioni morali è l’assoluta libertà di mezzi e di metodi
per descrivere e spiegare questi stati di cose. Lo si può fare tramite
un discorso teorico che attinga a campi consolidati del sapere, ed è
ciò che qui ancora una volta faremo. Ma lo si può fare anche studiando casi singoli che mettono in gioco l’empatia del ricercatore,
sino all’autobiografia e all’invenzione verosimile, che è quello che
Premessa
9
forse un giorno si dovrà fare. Qual è allora la differenza tra questa libertà metodologica e la particolarità del romanzo? Come ha osservato Gao Xingjian,
Anche la filosofia in fondo è un gioco dell’intelletto. Si situa dove matematica e scienze esatte non arrivano e si dedica alla costruzione di raffinate architetture. Terminata la costruzione, finisce il gioco. A differenza della filosofia, il
romanzo è un prodotto della sensibilità che fonde in una miscela di desideri un
sistema di segni arbitrariamente costruito. Quando la miscela si amalgama e
genera nuove cellule nasce qualcosa di nuovo. Osservi il prodotto e lo trovi
molto più interessante di qualsivoglia gioco dell’intelletto. E come la vita non
ha un obiettivo (Gao Xingjian, 2002, p. 406).
Dunque, a differenza del romanzo, la filosofia non può fondere la
vita con l’arbitrarietà semiotica. Tuttavia, con il suo gioco intellettuale può chiarirne le strutture e i gradi, quale premessa per
l’accettazione di quella vita senza scopo che il romanzo, in quanto
vita, dice ma non spiega.
***
I testi che compongono questo libro, benché provengano da varie
sedi e risalgano ad epoche differenti, formano, giusta l’espressione di
poco prima, un gioco intellettuale unico, sia nel metodo che nel
contenuto. Il metodo consiste nella ricostruzione e nel confronto con
il pensiero di differenti autori, da Frege a Peirce a Lukács, da Vailati
a Della Volpe a Scarpelli, da Locke a Hobbes a Saussure, e altri ancora, con Piaget come costante punto di riferimento. Il contenuto è
costituito dalla riflessione intorno a temi quali la natura conflittuale
del comunicare tra menti discorsive finite; il rispetto come struttura
affettivo–morale evolutiva, in cui si forma la norma ma vengono poste anche le premesse della sua trasformazione; la libertà nel e dal
linguaggio come chiave per la comprensione teorica e storica
dell’essere sociale.
10
Premessa
Metodo e contenuti di questo gioco intellettuale, sin dal suo esordio sono stati indicati con il termine semioetica1, che stava nel titolo
di tutti e tre i testi preparati per altrettanti seminari tenuti, sempre per
amichevole sollecitazione di Daniele Gambarara, cui va la mia non
formale gratitudine, alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
della Calabria, il primo risalente al novembre 1996, e pubblicato nel
numero 13 del «Bollettino Filosofico» del Dipartimento di Filosofia
di tale Università; il secondo, al gennaio 2001, e stampato nel numero 16 dello stesso «Bollettino»; il terzo, al marzo 2004, e apparso nel
numero 20, sempre nella stessa sede. Tali testi, debitamente riscritti,
costituiscono ora, pur mantenendo l’originario tono colloquiale, i capitoli primo, secondo e quarto di questo libro.
Il terzo capitolo, invece, è il rifacimento di un saggio apparso in
lingua per i «Cahiers Ferdinand de Saussure» (56/2004), una cui
prima stesura in italiano costituiva un capitolo del mio libro Ordine e
trasformazione. Morale, mente, discorso in Piaget, édito nel 2003.
Il quinto e il sesto capitolo, infine, sono rielaborazioni inedite di
appunti utilizzati nei corsi di Semiotica, di Etica della comunicazione e di Filosofia morale da me tenuti negli ultimi anni alla Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Messina, ai quali hanno
partecipato studentesse e studenti che con il loro ascolto intelligente
mi hanno molto insegnato.
giugno 2007
1
Per le vicende terminologiche
http://www.semioetica.net/suggest.html
F.A.
di
questo
neologismo,
cfr.
Capitolo primo
Strutture normative e volontà del soggetto
1. LA RAGIONE ANTIMONISTA DI GIOVANNI VAILATI
Il 23 ottobre 1996, Lord Simon Brown, giudice della High Court
d’Inghilterra, ha deciso che le carte della società Fininvest di Silvio
Berlusconi, sequestrate precedentemente a Londra dalla polizia inglese nella sede di una società collegata, dovevano essere consegnate
alla procura della Repubblica di Milano, la quale, con una rogatoria
internazionale, ne aveva fatto richiesta. In sé, questo fatto non può
interessare la semioetica, ma le motivazioni del provvedimento stese
dall’alto magistrato inglese, quelle sì, presentano un qualche interesse per questo indirizzo di studi che cerchiamo di sostenere il meno
indegnamente possibile.
Infatti, nel suo dispositivo di sentenza, come si dice con termine
tecnico, Lord Brown, rigettando l’assunto di uno degli avvocati del
magnate brianzolo, secondo il quale il pubblico ministero italiano «è
interessato a politicizzare certi casi che riguardano illustri uomini
politici per fini politici», scrive che «dire che i magistrati italiani
stiano facendo una campagna motivata da scopi politici, o che affrontino il caso Berlusconi animati da uno spirito di persecuzione
politica, significa fare un cattivo uso del linguaggio» (“L’Espresso”,
n. 45, 7 novembre 1996, p. 48. Corsivo mio).
11
12
Capitolo I
Il tema dell’abuso del linguaggio è tipicamente anglosassone, ed è
così vivo ed operante in quella cultura, che non lo troviamo solo nei
libri di filosofia, ma, come si vede, anche in sentenze giudiziarie dei
nostri giorni. Non si può dire certo lo stesso per l’Italia, dove non
solo non permea la vita quotidiana, ma è anche raro come tema di analisi e di riflessione filosofica. Giovanni Vailati (1863–1909) fa eccezione a questa regola.
Bisogna dire che con l’etichetta «abuso di linguaggio» ci si riferisce a una grande varietà di fenomeni linguistici. L’abuso di linguaggio rilevato da Lord Brown rientrerebbe, secondo la classificazione
fattane da Jeremy Bentham (1748–1832) nel suo classico Il libro dei
sofismi, nei «sofismi di pericolo» (Bentham, 1824, p. 42), cioè in
quei sofismi il cui contenuto è la prospettazione di un qualche pericolo, e il cui fine è di reprimere senz’altro ogni discussione suscitando allarme. Il loro uso è tipico del discorso politico o giudiziario.
Gli abusi di linguaggio studiati da Vailati riguardano invece quasi
sempre l’argomentazione filosofica e scientifica. Inoltre, la dizione
«abuso di linguaggio» non rende completamente la ricchezza delle
sue analisi, che ne fanno veramente un precursore in campi come gli
studi contemporanei di teoria dell’argomentazione che vanno sotto il
nome di informal logic (v. per esempio Alcune osservazioni sulle
questioni di parole nella storia della scienza e della cultura); o come
le ricerche retorico–linguistiche, soprattutto di area francese, sulla
“semantica” dei verbi, cioè sulle metafore “morte” con le quali, nel
discorso, si indicano operazioni di pensiero: la tal cosa “si basa”,
ecc. (v. per esempio I tropi della logica); o come, ancora, le analisi
semiotiche comparate della logica e del linguaggio (v. per esempio
La grammatica dell’algebra).
Il filo che lega questa varietà di contributi, con riferimenti a molteplici aspetti del linguaggio (Aqueci, 1998) e della scienza (Aqueci,
2000a), lo si può individuare tuttavia non tanto nella costruzione di
una qualche teoria linguistica, benché Vailati seguisse da vicino gli
«sviluppi straordinari» delle scienze linguistiche del suo tempo
(Scritti, II, p. 72), quanto piuttosto in un interesse per un uso sempre
più avvertito del ragionamento nell’argomentazione filosofica e
scientifica (v., per esempio, lavori come Il ruolo dei paradossi in filosofia e La caccia alle antitesi).
Strutture normative e volontà del soggetto
13
La sua fu, insomma, assieme ad altri suoi contemporanei, da Gottlob Frege (1848–1925) a Bertrand Russell (1872–1970), la cui opera
ebbe però più sviluppo e risonanza, una pioneristica filosofia analitica del linguaggio, il cui scopo era, come si esprimeva crudamente lo
stesso Frege, di «spezzare il dominio della parola sullo spirito umano» (Ideografia, p. 106). Un proposito che Vailati traduceva più mitemente nell’esigenza di migliorare e sanare il linguaggio ordinario
servendosi dei progressi del simbolismo logico (Epistolario, p. 174).
Nell’ultimo capitolo di questo libro, torneremo su questo punto.
Qui possiamo intanto osservare che l’approdo finale di Vailati al
pragmatismo rappresenta la costituzione in metodo filosofico di tale
pratica di analisi. Quale poi sia il significato più profondo di questo
metodo, lo si comprende dalla contrapposizione che Vailati instaura
tra il pragmatismo e ciò che egli chiama il monismo (Scritti, I, p. 90),
la tendenza cioè a generalizzare, a dissolvere le distinzioni, a ricercare in ogni cosa l’uno o il generale (Scritti, I, p. 91) — in altri termini,
la riduzione della riflessione scientifica e filosofica alla mera attività
di identificazione.
Questo pragmatismo antimonista e dalla forte sensibilità storico–genetica — per Vailati, uno dei meriti del metodo di presentazione della logica che il suo maestro, Giuseppe Peano (1858–1932), aveva adottato, era il saper dare di tale disciplina un’idea non «statica» ma «nel suo moto e sviluppo» (Scritti, I, p. 69) — troverà il suo
punto d’equilibrio nel criterio empirico della verificabilità degli enunciati e delle teorie da contrapporre alla tendenza identificatrice
(Scritti, I, p. 91).
Qualche decennio dopo, altri, come ad esempio Jean Piaget
(1896–1980), un autore che nella sua riflessione epistemologica ripercorre gli stessi passi di Vailati, dall’interesse per il ragionamento
cui accedere tramite il linguaggio, all’analisi dei concetti di definizione, di identità, di causalità, allo studio infine della natura della logica e della matematica, adotteranno per così dire una strategia più
d’attacco. Per restare a Piaget, egli non sceglie la strada della critica
linguistica dell’argomentazione filosofica e scientifica, ma denunciando «quel mostro amputato che è la ragione esclusivamente identificatrice» (Piaget, 1971, p. 161), mira a determinare, in una pro-
14
Capitolo I
spettiva genetica, le strutture che fanno della ragione una attività
produttrice di novità.
I risultati di questa differente strategia si vedono, ad esempio,
nella rispettiva concezione della matematica. Per Vailati, la matematica è un’«attività creatrice», in quanto è indipendente «da ogni riferimento agli oggetti o alle relazioni di cui essa tratta, e alle quali essa
è capace di venire applicata» (La più recente definizione della matematica, in Scritti, I, pp. 11–12). Piaget, che pure perviene ad una
concezione simile, si spinge sino ad analizzare le strutture di tale
creatività, come mostra la sua teorizzazione intorno alle astrazioni riflettenti che procedono dall’azione del soggetto (Piaget, 1971, p.
181).
In altri termini, la concezione di Vailati della matematica come
pura sintassi infinitamente interpretabile, si arricchisce in Piaget di
considerazioni intorno alla formazione del soggetto della conoscenza, per cui la matematica e, come accenneremo dopo, anche la logica, saranno concepite come una “emergenza” delle azioni concrete
del soggetto.
Su Piaget torneremo in chiusura di questo capitolo, e più volte,
nel corso di questo libro. Intanto, per concludere su Vailati, vorrei
ancora osservare come il suo pragmatismo antimonista non concerne
solo la teoria della conoscenza, ma anche altri aspetti della riflessione filosofica. Colpisce, ad esempio, la nettezza con cui egli coglie la
differenza che il significato svolge nel campo pratico rispetto a
quello teorico. Nel campo pratico, egli dice, il significato si presenta
sempre come intimamente connesso «alle questioni di interpretazione della volontà altrui» (Scritti, II, p. 54. Corsivo dell’autore). A
questo proposito, uno storico della filosofia molto serio come Mario
Dal Pra ha sostenuto che, sebbene a Vailati non mancasse la consapevolezza filosofica dei «problemi dell’uomo», cioè dei problemi
propri dell’etica e della politica, egli non seppe aprirsi la via verso di
essi (Dal Pra, 1971, p. L). Questo rilievo critico è accettabile se si ricerca in Vailati il sistema compiuto. Tuttavia, la costruzione di un
tale sistema non era fra gli scopi della sua attività di pensiero. Piuttosto, con un lavorìo critico fatto di saggi e interventi, in cui si avvertono, per quanto filtrate da un pessimismo di fondo, le speranze di
progresso del suo tempo, egli mirava ad affermare il valore civile del
Strutture normative e volontà del soggetto
15
retto ragionare (Aqueci, 2000b). Un intento ostacolato dalla sua
prematura scomparsa, e che comunque non avrebbe trovato facile rispondenza nei cambiamenti sociali e politici che già si preannunciavano.
2. IL VOLONTARISMO DIALOGICO DI GUIDO CALOGERO
Sotto la tormenta, per parafrasare il titolo di un famoso libro di
George Sorel (1847–1922), i semi gettati da Vailati non marcirono.
Nel secondo dopoguerra, in cui il rinnovamento degli studi si accompagna all’avvio di un lungo periodo di sviluppo e di trasformazioni sociali, politiche e di costume, ci si avvede dell’importanza
delle sue precorritrici riflessioni epistemologiche e linguistiche, e le
questioni etico–politiche legate all’«interpretazione della volontà altrui» ritornano al centro della riflessione filosofica. Sebbene per altri
stimoli e in modo del tutto autonomo, è questo il caso di Guido Calogero (1904–1986).
Per Calogero, l’«interpretazione linguistica» coincide con «tutto il
problema del linguaggio», con «tutta la semantica come scienza
dell’espressione e della comunicazione» (Logica, p. 21). Tuttavia,
questa «forma di ermeneutica del segno», di «interpretazione semantica delle parole e degli indizi» (ibidem) è anche sin dall’inizio
una nozione etica. Ciò che distingue, infatti, l’interpretazione linguistica dall’interpretazione scientifica è «la sua costitutiva attenzione
per la personalità», «la sua specifica direzione verso l’altrui coscienza» (ibidem). L’interpretazione scientifica spersonalizza gli eventi,
l’interpretazione linguistica assume interamente l’«altruità» o «altrui
egoità» (Etica, p. 132 e p. 138).
Sulla base di queste consapevolezze, che la distinzione di Vailati,
sebbene solo in negativo, già implicitamente conteneva, Calogero avanzerà verso la teoria della «situazione dialogica» (Logo e Dialogo,
p. 14). Una teorizzazione che procede lungo due dimensioni, una etico–discorsiva, l’altra più propriamente linguistica. La prima dimensione costituisce una teoria del dialogo. La seconda, un’indagine circa la natura del segno linguistico. Benché queste due dimensioni vivano unitariamente nel concetto di interpretazione linguistica, Calo-
16
Capitolo I
gero stesso prenderà atto ad un certo punto che l’una non si risolve
interamente nell’altra, e distinguerà infatti tra il linguaggio come
«alterno sforzo di capire e del farsi capire, dell’interpretare e del comunicare» (Logo e Dialogo, p. 16), ed il linguaggio «come modo
d’agire della stessa conoscenza per sé presa» (ibidem). Autorizzato
anche da queste oscillazioni dello stesso Calogero, esporrò qui distintamente le sue argomentazioni circa le due dimensioni sopra richiamate.
2.1.
La teoria del dialogo
L’interpretazione linguistica è dunque quella forma di ermeneutica del segno la cui specifica direzione è l’altrui coscienza. Tuttavia,
per quanto ci si sforzi, l’interpretazione linguistica non giunge mai a
saltare «il vallo dell’egoità» (Etica, p. 132), poiché l’altruità si presenta sempre come un dato irriducibile (Etica, p. 138). Questa impossibilità a realizzare l’identità con l’altro soggetto non dovrà essere vista come un difetto, bensì come una caratteristica propria della
struttura dialogico–morale. L’indagine etica ci insegna, infatti, che
ogni genuina morale vive della tensione di due bisogni, quello di investirsi nella persona altrui, e quello di non raggiungere mai l’“altro”
(Etica, p. 141). Il processo ermeneutico, dunque, in ciò soddisfa la
natura dell’esperienza morale che lo definisce.
D’altra parte, la tensione verso l’altro che definisce, ad un tempo,
la natura dell’esperienza morale ed il processo ermeneutico, non può
essere oggetto di dimostrazione logica. Come mostra, infatti,
l’indagine sulla genesi storica delle forme logiche — un’indagine
che Calogero, quale storico della logica antica, condusse in prima
persona — il principio di non–contraddizione, la coerenza semantica, i modi del sillogismo non sono altro che «schemi atti ad ostacolare gli indebiti sviamenti nell’assunzione del significato dei termini
durante il corso di un colloquio» (Etica, p. 160). La loro natura è interamente discorsiva1, ma in quanto «appelli alla lealtà», in quanto
1 Il principio di contraddizione, ad esempio, è nato quando, dopo aver riconosciuta alla
particella “è”, interposta tra due vocaboli, la funzione di indicare la pertinenza di quanto era
designato dal primo, e al nesso “non è” quella di indicare invece l’esclusione di tale pertinenza, si stabilì che il significato di “A è B” escludeva assolutamente quella di “A non è B”,
Strutture normative e volontà del soggetto
17
«norme» del gioco linguistico, essi servono soltanto a migliorare
l’efficienza comunicativa della conversazione, a far sì che nel colloquio non prevalga lo spirito di sopraffazione verbale (ibidem). Con
una formula molto concisa e molto attuale, se si pensa all’odierna ripresa della filosofia pratica, Calogero può allora concludere che
«non è […] la logica che sorregge la morale, ma al contrario la morale che rende possibile la logica, in quanto particolare etica della discussione» (Etica, p. 160).
Ora, per Calogero, la morale si fonda su un atto di volontà libero.
Ad essere altruisti, bisogna decidersi, e per questa decisione si è soli con sé
medesimi: soli con la propria volontà e libertà. Non si può esigere nessun motivo o pretesto. Si deve avanzare d’iniziativa propria, senza che i ponti alle
spalle siano stati tagliati dalla ragione (Etica, p. 164).
E tale atto trae la sua origine non dalla dimostrazione logica ma
dall’esempio morale.
Quel che conta non è l’apodeixis, la “dimostrazione” razionale, ma bensì il
paradeigma, l’“esempio” personale: il quale è, anch’esso, un modo di deikninai, di “mostrare” e far vedere e mettere sotto gli occhi, ma un modo che impegna infinitamente di più, che non permette di restare nell’adiaforìa argomentante. Si dimostra un teorema, e si può truffare un amico, senza che ciò comprometta l’efficienza della dimostrazione. Ma non si può ingannare, e educare
alla moralità: non si può adoperare l’indifferenza della tecnica, che serve insieme per il bene e per il male, allorché il problema è quello di far amare il bene, di richiamare l’animo dalle lusinghe del male. Come la “logica” deve mutarsi in eloquenza, in vivo moto e ridestamento di affetti, così l’esempio diventa la pagina più persuasiva, per dimostrare agli altri in che modo si debba
vivere. Educare all’ethos è la cosa più difficile, ed insieme la più alta che
l’uomo possa fare al mondo: e come potrebbe pretendersi che vi riuscisse con
quattro argomenti, senza mettervi in giuoco tutta la sua umanità, senza dare egli stesso un esempio di vita, impegnando in ciò tutta quanta la vita? A tale
scopo, più che la logica dei sillogismi, giova la logica dei martiri e degli eroi
(Etica, p. 168).
e viceversa. In questo senso, il principio di contraddizione, conclude Calogero, «non poteva
spiegare efficacia che in un mondo della dizione», opposto al mondo asemantico della pratica (Estetica, p. 215).
18
Capitolo I
Questo dell’esempio morale è uno dei punti su cui torneremo
quando avremo terminato l’esposizione del pensiero etico–discorsivo
di Calogero. Intanto, prendiamo atto che quel medesimo atto di volontà libero che fonda la morale, fonda anche il dialogo. E fonda anche la legge.
Un accenno merita ciò che Calogero dice intorno alla legge. La
legge, nella sua concezione, appare completamente immersa nel processo ermeneutico. Infatti, ogni legge è, sì, una dichiarazione di volontà, ma essa è tale in quanto «enunciazione verbale d’una richiesta
rivolta ad altri» (Etica, p. 264). «Non c’è legge — sostiene Calogero
— senza parola, e quindi senza un parlante ed una, o più, altre persone che l’ascoltino e la capiscano» L’attività giuridica è quindi una
delle tante facce del comunicare dialogico, sia in quanto manifestazione della volontà del legislatore, sia in quanto comprensione di tale
volontà da parte dei soggetti sottomessi alla legge: «non si capisce la
volontà di legge senza risalire dalla formula all’intenzione legislatrice, col consueto processo di ricostruzione ermeneutica di ogni situazione della consapevolezza altrui» (Etica, p. 299).
Ma come nasce, secondo Calogero, la norma giuridica? Che cosa
legittima l’enunciazione giuridica? Perché si è tenuti ad ascoltare e,
quando occorra, interpretare la legge? Fare ricorso all’ipotesi del
contratto, tanto nel caso della norma giuridica quanto nel caso della
norma linguistica, comporta, per Calogero, di incorrere in una petizione di principio (Etica, p. 328). Infatti, nel caso di quest’ultima, ci
si trova nella singolare situazione di dover «presupporre che gli uomini già s’intendano tra loro per potersi accordare sui nomi da dare
alle cose» (ibidem). Analogamente, nel caso della norma giuridica,
quando essa non nasca dall’iniziativa di volontà individuali, ciò che
è la normalità storica, non è la legge che presuppone il contratto, ma,
al contrario, è il contratto che presuppone la legge, intesa
quest’ultima, appunto, come manifestazione di volontà (ibidem).
Siamo così rinviati ancora una volta al volontarismo altruistico
che in Calogero fonda con un unico movimento la morale, il dialogo,
il diritto e la politica, come si può vedere da questa citazione:
Come l’altruismo non discende dal diritto delle altrui persone, ma bensì il
diritto delle altrui persone dalla volontà altruistica di capirle, così il principio
liberale del consenso e della rappresentanza non si deduce dalla pluralità dei
Strutture normative e volontà del soggetto
19
cittadini dello stato, ma solo dalla volontà che questi stessi cittadini possano
intervenire al massimo col proprio libero convincimento, nell’instaurazione
medesima delle norme coercitive (Etica, p. 333).
In altri termini, non è il fatto empirico della eterogeneità delle opinioni che fonda il principio del consenso, ma la volontà di garantire a tutti i cittadini l’espressione del proprio convincimento, nel momento in cui si enuncia una norma giuridica o si perviene ad una decisione politica.
2.2.
La teoria linguistica
Questo rifiuto della teoria del contratto è un altro dei punti su cui
torneremo alla fine, Ma veniamo per ora alla teoria linguistica che,
nella filosofia del dialogo di Calogero, è come un lungo intermezzo.
Dopo un primo tempo in cui vengono posti i principi cha abbiamo
appena visto, si esplorano poi con i ritmi dell’adagio i confini del
linguaggio, per ritornare infine con l’impeto del mosso al tema iniziale del dialogo, ma con l’arricchimento di variazioni e sfumature
che il lungo intermezzo linguistico consente. In questo intermezzo,
l’identificazione di arte e linguaggio, di intuizione estetica ed espressione, affermata da Benedetto Croce (1866–1952), fa da contrappunto ad una concezione del linguaggio, al tempo stesso, referenzialista, empirista e realista che Calogero va sbozzando.
L’esperienza del linguaggio, scrive Calogero (Estetica, p. 124),
ha questo fondamentale carattere: che quel che si ama, o si odia, ciò
che è oggetto della nostra gioia o del nostro dolore, non è mai il segno, ma il significato. Il segno, dunque, ha questa essenziale natura,
di non costituire mai il termine reale della nostra azione, poiché essa
ha sempre un «eidos», cioè un mondo di possibilità rappresentate,
verso cui si orienta, o da cui rifugge (ibidem). Certo, continua Calogero, «ogni segno può essere significato da un ulteriore segno, in una
illimitata catena di riferimenti semantici» (Estetica, p. 125). Ma questa catena semiotica deve pur pendere da qualche anello. E lo stabile
ed ultimo anello a cui è assicurata, è appunto «quell’immediato volto
della nostra pratica e consapevole realtà, la cui cancellazione cancellerebbe il senso della nostra vita, tuffandola senz’altro nel fiume
del nulla» (ibidem).
20
Capitolo I
Se la semiosi illimitata è puro suono che annulla il mondo (Estetica, p. 178), e se, invece, la realtà, oggetto e causa del nostro piacere
e del nostro dolore, è là, che richiede di essere detta, allora il linguaggio è essenzialmente un’«esperienza di riferimento». Più precisamente, il linguaggio è la designazione di uno degli aspetti
dell’«immediato volto della vita» mercé un altro qualsiasi di tali aspetti (Estetica, p. 125). In tal senso, il linguaggio è indifferente al
«contenuto d’esperienza» di cui si serve per designare, ma tutto concentrato invece sul «rapporto di designazione» stesso. Arbitrarietà
del linguaggio, dunque, in quanto rapporto di designazione (Estetica,
p. 125 e p. 179). Ma anche storicità del linguaggio, poiché esso persiste come un’abitudine in una più o meno vasta cerchia di uomini, i
quali, quindi, reagiscono con un salutare spirito di conservazione ad
ogni tentativo di innovazione rivoluzionaria (Estetica, p. 180). Tuttavia, la storicità del linguaggio non ci deve indurre ad accettare
l’idea arcaica di una congruenza naturale del segno al significato (Estetica, p. 181). La costituzione del rapporto arbitrario di designazione è invece opera dell’«infinito ripetersi e rinnovarsi del colloquio
umano» (ibidem). Tutto ciò per Calogero è una conferma del carattere strumentale e comunicativo del linguaggio.
Per questo aspetto, nulla di più prettamente strumentale, di più radicalmente subordinato alla sua capacità d’uso, del linguaggio. La sua bontà è tutta
nella sua efficienza comunicativa: se con esso ci si intende, lo scopo è raggiunto; e quanto meglio ci si intende, tanto più esso è un bel linguaggio. Di qui
il fatto che nell’uso, cioè nella più frequente o stabilizzata consuetudine dei
parlanti sta il canone ultimo della funzionale correttezza di una lingua (ibidem).
A proposito del linguaggio come strumento di comunicazione,
vedremo più sotto che sarà possibile enucleare in Calogero un significato più forte di tale principio, che ha rapporti più stretti con
l’insieme della sua elaborazione filosofica. Intanto, rileviamo come
in questa fase della sua elaborazione, che si attesta su una posizione
di referenzialismo classico, la sua terminologia è ancora abbastanza
rudimentale, come si può vedere da qualche passo dove il termine
“segno”, usato come sinonimo di “significante”, è inteso come etichetta sonora o grafica del significato o cosa (Estetica, p. 125).
Strutture normative e volontà del soggetto
21
Tuttavia, cessata l’urgenza di affermare contro Croce
l’irriducibile presenza della realtà e la conseguente natura comunicativa del linguaggio, Calogero mostra di avere una concezione più
scaltrita della natura del segno. Anche qui egli muove dal rifiuto
dell’identificazione crociana di intuizione ed espressione, ma da una
posizione, per così dire, semioticamente più interna, che prende in
considerazione non più il rapporto tra intuizione ed espressione, bensì la natura stessa dell’espressione, cioè dei segni linguistici.
Calogero comincia dicendo ancora un po’ genericamente che «ogni parola, ogni strumento semantico ha […] sempre due facce:
quella immediatamente propria, e quella del contenuto mentale che il
suo apparire deve presentare alla coscienza» (Estetica, p. 173). Ma
poco più sotto chiarisce qual è l’effettiva natura delle «due facce» di
ogni parola: «Nessuno che sente dire “pane” vi sente soltanto due
consonanti e due vocali, bensì sente insieme orientato il suo sguardo
mentale, da quel contenuto fonetico, verso il diverso contenuto visivo costituito dall’immagine del pane» (Estetica, p. 173).
Da qui la conclusione che l’espressione, cioè il linguaggio, è «non
già un’intuizione, ma bensì un rapporto funzionale di due intuizioni,
di cui l’una rinvia all’altra, cosicché l’una è segno e l’altra senso,
l’una significante e l’altra significato» (Estetica, p. 174).
Come si vede, mentre nel momento più acceso della polemica
anticrociana, il segno come etichetta veniva globalmente messo in
corrispondenza con un significato o cosa, qui il rinvio semantico avviene fra due intuizioni, l’intuizione sonora, o significante, e
l’intuizione eidetica o mentale, il significato. Quale sia la natura del
«rapporto funzionale» che lega significante e significato, Calogero
non lo dice. Resta il fatto che, spinto dalla polemica anticrociana, egli riesce a staccare il segno dall’ingenuo ancoraggio realistico, e a
concepirlo come fenomeno strutturalmente duale e dalla natura interamente psichica.
2.3.
Ritorno al dialogo
Dunque, per Calogero il segno è un’entità psichica a due facce,
cioè il rapporto funzionale di un’intuizione sonora e di un’intuizione
eidetica.
22
Capitolo I
Da premesse simili, Ferdinand de Saussure (1857–1913), di cui
tratteremo più oltre approfonditamente (cap. V), tirò una teoria del
valore linguistico che, prendendo a modello l’equilibrio economico
della scuola marginalista (Molino, 1984), fa della lingua un sistema
dove si scambiano valori. Roland Barthes addirittura osservò che il
modello di Saussure è la democrazia intesa come contratto sociale
(1973, p. 87). Vedremo quanto è fallace questa idea, salvo considerare la democrazia come un plebiscito permanente. Quanto a Calogero,
egli, oltre a diffidare, come abbiamo visto prima, dell’idea di contratto, non si interessa ad una teoria della lingua come sistema linguistico. Anche questo è un altro punto che, assieme all’esempio
morale e al rifiuto dell’idea di contratto, dovremo valutare alla fine
in sede critica.
Per ora limitiamoci ad illustrare come la nuova concezione del
segno, emersa nella polemica anticrociana, dia i suoi frutti quando
Calogero torna a trattare del rapporto tra la logica, la grammatica e il
linguaggio.
Per Calogero, la logica come sillogistica non è altro che «linguaggio cristallizzato», «linguaggio ridotto ad immobile schema»,
«una raccolta di schemi verbali» (Estetica, p. 215). E quanto alla
grammatica, le astratte strutture morfologiche non sono altro che
«schemi di schemi, classi generalissime di atteggiamenti semantici»
(Estetica, p. 219). Dunque, logica e grammatica «non sono entrambe
se non schematizzazioni arbitrarie, compiute per questo o quello
scopo pratico, dell’unica realtà vivente del linguaggio» (ibidem).
Ma, si chiede Calogero, in questo ridurre a schemi linguistici la
logica, in questo negare il carattere di logicità agli schemi verbali, in
altri termini, in questo richiamarsi alla «realtà vivente del linguaggio», così come faceva Croce, non c’è il rischio di aprire la via, assieme ad una concezione vitalistica del parlare, anche all’irrazionale?
La garanzia contro questo rischio, secondo Calogero, sta sempre
nella buona volontà d’intendere cose e persone (Estetica, p. 229). La
serietà dell’attenzione critica, l’onestà della discussione, egli afferma
in modo ancora sorprendentemente attuale, «non è questione di logica, bensì questione di pratico comportamento, faccenda morale: oggetto di quel particolare capitolo della filosofia della prassi, che è la
morale del colloquio, l’etica del linguaggio» (Estetica, p. 231).
Strutture normative e volontà del soggetto
23
Ancora una volta, dunque, ed ora dopo il lungo intermezzo linguistico, torna a stringersi quel nodo di etica, logica, e linguistica che
spiega come si instaura e funziona il dialogo, la cui forma più alta e
compiuta è il «dialogo scientifico» (Estetica, p. 198), al quale, pur
nella sua peculiarità, deve tendere anche la comunicazione politica
(Calogero, 1946). Ed è il modello del dialogo scientifico che chiarisce la sua concezione del linguaggio come strumento di comunicazione. Infatti, a differenza di quanto accade nella pratica, dove domina l’«ideazione diretta» che fa a meno della mediazione dei segni,
nel dialogo scientifico il linguaggio ci si presenta pienamente come
«ideazione parlata», attraverso cui il colloquio avanza di termine in
termine con un «processo di rinvio» semantico continuo, senza dover
ritornare, se non in piccola parte, alle cose (ibidem). In Calogero,
allora, la concezione strumentale del linguaggio, più che all’idea di
trasmissione di informazioni già date, si avvicina al modello giudiziario dell’istruire una causa2. in cui non basta raccogliere prove,
produrre memorie, presentare istanze, ma dove occorre dimostrare,
mettere in scena pubblicamente il proprio interno discorso. La comunicazione, allora, appare come l’ideazione pubblica di contenuti
discorsivi individuali.
2.3.1.
Excursus: Calogero e Vico
I temi che stiamo esaminando, rendono opportuno un accenno
alle critiche che Calogero formula nei confronti di Giambattista Vico
(1668–1744), e ciò sia in ragione dell’interesse in sé dei punti di vista avanzati, sia per quanto meglio ci fa capire delle sue posizioni
filosofico–linguistiche.
1) Un primo punto riguarda il significato delle etimologie proposte da Vico nel De antiquissima Italorum sapientia, in particolare
quella concernente la formula verum et factum convertuntur. Il richiamo a Vico avviene alla fine dell’esposizione di una sua originale
concezione dell’etimologia.
2 Devo questa suggestione a Jean–Blaise Grize (lettera privata, 8 gennaio 1993).
24
Capitolo I
Calogero distingue tra il «tema fonetico» o «tema etimologico»,
che corrisponde a ciò che i glottologi chiamano «radice», e il «tema
semantico», che è invece costituito dall’identità translinguistica di un
certo modo di designazione metaforica (Estetica, pp. 206–207). Per
esempio, in tedesco si ha il termine Anschauung, la cui radice o tema
fonetico è Schau; mentre in italiano si ha considerazione, la cui radice o tema fonetico è sidus. Si hanno dunque due temi fonetici, ma uno stesso tema semantico, cioè l’attività teoretica designata con la
metafora della visione. È solo a livello del tema semantico che, secondo Calogero, si possono fare legittimamente delle osservazioni
circa lo spirito di una lingua (Estetica, p. 210).
Ora, per tornare a Vico, Calogero suggerisce che egli,
nell’indagine etimologica su cui fondò tutto l’edificio del De antiquissima Italorum sapientia, altro non fece che ricercare temi semantici, e interpretarli come documentazioni di atteggiamenti spirituali del passato (Estetica, p. 211). In particolare, egli interpretò
l’uso linguistico registrato in antichi testi latini di factum est equivalente a verum est, come l’espressione del tema semantico secondo il
quale la verità è il prodotto di un facere mentale. Tuttavia, sostiene
Calogero, è assai più probabile «che quell’uso linguistico sia nato
invece dalla semplice parificazione del “vero”, nella sua identità col
“reale”, al “fatto” non già dell’azione conoscitiva ma proprio
dell’azione pratica, all’incirca allo stesso modo in cui sorgono, sia
nell’accezione corrente sia in quella positivistica, le locuzioni per cui
si chiedono non astratte idee, ma bensì “fatti”, verità “di fatto”, cose
che “stiano di fatto”, e così di seguito» (Estetica, p. 212). Dunque,
la corroborazione del principio gnoseologico del verum et factum
convertuntur, che Vico intendeva effettuare tramite la ricostruzione
storica del tema semantico soggiacente all’uso di significare verum
est con factum est, non può essere raggiunta, se non commettendo
l’errore di attribuire la sua stessa concezione gnoseologica
all’antichissima sapienza italica (Estetica, p. 211).
2) Un secondo punto concerne la discussione da parte di Calogero
del carattere metaforico del linguaggio sostenuto da Vico (Estetica,
pp. 93–98).
Strutture normative e volontà del soggetto
25
Il metaforeggiare, concede Calogero a Vico, è intrinseco al linguaggio. Tuttavia, per quanto frequentissimo, non è né onnipresente
né indispensabile. Nel linguaggio infatti non mancano le parole che
non presuppongono alcun processo metaforico, come è nel caso delle
parole che nascono da sigle, o come è nel caso delle onomatopee (Estetica, p. 96).
Quanto poi al fatto che la metafora sia sempre poetica, anche qui
Calogero obietta a Vico che «come il linguaggio è molto spesso metaforico, ma non sempre metaforico, così la metafora è qualche volta
poesia, ma non sempre poesia» (Estetica, p. 97).
In conclusione, contrariamente alle estensioni abusive di Vico, il
quale attribuì al linguaggio una natura radicalmente metaforica, e vide in ogni metafora manifestarsi una radicale forza poetica (Estetica,
p. 96), si deve distinguere, secondo Calogero, tra una «metafora lirica» e una «metafora semantica» (Estetica, p. 98). E geneticamente
bisogna porre prima la metafora semantica, e poi quella lirica. Infatti,
in quanto espressa nel mondo del linguaggio, la metafora lirica è implicitamente anche una metafora semantica: «parlare è una cosa,
cantare è un’altra, anche se la lingua è la stessa per entrambe» (ibidem).
3) Un terzo punto di discussione, infine, che si riattacca immediatamente al punto di sopra, concerne ciò che Calogero chiama «il
carattere radicalmente oratorio del linguaggio», che è per lui
l’occasione di riassumere tutta la sua concezione del linguaggio.
La dottrina crociana della linguistica–estetica, dice Calogero,
concepisce la comunicazione come l’estrinsecazione di un contenuto
già tutto dato nell’intuizione prelinguistica. Così facendo, però, essa
non può spiegare come un contenuto semantico passi da un soggetto
all’altro, e non è un caso che il problema della molteplicità dei soggetti resti in questo sistema praticamente in sospeso (Estetica, p.
241). Concependo il linguaggio, invece, come l’ideazione pubblica
di contenuti discorsivi individuali, si supera il paradosso crociano di
una incomunicabilità che comunica.
Ciò deve portare, secondo Calogero, a escludere definitivamente
«la classica idea vichiana, ripresa dal Croce, della priorità del linguaggio poetico rispetto al linguaggio oratorio» (Estetica, p. 245).
26
Capitolo I
Infatti, nota Calogero, «prima si parla e poi si canta; prima si ottempera alle immediate pratiche necessità, poi si apprende a superare la
brama e la malinconia nell’esperienza dell’arte» (Estetica, p. 246).
La tesi di Vico sull’originario carattere poetico del linguaggio è
stata vista come l’archetipo di ogni concezione della comunicazione
come comunione linguistica dei parlanti (De Mauro, 1965, p. 61). Il
suo principio del verum factum ha consentito di avvicinarlo ad un
pragmatista come John Dewey (1859–1952) (Child, 1970), ha permesso ai costruttivisti cosiddetti «radicali» di rivendicarlo come
l’anticipatore del loro indirizzo di pensiero (Gash, Glaserfeld, 1978;
Glaserfeld, 1989), ed ha indotto ad accostarlo all’epistemologia genetica di Piaget (Mora, 1975; Rosnow, 1978), al quale per altro gli
stessi costruttivisti radicali si rifanno.
Il confronto che Calogero instaura con Vico non è riconducibile a
nessuna di queste interpretazioni, poiché si tratta, come abbiamo visto, di un rifiuto critico che serve a definire il punto di vista opposto
da cui lo stesso Calogero muove. Per Vico, la verità è generata
dall’azione, e il linguaggio è un’energia affettivo–semantica, prima
di essere uno strumento logico–discorsivo. Al contrario, per Calogero la verità comporta una frattura tra discorso e azione, e una sua costruzione oratoria, cioè quella ideazione parlata, la cui base sta
nell’atto di volontà che motiva l’intenzione comunicativa del singolo
parlante. Questa posizione gnoseologico–linguistica si accompagna
ad una conseguente posizione etica i cui fondamenti, come vedremo
fra poco, possono essere messi in luce proprio nel confronto con
Piaget.
3. LE TRASFORMAZIONI MORALI DI JEAN PIAGET
L’aspetto del pensiero di Piaget che vogliamo utilizzare per il
confronto con Calogero, è il modello sperimentale di morale che
Piaget costruisce osservando come i bambini praticano e concepiscono le regole dei loro giochi, e per analogia anche quelle propriamente morali. Il quadro che esce fuori dall’insieme delle sue osservazioni, si può compendiare come segue.
Strutture normative e volontà del soggetto
27
Durante i primi anni di vita del bambino, la costrizione anche lieve degli adulti si sovrappone all’originario bisogno di reciproco affetto, concepito da Piaget, in accordo con un’intuizione già espressa
da Kant nell’Antropologia pragmatica3, come la radice affettiva del
bene morale. In ragione di ciò, si genera una cristallizzazione di sentimenti di dovere la cui presa di coscienza linguistica avviene in termini di realismo morale. Questa primitiva forma di pensiero costituisce per un lungo tratto la coscienza morale del bambino, almeno sino
a quando, grazie ad un’ulteriore ricostruzione, non sarà colmato il
ritardo tra la pratica ormai cooperatoria e la coscienza teorica ancora
tutta impregnata di realismo morale. Nell’evoluzione psicogenetica,
vi sono perciò secondo Piaget due fasi. Nella prima si ha
un’appropriazione puramente verbale delle norme così come vengono ricevute dall’esterno. Nella seconda vi è una ricostruzione discorsiva dei principi già contenuti nell’azione, che incorpora nella norma
il bisogno di reciproco affetto rimasto ai margini della costruzione
morale.
Ora, il passaggio da una fase all’altra dipende dalla trasformazione di un sentimento particolare, il sentimento di rispetto. Rifacendosi
a Kant, e alla revisione critica della struttura normativa
dell’imperativo categorico operata da uno dei suoi maestri, Pierre
Bovet (1878–1965), Piaget concepisce classicamente il rispetto come
un sentimento misto di amore, ammirazione e timore, ma vi introduce una dimensione evolutiva in grado di tener conto delle trasformazioni cognitive ed affettive che intervengono nel corso della psicogenesi. È per questo che egli parla di passaggio dal rispetto unilaterale,
o monologico, al rispetto reciproco, o dialogico. Nella fase caratterizzata dal rispetto unilaterale, si potrebbe pensare che il discorso
normativo abbia efficacia solo perché chi lo tiene è investito
d’autorità. In effetti, spiega Piaget, le norme si instaurano perché chi
le pone è anche oggetto di ammirazione e timore da parte di chi le riceve. Nella fase, invece, caratterizzata, dal rispetto reciproco, il di-
3 «Fu saggezza della natura averci data la disposizione alla simpatia per guidarci provvisoriamente, prima che la ragione sia giunta alla sua propria forza, l’aver cioè aggiunto
all’impulso morale verso il bene anche lo stimolo patologico (sensibile), come surrogato
temporaneo della ragione» (Antropologia pragmatica, p. 143).
28
Capitolo I
scorso normativo risulta da una negoziazione tra soggetti che tendono a divenire formalmente eguali.
Questa concezione dello sviluppo morale è stata fatta propria da
John Rawls (1921–2002), che l’ha incorporata nella seconda parte
della sua Teoria della giustizia (1971), per spiegare l’apprendimento
dei principi normativi di base della «società giusta». Tuttavia, a dispetto delle apparenze, le due prospettive sembrano divergere radicalmente. Infatti, mentre Rawls muove da una concezione della morale come conoscenza, e vede nello sviluppo morale la maturazione
di una competenza in qualche modo comparabile ad una grammatica
linguistica di tipo chomskyano, Piaget al contrario concepisce la morale come un fatto di discorso legato ad una prassi, e vede lo sviluppo morale come l’effetto del comportamento all’interno di un rapporto sociale in trasformazione. Da queste premesse deriva che
mentre Rawls pone l’accento sull’instaurazione di un ordine, Piaget
si interessa alle condizioni degli equilibri ideali, sia pure sempre
dentro i limiti di una «morale provvisoria» di tipo cartesiano.
Come si vede, l’accettazione da parte di Rawls del modello di
sviluppo morale a due fasi di Piaget nasconde una divergenza teorica
di fondo che non dovrebbe essere trascurata. Se lo si fa, si rischia di
assimilare le trasformazioni morali di Piaget ad un’uniforme «morale
autoritaria» del rapporto tra genitori e figli, sul quale lo stesso Rawls
modellerebbe il rapporto normativo più maturo tra individui e istituzioni (Maffettone, 2001, pp. 169–170). Posto così il problema, diventa giocoforza avanzare l’esigenza di integrare elementi psicoanalitici in grado di fornire un quadro più mosso della formazione di
quel «senso di giustizia» con cui secondo Rawls la persona dovrebbe
operare nelle istituzioni (Maffettone, 2001, p. 170). Tuttavia, vedremo nel prosieguo, in particolare nel capitolo secondo, che tale esigenza può essere perseguita non tanto contro una supposta «morale
autoritaria», che la semplificazione di Rawls autorizzerebbe a scorgere nel modello di Piaget, quanto per superare un residuo di naturalismo che in esso persiste.
Intanto, in tale modello, con riferimento al sintetico resoconto che
ne abbiamo fatto sopra, si possono mettere in evidenza tre fatti: 1)
l’esistenza di una fonte energetica originaria, cioè il bisogno di reciproco affetto; 2) l’esistenza altresì, non di una complessiva «morale
Strutture normative e volontà del soggetto
29
autoritaria», ma di due forme della morale, il rispetto unilaterale e il
rispetto reciproco, cui corrispondono due fasi della mente morale,
cioè il realismo morale e il pensiero morale critico; 3) il rapporto genetico, infine, che lega la fonte energetica originaria alle due forme
di rispetto, in particolare al rispetto reciproco, i cui prodotti normativi acquistano cogenza a condizione di incorporare l’energia affettiva
originaria.
La concezione della morale che emerge, allora, è quella di una
struttura che evolve instaurando un ordine logico–pragmatico, al
quale i singoli contribuiscono con lo sviluppo della propria mente,
divenendo così individui della totalità sociale. Una compatta morfogenesi cognitivo–morale che può essere illustrata con la seguente affermazione di Piaget: «La logica è una morale del pensiero, come la
morale è una logica dell’azione» (Il giudizio morale nel fanciullo, p.
328).
Se confrontiamo ora questa affermazione con quella che compendia la teoria dell’interpretazione linguistica di Calogero, vediamo che
le cose, all’apparenza simili, sono in realtà radicalmente differenti.
Come sappiamo, Calogero afferma: «Non è la logica che sorregge
la morale, ma al contrario la morale che rende possibile la logica, in
quanto particolare etica della discussione» (Etica, p. 160).
Come si vede, mentre in Piaget c’è una linea evolutiva che va
dall’interazione affettiva alla norma logica impregnata di comando
morale, in Calogero c’è una circolarità che riconduce tanto la norma
logica interpretata eticamente, quanto la morale che rende possibile
la logica, all’unico piano del dire, poiché come sappiamo solo qui
può dispiegarsi l’atto di volontà, sia esso linguistico, morale o etico–politico. Infatti, l’unico, apparente aggancio al piano del fare è
l’esempio morale, ma si tratta in effetti di un dire muto o di una mutezza eloquente che non fuoriesce dal piano del dire, il quale perciò
si presenta come un dire già a priori etico. Con la conseguenza decisiva che il fondamento dell’atto di volontà altruistico, al di là di ogni
evoluzione della struttura, è rimandato all’insondabile coscienza del
soggetto.
Assieme a quello dell’esempio morale, possiamo ora sciogliere
anche gli altri nodi che si sono venuti accumulando nell’esame del
pensiero etico–discorsivo di Calogero: il fatto che, nonostante vi sia-
30
Capitolo I
no le premesse, non c’è una teoria della lingua come sistema; il rifiuto della teoria del contratto tanto in linguistica, che nel diritto e
nella politica; la critica, infine, della teoria linguistica e del principio
gnoseologico del verum factum vichiani. Sono tutti aspetti, possiamo
dire, che rispondono all’unica esigenza di garantire la libertà del
soggetto dal peso che possono esercitare quelle istituzioni cui
l’attività stessa del soggetto dà vita. Così è per l’istituzione o sistema
linguistico, cui Calogero preferisce l’atto di volontà che genera
l’intenzione comunicativa. Così è per il contratto giuridico e politico,
cui Calogero preferisce la legge come manifestazione di volontà etico–discorsiva del soggetto. Così è per il linguaggio poetico e per il
principio del verum factum vichiani, nei quali Calogero scorge evidentemente il pericolo che la loro implicita tendenza evolutiva possa
espropriare il soggetto della sua volontà. Di conseguenza, la lingua,
ma anche la morale, il diritto e la politica, per Calogero sono solo
momenti empirici di quell’unico principio che è l’atto di volontà, beninteso altruistico, del soggetto.
Il soggetto e la struttura sono allora i poli, esemplificati dalle posizioni di Calogero e di Piaget, di una contrapposizione che vogliamo ulteriormente indagare nei capitoli che seguono. Dalla prospettiva di Calogero deriva una morale rigorosa, quando non eroica, ma
dalle conseguenze non tutte desiderabili. Oltre la buona volontà, infatti, non c’è alcun sistema di regole, che non sia un vuoto simulacro,
in grado di ovviare a individuali cattive volontà, o a momentanee eclissi della buona volontà. Nella contrapposta prospettiva di Piaget,
invece, la morale, ma anche la lingua, il diritto e la politica sono
strutture logico–normative dotate di vita propria, che trascendono gli
individui, nello stesso momento in cui ne incorporano lo sviluppo
cognitivo. Ciò che vogliamo capire, allora, è come recuperare un
qualche livello strutturale in cui la buona volontà d’intendere dia
luogo a istituzioni normativamente cogenti, e per converso come garantire la libertà del soggetto dentro la necessaria permanenza delle
strutture.
Capitolo secondo
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
Per proseguire nell’indagine annunciata alla fine del precedente
capitolo, riprenderemo e approfondiremo ora due direttrici, che dovrebbero portarci a vedere più a fondo in quella nozione di dialogo
apparsa già nell’elaborazione di Calogero.
La prima di queste direttrici è costituita dall’ancoraggio epistemologico che gli excursus in Vailati, Calogero e Piaget consentono
in una concezione antimonista e produttiva della ragione.
La seconda direttrice consiste nell’aspetto normativo del linguaggio esaminato in connessione con il tema della struttura morale del
rispetto.
1.
DELLA VOLPE: IL NESSO DIALOGICO DEGLI ETEROGENEI
Quanto alla prima direttrice, discutendo della critica linguistica
dell’argomentazione filosofica e scientifica in Vailati, abbiamo visto
che il significato più profondo del pragmatismo cui Vailati approda,
è il suo antimonismo, cioè il rifiuto della tendenza a generalizzare, a
dissolvere le distinzioni, a ricercare in ogni cosa l’uno o il generale,
spirito o materia che sia.
31
32
Capitolo II
Allargando poi la visuale a Piaget, abbiamo visto che il suo antimonismo, fuoriuscendo da residue impostazioni neopositivistiche,
pone al suo centro le trasformazioni che, tanto in ambito fisico,
quanto in ambito logico–matematico, generano novità. Piaget stesso,
però, pone un limite al suo antimonismo quando afferma che il suo
interesse è rivolto alle «trasformazioni che generano novità pur
mantenendo al loro interno, e in modo inscindibile, certe costanti»
(La causalità secondo E. Meyerson, p. 161).
La tensione tra stabilità e costanti nelle trasformazioni è dunque il
punto messo in gioco dal tema della ragione antimonista. Un tema
che approfondiremo ora in un autore, sino a vent’anni fa famosissimo, oggi quasi dimenticato, e che l’ha, per così dire, tessuto con il
filo d’oro di una filosofia del linguaggio passata quasi inosservata,
nascosta com’è rimasta, all’epoca, nelle pieghe di un discorso celebrato per altri aspetti, dall’interpretazione del marxismo ai canoni di
un’estetica materialista.
L’autore cui mi riferisco è Galvano Della Volpe (1895–1968), aristocratico di nascita, gentiliano di formazione, poi marxista fra i
maggiori, e dell’indirizzo non storicistico, autore di una Critica del
gusto (1963), che con il suo ostico stile affascinò e tormentò intere
generazioni di studenti.
Questa Critica del gusto, che fu l’opera che rese famoso il suo
autore, suscitando le reazioni ingiustificatamente critiche, lo si può
oggi ben dire, a distanza di quasi quarant’anni, di qualche linguista
supercilioso, è tutta presa dall’allora incipiente vague semiotica. E
ancora oggi, per chi la rilegga, con la sua attenzione per gli “specifici” dei generi artistici, risulta addirittura più attuale della semiologia
di un R. Barthes, se si pensa all’odierna rivendicazione, per altro non
sempre convincente, di una semiotica non puramente linguistica
(Fabbri,1998).
D’altra parte, la semiotica contemporanea, con la sua rinnovata
attenzione per le “passioni”, rimette in gioco problematiche filosofiche come il rapporto tra il sentimento e la ragione, la natura del dialogo, il riconoscimento dell’Altro e quindi il posto dell’etica nella riflessione sul linguaggio, tutti temi che, bisogna dire, la semiotica
stessa affronta o riducendoli ad aspetti tecnici della natura dei segni,
o con un discorso filosofico, per così dire, in tono minore e occasio-
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
33
nale. Temi, invece, che, organicamente orchestrati, sono presenti in
Della Volpe, non tanto nella citata Critica del gusto, opera levigata
della maturità, che facilmente si lascia etichettare come opera di estetica, ma paradossalmente già nella prima elaborazione teoretica
degli anni trenta e quaranta.
Il punto da cui vorrei partire è la questione che Della Volpe pone
nei Fondamenti di una filosofia dell’espressione, un’opera che risale
al 1936, quando, constatando che «la ragione, l’universale» è venuto
sempre più, dopo Kant, annullando «il sentimento, il particolare», si
chiede: «il sentimento non ha altro modo di esprimersi che nel processo categoriale?La sua natura si esaurisce in questa sorta di obiettivazione? Non ne conosce altra?» (Fondamenti di una filosofia
dell’espressione, p. 14).
Sembrano domande scolastiche, ma esse aprono la strada ad una
ricerca intorno ad una ragione non monista, ad una razionalità del
molteplice che, sin dall’inizio, si presenta come una ricerca, ad un
tempo, di etica e di filosofia del linguaggio. Infatti, in un’opera di
poco successiva, e che al suo apparire, non ebbe quasi nessuna risonanza, cioè la Critica dei principi logici (1942), Della Volpe parla
della sua filosofia come di una «critica trascendentale del fatto espressivo» che, ponendo al centro «l’esame trascendentale della
struttura assoluta della parola», si tramuta in una «filosofia
dell’esistenza» (Critica dei principi logici, pp. 172–3).
Insomma, mi pare che ce n’è abbastanza per suscitare l’interesse
non solo del filosofo del linguaggio teoricamente interessato alle radici storiche della propria disciplina, ma anche di chi si propone di
comprendere attraverso il linguaggio la natura e il senso dell’agire
umano. Non posso seguire qui nella sua complessità il discorso di
Della Volpe, le cui enunciazioni teoriche fanno un tutt’uno con le
molteplici analisi che egli conduce, da Dante a Galilei a Leopardi, di
testi scientifici e letterari. Mi limiterò a presentarne alcuni aspetti salienti, facendo riferimento sopratutto ai due testi prima citati, e cioè i
Fondamenti di una filosofia dell’espressione del 1936 e la Critica
dei principi logici del 1942.
In queste due opere, uno dei temi più suggestivi sviluppati da
Della Volpe è quello della «irrequietezza della parola» (Fondamenti
di una filosofia dell’espressione, passim; Critica dei principi logici,
34
Capitolo II
p. 262.), una formula suggeritagli dalla sua polemica antihegeliana
contro la quiete che lo spirito assoluto raggiungerebbe al culmine del
suo sviluppo dialettico.
Questa formula è centrale in Della Volpe, e proverò quindi, sia
pur brevemente, a chiarirne qui, per quanto è possibile, il significato.
Per Della Volpe dire che la parola è irrequieta, significa dire che la
parola vive nel «dialogo dell’idea col suo contrario, il sentimento»
(Fondamenti di una filosofia dell’espressione, p. 43). Per sentimento, Della Volpe intende ciò che non è mai predicato. Per idea, ciò che
è sempre predicato. La pura immagine che resta di un suono o di un
colore, tolta ogni determinazione categoriale, quello è sentimento. E
la pura determinazione categoriale o logica, come il concetto di essere o di uomo, quella è l’idea.
Ora, perché Della Volpe parla di «dialogo» e non più semplicemente di «dialettica», visto che il risultato di questo dialogo è, come
lui stesso afferma (Fondamenti di una filosofia dell’espressione, p.
47), quella sintesi di equilibrio espressivo che è la parola? In altri
termini, qual è la funzione euristica del concetto di dialogo in Della
Volpe?
Una prima pregnante funzione è quella di descrivere, beninteso
trascendentalmente, la struttura interna della parola. Della Volpe
ammette che tra idea e sentimento c’è una asimmetria di base, nel
senso che il regime formale proprio di quell’equilibrio espressivo
che è la parola, è il regime della determinazione categoriale, e non
quello dell’immagine sentimentale. Tuttavia, il dialogo tra idea e
sentimento non gli sembra una metafora vuota, perché la natura stessa dell’equilibrio espressivo richiede delle domande e delle risposte
«non finte», nel senso che la parola, per costituirsi nella sua formalità espressiva, deve passare per il molteplice e il contingente costituito dal sentimento (Fondamenti di una filosofia dell’espressione,
pp. 43–4). La parola, che qui viene a coincidere con il logos o razionalità, è dunque dialogica nella sua stessa interna struttura.
Questa natura dialogica della parola si articola — ed è questa la
seconda funzione, non meno pregnante, della presenza della metafora euristica del dialogo in Della Volpe — con il dialogo come scambio comunicativo tra parlanti.
Ecco l’intero passo in cui Della Volpe espone questa concezione:
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
35
Si suol dire che gli uomini “s’intendono sempre” e cioè fanno uno — appunto in quanto “hanno idee” o pensano; ma, si dice al contempo, gli uomini
pur “divergon fra loro” e cioè sono molti — appunto in quanto il loro pensare
non è vuoto bensì è pieno dei “loro sentimenti” cioè del diverso (per definizione).Eppure gli uomini, checché si dica o si creda, non “si scambiano” mai delle
pure idee: anche nell’astrazione più alta si scambiano, con le idee, dei sentimenti cioè delle immagini (indifferenti): il loro pensare è un sentire sempre —
e, conseguenza capitalissima, ciò che li unisce è il sentire tanto quanto il pens a r e — o il sentire come pensare: uniti, allora, in quanto divisi, uno–molti.Ogni uomo è, cosi, “se stesso” in quanto, ad es., fa delle scoperte
scientifiche (le fa “lui”) o ama o fa dell’arte ecc., — e si è visto che c’è bellezza ossia sentimento o stile insomma ( negativo o positivo qui non c’interessa)
in ognuno di questi atti; ed è, ogni uomo, al tempo stesso, “gli altri” cioè universo — in quanto tutti quegli atti non sono che un pensare (che è un sentire), e
tutti pensano (cioè sentono) e infatti “si comprendono”, come si dice, se sanno
e vogliono. Se sanno e vogliono, appunto: occorre cioè che ogni pensante si
sottometta all’autorità del gusto ossia del diverso — autorità così tipica nel
processo artistico — o insomma “abbia gusto”, sentimento. A questo punto ogni pensante diventa il pensante, anzi lo è già: poiché è proprio per questa perenne dialettica del gusto in quanto è la stessa dialettica dell’idea che
l’universo sorge ad ogni momento (esso non è veramente mai fatto ma si fa
sempre), ma sorge come universo pieno, uno–molteplice veramente; appunto
perché il pensare non è idea che gioca con se stessa in un vuoto formalismo,
ma idea che è senso e il pensiero ripetiamo un pensare concreto. L’universo
sorge, dunque, da o per ognuna delle prospettive che sono i pensanti in quanto
sono il pensante cioè la consapevolezza come dialettica dell’idea, ma sorge, ripetiamo, come universo individuato o concreto in quanto la dialettica dell’idea
è dialettica del gusto (= formalità come dialogo dell’idea col suo contrario)
(Fondamenti di una filosofia dell’espressione, p. 46).
Come si vede, il dialogo dell’idea con il suo contrario, il sentimento, che presiede alla generazione dei contenuti di pensiero individuali, ha la stessa logica del dialogo come scambio comunicativo
tra parlanti. Infatti, la dialettica dell’uno e dell’universale e del molteplice e del contingente è alla base tanto dell’uno, quanto dell’altro.
Nella prima forma di dialogo, il molteplice e il contingente è dato
dalla singolarità del nostro sentire. Nella seconda forma, dalle infinite prospettive dei partecipanti allo scambio comunicativo. Per
Della Volpe, insomma, pensare e comunicare sono atti distinti ma
coordinati di una stessa razionalità positiva.
36
Capitolo II
Viene spontaneo qui l’accostamento tra questa concezione dialogica della razionalità e la contemporanea (anni Quaranta) teorizzazione di un Piaget intorno allo scambio discorsivo equilibrato. Per
Piaget, il pensare e il comunicare formano una struttura operatoria,
descrivibile in termini di raggruppamento matematico. In questo senso, il dialogo è una «cooperazione sociale intesa come un sistema di
co–operazioni»,1 cioè come operazioni individuali la cui esecuzione
si integra in un sistema d’insieme. Questo carattere operatorio del
dialogo assicura la possibilità di accordarsi su contenuti sempre nuovi, ma in un quadro di stabilità del sistema della comunicazione.
Come si vede, ritorna qui l’impostazione epistemologica di fondo
di Piaget con la sua attenzione per il nuovo, ma anche per le costanti
del sistema. Tornerò ancora più in là su quest’aspetto. Intanto, vorrei
far notare come il tema dell’accordo è presente anche in Della Volpe. Infatti, per Della Volpe, il «nesso o circolo di eterogenei» che
genera la parola e lo scambio comunicativo, è un nesso o circolo «a
cui nessuna specie di storia è estranea» (Critica dei principi logici, p.
262). In altri termini, è un nesso a cui nessuna specie di discorso —
poetico, filosofico, pratico — si sottrae. A questo proposito, Della
Volpe adduce l’esempio della storia della filosofia intesa come dibattito nel tempo tra punti di vista differenti.
La storia della filosofia, o del pensiero, muove da concetti in
quanto muove nello stesso tempo da intuizioni. Ma non nel senso
che il pensiero da indistinto e astratto si fa distinto e concreto, bensì
nel senso che «nello stesso atto di “coerenza” in cui il pensiero nasce, con la sua singolarità lo chiude nell’involucro della sua coerenza
o non–contraddizione che fa tutt’uno con la “vocazione” o “genio”
di chi pensa» (ibidem). Con una formula più attuale, potremmo dire
che, nell’atto espressivo (filosofico, ma anche poetico o pratico),
contenuto dell’enunciazione enunciatore e atto dell’enunciazione sono inscindibili, formano cioè quell’unicità del locutore da cui deriva
il perpetuo variare e il contrasto dei sistemi o pensieri filosofici.
Se così non fosse, sottolinea Della Volpe, dovremmo riconoscere
con Hegel che ogni divergenza o disputa, filosofica o di ogni altro
1 Studi sociologici, p. 125. Una discussione più approfondita di questa concezione del
dialogo di Piaget, in Aqueci, 1995.
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
37
genere, esprime solo il grado maggiore o minore di astrazione attraverso cui la ragione, cioè l’unità, si manifesta nei suoi principi e sistemi, e quindi dovremmo ammettere che il fine immancabile del discorso filosofico, come di ogni altro tipo di discorso, è l’accordo nei
principi. Ma se il singolare e il molteplice sono solo lacune provvisorie dell’uno, gradi di astrazione del pensiero in generale, e non fatti
positivi, in che cosa consiste, si chiede Della Volpe (Critica dei
principi logici, p. 263), la positività del razionale o dell’uno? Che
diventa l’uno se non unizza nulla? Come può unizzare se esso è solo?
Dunque, conclude Della Volpe, non c’è e non ci può essere un accordo sui principi. Il solo accordo possibile non è nel pensare i principi, ma nel pensare tout court, ossia nell’agire. E poiché l’agire, ossia l’esperienza, è uno sforzo di coerenza contingentemente necessaria e universale, il solo accordo possibile è un accordo di discordia.
In altri termini, l’accordo ci può essere solo nel fatto che tutti
pensiamo, cioè agiamo, nel senso che cerchiamo soluzioni coerenti
per i problemi contingenti che ci sono dati da risolvere. Se vogliamo,
quello di Della Volpe è un pragmatismo che implica la coerenza
dell’adattamento biologico. Tuttavia, Della Volpe, dando prova di
rigore filosofico, non varca questa soglia, che pure intravede (cfr.
Critica dei principi logici, p. 173, dove rifiuta di seguire Nietzsche
su questa strada). Egli piuttosto intraprende la strada di una filosofia
dell’espressione che deve tramutarsi in una filosofia dell’esistenza.
2.
SCARPELLI: LA NATURA LINGUISTICA DELLA MORALE
A questo punto, proporrei di cambiare scenario, tralasciando momentaneamente questi sviluppi del discorso di Della Volpe, e cominciando ad occuparci della seconda direttrice che mi riprometto di approfondire, cioè il lato normativo del linguaggio esaminato in connessione con il tema della struttura morale del rispetto.
Lo farò, per cominciare, discutendo brevemente alcuni aspetti
della filosofia di Uberto Scarpelli (1924–1993), di formazione
anch’egli gentiliana, poi esistenzialista, infine, dagli anni cinquanta
in poi, approdato alla filosofia analitica, nel doppio senso di etica a-
38
Capitolo II
nalitica e di filosofia analitica del linguaggio. In Italia, come sappiamo, la filosofia analitica del linguaggio aveva fatto una fugace ma
luminosa apparizione già all’inizio del XX secolo, con Vailati. Decenni dopo, Scarpelli la riprende durante una sorta di felice intermezzo, quando ormai all’estero aveva avuto imponenti sviluppi, e
prima che in Italia conoscesse i più recenti successi. Inoltre, a differenza di Vailati, egli la comprende dentro una cornice di esplicita riflessione etica. Così, concetti centrali attorno a cui si organizza la
sua riflessione sono la coerenza del discorso e la libertà della scelta
etica.
La coerenza, che come abbiamo visto è anche un tema dellavolpiano, mentre in Della Volpe è una condizione dell’esprimersi e
dell’agire, in Scarpelli torna ad essere un principio logico di cui servirsi per demarcare il buono dal cattivo ragionamento, la scienza
dalla metafisica. Quanto invece alla libertà della scelta etica, per
Scarpelli è il fondamento del discorso normativo. Con una formula
in cui si avvertono chiaramente gli echi esistenzialistici, Scarpelli infatti afferma che «l’ordinamento dell’esistenza mediante le proposizioni direttive di un discorso etico razionale ha radice in un atto di
libertà, da rinnovare e confermare nel continuo riaprirsi delle possibilità» (Etica senza verità, p. 72).
Questa conciliazione dal sapore kantiano di libertà esistenziale e
di cogenza della norma non è però l’approdo finale di Scarpelli. Infatti, in un interessante confronto con il pensiero linguistico ed etico–politico di Hobbes circa la norma, la sua natura linguistica e la
sua cogenza normativa (Scarpelli, 1981), egli pone i seguenti punti:
a) la norma è un precetto attraverso cui un uomo è guidato e diretto in una qualsiasi azione; b) la morale consiste di norme, cioè di
atti discorsivi direttivi; c) le norme sono asserzioni di passioni; d) la
morale consiste di norme ancorate nelle passioni; e) la norma morale
fondamentale è quella della conservazione della vita.
Tre mi sembrano i tratti salienti di questa costruzione etica e linguistica. Anzitutto, l’affermazione della natura linguistica della morale. Infatti, è vero che la norma è un rapporto pragmatico, ma è anche vero che essa si esprime sempre attraverso un discorso.
L’eloquenza percettiva dell’esempio, su cui, ad esempio, insiste un
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
39
Calogero (Etica, p. 168), viene qui implicitamente concepita come
un momento, se non marginale, certo eccezionale della morale.
In secondo luogo, l’integrazione delle passioni nell’etica razionale
discorsiva. C’è qui, sebbene non esplicitamente tematizzato, qualcosa della preoccupazione di Della Volpe di integrare nella razionalità
ciò che egli stesso chiama il molteplice e il contingente.
In terzo luogo, la centralità assegnata alla passione egoistica
dell’autoconservazione della vita. Il dover essere, insomma, è una risposta adattiva, “pena la rovina”. Vedremo più in là (cap. IV) che
questo rispondere ”pena la rovina”, nell’elaborazione del già richiamato György Lukács, un autore di cui torneremo ancora ad occuparci, è la struttura ontologica di base dell’essere sociale.
Qui, però, di questi tre punti, vorrei sottolineare sopratutto il primo, e cioè l’affermazione della natura linguistica della morale. Come
abbiamo visto nel capitolo recedente, anche Piaget concepisce la morale come un discorso, distinguendola dal comportamento morale vero e proprio. Tuttavia, rispetto all’impostazione analitica di Scarpelli,
Piaget si pone il problema del rapporto tra discorso e comportamento
morale (teoria dei décalages o dislivelli temporali), mettendo in luce
le trasformazioni evolutive cui il discorso morale è soggetto, e che
dipendono dalle trasformazioni evolutive del rispetto. Di tali trasformazioni, vorrei ora approfondire il momento iniziale del contatto
affettivo, che nell’elaborazione di Piaget è come risucchiato verso
l’esito finale della psicogenesi. Lo farò discutendo innanzitutto il
racconto evolutivo della nascita del rapporto genitrice–prole che troviamo in uno dei più grandi biologi del secolo appena trascorso,
Ernst Mayr (1904–2005).
3.
MAYR: I PRODROMI EVOLUTIVI DEL RISPETTO
Ragionando intorno al processo di ominazione, Mayr mostra il
semplicismo del racconto secondo il quale, a determinare tale processo, sarebbe stata l’acquisizione della stazione eretta da parte di alcune orde di ominidi, che avrebbe permesso l’uso di strumenti.
L’uso degli strumenti da parte degli scimpanzé, infatti, lascia intendere che il loro utilizzo da parte degli ominidi fosse un’abilità acqui-
40
Capitolo II
sita prima della stazione eretta. L’acquisizione della stazione eretta,
inoltre, nei circa 2 milioni di anni e più successivi all’apparizione dei
primi manufatti umani non consentì che un lieve miglioramento della
tecnica della loro costruzione. Infine, la stazione eretta non ebbe
conseguenze significative sull’accrescimento del volume del cervello
che, per gli oltre 2 milioni di anni in cui vissero diverse specie di austrolapitechi, si mantenne molto piccolo (Il modello biologico, pp.
194–195). L’acquisizione della stazione eretta è stato allora un fatto
evolutivo di non così fondamentale importanza? Ovviamente, no.
Anzi, essa ha avuto un’enorme influenza evolutiva, ma non sul punto
su cui insiste il racconto che lega assieme stazione eretta–liberazione
della mano–uso degli strumenti–sviluppo del cervello. Il nesso è un
altro, e vale la pena di leggere tutto il passo in cui Mayr lo espone:
Le prime australopitecine erano ancora semiarboricole, con i piedi adatti
per arrampicarsi e le braccia relativamente più lunghe di quelle degli ominidi
fossili successivi e dell’uomo moderno. Di conseguenza, la loro prole doveva
essere sin dalla nascita in grado di afferrare la madre durante i suoi spostamenti
da un albero all’altro, proprio come avviene oggi con i piccoli delle varie specie di scimmie. Tra 2 e 2,5 milioni di anni fa, il passaggio definitivo alla vita
terrestre liberò le mani e le braccia delle madri che poterono così portare con sé
i propri piccoli, i quali videro allungare il periodo della loro dipendenza dalle
cure materne. Tale sviluppo più lento, a sua volta, fu favorevole al processo di
crescita del cervello nella prima infanzia, che è caratteristico della specie umana. Pertanto, l’impatto più importante della deambulazione eretta si ebbe sul
comportamento materno e non sull’uso di strumenti (ibidem).
Benché altri autori sfumino il quadro abbozzato da Mayr (Edelman, Tononi, 2000, p. 236), il senso del passo citato secondo me è il
seguente: all’origine del processo di ominazione non c’è
l’affermazione di una logica strumentale, bensì di un modello culturale. All’origine del processo di ominazione non c’è l’abilità tecnica
di forgiare l’ascia di pietra, bensì la costituzione dei prodromi di ciò
che poi sarà la diade madre–figlio.
A dire il vero, Mayr non sottolinea abbastanza il legame tra
l’emergenza del comportamento materno e il linguaggio. Per Mayr,
fu la realizzazione di vasti accampamenti ai fini della caccia a richiedere lo sviluppo del linguaggio. Tanto più complessi erano gli
accampamenti, tanto più elaborati i piani d’attacco, più sviluppate le
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
41
strategie, più sofisticate le armi. Questo nuovo stile di vita, conclude
Mayr, richiedeva «l’elaborazione di un efficiente sistema di comunicazione: il linguaggio» (Il modello biologico, p. 196).
Per Mayr, dunque, il linguaggio è un mezzo di comunicazione che
al suo apparire, 300–200 mila anni fa, accresce il vantaggio selettivo
dei piccoli gruppi di progenitori dediti alla caccia e alla raccolta di
frutta ed erbe selvatiche. È uno strumento del pensiero strategico.
Questo aspetto strumentale del linguaggio e il suo impatto evolutivo sono innegabili, ma dall’ontogenesi del linguaggio abbiamo appreso abbastanza sull’importanza del rapporto madre–figlio per non
immaginare che il comportamento materno come descritto da Mayr
stesso, sia stato — certo, assieme ad altri fatti evolutivi, come il possesso di un adeguato apparato fonatorio — un elemento essenziale
nella costituzione del linguaggio.
4.
LACAN: IL SIMBOLICO E IL NORMATIVO
Ho parlato prima di prodromi di ciò che poi sarà la diade madre–figlio. Stiamo parlando infatti di premesse evolutive di ciò che
poi sarà il vero e proprio linguaggio umano. Credo, infatti, che per
parlare di linguaggio umano vero e proprio si debba aspettare
l’instaurarsi del simbolico con le figure che lo caratterizzano: il servo e il padrone, il governato e il governante, la forza e il consenso,
l’uccisione rituale e il patto tra eguali, ecc. Figure che comportano il
superamento dei meri appetiti (sesso, territorio, fame) e l’abbozzo di
un primo, seppur terribile, mondo delle passioni (guerra, paura, insicurezza, ecc.). In altri termini, il linguaggio con cui comincia la storia umana. E qui, il racconto evolutivo di Mayr, per quanto avvincente, non ci basta più. Dobbiamo rivolgerci ad altri, a coloro che a
vario titolo hanno indagato il simbolico. Ad esempio, in campo psicoanalitico, a Jacques Lacan, un autore ora molto meno alla moda, e
a cui quindi ci si può accostare senza i pericoli che le mode comportano, anche per realizzare quell’integrazione psicoanalitica del modello genetico–normativo piagettiano, semplificato da Rawls, la cui
esigenza riconoscevamo nel capitolo precedente. A proposito
dell’Edipo, e della «logica del desiderio» che lo governerebbe, Lacan
42
Capitolo II
ha detto, sebbene a volte in modo oscuro, cose interessanti intorno al
tema del Nome–del–Padre, del rispetto e della Legge.
Un primo nesso che emerge dal discorso di Lacan, è quello tra la
figura (o ruolo) paterna, la legge, intesa come comando originario, e
il linguaggio. Per Lacan «è nel nome del padre che dobbiamo riconoscere il supporto della funzione simbolica, che dal sorgere dei
tempi storici identifica la propria persona con la figura della legge»
(Scritti, I, p. 271). E la legge «si lascia dunque riconoscere a sufficienza come identica a un ordine di linguaggio» (ivi, p. 270), nel
senso che sono le nominazioni di parentela a permettere al potere di
istituire le preferenze e i tabù lungo il filo generazionale delle discendenze (ibidem).
È evidente l’eco di Lévi–Strauss in quest’ultima affermazione, in
cui il linguaggio svolge ancora, tutto sommato, una funzione strumentale: la conoscenza dei nomi di parentela è la condizione per
poter discriminare tra le persone e fissare i tabù. Ma Lacan va più in
là, e staccandosi da questa matrice antropologica di stampo razionalistico, afferma che «l’attribuzione della procreazione al padre» è
soltanto l’«effetto di un puro significante, di un riconoscimento non
del padre reale ma di ciò che la religione ci ha insegnato a invocare
come Nome–del–Padre» (Scritti, II, p. 552).
Qui emerge un secondo nesso, più profondo, tra la religione, con
il suo tema del Nome di Dio, indagato da teologi e mistici, il padre
come ruolo simbolico e il linguaggio come lavoro sul significante.
Per i mistici, e penso soprattutto ai mistici della cabbala, il Nome di
Dio è l’Ur–Name, il nome originario che contiene l’essenza
dell’Universo. Esso è significante puro, e per di più un significante
scritto. Il che è un bel problema per chi sostiene l’innatezza del linguaggio. Dovremmo, infatti, cominciare a scrivere, prima di cominciare a parlare.
Ma per restare al nostro tema, Lacan attribuisce al Nome–del–Padre la stessa valenza originaria che il Nome di Dio ha per
i mistici. E ciò spiega l’associazione, vista prima, tra il padre, il Nome–del–Padre e la legge. Per i mistici cabbalisti, infatti, la parola di
Dio, che è il manifestarsi discorsivo del Nome di Dio, significa anche governo del mondo (Scholem, 1970, p. 59). Dio è un essere linguistico dotato di autorità legiferante, cui si deve un rispetto assoluto
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
43
(ivi, p. 20). È questo, a mio parere, il modello che ha in mente Lacan
quando enuncia il tema del Nome–del–Padre: il padre come una figura linguistica — nel senso di ente linguistico e di soggetto enunciatore — dotata di autorità legiferante cui si deve un rispetto assoluto.
Ma non eravamo forse partiti dalla diade madre–figlio, fattaci intravedere filogeneticamente da Mayr? Come siamo finiti al Nome–del–padre e al padre? Abbiamo forse perso per strada il filo del
discorso, che concerneva la madre? No, non abbiamo perso il filo del
discorso, perché la diade madre–figlio in Lacan acquista rilievo in
connessione con il tema del Nome–del–Padre. Afferma infatti Lacan:
Partiamo dalla concezione dell’Altro come luogo del significante. Ogni enunciato d’autorità non trova in esso altra garanzia che la sua stessa enunciazione, perché è vano che la cerchiamo in un altro significante, che in nessun
modo potrebbe apparire fuori da questo luogo. Cosa che formuliamo dicendo
che non c’è un metalinguaggio che possa essere parlato o, più aforisticamente,
che non c’è Altro dell’Altro. E il Legislatore (colui che pretende di erigere la
Legge) in quanto esige di supplirgli si presenta come impostore. Ma non così la
legge, né colui che se ne autorizza. Di questa autorità della Legge il Padre può
essere considerato il rappresentante originale: ciò esige che si specifichi quale
sia il modo privilegiato di presenza con cui si regge al di là di quel soggetto che
è portato ad occupare in modo reale il posto dell’Altro, e cioè la Madre (Scritti,
II, p. 817).
La Madre è dunque il lato percepibile di quel significante assoluto
e originario che è il Padre, di quel Padre che è il rappresentante originario dell’autorità della Legge. Ora, per uno psicoanalista come
Lacan, che reinterpreta strutturalisticamente l’Edipo freudiano e studia l’eziologia della psicosi, è importante occuparsi «non soltanto del
modo con cui la madre si colloca in rapporto alla persona del padre,
ma del caso ch’ella fa della sua parola, diciamo il termine giusto,
della sua autorità, in altri termini del posto che riserva al Nome–del–Padre nella promozione della legge» (Scritti, II, p. 575).
A dire il vero, nei mistici cabbalisti che abbiamo fin qui seguito,
manca questa figura di intermediazione etico–giuridico–linguistica
che è la Madre. Per loro, Dio linguaggio e legge formano un dispositivo unico che richiama una sorta di fisica mistica dell’universo. In
Lacan, invece, c’è l’esigenza di rendere percepibile il significante
44
Capitolo II
paterno. E proprio a questa funzione è chiamata la Madre. Più che un
modello fisico, agisce qui, credo, un modello biologico che recupera
ed ingloba la tattilità implicita nel racconto filogenetico di Mayr.
In conclusione, funzione della Madre è di iscrivere il Nome–del–Padre nel discorso che lei tiene con il figlio. La logica del
desiderio che alimenta l’Edipo acquista così un senso, la cui alterazione è alla base della psicosi. Ma non è questo lato propriamente
psicoanalitico e patologico della questione che ci interessa. Quello
che ci deve interessare è che in Lacan, come è stato giustamente osservato, si attenua l’aspetto di rivalità omicida, proprio dell’Edipo
freudiano, e viene in primo piano il tema del timore e del rispetto del
padre (Recalcati, 1996, p. 104). Specularmente, come è stato ancora
osservato, la madre lacaniana è «la madre che porta la parola. È infatti la parola della madre che rende attiva la metafora paterna. È attraverso la parola della madre che un padre riceve agli occhi di un
bambino il suo prestigio» (ivi, p. 183).
In altri termini, la madre lacaniana è l’articolazione discorsiva del
Nome–del–Padre, inteso secondo il modello mistico–cabbalistico,
cioè come essere linguistico dotato di autorità legiferante. In quanto
tale, la madre lacaniana rende possibile l’instaurarsi della struttura
del rispetto, quella struttura in cui il padre è dotato di prestigio ed è
oggetto di timore. È questo l’ordine simbolico che ingloba e umanizza la diade madre–figlio resa possibile dalla deambulazione eretta.
Ed in questo ordine simbolico originario, etica diritto e linguaggio
formano un tutto unico.
5. DALLA COSTRIZIONE DELLA LINGUA ALLA LIBERTÀ DEL DISCORSO
La prospettiva da cui siamo partiti è quella di Della Volpe, di una
filosofia dell’espressione che deve tramutarsi in una filosofia
dell’esistenza. Alle prese con il molteplice e il contingente, questa
filosofia non tenta di ridurli all’uno, negandoli o assolutizzandoli, ma
intraprende la via difficile dell’accordo di discordia, che fa del dialogo addirittura la struttura interna del pensare. Questo sforzo di coordinazione, etico–linguistico e teoretico, è reso possibile dalla parola,
che è irrequietezza e equilibrio espressivo. Essa, però, è anche im-
Irrequietezza espressiva e scelte vitali
45
possibilità di contraddirsi (Critica dei principi logici, p. 173). Infatti,
la parola è azione spontaneamente adattata che, in quanto tale, riflette e partecipa della condizione umana, definita dalla sua contingenza necessaria e dalla sua singolarità. Esistere, comunicare e agire
si equivalgono, e condividono tutti il rischio della morte, dello scacco comunicativo e del fallimento.
L’altra prospettiva con cui abbiamo proseguito, è stata quella
della natura affettiva del rispetto, dove abbiamo affrontato il problema dell’ordine simbolico originario da cui scaturisce la diade madre–figlio, e nel quale etica diritto e linguaggio appaiono marcate dal
principio di autorità. La riflessione di Lacan si accorda con le speculazioni etiche, giuridiche e linguistiche che pongono in un dio
concepito come autorità, l’origine dei doveri morali, delle leggi, del
linguaggio. Limitandoci al linguaggio, secondo i grammatici indiani
(Katyayana, Panini e Patanjali) l’autorità riguardo alla conoscenza
delle parole del sanscrito era posseduta dagli Sistas, Bramini
dall’aura misteriosa che vivevano in una certa regione dell’India
(Aryavartta), e il cui comportamento faceva pensare al possesso di
una grazia divina o comunque di una natura speciale (Deshpande,
1998).
Così concepiti, religione, diritto, morale, lingua sembrano avere il
carattere comune di sovrastare l’individuo, e di imporsi ad esso
dall’esterno. Appaiono come forme di costrizione. La stessa costrizione che la psicogenesi, nelle ricerche di Piaget sullo sviluppo del
giudizio morale nel bambino, ci fa osservare all’inizio del rapporto
di rispetto, dove i genitori o gli adulti o, in generale, i più grandi, sono come i Bramini Sistas per i grammatici indiani: conoscono l’uso
delle parole, tra cui, frequentissime, quelle che esprimono obblighi e
permessi, e fanno pensare al possesso di una grazia divina o comunque di una natura speciale.
Tuttavia, quello che la psicogenesi ci fa ulteriormente osservare è
il fatto che le forme originariamente costrittive del linguaggio, del
diritto e della morale evolvono verso la cooperazione, e che
l’originaria credenza o affermazione circa il carattere divino delle
regole e di chi le pone, lascia il posto all’affermazione della loro natura contrattuale. In campo linguistico, è stato Michail Bachtin
(1895–1975) ad interessarsi a questa trasformazione, con
46
Capitolo II
l’opposizione, alla base di una filosofia dell’esistenza prossima a
quella qui esaminata di Della Volpe (Bachtin, 1920–24), tra discorso
autoritario e discorso internamente persuasivo (Estetica e romanzo,
pp. 150 sgg.). E con tale opposizione converge anche la distinzione
di Émile Benveniste (1902–1976) tra segno e frase, segno e testo,
lingua e discorso. Dice Benveniste: il segno deve essere riconosciuto, il discorso deve essere compreso (Problèmes de linguistiques générales, 2, pp. 64–5).
Questo passaggio evolutivo dalla costrizione della lingua alla libertà del discorso, che nel corso di questo libro dovremo ulteriormente indagare, ci consente infine di concepire la psicogenesi non
come un processo deterministico che, incorporando uno stadio dietro
l’altro, colmando una lacuna dietro l’altra, si acquieta nel pensiero ipotetico–deduttivo e nell’assetto normativo «giusto», ma come una
possibilità esistenziale che, per quanto biologicamente determinata,
realizziamo con le nostre scelte. Scelte che avvengono in quel rischioso crogiuolo affettivo che è la struttura linguistico–normativa
del rispetto.
Capitolo terzo
Sistema linguistico e eccedenza normativa
Nel capitolo precedente, abbiamo visto emergere, con Mayr, il
modello culturale all’origine del processo di ominazione, cioè il modello materno. Abbiamo visto anche delinearsi, con Lacan, il nesso
di etica, diritto e linguaggio, segnato originariamente dal principio di
autorità. Al contempo, le analisi di Piaget circa lo sviluppo morale,
rivisitate alla luce della filosofia dell’esistenza di Della Volpe, che
converge con suggestioni filosofico–linguistiche circa l’esistenza di
fasi distinte e geneticamente concatenate del tempo normativo, ci
hanno offerto una prospettiva di liberazione non deterministica dagli
originari rapporti di costrizione.
Ciò che vogliamo fare in questo capitolo è di consolidare questi
risultati, da un lato, saggiando ancora il nesso di etica e linguaggio,
di segno e legge, e questa volta direttamente nel vivo della semiotica
novecentesca, cioè nelle teorizzazioni di Peirce e Saussure;
dall’altro, approfondendo i problemi evolutivi che questo nesso porta
con sé: dobbiamo porre il segno all’apice dello sviluppo normativo,
oppure come già in parte alcune prospettive ci suggeriscono, da Piaget a Bachtin a Benveniste, dobbiamo andare oltre il segno?
Faremo tutto ciò, da una parte, ricostruendo il confronto che Piaget stesso, interessato a descrivere la genesi del segno, instaura con
Peirce e Saussure; dall’altra, utilizzando alcune distinzioni metodo47
48
Capitolo III
logiche che Mayr, ancora lui, riflettendo sullo statuto epistemologico
della biologia, avanza rifacendosi proprio a Peirce. I concetti che
metteremo a fuoco, in particolare quello di scopo, ci serviranno, come vedremo nel capitolo successivo, per allargare ed arricchire ulteriormente la nostra prospettiva semioetica.
Il punto da cui partirò sarà l’analisi della nozione di teleologia così come svolta da Mayr in riferimento alla biologia. Per spiegare
cos’è un processo non–teleologico, tipico del mondo inorganico, e
per discutere del carattere non finalistico dell’adattamento evolutivo,
Mayr, come già detto, fa riferimento più volte proprio a Peirce
(Mayr, 1992, pp. 123, 125, 132), precisamente a quel passo in cui
Peirce osserva come il termine «teleologico» sia inadatto per parlare
dei processi naturali del mondo inorganico, e quindi suggerisce di adottare il termine «finious», appositamente coniato dallo stesso Peirce , per esprimere la tendenza dei processi naturali inorganici verso
uno stato finale (CP, 7.471).
Le considerazioni di Mayr sono interessanti non solo per il ricorso
a Peirce, ma anche per il loro contenuto riguardo alla concezione del
segno come agire finalizzato che è possibile ricostruire in Peirce,
Saussure e Piaget. Una concezione utile anche a fornire una risposta
all’interrogativo di recente posto in intelligenza artificiale,
nell’ambito delle ricerche sulle reti neurali, quando, dopo aver affermato che «il simbolo è una rappresentazione, ed è tale in quanto
può operare anche “in absentia” dell’oggetto–stimolo originario (che
diventerà il “rappresentato”)», ci si è chiesti: «perché allora questa
rappresentazione non potrebbe essere, ad esempio, usata per regolare
finalisticamente il comportamento del sistema? Cosa lo vieta?» (C.
Castelfranchi, 2000, p. 45, cit. in Tagliagambe, 2001, p. 279). La risposta che emergerà, come vedremo, è che, almeno per quanto riguarda l’organismo vivente, non solo nulla vieta di concepire il simbolo come una regolazione finalistica del suo comportamento, ma
anche che questa concezione, ben prima di recenti riscoperte artificialiste, è inscritta nei fondamenti della semiotica novecentesca.
Sistema linguistico e eccedenza normativa
1.
49
MAYR: PROCESSI TELEOMATICI E PROCESSI TELEONOMICI
In biologia, il concetto di teleologia è centrale. Adottare o meno
una concezione finalistica dell’evoluzione comporta l’accettazione o
meno dell’opera di Darwin e della cosiddetta “sintesi darwiniana”
che ne è derivata. E anche quando si rifiuti il finalismo evolutivo,
non sempre si riescono ad evitare oscillazioni e malintesi legati al
concetto di teleologia. Con la sua riflessione intorno ad esso, Mayr
intende proprio distinguere i molteplici significati del termine ai vari
livelli della teoria biologica.
Una delle distinzioni che riterrò, e che mi sarà utile nel trattare del
segno in Peirce, Saussure e Piaget, è quella che Mayr opera tra processi teleomatici e processi teleonomici. Un fiume che scorre verso il
mare, o una pietra che precipita a terra, sono tipici processi teleomatici. In questi processi c’è un cambiamento di stato che obbedisce a
delle leggi naturali (seconda legge della termodinamica, forza di
gravità), ma si tratta di processi che si dirigono verso il loro fine in
modo passivo e automatico, regolati da forze o condizioni esterne
(1992, p. 125).
Altra cosa sono, invece, i processi teleonomici che sono tipici del
mondo organico, in particolare dei processi di sviluppo cellulare e
del comportamento degli organismi, come le migrazioni, la ricerca
del cibo, il corteggiamento, l’ontogenesi e tutte le fasi di riproduzione. Per Mayr, un processo teleonomico, ovvero un comportamento, è
un processo che deve la propria direzione finalizzata all’azione di un
programma, risultato di selezione naturale, laddove per programma
si intende una informazione codificata che controlla il processo stesso conducendolo verso il suo scopo (1992, pp. 127–8).
Che poi questi programmi siano innati o meno, per Mayr è una
questione che allo stato attuale delle conoscenze genetico–molecolari
resta indecidibile. Pertanto, egli preferisce sottolineare il fatto che
questi programmi possono essere chiusi o aperti, a seconda che incorporino o meno informazione durante il loro tempo di vita, tramite
procedimenti come l’apprendimento o il condizionamento (1992, p.
129). Mayr, inoltre, riferendosi ai meccanismi omeostatici di Waddington, invocati per altro dallo stesso Piaget per corroborare la sua
teoria biologica della fenocopia, di cui tratteremo qui nel capitolo
50
Capitolo III
ottavo, riconosce l’esistenza di distinti programmi somatici, quali
per esempio i singoli stadi dell’ontogenesi, caratterizzati da una determinazione genetica solo indiretta, dal momento che il corso di ciascuno di essi può essere deviato anche se solo temporaneamente dal
suo sviluppo (1992, p. 130).
Scopo ultimo delle distinzioni di Mayr circa il concetto di teleologia è di dimostrare, da un lato, che l’adattamento evolutivo non è
un processo finalistico, né in senso teleomatico né in senso teleonomico (1992, pp. 132–133); dall’altro, che non esiste, almeno dal
punto di vista della biologia evolutiva, una teleologia cosmica (1992,
pp. 133–135). Secondo Mayr, infatti, la controversia se l’evoluzione
dai batteri all’uomo sia un progresso non può riguardare la biologia.
Quanto, invece, all’adattamento, Mayr constata che esso potrebbe
giovarsi della definizione di Peirce quale processo teleologico «finious», ma tenuto conto della casualità degli scopi e dei premi evolutivi, nonché del movimento a zig zag del cambiamento evolutivo
stesso, risulterebbe singolarmente inappropriato parlare della selezione naturale come di un processo teleologico. L’adattamento, conclude Mayr, più che avere degli scopi definiti, è solo un processo casuale di ottimizzazione che noi constatiamo a posteriori (1992, p.
132).
Vedremo nel seguito (cap. V) che questa caratterizzazione
dell’evoluzione come regno del caso ci servirà a identificare il principio evolutivo sottostante alla concezione saussuriana della lingua.
Ma per intanto proseguiamo nel confronto tra le prospettive semiotiche di Peirce, Piaget e dello stesso Saussure.
2. LA MORFOGENESI DEL SEGNO
Normalmente, si ha la tendenza a considerare come secondario o
irrilevante l’aspetto sociogenetico del pensiero di Piaget. Ma la problematica del segno in Piaget, e quella più generale
dell’equilibrazione cognitiva, prende corpo nel parallelismo tra psicogenesi e sociogenesi. Se così non fosse, non si spiegherebbe la sua
insistenza sulla presenza e la progressione gerarchica, tanto nella
dimensione psicogenetica, quanto in quella sociogenetica, di quelle
Sistema linguistico e eccedenza normativa
51
che egli chiama le «strutture fondamentali della vita psichica», cioè i
ritmi, le regolazioni e i raggruppamenti.
Un esempio particolarmente significativo della presenza di queste
strutture e della loro progressione gerarchica è quello che, nella dimensione psicogenetica e allo stadio sensomotorio, conduce alla costituzione del gruppo degli spostamenti. Il livello dei ritmi è rappresentato dagli spazi tattile, buccale, visivo, ecc., non coordinati tra di
loro, e ciascuno di essi con i loro ritmi formalizzabili in termini dello
schema d’insieme AB, BA. Il livello delle regolazioni è costituito dalla integrazione progressiva di questi diversi spazi, grazie alla
coordinazione della prensione con la visione, che ha come effetto la
costituzione di sistemi spaziali elementari. Il livello dei raggruppamenti, infine, è dato dalla coordinazione degli spazi e dalla loro unificazione in uno spazio totale, di concerto con la costituzione
dell’oggetto e con la decentrazione del soggetto dal proprio corpo
(Piaget, 1947, pp. 152–3; 229).
Ora, la differenza tra la psicogenesi e la sociogenesi è che, mentre
nella psicogenesi allo stadio sensomotorio seguono poi le regolazioni
delle operazioni concrete e i raggruppamenti delle operazioni formali, che costituiscono altrettanti grandi stadi dello sviluppo, nella sociogenesi, le tre strutture dei ritmi, delle regolazioni e dei raggruppamenti vengono a coincidere con l’intero sviluppo sociale, senza
l’intermediazione degli stadi. Dello stadio resta solo il carattere della
sequenzialità, ma senza chiusura necessaria sul raggruppamento. Nel
loro carattere embrionale e nella loro relativa staticità, le tre strutture
fungono anche da principio di classificazione, che nella dimensione
psicogenetica è svolto invece dagli stadi.
In particolare, per quanto riguarda i ritmi, Piaget fa riferimento ai
ritmi biologici incorporati nelle forme più elementari di economia,
nonché al susseguirsi delle generazioni. Per le regolazioni, cita
l’esempio dell’opinione pubblica, e quello delle varie forme di coercizione, dalla politica alla scuola, alla famiglia, alla chiesa, con particolare attenzione alla struttura affettivo–morale del rispetto, che già
abbiamo più volte incontrato. Per i raggruppamenti, infine, si riferisce al diritto, alla morale razionale, e allo scambio discorsivo equilibrato (Piaget, 1977, p. 76 sgg.).
52
Capitolo III
Si tratta di suggestioni, osservazioni, sviluppi analitici più o meno
ampi che, assieme alle ricerche psicogenetiche “maggiori”, formano
un quadro d’insieme coerente, intorno al quale si può osservare
quanto segue:
1) nella dimensione psicogenetica, la sequenza dei ritmi, delle regolazioni e dei raggruppamenti sembra avere due cicli, uno minore
che conduce a quella sorta di logica–in–azione che è il gruppo degli
spostamenti e l’invariante oggettuale; l’altro maggiore che conduce
dallo stadio sensomotorio allo stadio delle operazioni concrete sino
allo stadio finale delle operazioni formali. All’origine del ciclo maggiore, c’è l’emergere della funzione semiotica e, con essa, del linguaggio che, come sappiamo, è, al tempo stesso, una risorsa evolutiva ma anche un ostacolo, l’“ostacolo epistemologico” per il pensiero
proiettato verso la logica;
2) al contrario, nella dimensione sociogenetica, lo sviluppo appare
come un processo debolmente strutturato, ciò che spiega probabilmente l’assenza di stadi analogamente a quanto si rinviene nella dimensione psicogenetica. Piaget ammette solo un certo finalismo razionale dentro la totalità sociale considerata, nei momenti di convergenza tra le sotto–totalità della politica, del diritto e della morale
(Piaget, 1977, p. 76). In generale, tuttavia, su una base intricata di
ritmi, la totalità sociale oscilla tra regolazioni probabilistiche e chiusura logica. Quest’oscillazione è la condizione d’esistenza del pensiero simbolico, in tutte le sue forme, dalla mitologia all’ideologia. Il
pensiero simbolico, i sistemi di segni e l’argomentazione razionale
sono gli attori, in rapporti di collaborazione e di antagonismo, della
vita semiotica sociale.
2.1.
I mediatori morfogenetici
Se la totalità sociale, comparata con gli stadi psicogenetici, appare
meno strutturata, ciò non vuol dire che manchi di una sua complessa
organizzazione. In particolare, Piaget suggerisce la presenza in essa
di «mediatori» tra processi probabilistici e stutture logiche (1977, p.
80).
Prima di esaminare più da vicino questi mediatori,
un’osservazione preliminare si impone, e cioè che psicogenesi e so-
Sistema linguistico e eccedenza normativa
53
ciogenesi, benché disegualmente differenziati, sono entrambi processi di generazione di forme. In Piaget, forma è apertura, mobilità, possibilità. Al contrario, contenuto è chiusura, dipendenza dal contesto,
necessità. Se teniamo conto di ciò, allora psicogenesi e sociogenesi
appaiono come processi morfogenetici, e i mediatori di Piaget come i
regolatori di tali processi. Piaget suggerisce che mediatori morfogenetici, o fattori di crescita speciali, siano presenti sulla superficie dei
ritmi e delle regolazioni, e che la loro espressione e regolazione, in
configurazioni spaziotemporali specifiche dello sviluppo della forma, porti a cambiamenti nella forma stessa.
Come ho già ricordato, quali esempi concreti di mediatori morfogenetici, Piaget cita l’opinione pubblica, le varie forme di coercizione, dalla politica alla scuola, alla famiglia, alla chiesa, infine la
struttura affettivo–morale del rispetto. In generale, dunque, Piaget
sembra riferirsi al normativo, ma non solo dal punto di vista delle istituzioni in cui esso si manifesta, ma anche dal punto di vista delle
strutture socio–affettive che lo generano, come dimostra la sua particolare attenzione per il rispetto (Piaget, 1977, p. 82), intorno al quale, come sappiamo, ruota tutta la sua teoria dello sviluppo morale.
Come vedremo più oltre, il rispetto come mediatore morfogenetico è
strettamente connesso con i processi semiotici, ma in un modo che
conduce oltre il sistema linguistico, introducendo un livello discorsivo che tiene conto dell’eccedenza normativa di cui testimonia la finalità espressiva perseguita dal locutore.
2.2.
L’imitazione come mediatore morfogenetico
Uno degli argomenti di Chomsky per avanzare la sua ipotesi di una facoltà linguistica universale e innata, è l’apparente contraddizione fra l’estrema complessità della struttura grammaticale delle lingue
e la facilità con cui qualsiasi locutore le padroneggia (Formigari,
2001, p. 262).
C’è un’argomentazione simile in Piaget concernente la competenza inconscia delle strutture logiche durante lo sviluppo psicogenetico. In particolare, a proposito della situazione sperimentale in cui un
preadolescente di 12–15 anni assiste ad un certo numero di movimenti e di soste d’un oggetto mobile accompagnate dall’accensione
54
Capitolo III
di una lampada, egli osserva che quest’adolescente, «senza conoscere alcuna formula logica, né la formula dei “gruppi” in senso matematico» (Piaget, Inhelder, 1966: 120), sarà capace di padroneggiare
una serie di ipotesi circa la connessione tra movimenti e accensione
della lampada, secondo le quattro possibilità della trasformazione identica (I), inversa (N), reciproca (R) e correlativa (C), che vengono
così a costituire un sistema di trasformazioni che sintetizza ad un livello astratto le strutture parziali costruite fin là al livello delle operazioni concrete (Piaget, Inhelder, 1966, p. 121).
Come sottolinea lo stesso Piaget, questa competenza logica inconscia del preadolescente è analoga a quella del neonato quando
scopre il gruppo pratico degli spostamenti (Piaget, Inhelder, 1966:
120). Suffragato da molti fatti, appare pertanto un parallelismo di
natura tra il linguaggio come competenza grammaticale di Chomsky
e il pensiero come competenza logica di Piaget.
Tuttavia, contrariamente a quanto fa Chomsky per il linguaggio,
dalla constatazione di quella competenza logica spontanea Piaget
non tira la conseguenza che vi sia una facoltà logica universale e innata. Egli piuttosto si pone due problemi e cioè: 1) se vi sia, da un
punto di vista genetico, una filiazione tra la logica e il linguaggio; 2)
da dove derivi geneticamente la logica.
Come abbiamo visto nel § 3.2, Piaget riconosce che il linguaggio
incorpora alcune essenziali strutture operatorie nella sua sintassi e
nella sua semantica. Tuttavia, egli constata anche come, dal fatto che
il linguaggio comporti una logica, si ammetta troppo facilmente che
la logica derivi dal linguaggio (Piaget, Inhelder, 1966, p. 79). Contro
questa tesi, egli cita una serie di fatti tratti dalla comparazione tra il
differente sviluppo delle abilità logiche nei bambini normali, in
quelli sordomuti e in quelli ciechi. In particolare, se nei sordomuti si
rileva solo un ritardo di 1 a 2 anni nella successione degli stadi, nei
ciechi invece si ha un ritardo di 4 anni e più, e ciò nonostante nei
bambini ciechi le seriazioni verbali siano normali. La conclusione di
Piaget in relazione a questi fatti è che
dato che il disturbo sensoriale caratteristico dei ciechi dalla nascita ha impedito sin dall’inizio l’adattamento degli schemi senso–motori e ha ritardato la
loro coordinazione generale, le coordinazioni verbali non bastano a compensa-
Sistema linguistico e eccedenza normativa
55
re questo ritardo, per cui tutto un tirocinio dell’azione resta necessario per far
capo alla costituzione di operazioni paragonabili a quelle del normale o perfino
del sordomuto. (Piaget, Inhelder, 1966, p. 80).
E, pertanto, la conclusione generale riguardo ai rapporti tra linguaggio e logica è che
il linguaggio non costituisce la fonte della logica, ma è invece da essa
strutturato. In altri termini, le radici della logica vanno cercate nella coordinazione generale delle azioni (condotte verbali comprese). (Piaget, Inhelder,
1966, p. 81).
Ma se la logica deriva dall’azione, da dove proviene allora il linguaggio? Almeno a prima vista, la risposta di Piaget su questo punto
sembra dilatoria. Egli infatti sostiene che, non tanto il linguaggio,
quanto tutta la funzione semiotica procede dall’imitazione. Ma se il
linguaggio è un sotto–prodotto della logica, perché invocare
l’imitazione per spiegarne la genesi?
Il fatto è che Piaget, a dispetto della sua fama di panlogista, sa
bene che noi esperiamo il linguaggio non come fatto logico, ma come nebulosa di significati che premono per essere espressi tramite
significanti. Spiegare il linguaggio, dunque, più che spiegare la sua
struttura logica, significa spiegare il segno in funzione del bisogno espressivo. Qual è a questo proposito l’argomentazione di Piaget?
Piaget distingue geneticamente due fasi. Una prima fase, senza evocazione di un oggetto assente, in cui i significati sono gli schemi
stessi con i loro contenuti relativi alle azioni in corso, e i significanti
sono percettivi e indifferenziati dai loro significati. Una seconda fase, con evocazione di un oggetto o di un avvenimento assente, che
implica l’uso di significanti differenziati (Piaget, Inhelder, 1966, pp.
51–52).
Si avrà così il bimbo di pochi mesi che riproduce in presenza del
modello un movimento della mano, e che continua anche in assenza
del modello, come puro fatto motorio. Ma si avrà poi la bimbetta di
16 mesi che assiste agli strepiti di un compagno e che, dopo qualche
ora dalla sua partenza, ne riproduce ridendo il comportamento. E,
poi, la stessa bimba che fa finta di dormire, e che poco dopo fa dormire il suo orsetto di peluche. E, infine, questa stessa bimba che dice
56
Capitolo III
“Miao” quando non vede più il gatto, o “Nonno via” indicando la
strada che poco prima il suo nonno ha imboccato andando via (Piaget, Inhelder, 1966, pp. 52–53).
Ora, in questi comportamenti rappresentativi dell’evoluzione
dalla prima alla seconda fase gli aspetti da sottolineare sono tre:
1) ad un livello primario, il significato coincide con l’azione ed è
mentalmente “cieco”. Con una frase incisiva, Piaget afferma che «ogni assimilazione senso–motoria (quella percettiva inclusa) consiste
già nel conferire significati» (Piaget, Inhelder, 1966, pp. 51–52).
Tuttavia, questi significati, la cui consistenza è assicurata dagli indici, rinviano a null’altro che a se stessi. Se, come Piaget sostiene rifacendosi ad una concezione veneranda del significare, sulla cui permanente validità torneremo tra poco, il significare consiste nel rappresentare qualcosa per mezzo di qualcos’altro, allora qui siamo al di
qua del significare. C’è la chiusura e la necessità del contenuto, e
non c’è l’apertura e la possibilità della forma;
2) nel caratterizzare la coscienza come un sistema di significati,
Piaget le attribuirà oltre all’operazione di implicazione, anche quella
di designazione (Piaget, 1967, p. 55). Ma prima che la coscienza si
installi come pensiero o forma logica compiuta, egli riconosce che il
segno, più che designare, evoca, suggerisce, narra, vive cioè in
stretta simbiosi con lo psichismo proprio del simbolo. L’emergenza
del segno, allora, si configura come un processo morfogenetico che
dall’azione corporea “cieca”, passando per il territorio del simbolico,
giunge al significare come rappresentazione, nel senso di qualcosa
che sta al posto di qualcos’altro. Come ho già detto, sulla struttura di
questo stadio finale, indagato da Peirce, ma anche da Saussure in
termini di immotivatezza del segno, tornerò tra poco;
3) nella morfogenesi del segno, l’imitazione, diffusa anche nel più
elementare mondo animale, assume la funzione di mediatore o fattore di crescita speciale, le cui varie espressioni, dal germe affettivo
dell’evocazione alla compiutezza formale del riferimento, avvengono nel quadro di processi di decentramento conoscitivo (Piaget,
1945). Questo status di alta specializzazione cognitiva è quello che le
odierne scienze della cognizione fanno oggetto delle loro indagini
(Meltzoff, Prinz, 2002), restringendosi però al solo comportamento
imitativo individuale, a prescindere dal contesto sociale e culturale
Sistema linguistico e eccedenza normativa
57
(Meltzoff, Prinz, 2002, p. 1). Quanto abbiamo visto sin qui, invece,
mostra che lo sviluppo psicogenetico indagato da Piaget, lungi dal
resuscitare una regressiva psicologia delle facoltà, può essere posto
in stretta continuità con le dinamiche sociogenetiche dell’imitazione.
In questo modo, si evita di operare, tra il livello dell’individuo e
quello della totalità sociale, un taglio magari giustificato dalla selettività della scienza (Meltzoff, Prinz, 2002, p. 2), ma che finisce per
impoverire l’analisi tanto dell’uno, quanto dell’altro livello. In ciò
sta l’interesse della possibile convergenza tra le indagini di Piaget e
quelle condotte nella più generale incomprensione da un autore come
György Lukács il quale, come abbiamo già ricordato, sotto
l’equivoca etichetta di un trattato di estetica, propose in realtà una
teoria sociogenetica della mente sociale (Lukács, 1963). In particolare per quanto concerne l’imitazione, Lukács mostra lungamente
(1963, I, capp. V–X) la sua funzione morfogenetica nel passaggio dal
sistema di segnalazione animale al linguaggio vero e proprio, sottolineando come una delle espressioni principali di tale crescita morfologica sia la «fantasia motoria», sorta di sistema semiotico intermedio, solidale con le manifestazioni evocativo–simboliche a valenza affettiva, le quali, nelle distinte sfere del pensiero quotidiano,
dell’arte e della scienza, sono toccate in modo differenti da ciò che
egli chiama i «processi disantropomorfizzanti», equivalenti di ciò
che Piaget, a sua volta, denomina processi di decentramento cognitivo. Del pensiero di Lukács, prenderemo in considerazione nel prossimo capitolo aspetti etico–ontologici e retorico–linguistici che, oltre
a confermare la sua sintonia con l’elaborazione di Piaget, saranno utili a definire la nostra prospettiva semioetica. Qui però era già opportuno segnalare queste convergenze nel campo specifico
dell’imitazione, anche alla luce delle ricerche in corso nelle neuroscienze circa le sue basi neurali, localizzate nei cosiddetti neuroni–specchio (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006). L’«immaginazione motoria», di cui si parla in tali ricerche, (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006, p.
94), sembra confermare, infatti, l’intuizione di Lukács circa la fantasia motoria. Ma ancora più importante è il fatto, da esse messo in evidenza, che i circuiti neuronali mirror implicati nell’osservazione e
nell’esecuzione di comportamenti finalistici, si attivano anche nel
funzionamento di quella soglia etica che è l’empatia, intesa come
58
Capitolo III
struttura motoria imitativa, precedente il livello linguistico–dichiarativo (Jacoboni, 2003; Gallese, 2005). Questi risultati, da
un lato, offrono ulteriore alimento all’integrazione di quel punto di
vista semioetico cui qui ci andiamo man mano introducendo;
dall’altro, come vedremo nel capitolo sesto, richiedono di essere assunti con cautela, soprattutto quando, nel giusto intento di evidenziare la novità dei meccanismi neuronali di base dell’imitazione e
dell’empatia, la polemica contro la concezione teoreticistica della
mente, propria del cognitivismo classico, si tramuta in un riduzionismo neuronale inaccettabile.
3. TIPOLOGIA DEI SEGNI E NATURA SEMIOTICA DELL’INTELLIGENZA
La tipologia dei segni (indice, simbolo, segno) emersa nella ricostruzione sin qui operata della semiologia di Piaget, si ricollega alla
tipologia di Peirce e Saussure, che Piaget non solo conosce bene, ma
a proposito delle quali mostra di avere un preciso giudizio.
Questo è quanto si deduce quando, quale esempio di una continua
autocostruzione del pensiero, Piaget cita proprio la funzione semiotica, con un diretto riferimento a Saussure e a Peirce:
Per attenersi alla funzione semiotica, non si può già pensare, accettando la
distinzione saussuriana fra il segno e il simbolo (più profonda, ci sembra, della
classificazione di Peirce), che c’è stata evoluzione dal simbolo immaginifico al
segno analitico? (Piaget, 1968, p. 144).
E, in una nota a questo passo, spiega:
Saussure distingue l’indice (che partecipa causalmente del suo significato),
il simbolo (motivato) e il segno (arbitrario), il quale è dunque necessariamente
sociale perché convenzionale, mentre il simbolo può essere indivduale (sogni,
ecc.). Peirce opponeva all’indice l’icona (immagine) e il simbolo (il segno, ma
legato ai due precedenti). (Piaget, 1968, p. 150).
Come si vede, qui convivono entrambe le accezioni del termine
arbitrarietà, quella pre–saussuriana di convenzionalità, e quella propriamente saussuriana di immotivatezza. Ma la convenzionalità è
Sistema linguistico e eccedenza normativa
59
interpretata come l’effetto del grado di astrazione raggiunto dal pensiero sociale. Di qui il giudizio di maggiore profondità sulla classificazione di Saussure rispetto a quella di Peirce.
3.1.
La tipologia dei segni in Peirce e Saussure
Vorrei qui richiamare il modo in cui Peirce illustra la dinamica
della seconda delle sue tre tricotomie dei segni, quella appunto cui fa
riferimento Piaget e in forza della quale un Segno può essere detto Icona, o Indice, o Simbolo (CP, 2.247 = 2003, pp. 139–140). Scrive
Peirce in proposito:
Un Simbolo è un segno naturalmente atto a esprimere quanto segue:
l’insieme di oggetti denotato da qualsiasi serie di indici, in certi modi connesso
al simbolo, è rappresentato da un’icona associata a esso. Per mostrare che cosa
significhi questa definizione complicata, prendiamo come esempio di simbolo
la parola “ama”. Associata a questa parola è un’idea, la quale idea è l’icona
mentale di una persona che ne ama un’altra. Ora si deve tenere presente che
“ama” occorre in un enunciato, e che ciò che può significare in sé, se pure significa qualcosa, non è qui in questione. Supponiamo allora che l’enunciato sia
“Ezechiele ama Huldah”. Allora, Ezechiele e Huldah debbono essere o contenere indici: infatti senza indici è impossibile designare ciò di cui si parla; qualsiasi mera descrizione lascerebbe in sospeso se essi possano essere meri personaggi di una ballata o no; ma sia che essi siano meri personaggi o no, gli indici
possono designarli. Ora, l’effetto della parola “ama” consiste nel fatto che la
coppia di oggetti denotati dalla coppia di indici Ezechiele e Huldah viene rappresentata dall’icona, ossia dall’immagine che abbiamo nella mente, di un amante e della sua amata (CP, 2.295 = 2003, pp. 173–74).
Dunque, gli indici sono ciò che dà consistenza alla designazione,
mentre l’icona è molto simile a ciò che oggi chiameremmo prototipo.
La funzione designativa degli indici e quella prototipica dell’icona è
ciò che consente ad un Segno, ovvero al simbolo, di significare. Se
vista in maniera dinamica e non statica, la seconda delle tricotomie
del Segno di Peirce è la descrizione del funzionamento cognitivo di
un atto di significazione.
Quanto a Saussure, conviene anche qui citare senza ulteriori
commenti il passo in cui ricorre la distinzione tra il simbolo, motivato, e il segno, immotivato, cui fa riferimento Piaget:
60
Capitolo III
Ci si è serviti [tradizionalmente] della parola simbolo per designare il segno
linguistico o più esattamente ciò che chiamiamo significante. Vi sono degli inconvenienti ad accoglierlo, appunto a causa del nostro primo principio [idest,
principio di arbitrarietà]. Il simbolo ha per carattere di non essere mai completamente arbitrario. Non è vuoto, implica un rudimento di legame naturale tra il
significante e il significato. Il simbolo della giustizia, la bilancia, non potrebbe
essere sostituito da qualsiasi altra cosa, per esempio un carro. (Saussure, CLG,
pp. 86–87).
In conclusione, come effettivamente Piaget sostiene, in Peirce il
simbolo appare «legato ai due precedenti», cioè l’indice e l’icona.
Ma la funzione che questi ultimi due svolgono nell’atto di significazione non è propriamente ciò che attira Piaget, che è invece interessato alla dimensione genetica implicita nella distinzione saussuriana
tra simbolo e segno. Egli, quindi, da un lato, adotta questa distinzione; dall’altro, la completa sia con la considerazione degli indici, sia
introducendo una progressione genetica dagli indici, propri dei significati agiti, ai simboli, motivati e individuali, ai segni, arbitrari nel
senso di convenzionali proprio perché immotivati.
3.2.
La natura semiotica dell’intelligenza: Piaget
Come abbiamo visto, per Piaget significare è rappresentare qualcosa per mezzo di qualcos’altro. L’interesse di questa classica concezione consiste nel modo in cui Piaget la intreccia con la sua concezione, altrettanto classica, dell’intelligenza.
Piaget critica l’interpretazione simbolica, avanzata dagli psicanalisti, della suzione del pollice da parte del bambino piccolo come
simbolo che sta per la suzione del seno. Qui, egli sostiene, non ci sarebbe simbolismo, ma solo estensione di schemi motori per integrazione di nuovi contenuti (Piaget, Inhelder, 1966, p. 17). Per dirla con
Mayr, siamo ad un livello teleomatico di abitudini, quindi di schemi
sensomotori d’insieme senza differenziazione tra mezzi e fini.
Ora, per Piaget, l’intelligenza consiste precisamente nella scelta
deliberata di perseguire scopi, ricercando attivamente i mezzi adatti
per raggiungerli (Piaget, Inhelder, 1966, p. 17). Un esempio di condotta intelligente lo offre il bambino che si propone di aprire una
scatola di fiammiferi socchiusa per impossessarsi di un dado che vi è
Sistema linguistico e eccedenza normativa
61
stato posto prima dentro (Piaget, Inhelder, 1966, pp. 19–20). In questo comportamento, è interessante il fatto che lo scopo di allargare
l’apertura della scatola per raggiungere il dado, è preceduto
dall’apertura e dalla chiusura della mano o della bocca da parte del
bambino, cioè dalla rappresentazione mentale, sebbene in parte ancora agita, dello scopo stesso: l’apertura e la chiusura della mano o
della bocca stanno per la scatola aperta. La funzione euristica della
significazione, che questa condotta esemplifica, spiega perché il linguaggio, secondo l’antica osservazione di Aristotele, serve agli uomini per determinare «ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di
conseguenza, il giusto e l’ingiusto» (Pol., 1253a 15–20). Nel suo intrecciarsi con l’intelligenza, il linguaggio, in quanto struttura semiotica, permette di anticipare la realtà, rendendo i mezzi e gli scopi non
solo calcolabili, ma anche ponderabili secondo criteri morali. Tuttavia, perché ciò avvenga, e su questo punto il testo aristotelico è assai
sintetico, l’intelligenza dovrà, per così dire, umanizzarsi, uscire cioè
dalla mutezza strumentale, e congiungersi con quella parola irrequieta che mette in contatto non più singoli della specie, ma individui di una comunità. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo,
in questo germinale momento discorsivo l’intelligenza si presenta
come lavoro, ovvero intelligenza storicamente situata, legata
all’emergenza della figura del dovere, che pone le basi per le successive trasformazioni morali.
Ma nell’attesa di questi approfondimenti, ritorniamo alla lettura
parallela di Peirce, Saussure e Piaget.
3.3.
La natura semiotica dell’intelligenza: Peirce
A questo proposito, ciò che si può facilmente constatare è che azione, scopo, segno e significazione come stare per sono i concetti
che anche Peirce usa per analizzare la stessa realtà di Piaget, cioè il
comportamento intelligente.
Per Peirce, la semiotica è la «dottrina della natura essenziale e
delle varietà fondamentali di ogni possibile semiosi» (CP, 5.488 =
2003, p. 270), dove per semiosi si intende una influenza tra il segno,
il suo oggetto e il suo interpretante «tale che questa influenza
tri–relativa non si possa in nessun modo risolvere in azioni fra cop-
62
Capitolo III
pie» (CP, 5.484 = 2003, p. 268). Ora, un’azione fra coppie è «ogni
azione dinamica o azione di forza bruta, fisica o psichica» avente
luogo o fra due soggetti, oppure risultante di tali azioni fra coppie
(CP, 5.484 = 2003, p. 268). E, a sua volta, un’azione bruta è
un’azione senza scopo, come la caduta di una pietra a terra (CP,
8.330 = 2003, p. 187). Nei termini di Mayr, un processo teleomatico.
Un segno, invece, è un’azione dotata di scopo, come per esempio il
comando «Armi a terra!» (CP, 5.473 = 2003, p. 260). Nei termini di
Mayr, un processo teleonomico.
Quest’analisi del segno condotta in termini di azione e scopo arriva, come ora vedremo, sin dentro al cuore del processo di significazione come stare per. Scrive infatti Peirce che «un segno, o representamen, è qualcosa che sta a qualcuno per qualcosa sotto qualche
rispetto o capacità. […] Il segno sta per qualcosa: il suo oggetto. Sta
per qualcosa non sotto tutti i rispetti, ma in riferimento a una sorta di
idea che io ho talvolta chiamato la base del representamen» (CP,
2.228 = 2003, pp. 147–48).
Un’analisi del carattere sostitutivo del segno in grado di unificare
le molteplici dimensioni cognitive, etiche e adattive del finalismo
linguistico: «RAPPRESENTARE. Stare per, cioè essere in una tale
relazione con un’altra entità da essere trattato da qualche intelletto
per certi scopi come se si fosse l’altra entità» (CP, 2.273 = 2003, p.
163. Corsivo mio).
Dunque, lo stare per del segno implica il suo essere trattato da
qualcuno per certi scopi, come si evince dal seguente passo dove
Peirce, a proposito dell’Icona, afferma che «qualsiasi cosa è atta a
servire da Sostituto per qualsiasi altra cui sia simile (il concetto di
“sostituto” implica quello di scopo, e dunque di Terzità genuina)»
(CP, 2.276 = 2003, p. 165. Corsivo mio).
Con riferimento al tema dell’imitazione cui più sopra si è accennato e alle ricerche neurocognitive sui neuroni–mirror, vorrei sottolineare il nesso che qui Peirce pone tra lo stare per del segno, il suo
essere trattato per certi scopi, e il suo essere in qualche modo copia
per poter funzionare da Sostituto. In particolare, l’Icona sembra essere la mappa neuro–motoria che si attiva quando degli indici sono interpretabili come indizi di scopi (Rizzolatti, Fogassi, Gallese, 2006,
p. 56)
Sistema linguistico e eccedenza normativa
63
Ma continuando nell’esame del rapporto tra stare per e scopo in
Peirce, si constata facilmente come esso si annidi dappertutto nella
sua riflessione. Così è quando, con riferimento alle definizioni di
pragmatismo date da James, scrive che «la sua quarta definizione è
che il pragmatismo è la dottrina secondo cui “ogni significato dipende dallo scopo”. Penso che vi sia molto da dire in favore di questa
definizione, che, tuttavia, farebbe apparire pragmatisti molti pensatori che non si considerano appartenenti alla nostra scuola di pensiero,
anche se le loro affinità con noi sono innegabili» (CP, 5.494 = 2003,
p. 277).
E così pure è quando riprende e sviluppa tutta questa materia a
proposito dei tre livelli di realtà, cioè la Primità, la Secondità e la
Terzità. Anche qui egli distingue tra azione diadica o bruta (Mayr direbbe azione teleomatica), e azione triadica o intelligente (Mayr direbbe azione teleonomica) (CP, 5.472 = 2003, p. 260). Ora, l’azione
diadica o bruta è anche Secondità, e «il tipo di idea di Secondità è
l’esperienza di uno sforzo, prescindendo dall’idea di uno scopo»
(CP, 8.330 = 2003, p. 186). L’azione triadica, invece, mediata dal
segno, è Terzità, e nella Terzità si troverà sempre un elemento mentale: «L’azione bruta è secondità, mentre ogni mentalismo implica la
terzità» (CP, 8.331 = 2003, p. 189).
Un’azione diadica o bruta, propria della Secondità, è dunque
un’azione senza scopo. Un’azione triadica o segnica, propria della
Terzità, è invece un’azione dotata di scopo. L’azione bruta è un processo teleomatico, l’azione segnica un processo teleonomico. Dunque, la vita, cioè i processi biologici volti al cosciente perseguimento
di scopi, coincidono con il segno.
3.4.
La performatività adattiva del segno
Nella sua analisi semiotica del vivente, laddove per vivente si intende un organismo intelligente, cioè capace di perseguire scopi,
Peirce avanza in una direzione presente anche in Piaget quando tratta
delle equilibrazioni discorsivo–morali. È l’idea di Legge o Convenzione. Quest’idea è presente anche in Saussure, sebbene solo come
paradigma con cui confrontare il grado normativo del sistema linguistico. Un punto sul quale, come vedremo nel capitolo quinto, egli si
64
Capitolo III
pone degli interrogativi che lo conducono in una direzione semioetica.
Per restare a Peirce, un’azione bruta o diadica o della Secondità, è
un’azione non regolata da una Legge o Convenzione. In proposito,
Peirce scrive: «Generalmente parlando, la Secondità genuina consiste in una cosa che agisce su un’altra: in un’azione bruta. Dico bruta,
perché nella misura in cui interviene l’idea di una qualsiasi legge o
ragione, interviene la Terzità» (CP, 8.330 = 2003, p. 187).
Ma che cos’è questa legge o ragione, e qual è la sua funzione?
Rileggiamo un passo precedentemente citato, ma questa volta per
intero e sino in fondo:
Se prendete in esame una qualunque comune relazione triadica, troverete
sempre un elemento mentale in essa. L’azione bruta è secondità, mentre ogni
mentalismo implica la terzità. Analizzate per esempio la relazione implicata in
‘A dà B a C’. Ora, che cos’è dare? Non consiste nel fatto che A allontana B da
sé e successivamente C prende B. Non è necessario che abbia luogo un trasferimento materiale. Dare consiste nel fatto che A rende C possessore secondo la
Legge. Ci deve essere un tipo di legge prima che vi possa essere un tipo di dare
— sia pure la legge del più forte. Ma ora supponete che dare consista in verità
semplicemente nel fatto che A depone il B che C successivamente raccoglie.
Questa sarebbe una forma degenerata di Terzità in cui la terzità è aggiunta esteriormente. Nel fatto che A allontana B non vi è terzità. Nel fatto che C prende
B non vi è terzità. Ma se dite che queste due azioni costituiscono una sola operazione in virtù dell’identità del B, superate il puro fatto bruto, e introducete un
elemento mentale. (CP, 8.331 = 2003, p. 189).
La chiusa di questo passo rivela, anzitutto, la consonanza esistente tra Piaget e Peirce circa la loro concezione del «mentale». Per
Piaget, la mente è retta da una logica sorta dall’interiorizzazione
dell’azione intersoggettiva (Aqueci, 2003). Analogamente, per Peirce, la mente è costituita dalla «sola operazione in virtù dell’identità
del B», che unifica le azioni singole di A e di C. Anche qui, dunque,
la mente, sebbene solo dal punto di vista strutturale e non più genetico, coincide con un’operazione logica intersoggettiva.
Ora, questa concezione logico–intersoggettiva della mente consente a Peirce, come mostra l’intero passo che abbiamo letto, di affermare una performatività del segno più generale e profonda rispetto a quella che, negli anni Cinquanta del secolo scorso, John L.
Sistema linguistico e eccedenza normativa
65
Austin (1911–1960) sottolineò a proposito di alcune classi di segni
(Austin, 1962). Infatti, mentre Austin, almeno in una prima fase, distingue tra enunciati constativi, con cui descriviamo fatti, e enunciati
performativi, con cui compiamo azioni, Peirce afferma che il segno è
sempre performativo, e ciò in virtù del nesso tra il suo stare per e il
suo essere trattato per certi scopi. Un nesso che è il mezzo per rendere efficiente, cioè non bruta ma finalistica, l’azione: «Mi sembra che
la funzione essenziale di un segno sia di rendere efficienti relazioni
inefficienti — non di porle in azione, ma di stabilire un abito o regola generale secondo la quale esse all’occasione entreranno in azione» (CP, 8.332 = 2003, p. 191).
Segno e Legge, dunque, coincidono. Certo, la Legge o abito di cui
parla Peirce, e con lui tutto il pragmatismo, è come un magma morale raffreddatosi nello stampo del segno. Vedremo nel corso di questo libro come occorrerà staccarsi da questo ancoraggio, e affrontare
il mare aperto della norma etico–politica. Ciò che qui possiamo affermare, però, è che Segno e Legge sono lo strumento per rendere efficiente il perseguimento degli scopi e, in ultima analisi, per permettere al vivente di accrescere le proprie opportunità adattive.
4.
PEIRCE, SAUSSURE, PIAGET: UNA ANALITICA DEL VIVENTE
Abbiamo visto che per Peirce la semiotica è la dottrina di ogni
possibile semiosi, semiotiche brute o teleomatiche come semiotiche
segniche o teleonomiche (CP, 5.488 = 2003, p. 270). Quanto a Saussure, una prima definizione è quella ben nota della semiologia come
scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale, e
che dovrebbe dirci in che consistono i segni e quali leggi li regolano
(Saussure, CLG, pp. 25–27). Una seconda è l’altra, altrettanto nota
ma assai meno citata, secondo la quale oggetto principale di una semiologia interamente stabilita deve essere «l’insieme dei sistemi
fondati sull’arbitrarietà del segno», poiché è nei segni interamente
arbitrari, cioè immotivati, come quelli della lingua, che si realizza
meglio «l’ideale del procedimento semiologico» (Saussure, CLG, p.
86).
66
Capitolo III
Morfogenesi della cognizione sociale
pensiero individuale
egocentrico
pensiero sociale
decentrato
costrizione
(rispetto unilaterale)
cooperazione
(reciprocità morale)
discorso autoritario
(monologo)
–
simbolo
discorso internamente
persuasivo
(argomentazione)
segno arbitrario
funzionale a sistema di concetti
stabile e mobile
–
Alla luce anche di quanto abbiamo visto in Peirce, possiamo ora
mettere a frutto la lettura genetica di Saussure che Piaget ci suggerisce. Se, infatti, il segno immotivato, ovvero analitico, rappresenta il
culmine tanto dello sviluppo psicogenetico, quanto dell’evoluzione
sociogenetica; se, per converso, la psicogenesi, e in una qualche misura anche la sociogenesi, sono una sorta di “narrazione”
dell’immotivatezza del segno; se, infine, il segno immotivato rappresenta il completo stabilirsi dei processi teleonomici, allora la semiologia saussuriana non sarà solo una scienza classificatoria, ma
un’analisi formale del segno vivente.
Nel capitolo quinto, vedremo quali sono le strutture che
quest’analisi formale porta alla luce, di che natura sono, e quali sono
i rapporti tra la normatività linguistica e la normatività della Legge o
Convenzione. Ciò che qui possiamo anticipare è che la tensione tra
libertà espressiva e costrizione dell’uso, se è tipica del sistema linguistico (Gambarara, 2006, p. 227), essa è anche un’eccedenza normativa che, malgrado gli sforzi operati per tenerne conto linguisticamente (Coseriu, 1952; Coseriu, 1958), conduce fuori dal sistema
linguistico.
In tal senso, la prospettiva genetica di Piaget, con la quale abbiamo fatto interagire le semiotiche di Peirce e Saussure, suggerisce che
tanto la Legge di Peirce, quanto il sistema linguistico di Saussure
normativamente inteso, possono essere concepiti come una morfogenesi della cognizione sociale, governata dalle trasformazioni af-
Sistema linguistico e eccedenza normativa
67
fettivo–morali del rispetto, le quali si manifestano passando da forme
di discorso che, sulla scorta di Bachtin, potremmo chiamare autoritarie, a forme di discorso internamente persuasivo. Tale morfogenesi,
le cui manifestazioni discorsive sono state del resto analizzate dallo
stesso Piaget sul piano psicogenetico (Piaget, 1923), appare segnata
dalla successione delle due grandi fasi della costrizione e della cooperazione, cui corrisponde cognitivamente il passaggio dal pensiero
individuale egocentrico al pensiero sociale decentrato, con le loro rispettive strutture semiotiche (Piaget, 1977, pp. 271–73) (v. schema
della morfogenesi della cognizione sociale).
Da questo punto di vista discorsivo, e non più puramente linguistico, può essere allora rivisitata, come faremo più oltre (cap. V), la
distinzione di Saussure tra esprit de clocher e esprit d’intercourse,
per imprimerle quel dinamismo evolutivo che Piaget suggerisce tra
simbolo individuale e segno analitico. Quel che intanto possiamo affermare, in chiusura di questo capitolo, è che la lettura genetica della
distinzione saussuriana di simbolo e segno, avanzata da Piaget, consente di legare la semiotica di Peirce alla semiologia di Saussure,
proiettandole verso l’orizzonte di una analitica del vivente in cui acquista un ruolo centrale la dinamica delle strutture discorsivo–morali.
Capitolo quarto
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
Le vie sin qui esplorate di una possibile semioetica, implicano una definizione di comunicazione come ideazione pubblica di contenuti di pensiero individuali, intendendo con ciò la progressione genetica ma, al tempo stesso, la problematicità con cui si stabilisce la
comunicazione sociale.
Questa definizione ripropone la questione di ciò che trent’anni fa
Ferruccio Rossi Landi chiamava l’alienazione del linguaggio. Alienazione linguistica, nel senso che il parlante, dal momento in cui entra nella macchina di produzione linguistica, ne deve accettare inesorabilmente le regole, pena la sua morte linguistica. E questa inesorabilità del meccanismo lo spossessa del suo prodotto linguistico, e
rende la comunicazione un processo che sovrasta l’individuo (Rossi
Landi, 1968, pp. 103–104). Non esiste, dunque, linguaggio privato, e
la comunicazione è solo pubblica, ma in quanto tale il linguaggio è
alienato.
Questa identificazione di linguaggio, carattere pubblico della comunicazione e alienazione riproduce lo stesso errore che György
Lukács riconobbe autocriticamente nella sua identificazione giovanile di oggettivazione e alienazione, ammettendo che
«l’oggettivazione è naturalmente priva di un indice di valore» (Lukács, 1967, p. XLIV). Lo stesso si può dire del linguaggio, il quale
69
70
Capitolo IV
emerge da una socialità eticamente neutra, di cui la naturale «attenzione comune» fra i partecipanti all’interazione comunicativa è il
tratto peculiare (Bara, 1999, p. 84). Tuttavia, una caratterizzazione di
tale emergenza come progressione linearmente naturale che va
dall’attenzione comune alla restrizione progressiva sui materiali fonetico–sintattici, sino al dibattito pubblico quale libero esame condiviso (Changeux, 2002, pp. 149–152), rende implausibilmente deterministico, per dirla con i termini classici di John Locke (1632–1704),
autore di cui tratteremo nel capitolo sesto, il passaggio dalla socialità
linguistica, o socialità naturale dello stato di natura (Locke, Secondo
trattato sul governo, VIII, 95, p. 297), alla socialità discorsiva, o socialità normativa del patto politico (ivi, IV, 22, p. 244). Un passaggio
che, quando si innesca, è sorretto dalla struttura trasformazionale del
rispetto, il quale, come è stato ultimamente sottolineato, «significa
accettare negli altri proprio ciò che non si capisce di loro» (Sennett,
2004, p. 256). L’opacità dei contenuti individuali non è dunque un
dato estrinseco che la comunicazione può rimuovere, né d’altra
parte la loro messa in discorso coincide con l’alienazione del soggetto linguistico. L’attenzione comune, come anche la presupposizione che l’altro compia le mie stesse operazioni logico–discorsive
quando usa le parole, già messa in evidenza dallo stesso Locke (Saggio sull’intelletto umano, III, II, 4, p. 477), e su cui torneremo più
oltre (cap. VI), sono strutture eticamente neutre della comunicazione.
Tuttavia, se al pari dell’oggettivazione, la comunicazione vuole essere un’esperienza che non allontana l’essere dell’uomo dalla sua essenza (Lukács, 1967, p. XLIV), allora essa deve incorporare una
buona dose di opacità dell’altro.
Nel presente capitolo, affronteremo queste questioni approfondendo il nesso tra segno, scopo e intelligenza già in parte esplorato
nel capitolo precedente, a proposito delle semiotiche di Peirce, Saussure e Piaget. Come si ricorderà, il rapporto tra segno e morale è emerso dal fatto che il linguaggio, in quanto programma finalistico aperto o, secondo i termini di Mayr, teleonomico, comprende fra i
suoi scopi anche quello di ponderare il giusto e l’ingiusto. Proveremo ora a serrare ulteriormente questo nesso semioetico, prendendo
in conto non più solo il linguaggio, ma anche la mente.
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
71
1. LA MENTE TRA DOVERE E SEGNO
A tal fine, vorrei ricollegarmi ancora alle ricerche di Rossi Landi,
in particolare alla sua ipotesi circa un’omologia esistente tra linguaggio e mercato, tra segni e merci, ipotesi poi ripresa in maniera
più sofisticata da Umberto Eco (1975, pp. 39–40; 203), il quale non
cercherà più di applicare le categorie dell’economia al linguaggio,
ma di inglobare l’economia nella semiotica.
Il punto che vorrei riprendere di queste discussioni, concerne la
caratteristica di tutte le merci, compresa la merce–lavoro, di essere
segni del lavoro sociale astratto.
Secondo la formulazione di Lucio Colletti (1969, p. 106), interessante non solo perché, come al solito, molto limpida, ma anche per le
conseguenze che se ne possono trarre circa i modi di conoscenza del
pensiero sociale, aspetto che qui però non tratterò — secondo tale
formulazione, dicevo, il lavoro sociale astratto è ciò che vi è di eguale e comune in tutte le concrete attività lavorative umane (falegnameria, tessitura, filatura, ecc.), quando queste attività siano considerate a prescindere dagli oggetti reali, o valori d’uso, che esse di
fatto lavorano e in funzione dei quali si diversificano (tavolo, stoffa,
filo, ecc.). Considerati come prodotti dal lavoro astratto, considerati
cioè in riferimento ad un valore che li eguaglia e li rende scambiabili
l’uno con l’altro, tutti i prodotti dei lavori concreti vedono cancellate
le loro qualità sensibili di valori d’uso, per rappresentare ormai soltanto dei valori di scambio, valori di merci. In altri termini, un tavolo
sta per tot ore di lavoro astratto, una stoffa sta per altre tot ore di lavoro astratto, e ciò che in realtà si baratta o, servendosi
dell’intermediario del denaro, si scambia, sono quantità di lavoro
sociale astratto, cioè valori di scambio.
Non bisogna nascondersi il fatto che, nella scienza economica,
per le difficoltà che sorgono dal tradurre il valore in prezzi (cioè, in
valori di efficienza), questo modo di concepire la merce e il mercato
è stato a più riprese contestato e rigettato. E a tal proposito, basti
citare la travagliata riflessione di un Claudio Napoleoni che, cosa
degna di nota, seguendo un percorso tutto interno all’economia politica, dalla negazione della teoria del valore–lavoro è giunto a riscoprire «l’altro come tuo primo bisogno», e l’uomo come «nodo di re-
72
Capitolo IV
lazioni» naturali e sociali (Napoleoni, 1985).Oggi, Amartya Sen, con
la sua teoria delle capacitazioni, cerca forse di rendere tecnico ciò
che per Napoleoni restò solo un orizzonte.
Ma tornando al filo del discorso, non bisogna nascondersi, dicevo,
il fatto che la scienza economica rifiuta la teoria del valore–lavoro, e
ciò per evitare quell’impressione di “mare tranquillo”nei rapporti tra
le discipline, in particolare la semiotica e l’economia politica, che si
ricava da Rossi Landi e Eco, come se le categorie dell’una potessero
essere “verificate” senza residui dall’altra.
C’è indubbiamente questa categoria dello stare per che è un forte
punto di contatto tra le due discipline, e che rende suggestiva
l’ipotesi che la merce, in quanto sta per una certa quantità di lavoro
sociale astratto, è in forza di ciò un segno. È a partire da qui che Eco
ha proposto la sua nozione di cultura come semiotica generale, la
quale si instaura nel momento in cui il lavoro di un essere pensante si
fissa in una relazione di rimando ad uno scopo. Ad esempio, a seguito di una pratica fortuita e primordiale, un essere pensante userà
pietre S1, S2, … Sn, in funzione dello scopo di rompere delle noci, riconoscendole come occorrenze di ciò che egli, poco importa se pubblicamente o privatamente, ha denominato “pietra che serve a qualcosa”, cioè a rompere delle noci (Eco, 1975, pp. 37–38).
È di tutta evidenza, e non meraviglia che ciò accada in Eco, che la
relazione di rimando che rende semiotico quel lavoro (“la pietra che
serve a qualcosa” e tutte le sue occorrenze stanno per lo scopo di
rompere le noci) ricade interamente in una delle due definizioni di
segno di Peirce, quella secondo la quale il rappresentare è uno «stare
per, cioè essere in una tale relazione con un’altra entità da essere
trattato da qualche intelletto per certi scopi come se si fosse l’altra
entità» (Peirce, 2003, p. 163).
Notiamo ancora che Eco afferma che «se un essere vivente usa una pietra per spaccare una noce, non si può ancora parlare di cultura»
(1975, p. 37). Di conseguenza, il lavoro produttivo di cui poi Eco si
occuperà in tutto il suo Trattato, non sarà il lavoro in generale, ma
solo il lavoro produttivo segnico, cioè lo sforzo fisico e psichico
compiuto nell’interpretare e produrre segni, messaggi, testi (1975, p.
204).
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
73
Notiamo, infine, che per Eco le discipline che studiano il lavoro
produttivo segnico, sono la teoria dell’informazione, la fonetica, le
scienze fisiche, poi la retorica in un senso ampio, e infine la logica e
la filosofia dei linguaggi naturali. Solo marginalmente e genericamente vengono menzionate anche le altre scienze «che vertono sugli
stessi argomenti» (1975, p. 205, tavola 31).
È questa barriera disciplinare così netta che qui vorrei provare un
po’ a scuotere, puntando lo sguardo su quel momento in cui il lavoro
è ancora solo produttivo e sta per diventare segnico, prima insomma
che la struttura semiotica si installi, e le discipline chiamate ad analizzarla stabiliscano la loro ferrea legalità.
Capisco che è come andare a cercare guai, perché, tentando di fissare qualche fotogramma in più della genesi, da un lato si rischia di
perdere la cristallina purezza del lavoro produttivo segnico, dall’altro
non si ha nemmeno il conforto dell’economia politica che, come ho
già ricordato, rifiuta con buoni argomenti di teoria economica la categoria del lavoro da cui deriverebbe il valore di scambio delle merci, e quindi il carattere semiotico del mercato.
Tuttavia, ritengo che valga la pena di pagare il primo prezzo, e
quanto al secondo, non essendo primariamente interessati all’analisi
economica, possiamo limitarci ad estrapolare l’ipotesi antropologico–evolutiva che c’è dietro la concezione del valore–lavoro, così
come la si ritrova nei padri fondatori dell’economia politica, da Locke, per il quale il lavoro era il modo in cui l’uomo si assimila la
natura e da cui nasce il diritto alla proprietà privata, a Smith, che lo
considerava nel quadro di un’etica “umanistica” della simpatia, sino
allo stesso Marx, che è critico dell’uno e dell’altro, ma, come dire,
per troppo generosità, perché nel lavoro vedeva la possibilità della
realizzazione massima delle potenzialità umane, e gli dispiaceva che
vi si scorgesse solo la dimensione del sacrificio imposto dalla maledizione divina. Questo è un punto su cui ritornerò.
Intanto, se vogliamo riassumere quest’ipotesi antropologico–evolutiva, possiamo dire che Locke o Smith o Marx, tutti hanno
più o meno sottolineato il fatto che dopo l’esplosione dell’istinto, il
lavoro è stato il modo tipico dell’uomo di soddisfare i propri bisogni.
In particolare, il lavoro è apparso come il mezzo che serve a raggiungere i fini legati al soddisfacimento dei bisogni umani. Questo
74
Capitolo IV
rapporto mezzi/fini era prima incorporato nell’istinto (il castoro che
costruisce le dighe, l’ape che dà vita all’alveare). Dopo l’esplosione
dell’istinto, avvenuta con l’emergere e per l’emergere della specie
umana, cioè dopo la rottura del legame meccanico e unideterminato
tra mezzi e fini, il lavoro è stato la risposta adattiva tipica della specie umana per riaccordare questi “pezzi” del meccanismo finalistico.
La storia sociale del lavoro è poi un capitolo che è stato scritto
soprattutto da Marx, quando ha mostrato che l’avvento del mercato
capitalistico ha trasformato il lavoro, da mezzo per soddisfare bisogni, in una potenza sociale “macchinale” o “macchinica”, (certo il
termine “tecnologico” è troppo usurato per rendere l’idea di una
concentrazione inaudita di tecnica e cognitività), di cui gli individui
sono delle semplici appendici nervose (Grundrisse, p. 709). È questo
lo stadio del vero e proprio lavoro sociale astratto, un lavoro reificato, alienato, “estratto” dagli individui da quel potente ma cieco meccanismo di coordinazione dei mezzi con i fini che è il lavoro divenuto capitale.
Ma qui possiamo tralasciare quest’aspetto, per concentrarci, invece, sulle conseguenze semioetiche che derivano, da un lato, da una
concezione sostantiva, e non più semiotico–formale, del lavoro come
struttura finalistica, e, dall’altro, da una concezione strumentalmente
semiotica della merce come stare per, cioè come qualcosa (l’oggetto
sensibile che soddisfa un nostro bisogno) che sta al posto di qualcos’altro (la quantità di lavoro sociale astratto necessaria a produrlo).
A questo punto, consideriamo le due definizioni di segno che si
ritrovano in Peirce, la prima, già richiamata, secondo la quale il segno è qualcosa che sta al posto di qualcos’altro, in funzione di un
qualche scopo; la seconda che afferma che il segno è un mezzo per
rendere efficienti relazioni inefficienti (Peirce, 2003, p. 191). Dopo
l’esplosione dell’istinto, l’efficienza della relazione mezzi/fini è cruciale per l’adattamento vitale della specie umana. Qual è allora il legame tra il segno così definito e l’adattamento vitale post–istintuale?
Leggiamo l’analisi dell’atto del dare che Peirce ci propone:
Se prendete in esame una qualunque comune relazione triadica, troverete
sempre un elemento mentale in essa. L’azione bruta è secondità, mentre ogni
mentalismo implica la terzità. Analizzate per esempio la relazione implicata in
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
75
‘A dà B a C’. Ora, che cos’è dare? Non consiste nel fatto che A allontana B da
sé e successivamente C prende B. Non è necessario che abbia luogo un trasferimento materiale. Dare consiste nel fatto che A rende C possessore secondo la
Legge. Ci deve essere un tipo di legge prima che vi possa essere un tipo di dare
— sia pure la legge del più forte. Ma ora supponete che dare consista in verità
semplicemente nel fatto che A depone il B che C successivamente raccoglie.
Questa sarebbe una forma degenerata di Terzità in cui la terzità è aggiunta esteriormente. Nel fatto che A allontana B non vi è terzità. Nel fatto che C prende
B non vi è terzità. Ma se dite che queste due azioni costituiscono una sola operazione in virtù dell’identità del B, superate il puro fatto bruto, e introducete un
elemento mentale (Peirce, 2003, p. 189).
Vorrei far notare che le forme primitive del baratto sono regolate
da un’etichetta che appare curiosamente simile alla terzità degenerata di Peirce, cioè qualcuno lascia cadere “casualmente” qualcosa
che qualcun altro successivamente altrettanto “casualmente” raccoglie (Polany, 1944, p. 80). Ma più che terzità degenerata, qui c’è, da
un lato, il permanere piacevole nella degenerazione che segue
all’esplosione dell’istinto e che precede l’instaurarsi del mentale;
dall’altro, terzità germinale, com’è testimoniato dal fatto che lo
scambio risponde ad una logica sociale di reciprocità, irriducibile al
punto di vista economico–razionale. Del resto, qualcosa di simile si
riproduce sui treni, gli autobus o i caffè, soprattutto del Nord Europa,
con quelle ragazze o ragazzi che passano, lasciano un ninnolo ad ogni passeggero o avventore, e ripassano poco dopo ritirando le monete che ciascuno di essi ha deciso di dar loro. In questa pratica silenziosa che, certo, non è più un dare, ma un sollecitare, sollecitare
un dono, si sarebbe tentati di vedere ancora una volta una logica economica mascherata o degenerata, quando probabilmente non c’è
altro che una residua luminescenza della gratuità del legame sociale
andata perduta in una società interamente retta dalla logica economica.
Ma tornando all’etichetta del baratto primitivo, e alla strana terzità che ci rivela, potremmo dire che essa è come se testimoniasse
dell’impulso a godere dell’infinita libertà acquisita dopo la fine della
costrizione della relazione istintuale mezzi/fine, e prima che si instauri il «mentale» (Peirce), cioè la regolazione costruita della relazione mezzi/fini. Ma costruita, come?
76
Capitolo IV
L’abbiamo visto: un contributo importante lo dà il segno, sub
specie di abito, in quanto mezzo per rendere efficienti relazioni inefficienti. Ma c’è dell’altro. Una delle prime manifestazioni discorsive
della figura deontica del Dovere è, subito dopo il divieto di conoscere il fondamento della morale, la maledizione divina seguita alla caduta, e riportataci dal Genesi: “Lavorerai con il sudore della tua
fronte”. Una figura che si manifesta proprio quando esplode quella
consonanza istintuale tra natura e bisogni trasfigurata nel mito del
Paradiso terrestre.
Intendiamoci, non voglio dire che prima di quella “scissione” non
ci sia lavoro. Se leggiamo il resoconto del Genesi, vediamo che Dio
crea Adamo e lo pone nel bel giardino perché lo mantenga e lo custodisca. Non è, dunque, che Adamo è posto nel giardino perché non
faccia nulla. Adamo ha un lavoro da fare, quello di mantenere e custodire il giardino. Semplicemente, si tratta di un lavoro che risponde
ad una causalità posta non da lui, ma da Dio. Egli è strumento di una
teleologia che lo sovrasta. Solo quando Adamo pecca, indotto in ciò
dalla sua compagna, e viene scacciato dal giardino, il lavoro diventa
un’alternativa: lavorare e sopravvivere, non lavorare e morire. Il lavoro diventa, dunque, oggetto di scelta, e allora si rende necessario
un regolatore sociale che conformi la decisione ai bisogni vitali.
Osservo di passata che in questo racconto delle origini la donna
appare come un operatore di libertà. Ma il punto che voglio sottolineare, e che riconduce alla traccia principale del nostro ragionamento, è che, come il segno, anche il Dovere si presenta come un
mezzo per rendere efficienti relazioni inefficienti, un mezzo per
contro–bilanciare l’impulso a dissipare energia, in assenza ormai
delle regolazioni automatiche dell’istinto. Nella sua prima forma costrittiva, ecco allora il carattere adattivo della morale, su cui, dai sociologi agli etologi, si insiste. Ma ciò significa anche che, originariamente, il «mentale» di Peirce è, oltre che semiotico (segno), anche
etico (Dovere), in quanto si instaura grazie alla funzione adattiva
tanto del segno, quanto del Dovere.
L’impulso, poi, che ha portato a escogitare il segno e il Dovere
come mezzi adattivi, non può che essere l’istinto di sopravvivenza,
esattamente opposto all’istinto di morte che si manifesta nella dissipazione piacevole della reciprocità sociale primitiva, ma anche del
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
77
simbolo. Qui si vede il carattere sofistico e forse patologico di chi,
mondanizzando il pessimismo religioso del racconto biblico delle origini, ha preteso di raffigurare l’uomo come “gettato nel mondo”,
rappresentandolo in preda all’angoscia. Così facendo, si è enfatizzato
il momento negativo di una situazione che in realtà non è tanto dominata dalla paura della morte o dalla speranza di qualcuno o qualcosa che ci salvi, ma è piuttosto caratterizzata dal desiderio di vivere.
In realtà, in quanto essere biologico, l’uomo desidera, desidera vivere, e questo desiderio incontra la resistenza dell’ambiente.
Un’ontologia non mistificatrice non può essere, allora, quella esistenzialista dell’angoscia, della morte e del nulla, ma un’ontologia
realista di un soggetto che nel suo desiderio di vivere incontra la forza di resistenza dell’oggetto.
2. L’INTELLIGENZA AL LAVORO: PEIRCE E LUKÁCS
Sul terreno di una tale ontologia realista reincontriamo, come già
annunciato, György Lukács, autore in vecchiaia della grande Ontologia dell’essere sociale, e possiamo riprendere il discorso su Peirce,
per un confronto che chiarisca e arricchisca entrambe le prospettive.
Fra i due, infatti, c’è una insospettabile ma credo non superficiale
convergenza che verte intorno alla dicotomia tra causalità e teleologia, ovvero per dirla ancora con Mayr, tra processi teleomatici e processi teleonomici. Una dicotomia, che almeno per quanto riguarda
Peirce, ma in maniera più sottintesa anche Lukács, innerva
l’ontologia su cui edificare ogni semiotica (Lukács direbbe: ogni teoria dell’ideologia). Data la vastità della trattazione, specie in Lukács,
il confronto che proporrò non è organico. A titolo di esperimento,
oltre a fare riferimento agli scritti canonici di Peirce, ho utilizzato
qui di Lukács, oltre che alcuni luoghi dei Prolegomeni all’ontologia
dell’essere sociale, sorta di abrégé della grande Ontologia, soprattutto un piccolo testo di sintesi che egli redasse come comunicazione
ad un congresso di filosofia della fine degli anni Sessanta, che ebbe
luogo a Vienna, e a cui poi non partecipò. In lingua italiana, lo
scritto si intitola Le basi ontologiche del pensiero e dell’attività
dell’uomo, ed è stato pubblicato nel 1973, assieme a un saggio Su
78
Capitolo IV
Lenin e il contenuto attuale del concetto di rivoluzione, dagli Editori
Riuniti, in un volumetto ormai credo introvabile dal titolo complessivo e sommario L’uomo e la rivoluzione. Benché dunque la base testuale del confronto sia limitata, credo che, per gli scopi che qui mi
propongo, il rischio dell’incompletezza andava corso, anche perché
il confronto ci permetterà un rilancio sul tema del lavoro come intelligenza applicata all’adattamento vitale dopo l’esplosione
dell’istinto.
Entrando in argomento, ricorderò che la tripartizione ontologica
di Peirce è quella che abbiamo incontrato nel brano sopra letto, dove
si distingue una Primità, una Secondità e una Terzità. Abbozzando
una analisi pragmatista dei significati modellata sulla valenza e la
combinabilità degli elementi della tavola chimica di Mendeleev,
Peirce così definisce una prima volta le tre classi di caratteri o predicati denominate appunto Primità, Secondità e Terzità:
In primo luogo vengono le “primità”, o caratteri positivi interni del soggetto
in sé; in secondo luogo vengono le “secondità”, o azioni brute di un soggetto su
un altro, senza riguardo alla legge o ad alcun altro terzo soggetto; in terzo luogo vengono le “terzità”, intendendo per “terzità” l’influenza mentale o quasi–mentale di un soggetto su un altro relativamente a un terzo (Peirce, 2003, p.
258).
Un’altra definizione delle stesse categorie è la seguente:
Fra i tanti principi di Logica che trovano applicazione in Filosofia, qui posso menzionarne solo uno. Ci sono tre concetti, che saltano fuori dappertutto in
ogni teoria della logica, e che nei sistemi più rifiniti si presentano in connessione fra loro. Sono talmente ampi e quindi indefiniti che è difficile afferrarli, e
così possono facilmente venir trascurati. Io li chiamo i concetti di Primo, Secondo, Terzo. Primo è il concetto di essere o di esistere indipendentemente da
alcunché d’altro. Secondo è il concetto di essere relativo a, il concetto di reazione con, qualcosa d’altro. Terzo è il concetto della mediazione, per mezzo
della quale un primo e un secondo sono posti in relazione. Per illustrare queste
idee fondamentali mostrerò come entrino nelle idee che stiamo considerando.
L’origine delle cose, considerata non in quanto conduca ad alcunché, ma in se
stessa, contiene l’idea di Primo; il compimento delle cose l’idea di Secondo; il
processo di mediazione fra di esse l’idea di Terzo. Una filosofia che ingigantisce l’idea dell’Uno è generalmente una filosofia dualistica in cui il concetto di
Secondo riceve esagerata attenzione; perché questo Uno (sebbene naturalmente
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
79
implichi l’idea di Primo) è sempre l’altro di una molteplicità che non è una.
L’idea di Molti, poiché la varietà è arbitrarietà, e l’arbitrarietà è rifiuto di ogni
secondità, ha come componente principale il concetto di Primo. In psicologia,
il Sentimento è primo. il Senso di reazione è Secondo, il concetto Generale è
Terzo o mediazione. In biologia, l’idea di variazione arbitraria è Primo,
l’ereditarietà è Secondo, il processo per cui si fissano i caratteri accidentali è
Terzo. Il caso è Primo, la legge è Secondo, la tendenza ad assumere abiti è Terzo. La Mente è primo, la Materia è secondo, l’Evoluzione è Terzo (Peirce,
2003, p. 348).
Da questi passi credo che si comprenda agevolmente come
l’intento di Peirce sia di costruire una ontologia logico–formale capace di districarsi dalla pastoie della materia. Per Peirce, infatti, le
classificazioni fondate sulla forma sono di molto superiori per la
comprensione scientifica delle cose, di quelle fondate sulla materia.
E la classificazione chimica di Mendeleev, con la sua distinzione tra
«gruppi» (cioè fra le diverse colonne verticali della tavola), e «serie»
(cioè le diverse file orizzontali della tavola), ne è per lui un chiaro
esempio. Infatti, mentre le distinzioni fra gruppi dipendono dalle differenti valenze degli elementi, le distinzioni fra serie dipendono dal
fatto, «non tanto formale, quanto materiale, che gli atomi degli elementi di una “serie” hanno masse maggiori degli atomi di un’altra
serie». Ugualmente, elementi che si trovano in differenti file orizzontali, ma nella stessa colonna verticale, presentano sempre marcate
differenze fisiche, ma il loro comportamento chimico a temperature
corrispondenti è esattamente simile (Peirce, 2003, p. 258).
Il primato della forma sulla materia che Peirce pone a base della
sua ontologia, comporta di conseguenza il superamento della distinzione tra organico e inorganico, che è invece quella cui si attiene Lukács, il quale distingue tra mondo inorganico, organico e sociale, secondo il criterio della predicabilità o meno, per ciascuno di questo
regno dell’essere, delle categorie di valore e dover essere. Nella natura inorganica, nota Lukács (1969, p. 27), è di tutta evidenza che i
mutamenti da un modo di essere all’altro non hanno nulla a che fare
né coi valori, né con il dover essere. Nella natura organica, nota ancora Lukács, il processo di riproduzione significa ontologicamente
adattamento all’ambiente, e si può già parlare di riuscita o di insuccesso. Dal punto di vista ontologico, però, non si oltrepassa il mero
80
Capitolo IV
passaggio da uno stato A precedente, a uno stato B susseguente.
Completamente diversa è la situazione quando si entra nel mondo
sociale, dove gli oggetti incorporano quale proprietà effettiva il loro
essere finalizzati ad un qualche scopo, il che fa sì che gli oggetti assumano un valore per chi pone lo scopo.
Come si vede, a questo livello, il punto di vista di Lukács è più
tradizionale di quello di Peirce, poiché la sua tripartizione è ancora
di tipo sostanzialistico. Ciò che è interessante, però, è la parentela,
segnalata già dal concetto di scopo, e al tempo stesso la contrapposizione delle forze che, per così dire, muovono queste tripartizioni.
In effetti, la tripartizione di Peirce, per il suo carattere non solo
ontologico, ma anche logico, sembra essere fatta apposta per fare a
meno di qualsiasi dinamismo. Si vede però che ciò non appaga Peirce, se è vero che egli tenta di dinamizzarla tramite un Amore universale dal carattere orgogliosamente lamarckiano. Ritengo infatti che la
sua teoria agapica non sia una bizzarria di un pensatore altrimenti
geniale, ma una parte essenziale del suo pensiero, contro cui non
serve far finta di niente, né minimizzarne o ignorarne, più o meno
consapevolmente, gli aspetti sorprendenti o addirittura imbarazzanti.
Il lamarckismo, ad esempio, è uno di tali aspetti.
Ma tornando a Lukács, la sua tripartizione ontologica, che a prima vista appare appesantita dalla distinzione sostanzialistica tra organico e inorganico, è poi mossa dal dinamismo di una forza più terrena e, direi, darwiniana, ma direi ancora meglio piagettiana. Mi riferisco al lavoro inteso come struttura finalistica:
Il lavoro è un porre consapevole, quindi presuppone una conoscenza concreta, anche se mai perfetta, di fini e mezzi determinati (Lukács, 1969, p. 29)
Il lavoro è fatto di posizioni teleologiche le quali ogni volta mettono in funzione delle serie causali. […] Contrariamente alla causalità, che rappresenta la
legge spontanea in cui tutti i movimenti di tutte le forme dell’essere trovano la
loro espressione generale, la teleologia è un modo di porre — posizione sempre
compiuta da una conoscenza — il quale, pur guidandole in determinate direzioni, può mettere in movimento soltanto serie causali (Lukács, 1969, p. 27).
Questi passi ricorrono in contesti in cui, Lukács sembra un nuovo
George Sorel, interessato com’è a rimuovere le incrostazioni fatali-
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
81
stiche e dogmatiche che si erano attaccate al marxismo. Ma possiamo tralasciare questi aspetti contingenti di lotta ideologica, e concentrarci su quelli di interesse permanente del suo discorso.
Intanto, Lukács parla di «forme dell’essere». Dunque, come in
Peirce, c’è la preoccupazione di dare una ontologia generale. Come
in Peirce, anche la pietra fa parte dell’essere.
Poi, c’è chiara e netta la distinzione tra processi teleomatici, rappresentati dalla causalità quale legge spontanea dell’essere stesso, e
processi teleonomici, rappresentati da un soggetto che pone. Che pone dei fini alla sua attività.
Ancora, il lavoro è la sorgente stessa della teleonomia. Esso è, al
tempo stesso, porre consapevole di fini e mezzi determinati, e conoscenza concreta anche se mai perfetta. Il lavoro, dunque, sia staticamente (conoscenza) che dinamicamente (porre), è una struttura cognitiva a parte intera. Non mi pare esagerato dire che, in quanto tale,
il lavoro di Lukács altro non è che l’intelligenza di Piaget e il segno
di Peirce finalisticamente inteso. Ma mentre Peirce e Piaget indagano la mente–segno lasciando ai margini la concretezza del mondo
sociale, salvo più o meno sapienti recuperi, e sui recuperi di Piaget
tornerò brevemente un po’ più in là, Lukács invece parte proprio dal
mondo sociale, per vedere come l’azione intelligente dell’uomo, cioè
il suo lavoro, lo modella. L’intelligenza, dunque, nella sua concretezza sociale e, aggiungerei, in forza di quanto abbiamo visto prima,
nella sua pesantezza deontica. L’intelligenza come lavoro.
Ma ancora altre due notazioni si impongono circa questa ontologia sociale di Lukács. La prima. Tanto Piaget, tentato a volte da un
certo finalismo normativo, quanto Peirce, nettamente schierato per
un irenismo lamarckiano come meta finale dell’evoluzione, hanno un
rapporto conflittuale, anche se mai di rifiuto, con il darwinismo. Invece, la concezione generale dell’evoluzione sociale cui Lukács perviene è direi perfettamente darwiniana, nel senso in cui la precisa
Mayr.
Per Mayr, la controversia se l’evoluzione dai batteri all’uomo sia
un progresso non può riguardare la biologia. La biologia, infatti, non
ha nulla da dire circa una teleologia cosmica. La selezione naturale,
infatti, non è un processo teleologico, ma un processo casuale di ottimizzazione che noi constatiamo a posteriori.
82
Capitolo IV
Ora, ciò che Mayr afferma a proposito del mondo naturale, Lukács lo afferma a proposito del mondo bio–sociale umano. Con le loro infinite posizioni teleologiche, i soggetti mettono in moto infinite
serie causali di cui hanno una coscienza assai limitata, a volte addirittura una non–coscienza, per così dire, che li spinge ad agire contro
i loro convincimenti. Lo stadio a cui si trova pervenuto l’uomo (homo sapiens sapiens) è il prodotto di tali serie causali. Tale processo,
però, non ha uno scopo (Lukács, 1969, p. 36), non è finious, non è
teleologico. Esso, se vogliamo stare ad una preoccupazione espressa
da Piaget a proposito dell’evoluzione darwiniana, è soggetto a sprechi, e avanza per contraddizioni immanenti al complesso stesso delle
serie causali innescate dalle posizioni teleologiche dei soggetti (Lukács, 1969, pp. 32 e 36). Il mondo descrittoci da Lukács è quello di
un soggetto che deve porre dei fini se vuole sopravvivere, ma senza
mai essere in grado di vedere tutte le condizioni e le conseguenze
della propria attività (Lukács, 1969, p. 28).
Tornerò fra un attimo su questo aspetto. Intanto, vorrei osservare
che molto semplicemente, ma in modo anche molto austero, per questo soggetto adattarsi ad un mondo è decidere tra alternative in condizioni di incertezza. C’è qualcosa del velo di ignoranza di Rawls,
ma mentre in quest’ultimo l’incertezza, volontariamente ricercata,
mira a salvaguardare la possibilità di costruire l’ordinamento sociale
giusto, secondo un ideale a priori di razionalità che, come sappiamo,
incorpora un modello semplificato di apprendimento morale in cui è
stato riscontrato un orientamento autoritario, per Lukács l’incertezza
è la condizione esistenziale del soggetto che, senza indulgere al senso di angoscia mortale che tale innata restrizione conoscitiva comporta, si slancia nella attiva costruzione di una forma di vita adattata.
Resta, certo, il problema di definire normativamente la razionalità
che deriva da tale slancio adattivo. Come vedremo più sotto, nel suo
tentativo di derivare l’implicazione logica del dovere dalla causalità
biologica del lavoro, Lukács non è del tutto persuasivo, mentre più
aderente alla sua concezione attiva del soggetto appare la rivendicazione della razionalità dell’utopia, intesa come prodotto, a sua volta,
possibile ma non necessario, delle energie umane sprigionate dallo
sviluppo stesso (Lukács, 1969, p. 38). Un’apertura che, in un immanentismo ai limiti, se si vuole, della claustrofobia, proviene ancora
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
83
una volta, non da un ideale a priori, né tanto meno da un qualche dio
che ci salvi, ma dall’attività stessa del soggetto.
2.1.
Digressione sull’ideologia in Lukács
Spezzando un po’ il filo del discorso, vorrei fare a questo punto,
una diversione su un aspetto, come dire, molto classico del pensiero
di Lukács, ma che, a distanza ravvicinata, si rivela, almeno a mio parere, sorprendentemente fresco e attuale. Mi riferisco alla sua teoria
dell’ideologia che deriva dalla sua ontologia, analogamente a quanto
accade in Peirce per la teoria del segno fondata anche lì su una ontologia.
Da un marxista come Lukács, ci aspetteremo una riproposizione,
per quanto smaliziata e personale, di una teoria dell’ideologia come
“falsa coscienza” della realtà. Ma Lukács respinge dichiaratamente
una tale prospettiva (Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale,
p. 6 e p. 74, nota 29), e pur mimando il solito costume delle glosse a
Marx, abbozza una teoria dell’ideologia per nulla dogmatica, i cui
capisaldi sono i seguenti:
1) non esisterebbe ideologia se l’uomo non fosse quella macchina
finalistica teleologica in gradi di porsi delle alternative: fare o non
fare qualcosa. L’ideologia è, dunque, legata a quella condizione
post–istintuale che chiamiamo libertà umana;
2) funzione dell’ideologia è, infatti, quella di raccordare le molteplici, infinite decisioni dei singoli componenti di una totalità sociale,
e di chiarire loro la necessità di tenere conto, nelle loro decisioni,
degli interessi della collettività. Una funzione, dunque, normativo–persuasiva di tipo adattivo, analogamente a quanto si può rinvenire in un Vilfredo Pareto (1848–1923) (Aqueci, 1991, p. 158), autore che Lukács conosce e con cui si confronta, e di cui ci occuperemo
più estesamente nel capitolo quinto;
3) quale meccanismo di pensiero, l’ideologia funziona per proiezioni analogiche di proprie esperienze ontologiche sull’essere in generale. Di qui le entificazioni, le personificazioni, le generalizzazioni
“abusive”. Le interpretazioni sorte intorno all’esperienza del lavoro
sono un esempio tipico di tali proiezioni: «Tutti gli dei delle religioni
84
Capitolo IV
naturali hanno delle “funzioni lavorative” a fondamento della loro esistenza» (Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale, p. 14);
4) assieme al lavoro, il linguaggio — che ontologicamente viene
in essere simultaneamente al lavoro (ibidem) — è la parte più importante della vita visibile, percepibile dell’uomo, soprattutto nelle
fasi primordiali del vivere in società. Il linguaggio, pertanto, fornisce
un ausilio essenziale alla edificazione delle ideologie, per esempio
attraverso l’attività di dare e di dire i nomi delle cose. Nella sua ottica filogenetica, Lukács rileva quest’attività soprattutto nelle prime
fasi della socialità umana ma, come già osservava lo stesso Pareto, il
carattere linguistico dell’ideologia (o «derivazioni») è proprio anche
di livelli ulteriori, come si può osservare nella lotta politica, dove
spesso gli affrontamenti avvengono attorno a nomi da dare, o formule verbali da interpretare;
5) l’ideologia, nella misura in cui “deforma” la realtà, viene riadeguata alla prassi sociale tramite altri processi ideologici che rischiarano e ripuliscono l’essere sociale stesso (Prolegomeni
all’ontologia dell’essere sociale, p. 15). Così come non si esce mai
dalla semiosi, altrettanto non si esce mai dall’ideologia;
6) i meccanismi di pensiero “proiettivi” e i “giochi linguistici”
magico–religiosi sono solo strumenti di una più generale cognitività
— diremmo oggi, di una mente — che nasce limitata: nel suo agire,
infatti, l’uomo non ha mai presente tutte le circostanze e le conseguenze che derivano dalle sue decisioni (Prolegomeni all’ontologia
dell’essere sociale, p. 15). Il “velo di ignoranza” è, dunque, in Lukács, oltre che una caratteristica ontologico–normativa, anche una
proprietà della mente, e in ciò richiama il carattere non logico, ovvero inconscio ma spontaneamente adeguato al fine, dell’agire sociale
visto sempre da Pareto.
Come si vede, e come avevo annunciato, si tratta di una teoria
dell’ideologia ben lontana dal semplicismo dell’ideologia come “falsa coscienza”. Al contrario, come si potrebbe mostrare con una opportuna rilettura della grande Estetica, cosa che mi riprometto di fare
in altra sede, si tratta di una rinnovata e originale orchestrazione di
molteplici motivi della tradizione empiristica, volta ad evidenziare
una struttura infralinguistica all’opera nel comportamento quotidiano, e che collega dialetticamente lo schematismo primario, che
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
85
l’uomo condivide con gli altri animali, con il pensiero discorsivo (Estetica, II, pp. 815 sgg.). Insomma, una teoria dell’ideologia che è, in
effetti, parte di una più generale teoria della mente come cognitività
limitata, una concezione oggi all’ordine del giorno in scienza cognitiva, ma che Lukács propose in tempi insospettati, integrandovi
l’ineliminabile dimensione della genesi storico–sociale (Tertulian,
2003; 2004), e l’esigenza di una morale della lotta contro la tendenza
sociale dominante, cioè la «manipolazione» che distoglie l’essere sociale dal suo centro.
2.2.
Ripresa: le radici ontologiche del dover essere
Torniamo al filo del nostro discorso. Dicevamo, due notazioni
circa l’ontologia sociale di Lukács. La prima ci ha messo di fronte
alla austera libertà dell’essere sociale di Lukács, con la necessità che
lo caratterizza di gettare uno sguardo, per quanto è possibile penetrante oltre il luogo chiuso della sua condizione bio–sociale.
La seconda, ad essa in qualche modo legata, concerne il livello
simbolico e normativo delle strutture finalistiche. Come ricorda lo
stesso Lukács, il lavoro è il modello cui la mente primordiale si rifà
per concepire la creazione divina della realtà (1969, p. 29). Dunque,
oltre il finalismo delle strutture, permane sempre lo spazio soggettivo del simbolico, del mitologico, dell’ideologico, nei cui confronti,
in determinati periodi storici, il lavoro–intelligenza addirittura appare come un’energia al loro servizio. Basti pensare all’utilizzazione
del valore d’uso del lavoro per la costruzione di un simbolo quali le
piramidi egiziane. A questo proposito, però, Marx ha mostrato che,
con l’avvento del capitale, lo scopo ultimo del lavoro trasformato in
capitale sociale è «l’universale ricchezza di forma e di contenuto
della produzione» (Grundrisse, II, p. 793). Ci troviamo qui in uno
dei luoghi d’elezione dove è nata l’idea secondo la quale il nesso di
scienza, tecnica e lavoro rappresentato dal capitale avrebbe inglobato
il simbolico, e che ormai l’unico scopo sopravvissuto sia quello
dell’accrescimento infinito della produzione. E una prova di ciò sarebbe lo stadio attuale dello sviluppo del capitale che, in funzione di
quell’unico scopo, colonizzerebbe con le marche (brands), ovvero
con simboli–parassiti, gli spazi connotativi dell’esistenza.
86
Capitolo IV
Di qui, allora, la domanda: con il capitale, le strutture finalistiche,
trasformate esse stesse in scopo ultimo, sono arrivate alla fase terminale in cui fagociteranno l’uomo e i suoi bisogni, ivi compresi quelli
simbolici? Contro quella che appare l’incontrollabile potenza delle
strutture finalistiche, è possibile trovare in Lukács una risposta che
concerne il livello normativo della società. Ogni società, nota Lukács
in un modo che si presta agevolmente a essere tradotto nei termini
sociogenetici di Piaget (1977, p. 49), si sviluppa oltre il grado puramente causale, per pervenire al livello implicativo dell’indurre, dello
spingere, del costringere, oppure del trattenere gli uomini da determinate decisioni teleologiche (Lukács, 1969, p. 32). Al di là della
sfera della produzione, che sembra esaurire l’Umwelt dell’uomo
contemporaneo, ecco apparire lo spazio del discorso normativo, con
la sua tipica funzione persuasiva, di cui Lukács ha cura di citare i
singoli atti linguistici. Discorso normativo che, potremmo dire con
Peirce (2003, pp. 1101 sgg.), sta in una posizione ontologica, non di
estraneità o di opposizione, ma piuttosto di «continuità» con il lavoro. Il contenuto del dover essere, afferma infatti Lukács,
è un comportamento dell’uomo determinato da fini sociali (e non da inclinazioni semplicemente naturali o spontaneamente umane). Ora, essenziale al
lavoro è che in esso ogni movimento e gli uomini che lo compiono devono essere diretti da fini determinati in precedenza. Quindi ogni movimento è soggetto a un dover essere. Anche qui non abbiamo nulla di nuovo, fra gli elementi
ontologicamente importanti, quando questa struttura dinamica si trasferisce in
campi d’azione puramente spirituali. Al contrario, gli anelli di congiunzione
ontologica, che dal comportamento iniziale conducono ai successivi comportamenti più spirituali, appaiono in tutta chiarezza, di contro ai metodi gnoseologici–logici con i quali il cammino che dalle forme più elevate porta a quelle
iniziali risulta invisibile, dove anzi le seconde dal punto di vista delle prime
appaiono addirittura come opposizioni (1969, p. 28).
Dunque, continuità ontologica in grado di esibire la genesi delle
proposizioni normative. Non si può non sottolineare, tuttavia, che,
almeno in questo testo, l’esigenza di esibire la genesi resta semplicemente affermata da parte di Lukács, che incorre in un arresto deterministico. Egli, infatti, dapprima si limita a riproporre (e non è
poco) la definizione kantiana di dover essere, quale comportamento
determinato da «fini sociali», cioè da norme, che non coincidano con
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
87
inclinazioni semplicemente naturali o spontaneamente umane. Successivamente, demanda la necessità di tale principio al fatto che ogni
movimento del lavoro degli uomini deve essere diretto da fini determinati in precedenza. Il dover essere sarebbe dunque un segmento
del filamento teleologico del lavoro, di modo che una volta che una
posizione teleologica è posta, il dover essere successivamente si installa. Non si può non ammirare l’immaginazione biologica che sta
dietro questa spiegazione della libertà umana, la quale, come un filamento di DNA che si srotola, deriverebbe dagli stessi materiali
della causalità. A mio parere, tuttavia, l’analogia biologica con cui
questa spiegazione si lascia interpretare, sacrifica l’autonomia del
soggetto che si trova ancora una volta determinato da un meccanismo che lo sovrasta, e comprime livelli che, pur nell’ipotesi suggestiva della continuità ontologica, vanno salvaguardati nella loro specificità etica, un problema che si pone, del resto, anche per quegli indirizzi di ricerca che oggi vanno sotto il nome di neuroetica (Gazzaniga, 2005), verso il cui riduzionismo, dai rilevanti risvolti pratici, si
levano voci critiche dentro le stesse neuroscienze (Rose, 2005). Da
questo punto di vista, va valutata la condizione che i «fini sociali»
siano il risultato di un contrasto di discorsi al quale l’individuo partecipa liberamente. E nel passaggio dalla causalità organica
all’implicazione normativa va valorizzata l’ipotesi della struttura evolutiva del rispetto, in modo che il dover essere kantiano, preziosamente riaffermato da Lukács, non sia il portato di un meccanismo
evolutivo “cieco”, ma l’esito di una costruzione dove intervengono
effettivamente e progressivamente le libere determinazioni del soggetto in interazione con gli altri soggetti.
3. PER L’UNITÀ DEL PENSIERO CRITICO: POPPER, PIAGET,
LUKÁCS
Tra la fine degli anni venti e i primi anni trenta del secolo scorso,
in rapidi saggi psicogenetici e sociogenetici culminati nel Giudizio
morale nel fanciullo, e la maggior parte dei quali raccolti poi in volume solo nei tardi anni settanta, Piaget propone un modello evolutivo, di cui abbiamo trattato nel capitolo terzo, che spiega il passaggio
dalle forme di socialità costrittive, dominate dal pensiero sociocen-
88
Capitolo IV
trico, alle forme di socialità cooperatorie, in cui il pensiero decentrato fonda e si alimenta della nuova libertà dell’argomentazione
(Piaget, 1932; 1977).
Nel 1932, giusto l’anno di pubblicazione del Giudizio morale nel
fanciullo, Henri Bergson (1859–1941), già anziano e troppo prestigioso per poter prendere in considerazione il punto di vista del valente ma ancor giovane e periferico Piaget, riformula il problema,
proponendo una spiegazione alternativa di tale passaggio. Secondo
Bergson, la società prodotta dalla natura è una società chiusa, retta
cioè dall’istinto e dall’abitudine (“si fa così, perché si fa così”).
L’esperienza mistica, di ordine emozionale, e che è propria dei santi
e degli eroi, conduce alla società aperta. Lo slancio emozionale verso
la società aperta è sorretto e provocato dalla facoltà “fabulatrice”,
cioè dall’atto che fa sorgere le rappresentazioni fantasmatiche che si
concretizzano nei miti, nei drammi, nei romanzi, nelle produzioni
artistiche (Bergson, 1932, p. 111).
Qualche anno più tardi, ormai in piena guerra mondiale, Karl R.
Popper (1902–1994), indipendentemente dalla precedente elaborazione di Piaget, riprende la terminologia della dicotomia di Bergson
e, riformulandola teoricamente in termini che si ritrovano già in nuce
in Piaget, ne fa un modello di spiegazione, al tempo stesso teorico e
politico, della genesi della civiltà occidentale. Secondo Popper, il
totalitarismo contro cui le nazioni libere in quel momento si battevano, è la risposta ricorrente allo stress della rottura del legame naturale su cui riposa la società tribale o chiusa (Popper, 1943, I, p. 248;
II, p. 82). Da quella rottura, operatasi per la prima volta nella civiltà
greca, e di cui è emblema quella prima e paradigmatica forma di accordo di discordia che è il dialogo socratico, è derivata la società aperta, fondata sulla discussione come sincero desiderio di comprendere il discorso proposto dall’interlocutore (Popper, 1969, pp.
597–598).
Con questa difesa della funzione argomentativa del linguaggio
(Popper, 1969, pp. 231–232) che sarebbe piaciuta non solo a Piaget,
ma anche a Guido Calogero, Popper si oppone tanto al pragmatismo
irrazionalista di un Bergson, quanto al pragmatismo a sfondo biologico di Uexküll, padre e figlio, con il loro Umwelt quale estensione
della biologicità umana (Popper, 1969, pp. 642–649). Queste forme
Strutture finalistiche e libertà dell’individuo
89
di pragmatismo, infatti, assai distanti da quelle di un Peirce o di un
Vailati, identificando la conoscenza con l’azione, dissolvono
l’oggetto e la possibilità da parte del soggetto di condurvi sopra un
discorso conoscitivo critico — una posizione, anche questa, che Piaget, impegnato a spiegare geneticamente la costruzione dell’oggetto,
avrebbe senz’altro apprezzato.
Questa teoria critica della conoscenza, che nella versione razionalista di Popper si nutre di fede nella ragione (Popper, 1943, II, pp.
303–304), e nella versione genetica di Piaget di fiducia nelle autoregolazioni della scienza (Piaget, 1928, pp. 38–39), credo che, raffreddatesi ormai le linee di scontro politico che, nel secolo scorso, hanno
minato l’unità interna del pensiero critico, si sposi bene, a dispetto
della sua fama di costruzione dogmatica, con l’ontologia sociale di
György Lukács, di cui prima ho presentato e discusso qualche tratto.
Capitolo quinto
Mente collettiva e naturalità del segno
Giunti a questo punto, vorrei riprendere due figure il cui pensiero
è essenziale per precisare ed approfondire il campo di studi semioetici. Si tratta di Vilfredo Pareto e soprattutto di Ferdinand de Saussure. Il primo è già apparso, ma fugacemente, mentre del secondo ci
siamo più ampiamente occupati nel terzo capitolo. Entrambi svilupparono la loro indagine, sociologica il primo, linguistica il secondo,
nella stessa epoca, l’ambiente svizzero romando tra fine XIX e inizio
del XX secolo, di cui già conosciamo figure come Pierre Bovet e soprattutto Jean Piaget, e che, con una modernizzazione non tanto abusiva, potremmo definire come uno dei maggiori centri degli studi cognitivi dell’epoca. Sia Pareto che Saussure, infatti, ciascuno nel proprio ambito disciplinare, e in modo reciprocamente autonomo, indagarono intorno agli stessi oggetti, dalla mente, dell’individuo sociale
Pareto, del parlante Saussure, al sistema, l’equilibrio sociale Pareto,
il sistema linguistico o langue Saussure. E i risultati cui giunsero sono, come vedremo, facilmente integrabili in un’unica prospettiva
che, sebbene non esplicitata da nessuno dei due, oggi può contribuire
a rendere più perspicue le loro analisi, soprattutto per quanto riguarda Saussure. La sua semiologia, infatti, sembra essere entrata in un
cono d’ombra, e addirittura a volte, come vedremo, va incontro a dei
rifiuti. Oblio e incomprensione che, per quanto è possibile, vanno
91
92
Capitolo V
rimossi, se non si vuole disperdere la ricchezza di suggestioni che il
suo pensiero contiene per numerosi ambiti contemporanei di ricerca,
dalle odierne indagini, abbondanti ma non sempre interessanti, intorno alla mente, ai problemi concernenti la genesi dell’ordine sociale e
le sue trasformazioni.
1. INTERROGAZIONI SAUSSURIANE
Incomincerò, dunque, ricollegandomi alla tesi storiografica ormai
classica, secondo la quale la teoria linguistica di Saussure è il portato
di un movimento plurisecolare che affonda le sue radici
nell’Umanesimo e nel Rinascimento, quando al verbalismo e al logicismo derivanti dalla concezione linguistica della scienza di Aristotele, si vengono a sostituire il metodo sperimentale e le classificazioni fondate su criteri non più verbalistici ma oggettivi (De Mauro,
1965, pp. 51–52).
La conseguenza in campo linguistico di questa rivoluzione di
pensiero è che, mentre in Aristotele la lingua era solo la porta che
dava accesso alla mente e alla realtà, in Saussure la lingua diventa
oggetto di scienza in sé (De Mauro, 1965, p. 50).
Questa costituzione della linguistica in campo autonomo di indagine scientifica produce però un paradosso che forse non è stato sufficientemente notato.
Come si è a ragione sostenuto, la corrispondenza in Aristotele tra
lingua, mente e realtà, era la garanzia della stabilità dei significati, su
cui, contro lo scetticismo logico e morale, potevano fondarsi una
scienza, un’etica, una società ordinate e razionali (De Mauro, 1965,
p. 48).
Differentemente, la rivoluzione scientifica dell’epoca umanistico–rinascimentale, che si prolunga nell’Illuminismo, potrà fare a
meno di questa garanzia fornita dal linguaggio, poiché adesso è la
scienza con i suoi propri metodi a proporsi come criterio della stabilità del reale.
Dunque, nel momento stesso in cui il linguaggio diventa oggetto
di scienza, perde quel posto privilegiato di pietra angolare del sapere
Mente collettiva e naturalità del segno
93
e del vivere civile. Non sarà più esso, bensì la scienza, a fornire i
criteri di verità su cui edificare il sapere, la morale e l’ordine sociale.
Non bisogna nascondersi che questo decentramento rispetto al
linguaggio, operato dal pensiero logico–sperimentale moderno, non
sempre è stato vissuto come una liberazione. Al contrario, a volte è
stato visto come una minaccia, soprattutto quando sembrava mettere
in discussione il valore referenziale di un genere di discorso eticamente e politicamente “sensibile” come il discorso storico.
Ad esempio, di una paura simile si fa portavoce Paul Ricoeur,
quando imputa a Roland Barthes di estendere indebitamente il modello saussuriano dalla linguistica alla semiotica, allo scopo di denunciare il carattere “ideologico” del discorso storico che, secondo
Barthes, deriverebbe dal fatto che lo storico, sfruttando la funzione
referenziale del linguaggio, proporrebbe come verità ciò che è soltanto una sua propria costruzione di senso.
A questa imputazione di indebita estensione, che potrebbe anche
essere condivisa, Ricoeur fa però seguire la denuncia della minaccia
implicita che il «modello saussuriano» conterrebbe contro la referenzialità, ovvero il valore conoscitivo del discorso storico (Ricoeur,
2000, pp. 353–357). Una denuncia, poi, che in posizioni meno avvertite e sofisticate diventa addirittura il rifiuto del «dogma saussuriano» (Caserta, 2005, p. 13).
E, allora, prima che la reazione di Ricoeur diventi senso comune,
con le sue appendici di processi e condanne, conviene interrogarsi su
una proposta teorica come quella saussuriana che evidentemente il
mutare dei tempi non rende più trasparente nelle sue interne articolazioni.
Senza mirare alla difesa di un’ortodossia, per altro inesistente, bisogna chiedersi allora se la contrapposizione tra il referenzialismo aristotelico e l’arbitrarismo assoluto di Saussure sia veramente così
netta e inequivocabile; e, seconda questione, quale genere di socialità
chiama in causa la fondazione sociale del fatto linguistico che, secondo l’ormai classica tesi storiografica richiamata, il suo arbitrarismo assoluto assicurerebbe (De Mauro, 1965, p. 176).
94
Capitolo V
2. DAL LINGUAGGIO ALLA COGNIZIONE
Per venire al primo quesito, se cioè la contrapposizione tra il referenzialismo aristotelico e l’arbitrarismo assoluto di Saussure esista, e
sia così netta e inequivocabile, ciò che si può cominciare a dire è
che, se si resta in ambito strettamente linguistico, tale contrapposizione sicuramente c’è.
Per Aristotele, infatti, almeno ad una prima lettura del famoso
passo iniziale del Peri hermenias (De interpretatione, in latino,
Dell’espressione, in italiano), il segno sta per qualcosa, e precisamente sta per l’oggetto esterno di cui le affezioni dell’anima sono
un’immagine interna (Dell’espressione, 1, 16a, 5–10). Dunque, segni
da un lato, e oggetti e entità mentali dall’altro. Non c’è bisogno di richiamare gli schemi saussuriani, per ricordarsi che per Saussure il
rapporto non è tra una collezione di oggetti e una collezione di nomi,
ma tra segni all’interno di uno stesso sistema (CLG, p. 410).
Ma questa lettura è adeguata? E, si badi bene, è adeguata tanto per
Saussure, quanto per Aristotele? Perché, se si va oltre la considerazione linguistica, e oltre la canonica ripetizione del principio nomenclaturista aristotelico e di quello sistemico saussuriano, si vede come
la contrapposizione sfuma e cambia di oggetto tanto per l’uno,
quanto per l’altro.
Aristotele, infatti, liberato dal ruolo di rappresentante di un arcaico passato epistemologico–linguistico, non appare più solo come il
padre del tradizionale e secolare referenzialismo. Perché, certamente,
il segno sta per, ma sta per, prima ancora che per gli oggetti, per le
affezioni dell’anima.
Non che Aristotele non sia interessato a quel nesso di segno, immagine interna e realtà, garanzia di stabilità logica, etica e politica.
Ma il fatto è che egli ricerca quel fondamento non tanto nel linguaggio, quanto nella mente. Il fulcro della sua argomentazione, infatti,
non sta tanto nel rapporto linguistico tra segno e realtà, ma nel fatto
che i segni rinviano alle affezioni dell’anima, cioè a delle strutture
della mente che, egli afferma, «sono le medesime per tutti»
(Dell’espressione, 1, 16a, 5–10).
Aristotele è insomma interessato alla cognizione e al modo in cui
essa si rapporta all’ambiente. Ed egli pensa che è possibile fare
Mente collettiva e naturalità del segno
95
scienza della cognizione, quindi logica, etica e politica, perché c’è una certa omogeneità del campo di indagine («sono uguali per tutti»).
Che l’impianto, poi, del suo cognitivismo resti germinalmente osservativo, poco sperimentale, verbalistico e speculativo, è un limite
contingente del quale, per altro, noi stessi, che pure abbiamo a disposizione la risonanza magnetica funzionale e la tomografia ad emissione di positroni, siamo ben lungi dall’aver superato.
Se tutto ciò è plausibile, la questione centrale diventa allora quella
di vedere come Saussure si pone non tanto nei confronti del referenzialismo, ma del cognitivismo aristotelico. In altri termini, esiste
un’interrogazione saussuriana sulla mente? Se esiste, essa è un prodotto spurio e marginale della sua proposta teorica, oppure ne costituisce il fulcro centrale? In che cosa si differenzia, in che cosa innova e in che cosa riconduce all’indagine aristotelica sulla cognizione?
Per non complicare troppo il discorso, in questa sede cercherò di
rispondere soprattutto alle prime due domande, lasciando sullo sfondo la terza. E, per cominciare, riepilogo per sommi capi la posizione
di Saussure circa la disciplina deputata allo studio del segno, cioè la
semiologia.
3. LA MENTE IN SAUSSURE
Sappiamo bene che nel definire lo statuto della semiologia, Saussure ne rivendica l’autonomia rispetto alla psicologia, ponendo tuttavia quest’ultima come quadro di riferimento della semiologia (CLG,
p. 26). Compito autonomo della semiologia sarà allora di determinare la struttura di quel «sistema speciale che è la lingua» fra gli altri
sistemi semiologici (CLG, p. 26–27).
Per inciso, osserviamo che, che nella temperie culturale comune
sopra richiamata della Svizzera romanda di fine XIX e di inizio del
XX secolo, un’operazione metodologica analoga compie Pareto con
la sua «sociologia scientifica», la quale sta in un rapporto di inclusione ma di autonomia rispetto alla psicologia. L’omologia non finisce qui. Le operazioni di base della mente sociale indagata da Pareto
sono il combinare e l’associare (Aqueci, 1991, pp. 41 sgg.). Vedre-
96
Capitolo V
mo che qualcosa di analogo c’è nell’indagine di Saussure intorno
alla mente del parlante.
Richiamiamo ora sinteticamente i principi dello strutturalismo
linguistico di Saussure, facendo attenzione a cogliere la loro valenza
cognitiva rimasta sinora assai in ombra.
3.1.
Una distanza apparente
Come sappiamo, Saussure parte dal rifiuto del nomenclaturismo,
a favore del carattere relazionale della lingua e, egli dice, dello
«esprit humain» (CLG Payot, p. 440). Senza forzare il suo testo, oggi
diremmo a favore del carattere relazionale della «mente umana».
Al rifiuto del nomenclaturismo, che avviene dunque su un terreno
cognitivo, Saussure fa seguire l’affermazione di una concezione
della lingua come totalità di valori linguistici, laddove il valore è
dato dalla presenza simultanea di tutti gli elementi e dalla loro differenza (CLG, pp. 138–143). La lingua funziona sia perché c’è un
concetto che si scambia con la sua immagine acustica, ovvero perché
un’immagine acustica sta per un concetto, sia perché ciascun segno è
in rapporto con gli altri segni (CLG, pp. 139–141). Se la lingua fosse
una nomenclatura del pensiero, da una lingua all’altra si avrebbero
delle parole esattamente corrispondenti per ciascun concetto o senso.
Ma così non è (CLG, pp. 141).
Quindi, se non si vuole cadere in una concezione sostanzialista
della lingua, lo stare per va visto sempre all’interno dei rapporti che
ciascun segno intrattiene con tutti gli altri. Non c’è una sostanza
della cosa che il segno attualizza con il suo stare per, ma c’è una
forma che deriva dal suo stare per in rapporto con tutti gli altri segni,
e tramite la quale si effettua la significazione.
Qui la distanza dal referenzialismo che attribuiamo ad Aristotele
sembra massima. Aristotele, servendosi del linguaggio, va a vedere
com’è fatto l’oggetto nella sua pesantezza ontologica, e stila la lista
delle categorie quali determinazioni dell’essere. Al contrario, Saussure, liberandosi di ogni metafisica e di ogni ontologia, si concentra
esclusivamente sul segno, e sui rapporti che essi hanno all’interno
della lingua, e sembra quasi suggerire che ogni lingua corrisponda ad
una concezione del mondo.
Mente collettiva e naturalità del segno
97
Ma si tratta di una distanza effettiva? Anzitutto, come ha mostrato
ad abundantiam la sterilità della cosiddetta ipotesi Sapir–Whorf, dal
nome di Edward Sapir (1884–1939) e Benjamin Whorf (1897–1941),
il linguista e l’antropologo americani che nel corso degli anni Trenta
del secolo scorso l’avanzarono, l’attribuzione ad ogni lingua di una
particolare concezione del mondo, più che una suggestione, è un miraggio. Un miraggio che Saussure non ha mai inseguito. Tenere
conto della variabilità linguistica, infatti, come un linguista come
Saussure non poteva non fare, non deve per forza comportare di tagliare i ponti con il pensiero, ovvero con le strutture della mente che,
per dirla con Aristotele, sono uguali per tutti.
In secondo luogo, come abbiamo visto, Saussure non rifiuta la
concezione del segno come stare per, ma la desostanzializza, cioè la
scioglie all’interno dei rapporti tra i segni che formano la struttura
della lingua. In altri termini, per Saussure, noi significhiamo qualcosa non indicandola per così dire con un’etichetta, bensì tramite i valori della lingua. E quest’atto di denotazione si realizza nell’atto di
parole, che è opera del soggetto parlante. Quest’autonomia della lingua e del locutore sembrerebbe ancora una volta proiettare Saussure
verso una posizione di idealismo linguistico. La nostra tesi, al contrario, è che l’abbandono di ogni preoccupazione metafisica e ontologica, lo predisponga verso una posizione naturalistica che, facendo
salva l’autonomia del segno, recupera al livello della mente il rapporto tra lingua e oggetto.
Il referenzialismo, dunque, non sembra essere la frattura principale tra Saussure e Aristotele, che va invece cercata altrove. A questo scopo, torniamo al tema dei rapporti tra i segni nella lingua. Che
genere di rapporti sono?
3.2.
Combinare e associare
Si tratta di rapporti sintagmatici, cioè combinazione nella linearità
del discorso dei vari elementi linguistici, e di rapporti associativi,
cioè “stockaggio” nella memoria, tramite associazione, degli elementi linguistici (CLG, pp. 149–153). Rapporti che, dice Saussure,
«corrispondono a due forme della nostra attività mentale, entrambe
indispensabili alla vita della lingua» (CLG, p. 149).
98
Capitolo V
La lingua vive perché la nostra mente è capace di queste due operazioni, l’operazione del combinare e l’operazione dell’associare.
Qui bisogna fare attenzione, perché non si tratta di due proprietà del
modello che il linguista sta costruendo a fini analitici, ma di due vere
e proprie attività della nostra mente. La lingua è il prodotto cognitivo
di queste due attività mentali.
Si pone già qui la questione se il combinare sia completamente libero. Vi ritorneremo alla fine. Ma intanto si può dire che la libertà
del combinare, per Saussure, è propria della parole, cioè del soggetto
parlante (CLG, p. 24), anche se di questa attività mentale è difficile
dire che cosa è della lingua e che cosa della parole (CLG, p. 151).
Questo perché il combinare deve sempre vincere la vischiosità
dell’associare (ibidem), il quale però concorre alla ricchezza espressiva (CLG, p. 152).
Notiamo, infine, quanto Saussure afferma a proposito dei rapporti
associativi. I gruppi di forme linguistiche creati per associazione
mentale non si limitano a raccostare i termini che presentano qualche
cosa di comune, poiché, sottolinea Saussure, «lo spirito percepisce
anche la natura dei rapporti che li collegano in ciascun caso e crea
con ciò tante serie associative quanti sono i diversi rapporti» (CLG,
p. 152).
Anche qui, l’«esprit» di questo passo (CLG Payot, p. 173) è inequivocabilmente «mente».
3.3. La lingua regno del caso
Dicevamo prima che l’atto di significazione si realizza nella parole, che è opera del soggetto parlante. La lingua (langue) è allora una forma sempre attualizzabile a disposizione del soggetto parlante.
E l’atto di parole, dal canto suo, è un’attualizzazione della forma
linguistica in funzione di un bisogno espressivo.
Quindi, da un lato, la libertà del soggetto parlante è massima, perché è lui che mette la langue in rapporto con il mondo; dall’altro, il
soggetto parlante può far questo solo in rapporto ad una forma che è
collettiva, cioè sociale. E, Saussure lo dice chiaramente (CLG, p.
200; p. 203), tutte le forme nuove che possono sorgere nell’atto di
Mente collettiva e naturalità del segno
99
parole, per diventare patrimonio collettivo devono passare dal filtro
della langue.
Ma, ecco il punto, «sociale» in Saussure non evoca per così dire
una festa della libertà dell’individuo. Benché infatti la significazione
sia affidata ai suoi atti di parole, esso appare completamente subordinato alla lingua. Questo è un punto centrale del discorso che stiamo conducendo lungo tutto questo libro, e va quindi ulteriormente
approfondito.
A proposito del segno, Saussure ne afferma il carattere arbitrario
sia dal lato del suo aspetto sensibile (immagine acustica o significante), sia dal lato del suo aspetto concettuale (concetto o significato). Per Saussure, la lingua è un taglio che il corpo sociale opera arbitrariamente nel continuum della sostanza fonica e della sostanza
concettuale, le quali, di per sé, prima di questo intervento, sono amorfe.
Notiamo, per inciso, che anche questa formulazione, nel contesto
del naturalismo di Saussure, di cui fra poco apprezzeremo la consistenza, non può dar adito a nessuna posizione di idealismo linguistico. L’arbitrarietà del taglio linguistico collettivo è limitata, infatti,
dai vincoli adattivi del sistema. Ma tornando al filo del discorso, il
taglio che la lingua opera, crea continuamente un sistema sincronico,
la “partita a scacchi” della lingua, che qui e là è continuamente modificata dal tempo e dall’uso, ma sempre ricomponendosi in uno
“stato”del sistema. Qui conviene avere sott’occhio tutto il passo di
Saussure:
In una partita a scacchi, una qualsiasi determinata posizione ha il singolare
carattere d’essere indipendente dalle precedenti; è totalmente indifferente che
vi si sia arrivati per una via oppure per un’altra; colui che ha seguito tutta la
partita non ha alcun vantaggio sul curioso che viene a considerare lo stato del
gioco nel momento critico; per descrivere questa posizione, è assolutamente inutile richiamare ciò che è avvenuta nei dieci secondi precedenti. Tutto questo
si applica ugualmente alla lingua e consacra la distinzione radicale di diacronia
e sincronia. La parole opera sempre e solo su uno stato di lingua, ed i mutamenti che vi intervengono tra gli stati non vi hanno alcun posto.
Vi è soltanto un punto in cui il paragone è difettoso: il giocatore di scacchi
ha l’intenzione di operare lo spostamento e di esercitare una azione sul sistema;
invece la lingua non premedita niente: i suoi pezzi si spostano, o piuttosto si
modificano, spontaneamente e fortuitamente: l’Umlaut di Hände per hanti, di
100
Capitolo V
Gäste per gasti ha prodotto una nuova forma verbale come trägt per tragit ecc.
Perché la partita di scacchi rassomigliasse in tutto e per tutto al gioco della lingua, bisognerebbe supporre un giocatore incosciente o stupido. D’altra parte
questa unica differenza rende la comparazione ancora più istruttiva, mostrando
la assoluta necessità di distinguere in linguistica i due ordini di fenomeni. Perché, se dei fatti diacronici sono irriducibili al sistema sincronico da essi condizionato, quando la volontà presiede a un mutamento di questo tipo, a più forte
ragione essi lo saranno quando oppongono una forza cieca all’organizzazione
di un sistema di segni (CLG, pp. 108–109).
Che cosa si trae da questo passo arcinoto? Si trae, come avevamo
intuito, che al centro non ci sono i singoli soggetti con i loro scambi
linguistici: «lo spostamento di un pezzo è un fatto assolutamente distinto dall’equilibrio precedente e dall’equilibrio seguente. Il cambiamento avvenuto non appartiene a nessuno di questi due stati: ora,
i soli stati sono importanti» (CLG, p. 108).
Al centro, invece, c’è lo stato di lingua, ovvero una totalità cognitiva che emerge dalle operazioni di combinazione e di associazione
dei singoli parlanti.
Ora, come abbiamo visto, Saussure, paragonando i passaggi di
stato della lingua con quelli della partita a scacchi, trova che l’unica
differenza sta nell’assoluta mancanza di intenzionalità dei primi rispetto ai secondi. In un certo senso, la lingua è come il «giocatore
incosciente o stupido» di una assurda partita a scacchi (CLG, p.
109). E questo, dice Saussure, perché «la lingua non premedita
niente» (ibidem).
Ecco, qui tocchiamo con mano il naturalismo di Saussure, il quale
sembra aver assimilato quello che, discutendo di Mayr, ci è apparso
come uno dei cardini dell’evoluzionismo darwiniano: così come
l’evoluzione, anche la lingua è naturalisticamente il regno del caso.
Se una cesura c’è con Aristotele, allora, è su questo piano che bisogna cercarla, cioè in un differente naturalismo che ha le sue conseguenze nella concezione tanto della lingua, quanto dell’etica e della
politica. Questa è una questione che affronteremo nel prossimo capitolo, soprattutto in Aristotele, ma di riflesso anche in Saussure, per
mostrare il suo ambiguo rapporto con il “sociale”, ovvero con il
contrattualismo etico–politico tipico della modernità. Una questione,
dal cui chiarimento, dipende anche il posto della semiotica
Mente collettiva e naturalità del segno
101
nell’ideologia contemporanea, sol che non la si voglia ridurre ad
un’agenzia di consulenze di marketing.
3.4.
La mente grammaticale collettiva
Se la lingua è il regno del caso, invece, come più volte detto, regno del singolo individuo è la parole. Ogni innovazione sorge ad opera di un individuo o di un gruppo di individui (CLG, p. 118). Ma
Saussure subito dopo aggiunge che l’innovazione del singolo individuo diventa fatto linguistico solo quando la collettività l’accoglie
(CLG, p. 119). Dunque, è solo la collettività che, con il suo consenso
implicito, spontaneo e necessario, trasforma una innovazione linguistica in un uso. Ancora una volta, in Saussure, l’individuo è la fonte
del cambiamento, ma solo se passa al vaglio della collettività. C’è in
lui un antagonismo mai risolto tra ragioni dell’individuo e ragioni
del sistema. Nella parole, il ruolo dell’individuo è massimo. Ma senza la langue, la parole è un fatto linguistico mai avvenuto.
La conseguenza di tutto ciò, allora, è che Saussure, più che fondare socialmente il fatto linguistico, finisce per costruire una teoria
naturalistica della mente grammaticale collettiva.
Abbiamo visto che i rapporti tra i segni che formano la struttura
della lingua sono rapporti sintagmatici (combinazione nella linearità
del discorso dei vari elementi linguistici), e rapporti associativi
(“stockaggio” nella memoria, tramite associazione, degli elementi
linguistici).
Ora, come abbiamo già detto, il combinare e l’associare non sono
proprietà del sistema linguistico elaborato dal grammatico per capire
come funziona la lingua. Al contrario, sono proprietà di una mente
che è la mente del singolo individuo. Ma abbiamo visto che questa
sorta di individualismo metodologico non regge, dal momento che i
singoli atti di parole prendono vita solo dentro il sistema. Dunque,
giunti a questo punto, possiamo affermare con certezza che il combinare e l’associare non sono proprietà del modello, ma sono operazioni di un sistema che, nella sua cogenza, è un fatto ben reale per chi
parla. Un sistema che è, appunto, quella langue o mente grammaticale collettiva di cui Saussure costruisce una teoria naturalistica.
102
Capitolo V
D’altra parte, le operazioni del combinare e dell’associare non sono le uniche che si possono rinvenire in tale teoria. Operazioni altrettanto importanti sono l’analisi, che individua le radici (CLG, p.
227) e «sente» l’alternanza delle forme linguistiche (CLG, p. 202), e
l’analogia fondata sulla capacità di imitare con regolarità un modello
(CLG, p. 195).
3.5.
Lingua e mente sociale
Dunque, combinare, associare, analizzare, imitare. Queste le
quattro operazioni fondamentali della mente grammaticale collettiva
che sembrano emergere dall’analisi di Saussure. Ma perché le operazioni del combinare e dell’associare hanno un rilievo speciale rispetto alle altre? Saussure afferma a ragione che «la lingua è un sistema che conosce soltanto l’ordine che gli è proprio» (CLG, p.
33).La storia naturale, sociale, politica di chi la parla, è esterna alla
lingua stessa, e la linguistica non deve occuparsene se non appunto
in quanto «linguistica esterna» (CLG, p. 31). Il rilievo speciale delle
operazioni del combinare e dell’associare, allora, deriva dal fatto che
esse sono quelle dove maggiormente sfuma il netto confine tra interno ed esterno del sistema linguistico. Per rendersene conto, basta
leggere con la dovuta attenzione quel passo purtroppo assai trascurato del Corso di linguistica generale, in cui Saussure parla della
forza di interscambio e dello spirito di campanile, e che qui di seguito ripropongo nella sua interezza:
La propagazione dei fatti di lingua è sottomessa alle stesse leggi di qualsiasi
altra abitudine, per esempio la moda. In ogni massa umana due forze agiscono
senza posa simultaneamente ed in senso contrario: da una parte lo spirito particolaristico, lo “spirito di campanile”: dall’altra, la forze di “interscambio” che
crea le comunicazioni tra gli uomini.
Per lo spirito di campanile una comunità linguistica ristretta resta fedele alle
tradizioni sviluppatesi nel suo seno. Queste abitudini sono le prime che ogni
individuo assimila nell’infanzia; di qui la loro forza e persistenza. Se agissero
sole, creerebbero in materia di linguaggio particolarità che andrebbero
all’infinito.
Ma i loro effetti sono corretti dalla forza opposta. Se lo spirito di campanile
rende gli uomini sedentari, l’interscambio li obbliga a comunicare tra loro. E
l’interscambio che conduce in un villaggio i passanti di altre località, che spo-
Mente collettiva e naturalità del segno
103
sta una parte della popolazione in occasione d’una festa o d’una fiera, che riunisce sotto le armi uomini di provincie diverse, ecc. in una parola, è un principio unificante, che contrasta l’azione dissolvente dello spirito di campanile.
È all’interscambio che si deve l’estensione e la coesione d’una lingua. Esso
agisce in due modi: a volte negativamente: previene il frazionamento dialettale
soffocando un’innovazione nel momento in cui sorge in un punto; a volte positivamente: favorisce l’unità accettando e propagandando tale innovazione. È
questo secondo tipo di interscambio che giustifica la parola onda per designare
i limiti geografici d’un fatto dialettale: la linea isoglossematica è come il bordo
estremo di un’inondazione che si espande,e che può anche rifluire (CLG, pp.
249–250).
Ho già richiamato più sopra l’analogia metodologica esistente tra
Saussure e Pareto circa il modo di concepire rispettivamente il rapporto tra semiologia e psicologia, e quello tra sociologia e psicologia, e ho anticipato il fatto che Pareto, nell’indagare la mente sociale,
vede nel combinare e nell’associare le due operazioni di base. Si può
ora qui aggiungere che, per Pareto, il combinare, o «istinto delle
combinazioni», genera tutto ciò che, per dirla con un vecchio ma
pregnante termine di Lukács, la prassi produce di nuovo (Aqueci,
1991, pp. 40–64); mentre l’associare è all’origine di «aggregati persistenti», ovvero di costrutti percettivo–simbolici, “sigillati” dai nomi, che formano il deposito della memoria collettiva (Aqueci, 1991,
pp. 64–77). Credo che, anche in ragione della sorprendente assonanza terminologica, il passo di Saussure citato serva a chiarire cosa intende Pareto con i suoi due istinti e, viceversa, la teorizzazione sociologica di Pareto serva ad attribuire al passo di Saussure il rilievo
che merita.
Combinare elementi linguistici sull’asse sintagmatico, infatti, è il
modo peculiarmente linguistico di produrre novità espressive, a partire da costrutti che persistono grazie all’operazione di associazione,
e che vengono rinnovati dalle combinazioni stesse. Come si vede dal
passo citato, queste due operazioni hanno la loro proiezione esterna
al sistema linguistico rispettivamente nella forza di interscambio e
nello spirito di campanile, che non sono altro che comportamenti
collettivi derivanti dalle due tendenze di fondo della mente sociale,
così come analizzata da Pareto. Combinazioni che innovano e aggregati che persistono, dunque, sia dentro il sistema linguistico, che
104
Capitolo V
all’esterno, secondo un movimento ad «onde» che non sembra essere
altro che un caso particolare e autonomo, ma quanto mai importante,
dei «cicli sociali» di Pareto, con le loro alternanze di «pensiero libero» e di «fideismo», di «speculatori» e di «redditieri» (Pareto, TSG,
IV, cap. XII). Di modo che, in un’ottica semiologica del tutto saussuriana, ma cognitivamente rinnovata, la lingua non sembra essere altro che una manifestazione fra le tante, anche se certo la più importante, della mente sociale, la quale appare perciò unitaria nella sua
costituzione cognitiva e retta dalle medesime leggi.
3.6.
Il grado zero della libertà del segno
Come ho mostrato altrove a proposito di Pareto, la socialità generata dalla mente sociale intenta a combinare e associare, analizzare e
imitare, è una socialità costrittiva e eteronoma (Aqueci, 1991, pp.
77–82; 107–112).La socialità cooperatoria degli individui autonomi
nasce da una rottura con quella prima forma di socialità, solo quando
dalla stessa evoluzione cognitiva della mente sociale emergono gli
«equilibri ideali», con la loro forza dissolvente dei precedenti equilibri statici (Aqueci, 1999; 2000). Questo nesso di problemi, che a
prima vista sembrerebbe non più riguardare la lingua, si ripresenta
invece in Saussure quando si consideri la sua sensibilità per gli aspetti diremmo “semioetici” delle questioni linguistiche, che recenti,
intelligenti letture stanno riportando alla luce (Gambarara, 2005).
Già a proposito del combinare abbiamo accennato alla questione
della libertà nella lingua. Possiamo riprendere ora questo aspetto ed
approfondirlo. Nella lezione del 19 maggio 1911 del terzo corso di
linguistica generale (1910–1911), Saussure anzitutto riconosce chiaramente il carattere intrinsecamente eteronomo del segno:
Par rapport à la société humaine qui est appelée à l’employer, le signe n’est
point libre mais imposé, sans que cette masse sociale soit consultée et comme
s’il ne pouvait pas être remplacé par un autre [Riguardo alla società umana che
è chiamata a usarlo, il segno non è affatto libero ma imposto, senza che questa
massa sociale sia consultata e come se esso non potesse essere sostituito da
nessun altro] (Saussure, 2005 [1911], p. 169).
Mente collettiva e naturalità del segno
105
Come si vede, un’asserzione che non lascia spazio ad una concezione della lingua come mediazione fra individui autonomi, e liberi
di disporne secondo le loro convenienze. Non è così che funziona il
segno, sembra dirci Saussure, poiché esso non è libero, nel senso che
i suoi utenti lo subiscono. Ma subito dopo Saussure ancora aggiunge:
La transmission des institutions humaines, voilà la question plus générale
dans laquelle nous voyons enveloppée la question posée au début: pourquoi la
langue n’est–elle pas libre? [La trasmissione delle istituzioni umane, ecco la
questione più generale nella quale noi vediamo avvolta la questione posta
all’inizio: perché la lingua non è libera?] (ibidem).
Nella successiva lezione del 30 maggio 1911, la risposta di Saussure a questa cruciale domanda consiste nel mettere in evidenza la
linea ininterrotta del tempo che innerva la lingua:
La langue n’est pas libre, parce que principe de continuité ou de solidarité
indefinie avec les âges précédents [La lingua non è libera, a causa del principio
di continuità e di solidarietà ininterrotta con le epoche precedenti] (Saussure,
2005 [1911], p. 172).
Con questa risposta tutta interna alla linguistica — il segno non è
libero a causa dell’eredità linguistica, cioè della pressione dello stato
di lingua precedente su quello seguente, il compito di Saussure potrebbe essere terminato. Ma, e qui sta la sua grandezza che rende vivente il suo pensiero, egli è inquieto, e si chiede:
Mais pourquoi est–ce un héritage? Pourquoi ne pourrait–on rien changer à
cet héritage? Nous voyons d’autres choses héritées des siècles précédents: ainsi
les lois. On ne pas tenue à ne pas changer les lois [Ma perché è un eredità? Perché non si potrebbe cambiare niente di questa eredità? Noi vediamo altre cose
ereditate dai secoli precedenti: ad esempio, le leggi. Non si è obbligati a non
cambiare le leggi] (Saussure, 2005 [1911], p. 169).
Ecco, qui Saussure è già fuori dalla linguistica, ed entra in una
semiologia che non è la scienza generale che classifica tutti i tipi di
segni, ma una riflessione sulla libertà umana così come si realizza
nelle varie istituzioni prodotte, per usare ancora il vecchio ma quanto
mai significativo termine di Lukács, dalla prassi.
106
Capitolo V
Anche qui, un’altra sorprendente assonanza con Pareto, quando
questi si chiede quale sia il «modo analogo» con cui scrittura, lingua,
religione, diritto, morale si sviluppano in quanto «prodotti simili
dell’attività umana». Ed ecco la risposta di Pareto:
in tempi remoti, [scrittura, lingua, religione, diritto, morale] si confondevano in una massa unica, come le parole che nelle antiche iscrizioni greche sono
scritte senza essere separate, e nelle quali il contatto modifica l’ultima lettera e
la prima di due parole che si separano. L’operazione analitica tanto semplice di
separare una parola dall’altra, rimasta incompiuta nel sanscrito, si compie nel
greco in un tempo non tanto lontano, e lascia traccia dell’antica unione sino
alla letteratura classica. Similmente l’operazione analitica che separa il diritto,
la morale, la religione, accennata fortemente pur non essendo compiuta, presso
i popoli moderni, rimane ancora da compiersi presso i Barbari. Le iscrizioni
greche come la storia delle origini greco–latine, ci mostrano lingua, diritto, morale, religione, come una specie di protoplasma, da cui, per scissione, nascono
parti che poi crescono, divengono distinte, si separano (TSG, I, § 469).
Come si vede, nella sua allusione biologica, è una risposta suggestiva, ma tutta giocata dentro una teoria filogenetica dell’astrazione.
Su questo punto, invece, Saussure è un passo oltre. La sua inquietudine lo porta a porsi il problema semioetico del grado di libertà delle
istituzioni umane: «Il y aura lieu de comparer le degré de liberté
qu’offrent d’autres institutions [Sarà opportuno comparare il grado
di libertà che offrono altre istituzioni]» (Saussure, 2005 [1911], p.
169).
Certo, in Saussure c’è l’apertura a questo problema, ma non c’è la
risposta. O per lo meno, c’è una risposta in negativo che ci dice ciò
che nella lingua non può accadere. Per Saussure, infatti, la lingua,
come è stato osservato, è «l’unica istituzione sociale in cui non si
possono fare rivoluzioni» (Gambarara, 2005, p. 181). Spetta a noi,
invece, capire cosa e perché si può fare di altro nelle altre istituzioni.
Capire, in altri termini, perché il segno non si può cambiare, ma le
leggi sì.
Capitolo sesto
Mente moderna e libertà politica
Potremmo compendiare quanto abbiamo visto nel capitolo precedente, con la seguente affermazione di Piaget: «Il pensiero crea la
lingua, poi la supera; ma la lingua si ripercuote sul pensiero e cerca
di imprigionarlo» (Piaget, 1926, p. 254).
Sappiamo come Frege si proponesse di abbattere questa prigione.
E sappiamo come Saussure porti all’estremo limite la riflessione
sulla lingua quale inevitabile prigione del pensiero. Istruiti da quanto
abbiamo appreso dall’analitica del vivente prospettata sulla base
delle distinzioni di Mayr, è ora completamente visibile davanti a noi
l’antinomia tra la lingua come teleonomia aperta che incorpora fini
espressivi, e la lingua come regno del caso che imprigiona il pensiero. Qual è il significato di tale antinomia? Perché Frege, alle origini
della filosofia analitica del linguaggio, in contemporanea con la riflessione di Saussure, e cogliendo inquietudini espresse
dall’affermazione di Piaget, si propone l’impresa di liberare il pensiero dalla sua prigione linguistica?
Ciò che vogliamo mostrare in questo capitolo conclusivo è che il
senso di questa riflessione sul peso della struttura nei confronti del
soggetto, si può cogliere se si riportano geneticamente alla luce alcuni fili di quella arbitrarietà linguistica su cui riflette Saussure, e che
conducono a quelle che potremmo indicare come le prime manife107
108
Capitolo VI
stazioni della mente moderna. L’antinomia, allora, su cui Frege,
Saussure e Piaget in maniera diversa ma convergente si interrogano,
diventa il sintomo di trasformazioni profonde della modernità stessa
In questa direzione, un punto da cui muovere è il fatto che la concezione saussuriana dell’arbitrarietà del segno non è la prima volta
che appare nella storia del pensiero semiotico. Nel Seicento, John
Locke, il filosofo della libertà politica, cui già abbiamo accennato
nel capitolo quarto, spostandosi sul terreno gnoseologico, emerso
dalla frattura tra la nuova scienza sperimentale e la vecchia ontologia
religiosa sin allora dominante, la avanza in termini apparentemente
simili. Nelle storie della semiotica, perciò, si ha la tendenza a presentarlo come un precursore, per quanto importante, di Saussure.
Tuttavia, è sufficiente riandare ai passi ben noti del Saggio
sull’intelletto umano (1690), l’opera in cui Locke, nel quadro della
sua teoria della conoscenza, prospetta le sue posizioni
sull’arbitrarietà del segno, per rendersi conto che dietro l’apparenza
di una certa continuità, si nascondono differenze essenziali tra i due
autori, concernenti in particolare il ruolo dell’individuo nella lingua.
Da dato storico–erudito, allora, il rapporto tra Locke e Saussure
diventa un tassello della questione teorica che in vari modi abbiamo
affrontato nel corso dei precedenti capitoli, cioè i fattori cognitivi e
pragmatici che conducono all’individuo autonomo e alle costruzioni
normative che ne governano il comportamento sociale. Una questione che, dal punto di vista storico–culturale, coincide, appunto, con la
genesi di ciò che chiamiamo modernità. Alla luce di quanto abbiamo
visto sin qui, allora, e muovendo sempre dalla teoria del segno, scopo di questo capitolo conclusivo è di riepilogare e rilanciare su tale
questione, spingendoci sino alla crisi che oggi sembra colpire la modernità stessa.
1. LOCKE: GENESI POLITICA DELLA SEMIOTICA MODERNA
Il primo e più famoso dei passi del Saggio sull’intelletto umano
dedicati all’arbitrarietà del segno è quello in cui Locke, proponendo
una nuova organizzazione delle scienze alla luce della critica gnoseologica sin lì condotta, accanto alla fisica, deputata alla conoscenza
Mente moderna e libertà politica
109
delle cose in sé, e all’etica, il cui scopo è la determinazione di ciò
che è giusto, pone anche la semiotica, quale ambito autonomo di studio dei segni. Non c’è bisogno di dire che il contributo dell’antichità
a tale studio è ricchissimo, ma la decisione di Locke di farne un ambito autonomo, denominandolo con quel termine che, soprattutto
dalla seconda metà del XIX secolo, avrà poi un così vasto impiego, è
una novità del tutto moderna che, come vedremo, non è solo terminologica ma sostanziale. Ma leggiamo il passo del S a g g i o
sull’intelletto umano in cui Locke definisce questa terza nuova branca delle scienze:
In terzo luogo, la terza branca può essere chiamata Semiotiké o dottrina dei
segni, e poiché la parte più comune di essa concerne le parole questa è abbastanza convenientemente chiamata anche Loghiké logica: il suo compito è di
considerare la natura dei segni che lo spirito usa per intendere le cose e comunicare la sua conoscenza agli altri. Giacché, dal momento che le cose che lo
spirito contempla non sono mai presenti all’intelletto, tranne lo spirito stesso, è
necessario che qualcosa d’altro come il segno o la rappresentazione della cosa
considerata, sia presente allo spirito; e questa è l’idea. E poiché la scena delle
idee, che costituisce i pensieri di un uomo, non può aprirsi alla vista immediata
di un altro uomo né può essere accumulata altrove che nella memoria, che non
è un deposito molto sicuro, per comunicare ad un altro i nostri pensieri, come
per registrali per il nostro proprio uso, sono necessari i segni delle nostre idee e
quelli che gli uomini hanno trovato più comodi e quindi usano generalmente,
sono suoni articolati. La considerazione delle idee e delle parole è perciò un
grande strumento di conoscenza e costituisce una parte non disprezzabile della
contemplazione di chi vuole abbracciare la conoscenza umana nella sua intera
estensione. E forse, se esse fossero distintamente investigate e debitamente
considerate, ci consentirebbero un’altra specie di logica e di critica, diversa da
quella che c’è stata fin qui familiare (Saggio sull’intelletto umano, libro IV,
cap. XXI, p. 818).
Come si vede, in questo passo Locke, quasi a giustificare il ruolo
di precursore che le ricostruzioni storiche gli assegnano, enuncia un
programma di ricerca semiotica che sembra una formulazione ante
litteram di quello di Saussure. La distinzione, infatti, tra lo studio dei
segni, compito della semiotica, e lo studio in particolare delle parole,
compito della logica, potrebbe essere vista, tenendo conto del vasto
rivolgimento che nel campo logico, linguistico e retorico avrà luogo
110
Capitolo VI
nei successivi tre secoli, come una prefigurazione di quella saussuriana tra semiologia e linguistica.
Altrettanto pre–saussuriana potrebbe essere giudicata l’analisi dei
segni linguistici come entità composte da un lato interno o significato, e da un lato esterno o significante, anche se questa analisi non
conduce Locke ad una teoria dei valori linguistici ma, coerentemente
con le sue preoccupazioni gnoseologiche, ad una specificazione della
funzione dei segni verbali.
Locke, infatti, interessato ad analizzare quegli oggetti del pensiero
che sono le idee, sia esse che provengano dalla percezione degli oggetti esterni (il bianco, il caldo, il dolce, ecc.), o dalla percezione
delle operazioni della nostra mente (il pensare, il dubitare, il credere,
ecc.), concepisce i segni linguistici come entità bifacciali che servono per conoscere e per comunicare. In particolare, la conoscenza richiede il differimento dell’oggetto e la sua sostituzione con qualcosa
di astratto che sta al suo posto. Questa è l’idea o significato o lato
interno del segno. Nella comunicazione, invece, i segni rendono percepibile ciò che è astratto, cioè l’idea o significato. Questo è il suono
articolato, o significante o lato esterno del segno. Per entrambe queste operazioni il segno fa da supporto in quanto entità che sta per
qualcos’altro: l’idea per l’oggetto, il suono articolato per l’idea.
Notiamo qui che il classico principio del segno come qualcosa
che sta al posto di qualcos’altro, non serve a Locke per indagare la
funzione regolativa del segno, così come abbiamo visto in Peirce,
bensì a inoltrarsi su quel nuovo terreno gnoseologico in cui, senza
entrare in conflitto con l’ontologia religiosa dominante, ci si interessa ai processi conoscitivi piuttosto che alle modalità dell’essere.
L’ideale traiettoria della modernità, dunque, che la sua indagine
contribuisce ad aprire, se lascia presagire sviluppi saussuriani, non
sembra indirizzarsi verso le analisi semiotiche di Peirce, ma in direzione di altre mete che nel corso di questo capitolo dovremo individuare.
Ma tornando alle anticipazioni saussuriane che esisterebbero in
Locke, l’impressione che il suo programma di ricerca semiotica sia
un’anticipazione di quello di Saussure posteriore di tre secoli, è ulteriormente rafforzata dal modo in cui Locke si pone nei confronti
della pietra angolare di ogni costruzione semiotica, cioè la giustifica-
Mente moderna e libertà politica
111
zione del legame esistente tra il significato e il significante. A questo
proposito Locke, infatti, sostiene:
Come abbiamo detto, le parole, mediante l’uso prolungato e la familiarità,
suscitano negli uomini costantemente e prontamente certe idee che si è portati a
supporre che ci sia una connessione naturale fra le due cose. Ma è evidente che
le parole indicano solamente le idee particolari degli uomini, e ciò mediante
un’imposizione perfettamente arbitraria, in quanto spesso mancano di suscitare
in altri (anche se adoperano lo stesso linguaggio) le stesse idee di cui le riteniamo segni; e ciascun uomo ha una libertà così inviolabile di fare che le parole
stiano per le idee che più gli piacciono, che nessuno ha il potere di far sì che
altri abbiano nel loro spirito le stesse sue idee quando usano le stesse parole
che egli usa. Perciò lo stesso grande Augusto, che col suo potere dominava il
mondo, riconosceva di non poter fabbricare una nuova parola latina: il che voleva dire che non poteva arbitrariamente designare quell’idea il cui suono avrebbe dovuto essere il segno sulla bocca e nel linguaggio comune dei suoi
sudditi (Saggio sull’intelletto umano, libro III, cap. II, § 8, pp. 478–9)
Come si vede, in questo passo Locke nega la teoria di una connessione naturale fra parole (ovvero, significanti) e idee (ovvero, significati), e adotta la teoria di un legame arbitrario, cioè immotivato,
fra queste due entità.
Se si limitasse a questa posizione di arbitrarismo linguistico, Locke sarebbe effettivamente quell’importante ma nient’affatto originale precursore di Saussure che le storie della semiotica ci presentano. Ma come abbiamo appena letto, egli precisa non solo che le parole indicano «le idee particolari degli uomini», cioè di ciascun individuo singolarmente preso, ma anche che l’imposizione arbitraria
delle parole per indicare le idee particolari degli uomini dipende
dalla libertà inviolabile di ciascun individuo di indicare con le parole
le idee che più gli piacciono, e ciò al di là di ogni possibile costrizione («nessuno ha il potere di far sì che altri abbiano nel loro spirito le
stesse sue idee quando usano le stesse parole che egli usa»).
Quindi, analogamente a quanto fa Saussure, Locke afferma
l’arbitrarietà, cioè l’immotivatezza, del legame tra significanti e significati, ma, a differenza di quanto sostiene Saussure, Locke concepisce l’arbitrarietà non come l’effetto del taglio che il corpo sociale
«incosciente o stupido» (CLG, p. 109) opera nel continuum amorfo
della sostanza fonico–concettuale, bensì come il portato di
112
Capitolo VI
un’euristica individuale, cioè di un modo di conoscenza semiotico
fondato sull’assoluta libertà dell’individuo.
C’è quindi in Locke un radicale individualismo linguistico–conoscitivo che fa dell’arbitrarietà linguistica non una legge naturale di autoregolazione della totalità linguistica, ma la conseguenza
del principio politico della libertà dell’individuo. Una libertà che,
beninteso, Saussure non disconosce, ma che relega funzionalmente
nella parole, senza ulteriormente indagarne la natura.
Posto ciò, come avviene allora la comunicazione? Come si esce
dall’anarchia comunicativa cui potrebbe condurre questo radicale individualismo linguistico–conoscitivo? Leggiamo in proposito il seguente passo del Saggio sull’intelletto umano:
4. Ma sebbene le parole, come sono adoperate dagli uomini, non possono
propriamente e immediatamente significare se non le idee che stanno nello spirito di chi parla, tuttavia gli uomini, nei loro pensieri, attribuiscono loro un riferimento segreto a due altre cose.
In primo luogo, suppongono che le loro parole siano segni di idee che sono
anche nello spirito degli altri uomini coi quali comunicano: infatti, parlerebbero invano e non potrebbero essere compresi se i suoni che applicano ad un’idea
venissero applicati dall’ascoltatore ad un’altra idea, il che significa parlare due
lingue diverse. Ma quanto a questo, gli uomini di solito non si soffermano ad esaminare se l’idea che essi hanno nello spirito e quella di coloro coi quali discorrono sia la stessa: pensano che basti usare quella parola, secondo essi la
immaginano, nella comune accezione di quella lingua. Con ciò suppongono
che l’idea, di cui l’hanno fatto diventare un segno, è precisamente la stessa alla
quale gli uomini dello stesso paese che sono in grado di capire, applicano quel
nome.
5. In secondo luogo, giacché gli uomini vorrebbero si ritenesse che parlino
non solo di cose che stanno solo nella loro immaginazione, ma anche di cose
che realmente ci sono, suppongono spesso che le parole stanno anche per la
realtà delle cose (Saggio sull’intelletto umano, libro III, cap. II, §§ 4 e 5, p.
477).
Come si vede, un primo freno all’anarchia comunicativa è costituito da un residuo di innocuo, anzi funzionale, realismo nominale,
che limita gli spazi sconfinati guadagnati dalla mente, nel momento
in cui, grazie al segno, differisce l’oggetto.
Un secondo freno, ancora più importante, perché di natura intersoggettiva, consiste in una sorta di supposizione implicita che i par-
Mente moderna e libertà politica
113
lanti fanno circa l’identico funzionamento semiotico delle rispettive
menti: così come la mia, la mente dell’altro con cui sto parlando è
fatta di idee; così come faccio io, anche per lui le parole sono segni
delle idee della sua mente; le idee che ho nella mia mente, infine, e
che indico con determinate parole, stanno anche nella mente di colui
con cui sto comunicando, ed egli stesso le indica con medesime parole.
Questa supposizione implicita, che richiama il reciproco riflesso
neurale che, secondo le più recenti ricerche neurocognitive, i neuroni
specchio assicurerebbero ai parlanti (Rizzolatti et al., 2006), è qualcosa di più che il semplice conformarsi all’uso comune. Osserva infatti in proposito Locke:
È vero che l’uso comune, mediante un tacito consenso, accoppia certi suoni
con certe idee in ogni linguaggio, il che limita il significato di quel suono a tal
punto che, se un uomo non l’applica alla stessa idea non parla con proprietà; e
mi sia consentito di aggiungere che, se le parole di un uomo non suscitano
nell’ascoltatore le stesse idee per cui quelle parole stanno per chi parla, questi
non parla in modo intellegibile. Ma qualunque siano le conseguenze dell’usare
le parole diversamente dal loro significato generale o dal senso particolare in
cui le intende la persona alla quale le rivolge, è certo che il loro significato, per
chi le usa, è limitato alle sue idee e che esse possono solo essere i segni di queste idee (Saggio sull’intelletto umano, libro III, cap. II, § 8, p. 479).
Come vediamo, qui Locke ha ben presente il consenso tacito
dell’uso comune che regge lo scambio linguistico, ma ancora una
volta egli pone l’accento sull’individuo che, nell’usare le parole, crea
i significati in corrispondenza con le sue idee. Oggi, i neuroscienziati
si spingono sino ad affermare che «la comprensione diretta significa
che due individui non hanno bisogno di precedenti accordi — per esempio su simboli arbitrari — per potersi comprendere tra loro:
l’accordo è inerente all’organizzazione neurale di tutti e due» (Rizzolatti et al., 2006, p. 61). Locke offre il modello di come fronteggiare il rischio dell’eliminazione del piano etico–discorsivo che implicitamente comporta un simile riduzionismo neuronale. Infatti, come
abbiamo visto, benché la sua argomentazione non si opponga, ma
anzi evochi la nuova spiegazione neurocognitiva, egli tuttavia sottolinea sempre la libertà linguistico–conoscitiva dell’individuo, in con-
114
Capitolo VI
seguenza della quale la comunicazione resta un fatto eminentemente
politico, che non può fare a meno dell’idea di patto tra individui autonomi.
Certo, si può immaginare un futuro in cui costrutti proposizionali
come patto, autonomia, libertà siano resi inutili e sostituiti dalla generale consapevolezza tutta scientifica dell’identica costituzione neuronale. Ma non per ciò sarebbero risolti i problemi che quei costrutti
cercavano di risolvere. Infatti, non è difficile immaginare che dalla
consapevolezza dell’identica costituzione neuronale discenderebbero
richieste ancora più stringenti di libertà, e quindi di eguaglianza circa
l’accesso al potere e alla ricchezza. Non è dunque imboccando scorciatoie riduzioniste che tali problemi possono essere affrontati, i
quali anzi richiedono che le “finzioni” politiche permangano, benché
rinnovate nei loro contenuti alla luce delle nuove conoscenze.
2 . DA L OCKE A
SOCIALE
H OBBES :
LIBERTÀ DELL’INDIVIDUO E ASTRAZIONE
Il radicale individualismo linguistico–conoscitivo di Locke non
viene dal nulla, ma trova la sua spiegazione nel Locke filosofo della
politica moderna, di cui assieme a Thomas Hobbes (1588–1679) è
fondatore, e in particolare nel Locke filosofo della proprietà privata,
da un lato, e della società politica (commonwealth) come contratto,
dall’altro.
Quanto al primo punto, basterà dire qui che per Locke la proprietà
privata è l’assimilazione della natura da parte dell’uomo ai suoi bisogni tramite il lavoro. Come abbiamo visto in altri autori posteriori
a Locke, il lavoro è intelligenza, ovvero capacità storicamente situata
di perseguire scopi. Quella di Locke, allora, si può considerare come
una delle prime analisi delle condizioni che generano lo stadio storico moderno dell’intelligenza. Per Locke, infatti, il lavoro è condizione della libertà dell’individuo, poiché consente di uscire dalla schiavitù e dalla condizione servile medioevale (Secondo trattato sul governo, cap. V). Libero sarà, allora, non solo l’agricoltore indipendente, che trasformando la terra con il suo lavoro ne acquista il diritto di proprietà, ma anche il lavoratore salariato, con la sua possibi-
Mente moderna e libertà politica
115
lità, come chiarirà l’economia politica, da Smith a Ricardo a Marx,
di vendere forza–lavoro, un’energia misurabile in termini quantitativi di valore, indifferente perciò al soggetto che la eroga e
all’oggetto, o merce, in cui si incorpora. Con la sua critica
dell’economia politica, Marx mostrerà poi i limiti della libertà del
lavoro salariato, ma ciò che qui importa notare è il nesso tra libertà
dell’individuo e accrescimento dell’astrazione sociale, la quale tocca
aspetti differenti e apparentemente slegati dell’esperienza quali il lavoro ma anche, come vedremo appresso tanto in Locke quanto in
Hobbes, il linguaggio e la politica.
Veniamo così al secondo punto, cioè il Locke della società politica come contratto, da cui si evince che lo stato di natura non è la
guerra di tutti contro tutti, come aveva sostenuto prima di lui, appunto, Hobbes, ma è caratterizzato da una «libertà estesa» (Secondo
trattato sul governo, cap. VIII, § 97), ovvero dall’assenza di una
norma fissa secondo cui vivere, la quale invece interviene proprio
con il patto che fonda la libertà regolata (cap. IV, § 22). Lo stato di
natura è dunque una forma di socialità in cui individui embrionalmente dotati di ragione (perseguono scopi ma sono anche potenzialmente in grado di compiere libere scelte etiche), vivono in condizione di pace precaria. In termini comunicativi, esso corrisponde alle
intese labili e contingenti che sono possibili grazie alla dotazione
semiotica di base che l’uomo in parte condivide con le altre specie
animali (segnali, indici, protofrasi legate all’azione).
La necessità di uscire dallo stato di pace precaria e di conseguire
la sicurezza reciproca, che è lo scopo precipuo del contratto, spinge
al patto politico, secondo modalità costruttive che Locke così descrive in termini normativi:
Poiché gli uomini sono, come s’è detto, tutti per natura liberi, eguali ed indipendenti, nessuno può esser tolto da questa condizione e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso. L’unico modo con cui uno si spoglia della sua libertà naturale e s’investe dei vincoli della società civile, consiste nell’accordarsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comunità,
per vivere gli uni con gli altri con comodità, sicurezza e pace, nel sicuro possesso delle proprie proprietà, e con una garanzia maggiore contro chi non vi
appartenga. Ciò può esser fatto da un gruppo di uomini, in quanto non viola la
libertà degli altri, i quali rimangono com’erano, nella libertà dello stato di natu-
116
Capitolo VI
ra. Quando un gruppo di uomini hanno così consentito a costituire un’unica
comunità o governo, sono con ciò senz’altro incorporati, e costituiscono un unico corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di deliberare e decidere per
il resto (Secondo trattato sul governo, VIII, § 95, p. 297).
Il processo di incorporazione, il cui motore è ancora una volta la
libera volontà dei singoli individui, produce dunque il corpo politico,
cioè un’entità normativa costruita e non naturale che assicura la sicurezza reciproca. Da un punto di vista comunicativo, il patto politico
corrisponde all’intesa linguistico–conoscitiva che si stabilisce grazie
alla supposizione implicita sull’identico funzionamento della mente
altrui. Una supposizione, quindi, che non ha solo un valore funzionale ma anche normativo.
Questa omologia che abbiamo appena ricostruito in Locke tra ordine politico e ordine comunicativo, ci permette di avanzare due serie di considerazioni. La prima concerne la «massa parlante» che, in
Saussure, adopera la lingua. Essa, a differenza del corpo politico,
non è un’entità costruita, ma un dato naturale, senza alcuna volontà
che non sia la spinta — teleomatica, potremmo dire — del caso. Ecco perché, prendendo in contropiede l’analogia di Saussure,
l’abbiamo potuta paragonare a un giocatore di scacchi incosciente o
stupido. A voler estendere ulteriormente il senso di quest’analogia, si
potrebbe dire che in Locke la comunicazione, nella sua forma compiuta, è una partita a scacchi condotta da giocatori coscienti e intelligenti. Questo arretramento del dato naturale è l’effetto dell’idea
normativa di patto che Locke introduce tanto nell’ordine politico
quanto nell’ordine comunicativo. I teorici del linguaggio hanno,
dunque, ben ragione a valorizzare la plasticità comunicativa dello
stato di natura linguistico, ma quando su di esso proiettano una dimensione normativa, affermando che la parola altrui contiene di per
sé il riconoscimento etico dell’altro, comprimono livelli, quello naturale e quello normativo, che vanno invece tenuti separati, per non
occultare il processo costruttivo che conduce dall’uno all’altro.
L’altra serie di considerazioni concerne proprio il carattere del
corpo politico generato dal patto. Locke sembra concepire la sua costruzione semiotico–politica come il potenziamento di una socialità
spontanea fondata su una ragione naturale. In qualche modo,
Mente moderna e libertà politica
117
nell’autore della tabula rasa c’è come una contraddizione di fondo:
la mente esiste ab initio, basta potenziarla con opportuni accordi che
facciano presa sui bisogni e gli interessi degli uomini. E in questo
modo, essa viene a coincidere con la società stessa costituitasi in
corpo politico, verso cui lo Stato avrà una mera funzione di coazione.
Assieme, allora, alla concezione dello stato di natura, questo è un
altro punto di differenza con Thomas Hobbes, per il quale, invece,
come vedremo fra poco, lo Stato o sovrano è la costruzione di una
mens unica, una razionalità che, prendendo il posto delle inconciliabili passioni dello stato di natura, viene a costituire un livello di astrazione totalmente nuovo, senza alcun legame con il dato naturale
pre–esistente (Izzo, 2005). Se, dunque, nell’ordine comunicativo Locke introduce un grado di astrazione normativa che lo differenzia dal
successivo naturalismo di Saussure, anche se sappiamo quanto
quest’ultimo avverta l’urgenza del normativo, nell’ordine politico
sembra arrestarsi ad un’astrazione quasi gravata dal peso fisico degli
«incorporati». Il corpo politico, infatti, non è una totalità nuova rispetto alle parti componenti (una totalità logica, per dirla con Piaget), ma è la somma delle singole volontà libere (una totalità additiva, per dirla ancora con Piaget).
La domanda cui rispondere è, allora, come si costruisce quel livello puro, o logico, di astrazione che è lo Stato quale mens unica di
Hobbes, e se e quali procedimenti semiotici sono coinvolti in tale
processo costruttivo. In questo modo, potremo stabilire anche se
nello stesso Hobbes la semiotica, sebbene con modalità differenti rispetto a Locke, gioca un ruolo costruttivo nella trama del pensiero
moderno.
3.
HOBBES: GENESI SEMIOTICA DELLA POLITICA MODERNA
Per stabilire come si costruisce il livello puro, o logico, di astrazione che è lo Stato quale mens unica, dobbiamo andare oltre
l’omologia tra ordine linguistico e ordine politico che abbiamo ricostruito in Locke, e individuare gli strumenti che nella descrizione di
Hobbes generano la sovranità. Siamo qui ad uno snodo centrale del
118
Capitolo VI
pensiero moderno, cioè l’enucleazione dei principi di una nuova teoria politica dalle trasformazioni storiche che conducono al mondo
moderno: dalla lotta contro l’assolutismo politico di derivazione divina, alla mondanizzazione del potere e della religione, dalla rottura
dei vecchi legami sociali sotto l’urto del nuovo modo di produzione
economica, al bisogno di un nuovo ordine sociale. Tutto ciò impone,
anche contro le stesse intenzioni dei suoi autori (Hobbes era un difensore dei vecchi assetti di potere), l’idea di un potere legittimo che
non deriva più dal mandato divino o dall’atto d’imperio, bensì dal
patto tra individui liberi.
Ora, ciò che appare chiaro in Hobbes, è il fatto che lo Stato quale
mens unica o totalità logico–normativa propria della sovranità moderna, è generato da una struttura di stare per di tipo semiotico che
altro non è che il meccanismo della rappresentanza.
In questo senso, particolarmente significativo è quanto Hobbes afferma nel Leviatano (1651), l’opera in cui egli espone compiutamente la nuova concezione contrattualista della politica. Per Hobbes,
la sola via per erigere un potere comune che possa essere in grado di
difendere gli uomini dalle aggressioni esterne e dai conflitti interni, è
quella di conferire tutti i loro poteri e tutta la loro forza ad un uomo o
ad un’assemblea di uomini che possa ridurre tutte le loro volontà ad
una volontà sola.
Ora, sostiene Hobbes,
ciò è come dire designare un uomo o un’assemblea di uomini a sostenere la
parte della loro persona, e ognuno accettare e riconoscere sé stesso come autore
di tutto ciò che colui che sostiene la parte della loro persona, farà o di cui egli
sarà causa, in quelle cose che concernono la pace e la sicurezza comuni, e sottomettere in ciò ogni loro volontà alla volontà di lui, ed ogni loro giudizio al
giudizio di lui (Leviatano, II, XVII, p. 167).
E poco più avanti, in maniera più completa, ancora afferma:
Si dice che uno stato è istituito, quando una moltitudine di uomini si accorda e pattuisce, ognuno con ogni altro, che qualunque sia l’uomo o l’assemblea
di uomini cui sarà dato dalla maggior parte, il diritto a rappresentare la persona
di loro tutti (vale a dire, ad essere il loro rappresentante), ognuno, tanto chi ha
votato a favore quanto chi ha votato contro, autorizzerà tutte le azioni e i giudizi di quell’uomo o di quell’assemblea di uomini, alla stessa maniera che se
Mente moderna e libertà politica
119
fossero propri, al fine di vivere in pace tra di loro e di essere protetti contro gli
altri uomini (Leviatano, II, XVIII, p. 169).
Come si vede, analogamente a quanto accade in campo semiotico,
dove, più compiutamente del simbolo, sempre motivato, e ancor più
dell’indice, dipendente dalla materialità di ciò che significa, il segno
si costituisce quando qualcosa in modo del tutto immotivato sta al
posto di qualcos’altro, anche nel dominio della politica il potere, se
vuole evolvere verso una forma più astratta che lo liberi dalle “aderenze” sostanzialistiche della derivazione divina o della forza, deve
costituirsi quale effetto di un’operazione di rinvio, o «designazione»,
per mezzo della quale qualcuno, il rappresentante, ovvero il Sovrano
(Leviatano, II, XVII, p. 168) sta al posto di qualcun altro, il rappresentato, ovvero la moltitudine che, riunita nel patto, si trasforma in
corpo politico.
Senza quest’operazione di rinvio, infatti, il corpo politico, da totalità logica, torna ad essere moltitudine, cioè un significato “cieco”;
il sovrano, un significante ”libero”, non più vincolato alla immanenza del corpo politico; la politica, atto decisorio arbitrario, ma non nel
senso di immotivato, proprio dell’astrazione semiotica, bensì nel
senso di volontà incontrollata, proprio dello stato di natura.
In virtù di tale operazione, invece, la politica diviene una rappresentazione, ma in un senso del tutto nuovo rispetto alla teatralità
della vecchia politica, dove emblemi e simboli rinviavano allegoricamente alla sostanza arcana del potere. Il fondamento del nuovo
potere è, infatti, funzionalmente semiotico, nel senso che, grazie alla
reversibilità dell’operazione di rinvio (Eco, 1972, p. 24), propria dei
processi logici, designante e designato si vengono a trovare in una
relazione di reciprocità: il designato può essere persona, cioè attore,
al posto di qualcun altro, e il designante può riconoscersi autore di
ciò che fa il designato.
Questa logicizzazione del potere spiega due fatti. Anzitutto, si capisce perché il segno non si può cambiare, mentre le leggi sì. Con la
fine dello stato di natura, la legge, infatti, diviene motivata, e perciò
soggetta a contestazione. Il procedimento semiotico, che normalmente porta all’immotivatezza, agisce qui come un reagente chimi-
120
Capitolo VI
co: almeno per questo aspetto, nella nuova soluzione non ce n’è più
traccia.
In secondo luogo, con la logicizzazione del potere si capisce perché l’incorporazione in Hobbes va oltre, come abbiamo anticipato, la
totalità “additiva” di Locke. Per Hobbes, infatti, l’operazione di designazione non produce il semplice consenso o la concordia tra coloro che stipulano il patto, bensì
un’unità reale di tutti loro in una sola e medesima persona fatta con il patto
di ogni uomo con ogni altro, in maniera tale che, se ogni uomo dicesse ad ogni
altro, io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso, a quest’uomo, o
a questa assemblea di uomini a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto,
e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile (Leviatano, II, XVII, p. 168).
Come si vede, l’unità reale delle molteplici volontà in una sola
persona è l’effetto di una coordinazione di scopi tra individui che
l’operazione di designazione pareggia e rende sostituibili l’uno con
l’altro, analogamente a quanto accade nella sfera autonoma ma coordinata del lavoro dove, come abbiamo visto, la stessa tensione verso
l’astratto libera quell’energia eguale da individuo a individuo, e indifferente all’aspetto fenomenico della merce, che è la forza–lavoro.
Se nel campo dell’economia ciò produce la nuova totalità finalistica sorta dalla combinazione di lavoro e capitale, nel campo della
politica si ha non una fusione mistica, né la semplice somma delle
volontà concordi, ma una totalità normativa, di cui gli individui sono
i singoli ed infiniti nodi logici.
È questo lo Stato quale mente collettiva che Hobbes, nella maniera devota ma ardita che gli è propria, in un passo conclusivo di tutta
la sua costruzione chiama il Leviatano:
Questa è la generazione di quel grande LEVIATANO, o piuttosto (per parlare con più riverenza) di quel dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio
immortale, la nostra pace e la nostra difesa. Infatti, per mezzo di questa autorità
datagli da ogni particolare nello stato, è tanta la potenza e tanta la forza che gli
sono state conferite e di cui ha l’uso, che con il terrore di esse è in grado di informare le volontà di tutti alla pace interna e all’aiuto reciproco contro i nemici
esterni. In esso consiste l’essenza dello stato che (se si vuole definirlo) è una
persona dei cui atti ogni membro di una grande moltitudine, con patti reciproci, l’uno nei confronti dell’alto e viceversa, si è fatto autore, affinché essa pos-
Mente moderna e libertà politica
121
sa usare la forza e i mezzi di tutti, come penserà sia vantaggioso per la loro
pace e la comune difesa (Leviatano, II, XVII, pp. 167–168).
Prendiamo atto che in questo passo, da un periodo all’altro, quasi
senza soluzione di continuità, convivono due modelli, quello arcaico
del potere come forza e terrore, e quello moderno del potere come
totalità logica prodotta dall’operazione di designazione. Torneremo
alla fine su questo punto. Qui notiamo invece come questa costruzione semiotica della politica si spinga sino a rigenerarne lo stesso
campo terminologico, come si evince da quest’altro passo del Leviatano:
La differenza degli stati consiste nella differenza del sovrano o della persona rappresentativa di tutta la moltitudine e di ciascun suo componente. E per il
fatto che la sovranità è in un uomo o in un’assemblea di più uomini, e che in
quell’assemblea hanno diritto a entrare o tutti gli uomini oppure non tutti ma
solo certuni che si distinguono dagli altri, è manifesto che non ci possono essere che tre generi di stato. Il rappresentante infatti deve essere necessariamente
un uomo o più uomini; se sono più uomini, è allora o l’assemblea di tutti o solo
di una parte. Quando il rappresentante è un uomo, lo stato allora è una
MONARCHIA; quando è un’assemblea di tutti coloro che vogliono riunirsi,
allora è una DEMOCRAZIA o stato popolare, quando è un’assemblea di una
parte soltanto, è chiamata allora una ARISTOCRAZIA. Non vi può essere alcun altro genere di stato, poiché o uno, o più, o tutti devono avere il potere sovrano (che ho mostrato essere indivisibile) per intero (Hobbes, Leviatano, II,
XIX, p. 181).
I nomi del potere dipendono, dunque, dalla natura del rappresentante: se il potere è rappresentato da un uomo, si ha la monarchia, se
è rappresentato da un’assemblea, si ha la democrazia, se è rappresentato da un’assemblea di una parte soltanto, si ha l’aristocrazia.
Tutto ciò non è puro gioco terminologico, e per rendersene conto,
basti vedere cos’è lo Stato, il cittadino e le forme della politica in Aristotele, che su questi argomenti ai tempi di Hobbes era l’autorità
per eccellenza, e contro cui Hobbes lotta aspramente.
Per Aristotele, conformemente al suo ammirevole naturalismo,
tuttavia oberato da un finalismo indiscriminato, lo Stato è un prodotto naturale in quanto è il fine naturale delle comunità (famiglie e
villaggi) che lo compongono (Politica, 1253a). Esso, dunque, coin-
122
Capitolo VI
cide con quella condizione naturale che Hobbes chiama stato di natura. Ma mentre per Hobbes si tratta di una condizione da superare,
poiché priva di una sua spontanea capacità di coordinazione, cui
supplisce, come sappiamo, l’operazione di designazione, per Aristotele, al contrario, lo stato di natura, come ogni cosa creata dalla natura, possiede un suo fine che lo porta a compimento, cioè appunto allo
Stato quale aggregato di comunità ad esso pre–esistenti.
Si potrebbe osservare che anche in Aristotele c’è l’idea dello
Stato quale totalità nel senso di un rapporto di parte a tutto (Politica,
1253a 15–25), ma qui non possiamo addentrarci in questi particolari.
Ciò che importa è cogliere la rottura che interviene con Hobbes nella
concezione della politica, una rottura che concerne la concezione
dello Stato, ma dicevamo anche del cittadino.
Infatti, mentre per Hobbes il suddito, come egli lo chiama, tradendo tanto le sue aspirazioni restauratrici quanto il suo rapporto
ambiguo con il modello arcaico del potere, è quel nodo logico di una
totalità astratta che abbiamo sopra visto, per Aristotele il cittadino è
chi può assumere cariche e funzioni (Politica, 1275a 20–25). Una
definizione fattuale, dunque, tratta dall’osservazione della storia e
delle costituzioni, così come accade, infine, per i nomi del potere e la
tipologia che ne deriva. Infatti, regno, aristocrazia e politia, con i
nomi correlati delle loro degenerazioni, tirannide, oligarchia e democrazia (Politica, 1279b 5–10), non sono i nomi che specificano le
modalità della designazione, ma l’inizio di una lunga descrizione
empirica di stati di cose.
Ai giorni nostri, non più segnati dalle urgenze normative dei secoli originari della modernità, ma anzi caratterizzati dalla sua crisi, si
può anche preferire l’approccio empirico di Aristotele, e forse questo
è uno dei significati dell’odierna ripresa aristotelica nella filosofia
pratica non solo continentale. Una ripresa che, per evitare conseguenze “sgradevoli” (naturalità della schiavitù e della subordinazione delle donne), è costretta ad “allargare” il concetto di natura di Aristotele, attribuendogli una componente normativa ad esso estranea
(De Anna, 2006). Ma qui non possiamo soffermarci oltre su queste
questioni. Ciò che importava mostrare era come, nella sua tensione
verso l’astratto e il normativo, la modernità trovi nei procedimenti
semiotici uno strumento essenziale di sviluppo. Ciò che, contro un
Mente moderna e libertà politica
123
certo continuismo dominante nella storia della semiotica, dovrebbe
forse indurre a marcare di più la differenza tra una semiotica dei moderni distinta da una semiotica degli antichi, in corrispondenza con
l’emergenza del concetto di individuo autonomo.
4 . COMPIMENTO E CRISI DELLA MODERNITÀ: L’INDIVIDUO TRAGICO DI
FREGE
Eppure, come abbiamo visto in chiusura del precedente capitolo,
al culmine della modernità, nella costruzione linguistica di Saussure,
la constatazione che si impone è quello del segno non libero ma imposto, della lingua come istituzione sociale in cui non sono possibili
rivoluzioni. È come la fine dell’illusione sulla forza dell’individuo e
sulla cogenza delle costruzioni astratte, che legittima un ritorno del
naturalismo, sebbene nelle forme scientificamente rinnovate del
darwinismo.
Il Novecento, però, non si rassegna a questo esito, ma anzi è segnato da tentativi di forzare la ferrea legalità naturale descritta da
Saussure. All’inizio di questo libro, abbiamo accennato alle esigenze
di riforma logica del linguaggio ordinario avanzate da Frege e Vailati. Alla luce di quanto abbiamo visto in Saussure, e poi in Locke e
Hobbes, esse ci appaiono ora come dei tentativi, sorti nella riflessione logica ma assurti a bisogno generale, di salvare il programma
della modernità, controllando l’arbitraria potenza del linguaggio.
Vailati, raffigurando il linguaggio come «un’istituzione, che (come quella della proprietà) è piuttosto “da riformare” che da abolire
(anche in matematica)», si proponeva con le sue analisi logiche il
compito di «mettere a nudo le magagne del linguaggio ordinario,
mostrando in che direzione si dovrebbe provvedere a migliorarlo e a
sanarlo (precisamente come il socialismo mette a nudo i difetti
dell’ordine sociale presente)» (Epistolario, p. 174). Di qui l’idea
implicita del valore civile del retto ragionare, ovvero la fiducia di
poter migliorare con dialoghi ben condotti tra individui autonomi
l’ordine linguistico esistente.
Più radicalmente Frege, quasi a voler tentare l’impossibile rivoluzione contro il segno, si proponeva di «spezzare il dominio della pa-
124
Capitolo VI
rola sullo spirito umano» (Ideografia, p. 106). Una rivolta contro il
linguaggio che di conseguenza andava al di là della mite filosofia civile adombrata da Vailati, e che, forse a causa di radici oggettivamente più profonde nell’originario progetto moderno, comportava un
soggetto parlante sottratto alla irriflessiva spontaneità quotidiana, e
ancorato a categorie di pensiero consapevolmente poste. In articulo
mortis, dunque, un ritorno dell’ontologia, le cui forme e modalità sono tutte da valutare, ciò che tra l’altro faremo nel prosieguo affrontando proprio il progetto di riforma logica del linguaggio di Frege.
Dire riforma del linguaggio in Frege significa dire edificazione di
una logica del pensiero, cioè di una struttura simbolica verofunzionale in grado di controllare il corretto rapporto tra linguaggio e mondo. A questo scopo, Frege procede alla scomposizione del segno
(Zeichen) nei suoi elementi costitutivi, e cioè il senso (Sinn) e la denotazione (Bedeutung), che sono oggettivi e esterni, e l’immagine o
rappresentazione (Vorstellung), che è soggettiva e interna.
Il senso di un segno corrisponde al suo apporto conoscitivo, ovvero esprime una conoscenza che è il possesso di più persone (Senso e
denotazione, p. 11).
La denotazione esprime il valore di verità di un segno: l’enunciato
vero «Ulisse è un uomo», di contro all’enunciato falso «Ulisse è un
cavallo». Se siamo protesi verso la verità, dice Frege, come ci accade
quando consideriamo la denotazione di un segno, la seconda frase
perde subito di interesse per noi (Senso e denotazione, p. 16). In altri
termini, l’essere protesi verso la verità equivale a puntare dritto alle
cose, un principio che, come vedremo appresso, non è rivendicato
solo dalla logica, e dalla cui concezione dipende l’esito stesso della
rifondazione ontologica.
Distinta dal senso e dalla denotazione, c’è, infine, la rappresentazione, cioè l’immagine interna che ciascuno di noi collega ad un segno, la quale, fa notare Frege, «è spesso impregnata di sentimenti»
(Senso e denotazione, p. 12), e dà il «tono», ovvero l’impronta soggettiva, all’asserzione (Il pensiero. Una ricerca logica, p. 51). Per
questo suo carattere soggettivo, ai limiti del solipsismo (Il pensiero.
Una ricerca logica, pp. 56–59), la rappresentazione è estranea al vero, il quale, come abbiamo visto, è invece il possesso di più persone.
Senza questa intersoggettività del vero, la scienza non sarebbe possi-
Mente moderna e libertà politica
125
bile poiché non ci potrebbe essere discussione, ovvero contraddizione tra opposte asserzioni (Il pensiero. Una ricerca logica, p. 60), le
quali sono pensieri presi a carico dai soggetti linguistici.
Questa distinzione tra pensieri e asserzioni, ovvero tra contenuto
cognitivo e enunciazione discorsiva, ci conduce all’ontologia che
sorregge l’analisi che Frege opera del segno. Frege pone che, accanto al mondo esterno degli oggetti fisici (tavoli, cavalli, uccelli,
martelli e quant’altro), e al mondo interno delle rappresentazioni
(impressioni sensoriali, immagini, sensazioni, desideri, ovvero le «idee»), ci sia il mondo oggettivo ma non attuale dei pensieri e dei loro
sensi costituenti (ad es., il numero che, così come l’equatore o il
centro di massa del sistema solare, è «oggettivo» ma «non attuale»,
non ha cioè alcuna influenza causale su di noi).
Ora, il mondo esterno è esteriore e pubblico, in quanto tale indipendente da un possessore. Gli oggetti esterni, infatti, esistono indipendentemente dal fatto che qualcuno li possieda, desideri, ecc. Il
mondo interno è, invece, interiore e privato. Le rappresentazioni o idee esistono in funzione di un solo possessore, nel senso che due individui non avranno mai due idee perfettamente uguali. Il mondo dei
pensieri, infine, non è percepibile con i sensi ma è indipendente da
un possessore di pensieri e le sue verità sono eterne (il teorema di
Pitagora è vero per l’eternità, ed è solo asserito ogni volta che qualcuno lo dimostra). L’intersoggettività è propria solo di questo mondo, che però è tutt’altro che sicuro. Anzi, avverte Frege, il luogo
della sicurezza è il mondo interno. Il mondo esterno è invece il luogo
del dubbio e del possibile errore.
In conclusione, il soggetto parlante che risulta da questa rifondazione logico–ontologica, è un soggetto pubblico che, con una lingua
logicamente controllata, «afferra», cioè enuncia, asserisce, prende a
carico pensieri. Dalla irriflessiva spontaneità linguistica siamo
proiettati verso uno spazio intersoggettivo abitato da soggetti naturalmente protesi verso la verità, cioè che, tramite pensieri oggettivi e
eterni, puntano dritto alle cose.
Due osservazioni si possono fare, a questo punto. La prima concerne la connotazione negativa che, rispetto a Locke, Frege riserva al
fatto che due individui non avranno mai due idee o rappresentazioni
perfettamente uguali. Come sappiamo, Locke non era per nulla sco-
126
Capitolo VI
raggiato da questa circostanza, anzi ne faceva la chiave di volta della
sua costruzione politico–comunicativa. Frege, al contrario, la esorcizza, andando alla ricerca con la sua ontologia di un mondo in cui,
quale garanzia di verità logico–linguistica, gli oggetti siano completamente staccati dal soggetto.
Questo ci porta alla seconda osservazione. L’essere protesi verso
la verità è un principio debole, se reciso dalla sua costruzione genetica. Come ha mostrato Piaget, infatti, non è l’attività intellettuale iniziale che ricerca attivamente il vero, ma è l’organismo che, costretto
dalla resistenza delle cose e delle persone, seleziona i suoi modi di
procedere (Piaget, 1932, p. 329). Ecco perché la verità, prima di essere tale, è solo un’opinione valida cui ci si conforma per rispetto
della fonte da cui promana (Piaget, 1932, p. 331). La genesi, dunque,
benché cognitivamente opaca, è ontologicamente costruttiva, e ciò
spiega perché Lukács, la cui ontologia nel capitolo quarto abbiamo
confrontato con quella di Peirce, inserisca in una cornice genetica
l’assioma ontologico secondo il quale «l’uomo è un essere che risponde». Dalla mancata considerazione di questo dinamismo, ovvero
del ruolo causale della genesi, che si manifesta nella centralità sociocognitiva della presa di coscienza (Piaget, 1974), deriva il carattere
disincarnato del soggetto linguistico rimesso a nuovo da Frege, pura
macchina logico–enunciativa, tuttavia angosciato dal pericolo che
l’apertura al mondo esterno fa incombere su di lui:
In effetti, con il passo nel quale mi guadagno il mondo che mi circonda mi
espongo al rischio dell’errore. E qui mi accorgo di un’altra differenza tra il
mondo esterno e il mondo interno. Per me non può esserci alcun dubbio che ho
l’impressione visiva del verde; ma non è altrettanto certo che io veda una foglia
di tiglio. Contrariamente a opinioni assai diffuse troviamo così nel mondo interno la sicurezza, mentre il dubbio non ci abbandona mai completamente nelle
nostre peregrinazioni nel mondo esterno. Ciò nonostante anche qui la probabilità è in molti casi appena distinguibile dalla certezza, cosicché possiamo azzardarci ad avanzare dei giudizi circa le cose del mondo esterno (Il pensiero.
Una ricerca logica, p. 67).
Incertezza, dubbio, errore, una condizione tragica, quella del soggetto linguistico in Frege, determinata da una generale limitatezza
dell’essere, cui Frege allude in chiusura del brano sopra citato: «E
Mente moderna e libertà politica
127
dobbiamo azzardarci, anche a rischio dell’errore, se non vogliamo
soccombere a pericoli maggiori» (ibidem).
Si può cogliere qui un’assonanza con «la scelta, pena la rovina»,
l’altro assioma che Lukács pone a base della sua ontologia storico–genetica. Ma la cifra di Frege è piuttosto quella classificatorio–formale che, almeno all’apparenza, sembra avvicinarlo più a
Peirce.
Sappiamo, infatti, che in Peirce la Primità comprende i caratteri
positivi interni del soggetto in sé (l’essere in sé); la Secondità, le azioni brute di un soggetto su un altro senza riguardo alla legge o ad
alcun altro soggetto (essere relativo a o di reazione con); la Terzità,
l’influenza mentale di un soggetto su un altro relativamente a un terzo (mediazione, per mezzo della quale un primo e un secondo sono
posti in relazione).
Come si vede, tanto Frege divide (mondo interno dal mondo esterno) e sottrae (la rappresentazione dal complesso del segno),
quanto Peirce integra e somma. Peirce, infatti, non è interessato ad
un soggetto disincarnato afferratore di pensieri eterni. Al contrario,
gli interessa vedere come, grazie ai segni, esseri in sé, in tutta la loro
“pesantezza” ontologica, entrano in relazione tra loro. E la modalità
è quella di porre scopi tramite segni. Il segno come regolatore
dell’azione intelligente.
Differenze di metodo, dunque, tra Frege e Peirce, ma anche differenze quanto all’esito finale. Da un lato, infatti, con Frege abbiamo
la costituzione di uno spazio logico–enunciativo che, con i suoi soggetti disincarnati, prefigura paesaggi cibernetici, se non fosse per
quel residuo della scelta pena la rovina, che ritorna come un sintomo
angoscioso e non ulteriormente analizzabile; dall’altro, con Peirce
abbiamo l’assunzione della pienezza ontologica dell’essere semiotico relazionale, ma in una direzione fanciullescamente agapica che
dissolve il portato tragico della limitatezza dell’essere.
Più in Frege che in Peirce, dunque, si avverte la compiutezza del
tema moderno dell’emergenza dell’individuo, annunciato da Locke.
Un tema, tuttavia, che a causa della mutilante rifondazione ontologica da Frege stesso operata, appare esposto a derive e metamorfosi
impreviste e forse indesiderate.
128
Capitolo VI
Tutto quello che non è pensiero, afferma Frege, è poesia (Il pensiero. Una ricerca logica, p. 51). Appena qualche decennio dopo,
Wittgenstein riformula quest’opposizione, sostituendo alla poesia
l’etica, e affermando che tutto ciò che non è logicamente pensabile, è
mistica, salvo poi recuperare l’impegno etico nei giochi autofondanti
(Livret, 2006). Questa impossibilità dei giochi di uscire da se stessi
per giustificarsi, con l’implicita violenza verso il molteplice e il differente che ciò comporta, non è il solo sintomo delle amputazioni
che una pura rifondazione logico–ontologica può arrecare all’essere.
L’opposizione di Frege tra pensiero e poesia appare esposta, infatti,
all’autonoma azione di ritorno della poesia stessa, la quale non si fa
così facilmente ridurre ad inerte ricettacolo di tutto ciò che non è logico.
Emblematica, da questo punto di vista, la rivolta estrema contro il
giogo dell’arbitrarietà linguistica teorizzata da Samuel Beckett
(1906–1989), con accenti, per somma ironia, molto simili a quelli di
Frege, come si può vedere in questa lettera dello stesso Beckett
all’amico Axel Kaun:
mi diventa sempre più difficile, per non dire insensato, scrivere nell’inglese
“ufficiale”. E sempre più la mia lingua mi appare come un velo che bisogna lacerare per giungere alle cose (o al Nulla) che dietro si nascondono. La grammatica e lo stile: sono divenuti caduchi come un costume da bagno dell’epoca
Biedermaier o come l’imperturbabilità di un gentleman. Una larva. Speriamo
che venga il tempo, e già è giunto, grazie al cielo, almeno in certi circoli, in cui
il miglior uso della lingua sarà con la più alta bravura mal usarla. E poiché non
si può eliminarla d’un tratto, bisogna almeno nulla trascurare che possa contribuire al suo discredito. Trapanare in essa un buco dopo l’altro, finché ciò che si
rannicchia dietro — che sia qualcosa o nulla — cominci a trasudare, non posso
rappresentarmi compito più alto per uno scrittore d’oggi (Beckett, 1937).
Anche qui, come in Frege, opera l’attrazione per le cose, per gli
oggetti, cui giungere senza mediazioni soggettive che non sia, nel
caso del letterato, la sua singolarità universale. Lacerare il velo della
lingua, infatti, è l’equivalente dell’essere spontaneamente protesi alla
verità con cui spezziamo il dominio del linguaggio. Ma, ecco
l’inatteso e forse indesiderato “spostamento” di Beckett: lacerare il
velo della lingua è un essere protesi che può anche condurre verso il
Mente moderna e libertà politica
129
Nulla. La prospettiva di un ordine logico eternamente perfezionabile
si tramuta nel rischio estremo e imprevisto della dissolvenza
dell’essere. La logica, che nella grande mole dell’essere si era orgogliosamente ritagliata il suo mondo di pensieri puri, è attratta nella
medesima cattiva compagnia di quella poesia, sub specie letteratura,
che il poeta vuole emendare dei suoi ritardi rispetto alla capacità
sviluppata dalla musica e dalla pittura di puntare dritto alle cose:
O deve la letteratura rimanere sola su un vecchio cammino disertato dalla
musica e dalla pittura? C’è forse qualcosa di così sacro da paralizzare nella
“innaturalità” della parola, che non si troverebbe negli elementi delle altre arti?
C’è mai qualche fondamento per cui questa materialità terribilmente arbitraria
della superficie della parola non possa essere dissolta, come ad esempio la superficie del suono, inghiottita da enormi pause nere, nella 7° Sinfonia di Beethoven, che fa sì che per interi movimenti non possiamo nient’altro percepire
che un vertiginoso abisso di silenzi tesi a annodare, sul senza fondo,un sentiero
di corde sonore? (ibidem).
Questi tormentosi interrogativi dell’artista intorno alla parola
sembrano ricollegarsi a quello saussuriano: perché l’immodificabile
eredità del segno? Ma non è più il tempo della rasserenante indagine
che un nuovo naturalismo darwinianamente istruito può assicurare,
né a Beckett basta la rivolta logica contro il linguaggio: «Sul cammino dunque di una desiderabile Letteratura della non–parola, qualsiasi
forma di ironia nominalista può davvero essere uno stadio necessario
[…] Un precipite distruggere nomi, in nome della bellezza» (ibidem).
5 . L ’ IDEOLOGIA CONTEMPORANEA E LA RICOSTRUZIONE DELL’ESSERE
SOCIALE
La gnoseologia di Locke, da cui siamo partiti, esprimeva la fiducia nel potere costruttivo della conoscenza che, grazie al circolo semioetico di astrazione e di autonomia dell’individuo, diveniva una
potenza sociale per la quale si sarebbero man mano aperte possibili-
130
Capitolo VI
tà, impensate per coloro che per primi ne esploravano il territorio, di
sviluppi logici, metodologici, cognitivi, cibernetico–informatici.
Alla fine del percorso, mentre la conoscenza appare lanciata verso
le ulteriori mete della realtà virtuale, delle reti cognitive,
dell’economia informazionale, ritroviamo in Frege il bisogno di ontologia che Locke si era lasciato alle spalle. Ma tale bisogno assume
quasi la forma di un ritorno del rimosso, soddisfatto con una formazione reattiva, qual è l’ontologia dei tre regni, in cui le basi del rimosso non vengono raggiunte, e il bisogno risorge in forme più esacerbate e angosciose, sino all’ideale della distruzione estetica del
linguaggio.
Questo conflitto con l’interezza dell’essere, che segna la modernità compiuta, comprese le sue propaggini nichilistiche, lo si ritrova
nella proclamazione, appunto, del carattere di sintomo del «reale»,
che preparerebbe il prossimo «trionfo della religione» come cura per
l’individuo di cui si diagnostica lo stato patologico: «l’essere parlante è un animale malato » (Lacan, 1974/2006, p. 105). E lo si ritrova quando, a proposito del contratto sociale hobbesiano, non si parla
più di operazione di designazione, ma di «alienazione»: «il contratto
sociale rappresentava la parte di sovranità che il cittadino aliena a
beneficio dello Stato ma, ai giorni nostri, sarebbe piuttosto la parte
alienata di se stesso di cui il cittadino si sbarazza per conservare la
propria sovranità» (Baudrillard, 2004, p. 143).
Non più solo, dunque, la malattia dell’individuo, ma dell’intero
corpo sociale, con le sue molteplici conseguenze: la designazione
hobbesiana diventa un’espulsione psicotica del male che è
nell’individuo; il rappresentante, cioè l’élite politica, non è più una
entità astratta, risultato di un’operazione analitica, ma il capro espiatorio su cui, come in un rito magico, è possibile concentrare il
male di cui ciascuno è portatore; la politica, infine, diventa la totalità
del Male e della corruzione.
Non mancano certo le cause che, nello stesso programma moderno di libertà dell’individuo, hanno potuto condurre a questa sfiducia.
Nel nostro percorso, abbiamo intravisto due grandi questioni la cui
sistemazione già in Locke e in Hobbes appariva precaria: la questione del lavoro e quella del comando–obbedienza.
Mente moderna e libertà politica
131
Quanto alla prima questione, abbiamo visto che in Locke il lavoro, in quanto intelligenza storicamente situata, è condizione della libertà dell’individuo, ma anche di una sua nuova servitù nella forma
del lavoro salariato. Abbiamo anche ricordato che l’economia politica classica, soprattutto nei suoi svolgimenti critici, ha descritto le
condizioni di tale servitù, sino all’analisi del general intellect, con
cui si presagiscono gli ulteriori sviluppi cognitivi del capitale, per i
quali si parla oggi di società informazionale (Castells, 1995–2000).
D’altra parte, a queste trasformazioni interne delle strutture finalistiche autovalorizzanti, si accompagna l’affermarsi puntiforme di una
sfera di vita sociale in cui la merce, nella veste di brand o marchio
(Klein, 2000), è il simbolo stesso, la cui produzione tuttavia dà luogo
paradossalmente ad un ritorno di lavoro servile quando non schiavistico. Queste antinomie del lavoro, preso da un lato in modi di produzione sempre più autovalorizzanti, dall’altro in regressioni
pre–moderne funzionali ad un moderno sempre più stilizzato, ne corrodono il nesso originario con la libertà dell’individuo, dal quale dovrebbe trarre slancio la mente sociale. Occorre risalire, allora, alla
struttura antropologica–evolutiva del lavoro, di cui abbiamo trattato
nel capitolo quarto, per scorgere le condizioni di una possibile rimessa in moto del circolo tra astrazione e lavoro.
Ora, ciò che tale struttura antropologica–evolutiva mostra è che la
fatica del lavoro come mezzo per soddisfare bisogni è naturale nel
senso che è successiva all’esplosione dell’istinto. Nell’istinto, lavoro
e bisogno sono un tutt’uno. La scissione che l’esplosione dell’istinto
provoca, giustifica l’instaurarsi della morale nella figura del Dovere.
Questa condizione del lavoro, scisso dal bisogno e sottomesso alla
prescrizione, non è dunque atemporale e assoluta, ma costituisce un
momento della storia evolutiva. Restando all’interno di tale storia,
ciò che si impone, allora, è la ricerca dei modi per pervenire alla ricomposizione razionale dei mezzi (lavoro) con i fini (bisogno), già
spontaneamente presente nell’istinto, per farli ridiventare momenti
interni e non più scissi dell’agire umano. Una ricomposizione, ovviamente, che non potrebbe più avere la rigidità e la specializzazione
dell’istinto, ma che si realizzerebbe su di un piano di infinita combinabilità (infiniti mezzi per infiniti fini), e che soprattutto costituirebbe non una destinazione finale specularmente opposta alla condizio-
132
Capitolo VI
ne originaria, ma una sorta di ideale regolativo verso cui far tendere
incessantemente le situazioni di fatto.
Quanto all’altra questione, quella del comando–obbedienza, abbiamo visto che in Hobbes convivono, quasi senza soluzione di continuità, il modello arcaico del potere come forza e terrore, e quello
moderno del potere come totalità logica prodotta dall’operazione di
designazione. Ma se rileggiamo il testo di Hobbes, vediamo che, in
effetti, il secondo modello è, se non un modo indiretto per ottenere lo
scopo raggiunto con il primo, certo come una trasfigurazione del
primo. Da questo punto di vista, l’operazione di designazione è certamente la “tecnologia” che la semiotica mette a disposizione del nascente pensiero moderno in lotta contro le aderenze sostanzialistiche
della vecchia mente sociale. Tuttavia, in questa ricerca dell’astratto
l’effetto conseguito è, alla fine, di occultare il dato reale, cioè la salvaguardia del carattere dicotomico e asimmetrico del rapporto politico, fondato sul blocco emotivo della paura.
La tesi “materialistica” classica vuole che la mancata integrazione
del dato affettivo all’interno della nuova totalità cognitiva moderna
sia da attribuire alla struttura degli interessi, in cui la paura stessa
continua a svolgere un ruolo cruciale, sotto forma di minaccia “legale” a difesa di interessi privati. La totalità logica di Hobbes “processerebbe”, insomma, una “materialità” che ne costituisce un ostacolo evolutivo. Fondata o meno che sia tale tesi, fra gli esiti di quella
mancata integrazione c’è una “ideologia del presente” nella quale, al
posto dell’individuo che liberamente aderisce alla libertà regolata di
cui parla Locke, si pongono strutture, totalità, organismi che si autoregolano secondo le leggi di un olismo tanto equivoco quanto pervasivo: il linguaggio, il mercato, l’Impero, la società informazionale, la
natura. Tali strutture sarebbero portatrici di libertà poiché l’individuo
non sarebbe più sottoposto a costrizioni normative di sorta. Da un
lato, infatti, nella società informazionale, egli potrebbe sviluppare
indefinitamente la propria creatività, anche se poi gli stessi teorici di
tale modello di società non possono far a meno di constatare che, nei
fatti, l’informazionalismo è principalmente un mezzo di ribadire e
rafforzare la subalternità del lavoro (Castells, 1995–2000, I. cap. IV).
Dall’altro, con l’Impero, l’individuo, inglobato nella nuova soggettività della moltitudine, che all’Impero si oppone, avrebbe la possibi-
Mente moderna e libertà politica
133
lità, trascendendolo con l’esodo, di pervenire ad una nuova, più
grande, definitiva libertà (Hardt, Negri, 2000; 2004).
Tuttavia, il punto debole di tale ideologia contemporanea, a volte
irta di statistiche, a volte tinteggiata di tenui colori new age, è che le
strutture, totalità, organismi autoregolantesi, nel loro fare a meno
dell’individuo, lo riducono di nuovo, sì, a moltitudine, ma nel senso
di significato “cieco” che abbiamo sopra visto. Nell’Impero, infatti,
la possibilità di «andarsene» è illusoria, poiché la moltitudine non esiste senza l’Impero, in quanto è l’Impero che la produce, destrutturando l’individuo autonomo (Aqueci, 2003). E quanto alla società informazionale, che i suoi teorici vorrebbero attuata secondo il modello ideale dell’infinita creatività dell’individuo, essa, più che un ideale regolativo, è solo un’illusione, come essi stessi sono costretti
ad ammettere.
Di fronte a tutto ciò, piuttosto che abbandonare il programma
moderno di libertà dell’individuo, è meglio, allora, saggiarne la consistenza in una direzione resa bene da una osservazione di Antonio
Gramsci (1891–1937) quando, pur accettando il dato di fatto «tecnico» della divisione, anche all’interno di un gruppo sociale omogeneo, in governanti e governati, afferma che, nella formazione dei dirigenti, il punto da cui partire deve essere il seguente:
Si vuole che ci siano sempre governati e governanti oppure si vogliono creare le condizioni in cui la necessità dell’esistenza di questa divisione sparisca?
cioè si parte dalla premessa della perpetua divisione del governo umano o si
crede che essa sia solo un fatto storico, rispondente a certe condizioni? (Quaderni del carcere, vol. III, p. 1752).
A prima vista, può sembrare che la direzione qui proposta sia
quella di una esclusiva valorizzazione della società civile, che diverrebbe così il luogo dove le varie identità crescono e competono, lasciando al politico il ruolo marginale di rappresentare gli esclusi. È
questo l’equivoco in cui cade chi, come qualche rappresentante dei
cultural studies (Chatterjee, 2006), cercando di uscire da un’ottica
puramente occidentale, propone un modello della politica adatto alle
società un tempo colonizzate, e dove oggi è forte la resistenza, condotta in nome dell’identità, all’innesco di processi di astrazione so-
134
Capitolo VI
ciale. Ma un tale modello sarebbe in realtà solo un ritorno mascherato allo stato di natura hobbesiano, selva di identità inconciliabili,
contro cui poco potrebbe un Leviatano semplice difensore di chi non
ha identità forti da far valere.
Alla domanda di Gramsci, invece, si può rispondere imboccando
una differente direzione, che egli stesso del resto autoironicamente
suggerisce con il mito rinascimentale del Leonardo da Vinci di massa:
L’uomo moderno dovrebbe essere una sintesi di quelli che vengono… ipostatizzati come caratteri nazionali: l’ingegnere americano, il filosofo tedesco, il
politico francese, ricreando, per dir così, l’uomo italiano del Rinascimento, il
tipo moderno di Leonardo da Vinci divenuto uomo–massa o uomo collettivo
pur mantenendo la sua forte personalità e originalità individuale. Una cosa da
nulla, come vedi (Gramsci, 1965, p. 654. Lettera alla moglie Iulca, del primo
agosto 1932).
La visione, cioè, per quanto ardua, di uno sviluppo dell’astrazione
sociale, in grado di vincere le vischiosità della tradizione e delle identità. Dunque, non un ritorno al significato “cieco” dello stato di
natura, comunque giustificato, né un ritorno alla libertà arbitraria, e
perciò totalitaria, del “significante”, bensì la valorizzazione politica
integrale della mobilità del segno, tentata da Hobbes, e infrantasi sugli scogli di una emotività prigioniera della dura materialità degli
interessi.
Conclusione
Il nostro percorso, conclusosi sulla necessità di una ripresa della
matrice della mente moderna, alla quale siamo risaliti seguendo le
tracce semiotiche, si è aperto con uno sguardo sulle origini della ragione analitica, che ci ha mostrato la speranza temperata di un riformismo linguistico il quale, muovendo dall’esigenza conoscitiva di
distinguere e verificare, mirava ad affermare il valore pratico del
retto ragionare.
Ma abbiamo visto poi che presto subentra lo smarrimento in un
programma che, nato per spezzare il dominio della parola sullo spirito umano, confluisce e diventa uno dei sintomi della tragedia
dell’individuo moderno.
La passione per la ragione critica si spegne infine nel gelo analitico di una filosofia del linguaggio incapace di discernere il fondamento etico del discorso. Infatti, con le massime conversazionali di
Grice (1913–1988) declina l’impegno di tutto l’individuo nel dialogo, dal cui esercizio invece possono pur scaturire nuovi assetti sociali (Aqueci, 1995a), e si afferma la messa in scena strategica della
conversazione (Aqueci, 1995b).
Gran parte del secolo poi è segnato da uno scontro che, per ragioni politiche, vede schierate su fronti contrapposti saggezze conoscitive i cui presupposti giustificherebbero più una confluenza che un
conflitto. A questa lunga guerra intestina, che prostra il pensiero critico, nell’ultimo scorcio del millennio subentra la risorgenza del pensiero conformistico, lo sgretolamento dei livelli normativi, il misticismo dei singoli riuniti non più in corpi politici ma nelle nuove mol135
136
Conclusione
titudini, quelle virtuali, che vagano nelle reti informatiche, autoriproducendo i propri demoni con tecnologie prêt–à–porter, e quelle
che, in un arcaismo di ritorno, accrescono l’audience dei pulpiti tradizionali e delle televisioni globali.
Di fronte a questo paesaggio di patti sociali falliti e di stati di natura qui e là risorgenti, le sorti della ragione sembrano sempre più affidate al crescere delle conoscenze e delle metodologie scientifiche,
le quali però non sono né neutre, né immediatamente disponibili.
La scienza si presenta come una potenza cognitiva dallo sviluppo
casuale e illimitato. Questo sviluppo di tipo darwiniano non è una
freccia nel vuoto, ma si lega alle strutture finalistiche autovalorizzanti, che vedono così accentuata la loro tendenza a misurare e manipolare l’esistenza degli individui.
A questo aspetto già rilevato in passato, si aggiunge quello più recente delle possibili e diverse manipolazioni dei processi vitali. Una
novità che investe tanto l’individuo quanto la specie, come dimostrano sia le dispute bioetiche sul controllo della nascita e della
morte, sia quelle sulla sostenibilità ecologica dello sviluppo.
Se l’evoluzione della scienza può dissolvere dilemmi e svelare direzioni, essa può anche distorcere le finalità dei singoli e della totalità sociale. L’evoluzione è una sintassi il cui senso è prodotto dal
comportamento dell’individuo. Alla scienza non si possono dunque
delegare gli scopi, tanto quanto l’espressività non può essere delegata alla struttura della lingua.
C’è quindi la necessità di un’analisi categoriale permanente, cioè
di una critica ontologica che controlli gli scopi che la scienza con il
suo stesso sviluppo rende possibile raggiungere, e con i quali si alimenta il processo finalistico dell’esistenza. L’ontologia diventa così,
non più un bisogno di ordine metafisico, religioso o secolare che sia,
né, come più recentemente, un supporto ad una conoscenza tecnologicamente omogeneizzata (Casati, 2003), ma il luogo del decentramento cognitivo per una visione prospettica dei processi sociali finalistici. Un luogo, tuttavia, non esterno, riservato agli “esperti”, bensì
un’istanza politica incorporata nei processi finalistici stessi, e volta
ad accrescere la libertà dell’individuo.
Una analisi categoriale di questo tipo è oggi svolta dal cosiddetto
“dibattito pubblico”, la cui conduzione, come è stato proposto, do-
Conclusione
137
vrebbe essere assicurata da una «metafisica “pubblica”», in grado sia
di riconoscere, senza pretese prescrittive, la pluralità delle opzioni
teoriche in campo, sia di riflettere sui propri strumenti linguistico–discorsivi (Maffettone, 2001). Una tale prospettiva ha il merito di
respingere il tentativo postmoderno di liquidare la nozione, per
quanto difficile, di verità. Tuttavia, non si può non riconoscere che,
al momento attuale, il “dibattito pubblico” è più un’arena di dispute
che trasfigurano antagonismi profondi (Aqueci, 2006), che il luogo
in cui tradurre criticamente posizioni particolari in consapevolezze
universali. Ciò dipende probabilmente dal fatto che il distacco degli
individui dalle matrici ancestrali, che un integrale controllo categoriale richiederebbe, si presenta attualmente come una richiesta cognitiva troppo onerosa.
D’altra parte, la posizione “post–illuministica”, intesa come una
procedura nella quale le varie concezioni del mondo, fra le quali
quella di derivazione scientifica, convivono in ascolto reciproco,
autoriflessivamente coscienti dei propri limiti, viene presentata come
l’esito finale di una ragione colpevolmente auto–concepitasi come
potenza (Habermas, 2005). In una visione meno contrita, e che tenga
conto realisticamente del peso del controllo categoriale, tale posizione può essere vista come quella tatticamente più adatta a preservare
le potenzialità evolutive di una ragione decentrata da luoghi e storie
particolari, e che, arginata la paura, voglia tornare a dettare nuove
norme in grado di superare l’odierna eterogeneità cognitiva.
In quest’ottica, è cruciale chiarire se l’apprendimento dei principi
procedurali è indipendente dall’apprendimento di una visione razionale del mondo, se cioè la forma del dialogo ragionevole è indipendente dai contenuti di una visione laica e immanente, altrettanto
quanto, del resto, può esserlo da una visione religiosa fondata
sull’amore del prossimo.
È qui che può acquistare rilievo la struttura del rispetto, messa in
evidenza dall’indagine semioetica, le cui trasformazioni conducono
all’apprendimento formale della norma di cooperazione, che condiziona performativamente la vita dell’individuo, in virtù del legame
con l’affettività originaria.
Tale apprendimento coordina entità originariamente eterogenee:
chi crea e può dare ordini; chi è creato e deve riceverli. Il rispetto u-
138
Conclusione
nilaterale valorizza la capacità di obbedire, esemplificata dalla leggenda biblico–cabbalista del Golem, che il futurismo novecentesco
ha rivisitato con il mito della Macchina Universale. Ma il Golem,
creato dalla parola rituale magica, è passivamente muto (Idel, 1990),
mentre la parola mediatrice della madre introduce attivamente
l’infante nel circuito discorsivo della norma.
D’altra parte, anche i primi informatici alle prese con la mente artificiale che stavano creando, avevano già chiaro che la disciplina da
sola non basta a produrre ragione, e che è richiesta in aggiunta ciò
che chiamavano iniziativa (Turing, 1948). Ora, di iniziativa dà prova
con la sua resistenza colui che è stato creato, imponendo per così
dire al creatore il rispetto reciproco, che deriva dalla sua crescente
autonomia. Se l’infante all’inizio appare un tenero Golem, o una
malleabile Macchina Univerale, che alcuni addirittura vorrebbero
determinare geneticamente, con tale resistenza, in qualche modo attesa da chi lo ha affettuosamente creato, egli dà vita ad una dialettica
della libertà fondata sull’irriducibilità di chi è posto agli schemi di
chi pone.
Tale irriducibilità non è un passivo resistere, bensì un attivo rispondere a delle alternative che si traducono in “scelte, pena la rovina”. Il rispetto rimanda, dunque, al dato ontologico di fondo, cioè
all’essere che per adattarsi pone scopi. In questa completa trasparenza di ciò che l’essere è, risalta la scelta di base, già espressa nel mito
greco di Hestia ed Hermes, tra la quiete del conosciuto, e la sfida
dell’ignoto, tra il ripiegare sull’identico e l’aprirsi al molteplice, tra
lo stato di fatto e l’ideale regolativo che guida la prassi.
La scelta di base, nel crescere su se stessa dentro una forma orientata alla reciprocità, resta dunque sempre aperta a quel kantiano
regno dei fini in cui tutti, essendo legislatori, sono capi, ovvero capaci di controllo categoriale. L’apprendimento formale della norma
di reciprocità, allora, è solo il momento “liberale” di un’evoluzione
che nel suo stato presente è “post–illuministica”, ma la cui storia non
è conclusa, e il cui orizzonte, al suo estremo limite, mai esauribile
senza per questo essere un miraggio, è quello nel quale non c’è più
l’ansia di un senso da ricercare: «Quando egli considerando la pluralità de’ mondi perde quasi se stesso nel pensiero della immensità
delle cose, e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile
Conclusione
139
dell’esistenza, allora con questo atto e con questo pensiero egli dà la
maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua mente».
Bibliografia
Aqueci, Francesco, La nozione kantiana di rispetto da Bovet a Piaget, «Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di
Messina», 7, 1989, pp. 605–621, ora in Aqueci, 2003
Id., I problemi del linguaggio secondo
ne–Frankfurt/M.–New York, Peter Lang, 1991
Pareto, Ber-
Id., The Embarrassment of Communication from Mandeville to Grice, in L. Formigari, D. Gambarara (ed. by), Historical Roots of Linguistic Theories, Benjamins, Amsterdam, 1995 (a), pp. 203–219
Id., Argumentation et dialogue: le problème de la comprehension
dans les échanges socio–discursifs, «L’Année sociologique», 45,
1995 (b), n. 1, pp. 11–34
Id., Quale razionalità limitata per la morale. La genesi delle norme
in Jean Piaget, in «Politeia», XIII, 46, 1997, pp. 48–55, ora in Aqueci, 2003
Id., Una semioetica tra Vailati e Gramsci, in «Segno», XXIV, n.
194–195, aprile–maggio 1998, pp. 51–64
141
142
Bibliografia
Id., Testi, norme, sistema sociale. La problematica dell’equilibrio in
Pareto, «Revue Européenne des Sciences Sociales», t. XXXVII,
1999, n. 116, pp. 237–243
Id., Diritto, morale e discorso in Pareto, in C. Malandrino, R. Marchionatti, Economia, sociologia e politica nell’opera di Vilfredo Pareto, Firenze, Olschki, 2000, pp. 313–328
Id., Il fondamento linguistico della scienza in Vailati, in M. De Zan,
(a c. di), I mondi di carta di Giovanni Vailati, Milano, Angeli, 2000
(a), pp. 131–140
Id., Linguaggio, morale ed evoluzione sociale nella collaborazione
di Giovanni Vailati alla “Riforma sociale”, in C. Malandrino, (a cura di), Una rivista all’avanguardia. La "Riforma sociale”.
1894–1935, Firenze, Olschki, 2000 (b), pp. 171–187
Id., Ordine e trasformazione. Morale, mente discorso in Piaget, Acireale–Roma, Bonanno, 2003
Id., La sémiologie de Piaget entre Peirce et Saussure, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 2004, 56, pp. 193–212, con una nota a commento di J.P. Bronckart, Le sémiotique comme condition de
l’intelligence humaine. Commentaire de F. Aqueci, La sémiologie de
Piaget entre Peirce et Saussure, pp. 213–224
Id., Matrici e significato del dibattito bioetico, «Critica marxista», n.
3–4, maggio–giugno 2006, pp. 87–94
Aristotele, Dell’espressione, in Opere, Bari, Laterza, 1982, vol. I,
pp. 49–81, tr. it. Gigante–Colli
Id., Politica, in Opere, Bari, Laterza, 1983, vol. IX, tr. it. di R. Laurenti
Austin, J. L., Quando dire è fare, (1962), Milano, Marietti, 1974,
[nuova tr. it. Come fare cose con le parole. Milano, Marietti, 1987]
Bibliografia
143
Bachtin, Mikhail, Per una filosofia dell’azione responsabile,
(1920–24), Lecce, Manni, 1998
Id., La parola nel romanzo, (1934–35), in Id., Estetica e romanzo,
Torino, Einaudi, 1979, pp. 67–230
Bara, Bruno G., Pragmatica cognitiva, Torino, Bollati–Boringhieri,
1999
Barthes, Roland, Saussure, le signe, la démocratie, in «Le discours
social», nn. 3–4, aprile 1973, pp. 84–87
Baudrillard, Jean, Il patto di lucidità o l’intelligenza del Male,
(2004), Milano, R. Cortina, 2006
Beckett, Samuel, Come le pause nere di Beethoven, titolo redazionale di una lettera redatta in tedesco nel 1937 e edita in “Disiecta”,
London, 1983. Traduzione italiana di Christine Jacquet–Pfau e Carlo
Ossola. © Estate Samuel Becket–John Calder, London. Pubblicata in
“Il Domenicale del Sole 24–Ore”, 12 marzo 2006.
Bentham, Jeremy, Il libro dei sofismi, (1824), Roma, Editori Riuniti,
1981, tr. e cura di Lia Formigari
Benveniste, Émile, Problèmes de linguistiques générales, 2, Paris,
Gallimard, 1974
Bergson, Henri, Les deux sources de la morale et de la religion,
(1932), Paris, Presses Universitaires de France, 1990
Borutti, Silvana, Perissinotto, Luigi, Il terreno del linguaggio. Testimonianza e saggi sulla filosofia di Wittgenstein, Roma, Carocci,
2006
Bovet, Pierre, Les conditions de l’obligation de conscience,
«L’année psychologique», XVIII, 1912, pp. 55–120
144
Bibliografia
Calogero, Guido, L’abbiccì della democrazia, (1946), Reggio Emilia, Diabasis, 2001, pp. 9–37
Id., Lezioni di Filosofia, I: Logica, (1948),Torino, Einaudi, 1960
Id., Lezioni di Filosofia, II: Etica, (1946), Torino, Einaudi, 1960
Id., Lezioni di Filosofia, III: Estetica, (1947), Torino, Einaudi, 1960
Id., Logo e dialogo, Milano, Edizioni di Comunità, 1950
Casati, Roberto (a cura di), Ontologie, numero monografico di «Sistemi Intelligenti», anno XV, numero 3, dicembre 2003
Caserta, Caterina, Saussurismo e scrittura della storia (e altro), «La
Critica Sociologica», 153.primavera 2005, gennaio–marzo, pp.
12–21
Castelfranchi, Cristiano, Come studiare la mente (per quello che è),
«Sistemi intelligenti», XII, 1, 2000
Castells, Manuel, L’età dell’informazione, (1995–2000), Milano, Università Bocconi Editore, voll. 3: vol. I, La nascita della società in
rete, 2002; vol. II, Il potere delle identità, 2003–2004; vol. III, Volgere di millennio, 2003
Changeux, Jean–Pierre, L’uomo di verità, (2002), Milano, Feltrinelli,
2003
Chatterjee, Partha, Oltre la cittadinanza, Roma, Meltemi, 2006
Colletti, Lucio, Ideologia e società, Bari, Laterza, 1969
Coseriu, Eugenio, Teoria del linguaggio e linguistica generale,
(1952), Roma–Bari, Laterza, 1971, a c. di R. Simone e L. Ferrara
degli Uberti
Bibliografia
145
Id., Sincronia, diacronia e storia, (1958), Torino, Boringhieri, 1981,
a c. di P. Mara
De Anna, Gabriele, La naturalezza della politica. Il (possibile) contributo di Aristotele alla riflessione politica anglo–americana, «Fenomenologia e Società», 1/2006, XXIX, pp. 107–134
Dal Pra, Mario, Introduzione a G. Vailati, Epistolario, Torino, Einaudi, 1971, pp. XXVII–LVIII
De Mauro, Tullio, Introduzione alla semantica, (1965), Bari, Laterza, 1970
Deshpande, Madhav M., Evolution of the notion of authority (Pramanya) in the paninian tradition, in «Histoire Épistemologie Langage», 20/1, 1998, pp. 5–28.
Della Volpe, Galvano, La filosofia dell’esperienza di David Hume,
(1935), in Opere, cit., vol. II
Id., Fondamenti di una filosofia dell’espressione, (1936), in Opere,
Roma, Editori Riuniti, 1973, voll. 6, a c. di I. Ambrogio, vol. III, pp.
9–53
Id., Critica dei principi logici, (1942), in Opere, cit., vol. III, pp.
135–266
Id., Critica del gusto, (1963), , in Opere, cit., vol. VI, pp. 9–263
Dogana, Fernando, Il pensiero di G.B. Vico alla luce delle moderne
dottrine psicologiche, «Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria», 31 (1970), fasc. 4, pp. 514–530
Eco, Umberto, Segno, Milano, Isedi, 1973
Id., Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani , 1975
146
Bibliografia
Edelman, Gerald M., Tononi, Giulio, Un universo di coscienza, Torino, Einaudi, 2000
Fabbri, Paolo, La svolta semiotica, Bari, Laterza,1998
Fadda, Emanuele, Lingua e mente sociale. Per una teoria delle istituzioni linguistiche a partire da Saussure e Mead, Acireale–Roma,
Bonanno, 2006
Frege, Gottlob, Ideografia, un linguaggio in formule del pensiero
puro, a imitazione di quello aritmetico, (1879), in Id., Logica e aritmetica, Torino, Boringhieri, 1965, a cura di C. Mangione, pp.
103–126
Id., Senso e denotazione, (1892), in A. Bonanni, (a cura di), La
struttura logica del linguaggio, Milano, Bompiani, 1973, pp. 9–32
Id., Il pensiero. Una ricerca logica, (1918–1919), in Id., Ricerche
logiche, Milano, Guerini e Associati, 1988, pp. 43–74
Gallese, Vittorio, La consonanza intenzionale: meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettività, «Sistemi intelligenti», n. 3, dicembre
2005, pp. 353–382
Gambarara, Daniele, La mente collettiva. Per una lettura del terzo
corso come teoria delle istituzioni sociali, «Forme di vita», Roma,
Derive/Approdi, 2005, pp. 173–181
Id., Il posto delle istituzioni, Postfazione a Fadda, 2006, pp. 217–231
Gash, Hugh, Glaserfeld, Ernst von, Vico (1668–1744): An early anticipator of radical constructivism, «The Irish Journal of Psychology», 1978, iv, 1, pp. 22–32
Gazzaniga, Michael, S., La mente etica, (2005), Torino, Codice Edizioni, 2006
Bibliografia
147
Glaserfeld, Ernst von, Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, Milano, Clup, 1989
Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, 1975, ed.
critica in 4 voll. a c. di V. Gerratana
Id., Lettere dal carcere, Torino, Einaudi, 1965
Habermas, Jürgen, Tra scienza e fede, (2005), Roma–Bari, Laterza,
2006
Hardt, Michael, Negri, Antonio, Impero, (2000), Milano, Rizzoli,
2002
Hardt, Michael, Negri, Antonio, Moltitudine, Milano, Rizzoli, 2004
Hobbes, Thomas, Leviatano, (1651), tr. it. di G. Micheli, Firenze, La
Nuova Italia, 1976
Iacoboni, Marco, Imitazione: meccanismi neurali e cognitivi, «Sistemi Intelligenti», a. XV, n. 1, aprile 2003, pp. 149–174
Idel, Moshe, Golem, (1990),Torino, Einaudi, 2006
Izzo, Francesca, Forme della modernità. Antropologia, politica e teologia in Th. Hobbes, Roma–Bari, Laterza, 2005
Kant, Immanuel, Fondazione della metafisica dei costumi, (1785), tr.
it. a cura di P. Chiodi, Bari, Laterza, 1988,
Id., Antropologia pragmatica, (1798), Bari, Laterza, 1985, tr. it. di
G. Vidari, riveduta da A. Guerra
Klein, Naomi, No logo, (2000), Milano, Baldini & Castoldi, 2001
Lacan, Jacques, Scritti, Torino, Einaudi, 1974, voll. 2
148
Bibliografia
Id., Dei Nomi–del–Padre seguito da Il trionfo della religione, (1963;
1974), Torino, Einaudi, 2006
Livret, Pierre, L’etica: al di là della forma logica, od orizzonte delle
regole d’inferenza?, in S. Borutti, L. Perissinotto, 2006, pp. 145–151
Locke, John, Saggio sull’intelletto umano, (1690), Torino, UTET,
1971
Id., Secondo trattato sul governo, (1690), in Due trattati sul governo
e altri scritti, Torino, UTET, 19823, pp. 227–412
Lukács, György, Estetica, (1963), Torino, Einaudi, 1970, voll. 2
Id., Prefazione a Storia e coscienza di classe, (1967), Milano, Sugar
Editore e Mondadori, 1967 e 1973, pp. XXV–LXI
Id., Le basi ontologiche del pensiero e dell’attività dell’uomo,
(1969), in L’uomo e la rivoluzione, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp.
19–43
Id., Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale, (1970), Milano,
Guerini & Associati, 1990
Maffettone, Sebastiano, Etica pubblica. La moralità delle istituzioni
nel terzo millennio, (2001), Milano, Il Saggiatore, 2006
Marx, Karl, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica («Grundrisse»), (1857–1858), Torino, Einaudi, 1976
Mayr, Ernst, The Idea of Teleology, «Journal of The History of Ideas», vol LIII, january–march 1992, n. 1, pp. 117–135, ora in Id.,
What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy of a
Scientific Discipline, (2004), tr. it. Milano, Cortina, 2005, pp. 41–67
Id., Il modello biologico, (1997), Milano, McGraw–Hill, 1998
Bibliografia
149
Meltzoff, A. N., Prinz, W., The imitative mind, Cambridge, Cambridge University Press, 2002
J. Molino, Saussure et l’économie, in «Revue Européenne des Sciences Sociales», t. XXII, 1984, n. 66, pp. 145–161
Mora, George, Vico, Piaget e l’epistemologia genetica, in Tagliacozzo, Giorgio, (a cura di), Giambattista Vico e Galiani, Joyce, Lévi–straus, Piaget, Roma, Armando, 1975, pp. 173–218
Napoleoni, Claudio, Discorso sull’economia politica, Torino, Boringhieri, 1985
Pareto, Vilfredo, TSG = Trattato di sociologia generale, (1916), Torino, UTET, 1988, voll. 4, edizione critica a cura di G. Busino
Peirce, Charles S., CP = Collected Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1931–1958, voll. I–VIII in 5 tomi, a cura di
Ch. Hartshorne, P. Weiss, A. Burks (Il numero arabo citato nel testo
indica i paragrafi numerati progressivamente cui, quando è il caso,
viene fatto corrispondere la traduzione italiana dei testi compresi
nella silloge di cui alla voce bibliografica successiva)
Id., Opere, Milano, Bompiani, 2003
Piaget, Jean, Il linguaggio e il pensiero del fanciullo, (1923), Firenze, Giunti Barbèra, 1978
Id., La rappresentazione del mondo nel fanciullo, (1926), Torino,
Boringhieri, 1966
Id., Deux types d’attitudes religieuses: Immanence et Trascendence,
Genève, Association chrétienne d’étudiantes de Suisse romande,
1928
Id., Il giudizio morale nel fanciullo, (1932), Firenze, Giunti–Barbèra,
1972
150
Bibliografia
Id., La formazione del simbolo nel bambino, (1945), Firenze, La
Nuova Italia, 1972
Id., La psychologie de l’intelligence, (1947), Paris, Colin, 1998
Id., La causalità secondo E. Meyerson, in J. Piaget, et alii, Le teorie
della causalità, (1971), Torino, Einaudi, 1974, pp. 161–217
Id., Inconscient affectif et inconscient cognitif, (1971), in J. Piaget,
Problèmes de psychologie génétique, Pris, Denoël/Gaunthier, 1972,
pp. 7–24
Id., La prise de conscience, Paris, PUF, 1974
Id., Studi sociologici, (1977), Milano, Angeli, 1989
Piaget, Jean, Inhelder, Bärbel, La psicologia del bambino, (1966),
Torino, Einaudi, 1970
Polany, Karl, La grande trasformazione, (1944), Torino, Einaudi,
1974 e 2000
Popper, Karl Raimund, La società aperta e i suoi nemici, (1943),
Roma, Armando, 1973, voll. 2
Id., Congetture e confutazioni, (1969), Bologna, il Mulino, 1972
Rawls, John, Una teoria della giustizia, (1971), Milano, Feltrinelli,
1982
Recalcati, Massimo, Introduzione alla psicoanalisi contemporanea,
Milano, B. Mondadori, 1996
Ricoeur, Paul, La memoria, la storia, l’oblio, (2000), Milano,
R.Cortina, 2003
Bibliografia
151
Rizzolatti, Giacomo, Sinigaglia, Corrado, So quel che fai. Il cervello
che agisce e i neuroni specchio, Milano, Cortina, 2006
Rizzolatti, Giacomo, Fogassi, Leonardo, Gallese Vittorio, Specchi
nella mente, «Le Scienze», 460/dicembre 2006, pp. 54–61
Rose, Steven, Il cervello del XXI secolo, (2005), Torino, Codice Edizioni, 2006
Rosnow, Ralph, L., The prophetic vision of Giambattista Vico: implications for the state of social psychological theory, «Journal of
Personality and Social Psychology», 1978, vol. 36, n. 11, pp.
1322–1331
Rossi Landi, Ferruccio, Il linguaggio come lavoro e come mercato,
(1968), Milano, Bompiani, 2003
Saussure, Ferdinand de, CLG = Corso di linguistica generale,
(1916), Bari, Laterza, 1970, Introduzione, traduzione e commento di
T. De Mauro
Saussure, Ferdinand de, CLG Payot = Cours de linguistique générale, (1916), Paris, Payot, 1973, édition critique préparée par Tullio
De Mauro
Id., Cours de linguistique générale, Wiesbaden, voll. 4, edizione critica a cura di R. Engler
Id., La lingua e l’opera dell’intelligenza collettiva. Due lezioni del
terzo corso di linguistica generale (1910–1911), «Forme di vita»,
Roma, Derive/Approdi, 2005, pp. 165–172, con introduzione e presentazione di D. Gambarara
Scarpelli, Uberto, Etica senza verità, Bologna, Il Mulino, 1983
Id., Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali, Milano, Giuffré,
1981
152
Bibliografia
Scholem, Gershom, Il nome di Dio e la teoria cabbalista del linguaggio, (1970), Milano, Adelphi, 1998
Sennett, Richard, Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali, (2003), Bologna, Il Mulino, 2004
Tagliagambe, Silvano, L’intelligenza come realtà di confine, in M.
D’Agostino, G. Giorello, S. Veca, (a c. di), Logica e politica. Per
Marco Mondadori, Milano, Il Saggiatore/Fondazione Mondadori,
pp. 255–286
Tertulian, Nicolas, Nicolai Hartmann et Georg Lukács. Une alliance
féconde, «Archives de philosophie», 2003, 46, pp. 663–698
Id., De la méthode ontologico–génétique en philosophie, manoscritto
inedito, 2004
Turing, Alan, Intelligent Machinery, (1948) in Turing, Alan M., The
Collected Works, Amsterdam–London, North–Holland, 1992, vol. I,
Mechanical Intelligence, pp.100–140
Vailati, Giovanni, Epistolario, Torino, Einaudi, 1971
Id., Scritti, Bologna, A. Forni Editore, 1987, voll. 3
Xingjian, Gao, La Montagna dell’Anima, Milano, Rizzoli, 2002
AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI
Area 01 – Scienze matematiche e informatiche
Area 02 – Scienze fisiche
Area 03 – Scienze chimiche
Area 04 – Scienze della terra
Area 05 – Scienze biologiche
Area 06 – Scienze mediche
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie
Area 08 – Ingegneria civile e Architettura
Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 12 – Scienze giuridiche
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Area 14 – Scienze politiche e sociali
Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su
www.aracneeditrice.it
Finito di stampare nel mese di settembre del 2011
dalla « Ermes. Servizi Editoriali Integrati S.r.l. »
00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15
per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma