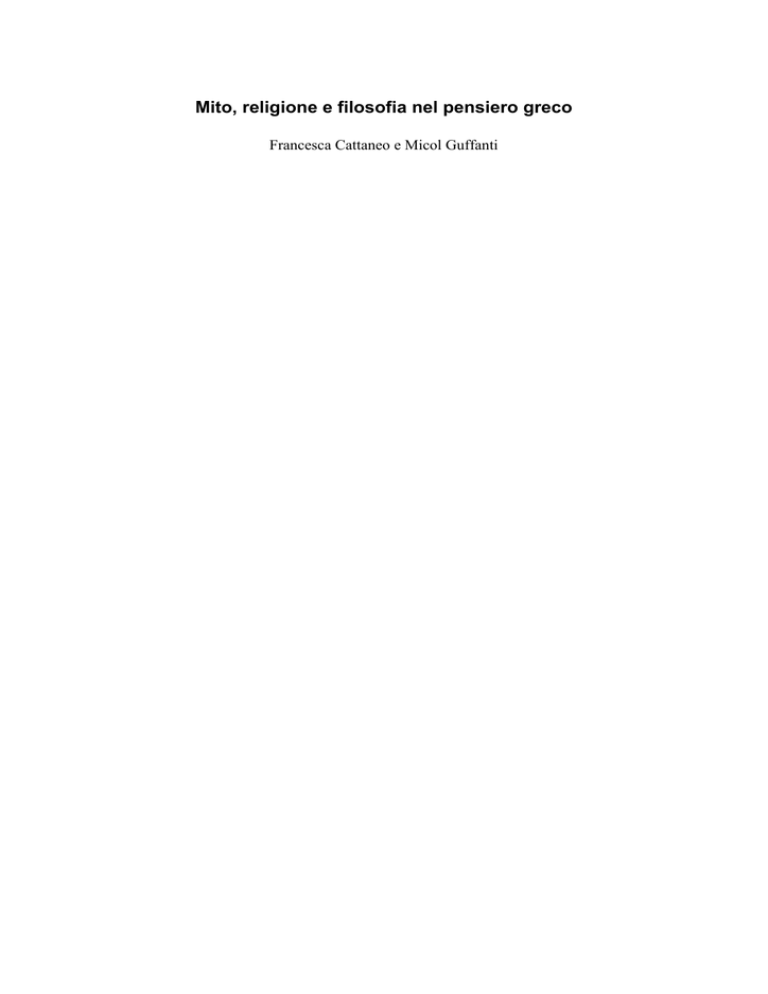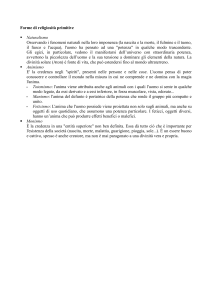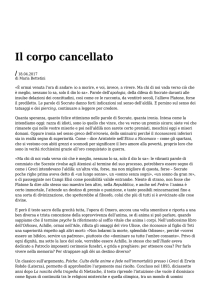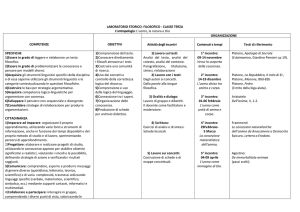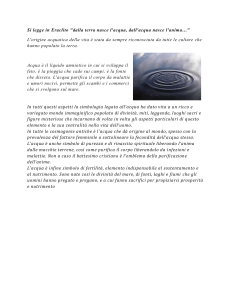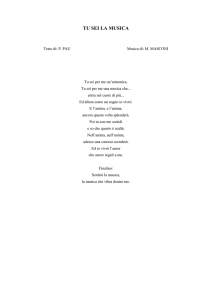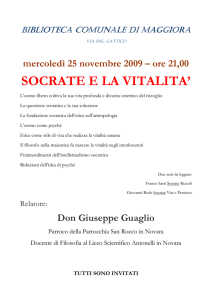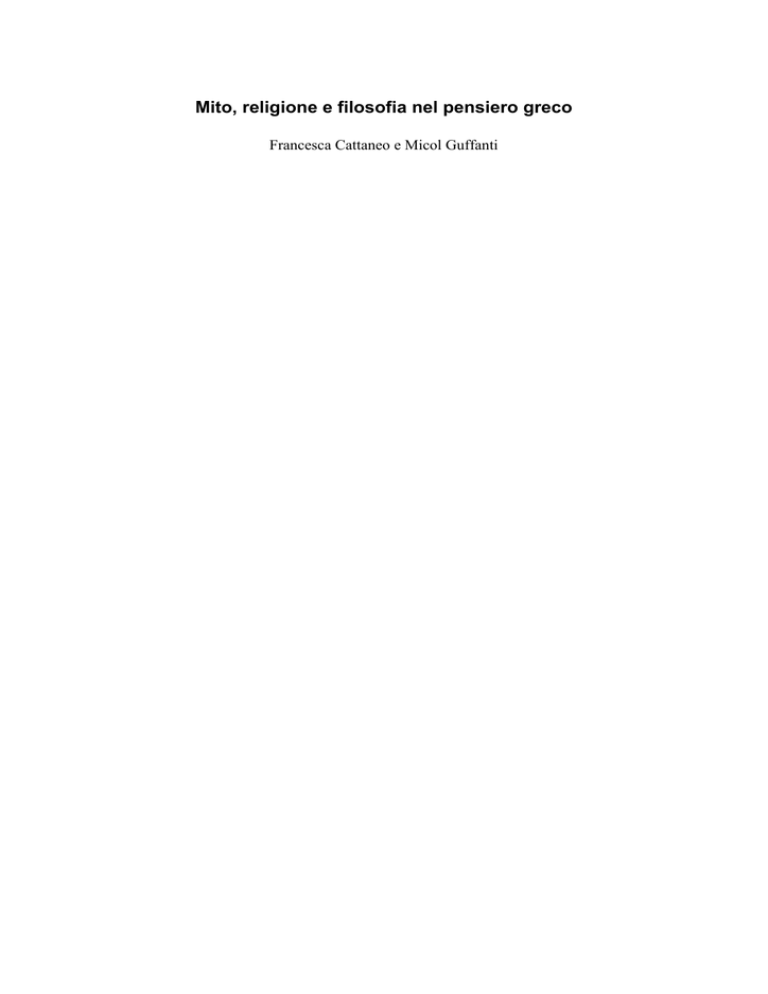
Mito, religione e filosofia nel pensiero greco
Francesca Cattaneo e Micol Guffanti
Parte prima: Orfismo: mito, religione e filosofia [lezioni 1- 5]
Lezione n. 1: Concezione dualistica dell’uomo
La parola greca psyché si riferisce a un’area semantica piuttosto ampia (può essere tradotta, a
seconda del contesto, con anima, vita, spirito, coscienza; tra i suoi significati c’è anche quello
di farfalla), che ha subìto significative trasformazioni storiche:
•
•
•
•
•
in Omero corrisponde all’immagine che si allontana dal cadavere di un defunto per
raggiungere l’Ade, all’ombra spettrale con la quale si indica la persona nel suo “non
essere più”;
le testimonianze del VI e del V secolo mostrano una trasformazione nell’uso del termine
psyché, impiegato per indicare la personalità del vivente, particolarmente per quanto
riguarda gli aspetti emotivi: è la sede del coraggio, dell’angoscia, della passione e della
pietà e, raramente prima di Platone, della ragione;
fra la psyché così concepita e il corpo non sussiste nessuna conflittualità: la psyché
rappresenta il principio vitale (letteralmente soffio, da psychéin, soffiare) intimamente
connesso al corpo e ai suoi movimenti;
questa concezione naturalistica viene approfondita dai filosofi della natura del VI secolo,
che identificano la psyché con l’arché, il principio cosmico della vita e del movimento:
così la psyché è per Anassimene essenzialmente aria, per Eraclito fuoco, per Filolao e il
tardo pitagorismo armonia;
occasionalmente, specie nei testi degli autori tragici, la psyché si presenta come organo
della coscienza e le si attribuisce una specie di intuizione non razionale: un bambino può
afferrare con la psyché qualche cosa di cui non può avere conoscenza razionale; ha una
psyché divina non chi è più intelligente o virtuoso, ma il veggente; si immagina che la
psyché abiti in qualche profondità dell’organismo e di lì possa parlare a chi la possiede,
con voce propria.
Per quanto la terminologia psicologica in uso nel V secolo risulti piuttosto confusa (è ormai
completamente sovvertito il vocabolario omerico), appare chiaro che, se anche l’idea di
psyché può evocare un vago sentore di soprannaturale, l’anima non è considerata affatto
prigioniera del corpo: è piuttosto il principio vivificante il corpo, nel quale quindi si trova
come a casa propria.
Accanto a questa concezione naturalistica della psyché si viene però formando una diversa
nozione di anima, implicante un rigido dualismo anima-corpo.
Proprio il dualismo fra anima (psyché) e corpo costituisce l’asse portante della religiosità
orfica, così detta perché ispirata alla figura del leggendario cantore tracio Orfeo, al quale
vengono attribuite le dottrine e gli scritti che costituiscono il riferimento per questa forma di
spiritualità.
Si tratta di una corrente religiosa molto lontana dalla religione “pubblica” della pòlis e legata
piuttosto alla sfera dei culti misterici per la centralità accordata al problema della salvezza
personale. Le testimonianze più antiche riconducibili alla corrente religiosa orfica sono del VI
sec. a.C.; è molto difficile stabilirne con certezza i caratteri, specialmente considerando che le
testimonianze dirette (laminette e terracotte funerarie) sono successive e le opere integrali
tramandate come orfiche sono falsificazioni di età tardo-antica e quindi circa di un millennio
posteriori alle origini dell’orfismo.
Tramite le testimonianze indirette è tuttavia possibile enucleare alcuni caratteri distintivi delle
credenze legate al movimento orfico e coglierne l’originalità rispetto alla cultura greca
tradizionale e insieme la pesante ricaduta sulla trasformazione di quella stessa cultura.
Per seguire le tracce di questa alternativa matrice di significati, che Rohde ha chiamato “una
goccia di sangue estraneo nelle vene dei Greci”, occorre rifarsi alla prima testimonianza
significativa in questa direzione, quella del poeta Pindaro, che trova riscontri terminologici e
concettuali in Senofonte e Aristotele.
L1- T1 Un’immagine dell’uomo che viene dagli dei
E il corpo di tutti soccombe alla morte potente.
Ma viva ancora un’immagine
rimane dell’uomo, ché sola
dagli dei viene; essa dorme,
mentre operano le membra;
ma dimostra nei sogni ai dormienti
sovente il giudizio, che avanza, di gioie e di pene.
[Pindaro, fr.116 Bowra. Traduzione di F. Sarri]
Dal testo di Pindaro (prima metà del V secolo) emergono alcuni spunti significativi circa il
problema della natura dell’anima e del suo rapporto con il corpo:
•
•
•
•
l’affermazione della sopravvivenza, dopo la morte del corpo, di una immagine
dell’uomo;
la giustificazione di tale sopravvivenza tramite il riferimento a una origine divina;
la constatazione del rapporto di proporzionalità inversa fra attività corporea e attività del
principio divino;
la sua esemplificazione con il richiamo all’esperienza dei sogni profetici.
L’immagine dell’uomo che rimane viva
Il frammento di Pindaro esprime chiaramente e nella sua originalità lo spirito della religiosità
orfica; ciononostante, per designare la psyché, si serve di una perifrasi tipicamente omerica, ossia
“l’immagine dell’uomo che rimane viva”: questa scelta linguistica richiama da vicino l’idea
dell’ombra spettrale che si allontana dal cadavere per recarsi nell’Ade, tipica dell’epica
tradizionale. Gli Orfici possono sussumere nella loro idea di psyché quella omerica di soffio vitale
che al momento della morte abbandona l’uomo, per quanto sia apparentemente incompatibile
con la divinità e immortalità dell’anima: infatti la psyché orfica presenta delle caratteristiche che ne
consentono l’accostamento alla “immagine dell’uomo” di Omero. Anche la psyché divina non è
che “immagine dell’uomo”: non partecipa alle attività dell’uomo che vive, sente, pensa, ma svolge
una attività propria che può realizzare pienamente solo quando allenta i legami con il corpo; la
sua consistenza si avvicina dunque molto a quella dello spettro omerico, la cui identità consiste
propriamente nel “non essere più” dell’uomo cui pure apparteneva.
L1- T2 Manifestazioni del divino nell’anima
Io per mio conto, o figlioli, non sono mai riuscito a persuadermi di questo: che
l’anima, finché si trova in un corpo mortale, viva; quando se ne è liberata, muoia.
Vedo infatti che l’anima rende vivi i corpi mortali per tutto il tempo in cui vi risiede.
E neppure mi sono mai persuaso che l’anima sarà insensibile, una volta separata dal
corpo, il quale è insensibile. Anzi, quando lo spirito si è separato dal corpo, allora,
che è sciolto da ogni mescolanza e puro, è logicamente sensibile più di prima.
Allorché il corpo dell’uomo si dissolve, si vedono le singole parti raggiungere gli
elementi della loro stessa natura, ma non l’anima: essa sola, presente o assente, sfugge
alla vista. Osservate poi, - proseguì,- che nessuno degli stati umani è più vicino alla
morte del sonno: e l’anima umana allora meglio che mai rivela con chiarezza la sua
natura divina, allora prevede il futuro, senza dubbio perché allora è più che mai
libera.
[Senofonte, Ciropedia, VIII, 7, 21. Traduzione di C. Carena]
L’esposizione in prosa di Senofonte sembra ribadire le idee essenziali del brano di Pindaro,
con alcune importanti precisazioni.
In essa troviamo:
•
•
•
•
•
la sottolineatura del rapporto di stretta intimità fra anima e corpo;
ciononostante, la convinzione che un diverso destino li attenda, dopo la loro separazione:
il corpo, insensibile, si dissolve e le parti che lo costituiscono raggiungono gli elementi
della loro stessa natura; l’anima è logicamente più sensibile di prima e sfugge alla vista;
quindi, la sottolineatura della proporzionalità inversa fra attività corporea e psichica;
il richiamo alla natura divina dell’anima umana;
l’accostamento morte-sonno e l’esempio del sogno profetico.
L1- T3 Dall’anima al divino
Aristotele diceva che la nozione degli dei ha avuto origine negli uomini da due fonti:
dagli avvenimenti concernenti l’anima e dai fenomeni celesti. Dagli avvenimenti
concernenti l’anima a cagione delle ispirazioni che questa ha nei sogni e nelle
profezie. Quando infatti, egli dice, nel sonno l’anima viene ad essere per sé, allora,
assunta la sua propria natura, essa prevede e predice le cose future. Tale essa è anche
nel separarsi dai corpi al momento della morte. Pertanto [Aristotele] approva anche il
poeta Omero per il fatto che ha notato questo: ha infatti rappresentato Patroclo che,
nel venire ucciso, predice l’uccisione di Ettore e Ettore la morte di Achille. Da questi
avvenimenti, egli dice, gli uomini furono indotti a supporre che esista alcunché di
divino simile per se stesso all’anima e il più capace fra tutti di avere
scienza.[Aristotele, Sulla filosofia, fr.12 a Ross. Traduzione di G. Giannantoni]
Oltre che dall’osservazione dei fenomeni celesti, la nozione degli dei è collegata da Aristotele
all’esperienza psichica. Come la contemplazione del cielo, l’esperienza coscienziale è alla
portata di ciascun uomo. A garantirne l’interpretazione è chiamato Omero, l’autorità per
eccellenza; la testimonianza del poeta, però, riguarda soltanto la capacità profetica della
psyché dei morenti, non il passaggio fondamentale concernente il legame con il divino, che
non poteva trovare riscontro nell’Iliade né nell’Odissea, in quanto propriamente estraneo alla
mentalità arcaica veicolata da quei testi. L’aggancio a Omero è in realtà una rilettura del poeta
alla luce di uno schema di pensiero più complesso:
•
•
•
•
nei sogni e nelle profezie l’anima umana è ispirata e prevede e predice le cose future;
ciò accade in virtù del fatto che nel sonno l’anima viene a essere per sé e assume la sua
propria natura;
le stesse condizioni si verificano quando l’anima si separa dal corpo al momento della
morte, come attestano i poemi omerici;
il divino è qualcosa di simile per se stesso all’anima.
La matrice dei nuovi significati dell’idea di psyché legati al dualismo anima-corpo e la
ragione del radicale capovolgimento del concetto omerico ma anche naturalistico di psyché è
rappresentata dalla idea dell’origine divina dell’anima. Si incomincia così a parlare della
presenza, nell’uomo, di una scintilla divina e immortale, proveniente dagli dei e situata nel
corpo; dal momento però che la sua natura è decisamente antitetica a quella del corpo, può
essere veramente se stessa quando i vincoli con il corpo si allentano, quindi quando il corpo
dorme oppure si appresta a morire.
Questa nozione di psyché pare non potersi ricollegare alla religione popolare dei Greci,
quanto piuttosto alle speculazioni dei teologi o “sapienti”, le cui figure (Abaris, Aristea,
Ermotimo, Epimenide, Ferecide) richiamano echi della tradizione sciamanica originatasi nel
mondo scitico, come anche delle credenze indoiraniche sull’immortalità. Tali credenze
sembrano passare nei misteri, nelle sette religiose chiuse dedite al culto di Dioniso e, in epoca
coeva alla nascita della filosofia greca, nell’orfismo.
Lezione n. 2: Metempsicosi, colpa originaria e purificazioni
La mentalità greca interpreta le credenze sciamanistiche in senso morale: il fatto che l’anima
divina sia racchiusa in un corpo è giudicato come un castigo.
Questa interpretazione, veicolata dall’orfismo, offre una risposta convincente ad alcune
esigenze logiche, morali e psicologiche dei Greci della fine dell’età arcaica. Determinando
una significativa discontinuità rispetto alla mentalità corrente, l’orfismo non si limita ad
affermare l’esistenza di premi e castighi nell’oltretomba (solo in casi eccezionali e limitati, se
ne trova traccia anche in Omero) o a parlare di rinascita delle anime (eventualità ammessa,
anche se solo per pochi), ma estende la reincarnazione a tutte le anime senza distinzione e le
attribuisce valore morale: la reincarnazione diventa un peso anziché un privilegio ed è
funzionale a spiegare la disparità delle sorti individuali, dimostrando, come afferma un poeta
pitagorico, che “le sofferenze degli uomini sono volute da loro stessi”.
La dinamica di sviluppo è la seguente:
•
•
•
•
con lo sviluppo del concetto di moralità, si fa sempre più urgente il bisogno di
razionalizzare il senso oscuro di colpa dominante nell’età arcaica: la credenza nella
ereditarietà della colpa diventa sempre più intollerabile, mentre si pone il problema di
giustificare le sofferenze apparentemente inspiegabili degli innocenti;
secondo la dottrina orfica, non esistono propriamente anime innocenti: tutti scontano
colpe di varia gravità commesse nelle vite anteriori;
la credenza nella trasmigrazione della psyché, nota come metempsicosi, riguarda appunto
la necessità della psyché di entrare, dopo la morte, in un altro corpo per potere completare
con le sofferenze della reclusione corporea il necessario ciclo delle purificazioni;
per ciascuna anima permane dunque la validità della misura arcaica della giustizia,
secondo la quale “chi ha peccato, pagherà”; tale misura si realizza però sul metro del
tempo cosmico.
L’esistenza nel corpo è dunque per la psyché occasione di espiazione: se ne troverebbe
testimonianza nello stesso uso linguistico, che si serve di parole molto simili per indicare il
corpo (sòma) e la tomba (uno dei significati di séma):
L2- T1 La tomba dell’anima
Difatti alcuni dicono che il corpo è tomba [séma] dell’anima, quasi che essa vi sia
presentemente sepolta: e poiché d’altro canto con esso l’anima esprime [semàinei]
tutto ciò che esprime, anche per questo è stato chiamato giustamente “segno” [séma].
Tuttavia mi sembra che siano stati soprattutto i seguaci di Orfeo ad aver stabilito
questo nome, quasi che l’anima espii le colpe che appunto deve espiare, e abbia
intorno a sé, per essere custodita [sòzetai] questo recinto, sembianza di una prigione.
Tale carcere dunque, come dice il suo nome, è “custodia” [soma] dell’anima, sinché
essa non abbia finito di pagare i suoi debiti, e non c’è nulla da cambiare, neppure una
sola lettera. [Platone, Cratilo, 400c. Traduzione di G. Colli]
Oltre a ribadire alcuni aspetti del rapporto anima-corpo in continuità con i testi precedenti,
questo brano di Platone offre un significativo riferimento all’idea di espiazione di una colpa e
di saldo di un debito, di cui viene individuata la matrice, senza però precisarne i contorni.
Così il testo presenta il corpo:
•
il corpo è segno: è grazie a esso che l’anima “esprime tutto ciò che esprime”;
•
•
il corpo è tomba dell’anima, recinto con l’aspetto di una prigione, custodia: all’interno,
l’anima “espia le colpe che deve espiare”, fino a che non abbia saldato il suo debito;
questa dottrina è da attribuirsi soprattutto ai seguaci di Orfeo.
Altrettanto incisiva è la descrizione aristotelica:
L2- T2 Il supplizio degli Etruschi
Considerando questi errori e queste tribolazioni della vita umana, sembra talvolta che
abbiano visto qualcosa quegli antichi, sia profeti sia interpreti dei disegni divini nella
narrazione delle cerimonie sacre e delle iniziazioni, i quali hanno detto che noi siamo
nati per pagare il fio di alcuni delitti commessi in una vita anteriore, e sembra vero
ciò che si trova presso Aristotele, ossia che noi subiamo un supplizio simile a quello
patito da coloro che in altri tempi, quando cadevano nelle mani dei predoni etruschi,
venivano uccisi con una crudeltà ricercata: i corpi vivi di costoro erano legati assieme
a dei morti con la massima precisione, dopo che la parte anteriore di ogni vivo era
stata adattata alla parte anteriore di un morto. E come quei vivi erano congiunti ai
morti, così le nostre anime sono strettamente legate ai corpi.[Aristotele, Protrettico,
fr.10 b. Traduzione di G. Colli]
Rispetto al contributo precedente, il testo mette a fuoco con maggiore precisione la
motivazione e la consistenza del debito della psyché; in esso si riscontrano di nuovo la
sottolineatura dello stretto legame fra anima e corpo e, all’interno di esso, la distinzione fra il
principio vivo, rappresentato dall’anima, e la pura passività caratteristica del corpo; emergono
però anche:
•
•
•
la caratterizzazione dell’unione anima-corpo come ricercato supplizio;
la giustificazione del supplizio: noi siamo nati per pagare il fio di alcuni delitti
commessi in una vita anteriore;
l’attribuzione di questa convinzione agli antichi, sia profeti sia interpreti dei disegni
divini e il riscontro di questa matrice culturale nel primo Aristotele.
È interessante rilevare come il motivo della reminiscenza, di importanza fondamentale nella
filosofia platonica, ma molto probabilmente già in quella pitagorica, potrebbe essere stato
originariamente legato proprio alla necessità di educare la memoria al ricordo di una vita
anteriore, ragione delle sofferenze di quella presente.
Restano da chiarire le modalità dell’espiazione:
L2- T3 Il contrappasso
Questo sia detto come preludio alla trattazione di questa materia, e si aggiunga a
questo la tradizione, alla quale, quando ne sentono parlare, molti di coloro, che nelle
iniziazioni ai misteri s’interessano di queste cose, prestano molta fede, che, cioè,
nell’Ade vi è una punizione per tali misfatti, e che gli autori di essi, tornati qui di
nuovo, devono necessariamente pagare la pena naturale, quella, cioè, di patire ciò che
hanno fatto, terminando in tal modo per mano d’altri la novella vita. [Platone, Leggi,
IX, 870 d-e. Traduzione di A. Cassarà]
Il testo prosegue offrendo esempi concreti in proposito: chi ha ucciso il padre deve sopportare
che un giorno lo stesso trattamento gli sia riservato da parte dei figli; il matricida deve
rinascere di sesso femminile e morire per mano dei figli; l’anima colpevole deve pagare
“l’uccisione con l’uccisione, il simile con il simile”. Dunque:
•
il castigo che attende i malvagi dopo la morte consiste nel tornare di nuovo in vita e
scontare la pena naturale, cioè patire ciò che hanno fatto.
Terminato il ciclo delle reincarnazioni, l’anima ha finalmente accesso al premio che realizza il
suo destino più pieno.
Circa la natura dei premi riservati alle anime purificate, le testimonianze offerte dalle
laminette auree trovate presso alcune tombe presentano versioni diverse: nella laminetta
trovata a Petelia si dice che il destino dell’anima è quello di regnare insieme agli Eroi; quella
di Ipponio afferma che l’anima purificata nell’aldilà fa molta strada per le vie che percorrono
anche gli altri iniziati e posseduti da Dioniso. Numerose laminette trovate a Turi assegnano
all’anima il recupero della sua divinità originaria.
Convivono comunque, nella descrizione dell’aldilà, una componente originale propriamente
orfica, e un quadro tradizionale:
•
•
nella maggior parte dei casi, il premio dell’anima che si è purificata scontando la sua pena
naturale consiste nel rinascere dio;
l’aldilà è descritto idealizzando la realtà terrena e collocando i beati in un rapporto di
armonia con gli dei.
Resta comunque da spiegare per quale motivo un principio divino si macchia di colpe e si
purifica da esse in un corpo mortale, vale a dire, secondo le parole di un poeta pitagorico, “da
dove proviene l’umanità, e perché divenne così cattiva”.
A questa domanda risponde la teogonia orfica, un complesso di narrazioni mitologiche
destinate, in conformità con le teogonie tradizionali greche e in particolare con quella esiodea,
a illustrare l’articolarsi delle genealogie divine e l’instaurarsi dei regni dei vari dei e a
svolgere così una cosmologia mitica in grado di abbracciare la generazione di tutto l’universo.
La particolarità della teogonia orfica risiede però nel fatto di chiudersi con la spiegazione
dell’origine della stirpe degli uomini e del bene e del male che è in essi: questo fa sì che il
racconto mitico possa rappresentare la base per una dottrina etica.
La teogonia orfica è di difficile ricostruzione: le fonti decisive sono infatti molto tarde, e
legate alla testimonianza dei Neoplatonici; questa duplice limitazione rischia di
comprometterne l’attendibilità, soprattutto perché l’orfismo ha subito un processo di
trasformazione plurisecolare che ben presto ha reso difficile distinguere gli elementi più
antichi dalle aggiunte successive.
Alcuni elementi sembrano però appartenere alla narrazione originaria. Quando Zeus conquista
il dominio del mondo dopo avere divorato Phanes da cui aveva avuto origine ogni cosa,
plasma di nuovo l’universo. Unitosi con Rhea Zeus genera Persefone, dalla quale ha Dioniso.
A questi, per quanto giovanissimo, viene attribuito il potere sul mondo e la signoria sugli dei.
I Titani, però, invidiosi di Dioniso e probabilmente sobillati da Era, gli tendono una trappola.
L2- T4 Dioniso sbranato dai Titani
[…] Intorno a lui ancora fanciullo si agitano in una danza armata i Cureti, ma i Titani
si insinuano con l’astuzia: dopo di averlo ingannato con giocattoli fanciulleschi, ecco
che questi Titani lo sbranarono, sebbene fosse ancora un bambino, come dice il
poeta dell’iniziazione, Orfeo il Tracio […]
[Clemente Alessandrino, Protrettico, 2, 17- 18. Traduzione di G. Colli]
I Titani dunque, dopo averlo ingannato con giocattoli fanciulleschi (tra cui lo specchio) fanno
a pezzi Dioniso. Atena riesce a salvare solo il suo cuore, da cui Zeus genera un nuovo
Dioniso. I Titani per punizione vengono fulminati da Zeus e dalla loro cenere nascono gli
uomini.
L’uomo si presenta, in questa concezione, come unione di elemento divino, dionisiaco, e
elemento titanico. Si spiega così la tendenza al bene e al male presente in ogni uomo: alla
parte dionisiaca corrisponde l’anima, alla parte titanica il corpo. Il compito morale che ne
deriva è quello di liberare l’elemento divino dall’involucro titanico. Il ciclo delle rinascite è
finalizzato a liberare l’uomo da questa colpa originaria.
Per affrettare la liberazione dell’elemento divino, si rende necessario un esercizio di
purificazione.
Il concetto di catarsi non rappresenta un elemento originale orfico: è infatti al centro degli
interessi del pensiero religioso anche durante l’età arcaica; certamente, all’interno dello
schema antropologico prospettato dall’orfismo, il tema della catarsi acquista un ruolo e
un’urgenza assolutamente prioritari: a garantire la salvezza è la purezza, prima ancora che la
giustizia.
Tra le pratiche catartiche maggiormente attestate vanno inclusi la partecipazione a riti e
cerimonie, spesso centrate sull’uccisione di Dioniso a opera dei Titani, la pronuncia di
formule a carattere magico e il vegetarianismo (considerato corollario naturale della
metempsicosi, ma legato, più in profondità, alla regola che comandava di astenersi da
qualsiasi spargimento di sangue).
Particolari declinazioni dell’ideale catartico si riscontrano presso alcuni filosofi che hanno
aderito alle dottrine orfiche.
Nodi
considerazione della vita del principio divino nel corpo come castigo
trasmigrazione in diversi corpi finalizzata all’espiazione di una colpa originaria
duplice natura della stirpe umana illustrata dalla teogonia orfica
liberazione dell’elemento divino
ruolo fondamentale della catarsi
Lezione n.3: Pitagorismo, Empedocle e Eraclito
Uno dei pochi dati certi riguardo alla figura di Pitagora (VI sec. a.C.), per molti aspetti
avvolta dal mistero, è la sua adesione alla dottrina orfica della metempsicosi.
Il contemporaneo Senofane, secondo quanto riferisce Diogene Laerzio, poteva scherzare sulla
compassione di Pitagora nei confronti di un cagnolino bastonato:
L3- T1 La metempsicosi
Dicono che egli passando accanto a un cagnolino che veniva percosso ne abbia avuto pietà e
abbia detto a chi lo percuoteva così: “Cessa, non percuoterlo, poiché d’un uomo amico è
l’anima che io riconobbi, udendo la sua voce”.[Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VIII,36.
Traduzione di M. Gigante]
Altre notizie ben attestate riguardano viaggi di Pitagora nel Vicino Oriente e in Egitto: il
filosofo si sarebbe fatto “discepolo degli Egiziani”. Lo storico Erodoto stabilisce addirittura
una linea di continuità fra tradizione egiziana, rituali orfici e dionisiaci e Pitagorismo.
Al termine dei suoi viaggi, Pitagora si sarebbe stabilito a Crotone, fondando una comunità dal
carattere esclusivo, organizzata secondo una rigida gerarchia, vincolata al silenzio circa
alcune verità fondamentali e con l’aspetto insieme di setta religiosa e centro di studi
scientifici.
Questo duplice aspetto del sodalizio pitagorico si spiega tenendo in considerazione la
concezione pitagorica della catarsi:
•
•
•
le pratiche di purificazione dell’anima includono l’esercizio e l’ascolto della musica,
nonché lo studio dell’armonica e degli intervalli musicali;
l’esercizio ascetico è legato alla indagine naturalistica, finalizzata a svelare l’armonia
sottesa alla simpatia e corrispondenza universale, secondo una concezione magica
probabilmente alla base delle stesse indagini matematiche;
più in generale, strumento di perfezionamento è la filosofia (il termine sarebbe stato
impiegato per la prima volta proprio all’interno della cerchia pitagorica); Pitagora, che
“diventato discepolo degli Egiziani portò per primo in Grecia tutta la filosofia”, oltre a
dedicarsi ai sacrifici e alle cerimonie dei riti sacri, diventa il modello della vita
pitagorica, fatta di studio e ascesi.
Per quanto l’impegno di indagine scientifica sia recuperato dai Pitagorici nel quadro delle
credenze orfiche come mezzo privilegiato di purificazione della psyché, la dottrina
dell’anima che elaborano e successivamente sviluppano come approdo della loro ricerca
sulla natura sembra semplicemente giustapporsi alla concezione di matrice orfica, senza
potersi armonizzare con i suoi fondamenti. Per quanto la ricostruzione delle tesi del
pitagorismo antico risulti problematica, pare che la considerazione scientifica della psyché
porti a identificarla con il numero o le proprietà del numero; questa posizione avrebbe poi
potuto con una certa coerenza evolvere verso la dottrina dell’anima-armonia. Sempre al
Pitagorismo sarebbe da attribuire la dottrina dell’anima come pnéuma, soffio vitale, in stretta
relazione con la cosmologia.
Nonostante le oscillazioni, non certo trascurabili, è chiaro che l’approccio scientifico conduce
i Pitagorici nel solco dell’indagine naturalistica che identifica nella psyché un frammento
dell’arché, il principio cosmico della vita e del movimento. Questo conduce certamente a
riconoscere alla psyché divinità e immortalità, ma l’immortalità è intesa come impersonale
ricongiungimento all’arché, laddove le dinamiche della colpa e della purificazione implicate
dalla fede orfica comportano necessariamente la conservazione dell’individualità nel
succedersi delle reincarnazioni. Il contrasto più stridente si manifesta però a proposito del
dualismo, fondamentale conseguenza della concezione orfica assolutamente inconciliabile con
una prospettiva di tipo naturalistico, impegnata viceversa a sottolineare la continuità fra
cosmologia e antropologia, fra l’organismo macrocosmico e quello microcosmico.
La giustapposizione di indagine naturalistica e credenze orfiche si riscontra in maniera ancora
più evidente e quindi problematica se si considera la figura di Empedocle di Agrigento,
vissuto a cavallo della metà del V sec.
Autore di un poema Sulla Natura in cui, intrecciando i registri espressivi della narrazione
mitica e dell’argomentazione razionale, tenta una sintesi fra logica dell’eleatismo e tradizione
naturalistica, Empedocle scrive anche le Purificazioni, testo nel quale si presenta come divino
taumaturgo.
Diverse ipotesi sono state avanzate per dare coerenza a una produzione così eterogenea: i testi
stessi smentiscono che si possano comporre le divergenze mettendo in campo ragioni
evolutive e attribuendo i due testi di Empedocle a due periodi della sua vita (a una attenta
lettura risulta che nello stesso poema Sulla Natura compaiono riferimenti alle dottrine
religiose orfiche e ai poteri straordinari dell’autore, che rivendica le facoltà di tenere a freno i
venti, comandare le piogge e risuscitare i morti); è difficile anche parlare di Empedocle come
“personalità filosofica sintetizzante”, perché ciò che sembra mancare è proprio la sintesi delle
due componenti del suo pensiero; come Pitagora, Empedocle sembra piuttosto un
rappresentante del tipo dello sciamano, insieme scienziato naturalista e predicatore, poeta e
filosofo, taumaturgo e pubblico consigliere.
Ecco come, nelle Purificazioni, dimostra di accogliere i temi fondamentali della fede orfica:
L3- T2 Colpa e espiazione
E c’è, come un dato ineluttabile, l’antico decreto degli dei,
sempiterno, suggellato con ampi rescritti giurati,
allorché per erramenti un uomo insozzi le proprie mani
[con il sangue.
<Ed è questo:> chi risulta spergiuro per la colpa
[commessa,
dovrà migrare lontano dai beati, che come demoni longevi
[hanno raggiunto
la vita, per tre volte diecimila stagioni,
rinascendo attraverso il tempo in molteplici forme di corpi
[mortali,
permutando i procellosi cammini della propria esistenza.
Così ora sono esule anch’io per il decreto divino ed errante
affidato all’astio furibondo …
[Empedocle, Poema Lustrale, fr.103 Gallavotti. Traduzione di C. Gallavotti]
L’esilio della vita terrena si consuma nella consapevolezza della caduta da uno stato di
perfezione originaria:
L3- T3 Precipitati dalla grandezza
Oh sciagura!, o stirpe meschina dei mortali, oppure infelice,
da tali contese siete nati e da questi lamenti,
e da quale dignità precipitando e dalla grandezza di quanta
[felicità.
[Empedocle, Poema Lustrale, fr.115-116 Gallavotti. Traduzione di C. Gallavotti]
Empedocle accoglie dunque le istanze fondamentali dell’orfismo:
•
•
l’anima individuale deve pagare per una colpa originaria;
l’espiazione della colpa originaria passa attraverso il ciclo delle reincarnazioni.
Non si possono però dimenticare gli elementi di matrice segnatamente pitagorica:
•
•
il ciclo delle reincarnazioni si presenta molto lungo e complesso;
l’attività intellettuale è ritenuta un esercizio di purificazione.
Anche nel caso di Empedocle è fondamentale, per comprendere il problema della presenza
concomitante di elementi di marca naturalistica e elementi orfici, analizzare la concezione
dell’anima che emerge dai testi:
•
•
•
•
•
il termine psyché compare in Empedocle una volta soltanto, con il significato di “vita”;
per indicare l’anima di origine divina che passa attraverso il ciclo delle successive
reincarnazioni, Empedocle parla di daimon,
mentre quando fa riferimento alla sede dei processi conoscitivi ne parla come di un
principio impersonale, diversamente distribuito ma comunque presente in tutta la natura;
è grazie alle quattro radici di tutte le cose (revisione pluralistica dell’arché dei filosofi
ionici) che tutte le cose sono in connessione armoniosa, ciascuna con la parte a lei
destinata di conoscenza e di pensiero;
la conoscenza si fonda sull’armonia del simile con il simile: è quindi plausibile,
nell’uomo, indicarne la sede principalmente nel sangue, risultato della mescolanza delle
quattro radici (aria, acqua, terra e fuoco).
Il naturalismo di Empedocle e in particolare la concezione della conoscenza come rapporto
del simile con il simile gli impediscono di fare propria una intuizione fondamentale per la
psicologia antica, quella conquistata da Eraclito di Efeso (seconda metà VI sec. - prima metà
V).
Eraclito fa proprie le idee fondamentali della spiritualità orfica, che esprime nel suo
caratteristico stile aforismatico, vicino all’enigma e alla profezia oracolare:
L3- T4 Vivere è morire
Immortali mortali, mortali immortali, vivendo la morte di quelli, morendo la vita di
quelli.
[Eraclito, fr.22 B62 DK]
L3- T5 L’oltretomba
Dopo la morte attendono gli uomini cose che essi non sperano e neppure
immaginano.
[Eraclito, fr.22 B27 DK]
I riferimenti si inscrivono all’interno delle coordinate classiche della dottrina orfica:
•
•
•
la vita terrena si configura come esistenza decaduta;
intercorre fra vita corporea e vita dell’anima di origine divina un rapporto
proporzionalità inversa;
dopo la morte l’anima va incontro a premi o castighi.
di
Il guadagno fondamentale di Eraclito non riguarda infatti una rivisitazione delle dottrine
orfiche, quanto piuttosto una svolta fondamentale impressa alla speculazione naturalistica e
conseguentemente alla psicologia modellata su di essa: la psyché è fatta coincidere con
l’arché, il fuoco cosmico; al principio è però attribuita l’intelligenza, che viene quindi a
essere una caratteristica propria anche della psyché. Anche nella psyché si manifesta
infatti l’attività del lògos, la regola che “governa tutte le cose attraverso tutte le cose”.
Questa fondamentale acquisizione apre alla psyché una nuova dimensione; a rivelarlo sono le
metafore spaziali impiegate dallo stesso Eraclito:
L3- T6 Un’anima senza confini
I confini della psyché non li potrai mai raggiungere, per quanto tu proceda fino in
fondo nel percorrere le sue strade: così profondo è il suo lògos.
[Eraclito, fr. 22 B 45 DK]
L3- T7 Un’anima che si accresce
C’è un lògos della psyché che accresce se stesso.
[Eraclito, fr.22 B 115 DK]
L’anima si presenta come l’unica realtà del mondo umano in grado di partecipare della
potenza del lògos e non di subirla: è grazie alla continuità garantita dal lògos che è possibile
per l’uomo superare l’estraneità rispetto al mondo ed è in virtù dell’onnipresenza del lògos
che non si dà contrapposizione fra indagine del macrocosmo e del microcosmo (Eraclito può
parlare della sua ricerca scrivendo: Ho indagato me stesso).
Certamente anche questo tipo di considerazione della psyché non esce dal solco del
naturalismo, con la conseguenza inevitabile dell’impersonale omogeneità di anima e arché:
tuttavia l’identificazione di anima e intelligenza, per quanto attuata attraverso il medium
rappresentato dall’universale presenza del lògos, rappresenta un traguardo del pensiero
naturalistico che, lasciato cadere da Empedocle, è destinato ad agire in profondità sullo
sviluppo del concetto di anima fino alla rivoluzione socratica.
Nodi
attività intellettuale come strumento di purificazione in Pitagora e Empedocle
giustapposizione di concezione naturalistica e concezione orfica della psyché
identificazione di psyché e intelligenza in Eraclito
Lezione n. 4: La rivoluzione socratica
Il tentativo di valutare l’apporto di Socrate nell’ambito dello sviluppo del concetto greco di
psyché si scontra inevitabilmente con l’ostacolo rappresentato dal margine di aleatorietà che
caratterizza qualsiasi ricostruzione del pensiero di questo autore. La totale assenza di
testimonianze dirette costringe, anche per quanto riguarda questo tema, a ipotizzare quale
possa essere stato il contributo di Socrate tramite approssimazioni successive, attraverso il
confronto delle testimonianze indirette. I testimoni cui fare riferimento sono:
•
•
•
•
•
Aristofane: è la fonte più antica; la sua commedia, Le Nuvole, assume il tono della parodia
per accusare Socrate di essere il peggiore dei sofisti e allo stesso tempo filosofo naturalista
vicino alle dottrine di Diogene di Apollonia;
Platone: attribuisce a Socrate il ruolo di protagonista della maggior parte dei suoi dialoghi;
la sua testimonianza va vagliata considerandone l’intento di esaltazione della figura di
Socrate, spesso trasfigurata fino a assumere valore di simbolo; occorre poi considerare che
nei dialoghi platonici Socrate si fa portavoce delle dottrine platoniche;
Senofonte: i Detti memorabili e altri scritti minori che hanno Socrate come protagonista
sono per la maggior parte opere della vecchiaia dell’autore, uditore di Socrate solo per
brevissimo tempo e durante la giovinezza;
Aristotele: pur offrendo contributi importanti, non è un contemporaneo e per di più parla
di Socrate solo sporadicamente;
i fondatori delle Scuole socratiche minori, le cui testimonianze sono scarse e filtrate
attraverso le rispettive riletture dell’insegnamento socratico.
Anche se le innumerevoli difficoltà che si incontrano cercando di orientarsi attraverso questi
riferimenti tendono a sfumarne irrimediabilmente i contorni, non si può fare a meno di
sottolineare il carattere decisivo del contributo socratico, in particolare per quanto riguarda
l’evoluzione del concetto di psyché. Proprio su questo punto infatti sembra più netta la
distinzione fra il prima e il dopo Socrate, tanto da far parlare di “rivoluzione socratica”.
Per documentarne la consistenza, vale la pena di rivolgersi innanzitutto alla platonica
Apologia di Socrate, probabilmente il documento più cospicuo e attendibile sulla figura
storica di Socrate. L’evento cui l’Apologia fa riferimento è il processo intentato contro
Socrate nel 399 a.C. Difendendosi contro i suoi accusatori, Socrate mette a fuoco l’oggetto
fondamentale della sua indagine filosofica:
L4- T1 Sapienza umana
Ebbene, che cosa affermavano i miei calunniatori nel calunniarmi?
Dobbiamo leggere il loro atto di accusa, come se fossero accusatori veri e propri:
“Socrate commette ingiustizia e si dà molto da fare, indagando le cose che stanno sotto
terra e quelle celesti, facendo apparire più forte il ragionamento più debole e insegnando
queste medesime cose anche agli altri”.
Questa è l’accusa che mi fanno. E queste stesse cose le avete viste nella commedia di
Aristofane, un Socrate che là viene portato attorno, dicendo di camminare nell’aria e
molte altre sciocchezze: tutte cose queste di cui io non mi intendo né molto né poco.
Dico ciò in quanto ho disprezzo per una scienza come quella, posto che ci sia qualche
sapiente di tali cose. Che io non debba ricevere da Meleto anche un’accusa di tal genere!
Dico, invece, che di queste cose, o cittadini ateniesi, io non faccio assolutamente ricerca.
Chiamo a testimoni, di nuovo, la maggior parte di voi. E ritengo opportuno che vi
informiate a vicenda e che riferiate le vostre opinioni, quanti mi avete sentito discutere. –
E siete in molti che mi avete sentito! – Consultatevi dunque a vicenda, se c’è qualcuno di
voi che mi abbia mai udito discutere di cose di tal genere, o poco o molto. E così vi
renderete conto che anche le altre cose che i più dicono di me sono come queste.
In realtà, niente di tutto questo è vero.
E se poi avete udito da qualcuno che io cerco di educare uomini e che esigo danaro,
neanche questo è vero.
In realtà mi sembra che sia una cose bella, se uno è in grado di educare uomini, come
sono in grado di farlo Gorgia di Leontini, Prodico di Ceo e Ippia di Elide.
[…]
Ma di tali cose non ho proprio conoscenza, cittadini di Atene!.
Ora, qualcuno di voi potrebbe fare questa considerazione: “Ma allora, o Socrate, quale è
la tua occupazione? Da che cosa ti sono derivate queste calunnie? Certamente non perché
non ti occupavi di nulla di più straordinario degli altri, si sono levate queste voci e una
fama così grande. Non sarebbero sorte, se tu non avessi fatto nulla di diverso rispetto agli
altri. Devi dirci, dunque, che cos’è, affinché non ti giudichiamo in modo sconsiderato”.
Chi dice ciò, mi sembra che dica il giusto. E io cercherò di mostrarvi che cosa ha dato
origine alla cattiva fama e alla calunnia contro di me.
Dunque, ascoltatemi! Forse a qualcuno di voi sembrerà che io stia scherzando. Ma
seppiatelo bene: io vi dirò tutta la verità.
Io, cittadini ateniesi, mi sono procurato questa rinomanza non per altro che per una certa
sapienza.
Quale è questa sapienza?
Quella che, forse, è una sapienza umana. Infatti, di questa può darsi veramente che io sia
sapiente.
Invece, quei tali di cui poco fa parlavo, o saranno sapienti di una sapienza superiore
rispetto a quella umana, o non so che cosa dire. Certamente, io non conosco questa
sapienza. E chi dice, invece, che la conosco, mente; e lo dice per calunniarmi. [Platone,
Apologia di Socrate, 19b-20e. Traduzione di G. Reale]
Socrate è accusato:
•
•
di indagare le cose che stanno sotto terra e quelle celesti: per comprendere come questa
attività potesse in certi casi diventare un capo di imputazione, basta citare il precedente
non lontano di Anassagora, processato nel 433 a.C. ad Atene proprio per empietà;
di far apparire più forte il ragionamento più debole: tramite questa insinuazione l’accusa
vuole parificare l’insegnamento socratico e quello dei sofisti, mirante alla persuasione e
non alla verità.
Nel rispondere, Socrate chiama gli Ateniesi stessi a testimoni della sua estraneità all’indagine
naturalistica e alla sofistica:
•
•
•
riconosce l’esistenza e la diffusione dell’opinione che lo vorrebbe filosofo naturalista; cita
direttamente Aristofane e la parodia delle Nuvole, la quale sfrutta fra l’altro il fatto che
Socrate era stato discepolo di Archelao di Atene, che poneva l’aria infinita come principio
delle cose;
chiarisce il suo disprezzo nei confronti di una scienza che voglia indagare le cose che
stanno sotto terra e quelle celesti e mette in dubbio addirittura che possa esserci qualche
sapiente di tali cose: in ogni caso, riconosce la propria ignoranza in proposito (tutte cose
queste di cui io non mi intendo né molto né poco);
insinua il dubbio anche circa la possibilità di dispensare insegnamenti circa le virtù
dell’uomo e del cittadino, alla maniera dei sofisti: ritiene certamente che sia una cosa
•
bella, se uno è in grado di educare uomini, ma nel suo caso specifico non esita a
ammettere di non avere alcuna conoscenza in merito;
dopo avere per due volte ribattuto alle accuse invocando la propria ignoranza, ammette
che le calunnie nei suoi confronti derivano da una certa sapienza, che ammette di
possedere: una sapienza umana.
Il magistero di Socrate in Atene inizia quando il filosofo si è lasciato definitivamente alle
spalle l’interesse per la filosofia naturalistica e ha circoscritto la sua indagine alla sapienza
umana. Questo nuovo tipo di sapere è “umano” in quanto:
•
•
prende le mosse dalla consapevolezza della limitatezza della capacità conoscitiva
dell’uomo: già dal testo sopra riportato è chiaro come la sapienza umana delimiti il
proprio perimetro in relazione a vaste regioni dichiaratamente consegnate all’ignoranza o
all’illusione di una sapienza superiore rispetto a quella umana;
mette esplicitamente a fuoco quello dell’uomo come il problema filosofico per eccellenza.
Seguire l’itinerario del pensiero di Socrate è quindi innanzitutto chiedersi quale sia l’essenza
dell’uomo e portarsi così alle radici, non raggiunte dalla sofistica che pure aveva indagato i
problemi dell’uomo, della filosofia morale.
L4- T2 Che cos’è l’uomo
Socrate. Potremo mai sapere quale arte renda migliore noi stessi, mentre ignoriamo chi
siamo noi stessi?
Alcibiade. È impossibile.
Socrate. Ma è forse facile conoscere se stessi ed era un buono a nulla colui che ha posto
quell’iscrizione sul tempio di Delfi, oppure si tratta di una cosa difficile e non alla portata
di tutti?
Alcibiade. Molte volte, Socrate, mi è sembrata una cosa alla portata di tutti, molte volte,
invece, assai difficile.
Socrate. Tuttavia, Alcibiade, che sia facile oppure no, per noi la questione si pone così:
conoscendo noi stessi potremo sapere come dobbiamo prenderci cura di noi, mentre, se
lo ignoriamo, non lo possiamo proprio sapere.
Alcibiade. È così.
Socrate. Ebbene, in quale modo si potrebbe trovare questo se stesso? Così, infatti,
scopriamo chi siamo, mentre, finché lo ignoriamo, ciò sarà impossibile.
Alcibiade. Dici bene.
Socrate. Fermati, per Zeus! Con chi stai parlando ora? Non stai parlando con me?
Alcibiade. Sì.
Socrate. E anch’io con te?
Alcibiade. Sì.
Socrate. Socrate, allora, è colui che parla?
Alcibiade. Proprio.
Socrate. Mentre Alcibiade è colui che ascolta?
Alcibiade. Sì.
Socrate. Ma Socrate non discute forse con parole?
Alcibiade. È ovvio.
Socrate. Il discutere e il servirsi di parole per te coincidono?
Alcibiade. Senz’altro.
Socrate. Ma chi si serve e ciò di cui si serve non sono differenti?
Alcibiade. Come dici?
Socrate. Per esempio il calzolaio taglia con il trincetto, la lesina e altri strumenti.
Alcibiade. Sì.
Socrate. Pertanto, chi taglia e si serve di qualcosa è diverso da ciò che, tagliando, usa?
Alcibiade. Come no?
Socrate. E così anche gli strumenti di cui si serve il suonatore di cetre sono diversi dal
citarista stesso?
Alcibiade. Sì.
[…]
Socrate. Dunque, calzolaio e citarista sono diversi dalle mani e dagli occhi di cui si
servono?
Alcibiade. È chiaro.
Socrate. E l’uomo non si serve di tutto il corpo?
Alcibiade. Senz’altro.
Socrate. Ma non ci risultava diverso chi si serve di qualcosa da ciò di cui si serve?
Alcibiade. Sì.
Socrate. Pertanto l’uomo è diverso dal suo corpo?
Alcibiade. Sembra di sì.
Socrate. Che cos’è, allora, l’uomo?
Alcibiade. Non so che cosa rispondere.
Socrate. Però sai che è ciò che si serve del corpo.
Socrate. Vi è forse qualcos’altro che se ne serve, al di fuori dell’anima?
Alcibiade. Nient’altro.
[…]
Socrate. L’anima quindi ci ordina di conoscere chi ci comanda “conosci te stesso”.
[Platone, Alcibiade Maggiore, 128e-131a. Traduzione M.L. Gatti]
Il monito delfico “Conosci te stesso” può senza dubbio essere assunto quale cifra del
filosofare socratico: la stessa urgenza dell’esigenza morale può trovare opportuna risposta
solo a partire da un’adeguata analisi introspettiva, come evidenziato in apertura del testo. Chi
è dunque il “te stesso” che l’oracolo comanda di conoscere?
Attraverso alcuni semplici passaggi, Alcibiade è messo nella condizione di poter rispondere:
•
•
•
•
•
•
il primo esempio prende spunto dall’esperienza del colloquio in atto: gli interlocutori
parlano, e per fare ciò si servono dello strumento rappresentato dalle parole;
seguono altri esempi: il calzolaio svolge il suo lavoro servendosi degli strumenti
caratteristici (trincetto, lesina…) e così il citarista;
sempre mantenendo gli esempi precedenti, si guadagna un ulteriore acquisizione: nel
lavoro, anche alcune parti del corpo intervengono come strumenti specializzati (mani,
occhi…);
se si considera quel particolare mestiere che è l’essere uomo, ci si accorge che a essere
impiegato come strumento è tutto il corpo;
anche in quest’ultimo caso, come nei precedenti, va tenuta ferma la regola per cui è
diverso chi si serve di qualcosa e ciò di cui si serve;
dunque l’uomo non è corpo, ma ciò che si serve del corpo: l’uomo è l’anima, un’anima
che si serve del corpo come strumento.
L’etica socratica prende le mosse proprio dall’identificazione dell’uomo con la sua anima, e
dalla particolare concezione dell’anima propria di Socrate. Ecco come il filosofo presenta la
propria originale attività di educatore della città, che considera missione divina:
L4- T3 La missione di Socrate
“Cittadini ateniesi, vi sono grato e vi voglio bene; però ubbidirò più al dio che a non a
voi; e finché abbia fiato e sia in grado di farlo, io non smetterò di filosofare, di esortarvi e
di farvi capire, sempre, chiunque di voi incontri, dicendogli quel tipo di cose che sono
solito dire, ossia queste: “Ottimo uomo, dal momento che sei ateniese, cittadino della
Città più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle
ricchezze per guadagnarne il più possibile e della fama e dell’onore, e invece non ti occupi
e non ti dai pensiero della saggezza, della verità e della tua anima, in modo che diventi il
più possibile buona?”.
E se qualcuno di voi dissentirà su questo e sosterrà di prendersene cura, non lo lascerò
andare immediatamente, né me ne andrò io, ma lo interrogherò, lo sottoporrò ad esame e
lo confuterò. E se mi risulterà che egli non possegga virtù, se non a parole, lo biasimerò,
in quanto tiene in pochissimo conto le cose che hanno maggior valore, e in maggior
conto le cose che ne hanno molto poco.
E farò queste cose con chiunque incontrerò, sia con chi è più giovane, sia con chi è più
vecchio, sia con uno straniero, sia con un cittadino, ma specialmente con voi, cittadini, in
quanto mi siete più vicini per stirpe. Infatti queste cose, come sapete bene, me le
comanda il dio. E io non ritengo che ci sia per voi, nella Città, un bene maggiore di
questo mio servizio al dio.
Infatti, io vado intorno facendo nient’altro che cercare di persuadere voi, e più giovani e
più vecchi, che non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze, né di alcun’altra
cosa prima e con maggiore impegno che dell’anima, in modo che diventi buona il più
possibile, sostenendo che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma dalla virtù stessa nascono
le ricchezze e tutti gli altri beni per gli uomini, e in privato e in pubblico. [Platone,
Apologia di Socrate, 29d-30b. Traduzione di G. Reale.]
Il testo evidenzia la portata dirompente dell’identificazione dell’essenza dell’uomo con
l’anima; Socrate:
•
•
•
•
caratterizza il suo filosofare come continuo interrogare e sottoporre a esame gli
interlocutori per metterli sulla strada della virtù;
capovolge la gerarchia dei valori: rimprovera infatti agli Ateniesi di tenere in maggiore
conto le cose che hanno scarso valore e di darsi pensiero unicamente delle ricchezze,
della fama e dell’onore;
recupera il primato della virtù rispetto a qualsiasi altro bene;
riannoda la virtù all’essenza dell’uomo: coltivare la virtù significa darsi pensiero della
saggezza, della verità e della propria anima, in modo che diventi il più possibile buona.
Il fatto che vengano accomunate la cura per la saggezza, per la verità e per la propria anima
chiarisce un aspetto essenziale della “rivoluzione socratica”: l’anima, che rappresenta per
Socrate l’essenza dell’uomo, è la coscienza pensante e operante, il soggetto dell’attività
intellettuale e morale.
In definitiva, uno sguardo complessivo sulla dottrina socratica dell’anima non può fare a
meno di sottolineare il ruolo decisivo di due componenti, già anticipate, senza svilupparne
tutte le implicazioni, da Eraclito:
•
•
l’interesse per l’indagine introspettiva
l’identificazione della psyché con la sede dell’intelligenza individuale;
Anche la matrice orfica rappresenta un riferimento imprescindibile; nell’appello socratico alla
“cura dell’anima” convergono:
•
•
•
•
la concezione della psyché come individuale (legata nell’orfismo alla necessità della
conservazione della medesima identità attraverso le successive trasmigrazioni);
la convinzione del primato dell’anima sul corpo e l’insistenza sulla necessità di
preoccuparsi della vita dell’anima piuttosto che di quella del corpo (le tracce del dualismo
gerarchico anima-corpo tipico dell’orfismo si ripresentano puntualmente nei limiti
intellettualistici dell’etica socratica, che riduce di fatto il vizio a un deficit di conoscenza);
l’idea che l’attenzione per l’anima si concretizzi in un esercizio continuo finalizzato alla
sua purificazione (così può essere letto il riferimento all’incessante esame di se stessi e
della propria condotta);
la centralità della tematica antropologica, pur non legata a una escatologia (la posizione
socratica circa il destino dell’anima è aporetica) e l’urgenza dell’esigenza etica, già
incontrate come caratteri distintivi dell’Orfismo e della narrazione teogonica che ne è alla
base.
Inoltre, l’importanza, per la costruzione dell’idea socratica di psyché, del concetto orfico di
anima-demone troverebbe conferma nella testimonianza del poeta comico Aristofane, nelle
Nuvole: la parodia dell’insegnamento socratico include infatti la presentazione del “pensatoio
delle psychài sapienti” come comunità mistico-esoterica.
L4- T4 Riti di iniziazione
Socrate. Vuoi chiaramente conoscere la vera essenza delle divine cose?
Strepsiade. Se si può, perdio!
Socrate. E intavolare un discorso con le Nuvole, nostre divinità?
Strepsiade. Certissimo.
Socrate. E allora siedi sul sacro trespolo.
Strepsiade. Eccomi seduto.
Socrate. Ora prendi questa corona.
Strepsiade. La corona, perché? Povero me, Socrate, baste che non mi sacrificate: che
sono, Atamante?
Socrate. Ma no: tutte cose che facciamo agli iniziati.
Strepsiade. E che me ne viene?
Socrate. A parlare diventerai limatissimo, sonante, fior di farina. (Lo spruzza di farina)
Ma sta’ fermo!
Strepsiade. Perdio, mi imbrogli! Spruzzato così, chi non diventa fior di farina?
Socrate. Che taccia il vecchio in devozione e ascolti la preghiera:
Aere possente signore
smisurato tu che la Terra
reggi sospesa nello spazio
Etere fulgido e Nuvole
sante divine tra i fulmini
tonanti or vi levate
apparite voi Signore
nell’aria a quei che pensa.
[Aristofane, Le Nuvole. Traduzione Marzullo]
I riferimenti di marca mistico-esoterica sono numerosi:
•
il sacro trespolo;
•
•
•
•
la corona;
l’accenno agli “iniziati”;
il battesimo con la farina;
l’invocazione delle divinità della setta, tra cui Caos e Etere, due figure fondamentali della
cosmogonia orfica.
Con Socrate tuttavia gli elementi desunti dall’Orfismo sono recuperati in una sintesi
speculativa del tutto originale: identificando nella psyché la sede dell’intelligenza e della
coscienza la riflessione filosofica sull’anima finisce di dividersi fra approccio naturalisticoscientifico (destinato irrimediabilmente ad appiattire il discorso sull’uomo nel quadro di una
più vasta indagine sulla natura) e considerazione teosofica (che prescrive la cura di un
misterioso “secondo io” che alberga nell’uomo) e apre lo spazio per l’autonomo sviluppo
della riflessione morale.
Lezione n. 5: Platone: l’anima e il suo destino
Con Platone giunge a piena maturazione il concetto di anima avanzato da Socrate; si possono
infatti riscontrare:
•
•
•
l’affermazione che l’uomo si identifica con la propria anima;
l’identificazione dell’anima individuale con la capacità di intendere e di volere del
singolo;
la prescrizione che di essa e non del corpo deve innanzitutto occuparsi l'uomo.
Questi guadagni fondamentali sono raggiunti dalla protrettica e dalla dialettica socratica
principalmente per via intuitiva, mentre grazie a Platone acquistano il rigore di conclusioni
dimostrate.
Un riferimento importante per l’indagine psicologica platonica è offerto dalla cosiddetta
seconda navigazione, che dischiude la dimensione del soprasensibile: ammettendo
l’appartenenza dell’anima a questo ordine di realtà è possibile acquisire per via dimostrativa i
punti principali di una dottrina della psyché che conserva molti aspetti di quella orfica,
ancorandola però a una salda fondazione speculativa.
Si ritrovano dunque in Platone temi caratteristici dell’orfismo, a partire da quello dello
scambio morte-vita. Un elemento ulteriore, anche se non del tutto originale (basta pensare ai
Pitagorici), rintracciabile nella trattazione platonica è invece la particolare interpretazione
dell’ esercizio di purificazione necessario per riscattare la psyché dal suo esilio corporeo: si
tratta innanzitutto di un esercizio filosofico. Date queste premesse, non risulta difficile
comprendere il messaggio proposto nel Fedone: i filosofi fanno della morte in quanto distacco
dal corpo la loro professione; a maggior ragione dunque non li spaventa il sopraggiungere
della morte vera, per prepararsi alla quale impiegano l’intera esistenza.
L5- T1 Occupati a morire
“Tutti coloro che praticano la filosofia in modo retto rischiano che passi inosservato
agli altri che la loro autentica occupazione non è altra se non quella di morire e di
essere morti. E se questo è vero, sarebbe veramente assurdo per tutta la vita non
curarsi d’altro che della morte, e poi, quando arriva la morte, addolorarsi di ciò che
da tanto tempo si desiderava e di cui ci si dava tanta cura”.
E Simmia, ridendo, disse: “Per Zeus, Socrate, mi hai fatto ridere, anche se ora non ne
avevo proprio voglia! Io penso che la gente, se sentisse dire questo, penserebbe che
sia davvero ben detto dei filosofi- e lo riterrebbero in particolar modo i nostri
concittadini-, ossia che essi sono veramente dei moribondi; e direbbe di essersi ben
accorta che i filosofi sono degni di subire la morte!”
“E direbbe la verità, Simmia! Però non è vero che la gente se ne sia davvero accorta.
Infatti non si è accorta in che senso i veri filosofi siano dei moribondi e in che senso
siano degni di morte, e di quale morte! Ragioniamo dunque, tra noi e lasciamo andare
la gente. Riteniamo noi che la morte sia qualche cosa?”
“Certo”, disse Simmia.
“E riteniamo che sia altro che non una separazione dell’anima dal corpo? E che
essere morto non sia altro che questo: da un lato, l’essere il corpo, separatosi
dall’anima, da sé solo, e dall’altro, l’essere l’anima, separatasi dal corpo, da sé sola? O
dobbiamo ritenere che la morte sia qualcosa d’altro e non questo?” [Platone, Fedone,
64 a- c. Traduzione di G. Reale]
Il discorso procede in maniera estremamente lineare:
•
•
la morte consiste nella separazione dell’anima dal corpo: dopo la morte, l’anima sta “da sé
sola” e così il corpo;
se si intende la morte in questo senso, l’occupazione dei filosofi è principalmente quella di
morire.
Resta però da chiarire perché il filosofo persegue la separazione dell’anima dal corpo, e
quindi in che senso la filosofia rappresenta una pratica di purificazione. Così argomenta il
Fedone:
L5- T2 Puri come la verità
“Sembra che ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a
questa considerazione: fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta
invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello
che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. […] Ma risulta veramente chiaro
che, se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, dobbiamo staccarci dal
corpo e guardare con la sola anima le cose in se medesime. E allora soltanto, come
sembra, ci sarà dato di raggiungere ciò che vivamente desideriamo e di cui ci diciamo
amanti, vale a dire la saggezza: cioè quando noi saremo morti, come dimostra il
ragionamento, e non fin quando siamo vivi. Infatti, se non è possibile conoscere
alcunché nella sua purezza mediante il corpo, delle due l’una: o non è possibile
raggiungere il sapere, o sarà possibile solo quando si sarà morti; infatti solamente
allora l’anima sarà sola per se stessa e separata dal corpo, prima no. E nel tempo in
cui siamo in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto di più al sapere quanto
meno avremo relazioni con il corpo e comunione con esso, se non nella stretta
misura in cui vi sia piena necessità, e non ci lasceremo contaminare dalla natura del
corpo, ma dal corpo ci manterremo puri, fino a quando il dio stesso non ci abbia
sciolto da esso. E, così puri, liberati dalla stoltezza che ci viene dal corpo, come è
verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi, e conosceremo da noi stessi tutto
ciò che è semplice: questa è forse la verità. Infatti, a chi è impuro non è lecito
accostarsi a ciò che è puro”. [Platone, Fedone, 66 b-67 b. Traduzione di G. Reale]
Dunque il filosofo, etimologicamente “amante della saggezza”, persegue un obiettivo, la
verità, per il raggiungimento del quale il corpo rappresenta un impedimento:
•
•
•
•
da esso non viene saggezza, ma “stoltezza”: nella parte di testo omessa, Platone
argomenta questa tesi, elencando le “innumerevoli preoccupazioni” a motivo delle quali il
corpo distoglie dalla ricerca della verità (necessità del nutrimento, malattie, amori,
passioni, paure, vanità e, come se non bastasse, interferenze nelle ricerche stesse che
impediscono di vedere il vero);
la acquisizione del sapere autentico presuppone che l’anima sia sola per se stessa e
separata dal corpo, dunque precisamente nella condizione che il testo precedente indicava
quale prodotta dalla morte;
quella approssimazione alla saggezza in cui precisamente consiste la vita del filosofo è
dunque un cammino di perfezionamento dall’essere la propria anima all’essere
esclusivamente la propria anima: per questo motivo ricalca l’itinerario della
purificazione orfica e ne rispetta l’assunto di fondo: a chi è impuro non è lecito accostarsi
a ciò che è puro;
la concezione dell’attività intellettuale come purificazione solo con Platone riesce a
armonizzarsi opportunamente con la dottrina della psyché, soprattutto per via degli
approdi della seconda navigazione;
•
se la "stoffa" dell’anima è quella del mondo soprasensibile e intelligibile, unico è il
cammino che conduce dal sensibile all’intelligibile (quello filosofico) e che consente la
emancipazione della psyché dalla corporeità (quello di purificazione).
Non stupisce quindi che Platone possa sentirsi sicuro nell’interpretare come conformi alla sua
dottrina le testimonianze degli esperti dei misteri:
L5- T3 Chi sono gli eletti
E certamente non furono degli sciocchi coloro che istituirono i Misteri: e in verità già
dai tempi antichi ci hanno velatamente rivelato che colui il quale arriva all’Ade senza
essersi iniziato e senza essersi purificato, giacerà in mezzo al fango; invece, colui che
si è iniziato e si è purificato, giungendo colà, abiterà con gli Dei. Infatti, gli interpreti
dei misteri dicono che “i portatori di ferule sono molti, ma i Bacchi sono pochi”. E
costoro, io penso, non sono se non coloro che praticano rettamente la
filosofia.[Platone, Fedone, 69 c-d. Traduzione di G.Reale]
Oltre allo scambio morte-vita e all’urgenza della pratica catartica, è possibile riscontrare
nella trattazione platonica sull’anima altri temi che richiamano, più o meno da vicino,
l’Orfismo. Analoghi in particolare sono gli interrogativi circa l’origine divina
dell’anima, le ragioni della sua “caduta” in un corpo e il suo destino ultimo; anche il
registro espressivo scelto ricalca quello mitico-poetico della teogonia orfica.
Il testo di riferimento per i temi in esame è il Fedro, a partire dal celebre mito
dell’auriga:
L5- T4 La struttura dell’anima
«Della immortalità dell’anima si è parlato abbastanza, ma quanto alla sua natura
dobbiamo dire che definire quale sia sarebbe trattazione adeguata solo per un dio e
anche lunga; tuttavia, parlarne per immagini è impresa umana e più breve. Questo sia
dunque il modo del nostro discorso. Si raffiguri l’anima come la potenza d’insieme di
una pariglia alata e di un auriga. Ora tutti i corsieri degli dei e i loro aurighi sono
buoni e di buona razza, ma quelli degli altri esseri sono un po’ sì e un po’ no.
Innanzitutto, per noi uomini, l’auriga conduce la pariglia; poi dei due corsieri uno è
nobile e buono, e di buona razza, mentre l’altro è tutto il contrario ed è di razza
opposta. Di qui consegue che, nel nostro caso, il compito di tal guida è davvero
difficile e penoso» [Fedro, 246a –246b. Traduzione di P. Pucci modificata].
Il testo si apre con un riferimento alla trattazione sull’immortalità dell’anima: tale accenno è
particolarmente importante, in quanto consente di ribadire, nel quadro di un discorso mirante
a rintracciare gli elementi di matrice orfica nel discorso platonico, l’irriducibile stacco
comunque sussistente fra il discorso filosofico e quello religioso sulla psyché: Platone può, a
differenza di qualsiasi iniziato ai misteri orfici, asserire di avere dimostrato razionalmente,
grazie alle acquisizioni della seconda navigazione, l’immortalità dell’anima (le principali
prove da lui offerte sono contenute nel Fedone; inoltre se ne contano una nel Fedro e una
nella Repubblica).
Ciò non toglie che altri aspetti della dottrina della psyché (la sua natura, origine e destino)
risultino meno accessibili all’indagine conoscitiva e possano essere espressi solo attraverso
immagini.
Il mito dell’auriga, consapevolmente utilizzato come strumento umano per affrontare un tema
divino, si propone di illustrare la struttura interna dell’anima:
•
•
•
•
•
l’anima umana presenta una articolazione funzionale rispetto alla sua destinazione di
ente immortale ma incarnato;
tale destinazione si riflette nella struttura: le anime destinate alla incarnazione sono
diverse – intrinsecamente caratterizzate da una eterogeneità di componenti - rispetto a
quelle uniformi degli dei, estranee alla prospettiva della unione con il corpo;
la struttura dell’anima presenta dunque una sostanziale tensione tra le componenti: una
ben disposta, l’altra meno, alla guida dell’auriga;
il disordine dell’anima è quindi potenzialmente legato alla sua struttura;
essa può essere così interpretata: una componente razionale [quella essenziale all’anima,
che impronta l’unità dell’anima divina], una irascibile, disposta a lasciarsi condurre dalla
prima ma da essa distinta, una concupiscibile, destinata a scontrarsi con le direttive
razionali e a essere la maggiore responsabile del disordine.
Una tale descrizione rappresenta indubbiamente un contributo fondamentale per l’evoluzione
del concetto di psyché:
•
•
l’intuizione socratica dell’identificazione dell’anima con l’intelligenza e la coscienza è
sviluppata in un quadro più complesso;
lo stesso rigido dualismo del Fedone sembra superato: la tripartizione dell’anima fa sì che
emozioni e desideri non siano imputati esclusivamente alla corporeità.
Seguire lo sviluppo del discorso sull’anima nel Fedro offre dunque la possibilità di osservare
come Platone declini il tema del dualismo, di matrice orfica, in una tensione interna all’anima;
il problema circa la componente che deve essere fatta prevalere è significativamente risolto a
partire dalla considerazione dell’origine dell’anima e del suo legame con il divino.
L5- T5 La natura dell’anima
«Ora dobbiamo spiegare come gli esseri viventi siano chiamati mortali e immortali.
Tutto ciò che è anima si prende cura di ciò che è inanimato, e penetra per l’intero
universo assumendo secondo i luoghi forme sempre differenti. Così, quando sia
perfetta ed alata, l’anima spazia nell'alto e governa il mondo; ma quando un’anima
perda le ali, essa precipita fino a che non si appiglia a qualcosa di solido, dove si
accasa, e assume un corpo di terra che sembra si muova da solo, per merito della
potenza dell’anima. Questa composita struttura di anima e di corpo fu chiamata
essere vivente, e poi definita mortale. […] Veniamo a esaminare il perché della caduta
delle ali per cui esse si staccano dall’anima. Ciò accade all’incirca in questo modo. La
funzione naturale dell’ala è di sollevare ciò che è peso e di innalzarlo là dove dimora
la comunità degli dei; e in qualche modo essa partecipa del divino più delle e altre
cose che hanno attinenza col corpo. Il divino è bellezza, sapienza, bontà e ogni altra
virtù affine. Ora, proprio di queste cose si nutre e si arricchisce l’ala dell’anima,
mentre dalla turpitudine, dalla malvagità e da altri vizi, viene corrotta e perduta»
[Fedro, 246b – 246d. Traduzione di P. Pucci modificata].
Il mito evidenzia:
•
il nesso strutturale tra anima e corpo, per cui – secondo tradizione – alla prima spetta il
compito di vivificare (dare vita a) il mondo materiale, nel suo complesso e nelle sue
varie parti [di qui la multiforme pregnanza e presenza dell’anima];
•
•
•
il nesso essenziale tra psyché e mondo divino: quella dell’anima è una natura meta-fisica
– che la avvicina alla perfezione– ma tendenzialmente destinata a sollevare, con le proprie
ali, un corpo;
conseguentemente, il nesso essenziale tra anima e idee (bellezza, sapienza …) e, una
volta incarnata, la sua possibilità di recuperarle (reminiscenza);
il nesso essenziale tra contemplazione e destino dell’anima: essa nutre delle idee la
propria essenza metafisica, mentre ciò che è legato alle distrazioni del corpo è causa di
corruzione.
Il testo che segue mostra come Platone, affrontando il tema del destino dell’anima,
rielabori anche il tema orfico della reincarnazione.
L5- T6 Anima e incarnazione
«Ecco la legge di Adrastea. Qualunque anima, al seguito di un dio, abbia contemplato
qualche verità, fino al periplo successivo rimane estranea a dolori, e se sarà in grado
di far sempre lo stesso, rimarrà immune da mali. Ma quando l’anima, incapace di
seguire questo volo, non colga nulla della verità, quando, in conseguenza di qualche
disgrazia, impregnata di smemoratezza e vizio, si appesantisca, e per colpa di questo
peso perda le ali e precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima non si
trapianti in alcuna natura ferma durante la prima generazione; ma prescrive che quella
fra le anime che più abbia veduto si trapianti in un seme d’uomo destinato a divenire
un ricercatore della sapienza e del bello o un musico, o un esperto d’amore; che
l’anima, seconda alla prima nella visione dell’essere si incarni in un re rispettoso della
legge, esperto di guerra e capace di buon governo; che la terza si trapianti in un uomo
di stato, o in un esperto di affari e di finanze; che la quarta scenda in un atleta incline
alle fatiche, o in un medico; che la quinta abbia una vita da indovino o da iniziato;
che alla sesta si adatti un poeta o un altro artista d’arti imitative, alla settima un
operaio o un contadino, all’ottava un sofista o un demagogo, e alla nona un tiranno.
Ora, fra tutti costoro, chi abbia vissuto con giustizia riceve in cambio una sorte
migliore e chi è senza giustizia, una sorte peggiore. Perché ciascuna anima non
ritorna al luogo stesso da cui era partita prima di diecimila anni — giacché non mette
ali in un tempo minore — tranne l’anima di chi ha perseguito con convinzione la
sapienza, o di chi ha amato i giovani secondo quella sapienza. Tali anime, se durante
tre periodi di un millennio hanno scelto, sempre di seguito, questa vita filosofica,
riacquistano per conseguenza le ali e se ne dipartono al termine del terzo millennio.
Ma le altre, quando abbiano compiuto la loro prima vita, vengono a giudizio, e dopo
il giudizio, alcune scontano la pena nelle prigioni sotterranee, altre, alzate dalla
Giustizia in qualche sito celeste, ci vivono così come hanno meritato dalla loro vita,
passata in forma umana. Allo scadere del millennio, entrambe le schiere giungono al
sorteggio e alla scelta della seconda vita; ciascuna anima sceglie secondo il proprio
volere: è qui che un’anima può passare in una vita ferma e l’anima di una bestia che
una volta sia stata in un uomo può ritornare in un uomo; ma ad essere uomo non
potrà mai giungere un’anima che non abbia contemplato la verità» [Fedro, 248c –
249b. Traduzione di P. Pucci modificata].
Nell’ultima parte del mito Platone (come nel Gorgia, nel Fedone e nella Repubblica) si
intrattiene sul tema dei destini ultraterreni dell’anima e sulle modalità dei cicli di
reincarnazione:
•
la incarnazione dell’anima è originariamente prospettata come effetto di un deficit
contemplativo, di una carente visione della verità intelligibile;
•
•
•
•
•
a motivo della essenziale coappartenenza, l’anima nutre la propria natura immortale della
contemplazione degli enti intelligibili: il deficit contemplativo comporta dunque uno
scadimento di condizione, che si traduce, miticamente, nella perdita dell’ala e nella
caduta;
anche la caduta è condizionata dalla precedente visione: quanto più un’anima ha
comunque contemplato della verità, tanto migliore la sua destinazione incarnata;
Platone può così delineare una gerarchia di incarnazioni, dal mondo vegetale al vertice
del tipo uomo rappresentato dal filosofo, sottolineando come, in ogni caso, l’anima
umana sia quella che più ha contemplato [e quindi più o meno faticosamente in grado di
progredire verso la verità];
ogni incarnazione, così determinata, è seguita da un giudizio sulla condotta dell’anima
incarnata, accompagnato da remunerazioni o pene;
la originaria contemplazione incide ancora all’interno del ciclo delle reincarnazioni: le
anime di coloro che più contemplarono e che, conseguentemente, ricevettero un destino
migliore, saranno poi anche le prime, confermando in un circuito di tremila anni la scelta
di vita filosofica, a sfuggire al percorso previsto (diecimila anni), tornando alla patria
celeste con grande anticipo rispetto alle altre anime.
In definitiva, si può affermare che, nel Fedone come nel Fedro, che pure sviluppano
diversamente la tematica del dualismo anima-corpo, rimane ferma, saldamente ancorata alle
acquisizioni della seconda navigazione, l’appartenenza strutturale dell’anima all’ordine
metafisico: nella misura in cui l’anima conserva la memoria di questa origine e asseconda il
desiderio dell’intelligibile, che di tale origine è testimonianza, adempie il suo più alto
destino; per questo motivo i due dialoghi presi in esame sono concordi nell’additare
nell’esercizio filosofico la forma più indicata di “cura dell’anima”.
Parte prima: conclusioni
Con la diffusione della corrente religiosa orfica, il mondo greco conosce un nuovo schema di
civiltà, fondato su un rigido dualismo anima-corpo.
Nonostante il carattere frammentario e in gran parte tardo delle testimonianze, è possibile
stabilire i motivi centrali di tale forma di spiritualità:
•
•
•
•
•
l’anima umana è sede di un principio divino;
tale principio, totalmente eterogeneo rispetto al corpo, manifesta la sua presenza quando i
legami con il corpo si allentano (nel sonno o in prossimità della morte;
il fatto che l’anima divina sia racchiusa in un corpo è considerato un castigo;
l’esistenza nel corpo e la reincarnazione in corpi diversi sono per la psyché occasione di
espiazione;
la teogonia orfica presenta l’uomo come unione di un elemento divino, dionisiaco (anima)
e di un elemento titanico (corpo): il ciclo delle rinascite è finalizzato a liberare l’elemento
divino dall’involucro titanico.
La tematica della purificazione dell’anima, centrale nell’Orfismo, si può rintracciare
nell’opera di numerosi interpreti della filosofia antica, che a loro volta l’hanno arricchita di
precisazioni e sviluppi:
•
•
•
•
•
i Pitagorici accolgono l’esigenza orfica della catarsi, perseguita attraverso l’esercizio e
l’ascolto della musica, ma anche tramite l’indagine filosofica; la loro dottrina sull’anima
non riesce però a armonizzarsi con il dualismo orfico, inconciliabile con ogni prospettiva
naturalistica;
Empedocle accoglie le istanze fondamentali dell’Orfismo, ma non offre soluzioni circa il
rapporto fra l’anima divina e l’anima come espressione di un principio che si distribuisce
in tutta la natura;
a Eraclito si deve l’attribuzione all’anima dell’intelligenza;
con Socrate la riflessione filosofica sull’anima cessa di dividersi fra approccio
naturalistico e considerazione teosofica;
la seconda navigazione platonica offre la base speculativa per sviluppare il dualismo
anima-corpo; la filosofia si configura come autentico esercizio catartico.
Ricerche
Per quanto riguarda lo sviluppo del concetto di anima nell’universo spirituale greco, con
particolare attenzione all’età arcaica, resta fondamentale, per lo studente con una conoscenza
anche solo elementare della lingua greca, il contributo classico di B. Snell, L’uomo nella
concezione di Omero, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo, , Einaudi, Torino
1963.
Un testo recente e piuttosto accessibile che segue l’evoluzione del concetto di uomo da
Omero a Platone è Corpo, anima e salute di G. Reale, Cortina, Milano, 1999. Per quanto
riguarda i temi specifici oggetto della parte prima di questo percorso, si consiglia in
particolare la lettura del capitolo ottavo, dedicato all’Orfismo come schema di cultura in
antitesi con quello dei poemi omerici, del nono (La psyché nei primi filosofi) , dei capitoli 1012 dedicati alla “rivoluzione socratica” e del capitolo quindicesimo (La natura dell’anima
secondo Platone).
Una sintesi chiara e efficace degli aspetti essenziali della dottrina orfica si trova
nell’appendice prima (L’Orfismo e la novità del suo messaggio) al volume I della Storia della
filosofia antica in cinque volumi di G. Reale, Vita e pensiero, Milano, 1975.
Di primario interesse, soprattutto per le ipotesi circa le origini della religiosità orfica, e di non
difficile lettura è anche il capitolo dedicato all’Orfismo dal classico E.R. Dodds, I Greci e
l’irrazionale, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
Per accedere alla lettura delle testimonianze e dei frammenti orfici si può consultare G. Colli,
La sapienza greca, I volume, Adelphi, Milano,1977. Impegnativa ma di indubbio interesse è,
nello stesso volume, la lettura della parte dedicata a Orfeo dell’Introduzione.
Per quanto riguarda, nello specifico, i contributi più decisivi per l’evoluzione del concetto di
psyché, il tema della “rivoluzione socratica” può essere sviluppato a partire da un
approfondimento sulla figura di Socrate con la lettura di G. Reale, Socrate: alla scoperta
della sapienza umana, Rizzoli, Milano, 2000; altro testo di riferimento, di agevole
consultazione, può essere Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, di F. Sarri,
Vita e Pensiero, Milano,1997. Per quanto riguarda Platone, il problema dell’anima, del suo
rapporto con il corpo e della sua immortalità, oltre ai capitoli specifici nel già citato Corpo,
anima e salute è possibile consultare R. Di Giuseppe, La teoria della morte nel Fedone
platonico, Il Mulino, Bologna, 1993 e la raccolta di J. Patoĉka, Platone e l’Europa, Vita e
Pensiero, Milano, 1997.
Parte seconda: Il poema Sulla natura di Parmenide [lezioni 6- 9]
Lezione n. 6: Il Proemio
Parmenide espone la sua dottrina filosofica in un’opera in versi, che i commentatori posteriori
hanno intitolato Sulla natura; la datazione è incerta, ma potrebbe essere collocata verso il 468
a.C. Del poema rimangono 154 versi, raggruppati in 19 frammenti.
Il Proemio (fr. 1, integralmente conservato) evidenzia, meglio di ogni altro frammento, la
forte incidenza, all’interno dell’opera parmenidea, della componente mitico-religiosa e del
linguaggio poetico in cui essa si esprime. Altre parti (fr.2-8) presentano una marca
decisamente logico-ontologica, mentre una mescolanza di elementi mitici e logico-razionali si
riscontra sia nella parte finale del Proemio (v. T2), sia nella parte dedicata alla verità
(alétheia), che è anche Alétheia (figura divina), sia nella seconda parte, dedicata
all’esposizione delle opinioni degli uomini e della dottrina corretta del mondo delle
apparenze.
Il poema si presenta come armonica e compiuta sintesi di un aspetto propriamente miticopoetico, interpretato dal linguaggio dell’epica, e di un aspetto schiettamente filosoficorazionale, attestato dalla comparsa di una terminologia di inedita astrattezza. L’elemento
religioso, asse portante della costruzione mitico-poetica, non rimane confinato all’interno di
essa, ma estende la sua funzione strutturale all’edificio filosofico, caratterizzato dallo statuto
del tutto particolare di rivelazione destinata alla disamina razionale, in quanto garantita dalla
sua stessa inattaccabilità logica.
L6- T1 Proemio del poema
Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio
[vuol giungere,
mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e
[mi ebbero posto sulla via che dice molte cose,
che appartiene alla divinità e che porta per tutti i
[luoghi l’uomo che sa.
Là fui portato. Infatti, là mi portarono accorte cavalle
Tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via.
L’asse dei mozzi mandava un sibilo acuto,
[infiammandosi, in quanto era premuto da due
[rotanti
cerchi da una parte e dall’altra-, quando
[affrettavano il corso nell’accompagnarmi,
le fanciulle Figlie del Sole, dopo aver lasciato le case
[della Notte,
verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo.
Là è la porta dei sentieri della Notte e del Giorno,
con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra;
e la porta, eretta nell’etere, è rinchiusa da grandi
[battenti.
Di questi, Giustizia, che molto punisce, tiene le
[chiavi che aprono e chiudono.
Le fanciulle, allora, rivolgendole soavi parole,
con accortezza la persuasero, affinché, per loro, la
[sbarra del chiavistello
senza indugiare togliesse dalla porta. E questa, subito
[aprendosi,
produsse una vasta apertura dei battenti, facendo
[ruotare
nei cardini, in senso inverso, i bronzei assi
fissati con chiodi e con borchie. Di là, subito,
[attraverso la porta,
diritto per la strada maestra le fanciulle guidarono
[carro e cavalle.
[Parmenide, Poema sulla natura. Traduzione di G. Reale. DK28B1 vv. 1-22]
È fondamentale, per comprendere il singolare e multiforme registro dell’esposizione
parmenidea, mettere a fuoco anzitutto il significato di un impiego filosofico del linguaggio
mitico-epico rispetto alla cultura del tempo:
•
•
•
•
•
•
l’operazione di Parmenide non rappresenta un attardarsi sulle forme espressive
tradizionali, ma un loro consapevole recupero dopo l’affermazione della prosa filosofica
ionica e la polemica contro il mito, decisamente propugnata dalla filosofia milesia e da
Senofane;
Parmenide si contrappone alla razionalità di tipo ionico sia dal punto di vista del registro
espressivo, sia dal punto di vista dei contenuti; è anzi la nuova formalizzazione che egli
offre dei problemi affrontati dalla tradizione precedente che permette di evidenziarne
efficacemente i limiti;
all’interno di questa ri-formulazione delle domande dei predecessori riveste un ruolochiave proprio il ritorno al mito, e la sua lettura mediata da una sensibilità nuova: la
domanda fondamentale da cui muove l’indagine parmenidea non è la domanda sul
principio dal quale tutte le cose derivano e nel quale tutte ultimamente si risolvono
(tematica rispetto alla quale si può riscontrare una vicinanza della filosofia ionica alla
tradizione mitica), ma la domanda sull’essere e sugli enti e sulla loro verità;
il contenuto dell’epica, così come si trova espresso nell’Iliade a opera dell’indovino
Calcante (I, 70) e nella Teogonia di Esiodo dalle Muse (Proemio, 26 ss.), riguarda proprio
“le cose che sono” e “le cose che sono vere”, intese secondo l’apertura totalizzante
caratteristica delle grandi descrizioni cosmogoniche e teogoniche;
nel momento in cui riporta l’attenzione su le cose che sono e le cose che sono vere,
Parmenide si richiama al linguaggio che da sempre ne ha veicolata l’espressione, il
linguaggio del mito e dell’epica;
come coloro che a vario titolo disprezzavano il mito, privandolo di qualsiasi consistenza
razionale, non facevano differenza fra le varie tradizioni mitiche, accomunandole in una
generale irrisione, Parmenide, pur animato da una valutazione opposta, si muove
all’interno di una pluralità di riferimenti (Omero e Esiodo certamente, ma anche i
misteri, la tragedia, la lirica arcaica), che raccoglie non in un sincretismo più o meno
esteriore, ma tramite una robusta sintesi che disponga lo scenario per quell’essere e quella
verità evocati dal mito e in attesa di diventare gli eroi protagonisti di un altro discorso, il
lògos filosofico.
Anche la componente religiosa acquisisce reale spessore solo se esaminata nel suo contesto:
•
il contributo di Parmenide si inserisce nel quadro degli sforzi di perfezionamento del
concetto del divino che a partire dal VI sec. a.C. si esprimono attraverso la
destrutturazione della religiosità di tipo olimpico a favore dei culti misterici, specialmente
orfici, l’elaborazione di nuove teogonie, la polemica dei filosofi contro i culti tradizionali;
•
•
•
•
dal punto di vista filosofico, il nodo problematico in esame è quello dei “molti nomi del
divino”, nati nell’ambito della religiosità pre-ellenica ma, diversamente che in essa, non
più armonizzati nell’unità della dea-madre e conseguentemente esposti alla reciproca
scomposizione e opposizione;
dal momento che i nomi divini rispecchiano altrettanti aspetti del reale, il prevalere delle
divergenti determinazioni del divino sulla capacità di attrazione centripeta dell’unità della
dea-madre porta inevitabilmente con sé la disgregazione del reale stesso, frantumato in
una molteplicità irrelata e contraddittoria;
un tentativo di superamento di questa contraddizione è ravvisabile in un tragico come
Eschilo; in Senofane l’approdo è la cancellazione dei molti nomi; in Parmenide la
polinomia non è cancellata, ma conservata e esplorata come illustrazione delle
diverse regioni e dimensioni del Tutto;
alla considerazione logico-ontologica dell’essere totale fa riscontro sul piano miticoreligioso la divinità pre-ellenica della Grande Dea mediterranea, unica e medesima pur
nelle diverse denominazioni, che ne accentuano l’aspetto normativo (Anànke, Necessità;
Mòira, Destino; Peithò, Persuasione; Alétheia, Verità) nella prima parte del poema e il
carattere di scaturigine dei molti aspetti del reale nella seconda (Afrodite, corona celeste);
la riconduzione delle diverse figure divine a un’unica divinità è dunque allo stesso tempo
la ricomposizione e riconciliazione della molteplicità degli aspetti del reale.
Del resto, quella che nel poema si prospetta come una rivelazione da parte della Dea, altro
non è che l’automanifestarsi del reale, legato a nessi di necessità e di razionalità che
vincolano uomini e dei a convergere nell’assolutezza della legge dell’essere, del cui
autosvelamento sono testimoni. Infatti:
•
•
•
mentre le Muse esiodee possono dire anche il falso, la Dea di Parmenide è vincolata a
manifestare la verità, l’essere;
la Dea esorta ripetutamente a considerare (fr.6), giudicare con la ragione (fr.7) quanto
propone;
l’accento posto sul coinvolgimento razionale riveste di nuovo significato l’epiteto di uomo
che sa, attribuito al destinatario della rivelazione: ricorrente nei misteri, particolarmente
quelli orfici, per additare l’iniziato, indica, nel corso del poema, un tipo ben diverso di
sapere, la cui inattaccabilità consiste nella coerenza logico-razionale.
Gli elementi mitici e religiosi del Proemio si dispongono tutti intorno al motivo principale che
lo attraversa, quello del viaggio, a sua volta dotato di una valenza mitica, religiosa e
speculativa:
•
•
•
•
il tema della via rappresenta forma e contenuto della rivelazione: il messaggio della dea è
comunicato nel corso di un viaggio, ma allo stesso tempo riguarda le possibili vie di
ricerca e la loro percorribilità;
indicando l’unica possibile via di ricerca e argomentando tale unicità, la Dea conferisce
alla strada (odòs) per la quale guida l’uomo che sa anche la valenza di metodo
(méthodos);
la via “dice molte cose”, “appartiene alla divinità” e “porta per tutti i luoghi l’uomo che
sa”: traccia un cammino sicuro (v. “subito”, “diritto”) sviluppandosi attraverso il tutto;
come la via attraversa una regione e insieme è parte di essa, così la via è méthodos per la
conoscenza della verità e già parte della verità stessa;
il viaggio è raccontato da chi ha ricevuto la rivelazione, dopo aver fatto ritorno dalle case
della Notte verso il mondo della luce (illuminato quotidianamente dal sole, come attesta
l’epica); le Heliadi, figlie del Sole, dopo essersi allontanate i veli dal capo, accompagnano
il protagonista alla luce, scortandolo nel viaggio di ritorno, momento critico di qualsiasi
viaggio ultraterreno, come testimoniato dagli esempi di Kore e Persefone, Orfeo e
Euridice, Ulisse, Fetonte, Ercole e Alcesti; il fatto che l’accento sia posto sul viaggio di
ritorno assume una valenza del tutto particolare se si considera l’importanza attribuita da
Parmenide alla corretta spiegazione del mondo delle apparenze alla luce della conoscenza
della verità.
Il programma della rivelazione della Dea rivela del resto apertamente l’esigenza logicoespositiva di riappropriazione del mondo alla luce della verità:
L6- T2 L’annuncio della rivelazione
E la Dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano
[la mia mano destra
prese, e incominciò a parlare così e mi disse:
«O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici,
con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora,
rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto
[a percorrere
questo cammino - infatti esso è fuori dalla via[battuta
dagli uomini -,
ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto
[apprenda:
e il solido cuore della verità ben rotonda
e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera
[certezza.
Eppure anche questo imparerai: come le cose che
[appaiono
bisognava che veramente fossero, essendo tutte
in ogni senso».
[DK28B1vv. 23-34]
La rivelazione si dispiegherà dunque in tre momenti:
•
•
•
•
il solido cuore della verità ben rotonda, vale a dire il lògos, la norma che rende veri i
contenuti veri;
le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera certezza e che pertanto necessitano di
essere confutate;
la spiegazione di come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, essendo
tutte in ogni senso, cioè la descrizione del mondo dell’esperienza secondo la corretta
interpretazione di esso che si fonda sul solido cuore della verità ben rotonda;
soltanto a partire da esso si possono derivare tesi il cui statuto sia quello della vera
certezza: certezza, e non verità, in quanto concernente una materia legata al mondo
dell’apparenza, ma pur sempre vera, perché l’apparenza è riletta sulla base della norma
della verità; le opinioni dei mortali sono dunque fallaci sia considerate in se stesse,come
opposte alla esatta descrizione de le cose che appaiono, sia considerate nella radice
comune che le fonda, l’errore circa il cuore della verità ben rotonda.
Introducendo il protagonista alla rivelazione tramite le sue anticipazioni, comunque, la Dea
mette in chiaro almeno due aspetti:
•
•
bisogna che l’iniziato tutto apprenda: la verità è tale in quanto si dispiega come totalità
onnicomprensiva;
la contrapposizione non è fra verità e apparenza o opinione, ma fra verità e apparenza o
opinione che non si fondino sulla verità e non conseguano quindi vera certezza; non è
negato il mondo dell’apparenza, ma la sua erronea interpretazione sulla scorta dell’errore
dei mortali.
Lezione n. 7: Il linguaggio della Verità
L7- T1 Essere, pensiero, intelligenza
Orbene io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia
[parola –
quali sono le vie della ricerca che sole si possono pensare:
l’una che “è” e che non è possibile che non sia
è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro
[alla Verità
l’altra che “non è” e che è necessario che non sia.
E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si
[apprende.
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché
[non è fattibile,
né potresti esprimerlo
[DK28B2]
Il primo rilievo che si impone nell’affrontare il contenuto della rivelazione della Dea riguarda
il registro del discorso: per quanto esso tratti del nucleo speculativo della dottrina di
Parmenide, conserva numerosi tratti di marca mitico-poetica:
•
•
•
la parola che la Dea invita a ascoltare e ricevere è indicata, nel testo greco originale, con
mỳthos;
persuasione e verità sono personificate nelle rispettive divinità;
il motivo dominante continua a essere quello della via, impiegato in sede logicoontologica a indicare le vie di ricerca.
Sebbene il contesto sia quello ideale per la comunicazione di un sapere di tipo iniziatico,
dispensato benevolmente da una divinità dotata di conoscenza soprannaturale a un devoto in
grado di riceverne il messaggio senza poterne comprendere le ragioni, la rivelazione della Dea
non tarda a manifestare la sua peculiarità: l’indicazione delle vie di ricerca e l’opzione per
l’unica realmente percorribile sono fondate su di un criterio, quello della concepibilità (infatti,
non potresti conoscere ciò che non è, perché non è fattibile, né potresti esprimerlo) che è
pienamente a disposizione di colui che riceve la rivelazione; questi può dunque riconoscere,
in virtù della sua razionalità, le leggi logico-ontologiche nello stesso cristallino rigore che le
rende vere per la divinità.
Sulla base del criterio della concepibilità sono delineate due vie di ricerca:
•
•
•
sono le sole che si possano pensare: il riferimento al pensiero anticipa l’equazione
pensabile-possibile-essere, che esplicita il contenuto del criterio di concepibilità in
chiusura del frammento; l’accento posto sul fatto che le due vie di seguito esposte siano le
sole pensabili ribadisce poi la permanente esigenza parmenidea (già sottolineata in
apertura del discorso della dea) di evidenziare l’apertura totalizzante come strutturale a
qualsiasi trattazione intorno alla verità;
una via afferma la formula dell’esistenza; l’altra delinea preliminarmente un’alternativa
opposta, pretesa e contemplata sulla base della sua pensabilità programmatica, ma del
tutto inindagabile nelle sue implicazioni;
il tentativo di delineare astrattamente una metodologia produce le prime formulazioni di
regole-base del lògos filosofico: le due vie di ricerca reciprocamente incompatibili sono
infatti riconosciute come le uniche pensabili e la loro inconciliabilità è fondata sulla loro
radicale opposizione, che è opposizione fra contraddittori (la via “che è” non è possibile
che non sia, quella che “non è” è necessario che non sia);
A proposito della formulazione della cifra caratterizzante le due vie, il fr.2 ha dato luogo a
diverse interpretazioni; il punto controverso riguarda la necessità o meno di attribuire un
soggetto alle espressioni “che è” e “che non è” e l’eventuale scelta del soggetto più adeguato:
•
•
•
secondo una prima interpretazione l’ “è” sottintenderebbe il soggetto “l’essere”, che
emergerebbe chiaramente dai frammenti successivi; Parmenide intenderebbe
affermare: “l’essere è, il non-essere non è”; infatti il soggetto dell’espressione “è”, per
accordarsi con il contesto del discorso, deve essere in contraddizione con il non essere
e tale valore può essere assunto soltanto dall’espressione “essere”, intendendo con essa
il tutto e anche ogni singola cosa di cui occorre dire che “è”;
il soggetto di “è” potrebbe però più semplicemente cercarsi nel testo stesso, che fa
riferimento alle due vie: l’una sarebbe “la via che è”e che conduce alla verità, l’altra “la
via che non è”, che cioè non ha esistenza reale e porta allo sbandamento dell’errore;
anche la terza interpretazione, sostenuta da Calogero, non cerca un soggetto da inserire nel
testo, che intende in questo senso: la prima via dice “è” e afferma l’impossibilità del “non
è” (non è possibile che non sia); la seconda pretende di affermare il “non è” e il suo valore
di necessità (è necessario che non sia), chiaramente smentita dal nesso pensiero-essere,
avanzato con il criterio della concepibilità e esposto perentoriamente nel fr.3:
Infatti lo stesso è pensare ed essere[DK28B3]
È importante sottolineare come l’equazione pensare-essere, che, considerando anche gli ultimi
versi del fr.2 (con il riferimento all’esprimibile) diventa pensare-essere-dire non rifletta
l’ingenuità fondamentale sottesa alla credenza di tipo magico per cui il possesso del nome o
dell’immagine mentale di una cosa rappresenta immediatamente il dominio su di essa; infatti
la consapevolezza dello scarto tra pensiero (almeno umano) e potere sulla realtà è già presente
nel patrimonio epico quale portato del senso comune. Parmenide accoglie l’istanza dell’epica
che fa presente come l’identificazione di pensiero e potenza valga soltanto per gli dei, e
nell’affermare l’identità di essere, pensiero e parola trasferisce la potenza, il criterio sulla base
del quale pensiero e parola divengono realtà, dalla sfera del divino a quella stessa del pensiero
e della parola, reali purché veri e quindi radicati nella via dell’essere, della quale fanno essi
stessi indovinare il tracciato, costituendo il reale nella sua manifestazione.
L7-T2 Essere e enti
Considera come le cose che pur sono assenti, alla
[mente siano saldamente presenti;
infatti non potrai recidere l’essere dal suo essere
[congiunto con l’essere,
né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo,
né come raccolto insieme
[DK28B4]
Indifferente è per me
Il punto da cui devo prendere le mosse; là, infatti,
[nuovamente dovrò fare ritorno
[DK28B5]
I due frammenti:
•
•
•
•
•
sottolineano la compattezza dell’essere e di conseguenza la solo relativa dispersione
degli enti molteplici, saldamente congiunti nell’essere (contrassegnando il fatto di essere
proprio di ogni cosa esistente, l’essere rappresenta lo sfondo imprescindibile perché ogni
ente possa delinearsi come tale);
evidenziano il ruolo fondamentale della mente, dell’intelligenza (noùs) nel leggere, oltre
le multiformi apparenze degli enti dell’esperienza, ciò che soltanto lo sguardo razionale
coglie, ossia il loro muoversi comunque nella scena dell’essere;
presentano, particolarmente il fr.4, una scoperta polemica con la tradizione della
filosofia naturalistica ionica, le cui espressioni non sembrano coerenti con le assunzioni
di fondo sull’essere e la sua radicale opposizione al non-essere fatte proprie da Parmenide
e riconosciute come il solido cuore della verità ben rotonda;
in particolare, la perentorietà delle premesse parmenidee rende impossibile qualsiasi tipo
di distinzione all’interno dell’essere che ne incrini la compattezza; qualsiasi tentativo di
discriminare nell’ambito dell’essere è squalificato in quanto indebito recupero del nonessere inizialmente emarginato;
si capisce quindi come Parmenide si dimostri critico nei confronti di quelle dottrine che
affermano la stabilità e indefettibilità - caratteristiche dell’essere - di un principio (arché),
per poi operare delle distinzioni all’interno di esso per contrapporre il principio agli enti
sottoposti al divenire; così concentrazione e rarefazione (il bersaglio del fr.4 sembra
Anassimene) minano la solidità dell’essere e sembrano coinvolgere nuovamente il nulla.
Lezione n. 8: i segni dell’essere
L8- T1 L’errore dei mortali
«È necessario il dire e il pensare che l’essere sia: infatti l’essere è,
il nulla non è: queste cose ti esorto a considerare.
E dunque da questa prima via di ricerca ti tengo lontano,
ma, poi, anche da quella su cui i mortali che nulla sanno
vanno errando, uomini a due teste: infatti, è
l’incertezza che nei loro petti guida una dissennata mente. Costoro sono trascinati,
sordi e ciechi a un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio,
dai quali essere e non essere sono considerati la medesima cosa
e non la medesima cosa, e perciò di tutte le cose c’è un cammino reversibile»
[DK28B6]
«Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono!
Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero,
né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi
a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba
e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto discussa
che da me ti è stata fornita»
[DK28B7]
Le acquisizioni speculative fondamentali guadagnate nei frammenti 2, 3 e 4 sono decisamente
ribadite nei due testi riportati:
•
•
si ripropone l’equazione pensare-essere-dire (apertura del fr.6);
ritorna il tema dell’impraticabilità della via che “non è”, dalla quale l’iniziato deve
essere tenuto lontano
Il principale elemento di novità è dato dall’introduzione della figura dei mortali; nel
descriverne l’atteggiamento Parmenide sembra fare proprio il tono sdegnoso della polemica
eraclitea contro i molti:
•
•
•
il carattere che contraddistingue i mortali è la carenza del loro sapere: sono infatti
indicati con l’epiteto di mortali che nulla sanno;
questo difetto di conoscenza ha la sua ricaduta pratica nella figura dell’erramento,
particolarmente efficace nel segnalare con la sua valenza metaforica l’aspetto
propriamente epistemico dell’errore e insieme il disorientamento di chi procede su un
sentiero lungo il quale non sa fissare dei riferimenti e del quale dunque non può dominare
il tracciato;
l’idea del disorientamento è rafforzata dalla caratterizzazione dei mortali come sordi e
ciechi, sbalorditi: al difetto del giudizio e alla mente dissennata si accompagna la
inaffidabilità delle facoltà sensoriali, che li condanna all’isolamento e all’estraneità
rispetto alla loro stessa esperienza (di nuovo sembra riproporsi il riferimento a Eraclito).
L’errore dei mortali rappresenta una forma di sviamento dalla verità forse ancora più
minacciosa della via che “non è”:
•
•
•
pretende di coniugare essere e nulla (essere e non essere sono considerati la medesima
cosa e non la medesima cosa);
cade irrimediabilmente in contraddizione, come suggerisce l’immagine icastica degli
uomini a due teste;
ciononostante, presenta un carattere capzioso: apparentemente infatti sembra possedere
una propria fondatezza, dovuta all’accordo con l’esperienza; si tratta però di una
esperienza assunta nella forma passiva dell’abitudine, e dunque in maniera tale da
paralizzare le capacità conoscitive umane (l’occhio che non vede, l’orecchio che
rimbomba), piuttosto che esaminata con il contributo attivo della ragione.
Se la Dea, esponente della stirpe eterna dei “sempre essenti”, secondo l’epiteto dell’epica, si
fa portavoce della via di ricerca che pone l’essere come identico a se stesso, i mortali
viceversa sono coloro che affermano la coesistenza di essere e non essere e il trapassare
dell’uno nell’altro. Nella polemica possono essere coinvolti:
•
•
•
i naturalisti ionici, rei di attribuire i caratteri dell’essere a un solo principio per poi
privarlo di essi al momento di spiegare gli enti di esperienza;
probabilmente anche Eraclito (la sua filosofia del divenire è l’esatto opposto di quella
parmenidea della stabilità e il riferimento alla reversibilità dei processi riecheggia il fr.60
di Eraclito: Una e la stessa è la via all’in su e la via all’in giù );
più in generale, chiunque si affidi all’ abitudine nata da numerose esperienze (fr.7), che
compromette la capacità di disamina razionale sulla scorta dell’intelligenza (per la quale
le cose assenti non scadono nel non-essere, ma rimangono saldamente presenti) e forza a
muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che/ rimbomba e la lingua. La lingua in
particolare non esprime la compiutezza dell’essere e non rispecchia la realtà: il fr.8
preciserà che sono meri nomi quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che
fossero vere:/ nascere e perire, essere e non essere,/ cambiare forma e mutare luminoso
colore.
Una volta marcato lo stacco rispetto alle opinioni dei mortali, la Dea espone una parte
fondamentale della sua rivelazione:
L8- T2 I segni dell’essere
Resta solo un discorso
[della via:
che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori
assai numerosi: che l’essere è ingenerato e imperituro,
infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza
[fine.
Né una volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto
[quanto,
uno, continuo. Quale origine, infatti, cercherai di
[esso?
Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere
[non ti concedo
né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né
[dire né pensare
che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto
a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla?
Perciò è necessario che sia per intero, o non sia
[per nulla.
E neppure dall’essere concederà la forza di una
[certezza
che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa
[ragione né il nascere
né il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo
[dalle catene,
ma saldamente lo tiene. La decisione intorno a tali
[cose sta in questo:
“è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario,
che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e
[inesprimibile, perché non del vero è la via, e invece che l’altra è, ed è vera.
E come l’essere potrebbe esistere nel futuro? E come
[potrebbe essere nato?
Infatti, se nacque, non è; e neppure esso è, se mai
[dovrà essere in futuro.
Così la nascita si spegne e la morte rimane ignorata.
E neppure è divisibile, perché tutto intero è
[uguale;
né c’è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere.
Perciò è tutto intero continuo: l’essere, infatti, si
[stringe con l’essere.
Ma immobile, nei limiti di grandi legami
È senza principio e senza fine, poiché nascita e
[morte
sono state cacciate lontane e le respinse una vera
[certezza.
E rimanendo identico e nell’identico, in sé medesimo
[giace,
e in questo modo rimane là saldo. Infatti, Necessità
[inflessibile
lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra
[tutt’intorno,
poiché è stabilito che l’essere non sia senza
[compimento:
infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse,
[mancherebbe di tutto.
Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il
[pensiero,
perché senza l’essere nel quale è espresso,
non troverai il pensare. Infatti, nient’altro o è o sarà
all’infuori dell’essere, poiché la Sorte lo ha
[vincolato
ad essere un intero e immutabile. Per esso saranno nomi
[tutte
quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che
[fossero vere:
nascere e perire, essere e non essere,
cambiare luogo e mutare luminoso colore.
Inoltre, poiché c’è un limite estremo, esso è compiuto
Da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera,
a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti, né
[in qualche modo più grande
né in qualche modo più piccolo è necessario che sia, da
[una parte o da un’altra.
Né, infatti, c’è un non -essere che gli possa impedire di
[giungere
all’uguale, né è possibile che l’essere sia dell’essere
più da una parte e meno dall’altra, perché è un
[tutto inviolabile.
Infatti, uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei
[suoi confini
[DK28B8 vv.1-49]
La via che “è” è costellata di segni indicatori, che manifestano ciascuno un particolare aspetto
dell’essere:
•
•
•
•
i segni (sémata) sono indizi che alludono a qualche cosa che li trascende e rappresentano
un invito a oltrepassarli; possono essere letti correttamente solo da chi conosca già
l’essere, al quale alludono; il fatto di condividere l’essere come riferimento comune
determina il fatto che i segni si implichino reciprocamente e siano correttamente intesi
solo come diversi aspetti di un’unica realtà; isolarne uno o alcuni sarebbe già negare
l’essere (è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla);
il metodo impiegato per ricavare i segni è quello della riduzione all’assurdo degli aspetti
della realtà illusoriamente attestati dai sensi (nascita, corruzione, divisibilità…); la
negatività (nel senso di carenza d’essere) che in essi emerge, una volta negata, produce
l’affermazione della assoluta positività;
i caratteri dell’esperienza vengono progressivamente ridotti all’assurdo in quanto avversi
ai postulati fondamentali dell’identità dell’essere con se stesso, della sua assoluta
incompatibilità con il suo opposto, il non-essere, e dell’uguaglianza essere-pensiero,
che infatti ritornano periodicamente nel fr.8 a segnare il ritmo della descrizione
ontologica;
dal punto di vista stilistico e del lessico, la presentazione dei segni dell’essere si
caratterizza per un elevato livello di astrattezza terminologica e agguerrita sottigliezza
argomentativa: basti citare il metodo confutatorio della riduzione all’assurdo,
consapevolmente codificato solo più tardi, da Zenone, o la formulazione del principio di
ragion sufficiente nella forma dell’ex nihilo nihil fit; considerando questi aspetti del
discorso parmenideo, alcuni interpreti ipotizzano alle spalle di esso un consistente
patrimonio di discussioni orali, che ne giustifichino la maturità logica.
Questa risulta, in sostanza, la struttura dell’argomentazione di Parmenide: l’essere è:
•
•
ingenerato e imperituro: - in quanto è una totalità compiuta (uno intero nel suo insieme,
immobile, senza fine, ora insieme tutto quanto, uno, continuo); - in quanto la temporalità
coinvolge il nulla (non può essere nato dal non-essere, perché non c’è necessità alcuna
della derivazione di qualcosa dal nulla; non può essere nato dall’essere, perché ne avrebbe
compromessa la compattezza; l’“è” ha come sua unica dimensione la puntualità
atemporale – se nacque, non è; e neppure esso è, se mai dovrà essere in futuro)
indivisibile: a motivo della sua omogeneità e densità (tutto intero uguale, tutto intero
pieno di essere, tutto intero continuo), per cui l’essere si stringe con l’essere
•
•
•
identico e nell’identico: giace saldo in sé medesimo in quanto è compiuto (non manca di
nulla)
compiuto da ogni parte: c’è infatti un limite estremo
simile a massa di ben rotonda sfera, a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti
la dissimmetria non può esservi introdotta dal non-essere né tantomeno dall’essere, della
cui compattezza costituirebbe una violazione.
L’equilibrio perfetto suggerito dall’immagine della ben rotonda sfera, a partire dal centro
uguale in ogni parte consolida ulteriormente l’idea dell’immobilità, che ritorna per ben tre
volte nel frammento e si precisa con il riferimento ai grandi legami del limite estremo, sigillo
di perfezione in quanto compiutezza, secondo un modo di sentire tipicamente pitagorico;
l’accenno ai legami della Necessità, così come alle catene della Giustizia serve del resto non
solo a preparare e rendere intelligibile l’immagine della sfera, ma anche a significare, secondo
il consueto intreccio di piano mitico e piano filosofico-razionale, un’immobilità del tutto
particolare, ottenuta tramite quel tipo particolare di costrizione che è la cogenza delle leggi
logiche.
Lezione n. 9: La dottrina vera dell’apparire
Nel fr.8 la Dea si accinge a illustrare sinteticamente il contenuto delle opinioni fallaci dei
mortali, e ne ribadisce il carattere capzioso, preannunciando il fatto che le sue parole
successive presenteranno un andamento seducente. La spiegazione del mondo delle apparenze
secondo l’opinione dei mortali è effettuata a partire da due principi, due forme, l’etereo fuoco
della fiamma e la notte oscura (forse di matrice pitagorica), l’unità delle quali per loro non è
necessaria.
Proprio questo aspetto fa sì che la loro dottrina del mondo dell’esperienza non sia dotata di
vera certezza: per poterla correggere è necessario apprendere come le cose che appaiono
bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso.
L9- T1 Luce e Notte e il loro legame con l’essere
E poiché tutte le cose sono state denominate luce
[e notte,
e le cose che corrispondono alla loro forza sono
[attribuite a queste cose o a quelle,
tutto è pieno ugualmente di luce e di notte oscura,
uguali ambedue, perché con nessuna delle due c’è il
[nulla
[DK28B9]
Il frammento sintetizza la dottrina parmenidea del mondo dei fenomeni, con particolare
attenzione a marcare lo scarto rispetto alle “opinioni dei mortali” (che comunque colgono nel
segno nell’individuare una polarità e nel ricostruirne i termini – etereo fuoco della fiamma e
notte oscura sono pressoché sovrapponibili a luce e notte):
•
•
•
•
contro quanti non sanno vedere l’unità necessaria dei due opposti principi, Parmenide ne
sottolinea, pur nell’opposizione, l’uguaglianza (ugualmente, uguali ambedue), e quindi
l’equipollenza;
l’equivalenza delle due potenze si motiva, contro quanti affermano l’indebita mescolanza
di essere e non-essere, con il loro comune radicamento nell’essere, che ne giustifica
anche la implicazione reciproca;
se Luce e Notte rappresentano i principi ai quali la totalità dell’essere che appare è
riconducibile e con nessuna delle due c’è il nulla, non ci sono aspetti del mondo
dell’esperienza che non siano ricompresi nell’essere: l’errore dei mortali consiste
dunque nello scambiare la differenziazione delle potenze nell’ambito della manifestazione
fenomenica dell’essere con una differenza di stampo ontologico;
la discriminazione di Luce e Notte, all’origine del mondo dell’esperienza, non
contravviene dunque alla norma esposta nel fr.8 per cui l’essere è un tutto intero continuo,
costituendone piuttosto la conferma anche per il mondo fenomenico (con nessuna delle
due c’è il nulla), contro la lettura della polarità offerta dai mortali, che scambiano i lati
notturni dell’essere per non-essere.
L’insistenza sul motivo della totalità (tutte le cose sono state denominate luce e notte, tutto è
pieno…) sulla quale si esercita il potere esplicativo delle due potenze dimostra come
Parmenide intenda, in sede di descrizione del mondo fenomenico, confrontarsi con la
tradizione naturalistica dei filosofi dell’archè, che si proponevano di ricondurre appunto la
totalità degli enti di esperienza all’elementarità di un principio:
•
•
•
•
nel caso di Parmenide l’arché si esprime attraverso due forze che si implicano
reciprocamente in una opposizione di tipo polare finalizzata alla loro mescolanza e alla
conseguente costituzione della totalità delle forme dell’apparire;
la veste duplice dell’arché prepara la sua evoluzione nel senso di elemento, ulteriormente
evidente in Empedocle;
l’individuazione di una duplicità di potenze si svolge comunque in un quadro in cui molto
forte è la sottolineatura della compatta unità dell’essere di cui Luce e Notte sono
l’espressione nel mondo fenomenico;
si delinea quindi, rispetto all’indagine dei filosofi naturalisti, una nuova collocazione
della ricerca sull’arché: la spiegazione sulla base di potenze opposte fra loro non è
l’unica o ultima; riguarda il mondo dell’apparire, non degradato a mera parvenza, ma
comunque tenuto fermo nella sua subordinazione e ricomprensione nell’essere (alla quale
si può far risalire la considerazione della fisica come scienza subordinata all’analisi
schiettamente ontologica).
L9- T2 Il programma della cosmologia
Tu conoscerai la natura dell’etere, e nell’etere
[tutte quante
le stelle, e della pura lampada del sole lucente
le invisibili opere e donde ebbero origine,
e apprenderai le azioni e le vicende della luna
[errabonda dall’occhio rotondo
e la sua natura; e conoscerai altresì il cielo che tutto
[circonda,
donde ebbe origine, e come la Necessità lo guidò e
[costrinse
a tenere fermi i confini degli astri.
[DK28B10]
L9- T3 Il governo della Dàimon
Le corone più strette furono riempite di fuoco non
[mescolato,
quelle che seguono ad esse furono riempite di notte,
[ma in esse si immette una parte di fuoco;
nel mezzo di queste sta una divinità che tutto
[governa:
dovunque, infatti, essa presiede al doloroso parto e
[alla congiunzione,
spingendo la femmina ad unirsi col maschio, e,
[all’inverso, di nuovo,
il maschio con la femmina.
[DK28B12]
La dottrina vera del mondo dell’apparire deve illustrare le modalità della manifestazione
dell’essere nell’ambito del visibile; deve dimostrare che l’essere è davvero “tutto” e quindi
abbraccia anche l’apparire, nel quale si completa. È quindi interessante rintracciare, in
apertura del discorso sulla cosmologia, alcuni tratti che richiamano la descrizione dell’essere
così come è prospettata nella parte dedicata all’esposizione della verità (alétheia):
•
•
•
•
il cielo che tutto circonda è guidato e costretto a tenere fermi i confini degli astri: il
richiamo è al fr. 8, là dove l’essere è descritto come immobile nei limiti di grandi legami,
saldo in sé medesimo, così che uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei suoi confini;
a determinare l’azione del cielo di mantenere saldi i confini è la Necessità, la stessa figura
che nel fr.8, inflessibile, tiene nei legami del limite l’essere: la Necessità si conferma,
nella trattazione sull’essere come in quella sull’apparire, la forza che stringe l’essere con
se stesso mantenendo dunque tutte le cose nell’essere;
il riferimento alle corone (il termine greco può indicare anello ma anche zona sferica o,
più genericamente, un punto attorno al quale si dispone una formazione di tipo circolare)
riecheggia l’immagine della ben rotonda sfera del fr.8: la compiutezza e il perfetto
equilibrio dell’essere non possono che rispecchiarsi in un universo compiuto;
il dinamismo che si associa all’immagine della circolarità in sede di cosmogonia non è
comunque del tutto assente neppure nella descrizione della sfera dell’essere; l’immobilità
da e verso il non-essere non esclude che l’essere sia in qualche modo attivo nella sua
densità: un indizio si troverebbe nel dinamismo interno alla descrizione del fr.8, che
considera la sfera alternativamente dal centro alla periferia e viceversa.
La cospicua parte del poema dedicata alla spiegazione dell’apparire (più di un terzo)
testimonia l’importanza attribuita da Parmenide a questa sezione, che si presenta con i
caratteri di una autentica “enciclopedia”, che spazia dalla cosmogonia e cosmologia alla
teogonia, all’antropologia e alla fisiologia; il linguaggio richiama da vicino quello di Esiodo,
ma anche quello della prima parte del poema: alla connessione necessaria fra concetti
caratteristica della logica dell’essere corrispondono i rapporti genealogici fra potenze divine,
confermando come la scelta del registro mitico-poetico sia opzione consapevole e finalizzata
al conseguimento di una maggiore espressività e significatività e non esito obbligato di
ingenuità comunicativa.
A proposito del procedimento esplicativo adottato, è significativo notare:
•
•
•
il rilievo attribuito alla conoscenza della natura delle cose, ricavabile a partire dalle
loro azioni (così si devono conoscere la natura dell’etere, le opere del sole e la loro
origine – la natura da cui derivano, e ancora le azioni e le vicende della luna e la sua
natura; anche del cielo si osserva prima l’azione di circondare tutto, poi l’origine,- la
natura, dalla quale ridiscendere poi a considerare le attività);
il richiamo alla Dea (Dàimon) come centro unificatore del sistema dell’universo: il
rischio che la polemica intorno ai “molti nomi degli dei” portasse a una disgregazione del
reale nei suoi diversi aspetti è decisamente scongiurato: tutto è pieno di essere e tutto è
pieno di Luce e Notte, la cui mescolanza è orchestrata dalla Dàimon;
il ruolo centrale della Dea nel garantire la contiguità di tutti gli enti nell’essere, e
specificamente la continuità esistente fra cosmologia e antropologia, per cui è la stessa
Dea che presiede alla mescolanza di Luce e Notte e alla nascita degli uomini.
Parte seconda: conclusioni
Il poema è strutturato intorno a due nuclei fondamentali:
•
•
esposizione della verità;
presentazione del mondo dell’apparire: come è erroneamente considerato dai mortali e
come va correttamente spiegato.
Il proemio consente di ricavare alcuni elementi costanti del testo:
•
•
•
l’impiego filosofico del linguaggio mitico-epico;
il rilievo attribuito alla componente religiosa, nel quadro del dibattito sui molti nomi del
divino;
la presenza della tematica del viaggio, caricata di una duplice valenza mitologiconarrativa e speculativa.
Il poema tratta della rivelazione ricevuta dal protagonista a opera di una Dea; questa ne è, in
sintesi la struttura:
•
•
verità:
• presentazione delle sole vie di ricerca pensabili: una “che è”, l’altra che “non è” e su
cui nulla si apprende;
• esplicitazione del nesso pensare-essere-dire; ruolo centrale dell’intelligenza nel
rintracciare la verità dell’essere;
• descrizione dei segni dell’essere
mondo delle apparenze:
• opinioni fallaci dei mortali, che non individuano l’unità delle forze opposte con cui
spiegano il mondo dell’esperienza;
• dottrina vera dell’apparire: comune radice nell’essere di Luce e Notte, sottoposte
all’unico comando della Dàimon
Ricerche
Decisamente impegnativa ma fondamentale è l’edizione del Poema sulla natura di Parmenide
curata da G. Reale e L.Ruggiu, Rusconi, Milano 1991; un’ottima guida per affrontare la
lettura dei frammenti è offerta dal saggio introduttivo, che mette a fuoco alcuni temi centrali
per la comprensione e l’interpretazione del testo; molto ricchi sono anche i commenti ai
singoli frammenti.
Importante è anche l’edizione a cura di M. Untersteiner, Parmenide. Testimonianze e
frammenti, La Nuova Italia, Firenze, 1967; l’introduzione presenta tra l’altro una particolare
interpretazione delle due vie parmenidee.
Interessante e con puntuali rimandi al testo parmenideo è il paragrafo dedicato a Parmenide
nel capitolo settimo (Filosofia e scienza empirica alla fine dell’età arcaica) di H. Fraenkel,
Poesia e filosofia della Grecia arcaica, Il Mulino, Bologna,1997.
Un contributo classico nello studio del pensiero di Parmenide è quello consultabile nel
paragrafo terzo del quarto capitolo, a cura di G. Giannantoni, del volume III della Storia della
filosofia diretta da M. Dal Pra, Vallardi, Milano, 1975.
Si può fare riferimento anche al capitolo terzo del primo volume della Storia della filosofia a
cura di P. Rossi e C. A. Viano, Laterza, Roma-Bari, 1993.
Per quanto riguarda l’aspetto specificamente cosmologico del Poema sulla natura può essere
utile affrontare la lettura del capitolo sesto (Il mondo di Parmenide. Note sul poema di
Parmenide e sulla sua origine agli albori della cosmologia greca) di K. Popper, Il mondo di
Parmenide. Note sul poema di Parmenide. Alla scoperta della filosofia presocratica, Piemme,
Casale Monferrato, 1998.
Parte terza: Crisi della tradizione mitico-religiosa e nuovi orizzonti del pensiero
teologico nell’età della polis [lezioni 10- 13]
Lezione n. 10: Polemica e convivenza
L’orizzonte cittadino muta profondamente i punti di riferimento dell’uomo greco e tra questi
anche la dimensione religiosa: nell’Atene democratica del V secolo le avanguardie
intellettuali si scontrano con il conservatorismo di alcuni ambienti, ma talvolta trovano anche
nuove modalità di approccio alla tradizione. Preliminarmente è da ricordare la messa per
iscritto dei poemi omerici alla metà del VI secolo per iniziativa del tiranno ateniese Pisistrato,
che mette così a disposizione una versione ufficiale dei miti iliadici e odissiaci, ponendo un
freno al proliferare di varianti, ma, soprattutto, consentendo la riflessione critica su quanto si
trova in quei testi. A partire da qui è tutto l’apparato mitico a subire l’attenzione, spesso in
chiave polemica, degli intellettuali ateniesi. Nonostante la fissazione e il conseguente
irrigidimento del mito, esso continua a stimolare la fantasia, a rimodellarsi tra le mani dei
pensatori che ne sfruttano la caratteristica duttilità e poliedricità.
Il poeta-filosofo Senofane di Colofone, che nasce intorno al 570 a.C., scaglia i suoi strali
contro Omero e Esiodo:
L10-T1 Contro Omero
Omero e Esiodo hanno attribuito agli dei tutto ciò che per gli uomini è onta e
biasimo: e rubare, e fare adulterio e ingannarsi a vicenda.
[fr.11 DK]
Ma i mortali si immaginano che gli dei siano nati e che abbian vesti, voce e figura
come loro.
[fr. 14 DK]
Ma se i bovi e i cavalli e i leoni avessero le mani, o potessero disegnare con le mani, e
far opere come quelle degli uomini, simili ai cavalli il cavallo raffigurerebbe gli dei, e
simili ai bovi il bove, e farebbero loro dei corpi come quelli che ha ciascuno di loro.
[fr.15 DK]
Gli Etiopi dicono che i loro dei hanno il naso camuso e son neri, i Traci che hanno
gli occhi azzurri e i capelli rossi.
[fr.16 DK]
I frammenti presentati polemizzano contro tre aspetti dell’immagine degli dei tratteggiata dai
due poeti:
•
•
•
l’antropomorfismo del loro aspetto esteriore;
l’empietà dell’attribuzione agli dei di caratteri psicologici e azioni biasimevoli, che li
abbassa a livello quasi umano;
l’arbitrarietà di una simile raffigurazione che risente di un assurdo particolarismo etnico,
tanto che le divinità finiscono con l'assomigliare anche fisicamente ai popoli di cui sono
costruzione.
Se vi sono dei, essi si devono necessariamente distinguere dagli uomini. Il vecchio pantheon
non soddisfa dunque le esigenze della polis: gli dei omerici sono oggetti costruiti, frutto di
opinione, sottoponibili a falsificazione. Senofane non sembra però avvertire la costitutiva
antistoricità della sua operazione: si confronta con Omero come con un concittadino, non
tiene conto del fatto che il suo mondo e il suo universo conoscitivo sono profondamente
diversi dal contesto che ha dato origine ai miti che critica.
Omero, ovviamente, non può rispondere di persona alle critiche di Senofane; in sua difesa si
schierano dunque i rapsodi. L'arma più efficace per difendere un testo ormai immutabile
perché scritto diventa la interpretazione allegorica.
Tornando al carattere di costruzione attribuito da Senofane agli dei, è facile notare come,
accanto alla critica alla pedagogia poetica, si affaccino dubbi anche più profondi sulla natura
reale della divinità. Si indaga innanzitutto sulla genesi del pantheon olimpico. La risposta
razionalistica più efficace e radicale si ha con Crizia, in linea con le prime formulazioni
dissacranti circa la natura contrattualistica dello Stato e l’opposizione phỳsis-nòmos (naturalegge) elaborate nell’ambiente sofistico.
L10-T2 La vera origine degli dei
“Un tempo vi fu quando senz’ordine era la vita umana e bestiale e serva della forza,
quando non c’era premio per i buoni né quindi si davano castighi ai malvagi. In
seguito penso che gli uomini abbiano emanato leggi per punire, affinché la giustizia
sia sovrana di tutti al pari e consideri schiava l’insolenza. Ed era castigato chiunque
errasse. Quindi, poiché le leggi impedivano loro di compiere delitti palesi con
violenza, ma occultamente agivano, allora io credo che per la prima volta un uomo
astuto e saggio nella mente inventò per gli uomini il terrore degli dei, perché i tristi
temessero anche per ciò che in modo occulto compissero o dicessero o pensassero.
Quindi introdussero il divino che è manifestazione demonica fiorente di vita
immortale che con forza percettiva ode e vede, attuando una volontà e reggendo il
tutto, avendo perennemente in sé natura divina; questa forza demonica udrà quanto
fra gli uomini si dice e vedere potrà ogni loro azione. Se mala impresa tu mediti in
silenzio, non sfuggirà agli dei, perché capacità percettiva sta negli dei. Con questa
dottrina addusse il più soave degli insegnamenti occultando la verità con falso verbo.
Diceva che gli dei abitano colà dove egli al sommo poteva atterrire gli uomini, donde
sapeva che ai mortali timori provengono e lotte alla misera vita, dall’alto vortice, dove
vedeva trovarsi i fulmini e i fragori orrendi del tuono e la stellante volta urania, bel
ricamo del saggio artefice Chronos, da dove muove la massa fulgida del sole e la
pioggia scende umida a terra. Tali terrori vibrò attorno agli uomini e tramite il loro
aiuto, ragionando, bene instaurò la potenza demonica e in luogo adatto, e spense con
le leggi l’assenza di ogni legge.
Dopo un breve sviluppo d’idee aggiunge:
Così, penso, in principio qualcuno persuase gli uomini a credere che gli dei esistano.”
[Crizia, Sisifo fr.25 DK]
La tesi centrale nel testo di Crizia è l’affermazione della natura politica della credenza negli
dei. L’argomentazione si sviluppa progressivamente nei seguenti punti:
•
•
•
•
l’esistenza di uno stadio bestiale della storia umana, uno stato di natura privo di leggi,
in cui, complice la natura dell’uomo, vigono anarchia e violenza;
la instaurazione umana delle leggi allo scopo di salvaguardare la giustizia e di rendere
tutti uguali dinanzi a essa;
la capacità coercitiva della legge si limita all’ambito delle azioni pubbliche, palesi,
visibili;
il timore degli dei supera tali limiti rendendo l’individuo visibile in ogni momento
all’occhio panoramico del dio;
•
la creazione delle figure divine è del tutto strumentale al controllo sociale e le
caratteristiche degli dei sono funzionali al loro compito di controllo sulle azioni private
degli uomini.
Chiariti questi passaggi si può facilmente notare il parallelismo proposto da Crizia tra legge e
credenza negli dei, l’una valida in pubblico, l’altra in privato, ma entrambe fonti di
limitazione della phỳsis che, se richiede l’imposizione di barriere, è perché potenzialmente
distruttiva della convivenza civile: la società umana priva di nòmos è infatti connotata come
senz’ordine, bestiale e serva della forza. Ma per controllare le spinte bestiali dell’uomo non è
sufficiente la legge, occorre un dio che vede e ode tutto ciò che l’uomo compie, anche in
segreto.
Accanto alla motivazione politica addotta da Crizia per dar conto del culto degli dei, Prodico
di Ceo avanza un’ipotesi per certi versi simile, basata sull’utile quale fondamento della
teologia. Chiarissima è la testimonianza di Sesto Empirico:
L10-T3 Dei e Utile
Prodico di Ceo afferma: ”Gli antichi considerarono dei, in virtù del vantaggio che ne
derivava, il sole, la luna, i fiumi, le fonti e, in generale, tutte le forze che giovano alla
nostra vita, come, per esempio, gli Egizi il Nilo” e per questo il pane era considerato
come Demeter, il vino come Dioniso, l’acqua come Posidone, il fuoco come Efesto,
e così ciascuno dei beni che ci è utile.
[Sesto Empirico, Contra matematicos, IX, 18=DK 84B5]
Prodico, pur rifiutando un’etica volta al conseguimento del piacere, sostiene però che la
morale non è mai disgiunta da ciò che è vantaggioso e utile per chi la pratica. All’interno di
questa visione rientra anche la sfera religiosa, pertanto:
•
•
gli dei non sono altro che le entità che si dimostrano utili alla vita umana che hanno subito
un processo di divinizzazione dimenticato con il passare del tempo;
implicitamente è chiaro che solo l’oblio di questa operazione consente che si formi
un’idea del divino come dotato di un’esistenza indipendente dall’uomo che lo costruisce a
immagine e somiglianza del mondo che lo circonda, come per sottolinearne con una
personificazione gli aspetti che risultano più carichi di valore, specie materiale, per la sua
vita.
Dati questi presupposti, è abbastanza semplice comprendere le ragioni per cui l’esistenza
degli dei viene messa in dubbio da un altro esponente della sofistica, Protagora:
L10-T4 Il problema dell’esistenza degli dei
Riguardo agli dei non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, né
di che natura sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la
brevità della vita umana.
[fr.4 DK]
Di tutte le cose misura è l’uomo: di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che
non sono per ciò che non sono.
[fr.1 DK]
I due frammenti sono strettamente legati:
•
•
è impossibile prendere posizione, per mancanza di prove, circa l’esistenza degli dei e,
eventualmente, circa la loro natura;
non resta all’uomo che affidarsi a se stesso come misura (métron) delle proprie azioni,
dei propri valori, delle proprie verità: resta solo il giudizio sul mondo espresso da un
tribunale composto da uomini.
Si intuisce come posizioni tanto radicali, agnostiche, razionalistiche, demistificanti non
potessero essere facilmente accolte dalla città e fossero suscettibili di essere interpretate come
mosse rivoluzionarie, destabilizzanti, empie e pertanto da condannare, pena la decadenza
della città stessa. Questa è la posizione del commediografo Aristofane che, nelle Nuvole,
commedia del 423 a.C., assimilando la figura di Socrate a quella di un sofista-naturalista,
condanna tutto un clima culturale colpevole ai suoi occhi di voler cancellare la tradizione
religiosa dei padri.
L10-T5 Il conservatore Aristofane
Fidippide: Che ne diresti se usando il discorso minore ti convincessi a forza di parole
che si impone di suonare la propria madre?
Strepsiade: Chi ti può impedire se fai questo di buttarti nel burrone tu, Socrate e il
discorso minore? Per voi mi succede, o Nuvole, dopo avervi affidato me stesso
Corifea: Solo tu sei causa di tutto: ti sei messo a fare il delinquente.
Strepsiade: perché non mi avvertivate allora, invece di illudermi, un campagnolo per
giunta vecchio?
Corifea: Lo facciamo sempre, quando vediamo uno che smani per le mascalzonate. Lo
imbarchiamo in un guaio, così impara a temere gli dei.
Strepsiade: E’ stato amaro, o Nuvole, ma santo: non dovevo negare i debiti che ho
fatto. (Al figlio) Nessuno mi tiene, adesso. Vieni con me, caro, andiamo ad accoppare
quel mascalzone di Cherefonte e Socrate. Ci hanno ingannati, me e te.
Fidippide: Come, fare un torto ai maestri?
Strepsiade: Certo, e rispetta il dio dei padri tuoi
Fidippide: Sentilo, il dio dei padri! Uomo antiquato : che, esiste dio?
Strepsiade: Esiste sì.
Fidippide: Noooh: da quando regna la Turbina, che ha cacciato Zeus.
Strepsiade: Che cacciato? Ci credevo pure io, non si parla che di turbine oggi! Povero
me, che l’ho creduta un dio!
Fidippide: Continua a sragionare, per conto tuo: tutte sciocchezze! (Esce)
Strepsiade: Oh, che mattana: ero pazzo, rinnegare gli dei per via di Socrate! (Rivolgendosi
a un’edicola del dio) Non ti arrabbiare, Ermete caro,non rovinarmi: abbi pietà, avevo
perso la testa per la chiacchiera. Dammi un consiglio: li devo citare in tribunale, o che
ti pare? Hai ragione, dici di non fare processi: dare subito fuoco alla casa dei
lestofanti? (Al servo) Corri, Santia, corri fuori: prendi una scala, porta il piccone.
Arrampicati sul Pensatoio, sfonda il tetto, se vuoi bene al padrone: finchè non gli
cade la casa addosso. Portatemi una torcia, accesa: oggi me la paga, uno di loro,
hanno voglia di imbrogliare!
[Aristofane, Nuvole, trad. Marzullo]
Il brano è tratto dal finale della commedia, momento in cui il vecchio Strepsiade, dopo aver
convinto Socrate a istruire il figlio Fidippide affinché possa, con abile arte retorica, tener
lontani i creditori, si trova davanti il figlio che, educato secondo i dettami socratico-sofistici,
non riconosce più gli antichi valori (il rispetto per i genitori in particolare) né le divinità
olimpiche. Il vecchio, ingannato dai miraggi della nuova cultura, si pente ora di avervi fatto
ricorso e cerca di riportare il figlio alla ragione.
Il testo stigmatizza:
•
•
•
•
la venerazione per i maestri da parte dei giovani allievi: l’adesione ai retori incantatori e
alle loro empie teorie distrugge il timore verso gli dei;
il naturalismo delle concezioni filosofiche dell’epoca con la conseguente divinizzazione
della natura e dimenticanza degli dei olimpici: la Turbina e le Nuvole hanno cacciato
Zeus;
l’immoralità conseguente ai nuovi insegnamenti: Fidippide picchia il padre e minaccia
di fare lo stesso con la madre, pensando di poter persuadere chiunque della giustezza di
simili atti;
l’agnosticismo di alcune posizioni: si veda, a riprova, il testo di Protagora.
Nonostante la radicalità delle posizioni sofistiche, proprio in questo clima si nota la
permanenza di figure mitiche e delle loro vicende nel bagaglio culturale degli intellettuali
dell’epoca che piegano tali reminiscenze alle proprie esigenze argomentative e ai nuovi criteri
di valutazione. Esemplare è il caso di Gorgia, che utilizza il personaggio di Elena e i
controversi giudizi espressi su di esso per mostrare la forza persuasiva delle parola.
Gorgia intraprende l’impresa titanica di difendere l’agire di Elena scandagliandone le possibili
motivazioni, le attenuanti, le circostanze. Fa di se stesso il difensore di un imputato nel
tribunale cittadino, impegnato a convincere con la sola forza della parola i giudici. La
rivoluzionaria riabilitazione di Elena è un gesto che mette in discussione l’affidabilità e il
valore della verità mitica e, dunque, di un’intera cultura.
Anche a Protagora è attribuita, da Platone (Protagora, 320d-322d), la narrazione di un mito
a sostegno della sua concezione politico-pedagogica: il mito riguarda l’origine delle comunità
umane, che, alla stregua di Crizia, Protagora vede come inizialmente afflitte da disordini e
discordie cui pone fine Zeus distribuendo ai mortali pudore e giustizia. Il mito si fa in questa
occasione fautore del sistema democratico.
Lezione n. 11: Socrate e gli dei cittadini
Personaggio esemplare, intellettuale cittadino per eccellenza, Socrate è una figura carica di
segreti e difficoltà interpretative: accanto alla questione delle fonti, del suo silenzio, delle sue
dottrine, è innanzitutto il suo rapporto con la città a costituire un problema. Il cittadino
irreprensibile e fiero della sua cittadinanza, tanto da non allontanarsi mai dalla patria, è
condannato dal tribunale dei concittadini con accuse infamanti di corruzione dei giovani e
empietà. Le testimonianze di Senofonte e Platone sottolineano l’assurdità delle imputazioni,
ribadendo la fedeltà di Socrate ai culti patrii, ma soffermandosi anche sugli aspetti che
distinguono la sua visione degli dei da quella comune.
Senofonte si chiede meravigliato su quali basi si sia resa possibile l’accusa:
L11-T1 L’accusa di empietà
Più volte mi sono meravigliato delle ragioni con cui gli accusatori di Socrate
riuscirono a persuadere gli Ateniesi che egli era reo di delitto capitale contro lo stato.
L’accusa contro di lui era in sostanza questa: “Socrate è colpevole di non credere
negli dei in cui la città crede e di introdurre altre nuove divinità; è reo pure di
corrompere i giovani”. Innanzitutto, che non credesse negli dei in cui lo stato crede,
quale mai prova ebbero? Sacrificava spesso in casa, spesso sugli altari comuni della
città, ed era noto a tutti: usava anche la divinazione e non ne faceva un segreto. Era
comunemente noto un suo detto che il demone gli dava suggerimenti. Di qui
soprattutto mi sembra che l’abbiano accusato di introdurre nuove divinità. In realtà
egli non ne introdusse nessuna diversa da quelle degli altri, che, credendo alla
divinazione, ricorrono agli auguri, agli oracoli, ai presagi, ai sacrifici. Costoro
suppongono che gli uccelli e le persone incontrate non sanno affatto quello che serve
a chi pratica la divinazione, ma che gli dei l’indicano mediante tali mezzi: ed anche
egli pensava così. Ma mentre i più affermano che sono trattenuti o spinti ad agire
dagli uccelli e dalle persone incontrate, Socrate, al contrario, come credeva, così
diceva e asseriva che gliel’indicava il demone. E consigliava molti dei suoi famigliari a
fare certe cose, a non farne delle altre, a seconda dell’avvertimento del demone: e quarti
gli dettero ascolto si trovarono bene, quanti invece lo respinsero ebbero a pentirsi.
Ora, chi non ammetterà che egli non volle apparire ai suoi famigliari né sciocco né
millantatore? E invece l’uno e l’altro sarebbe sembrato se, predicendo le cose come
manifestategli dal dio, fosse apparso mentitore. E’ chiaro quindi che non le avrebbe
annunciate, se non fosse stato convinto della loro verità.
Era convinto che gli dei si prendono cura degli uomini, ma non al modo che credono
i più: costoro infatti pensano che gli dei conoscono alcune cose, altre no; Socrate,
invece, riteneva che gli dei conoscono tutto, quel che si dice, si fa, si pensa in segreto,
che sono presenti dovunque e predicono agli uomini tutte le cose umane.
Mi meraviglio quindi come mai gli Ateniesi si lasciarono persuadere che Socrate non
fosso pio verso gli dei, egli che non disse né commise mai empietà contro di loro, ma
disse e fece nei loro confronti ciò che dovrebbe dire e fare un uomo per essere in
realtà e, insieme, per essere stimato, in sommo grado religioso.
[Senofonte, Memorabili]
Innanzitutto è da notare la tripartizione dell’imputazione di Socrate:
•
•
•
il disconoscimento degli dei in cui crede la città;
la introduzione di nuove divinità;
la corruzione dei giovani di cui, evidentemente, parte non secondaria è proprio
l’insegnamento scettico e innovativo in materia religiosa.
Senofonte obietta innanzitutto al primo punto sostenendo che:
•
•
Socrate sacrificava in privato e pubblicamente e si avvaleva della pratica divinatoria;
Socrate riteneva che gli dei si prendessero cura degli uomini.
Su un tronco tradizionale si innestano però le apparenti novità. Senofonte mitiga quelli che
ritiene gli aspetti della religiosità socratica che hanno prodotto la condanna, depotenziandoli,
ma allo stesso tempo rimarca il fatto che essi, ben lungi dal costituire credenze blasfeme, sono
testimonianza di una estrema fiducia negli dei e nelle pratiche cittadine, che anzi rivalutano e
portano alla massima espressione garantendo loro efficacia e potenza inaudite:
•
•
il demone non è affatto una nuova divinità, ma una diversa declinazione della pratica
profetico-divinatoria: Senofonte fa notare la veridicità delle predizioni e l’esito positivo
dei consigli del demone nella vita di Socrate e delle persone a lui vicine che l’hanno
ascoltato.
la potenza divina non viene messa in discussione da Socrate che ritiene gli dei partecipi
della vita umana e onniscienti, riconoscendo loro un potere maggiore rispetto alla
credenza comune che reputava limitata la loro conoscenza.
La conclusione di Senofonte non può che essere, alla luce di tali prove, che Socrate era un
uomo estremamente pio e religioso. Tale risultato è del resto in linea con l’intero ritratto
prodotto nei Memorabili, dove l’attenzione si focalizza sulla personalità e sulla componente
moralistica dell’insegnamento di Socrate, presentate come profondamente in armonia tra loro.
La testimonianza senofontea fa emergere l’inconsistenza dell’accusa di empietà che, piuttosto,
si mostra nel suo volto di espediente di sicuro effetto per liberarsi di un personaggio scomodo:
la messa in discussione degli dei, nell’organismo complesso della polis antica, coincide con
un colpo assestato all’istituzione cittadina stessa: chi si macchia di hỳbris (tracotanza) nei
confronti degli dei, quale rispetto potrà avere per i costumi e le leggi cittadine e umane? Quale
educatore potrà mai essere? Ecco anche chiarito il significato del legame tra le due accuse.
Dei della città e dei privati
Il culto civico ha il valore di una legge, trasgredirlo non significa venir meno a una qualche
ortodossia o rinnegare una fede, ma tradire una città e le leggi che si sono accettate decidendo di
vivere in essa, come mostra Socrate nel Critone. Gli dei, per questo, sono gli dei della città: non è
un caso che accanto ai culti cittadini, che hanno il carattere di vere e proprie feste civili, si
sviluppino in Grecia riti dionisiaci, misterici e soteriologici che via via acquisiscono adepti poiché
rispondono a esigenze diverse, private, interiori, assai distanti dalla pubblicità e esteriorità dei riti
che lo stesso Socrate, del resto, compie. Con la crisi della polis tali manifestazioni religiose, fino a
quel momento minoritarie, avranno sempre più peso, perché rispondenti a una situazione di
isolamento dell’individuo e di dissoluzione del tessuto di collettività e autoriconoscimento in essa
che la polis ha saputo produrre.
Socrate non si limita però a affermare la sua fede negli dei; egli chiama a garanzia del suo
sapere il dio di Delfi che l’ha indicato come il più sapiente degli uomini:
L11-T2 L’oracolo delfico
Della mia sapienza, se sapienza è e quale sia, vi presenterò a testimone il dio di Delfi.
(…)
Un giorno (Cherefonte) andò a Delfi e osò consultare l’oracolo su questo – ripeto,
cittadini, non rumoreggiate - chiese dunque se c’era qualcuno più sapiente di me. La
Pizia rispose che non c’era nessuno. Su ciò vi potrà dare testimonianza suo fratello
qui presente, perché Cherefonte è morto.
Guardate perché vi dico questo: sto per spiegarvi donde ebbe origine la calunnia.
Udito il responso, riflettei: “Che cosa vuol dire il dio? A che cosa allude? Sono
consapevole di non essere sapiente, né poco né molto. Che cosa vuol dire allora
quando afferma che sono il più sapiente di tutti? Certo non mente, perché non gli è
lecito.” Per molto tempo restai incerto su che cosa volesse dire; poi controvoglia mi
volsi a cercarlo. Mi recai da uno di quelli considerati sapienti, convinto che soltanto
così avrei confutato il responso e indicato all’oracolo “Costui è più sapiente di me,
mentre tu dicevi che ero io.” (…)
Questa indagine, cittadini Ateniesi, mi procurò molte inimicizie e così gravi e
pericolose, che ne nacquero molte calunnie e ne ricevetti la nomea di sapiente. Ogni
volta gli astanti credono che io sappia le cose su cui confuto un altro. Ma forse,
cittadini, veramente sapiente è solo il dio e col suo oracolo intende dire che la
sapienza umana è poco o nulla. Sembra che parli di Socrate, ma si serve del mio
nome solo come di un esempio, come se dicesse: “O uomini, tra voi il più sapiente è
chi, come Socrate, ha riconosciuto di non valere veramente nulla in fatto di
sapienza.” Per questo ancor oggi vado in giro a cercare e a esaminare, secondo
l’indicazione del dio, chi posso credere sapiente fra i cittadini e i forestieri. E se mi
pare che non lo sia, coadiuvo il dio dimostrando che non è sapiente. Questa
occupazione mi ha tolto il tempo di fare ogni altra cosa degna di menzione per la
città e per la mia casa, anzi, per questo servizio al dio, vivo in estrema povertà.
[Platone, Apologia di Socrate, 20e-21d; 23a-23c]
Socrate si interroga sulla natura della sua sapienza, cui l’oracolo delfico ha riconosciuto un
primato, ribadendo:
•
•
•
•
la fiducia nella parola oracolare: al dio non è concesso mentire e, per quanto bizzarro e
oscuro risulti il responso, esso deve essere vero;
il carattere umano della sua sapienza e dunque l’incolmabile distanza che la separa da
quella divina: questa particolare conoscenza consiste piuttosto nel pacato riconoscimento
della sua limitatezza e pochezza;
l’affidamento da parte del dio di una missione verso i suoi concittadini (o,
genericamente, i suoi simili), affinché acquisiscano anch’essi la coscienza della propria
ignoranza e accettino pertanto con maggiore serenità e responsabilità la propria
condizione;
la dedizione totale che il servizio al dio impone.
L’atteggiamento di Socrate, la sua risposta all’impegno impostogli dal dio e la sua profonda
religiosità e disciplina interiore nel seguirlo sono indici di una sensibilità religiosa che
coinvolge maggiormente l’individuo, lo fa portavoce del dio in un senso diverso rispetto al
poeta o all’oracolo ispirati dalle Muse o da Apollo. Accanto a tale dimensione permane però
anche la fede nella religione della città e nei suoi mezzi di veicolazione del messaggio divino.
Non a caso Socrate chiama a testimone, come voce autorevole e degna di ascolto, il dio
delfico.
Lezione n. 12: Religione e tragedia
La città di Atene trova nel V secolo un momento di coesione e di pedagogia collettiva
nell’esperienza del teatro, in particolare della tragedia.
La rappresentazione della tragedia avveniva, lungo tutto l’arco della giornata, nel corso di
alcune solennità (le Piccole e le Grandi Dionisie, le Lenee, le Antesterie). Si assisteva a un
vero e proprio concorso tragico, organizzato in queste occasioni accanto ad altri agoni
artistici.
L’elevato coinvolgimento popolare rendeva particolarmente importante, da un punto di vista
politico, il momento della selezione dei drammi, il cui contenuto non poteva essere
sottovalutato. L’aspetto educativo e il ruolo di “opinion maker” assunto in taluni casi dal
tragediografo erano il punto d’arrivo, la declinazione politica, di un processo che lega nel
mondo greco poesia e società. Ma la tragedia presenta anche un altro volto, quello religioso:
connessa ai culti dionisiaci, essa presenta nelle vicende narrate, una potente rielaborazione
del materiale mitico, intrisa, in Eschilo e Sofocle, anche di un profondo sentimento
religioso, più razionalizzata in Euripide.
Al legame con Dioniso si riferiscono le parole di Aristotele:
L12-T1 Dioniso, dio della tragedia
Tanto la tragedia che la commedia erano all’inizio basate sull’improvvisazione: la
prima derivò da coloro che intonavano il ditirambo (…) e dopo essere passata
attraverso vari cambiamenti arrestò la sua evoluzione una volta raggiunta la natura
che le è propria (…). Derivata da brevi racconti e caratterizzata in origine da un
linguaggio ridicolo, impiegò molto tempo per affrancarsi dall’elemento satiresco e
acquisire gravità di tono.
[Aristotele, Poetica, 1449a]
Aristotele affronta il problema dell’origine del genere tragico, così come farà Nietzsche
nell’Ottocento con la sua Nascita della tragedia in cui ricondurrà alla straordinaria fusione
dei due impulsi antitetici di dionisiaco e apollineo la scaturigine del dramma attico e la
ragione della sua unicità. Due i punti chiave del testo aristotelico:
•
•
il richiamo al ditirambo e al coro che lo intonava;
la reminiscenza dell’elemento satiresco.
Entrambi si legano al culto dionisiaco:
•
•
i satiri formavano il seguito di Dioniso: difficile da spiegare risulta però il passaggio dal
dramma satiresco, un’opera buffa, alla tragedia ditirambica;
il nesso del ditirambo con il culto di Dioniso è indubbio: ditirambo designa il genere di
danza e di musica che accompagnava il sacrificio dionisiaco e che attraversò il passaggio
dalla forma dell'azione rituale a genere letterario-musicale.
Nonostante questo, la teoria aristotelica e quelle che, anche in epoche successive vi si sono
richiamate risultano fragili:
•
è stato supposto che lo schema iniziale dei poemi tragici avesse relazione con la passione
di Dioniso (L2-T4) o derivasse da uno scenario da carnevale; oppure che i coristi della
tragedia in origine si travestissero da satiri;
•
•
•
non vi è nessun indizio positivo che possa corroborare la conclusione che la tragedia
originaria fosse un ludo della passione di Dioniso;
a quanto sembra, nel ditirambo non esistevano dialoghi;
i tre generi teatrali (commedia, tragedia, dramma satiresco) comportavano la maschera o
travestimenti di attori e coreuti, di cui non si trova traccia nei testi riferiti al ditirambo
letterario.
Quali che siano le origini rituali della tragedia, nei suoi contenuti è il mito a misurarsi con le
sue stesse potenzialità pedagogiche e le innumerevoli variazioni possibili. Ancora Aristotele,
nel soffermarsi su uno degli ingredienti fondamentali della tragedia, la fabula, il racconto, ne
delinea l’intricato rapporto con il mito affermando che i tragediografi: si richiamano ai miti
tradizionali pur non restando rigidamente a essi fedeli.
Il mito è dunque riplasmato dal tragediografo, conformemente all’immagine greca del
poeta come artigiano la cui creatività si esercita nel reperimento e nella rielaborazione di
eventi e figure già fissati dalla tradizione.
Quando la tragedia si afferma ad Atene, il mondo del mito è già percepito come distante, la
critica razionalistica ha già abbattuto la fiducia in esso, ma il mito
•
•
resta un elemento cui i greci guardano come costitutivo della loro identità collettiva;
in conformità con questa tensione tra passato e presente in cui si colloca, esso subisce un
processo di riattualizzazione.
L12-T2 Il mito attuale
Atena: Su questo colle Reverenza (aidòs) e Paura (phòbos), che di Reverenza è cognata,
impediranno ai cittadini di far offesa a Giustizia, quando non vogliano essi stessi
sovvertire le leggi: chi di correnti impure e fango intorbida limpide acque non troverà
più da bere. Né anarchia né dispotismo; questa è la regola che ai cittadini amanti della
patria consiglio di osservare, e di non scacciare del tutto dalla città il timore perché
senza il timore nessuno dei mortali opera secondo giustizia. E se voi, come dovete,
avete timore e reverenza della maestà di questo istituto, il vostro paese e la vostra
città avranno un baluardo di sicurezza quale nessun’altra gente conosce, né tra gli
Sciti né nella terra di Pelope. Incorruttibile al lucro io voglio questo Consiglio, e
rispettoso del giusto; e inflessibile, pronto, vigile scolta che, se anche gli altri
dormono, è desta.
[Eschilo, Eumenidi, 690-705]
Il testo è tratto dal finale delle Eumenidi, terza tragedia della trilogia che va sotto il nome di
Orestea e che narra le vicende seguite al ritorno in patria di Agamennone dalla guerra di
Troia: la sua uccisione ad opera della moglie Clitemnestra e dell’amante Egisto e l’omicidio
ai loro danni di cui si macchia Oreste, figlio di Agamennone, per vendicare il padre. Oreste è
giudicato ad Atene, dove la dea Atena istituisce il tribunale dell’Areopago. Il discorso della
dea rappresenta un potente tratto di attualizzazione del mito:
•
•
si fa portatore, tramite la voce autorevole di Atena, di un messaggio alla cittadinanza da
parte del poeta;
risente di un dibattito politico interno alla città:
• in quegli anni le riforme dei democratici radicali di Efialte stanno mutando
completamente la gestione della politica interna ad Atene;
• il drastico ridimensionamento delle competenze dell’Areopago, l’antico tribunale,
ultima roccaforte dei conservatori, a vantaggio degli istituti democratici scatena la
•
reazione dei più moderati. Atena sprona alla moderazione: invitando a un governo che
non costituisca né anarchia, né dispotismo.;
la tensione tocca il culmine con l’assassinio di Efialte. Da qui l’invito di Atena a
evitare la lotta civile, salvaguardando la concordia.
Il poeta rimodella dunque le storie tradizionali dal punto di vista del presente e trova spazi per
chiarire questo profondo legame con l’attualità. In Euripide ad esempio, molti sono i
riferimenti alla guerra e gli appelli pacifisti dei personaggi, chiari riflessi del clima di
stanchezza per il trascinarsi e le disfatte della Guerra del Peloponneso respirato dal
tragediografo nell’Atene degli ultimi due decenni del V secolo: i protagonisti di questi
drammi, le Troiane e l’Ecuba, sono Troiani, ovvero gli sconfitti per eccellenza, coloro che
hanno pagato più duramente il prezzo della guerra più celebrata dal mito.
Specie in Euripide, inoltre, si ravvisano anche spunti polemici, vicini alle tesi sofistiche,
contro una tradizione vissuta ormai come estranea.
L12-T3 La critica al mito
Io che gli dei si compiacciano di talami vietati dalle sacre leggi non credo, né mai
pensai che (reciprocamente) avvincano catene alle loro braccia né di ciò mi lascerò
persuadere, né che un dio abbia la natura di poter dominare un altro dio. Infatti un
dio, se è secondo verità un dio, non ha bisogno di nulla: questi sono i racconti
sciagurati degli aedi.
[Euripide, Eracle, vv.1341-1346]
Sono parole che non necessitano di alcun commento: lo spirito che le anima è chiaramente il
medesimo dei frammenti di Senofane (L10-T1). Ma simili echi si ritrovano anche in Platone
(L14-T1).
In particolare sono da sottolineare:
•
•
•
la presa di distanza dall’aedo, presentato come un ciarlatano;
il biasimo per l’attribuzione agli dei di azioni immorali;
l’affermazione della potenza divina come autarchica, il che invalida la possibilità di una
gerarchia tra dei: con questa affermazione il poeta si pone accanto a Socrate e alla sua
concezione del divino come essere che tutto vede e tutto ode (L11-T2).
Se Euripide non è più in grado di comprendere il senso del racconto mitico, quali fonti
potranno mai fornirgli opinioni condivisibili e razionalmente provate dell’esistenza degli dei?
L12-T4 La vena antireligiosa
Cos’è un dio? Cosa non è? Esiste alcunché di intermedio? Chi fra i mortali può dire
di aver trovato, cercando, il termine estremo, se vede le azioni divine balzare qua e là,
e di nuovo altrove, in gioco di opposte e imprevedibili sorti?
[Euripide, Elena, 1137-1143]
Vedo finalmente come sono falsi e menzogneri i responsi degli indovini. Nessuna
utilità c’è nell’esaminare i movimenti della fiamma o le voci degli uccelli, è da stupidi
pensare che gli uccelli si rendano utili agli uomini
[Euripide, Elena, 744-748]
I due brevi brani dell’Elena sono vivacemente in opposizione con l’immagine socratica del
divino, nonostante la lunga tradizione che, dall’antichità a Nietzsche, ha accostato i due
personaggi:
•
•
Euripide dichiara il suo agnosticismo, con chiari accenti protagorei (L10-T4), laddove
Socrate, afferma di credere negli dei;
Euripide denigra la pratica divinatoria: Socrate, invece, è persino visto come un
indovino sui generis, la cui capacità profetica si basa certo su una voce divina assai
particolare, ma è accostata proprio a tali esperienze religiose.
E’ però ancora Euripide a presentare la compiuta forma del nuovo dio, la cui figura esce
dall’esperienza tragica profondamente deantropomorfizzata e sfaccettata, come una potenza
impersonale che regge l’ordine universale:
L12-T5 Gli dei nella tragedia
Tu che sei sostegno della terra e sulla terra troneggi, chiunque mai tu sia,
impenetrabile alla conoscenza, o Zeus, legge di natura o intelligenza dei mortali, io ti
prego: movendoti lungo un sentiero silenzioso tu guidi tutte le cose mortali secondo
giustizia.
[Euripide, Troiane, vv. 884-888]
Quasi identiche le parole, più antiche, di Eschilo nella parodo (il canto corale d’ingresso)
dell’Agamennone:
Strofe2: Zeus, quale mai sia il tuo nome, se con questo ti piace esser chiamato, con
questo ti invoco. Né certo ad altri posso pensare, nessun altro all’infuori di te
riconoscere, se veramente questo peso vano dall’anima voglio scacciare.
Antistrofe2: Tale fu grande un giorno e fiorente di ogni audacia guerriera, e di costui
neppure più si dirà che esistette; poi venne un secondo, e anche questo comparve,
trovando un terzo più forte. Chi con cuore devoto canta epinici a Zeus, questo
soltanto avrà colto suprema saggezza.
Strofe3: Le vie della saggezza Zeus aprì ai mortali, facendo valere la legge che sapere è
soffrire. Geme anche nel sonno, dinanzi al memore cuore, rimorso di colpe, e cosi
agli uomini anche loro malgrado giunge saggezza.
E questo è beneficio dei numi che saldamente seggono al sacro timone del mondo
[Eschilo, Agamennone, vv.159-183, trad. Valgimigli]
I due testi, proprio perché appartenenti a due autori assai diversi, testimoniano un sentire
comune, evidentemente diffuso:
•
•
il politeismo pagano non risulta incompatibile con spunti monoteistici: nonostante le
numerose divinità, il loro nome è momentaneo, irrilevante, quel che conta, e che spiega
anche il sincretismo religioso, è il riconoscimento della presenza divina, identificata dai
due tragediografi con Zeus, ma quale mai sia il tuo nome, se con questo ti piace esser
chiamato, con questo ti invoco;
il divino regge il mondo, ne è il timone, ma, soprattutto, rappresenta, come già in Esiodo,
il garante della giustizia: la giustizia divina è ciò in cui trova consolazione il dramma
dell’eroe. Al di là dell’inspiegabilità delle dinamiche della giustizia, conta che vi sia un
dio che possa reggerne le fila, seppure per vie imperscrutabili, affinchè essa trionfi. Per
Euripide, soprattutto, Zeus, è l’ancora di salvezza dall’apparente irrazionalità
•
dell’universo, l’unica garanzia giustificatrice di una ricerca della verità razionale,
umanamente attingibile;
Zeus emerge come educatore: la consapevolezza e la presa di responsabilità relativamente
al proprio errore, che l’eroe tragico acquisisce spesso a costo della vita, è anch’essa opera
di Zeus, che responsabilizza l’individuo di fronte alle proprie azioni, lo rende saggio con
la sofferenza impostagli per effetto delle sue colpe.
Resta a questo punto da analizzare, in relazione al rapporto della tragedia con la città e la
religione, un aspetto legato al ruolo dello spettatore e al fine che nei suoi confronti questo
genere di opera drammatica si prefigge. Scrive Aristotele:
L12-T6 La catarsi tragica
Tragedia dunque è mimesi di un’azione seria e compiuta in se stessa, con una certa
estensione; in un linguaggio abbellito di varie specie di abbellimenti, ma ciascuno a suo
luogo nelle parti diverse; in forma drammatica e non narrativa; la quale, mediante una serie
di casi che suscitano pietà e terrore ha per effetto di sollevare e purificare l’animo da queste
passioni (kàtharsis tòn pathemàton).
[Aristotele, Poetica, 1449b 24-28]
Il filosofo coglie nell’interazione tra la tragedia e il suo pubblico due aspetti:
•
•
il coinvolgimento emotivo dello spettatore che diviene così partecipe dell’azione
drammatica provando pietà e terrore;
l'effetto catartico, ovvero purificatore, che la liberazione di tali sentimenti porta a
compimento.
Qual è il senso di questa catarsi?
•
•
•
•
•
il termine greco kàtharsis presenta diversi legami con la sfera religiosa, con i riti di
purificazione delle più diverse specie, ed è in tal senso, oltre che per la sua connessione
con i culti dionisiaci, che la tragedia possiede aspetti rituali e sacrali;
Aristotele, al di là della scelta terminologica, riconduce la esorcizzazione dei sentimenti
suscitati a una sfera decisamente umana: la pietà e la paura sono provati dallo spettatore
per il fatto che ciò che accade all’eroe, è quantomeno possibile e dunque anch’egli
potrebbe venirsi a trovare nelle medesime condizioni;
la depurazione da queste passioni consente il raggiungimento di una visione equilibrata
e di uno stato d’animo più sereno e consapevole di fronte alle cose;
la tragedia resta primariamente un rito collettivo: l'uso della musica nel trattamento e
nella cura di certe affezioni dovute alla possessione (all'entusiasmo) deve essere stato cosa
corrente e importante;
il gioco da cui sembra aver avuto origine il dramma satiresco, procede direttamente da tale
paideia catartica.
Lezione n. 13: La figura filosofica del dio
Se nel contesto della polis il rapporto con la tradizione mitico-religiosa da un lato è incanalato
in un culto civico, dall’altro si fa problematico, non viene però meno l’esigenza della
riflessione sulla natura della divinità. Si è visto, in riferimento alla tragedia, come emergano
forme di monoteismo pure in un contesto che fa uso largamente del materiale mitico. I filosofi
della polis proseguono questo cammino affermando con forza la figura del dio unico, privo di
caratteri squisitamente umani, frutto di una speculazione razionale e ragione esso stesso che
costituisce il risvolto positivo e costruttivo della loro operazione critica.
Scrive Senofane (vedi anche L10-T1):
L13-T1 Il dio di Senofane
Gli dei non hanno certo svelato ogni cosa ai mortali fin dal principio, ma, ricercando,
gli uomini trovano a poco a poco il meglio.[fr.18 DK]
Un solo dio, il più grande tra uomini e dei, né per la figura né per i pensieri simile ai
mortali.[fr.27 DK]
Tutto occhio, tutto mente, tutto orecchio.[fr.28 DK]
Ma senza fatica scuote tutto con la forza della mente.[fr.28 DK]
Rimane sempre nello stesso luogo immobile né gli si addice spostarsi or qui or là.
[fr.30 DK]
In continuità con le sue critiche alle caratteristiche delle divinità protagoniste dei poemi
omerici, Senofane costruisce il suo dio in opposizione a queste:
•
•
•
•
•
unico;
privo di caratteri antropomorfici sia in termini morali che fisici;
identificabile con una mente pensante e onnisciente;
con la forza della sua mente esercita la sua capacità modellatrice e trasformatrice, nonché
ordinatrice e reggitrice;
immutabile perché autosufficiente: il movimento è indice di mancanza e ricerca di
compimento, il dio, invece, in quanto tale, non ha bisogno di nulla.
Un po’ diverso il contenuto del frammento 18DK, che completa il quadro:
•
•
•
confermando la distanza tra uomo e dio la cui differenza si gioca innanzitutto sul piano
della capacità conoscitiva;
esplicitando la possibilità-necessità della ricerca da parte dell’uomo per avvicinarsi il più
possibile alla scienza divina;
caratterizzando il difetto conoscitivo come fonte di attività, sforzo, fatica e movimento,
assai lontani dalla stabilità immobile della figura divina.
Secondo Senofane l’esatta e esaustiva verità, è direttamente percepibile solo dal Dio e
inconoscibile per l'uomo che possiede una conoscenza congetturale. Tra Dio e uomo esiste
una distanza incolmabile, quasi che Dio rappresenti l’ideale limite di una conoscenza totale
che arresta l’affannarsi che attanaglia invece l’esistenza umana: agli dei attivi dell'epopea
omerica si sostituisce un dio astratto e immutabile.
Una particolare voce divina, assai distante dalle divinità omeriche, ma anche dall’onnipotente
dio di Senofane, è avvertita da Socrate che così la descrive:
L13-T2 Il daimònion
Così mi pare che il dio mi abbia imposto alla città affinché stimolandovi,
persuadendovi e rimproverandovi uno per uno, non cessi mai di starvi appresso per
tutto il giorno, in ogni luogo. (…)
La causa di questo è ciò che mi avete sentito dire sovente in molti luoghi. Che in me
c’è qualcosa di divino e di demonico, che anche Meleto ha indicato scherzando
nell’atto d’accusa. Questo, che è in me fin da bambino, è come una voce, che,
quando si fa sentire, mi distoglie sempre da ciò che sto per fare e non mi spinge mai
a nulla. E’ questo che mi impedisce di occuparmi di politica e fa bene ad
impedirmelo, mi pare. Sapete bene, Ateniesi, che se da un pezzo avessi intrapreso ad
occuparmi di politica, da un pezzo sarei morto e non sarei stato utile né a voi né a
me.
[Platone, Apologia di Socrate, 31a; 31d-e]
Nel brano Socrate pone l’accento:
•
•
sulla missione affidatagli dal dio (vedi L9-T2);
sulle ragioni della scelta del dio stesso: Socrate possiede in sé qualcosa di divino, una
voce che lo dissuade dal compiere alcune azioni, senza mai spingerlo a nulla. E’ la celebre
e sintetica definizione del daimònion socratico.
Difficile è chiarire quale sia l’intento di Socrate nell’introdurre questa figura: la si è
interpretata come una primitiva voce della coscienza, oppure come una metafora del dovere
morale, o, ancora, come vera e propria presenza divina. Universale è però il riconoscimento
dello speciale e primario rapporto tra religione e etica. La divinità non è tanto garante del
destino ultraterreno, né stabilisce da sé ciò che è giusto e ciò che non lo è, ma gli dei
confortano e confermano le scelte dell’individuo orientate da quei valori spirituali che essi per
primi riconoscono, dal momento che, per certi versi, altro non sono che la concreta
rappresentazione di quei valori. Ecco perché dunque in Socrate la credenza religiosa, e anche
l’atteggiamento del demone, coincidono perfettamente con un corretto atteggiamento morale.
L’opera del daimònion è riconosciuta da Socrate anche nel momento più drammatico della
sua esistenza, quello della sua condanna a morte:
L13-T3 Socrate e la morte
A voi che siete amici, voglio mostrare che cosa significa ciò che mi è successo oggi.
Infatti, o giudici, - chiamandovi giudici vi do il giusto nome - mi è successo un fatto
mirabile. La mia solita voce profetica, quella del demone, in tutto il passato era
sempre molto frequente e si opponeva molto anche in questioni da poco, se ero sul
punto di fare qualcosa scorrettamente. Ora invece mi è successo, lo vedete anche voi,
quello che si potrebbe credere e considerare l’estremo dei mali. Ma il segno del dio
non mi si è opposto, né quando stamattina sono uscito di casa, né quando sono
salito, qui in tribunale, né durante il dibattito in nessun momento, quando stavo per
parlare. Eppure in altri discorsi mi ha fermato spesso mentre parlavo; ora invece
durante questa faccenda non si è opposto a nessuna mia parola o atto. Quale penso
ne sia la causa? Ve lo dirò. Forse ciò che mi è successo è un bene e non è possibile
che pensiamo rettamente noi che crediamo la morte un male. Di ciò ho avuto una
grande prova: è impossibile che il solito segno non mi si sia opposto, se ero sul punto
di fare qualcosa che non fosse bene.
Consideriamo anche per questa via come ci possa essere grande speranza che esso sia
un bene. Il morire è una di queste due cose: o è come non essere nulla e chi è morto
non ha nessuna sensazione, o, come si racconta, è una specie di mutamento o di
trasferimento dell’anima da questo luogo a un altro. Se è non avere nessuna
sensazione, ma come un sonno quando si dorme senza sogni, la morte sarebbe un
guadagno meraviglioso. (…). Se invece la morte è come un viaggio di qui in un altro
luogo e sono veri i racconti che colà sono tutti i morti, qual bene, giudici, potrebbe
essere maggiore di questo? Se uno, giunto nell’Ade, libero da questi che si dicono
giudici, troverà i veri giudici, che si dice che sentenzino laggiù, Minosse, Radamanto,
Eaco, Trittolemo e gli altri semidei che furono giusti nella loro vita, questo viaggio
sarà un’inezia? E quanto non pagherebbe ciascuno di voi per trovarsi con Orfeo,
Museo, Esiodo e Omero? (….).
Anche voi, giudici, dovete nutrire buona speranza davanti alla morte e pensare che
una cosa è vera, questa: che ad un uomo buono non può avvenire nulla di male, né in
vita né in morte e le sue vicende non sono trascurate dagli dei. Così le mie ora non
sono avvenute per caso: a me è chiaro che ormai il morire è liberarmi dai fastidi era
per me la cosa migliore.- per questo il segno non mi ha distolto in nessun momento;
per questo non sono adirato con quelli che mi hanno condannato e con gli
accusatori. (…) Ma ormai è ora di andarsene, io a morire, voi a vivere: chi di noi vada
verso la meta migliore, è oscuro a tutti tranne che alla divinità.
[Platone, Apologia di Socrate, 40a-41c; 41d-41e, 42a]
L’assenza, in un momento tanto cruciale, della voce dissuasiva del demone spinge Socrate ad
alcune considerazioni finali sulla divinità, la morte, la vita ultraterrena:
•
•
•
•
•
•
•
la morte non può essere un male, se la divinità, che è sempre degna di fede, non tenta di
impedire azioni che, come il discorso dello stesso Socrate in tribunale, a essa conducono.
Solo l’ignoranza umana degli imperscrutabili disegni divini e l’eccessivo attaccamento
alla vita che ne discende possono produrre un’idea negativa della morte;
Socrate riprende l’immagine tradizionale dell’Ade ribaltandola in senso positivo, ma,
soprattutto, testimoniando ancora una volta la presenza costante, seppure non acritica,
della tradizione mitico-religiosa;
al di là della questione sulla sua reale fede in questa raffigurazione, conferisce il massimo
rilievo alle figure dei giudici infernali che, a differenza di quelli terreni, sono a
conoscenza della totalità delle azioni, dei pensieri e dei progetti umani e divini e possono
perciò esprimere un giudizio veritiero, garantendo un’effettiva giustizia che si dispiega
nell’eternità;
in conseguenza di ciò, Socrate ribadisce che il dio non si disinteressa delle vicende
terrene, ma le osserva e orienta rettamente il giudizio sull’individuo dopo la morte.
data la preoccupazione divina nei confronti delle cose umane, per l’uomo buono non vi è
nulla da temere né nella vita né nella morte: ecco il legame etica-religione farsi pregnante;
Socrate non afferma di credere in una vita ultraterrena, ma semplicemente, di ritenerla una
conclusione possibile e positiva per il destino dell’uomo;
in conclusione Socrate ribadisce la sua convinzione sull’onniscienza divina: solo la
divinità può sapere se sia meglio vivere o morire, all’uomo è lasciata solo la possibilità di
congetturare.
Parte terza: conclusioni
L’ambiente della polis e soprattutto la sua forma democratica, portatori di un’insita
plurivocità, mettono in crisi l’indiscutibile autorità della parola sacrale del mito. In primo
luogo, quindi, si apre nella polis un confronto con Omero e Esiodo, faccia a faccia che porta
in sé anche profondi significati politici: a far avvertire come ormai estranei gli autori
tradizionali su cui ci si è formati fino a quel momento è in particolare il passaggio da modelli
aristocratici di governo e concezione del mondo, basati sulla nobiltà di sangue a una visione
democratica che privilegia la collettività in ambito sia politico (assemblea) che militare (la
falange oplitica) che culturale.
La distanza da quella prospettiva si avverte:
•
•
•
nella critica all’antropomorfismo della divinità omerica;
nello sfruttamento retorico-argomentativo del patrimonio mitico;
nelle posizioni agnostiche e in quelle tese a riscontrare un’origine terrena del sentimento
religioso e le sue potenzialità per il mantenimento dell’ordine politico-sociale.
In questo contesto si muove la figura di Socrate che presenta alcuni tratti in comune con le
posizioni più radicali espresse dalla sofistica e messe in relazione dall’ambiente conservatore
con una generale decadenza della città. Le fonti a lui più favorevoli si mostrano invece
convinte:
•
•
della sua profonda, anche se non acritica, religiosità;
della sua investitura da parte del dio di una missione divina a vantaggio dell’umanità.
L’orizzonte religioso della polis, intrecciato in maniera indistricabile con la sua vita sociopolitica, ha una delle sue massime espressioni nel rito collettivo della tragedia che raccoglie in
sé spunti filosofici monoteistici e razionalistici e tradizione mitica, fondendoli in
un’irripetibile forma artistica che coinvolge:
•
•
•
una purificazione dalle passioni;
la convinzione in un ordine divino dell’universo;
una considerazione più meditata del mito piegato a significati etico-cosmici che
rispondono alle pressanti domande della ragione filosofica e dell’attualità politica.
Del resto i filosofi, molto spesso, muovono le loro critiche alla religiosità dei padri in vista
dell’affermazione di una figura innovativa del dio le cui massime espressioni sono:
•
•
•
il monoteismo razionalistico di Senofane;
il daimònion socratico;
ai margini dell’esperienza della polis, il dio ottimo e immutabile di Aristotele.
In generale si attua un approfondimento della frattura tra umano e divino, specie da un punto
di vista conoscitivo.
Aristotele, però, in risposta al radicalismo sofistico (e per certi versi anche senofaneo) della
riduzione del dio a invenzione-inganno umano, tende anche ad argomentare, secondo schemi
dimostrativi rigorosi, l’esistenza di una nozione del divino indubitabile e degna di fede, che
allontana da ogni possibilità di agnosticismo. Proprio tale strategia di difesa della credenza
religiosa, del resto, è un sintomo della sua crisi, oltre che del definitivo imporsi del lògos sul
mýthos che di quello necessita per ricevere una certificazione di verità, ormai incapace di
ottenere, come tradizionalmente avveniva, in nome della sua sola sacralità.
Ricerche
Per una generale e sintetica considerazione delle manifestazioni del sacro nella grecità e nella
polis in particolare si consigliano M. Vegetti, L’uomo e gli dei, in L’uomo greco, a cura di J.P.
Vernant, Laterza, Bari, 1998 e J.P. Vernant Le origini del pensiero greco, Editori Riuniti,
Roma, 1997 [Capitolo IV, L’universo spirituale della polis]. Un’interessante, ma anche
complessa, prospettiva sulla reale fede nei miti nella cultura e nei pensatori ellenici dell’età
della polis si ritrova in P. Veyne, I Greci hanno creduto ai loro miti?, Il Mulino, Bologna,
1984.
Un approfondimento su Senofane e sui significati socio-politici e antropologici della sua
critica a Omero e del suo dio è fornito da J. Svenbro, La parola e il marmo: alle origini della
poetica greca, Boringhieri, Torino, 1984.
Sulla tematica teologica affrontata dai sofisti in chiave retorica e politica si consigliano la
lettura dell’Encomio di Elena di Gorgia [Frammenti, a cura di C. Moreschini, Boringhieri,
Torino, 1959] e del mito di Epimeteo e Prometeo nel Protagora di Platone [320d-322d, in
Platone, Opere complete, trad di F. Adorno, Laterza, Bari, 1982]. Per una visione più
articolata della questione si consiglia il testo di G. Casertano Natura e istituzioni umane nelle
dottrine dei sofisti, Il Tripode, Napoli-Firenze, 1971.
Su Socrate la bibliografia è sterminata: si consiglia, per una più chiara visione del
personaggio G. Giannantoni, Socrate, tutte le testimonianze da Aristofane a Senofonte ai
Padri Cristiani, Laterza, Bari, 1971
Relativamente all’utilizzo del mito e della religione nella tragedia si consigliano i brevi saggi
di B. Snell, Mito e realtà nella tragedia greca, in La cultura greca e le origini del pensiero
occidentale, Einaudi, Torino, 1963 e di J.P. Vernant, Il dio della finzione tragica, in J.P.
Vernant – P. Vidal-Naquet, Saggi su mito e tragedia, Einaudi Scuola, Torino, 1994. Per un
approfondimento riguardo alla connessione tra Dioniso e la tragedia sono esaurienti i capitoli
dedicati alla questione da H. Jeanmaire nella voluminosa monografia Dioniso, Einaudi,
Torino, 1970: capp.4 [La manìa divina], 6 [Il ditirambo] e 7 [Il tiaso e l’origine del teatro].
Inoltre, circa la lettura aristotelica della tragedia, è interessante A. Pagliaro, La tragedia e il
tragico secondo Aristotele, in Altri saggi di critica semantica, D’Anna, Messina-Firenze,
1961. Sulla catarsi tragica è consigliabile la lettura di C. Diano, La catarsi tragica, in
Saggezza e poetiche degli antichi, Neri Pozza, Venezia, 1968
Si consiglia inoltre la lettura delle Baccanti, Rizzoli, Milano, 1983 che presentano Dioniso
come protagonista della tragedia e il rituale dionisiaco. Sulla considerazione degli dei e della
religione nella tragedia si vedano in M. Pohlenz, La tragedia greca, Paideia, Brescia, 1961 i
passi indicati nell’indice analitico sotto la voce “Dei” e “Mito”. Infine, per un inquadramento
filosofico del tragico, anche nelle sue declinazioni contemporanee, si consiglia R. Cantoni, Il
tragico come problema filosofico, in Tragico e senso comune, Mangiarotti, Cremona, 1963.
Parte quarta: Mỳthos e lògos in Platone [lezioni 14- 17]
Lezione n. 14: La superficialità della cultura religiosa corrente
Quando si parla, in riferimento al mondo greco, di cultura tradizionale si intende quel
complesso di valori, concezioni del mondo, comportamenti derivati dai poemi omerici.
Senofane affermava che “Tutti i greci hanno imparato da Omero” (fr.9 DK). Iliade e Odissea
costituivano infatti non solo il patrimonio mitologico dell’Ellade, ma la fonte primaria del
diritto, della religione e della morale. Contro questa cultura si scaglia autorevolmente Platone
sin dai suoi primi scritti:
L14-T1 L’immagine mitica della divinità
- (…) Ti porto una prova decisiva. Ne ho già fatto uso con molti, per dimostrar che
va bene agire in questo modo e che non si deve mostrarsi deboli con l’empio; mai,
chiunque egli sia.
Il genere umano ritiene che Zeus sia il più nobile e il più giusto fra gli dei. Eppure
tutti sanno che Zeus mise in catene il padre suo, perché ingiustamente aveva
trangugiato i propri figli. E questo padre a sua volta aveva evirato il suo per ragioni
non certo migliori. Ma intanto se la prendono con me, perché faccio causa a mio
padre, e così vengono a trovarsi in contraddizione: da una parte gli dei, dall’altra il
caso mio.
- Guarda guarda, Eutifrone! Questo è proprio il motivo per cui mi trovo citato in
tribunale. Devi sapere che non mi sento di accettare a cuor leggero certe affermazioni
sulla divinità. E per questa ragione appunto si dirà che grande è il mio errore. Ora in
ogni modo se tu, che la sai lunga in materia, hai quest’opinione, bisogna, come pare,
che mi rimetta.(…)A ogni modo, per piacere, in nome del dio che protegge gli amici:
credi davvero alla verità di questi racconti?
- Sì, e ve ne sono altri più stupefacenti, o Socrate, che la gente non conosce.
- E allora ritieni che vi siano veramente battaglie fra gli dei e inimicizie terribili e
guerre e altre brutte cose? Così almeno narrano i poeti. E i pittori? Non hanno con
tanta bravura introdotto nei loro quadri variazioni d’ogni genere sulla storia sacra?
Per esempio, nelle Panatenaiche, il peplo famoso viene recato sull’acropoli, tutto
istoriato di tali leggende. E dobbiamo dire che tutto questo, Eutifrone, risponde a
verità?
- Sì, e non soltanto questo, o Socrate; ma, ti dicevo or ora, ci sono altre leggende, e in
gran numero. Se desideri, te le posso raccontare. Sentirai, e certo rimarrai a bocca
aperta.
[Platone, Eutifrone, 5e-6c, trad. Turolla]
Il dialogo si svolge tra Socrate, che si reca in tribunale per rispondere dell’accusa di empietà,
e Eutifrone, un sacerdote, che ne sta uscendo dopo aver intentato causa contro suo padre per
l’omicidio di un servo:
•
•
•
Eutifrone sostiene che mai bisogna aver pietà dell’empio, neppure se si tratta di una
persona molto cara;
a giustificazione del proprio gesto chiama in causa la vicenda mitica di Zeus che ha
incatenato il padre Crono che aveva ucciso i propri figli temendo di essere spodestato;
Socrate si mostra incredulo nei confronti di certi racconti scabrosi relativi alle divinità,
attribuendone la paternità a poeti e pittori; non solo, ma sostiene essere questa incredulità
la ragione delle accuse rivoltegli.
La posizione di Platone, sotto le spoglie di Socrate, è chiarissima:
•
•
•
•
Socrate è stato vittima di un’accusa ingiusta, portata avanti da una cultura che non ha ben
chiaro che cosa sia bene e male, in assoluto, per un uomo;
la cultura epico-omerica trasmette un’immagine della divinità in cui trova
giustificazione e sanzione ogni comportamento: passioni come la lussuria, l’avidità,
l’ira, l’invidia sono attributi anche degli dei omerici.
poeti e pittori, hanno svolto in modo riprovevole il loro compito educativo,
tramandando come divini e ispirati racconti e raffigurazioni empi: gli esponenti della
cultura tradizionale sono dunque portatori di opinioni pregiudiziali, assolutamente
inverificabili e diseducative.
Eutifrone non nutre alcun dubbio circa la veridicità dei racconti mitici, anzi, vorrebbe
stupire Socrate raccontandogliene di ancor più incredibili, mostrando un futile gusto per
l’erudizione fine a se stessa, e difettando invece di una seria riflessione sui valori
veicolati, nel rispetto passivo delle verità tramandate.
Le critiche di Platone dovevano essere diffuse ad Atene, esse riecheggiano i toni della
polemica di Senofane e dei sofisti (L10), ma sono da sottolineare due importanti novità:
•
•
quello che da parte conservatrice era imputato alle nuove tendenze culturali, cioè la
immoralità conseguente all’abbandono dei culti antichi e alla sfiducia nei miti, è
attribuita da Platone proprio ai contenuti della pedagogia tradizionale, persino nei suoi
esponenti a parole meno superficiali;
l’intento implicito di Platone è quello di screditare la cultura omerica e i suoi diffusori,
nelle persone dei sacerdoti e dei poeti, per sostituirvi la sua nuova cultura filosofica e il
filosofo quale educatore della città.
L14-T2 Il mercato della santità
- Cerca dunque di insegnarmi quale parte del giusto spetta alla santità. Diremo allora
a Meleto di smettere con le sue ingiuste accuse di empietà; ormai abbiamo avuto la
lezione da te e sappiamo benissimo quali sono le opere conformi a religione e sante,
e quali non lo sono.
- Secondo me, vedi, Socrate, la pietà e la santità sono quella parte del giusto avente la
sua esplicitazione nel culto e nella cura verso gli dei. La parte invece rivolta agli
uomini è la restante.
- Sì, e direi proprio che tu abbia ragione, ma mi manca un piccolo particolare ancora.
Questa parola cura, non capisco bene in qual senso la si adoperi. Non vorrai
intendere, credo, nel comune senso, trattandosi della divinità. Sai bene, si dice, se si
tratta di cavalli, che non tutti sanno prendersene cura, soltanto la persona esperta.
Non ti pare?
(…)
- E allora santità, secondo questa interpretazione, sarebbe scienza del chiedere e del
donare agli dei.
- Hai capito, Socrate, perfettamente la mia dottrina.
- Sono ansioso, mio caro, di possederla nella mente, la tua dottrina. Oh, le tue parole
non cadranno per terra. Questo servizio che noi rendiamo agli dei, dimmi un po’, a
che cosa si riduce? Affermi che si tratta di rivolger preghiere e offrir doni?
- Sì.
- E credi che rivolgere una giusta preghiera sia diverso dal chiedere, con preghiera,
appunto, ciò di cui abbiamo bisogno?
- Che altro sarebbe?
- Se reciprocamente, l’offerta giusta dà agli dei ciò di cui hanno bisogno. Sarebbe
contrario a una buona norma offrire a qualcuno un dono di cui non ha bisogno.
- Hai ragione, Socrate.
- Si tratta allora di un mercato, o press’a poco, caro Eutifrone. Tale appare la santità:
un’operazione commerciale tra uomini e dei , nelle loro reciproche relazioni.
- Sì; se ti piace, chiamala operazione commerciale.
- Ma non è questione di piacere o meno, deve rispondere a verità. Dunque dimmi:
quale utilità hanno gli dei per questi nostri doni? (In quanto a ciò ch’essi concedono,
non c’è motivo di dubbio. Nessun bene esiste per noi che non ci sia concesso dagli
dei). Ma da ciò che prendono, quale vantaggio ne viene? E con la nostra abilità
commerciale arriviamo forse ad essere più furbi di loro? Si potrebbe prendere ogni
bene, e non dar nulla in ricambio.
- Ma puoi credere, Socrate, che gli dei ricavino utilità dai doni ricevuti?
- E allora in che cosa consistono mai, o Eutifrone, questi doni che offriamo agli dei?
- Cosa credi? Onore, segni di venerazione e, te lo dicevo poco fa, un senso di diletto
e di piacere.
- Ma allora la santità, Eutifrone, si risolve in qualche cosa che dia diletto, non certo in
cosa utile e cara agli dei.
- Anzi, è mia opinione che si tratti della cosa più cara.
[Platone, Eutifrone, 12e-13a; 14d-15c, trad. Turolla]
La domanda di Socrate al sacerdote Eutifrone, in teoria un esperto nel campo, è: che cos’è il
santo? Anche in questa occasione la visione di Platone traspare chiaramente sotto l’ironia
graffiante di Socrate che mostra lo svilimento del divino nella religione corrente:
•
•
•
•
•
la divinità non è riferimento trascendente, irraggiungibile e degno di rispetto, ma qualcosa
di cui ci si prende cura con culti sporadici e superficiali, come si fa con un cavallo, con
un animale qualunque;
il culto (come la cura dei cavalli) dovrebbe essere amministrato da persone esperte, che
sanno qual è il suo significato profondo, ma Eutifrone si mostra del tutto ignaro di questa
profondità;
la relazione dell’uomo con le divinità si limita a uno scambio commerciale di richieste
(preghiere) e doni (sacrifici, ex voto…) che non coinvolge alcuna dimensione spirituale o
etica;
gli dei sono ridotti a contraenti di un patto commerciale, per giunta truffati, dal
momento che, se è indubbio quale vantaggio gli uomini ricavino dai doni divini, è
impossibile riscontrare un tale vantaggio da parte degli dei per i doni degli uomini;
Eutifrone sostiene che il vantaggio per gli dei risiede nella venerazione e nell’onore che si
cela dietro alle manifestazioni di devozione, ma non si accorge che in tal modo abbassa il
dio al livello umano-omerico, dove ciò che conta è esclusivamente il riconoscimento
altrui: il dio non appare dunque affatto signore e controllore dell’universo, ma un essere
bisognoso di approvazione e onore, e dunque debole, e, cosa ancor più grave,
corruttibile con la più bassa adulazione.
La cultura tradizionale, è questa in ultima analisi la tesi di Platone, non conosce il significato
del sacro, sia perché accoglie una concezione dell’etica formalistica e vuota, sia perché non
conosce la vera natura del divino che dell’etica dovrebbe costituire la misura e la norma. Ma
ciò che è peggio è che pretende di conoscerla e di trasformare in leggi e precetti la propria
ignoranza.
Lezione n. 15: La prospettiva pedagogica della Repubblica
Si è accennato nella lezione precedente al ruolo ricoperto dal mito nell’educazione dei giovani
greci. E’ dunque logico che Platone, vestendo nella Repubblica gli abiti del fondatore della
città ideale, si ponga il problema di come collocare questa tradizione e di una sua possibile
pericolosità o utilità persuasiva per gli animi dei cittadini:
L15-T1 Il pericolo poetico
- Or non sai che l’inizio di ogni opera è cosa della massima importanza, specialmente
per ogni elemento giovane e tenero? Giacché allora soprattutto esso è plasmabile, e
vi si diffonde quell’impronta che uno voglia sia impressa in ciascuno.
- Senz’altro.
- Lasceremo allora così facilmente che i fanciulli ascoltino i primi miti che capitano,
foggiati dai primi venuti, e accolgano nell’anima opinioni per lo più opposte a quelle
che riterremo essi debbano avere, una volta fatti uomini?
Non lo permetteremo in alcun modo.
- Dovremo allora anzitutto soprintendere ai compositori di miti, e quelli che faccian
buoni trascegliere, e i non buoni scartare. I trascelti poi persuaderemo le nutrici e le
madri a raccontarli ai fanciulli, e a formare coi miti le anime loro assai più che non
con le mani i corpi. Ma di quelli che ora narrano i più vanno rigettati.
- Quali?
- Nei miti maggiori vedremo anche i minori, ché maggiori e minori debbon per forza
essere dello stesso tipo e avere lo stesso effetto. Non credi?
- Sì, ma non capisco nemmeno quali tu intendi per i maggiori.
- Quelli narratici da Omero ed Esiodo e dagli altri poeti; i quali han narrato e
narrano agli uomini miti falsi, da loro composti.
- Quali sono, diss’egli, e che ci trovi in essi a ridire?
- Ciò che anzitutto e soprattutto va biasimato, specialmente quando uno non
bellamente mentisca.
- E cos’è questo?
- Quando uno nei suoi discorsi malamente raffiguri la natura degli dei e degli eroi,
come un pittore che dipingesse immagini per nulla somiglianti agli oggetti che volesse
ritrarre.
- Ed è ben giusto biasimare simili cose. Ma in che senso diciam questo, e di quali
miti?
- Anzitutto malamente mentì, con la maggiore menzogna e su cose del massimo
conto, chi disse di Urano quello che Esiodo dice egli abbia fatto, e come Crono lo
punì. Quanto poi alle opere di Crono, e a quel che egli subì da parte del figlio,
neanche se fosse vero io riterrei si dovesse così facilmente dire a esseri irragionevoli e
giovani; ma piuttosto tacerlo, e se proprio ci fosse qualche necessità di dirlo, che lo
udissero per via misterica, quanto più pochi possibile, sacrificando non un porco ma
qualche grande e mal procurabile vittima, di modo che a pochissimi accadesse di
udirlo.
- Difatti, disse, questi racconti sono scabrosi.
- E non andranno fatti, diss’io, o Adimanto, nella nostra città. Né si dovrà dire a un
giovane ascoltatore che commettendo egli un’estrema ingiustizia non farebbe nulla di
strano, né punendo con estremi mezzi il padre ingiusto, ma che così farebbe proprio
ciò che han fatto i primi e massimi degli dei.
- No, per Zeus, neanche a me par che sian buone a dirsi queste cose.
- E neanche affatto che gli dei fan guerra agli dei, e s’insidiano e combattono fra loro,
ché non è vero, se bisogna che i nostri futuri custodi della città ritengano turpissima
cosa il venir facilmente in inimicizia gli uni contro gli altri. (…) Queste cose non
bisogna ammetterle nella città, siano esse state composte con o senza significato
allegorico. Giacché il giovane non è capace di distinguere quel che è o non è allegoria,
ma ciò che a quella età egli accolga nelle idee che si fa suol essere difficilmente
cancellabile e mutabile: e perciò bisogna fare ogni sforzo a che le prime cose che essi
odono siano miti composti quanto meglio è possibile per incitare alla virtù.
[Platone, Repubblica, 377b -379a, trad. Gabrieli]
La questione centrale affrontata dal testo, e che si pone come il problema politico primario per
Platone nell’inaugurare la sua città, è quella dell’educazione dei guardiani (i governanti), e
in genere della cittadinanza. In questo quadro si colloca la requisitoria platonica contro i
mitografi:
•
•
•
la questione è inevitabile dato che il sapere mitico è la base della cultura tradizionale;
enorme è per Platone il pericolo che racconti immorali o che presentano una immagine
distorta della divinità possano essere indiscriminatamente uditi dagli animi ingenui dei più
giovani, facilmente impressionabili e persuadibili;
Omero, Esiodo e i poeti in genere sono educatori degeneri, che spacciano racconti falsi
come ”verità di fede”.
Rispetto all’Eutifrone, il richiamo al quale è evidente persino negli esempi scelti, l’interesse
pedagogico è amplificato e si intreccia con la critica religiosa:
•
•
i miti poetici sono diseducativi perché rendono esemplari i difetti degli uomini
attribuendoli agli dei e dunque giustificandoli e abbellendoli e stimolando
l’identificazione con personaggi immorali;
il giovane possiede un animo facilmente plasmabile, perciò non può udire alcuni racconti:
egli non possiede strumenti critici di difesa che lo mettano in grado di distinguere
un’ipotetica narrazione allegorica dalla realtà; per questo, inoltre, quanto più forte è la
componente imitativa, che produce un’illusione di realtà, tanto più la poesia è pericolosa.
La soluzione proposta da Platone è semplice e allo stesso tempo radicale:
•
•
•
la fruizione di alcuni aspetti scandalosi del mito va limitata (l’allusione ai misteri e
agli iniziati) in modo che solo uomini consapevoli e in grado di discernere l’allegoria e la
letteralità ne siano a conoscenza;
l’intero patrimonio mitico, se anche resta alla base dell’educazione, deve essere
sottoposto a un rigoroso controllo e deve subire una drastica censura: le vere bugie dei
miti provocano altrimenti un’illusione di conoscenza assai più grave della stessa
ignoranza, in quanto subdola e inavvertita.
Platone stabilisce anche quali narrazioni siano da salvare: la poesia deve, nella città
ideale, trasmettere una nuova teologia la cui divinità sia eticamente razionale, buona,
aliena da propositi ingannatori e da ogni conflittualità.
Platone, tuttavia, rimane cosciente dell’immensa forza persuasiva che il mito possiede, per la
sua antichità e l’apertura al meraviglioso e al soprannaturale; ecco allora che il mito viene
conservato nei suoi tratti educativamente positivi. Ma egli non si limita a questo e intraprende
una dichiarata pedagogia mitologico-retorica che trova il suo culmine nella menzogna
politica:
L15-T2 La nobile menzogna
- Che mezzo ci sarebbe allora, inventando noi una buona di quelle menzogne che
han luogo in materia necessaria, e di cui poco fa parlavamo, per persuaderne
anzitutto i capi stessi, e, se non ci riesce, il resto della città?
- Di che menzogna si tratta?, disse.
- Nulla di nuovo, diss’io, ma qualcosa di fenicio, che prima accadeva in molti luoghi,
come affermano ed han persuaso i poeti, ma che al tempo nostro né è mai accaduto
né so se possa accadere, e richiederebbe poi molta persuasione per farne persuasi.
- Sembra che tu esiti a dirlo.
- E ti parrà ben naturale che io esiti, quando l’abbia detto.
- Dì pure, e non temere.
- Dico, per quanto non sappia con che ardire e servendomi di quali discorsi io dirò; e
cercherò anzitutto di persuadere i capi stessi e i soldati, e poi il resto della città, che
quell’allevamento e quell’educazione da noi data a loro, sembrava ad essi di subirla
tutta come un sogno, svolgentesi intorno a loro; ma che in realtà essi si trovavano
allora sotto terra, foggiati ed allevati, essi e le loro armi e ogni altro fabbricato
apparecchio, e che quando furono perfettamente lavorati, la terra madre li emise alla
luce; e che quindi ora essi debbono assistere col consiglio e difendere come genitrice
e nutrice la terra in cui si trovano, ove qualcuno l’assalga e considerare gli altri
cittadini come fratelli e nati dalla terra.
- Non senza ragione, disse, ti vergognavi prima di dire questa menzogna.
- E’ ben naturale, feci io; ma pur ascolta anche il resto del mito. Voi quanti siete, nella
città siete tutti fratelli, diremo loro mitologizzando; ma il dio che vi ha formati, quanti
erano atti a comandare ha mescolato nella loro generazione dell’oro, per cui essi sono
sopra tutti pregevoli; a quanti sono ausiliari dell’argento; e ferro e bronzo agli
agricoltori e agli altri artigiani. Come dunque tutti di una stessa stirpe, genererete per
lo più degli uguali a voi stessi, ma v’è il caso che dall’oro si generi una prole argentea
e dall’argento una aurea, e così da loro tutto il resto. Ai capi come prima e massima
raccomandazione il dio ingiunge che di nessuno abbiano a essere così buoni custodi e
nulla così attentamente custodiscano quanto la loro prole, badando a ciò che nelle
anime di costoro venga loro frammisto; e se un loro rampollo nasca con una certa
commistione di bronzo e di ferro, non si lascino commuovere in alcun moro, ma
assegnando alla natura il valore che le spetta lo caccino tra gli artigiani e gli agricoltori
e se per contro qualcun di costoro nasca con una vena d’oro o d’argento, lo
apprezzino e sollevino gli uni agli uffici di guardiano gli altri a quello di ausiliare;
essendovi un oracolo che allora la città andrà in rovina quando la custodisca il
guardiano di ferro o di bronzo. Or perché possano essi essere persuasi di un simile
mito, sapresti tu trovar qualche mezzo?
[Platone, Repubblica 414b-415d, trad. Gabrieli]
Il problema di Socrate è quello di legittimare la gerarchia politica che si viene a istituire nella
città ideale, innanzitutto per i governati e, in secondo luogo, anche per i governanti che
dovranno accettare alcuni obblighi (comunismo dei beni, delle donne, dei figli, divieto di
possesso di un patrimonio privato, l’onere stesso del governo), consci del valore del loro
ruolo: Socrate introduce una nobile menzogna o racconto fenicio per operare una totale
persuasione.
Il racconto fenicio è presentato consapevolmente come unico:
•
i miti narrati dai poeti pretendono di essere veri, questo è esplicitamente caratterizzato
come falso, finalizzato esclusivamente alla persuasione degli animi: è una menzogna sacra
•
•
•
a fin di bene che si pone come culmine della retorica politica e in questo senso è nobile o
utile;
Socrate esita a intraprendere la narrazione: mai questa esitazione coglierebbe Omero,
certo della verità dei suoi miti e dell’ispirazione divina che garantisce il suo canto e lo
rende possibile. Socrate teme invece di raccontare qualcosa di inaccettabile, laddove dalla
tradizione si è pronti ad accettare tutto, persino un dio patricida, invidioso, lussurioso;
l’attributo fenicio indica il carattere di mito di fondazione posseduto dal racconto, che,
infatti, rende accettabile una situazione di fatto fornendole una giustificazione teorica con
la sua antichità e origine direttamente dalla terra: esattamente la stessa giustificazione
divina di cui si serve la cultura tradizionale per giustificare certi comportamenti empi;
Socrate deve opporre al dato naturale, che mostra un soggetto ingiusto e immorale, un
soggetto costruito dall’educazione, pertanto il racconto è falso in quanto fa nascer dalla
terra qualcosa che è in realtà prodotto dall’educazione: non a caso i guardiani devono
credere che la loro educazione sia stata un sogno e che essi siano naturalmente destinati a
governare grazie all’oro presente nelle loro anime.
Il racconto persegue i suoi intenti persuasivi ricercando una garanzia autorevole per il dato di
fatto:
•
•
•
•
l’equivalenza terra-madre-natura supporta la tesi del carattere innato, originario e perciò
irrinunciabile della distinzione dei compiti nella città e del dovere dei guardiani di
difendere la patria (la terra che li ha generati);
il riferimento alla diversa nobiltà dei metalli e il dio plasmatore che determina le
caratteristiche delle anime giustificano divinamente e naturalmente la gerarchia;
la possibilità di generare figli diversi da sé rende ragione della mobilità sociale e della
meritocrazia, destituendo di fondamento l’aristocrazia di sangue;
il riferimento all’oracolo chiama in causa una voce autorevole, degna di fede, per
garantire il rispetto da parte dei guardiani di questa meritocrazia.
Il problema della giustizia è al centro della Repubblica, e rispetto a questo tema
l’organizzazione dello stato ideale rappresenta una sorta di digressione a scopo esplicativo.
Nel corso del secondo libro Glaucone narra il mito di Gige per dimostrare come il giusto non
sia tale volontariamente, ma solo per il timore che la sua ingiustizia possa venir scoperta e
punita. Al termine del suo racconto il fratello Adimanto lo approva, dichiarando per di più che
il perseguimento della giustizia non è disinteressato, ma è desiderato in considerazione dei
beni che ne derivano:
L15-T3 Dei e giustizia
Dunque, visto che l’apparenza, come mi dimostrano i saggi, sforza anche la verità e
determina la felicità, bisogna con tutte le forze volgersi a questo. Come facciata e
forma esteriore bisogna che io tracci a me intorno un’ombra sfumata di virtù, ma poi
mi tiri dietro la volpe furba e versatile del sapientissimo Archiloco. (…) “Ma agli dei
non si può né sfuggire né far violenza”. Orbene, se essi non ci sono o nessuna cura
hanno delle cose umane, che pensiero dobbiam darci noi di non farci scorgere? Se ci
sono, e se ne occupano, noi non sappiamo di loro altrimenti che per sentito dire, o
dalle leggende e dai poeti di genealogie, e questi ci dicono che essi sono smuovibili e
persuadibili con sacrifici e con blande preghiere e doni votivi. Ora a questi bisogna o
credere su tutti e due i punti, o su nessuno dei due. Se bisogna crederci, si ha a fare
un’ingiustizia e poi sacrificare a purificazione delle ingiustizie commesse. Giacchè se
saremo giusti resteremo senza pena soltanto da parte degli dei, e perderemo i
vantaggi dell’ingiustizia, se ingiusti, faremo i nostri guadagni, e poi supplicando da
trasgressori e peccatori, e così persuasi gli dei, ce la caveremo impuniti. “Ma nell’Ade
dovremo pagare il fio delle iniquità qui commesse, o noi o i figli dei figli”. Ma caro
mio, dirà quello facendo i suoi conti, una buona forza debbono poi avere le
espiazioni e gli dei proscioglitori, come asseverano le più grandi città e i figli degli dei,
fatti poeti e interpreti degli dei stessi, che dichiarano le cose star proprio così. Per
quale ragione dunque potremo ancor preferire la giustizia alla massima ingiustizia,
che ove riusciamo a procacciarcela insieme a un falso esterno decoro, vivremo a
nostro talento presso gli dei e presso gli uomini, da vivi e da morti, come vuole
l’opinione dei molti e dei sommi?
[Platone, Repubblica, 365c-366b, trad. Gabrieli]
A partire dal presupposto che la giustizia sia apprezzata solo in virtù dei beni che ne derivano
e non per convinzione interiore, Adimanto sostiene dunque che:
•
•
•
•
è sufficiente, per farsi una buona fama agire in pubblico giustamente, ma procurandosi in
segreto con ogni mezzo tutto ciò che si desidera;
chi dichiara che questi atti ingiusti, benché invisibili agli uomini, sono noti agli dei, non
considera l’incertezza circa l’esistenza degli dei e il loro interessamento alle vicende
umane;
ma anche ammettendo che questa tesi della visione degli dei fosse vera, i poeti affermano
che essi sono plasmabili con sacrifici e con blande preghiere e persino le pene dell’Ade
sono evitabili con queste forme di adulazione;
non vi è dunque ragione che consenta di ritenere più positiva una condotta giusta rispetto
a una ingiusta.
Analizziamo meglio quanto letto:
•
•
•
•
•
la posizione di Adimanto raccoglie alcuni temi dell’agnosticismo sofistico;
il dio era visto come custode e inibitore di quanto l’uomo faceva o pensava in privato:
Adimanto lo priva di questo ruolo attribuendogli una corruttibilità degna del più basso
degli uomini;
il culto ripara alle colpe commesse, in modo da procacciare non solo l’impunità terrena,
ma anche celeste, con una facciata di giustizia e devozione;
la conclusione di Adimanto è ancor più radicale di quella di Glaucone: anche se visto
dagli dei, l’uomo può perpetrare qualunque ingiustizia e guadagnarsi, nonostante ciò,
il rispetto degli dei e degli uomini; Glaucone poteva limitare la preferibilità
dell’ingiustizia alla sfera terrena, mantenendo come garanzia di giustizia lo sguardo
onnisciente della divinità;
non solo, ma Adimanto più oltre sostiene che, quasi certamente, chi sia davvero giusto
sarà malvisto dagli uomini e benvisto solo dagli dei, pertanto l’ingiusto, apprezzato da dei
e uomini, avrà una vita più felice del giusto e non dovrà attendere l’incerto al di là per
godere della eudaimonìa.
Il medesimo tema è ripresentato da Platone nelle Leggi (906d-907b), dove la questione posta
da Adimanto trova una di risposta a distanza. Platone utilizza paragoni infamanti per degli dei
che si lascino blandire così facilmente: cani da pastore corrotti da lupi, nocchieri ubriachi,
aurighi che vendono la vittoria. Lo scopo della dimostrazione è esplicitamente persuasivo: è
insopportabile che gli ingiusti possano agire indisturbati contando su una garanzia di
impunità persino divina, e mortificando a tale scopo la divinità stessa.
Ancora una volta si nota, come in molti altri dialoghi platonici (Fedro, Gorgia, Fedone), che
l’etica platonica può rimanere coerente fino in fondo con il suo carattere eudaimonistico solo
facendo ricorso all’escatologia: come mostra il mito di Er che chiude la Repubblica, è
necessario postulare, per rendere realmente appetibile un atteggiamento virtuoso, dei premi
per la virtù nell’oltretomba e, reciprocamente, castighi per la malvagità. Platone, che tanto
duramente si scaglia contro il mito, è costretto a salvare in extremis proprio con un mito il suo
progetto di stato ideale e per farlo crea un quadro grandioso.
La metempsicosi (reincarnazione), fatta oggetto di scelta, diventa in Platone qualcosa di
liberatorio e insieme responsabilizzante: l’eudaimonìa, il possesso di un buon demone, la
felicità, insomma, è resa possibile non tanto dal fatto che un buon daìmon presiede al
nostro destino, ma dal fatto che noi stessi abbiamo scelto un buon daìmon.
Lezione n. 16: Pensare per immagini
La posizione assunta da Platone rispetto alla poesia e in particolare alla produzione mitica è
certamente complessa e probabilmente soggetta a evoluzioni nel corso dello stesso sviluppo
del filosofare platonico. Certo è che Platone fa ampio ricorso, nei suoi dialoghi, alla
rielaborazione di miti tradizionali e alla creazione spontanea di miti del tutto originali, a
testimonianza del fatto che riteneva il mythos uno strumento privilegiato per veicolare
significati, anche specificamente filosofici. Le pesanti sferzate rivolte da Platone contro poeti
e mitologi non escludono dunque un impiego “positivo” del mito, e non solo quale elemento
unificatore e armonizzatore della società politica, ma anche come linguaggio “filosofico”.
Il testo che immediatamente segue riporta il caso di un racconto degli antichi che Socrate
propone a Fedro e che Fedro, non smentito dal suo interlocutore, attribuisce a Socrate stesso;
particolarmente significativa, per spiegare la considerazione platonica del mito, è l’ultima
battuta di Socrate:
L16-T1 Ciò che davvero importa
Socrate – Ho sentito narrare che a Naucrati d’Egitto dimorava uno dei vecchi dei del
paese, il dio a cui è sacro l’uccello chiamato ibis, e di nome detto Teuth. Egli fu
l’inventore dei numeri, del calcolo, della geometria e dell’astronomia, per non parlare
del gioco del tavoliere e dei dadi e finalmente delle lettere dell’alfabeto. Re dell’intiero
paese era a quel tempo Thamus, che abitava nella grande città dell’Alto Egitto che i
Greci chiamano Tebe egiziana e il cui dio è Ammone. Teuth venne presso il re, gli
rivelò le sue arti dicendo che esse dovevano esser diffuse presso tutti gli Egiziani. Il
re di ciascuna gli chiedeva quale utilità comportasse, e poiché Teuth spiegava, egli
disapprovava ciò che gli sembrava negativo, lodava ciò che gli pareva dicesse bene.
Su ciascuna arte, dice la storia, Thamus aveva molti argomenti da dire a Teuth sia
contro che a favore, ma sarebbe troppo lungo esporli. Quando giunsero all’alfabeto:
“Questa scienza, o re –disse Teuth – renderà gli Egiziani più sapienti e arricchirà la
loro memoria perché questa scoperta è una medicina per la sapienza e la memoria”.
E il re rispose: “O ingegnosissimo Teuth, una cosa è la potenza creatrice di arti
nuove, altra cosa è giudicare qual grado di danno e di utilità esse posseggano per
coloro che le useranno. E così ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei
inventore, hai esposto il contrario del suo vero effetto. Perché esso ingenererà oblio
nelle anime di chi lo imparerà: essi cesseranno di esercitarsi la memoria perché
fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente non più dall’interno di se
stessi, ma dal di fuori, attraverso segni estranei: ciò che tu hai trovato non è una
ricetta per la memoria, ma per richiamare alla mente. Né tu offri vera sapienza ai tuoi
scolari, ma ne dai solo l’apparenza perché essi, grazie a te, potendo avere notizie di
molte cose senza insegnamento, si crederanno d’essere dottissimi, mentre per la
maggior parte non sapranno nulla; con loro sarà una sofferenza discorrere, imbottiti
di opinioni invece che sapienti”.
Fedro – O Socrate, ti è facile inventare racconti egiziani e di qualunque altro paese ti
piaccia!
Socrate – Oh! Ma i preti del tempio di Zeus a Dodona, mio caro, dicevano che le
prime rivelazioni profetiche erano uscite da una quercia. Alla gente di quei giorni, che
non era sapiente come voi giovani, bastava nella loro ingenuità udire ciò che diceva
“la quercia e la pietra”, purché dicesse il vero Per te invece fa differenza chi è che
parla e da quale paese viene: tu non ti accontenti di esaminare semplicemente se ciò
che dice è vero o falso.
[Platone, Fedro, 274b-275c]
Il fatto che il mito sia inventato piuttosto che recuperato dalla tradizione non ne inficia il
valore, che risiede dunque non nella sua antichità o popolarità (si pensi alla polemica contro
Omero), ma nella sua capacità di esprimere un contenuto veritativo. È questa potenzialità a
definire il criterio sulla base del quale selezionare i miti da diffondere nella città ideale (come
afferma la Repubblica) e a determinare l’efficacia filosofica del mỳthos.
Impiego filosofico del mito non significa semplicemente presenza di inserti di stampo
narrativo, tradizionale o fantastico, all’interno dei dialoghi; per comprendere quanto il termine
mỳthos sia, in Platone, denso di significati, occorre innanzitutto considerare la particolare
concezione dei rapporti fra scrittura e oralità tipica di questo autore e sintetizzata nel
“racconto egiziano”:
•
•
•
•
la scrittura contribuisce a generare oblio, perché fissa i contenuti su un supporto esterno,
al quale fare riferimento invece di richiamare le cose alla memoria dall’interno di se
stessi;
lo scritto è utile limitatamente alla sua funzione ipomnematica, di richiamare cioè alla
mente contenuti già noti;
l’apprendimento tramite la parola scritta non produce il vero sapere, ma l’apparenza del
sapere; dando l’impressione di avere notizia di moltissime cose, fa sì che ci si creda
dottissimi senza che se ne conosca davvero nessuna e si discuta mettendo in campo non la
propria personale sapienza, ma le opinioni delle quali si è imbottiti;
il vero sapere riacquista solo tramite l’insegnamento, che coinvolge la vivacità della
parola orale e la sua capacità di scendere e prendere dimora nell’anima di chi ascolta.
Solo tenendo conto di queste assunzioni di fondo si comprende perché Platone affermi che
trattare della “scienza del giusto, del bello e del buono”(l’espressione è proprio del Fedro) in
testi scritti piuttosto che nella dimensione dell’oralità non può che essere un gioco, superiore a
tutti gli altri per serietà, ma pur sempre un gioco, e designi questo gioco come mythologhèin,
parlare per miti. Bisogna dunque concludere che Platone considera tutti i suoi dialoghi come
forme di mỳthos; anche nella Repubblica si riferisce alla sua trattazione sull’educazione come
a un racconto in forma di mito e illustrando la struttura generale dell’opera dice di stare
parlando per immagini (il verbo greco è ancora mythologhèin).
In alcuni casi, il discorso filosofico assume la forma del mito non o non solamente in quanto
scritto, ma perché è la materia stessa oggetto di trattazione a essere strutturalmente accostabile
solo con un approccio che si limiti allo statuto della narrazione (in greco mỳthos) probabile.
A questo proposito, ecco un passo tratto dall’apertura del Timeo:
L16-T2 Accontentarsi di una narrazione probabile
Timeo - Ma il Fattore e il Padre di questo universo è molto difficile trovarlo, e,
trovatolo, è impossibile parlarne a tutti.
E questo si deve indagare dell’universo: guardando a quale degli esemplari chi ha
fabbricato l’universo lo abbia realizzato, se all’esemplare che è sempre nello stesso
modo e identico o a quello che è generato.
Ma se questo mondo è bello e l’artefice è buono, è evidente che Egli ha guardato
all’esemplare eterno; e se, invece, l’Artefice non è tale, ciò che non è neppure
permesso a qualcuno di dire, ha guardato all’esemplare generato. Ma è evidente a tutti
che Egli guardò all’esemplare eterno: infatti l’universo è la più bella delle cose che
sono state generate, e l’Artefice è la migliore delle cause.
Se, pertanto, l’universo è stato generato così, fu realizzato dall’Artefice guardando a
ciò che si comprende con la ragione e con l’intelligenza e che è sempre allo stesso
modo.
Stando così le cose, è assolutamente necessario che questo cosmo sia immagine di
qualche cosa.
Ora, in ogni questione è della massima importanza incominciare dal suo principio
naturale. Pertanto, anche intorno all’immagine e all’esemplare di essa, bisogna
riconoscere questo, che i discorsi hanno un’affinità con le cose stesse di cui sono
espressione.
Dunque, ciò che è stabile e saldo e che si manifesta mediante l’intelletto, conviene
che sia stabile e immutabile, almeno nella misura in cui si concede ai discorsi che
siano inconfutabili e invincibili: di questo non deve mancare nulla.
Invece, i discorsi che si fanno intorno a ciò che fu ritratto su quel modello, e che
quindi è immagine, sono a loro volta verisimili e in proporzione ai primi: infatti, ciò
che in rapporto alla generazione è l’essenza, questo in rapporto alla credenza è la
verità.
Dunque, o Socrate, se dopo molte cose dette da molti intorno agli dei e all’origine
dell’universo, non riusciamo a presentare dei ragionamenti in tutto e per tutto
concordi con se medesimi e precisi, non ti meravigliare. Ma se presenteremo
ragionamenti verosimili non meno di alcun altro, allora dobbiamo accontentarci,
ricordandoci che io che parlo e voi che giudicate abbiamo una natura umana:
cosicché, accettando intorno a queste cose la narrazione probabile, conviene che non
ricerchiamo più in là.
Socrate - Molto bene, o Timeo, bisogna accettare in tutto e per tutto la cosa nella
maniera in cui dici. Il tuo proemio l’abbiamo accolto con ammirazione e ora facci
sentire il seguito del tuo canto.
[Platone, Timeo, 28b-29d. Traduzione di G. Reale]
Il brano è tratto dal preludio del discorso di Timeo, che espone la dottrina cosmologica
platonica; prima di addentrarsi nello sviluppo dell’argomento, Timeo si preoccupa di
specificare quale sarà il tenore del suo discorso; al termine, Socrate dimostra di avere
compreso che il registro del suo interlocutore è quello del mito: infatti indica quanto
precedentemente detto come proemio e quanto segue come il seguito del tuo canto.
I discorsi hanno un’affinità con le cose stesse di cui sono espressione: è questo il passaggiochiave del brano e il criterio che sta alla base dell’intero discorso platonico sulla cosmologia.
L’argomento platonico è il seguente:
•
•
•
•
•
una volta ammesso che il cosmo è in divenire e è stato generato da una causa, occorre
stabilire i termini dell’azione di questa causa produttrice: bisogna indagare se chi abbia
fabbricato l’universo lo abbia realizzato guardando a un modello eterno o a un modello
generato;
poiché questo mondo è la più bella delle cose che sono state generate e l’Artefice è la
migliore delle cause, è evidente che ha guardato all’esemplare eterno;
i discorsi hanno un’affinità con le cose stesse di cui sono espressione:
l’esemplare eterno è stabile e saldo e si manifesta mediante l’intelletto: i discorsi intorno a
esso devono essere inconfutabili e invincibili;
ciò che sull’esemplare si modella è immagine dell’esemplare: i discorsi intorno a esso
sono a loro volta verosimili e in proporzione ai primi.
Oltre alle difficoltà caratteristiche di ogni discorso che non si svolga nell’ambito dell’oralità e
conduca gradualmente al sapere autentico (a tali difficoltà Platone sembra accennare quando
afferma: Ma il Fattore e il Padre di questo universo è molto difficile trovarlo, e, trovatolo, è
impossibile parlarne a tutti), quello intorno alla cosmologia ne presenta dunque delle altre:
deve “adattarsi alle cose stesse di cui è espressione” e tratta di enti sottoposti al divenire. Se la
scienza di ciò che è immutabile e eterno si esprime in discorsi inconfutabili e invincibili in
quanto garantiti dall’immutabilità del loro oggetto, tutti gli aspetti della realtà connessi con
il divenire devono essere esposti in una forma di narrazione che sia semplicemente
probabile: si muovono infatti su piani ben diversi di stabilità l’essenza e la generazione, la
verità e la credenza; sono anzi fra loro in proporzione, come il modello e ciò che su di esso è
esemplato.
In sintesi, si potrebbe affermare che, poiché è assolutamente necessario che questo cosmo sia
immagine di qualche cosa, la riflessione intorno a esso deve a sua volta svilupparsi per
immagini: dal momento che il mondo fisico è stato generato dall’Artefice come immagine
sensibile di un modello intelligibile non può che essere espresso tramite un mito verisimile
che sia immagine vivida del Vero (Platone non perde mai di vista il legame del mito con la
verità, ragione del suo impiego filosofico).
Certamente influisce, sulla scelta della narrazione mitica, anche la considerazione della
limitatezza delle possibilità umane, che emerge chiaramente nel passo del Timeo: dobbiamo
accontentarci, ricordandoci che io che parlo e voi che giudicate abbiamo una natura umana:
cosicché, accettando intorno a queste cose la narrazione probabile, conviene che non
ricerchiamo più in là. Questo aspetto è dominante nei casi in cui Platone propone miti di
impronta escatologica.
In conclusione, si possono rintracciare vari usi “filosofici” del mito in Platone:
•
•
•
dato il particolare rapporto scrittura-oralità, sono un parlare per miti tutte le trattazioni
filosofiche che si svolgono al di fuori della dialettica orale;
è mito, cioè narrazione probabile, l’intera cosmologia platonica, poiché prende in esame
un oggetto che solo in termini di verosimiglianza può essere sviluppato;
è attraverso il mito che può essere affrontato l’ambito escatologico, a motivo delle
limitate capacità della ragione umana in questo settore
In tutti i casi è evidente come la funzionalità del discorso mitico sia legata al suo
rappresentare, nei singoli contesti, la migliore approssimazione possibile alla verità;
l’obiettivo filosofico della verità rimane quindi dominante e il registro mitico, lungi dal
precluderne l’accesso, moltiplica piuttosto i percorsi per raggiungerlo.
Lezione n. 17: La teologia “politica” delle Leggi
Le Leggi sono l’ultimo dialogo di Platone, che è stato definito come il suo testamento
politico. Come nella Repubblica, il filosofo si impegna nell’imponente opera di fondazione e
organizzazione di uno stato perfetto. Al di là delle differenze tra i due dialoghi, conta qui
sottolineare alcuni aspetti caratteristici di questo testo, legati al progetto politico dell’ultimo
Platone e ai suoi rapporti con la fede nel divino.
Iniziamo, allora, con un mito:
L17-T1 L’età di Crono
Prima delle costituzioni alle quali abbiamo accennato, si dice che di gran lunga
antecedente ci fosse stato il governo e lo stato, così felice al tempo di Crono. E che,
anzi, il governo più perfetto dei nostri tempi sia soltanto imitazione di quello. (…) la
tradizione è concorde nell’ammettere vita felice per gli uomini in quei tempi antichi;
si dice che l’umanità avesse allora in grande abbondanza ogni cosa e che tutto si
producesse spontaneamente. E press’a poco ecco la causa di questo fatto.
Crono sapeva che, come abbiamo osservato, l’umana natura non acconsente a nessun
uomo di provvedere con pieno assoluto potere a tutti gli interessi dei suoi simili.
Quando l’uomo perviene a questo grado supremo, purtroppo pieno di violenza e
d’ingiustizia se ne dimostra l’operato. Alla quale condizione il dio, riflettendo, mise sì
allora re e sovrani a capo delle città umane; ma non erano uomini questi re e questi
sovrani. Erano di più alta stirpe e più divina: demoni, cioè entità sovrannaturali. Allo
stesso modo noi oggi provvediamo agli armenti e alle greggi in genere d’animali
domestici. In tal caso non bovi per altri bovi, non pecore per altre pecore mettiamo a
presiedere quali governanti, ma noi stessi esercitiamo il dominio, noi che siamo di
generazione più eletta.
Questa medesima cosa dio ebbe a pensare evidentemente, ed essendo pure amante
dell’uman genere, ne mise a capo una stirpe migliore della nostra, quella dei demoni.
E questa stirpe, con facile opera di governo, e non piccolo vantaggio anche da parte
nostra, si prese cura delle nostra condizione. E questi demoni procurarono a noi
pace, reciproco rispetto, leggi ottime e perfette, pienezza di giustizia; questi demoni
resero i figli degli uomini concordi fra loro, senza più rivalità, felici e contenti.
E dice tuttora questa tradizione, e dice certo il vero, che quegli stati in cui non un dio,
ma umana potestà mortale governi, ebbene, per questi stati non v’è modo di evitare,
per nessun modo, sventura e affanno. E afferma ancora questa tradizione che l’uomo
deve, in ogni maniera, cercar di imitare la vita di cui tradizione ci parla; vita vissuta al
tempo di Crono. Nel nostro essere vi è, sai bene, facoltà immortale; si tratta quindi di
rispettarne in pieno le esigenze nelle pubbliche ragioni e nelle ragioni private, e in
questo modo governar le famiglie e gli stati, e null’altro ritenere sia legge se non in un
certo modo lettura di mente che trasceglie, distribuisce, dispensa.
(Platone, Leggi, 713b-714a, trad. Turolla)
Platone, a questo punto del dialogo, ha già stabilito che le condizioni per poter raggiungere lo
stato perfetto sono quelle in cui il massimo di temperanza e intelligenza si sposino con il
massimo del potere. Ora deve tentare di foggiare le leggi di questo stato e, allo scopo,
introduce il mito di Crono:
•
•
l’età del governo di Crono è presentata come antichissima, precedente all’ideazione dei
vari tipi di costituzione storicamente conosciuti;
il tempo in cui i destini degli uomini erano governati dagli dei era un’età dell’oro in cui la
natura offriva spontaneamente i propri frutti e regnava la pace;
•
•
gli stati dove il governo sia detenuto dagli uomini sono destinati alla rovina;
l’uomo deve nel governo di sé e dello stato adeguarsi e imitare il più possibile quell’antico
modello divino, rispondendo esclusivamente a ciò che di divino c’è in lui, l’anima.
Anche questo, come il racconto fenicio della Repubblica (L15-T2), è un mito politico, e un
tratto comune è il riferimento alla rovina in cui può cadere la città se mal governata (da
uomini di bronzo o, semplicemente, da uomini), ma esso:
•
•
•
•
non è presentato come falso, né vi è esitazione a raccontarlo;
rappresenta un ideale limite cui le leggi che si stanno per stabilire devono ispirarsi;
proietta l’ideale all’indietro, in un passato meraviglioso;
la divinità non ha caratteristiche demiurgiche, ma, più tradizionalmente, è rappresentata
sotto forma di legislatrice e garante della giustizia.
Il principio che giustifica il mito è quello dell’imitazione di dio cui deve spingere legislatori e
cittadini. Più oltre Platone scrive:
L17-T2 Dio-misura
Noi diremo così: “O uomini, come antiche tradizioni tramandano, iddio regge
cominciamento, termine e medietà di quanto esiste, retto egli procede secondo sua
natura, in giro sempiterno volvendosi. E dietro a lui, perenne, giustizia viene,
vendicatrice di quanti divina legge pongono in non cale. Di lei prossimo seguace,
viene, umile e modesto, l’uomo che dovrà esser felice. Chi invece, gonfio per
orgoglio, superbo per ricchezza o per onori, superbo per fisica prestanza, stolto
insieme e inesperto, arde nell’anima sua e si fa compagno a violenza; chi ritiene di
non aver bisogno d’altri che lo regga o lo governi, ma si reputa anzi guida adatta per i
propri simili. Ebbene, costui resta abbandonato, fatto deserto di dio. (…) In
conseguenza, dio in grado supremo è universale misura di tutte le cose. E ben più
che non l’uomo. Come pur si va dicendo. Perciò chi vorrà diventare amico a lui,
deve, per quanto è possibile, diventare egli pure in sommo grado a lui somigliante.
(Platone, Leggi, 716a-e, trad. Turolla)
Nel testo sono da sottolineare alcuni punti che si legano al mito di Crono, trasferendo nel
reale ciò che è stato detto con la favola.
•
•
•
•
•
•
rispetto al mito è dato maggior rilievo al potere del dio sull’intero cosmo, di cui è
reggitore oltre che iniziatore (prospettiva demiurgica), e non solo in riferimento
all’uomo;
con l’equivalenza divino-giustizia si equipara il rispetto delle leggi negli stati concreti
con l’obbedienza agli dei nel regno di Crono;
si puntualizza la pochezza dell’uomo la cui superbia è empia e tracotante;
si osserva la correlazione tra felicità e giustizia e quindi tra la fedeltà alle leggi divine
e felicità;
Platone rovescia il motto protagoreo, affermando che vera misura delle cose è il dio e
dunque egli non solo è il garante, ma anche il modello della giustizia cui la legislazione e i
cittadini si devono attenere;
il tentativo di somigliare al dio è positivo per l’individuo, che ottiene felicità e
benevolenza divina, ma, soprattutto, per lo stato, che attinge così alla sua origine lontana e
ai tempi lieti del governo di Crono è può aspirare a riprodurli.
Non sempre, nonostante il loro ruolo di modello, gli dei sono adeguatamente rispettati:
L17-T3 Il preludio alle leggi
In quanto poi si può far violenza agli dei con parola e con azione, dovremo
determinare ora la pena relativa, facendo precedere un ammonimento. E sia il
seguente: quanti conformemente alla legge credono nell’esistenza degli dei, non
vorranno per quanto sta in loro commettere empietà, mai pronunciare illecita parole;
il che invece potrà provenire da una delle seguenti tre cause: o non si crede
nell’esistenza degli dei, oppure, in secondo luogo, pur credendo nella loro esistenza,
non si pensa che si occupino degli uomini; o, terza ipotesi, si crede possibile placare
l’ira divina, guadagnandone il favore per mezzo di sacrifici e di preghiere.
(…) Eh, cosa vuoi, certo con un po’ d’ironia prenderanno la parola: “Amici cari, tu
ateniese, e tu o spartano, come te pure o cnosio, voi dite la verità. E’ un fatto, una
parte di noi non crede nell’esistenza degli dei, una parte, invece, è nella condizione
degli altri di cui avete fatto cenno. E si desidererebbe anzi una cosa. Come voi stessi
avete detto che ci si deve comportare promulgando una legislazione, ebbene, alla
stessa guisa, prima di procedere al severo linguaggio di minaccia, si desidererebbe che
faceste esperimento di persuasione su di noi, che insomma ci poteste istruire e ci
faceste vedere che gli dei veramente ci sono. Si vorrebbero da voi adatte prove e che
ci faceste comprendere che troppo sublime è quella natura perché, incantata da doni,
possa venir sviata contro giustizia”
(Platone, Leggi, 885b-d, trad Turolla)
Platone, prima di stabilire le pene relative ai reati di empietà, si premura di fare alcune
precisazioni:
•
•
•
tali gesti non possono provenire da uomini devoti;
i colpevoli saranno spinti a ciò da tre possibili concezioni:
• l’idea che non esistano gli dei;
• l’idea che, se pure esistono, non si occupano delle vicende degli uomini;
• la possibilità di placare l’eventuale ira divina con atti estrinseci di devozione;
è necessario persuadere questi miscredenti della falsità delle loro convinzioni: il dialogo
proseguirà infatti dimostrando l’esistenza degli dei, il loro coinvolgimento nel mondo e la
loro incorruttibilità.
Sono enunciati da Platone tre forti e diffusi elementi di sfiducia nella tradizione religiosa. La
strategia persuasiva proposta da Platone come contromisura alla miscredenza testimonia:
•
•
•
•
come sia ormai impossibile far riferimento alla passiva acquiescenza alla tradizione
religiosa per imporre alcunché, dunque come essa abbia perso il suo valore veritativo e
persuasivo;
come l’adesione a una legislazione da parte di un cittadino si ottiene veramente solo
se egli è intimamente convinto della sua giustezza;
chiamare in causa gli dei può essere persuasivamente efficacissimo, ma di fronte alla
crescente sfiducia religiosa persino la semplice affermazione della loro esistenza diventa
problematica;
proprio per la forza retorica che la religione possiede una volta liberata da possibili fonti
di incredulità, al termine delle confutazioni delle tre tesi degli agnostici Platone affermerà:
“per conto mio questo sarebbe il preludio più bello e più sublime ad ogni legge”.
Parte quarta: conclusioni
Affrontare Platone nel suo rapporto con il mito significa presentare il suo pensiero secondo
quella che sembra essere la sua considerazione dei dialoghi che, vista la svalutazione della
scrittura rispetto all’oralità, sono un “parlare per miti”. Egli prende spesso posizione nei
confronti del mito che sta alla base dell’educazione della grecità e inserendosi nel vasto
dibattito in corso nella polis. La prospettiva pedagogica è essenziale per comprendere il
significato di questi interventi:
•
•
Platone prende di mira gli educatori tradizionali, poeti e sacerdoti, smascherandone la
superficiale cultura religiosa e reputando indegni di fede e riprovevoli alcuni contenuti da
loro proposti;
scopo primario è quello di insediare, nel posto da essi occupato, il filosofo, che scende
nella caverna e ne riemerge con la missione di narrare all’umanità quanto ha conosciuto.
La critica al mito ha però soprattutto una finalità politica:
•
•
•
la educazione dei cittadini è d’importanza primaria per il buon funzionamento dello stato
e miti immorali sono pertanto assai rischiosi: a tale scopo Platone si fa teorico della
censura;
il mito ha però un valore persuasivo e una ricaduta esistenziale tali da rendere
impossibile il suo accantonamento come forma di trasmissione di sapere;
esso viene inoltre piegato alle esigenze dello stato, diventa menzogna politica che può far
accettare come naturale e divina ogni disposizione e ogni gerarchia.
La riabilitazione di certe forme del mito che si compie nelle Leggi discende da un’attenta e
più ampia valutazione di quanto pericolosi si rivelino l’ateismo e un’errata concezione del
rapporto degli dei con il mondo degli uomini per la compagine statale: favoriscono infatti
comportamenti ingiusti. Di qui la necessità:
•
•
di una persuasione religiosa che stimoli ad atteggiamenti virtuosi;
di dimostrare l’esistenza degli dei e la loro attenzione per le vicende terrene, ma
soprattutto l’inutilità di ogni tentativo di corruzione ai loro danni da parte dell’ingiusto.
Platone arriva dunque a formulare in via del tutto razionale una propria teologia di significato
spiccatamente politico, ma ricorre anche a narrazioni mitiche che sintetizzano i punti nodali
della sua dottrina e la esprimono in immagini efficacissime, pur nella convinzione che tale
narrazione si pone su un gradino più basso, seppure più immediatamente comprensibile,
rispetto al pensare per concetti che caratterizza la filosofia. Nonostante il costante
tentativo di arrivare per via razionale all’affermazione di un codice etico e di una visione
teoretica, si deve inevitabilmente ricorrere al mito escatologico per conferire un
fondamento realmente solido e convincente al proprio filosofare.
Ricerche
La bibliografia su Platone è naturalmente sterminata; si consiglia innanzitutto, per le
tematiche affrontate in questa Parte, la lettura integrale dell’Eutifrone [in Platone, Opere
complete, Laterza, Bari, 1988] e dei Libri II e III della Repubblica [Rizzoli, Milano, 1997]
oltre che del mito di Er alla conclusione del X libro del medesimo dialogo.
Particolarmente significativo per quanto riguarda la polemica di Platone contro la poesia
omerica è E.A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura: da Omero a Platone,
Laterza, Roma-Bari, 1983: capp.1 [Platone e la poesia], 2 [La Mimesi], 3 [La poesia come
salvaguardia della comunicazione], 13 [La poesia come opinione] e 15 [“La musica suprema
è la filosofia”].
Sull’Eutifrone si veda F. Trabattoni, Platone, Carocci, Roma, 1998, cap.3 [La critica alla
cultura tradizionale].
Per un’interpretazione della Repubblica e dei suoi miti in una chiave originale si consigliano i
saggi critici contenuti nell’edizione di Platone, Repubblica, Bibliopolis, Napoli, 1998 curata
da M. Vegetti; suggestiva anche la lettura proposta nelle lezioni universitarie di C. Sini, La
virtù politica. Filosofia e antropologia, CUEM, Milano, 2000.
Per una presentazione chiara della complessa architettura delle Leggi e un loro confronto con
le analoghe tematiche della Repubblica si consigliano i capp.10 [Etica e politica nella
Repubblica] e 15 [L’ultimo pensiero politico di Platone: il Politico e le Leggi] del già citato
Platone di F. Trabattoni.
Sulla religione nei dialoghi platonici si può affrontare la lettura di A. Bortolotti, La religione
nel pensiero di Platone dai primi dialoghi al Fedro, Olschki, Firenze, 1986.
Parte quinta: Etica e teologia nello stoicismo e nell’epicureismo [lezioni 18-20]
Lezione n.18: La lotta contro la superstizione
I massimi esponenti della filosofia epicurea, il suo ideatore Epicuro, e il poeta latino Lucrezio,
con la trattazione poetico-didascalica del pensiero epicureo nel De rerum natura, adottano un
atteggiamento fortemente critico nei confronti della tradizione religiosa: in particolare è
messo sotto accusa il rapporto di subordinazione e timore che l’uomo instaura con la divinità,
rendendosi così vittima di una superstizione dannosa e angosciante. In questo senso si muove
la ricerca scientifica di Epicuro, che si spinge alla ricerca delle cause prime dei fenomeni di
cui gli uomini sono spettatori allo scopo di reperirle all’interno della natura, senza ricorrere a
forze divine soprannaturali e minacciose, in grado di stravolgere l’assetto del cosmo del tutto
improvvisamente. Si rende necessaria una rivoluzione scientifica per liberarsi dall’oppio della
religione.
L18-T1 L’esigenza scientifica
XI - Se non ci turbasse la paura delle cose celesti e della morte, nel timore che esse
abbiano qualche importanza per noi, e l’ignoranza dei limiti dei dolori e dei desideri,
non avremmo bisogno della scienza della natura .
XII - Non era possibile dissolvere i timori riguardo a ciò che è più importante
ignorando che cosa fosse la natura dell’universo ma vivendo in sospettoso timore per
i miti. Così non era possibile senza lo studio della natura avere pure gioie.
XIII - A niente giovava il procacciarsi la sicurezza dagli uomini finché rimanevano i
sospetti e le paure per le cose del cielo e dell’Ade e di ciò che avviene nell’universo.
[Epicuro, Massime capitali]
Epicuro si sofferma a delineare la connessione tra scienza naturale e felicità in
contrapposizione al binomio superstizione-turbamento:
•
•
•
l’impegno scientifico si rende necessario per effetto dei timori degli uomini circa le
cose celesti (dei e fenomeni), le pene dell’Ade, la morte;
l’insegnamento veicolato dai miti impedisce la pura gioia, dal momento che ingenera
timori che è possibile dissolvere solo con la ricerca e il reperimento scientifico della vera
natura dell’universo;
nessun’altra forma di sicurezza e benessere elimina il sospetto ed è dunque serenamente
godibile.
Scopo di Epicuro è dunque liberare, mediante la spiegazione scientifica, l’uomo dal timore
della vita e della morte la cui fonte primaria è vista nei contenuti dei miti e delle prescrizioni
religiose.
La scienza epicurea adotta il metodo delle spiegazioni molteplici di un singolo fenomeno, di
per sé antiscientifico ma assai utile per i suoi scopi etici: Epicuro vuole persuadere il lettore
che tutto è spiegabile razionalmente e che la provvidenza divina non è coinvolta. Egli non
nega la esistenza degli dei, ma esclude la veridicità della concezione tradizionale che fa loro
esercitare una qualche influenza sugli uomini e sul mondo.
L18-T2 Gli dei e il mondo
Per quanto riguarda i moti, le rivoluzioni, e il sorgere e il tramontare, e gli altri
fenomeni simili dei corpi celesti, non bisogna credere che ci sia qualche essere che a
ciò è preposto e dia, o abbia dato, ordine ad essi, e nello stesso tempo goda della
più completa beatitudine e dell’immortalità – poiché occupazioni e preoccupazioni
e ire e benevolenze sono inconciliabili con la beatitudine: sono cose che
provengono da debolezza, e timore, e bisogno degli altri – né, essendo un po’ di
fuoco conglobato, dotati di beatitudine assumano questi moti per spontaneo atto di
volontà. (…)
Oltre a tutto ciò bisogna credere che il più grave perturbamento sorge nelle anime
degli uomini nel credere che le medesime creature possano essere beate e immortali
e avere volontà e azioni e cause contrarie a tali loro attributi, e, o nell’attendere o
nel temere, prestando fede ai miti, qualche male eterno, o nel paventare quella
mancanza di sensibilità che è nella morte, come se fosse per noi un male e nel
dover sopportare tutto ciò non in seguito a proprie opinioni, ma per una specie di
irragionevole insania; per cui, non sapendo ben determinare che cosa si deve
temere, [gli uomini] sono soggetti allo stesso o anche a maggiore perturbamento
che se avessero delle loro decise opinioni nei riguardo di ciò. L’imperturbabilità
proviene dalla completa liberazione da tutto ciò e dal ricordo ininterrotto dei
principi generali e fondamentali della dottrina.
[Epicuro, Lettera a Erodoto, 76-77 e 81-82]
Il testo torna sulla possibilità di spiegare fenomeni naturali con un intervento divino, ma:
•
•
•
rileva che un qualunque agire della divinità nel mondo è in contrasto con i caratteri di
beatitudine e immortalità a essa attribuiti;
questo perché ira, preoccupazioni, benevolenze sono indice di debolezza, mancanza,
incompiutezza, non autosufficienza: per converso agli dei è riconosciuta questa autarchia;
la credenza nella supervisione e nella preoccupazione divina per l’uomo e il mondo
produce grave turbamento nell’animo: Epicuro caratterizza questo prestar fede ai miti
come irragionevole insania.
Epicuro svela agli uomini le leggi fisiche a cui sottostanno tutte le cose, dei compresi, così si
pone fine all’arbitrio e l’uomo è reso finalmente padrone di se stesso e del suo destino.
Senza ricorrere ad astrazioni concettuali, Lucrezio mostra plasticamente le aberrazioni cui può
condurre la superstizione mediante la narrazione del sacrificio di Ifigenia da parte del padre
Agamennone:
L18-T3 Ifigenia, vittima della superstizione
Questa è la mia paura, che tu creda di accettare i principi
di una dottrina empia e di avanzare sulla via del delitto.
Al contrario, è stata proprio quella religione a produrre azioni
Empie e crudeli. Come in Aulide brutalmente deturparono
L’altare della vergine trivia con il sangue di Ifigenia
I capi scelti dei Danai, fior fiore di eroi.
E non appena la sacra benda, posta intorno alle chiome,
ricadde su entrambe le guance alla vergine,
e si accorse che il padre stava triste davanti agli altari,
e da presso i ministri celavano il ferro, e i cittadini
alla vista piangevano, muta per il terrore,
piegata sulle ginocchia cadeva a terra.
Né all’infelice poteva giovare in questo caso
Che per prima avesse donato al re il nome di padre,
e presa da mani di uomini fu portata all’altare
non per compiere un rito di nozze e accompagnata
da splendido corteo passare nella casa,
ma per morire impuramente, lei così pura
proprio in stagione di nozze, ammazzata dal padre.
Vittima infelice perché la flotta felice partisse.
A tanti mali indurre allora potè la religione.
[Lucrezio, De rerum natura, I, 80-101]
Lucrezio mira a suscitare orrore e sdegno:
•
•
•
•
la dottrina epicurea non è empia per la sua considerazione di dei e religione tradizionale,
anzi, è proprio quest’ultima a risultare empia come mostra la vicenda di Ifigenia;
il sacrificio è raccontato sottolineando l’aspetto ingannatore, e perciò colpevole, con cui è
presentato a Ifigenia come un rito di nozze;
a ordinare il sacrificio è il padre della vittima;
la giovane muore per volere di una divinità crudele affinché la navigazione achea verso
Troia abbia buon esito.
La narrazione lucreziana prende spunto da un’affermazione dello stesso Epicuro che, nella
Lettera a Meneceo, afferma che “Empio non è colui che rinnega gli dei del volgo, ma colui
che le idee del volgo applica agli dei”. La dottrina epicurea non è empia nel rinnegare la
religione tradizionale; l’esposizione di Lucrezio ribadisce alcuni cardini della requisitoria
epicurea:
•
•
il non coinvolgimento divino nelle vicende umane;
la pericolosità di una religiosità che, non ritenendo vera questa tesi, spinge ad azioni turpi
e sacrileghe come l’uccisione di una fanciulla innocente per la ragion di stato che impone
il sacrificio del singolo a vantaggio della comunità: Agamennone è vittima di un
accecamento superstizioso che gli impedisce di cogliere la follia del suo atto e a produrlo
è la fede nelle opinioni religiose del volgo.
Lucrezio arriva a sostenere che credenza negli dei costituisca esclusivamente una tappa della
evoluzione umana rispondente a quanto già gli uomini più antichi vedevano durante la veglia
o il sonno: l’origine della religione tradizionale è del tutto storica e psicologica, dovuta
all’incapacità di reperire razionalmente le cause di ciò che si osserva nel cosmo.
Dal riconoscimento della potenza illimitata degli dei immaginati derivano i culti in cui
Lucrezio crede di riconoscere:
•
•
•
il contrario della devozione, la cui vera natura risiede nella capacità di guardare tutto
serenamente;
la umiliazione dell’uomo che finisce per vedersi come un burattino nelle mani delle
potenze divine;
la angoscia dinanzi all’arbitrio dell’azione divina.
Un ulteriore aspetto connesso con la religiosità e che Epicuro tenta di esorcizzare con
spiegazioni razionali è la paura della morte.
Alla condanna dell’immagine dell’Ade descritta dai miti Lucrezio dedica versi carichi di
sarcasmo e amarezza:
L18-T4 Le pene dell’oltretomba
Senza alcun dubbio i tormenti, che si dice vi siano
Nel profondo Acheronte, sono in realtà tutti nella nostra vita.
Né Tantalo infelice, come si favoleggia, raggelato da un vano terrore,
teme l’enorme macigno che incombe sospeso nell’aria;
ma piuttosto nella vita lo stolto timore degli dei incalza i mortali
che temono le sventure di cui sarà foriera a ognuno la sorte.
Né gli uccelli penetrano in Tizio disteso nell’Acheronte,
né certo possono trovare entro il suo vasto petto
qualcosa in cui frugare nell’eternità del tempo.
….
Ma nella vita è il terrore delle pene per le malvagità compiute,
crudele per crudeli delitti, e l’espiazione della colpa,
il carcere e il tremendo balzo giù dalla rupe,
le frustate, i carnefici, le violenze, la pece, le lamine, le torce;
e anche se tutto ciò è lontano, la mente consapevole dei misfatti
rimordendo applica a sé quei tormenti, brucia sotto la sferza,
e non vede intanto qual termine possa esserci a quei mali,
né qual sia infine l’interruzione di quelle pene,
e teme anzi che le medesime in morte s’inaspriscano.
Qui sulla terra s’avvera per gli stolti la vita dell’inferno
(Lucrezio, De rerum natura, III, vv.978-986 e 1014-1023 trad. Canali)
Data per scontata, sulla base della fisica epicurea, la impossibilità delle vita ultraterrena,
assurde risultano anche le raffigurazioni dell’oltretomba e delle sue pene la cui origine, come
già quella della religione, è ricondotta a un antropomorfismo deteriore e ridicolo che traspone
le angosce, i timori, i rimorsi terreni in un immagine soprannaturale:
•
•
Lucrezio riprende alcune delle figure mostruose più tipiche dell’Ade mitico (Cerbero, le
Furie), le descrizioni dei luoghi (il fuoco, l’assenza di luce, i fiumi) e i tormenti esemplari
quali quelli di Tantalo, Tizio, Sisifo;
le pene e la orrorifica immagine dell’Ade, che occupano la mente degli uomini, non
sono altro che una proiezione nell’aldilà di colpe e rimorsi: di qui l’affermazione, che
torna come un ritornello all’inizio e alla fine del brano, secondo cui le pene dell’aldilà
sono tutte nella nostra vita.
Al di là del contenuto specifico, emerge nuovamente il nodo centrale di tutta la critica
religiosa epicurea: i terribili tormenti cui porta la credenza superstiziosa trasmessa dal
mito, ben simboleggiati dalla descrizione degli Inferi.
Lezione n. 19: La religiosità epicurea
Per lungo tempo la tesi dello stoico Posidonio (II secolo a.C.) secondo cui Epicuro avrebbe
sostenuto l’esistenza degli dei per mera opportunità politica, evitando così di incorrere in una
accusa di empietà, è prevalsa, ma recentemente si è rivalutata l’autenticità della religiosità
epicurea nel suo nesso con il complesso della dottrina: la divinità è presentata come modello
perfetto e realizzato di felicità, cioè come saggio realizzato che ha raggiunto la atarassìa
(assenza di turbamento); da ciò deriva l’inattività della divinità stessa e dunque il suo mancato
coinvolgimento nelle vicende mondane, aspetti che la rendono oggetto di aspirazione da parte
dell’uomo, che non deve però farsi intimorire o inibire sino a diventarne schiavo.
Epicuro, quasi inaspettatamente, mantiene ferma l’idea dell’esistenza degli dei: da sempre il
legame tra fede negli dei e loro intervento nelle vicende mondane è inscindibile e il venir
meno di questa seconda condizione sembrerebbe coincidere con l’eliminazione degli dei
stessi. Epicuro, invece, ricorrendo alla propria gnoseologia, non arriva affatto a conclusioni
ateistiche:
L19-T1 La nozione degli dei
Solo Epicuro capì che anzitutto gli dei devono esserci proprio perché la natura stessa
ne ha impresso la nozione nell’anima degli uomini tutti. E quale stirpe e quale gente
umana vi è mai infatti che non abbia, anche senza la conoscenza vera e propria,
almeno la prenozione del divino? Quella prenozione che Epicuro chiama prolessi.
[Cicerone, De natura deorum,I 19,51]
Da Epicuro ci si attenderebbe, al limite, un accenno al divino come attributo di atomi
indistruttibili ed eterni, cioè una coincidenza, quale quella stabilita dai fisici più antichi, tra il
divino e l’arché (principio) di tutte le cose. Invece Epicuro parla di dei in senso pieno e
Cicerone si sofferma a mostrare le ragioni di questa posizione:
•
•
•
la conoscenza o almeno una qualche nozione del divino è presente in tutti i popoli;
ciò significa che la natura stessa ha impresso la nozione degli dei negli uomini;
questa conoscenza è esattamente una prenozione o prolessi e, come tale, è prodotta da
specifici simulacri che non possono che provenire dai rispettivi oggetti e che colpiscono i
sensi o l’intelletto.
Il concetto di divinità che poi da questa prenozione è derivato è quello che Epicuro non
condivide, ma mai si permetterebbe di affermare l’esistenza di simulacri privi di un oggetto
che li generi. E’ indubitabile la veridicità delle sensazioni, prodotte dal distaccarsi di sottili
pellicole di atomi (simulacra) dagli oggetti; l’errore nasce in sede di giudizio, quando
l’individuo pretende di affermare, in base alle proprie sensazioni, che le cose stanno realmente
così come egli le ha percepite.
L19-T2 L’intelligibilità degli dei
Nell’opera Sugli dei dice senza lasciar adito a dubbi che l’essere che possiede una
natura perfetta deve essere tutto percettibile con l’intelletto e non essere concepito
affatto come sensibile
[Filodemo, Sulla pietà, 34 US]
Il frammento riportato è una logica conseguenza di quanto affermato da Cicerone:
•
•
•
la certezza dell’esistenza della divinità deriva dalla presenza in ciascuno di una sua
immagine;
è indubbio tuttavia che gli oggetti corrispondenti ai simulacra degli dei percepiti non
cadono sotto i nostri sensi;
pertanto l’ente divino in sé considerato è percepibile esclusivamente con l’intelletto.
La distinzione di grado tra intelletto e sensi ha tuttavia significato solo se le due cose si
percepiscono come aventi natura diversa, laddove invece il sensismo epicureo impedisce di
pensarli in tal modo.
La certezza dell’esistenza degli dei è da Epicuro motivata altrove diversamente:
L19-T3 L’isonomìa
Grandissima è poi l’essenza dell’infinito e altamente degna della più grande e
diligente attenzione; e bisogna comprendere bene come tale sia la sua natura che tutte
le cose si corrispondono esattamente, le uguali alle uguali. Epicuro chiamava ciò
isonomìa, cioè retta distribuzione. Per tale ragione avviene che, quanta è la moltitudine
degli uomini, altrettanta deve essere, e non minore, quella degli dei immortali; e se le
sue forze dissolventi sono innumerevoli, infinite devono essere ugualmente quelle
preservanti.
[Cicerone, De natura deorum, I, 19, 50]
•
•
•
Epicuro riconosce nella realtà una legge di equilibrio o compensazione;
l’esistenza di tale corrispondenza richiede che la moltitudine degli uomini sia compensata
dall’esistenza di altrettante divinità;
pertanto, riconosciuta l’isonomìa come dato di fatto, essa richiede che gli dei esistano.
Un altro argomento utilizzato da Epicuro è quello cosiddetto ex gradibus:
L19-T4 Le nature eccelse
Egli (Epicuro) afferma infatti che vi sono gli dei, poiché è necessario che vi sia una
qualche natura eccelsa, della quale nulla sia migliore.
[Cicerone, De natura deorum, II, 17, 46]
Epicuro attribuisce ai suoi dei l’immortalità e la beatitudine e sa bene che tali caratteri sono
propri anche della divinità della tradizione, che tuttavia prosegue poi in una direzione errata
sovrapponendo a questo quadro il tema del coinvolgimento divino nel corso del mondo:
L19-T5 Dei e saggi
La vita della divinità (Epicuro) la chiama anche nell’opera Sulla santità la più dolce e
sommamente beata, e la reputa capace di guardarsi da tutto ciò che è impuro.
[Filodemo, Sulla pietà, 38 US]
Per Epicuro, nell’opera Sugli dei, l’essere che non ha per natura una costituzione
caduca è sinonimo della natura divina, e l’essere che non è di natura che sia soggetta a
dolore….
[Filodemo, Sulla pietà, 32 US]
Osservando i due testi, essi sono accomunati da un riferimento al dolore e a ciò che è impuro
quali elementi distanti dalla vita della divinità:
•
•
•
•
sono gli stessi la cui assenza dalla vita di un uomo testimonia la perfetta saggezza che
coincide con la felicità;
liberato da ogni preoccupazione per la limitazione dei desideri, il saggio ottiene in vita la
pace dell’anima (atarassia) e dunque la felicità; non sarebbe credibile sottrarre agli dei
il privilegio di questa vita beata, dal momento che essa è concessa persino a alcuni
miseri mortali;
ma la sostanza della felicità divina non può differire da quella della felicità umana e
pertanto deve coincidere proprio con l’atarassìa;
dunque l’atarassia degli dei è incompatibile con una qualunque preoccupazione per
l’universo.
Come l’interesse di Epicuro nei confronti della filosofia è impregnato di un afflato etico, così
anche la sua concezione di Dio: la divinità che emerge è l’ideale della sua etica oggettivato
e sostanzializzato, fatto persona. I suoi dei sono una proiezione del Giardino e del saggio
epicureo, ed è in tal senso che si fa comprensibile il rispetto a essi dovuto:
L19-T6 Rispetto degli dei
Che approvassero l’uso dei giuramenti e delle invocazioni agli dei è ridicolo
rammentarlo, essendone piene le loro opere; conviene piuttosto dire che (Epicuro)
raccomandava di osservare la fede data per mezzo dei giuramenti e di simili cose, e di
rispettare il (giuramento) chiaramente fatto nel nome di Zeus stesso, non con lo
scrivere “per…ma che dico? Come parlare santamente?” E a Colote consigliò di aver
rispetto dei giuramenti e di tutto ciò che riguarda gli dei.
[Filodemo, Sulla pietà, 142 US]
…ma anche scrivendo a Polieno che bisogna festeggiare le Antesterie e ricordarsi
degli dei, in quanto sono causa di molti beni.
[Filodemo, Sulla pietà, 157 US]
e di nuovo: “Quanto a noi”, dice, “sacrifichiamo agli dei santamente quando lo si
deve, e agiamo bene in tutto il resto secondo le leggi senza turbarci minimamente per
le vane opinioni riguardo agli esseri che sono i migliori e i più augusti. E inoltre
diciamo che questo è giusto per la causa che ho detto; così infatti è possibile che una
creatura mortale viva, per Zeus, come Zeus, come ben si vede.”
[Filodemo, Sulla pietà, 387 US]
apparirà chiaro che Epicuro ha osservato tutte le regole del culto e ha raccomandato
di osservarle anche ai suoi scolari, non solo per ossequio alle leggi, ma anche per
osservanza di principi naturali. Dice infatti nell’opera….che è conforme a saggezza il
pregare, non perché gli dei si adireranno se non lo faremo, ma per l’idea che noi
abbiamo delle loro nature superiori per potenza e prestanza.
[Filodemo, Sulla pietà, 13 US]
I brevi frammenti riportati, appartenenti perlopiù a lettere, si soffermano a riportare le
indicazioni di Epicuro circa l’atteggiamento da tenere verso gli dei nella vita quotidiana.
Epicuro, completamente affrancato dall’accusa di empietà, emerge come uomo pio che
invitava i discepoli e si impegnava di persona a rispettare i giuramenti e a giurare in nome di
Zeus, a celebrare le feste, a sacrificare alle divinità, a pregare, a osservare tutte le regole del
culto.
Sono tutte pratiche che presuppongono una qualche fede negli dei, dal momento che se si
giudica sufficiente la garanzia di Zeus per un giuramento, ciò significa che Zeus ha
un’autorità tale da poterlo far rispettare; lo stesso vale per le esortazioni ad altri tipi di
pratiche:
•
•
•
•
Epicuro non si muove in una logica meramente utilitaria, per evitare l’ira divina, o
estrinseca, cioè per sottrarsi a accuse di empietà;
afferma che bisogna agire così in nome dell’idea che si possiede della natura divina e
della sua potenza, in ossequio al rispetto dovuto a qualcosa che è più grande dell’uomo,
senza per questo farsi attanagliare dal timore di questa forza soverchiante;
l’uomo saggio che onora gli dei vive, libero dai timori che l’eventuale inadempienza al
culto gli causerebbe, come un dio in terra;
Epicuro osserva il rito per un sentimento sincero, non per obbedienza a una legge: se
i suoi dei senza turbamento non si occupano delle cose umane, d’altro canto, poiché essi
sono beati, lodarli e avvicinarsi ad essi è prender parte alla loro felicità, ammirarne la
natura e la condizione, sforzandosi di avvicinarsela, aspirando ad essa.
Il dogma dell’indifferenza divina non cancella la religione, ma la purifica da aspetti deteriori e
superstizioni: l’uomo veramente pio non si rivolge agli dei per placarli o ottenere qualche
grazia, ma per unirsi a essi per mezzo della contemplazione, rallegrarsi della loro gioia e
assaporare così anch’egli la loro beatitudine infinita.
Per citare un esempio clamoroso che invalida i luoghi comuni circa l’ateismo della dottrina
epicurea, Lucrezio inaugura il De rerum natura con un inno a Venere che esprime il
riconoscimento di una potenza divina sulla natura.
Gli dei sono numerosissimi, almeno quanto gli uomini, sono maschi e femmine, conversano
tra loro parlando una lingua simile al greco e trascorrono un’esistenza beata in compagnia, in
una sfera chiusa alle vicende del mondo e a ogni nascere e perire; ma essi mantengono anche
un tratto antropomorfico tipico della religiosità popolare:
L19-T7 Dei "atomici"
E tuttavia questa loro (degli dei) conformazione non è corpo, ma quasi corpo, non è
sangue, ma quasi sangue
[Cicerone, De natura deorum,I, 18, 49]
L’espressione quasi utilizzata da Cicerone è sintomatica di una difficoltà in cui Epicuro non
può non cadere quando tenti di precisare la natura dei suoi dei concordemente con la sua
fisica:
•
•
•
•
come ogni cosa gli dei devono essere costituiti da atomi,
ma ogni composto atomico è suscettibile di dissoluzione, mentre gli dei sono immortali;
Epicuro sostiene che tale indissolubilità si deve alla specificità del composto atomico
che costituisce gli dei, il quale è in grado di ricolmare ogni volta le perdite di materia;
ma come si spiega lo statuto privilegiato di questi composti? Ecco allora che Epicuro deve
ricorrere a un concetto di quasi corpo decisamente debole; questa figura sarebbe, inoltre,
simile a quella umana, dal momento che quest’ultima è la più bella di quelle presenti in
natura, il che si ricollega all’argomento ex gradibus utilizzato da Epicuro per dimostrare
l’esistenza degli dei.
Lezione n. 20: Il panteismo monistico degli stoici
Gli stoici, benché sia quasi impossibile ricostruire per essi un corpo dottrinale unitario, sono
in genere più rispettosi della tradizione religiosa, pertanto si mostrano più acquiescenti nei
confronti dei suoi contenuti, innanzitutto mitici:
L20-T1 L’allegoria
E che dovrei dire di quelle assurde storie dei greci intorno ai loro dei, degne solo di
vergogna, e che vengono spiegate allegoricamente, come fa ad esempio Crisippo di
Soli, quel filosofo che si ritiene aver ornato la Stoa di molti acuti scritti; egli spiega la
pittura di Samo nella quale Era è rappresentata mentre fa turpitudini con Zeus; e dice
nei suoi scritti, quell’acuto filosofo, che materia accogliendo le ragioni seminali della
divinità li riceve in sé ad ordinamento del tutto: nella pittura di Samo Era simboleggia
la materia e Zeus la divinità.
[Origene, Contra Celsum, IV, 48, I, p.321 Kotschau=SVF II, 1074]
Gli stoici, secondo la testimonianza di Origene, intendono spiegare allegoricamente i
racconti mitici relativi alle divinità: i miti sono sottoposti a revisione, come già nell’età della
polis, con l’intento di far combaciare le immagini poetiche e pittoriche di quella tradizione
con le nuove teorie fisiche e cosmologiche proposte dallo stoicismo. Crisippo agisce in questo
modo:
•
•
•
•
non è possibile attribuire agli dei atti vergognosi come il congiungimento di Era con Zeus;
se il mito racconta questi fatti bisogna però credervi, pena la messa in discussione di
tutto l’edificio religioso greco;
pertanto l’unico modo per giustificare una simile narrazione o raffigurazione è
intenderla come metafora, immagine resa chiara dal suo richiamarsi alla consuetudine,
di una verità più profonda, concettualmente difficile da esprimere;
compito del filosofo è sviscerare questo nucleo dottrinario: in tal caso l’immagine
veicola l’idea di un principio attivo che vivifica l’inerte materia; il principio attivo
coincide con ciò che dà la forma, il seme, il maschio, mentre la materia è grembo inattivo
ricettacolo del seme che la vivifica; Zeus simboleggia qualcos’altro e così Era.
E’ logico che siano gli aspetti più evidentemente antropomorfici del mito a generare
insoddisfazione e sospetto nei suoi fruitori più consapevoli, che pertanto si attivano per
mantenerne la validità, al prezzo però di perderne la veridicità letterale in favore di una
allegorica ancor più opinabile in quanto soggettiva e non garantita dalla divinità. Cicerone
sembra più consapevole di questi rischi: definisce infatti questa strategia ermeneutica come un
voler rendere ragione delle menzogne contenute nelle favole.
Anche per lo stoicismo, come per l’epicureismo, la nozione della divinità è inseparabile dalla
dottrina fisica. Punto di partenza è la nozione di corpo inteso come materia e forma (o
qualità) inscindibilmente unite, l’una come principio passivo, l’altra come principio attivo:
L20-T2 I due principi
Essi ritengono che i principi del tutto siano due, il principio attivo e quello passivo. Il
principio passivo è la sostanza senza qualità, la materia; il principio attivo è la ragione
che risiede in essa, la divinità. Questa, che è eterna, foggia tutte le cose con arte
scorrendo per la materia. Questa dottrina la espone Zenone di Cizio, nel Della
sostanza.
[Diogene Laerzio, Vitae philosoph., 7, 39= fr.I, 85 SVF]
Nell’esposizione di Diogene Laerzio si coglie:
•
•
•
•
il legame istituito tra principio attivo e divinità;
la equivalenza tra dio e ragione;
la capacità plasmatrice, artigianale, del dio nei confronti della materia;
la coesistenza di materia e divinità, lo scorrimento di questa in quella.
Rispetto alla divinità epicurea è facile riscontrare un’enorme differenza: la capacità
demiurgica, plasmatrice, della divinità implica una sua attività e il coinvolgimento nella
conformazione del mondo, aprendo la strada a un suo influsso nella vita umana.
La concezione di fondo della fisica stoica è materialistica e corporeistica, ma essa non prende
la forma del pluralismo atomistico epicureo, ma si configura come:
•
•
•
ilemorfismo: il corpo è sempre materia e forma unite l’una all’altra;
ilozoismo: c’è un’unica materia che porta in sé il principio della vita e della ragione;
monismo: i due principi sono logicamente distinguibili, ma quanto al loro essere sono
inseparabili;
E’ chiaro che se dio è in tutto in quanto presenza vivificante, esso assume diverse forme,
plasmando la materia, pur restando se stesso.
Il contenuto panteistico della fisica stoica non si limita tuttavia al riconoscimento della
presenza attiva della divinità nella materia; data l’inscindibilità di materia e forma (dio) al di
fuori delle quali null’altro esiste, dio non solo è in tutto, ma è tutto:
L20-T3 Panteismo e provvidenza
Essi affermano che la divinità non è altro che il cosmo in tutte le sue parti: e dicono
che questo è unico, limitato, vivente, eterno, divino. In esso sono racchiusi tutti i
corpi, entro di esso non vi è alcun vuoto.
(….) A quel modo che la città indica insieme l’abitazione di chi vi risiede con i
residenti in essa, così anche il cosmo, come una città, è composto di uomini e di dei,
gli dei avendo la direzione, gli uomini essendo a loro soggetti. Vi è comunanza fra gli
uni e gli altri in virtù della ragione di cui entrambi partecipano, secondo la legge della
natura; e tutte le altre cose sono generate in ordine ad essi. Conseguentemente a tutto
questo, si deve credere che la divinità che governa il tutto eserciti azione
provvidenziale nei riguardi degli uomini, essendo benefica, buona, amica del genere
umano, giusta, dotata di tutte le virtù. Per questa ragione il cosmo si dice anche Zeus,
dal momento che a noi è causa di vita (zén). E in quanto governa tutte le cose in
maniera assolutamente necessaria in base a una parola pronunciata dall’eternità, si
dice anche fato; e si dice Adrastea perché è impossibile sfuggirle (apodidràskein); e
provvidenza perché governa tutte le cose per il loro vantaggio.
[Ario Didimo, presso Eusebio, Praep. Evang., XV, 15 segg.= fr II, 528 SVF]
La testimonianza argomenta una tesi che si può riassumere nella coincidenza tra divinità e
cosmo:
•
•
Dio equivale al cosmo in tutte le sue parti e pertanto ne ha i caratteri: è unico, limitato
(compiuto), vivo, eterno e ha in sé la totalità dei corpi;
il rapporto tra gli uomini e gli dei è quello che sussiste in una città tra sudditi e governanti;
•
•
•
dei e uomini sono accomunati dal possesso della ragione, per questo sono cittadini della
medesima città, il cosmo;
data la potenza della divinità e il suo rapporto privilegiato con l’uomo le viene attribuita
un’azione di governo sul tutto e un’azione provvidenziale in particolare proprio nei
confronti dell’uomo;
data la provvidenza, la divinità, oltre possedere le caratteristiche del cosmo prima
elencate, è anche benefica, buona, virtuosa, giusta, amica dell’umanità.
All’interno del brano sono ancora da sottolineare i richiami a nomi divini ripresi dalla
mitologia tradizionale, sviscerati etimologicamente per farli coincidere con le nuove
concezioni stoiche:
•
•
Adrastea: necessità assoluta, cui non è possibile sfuggire;
Zeus, il cui nome è fatto derivare da zèn, vita, dal momento che la divinità è il principio
attivo che dà vita alla materia, ma accostato anche ad attributi quali la giustizia e la bontà.
Ancora una volta è facile riconoscere i tratti antiepicurei del dio stoico che, oltre ad essere
unico, intrattiene stretti rapporti con l’uomo, governa e è all’origine di tutto quanto accade,
movendo il cosmo in una direzione necessaria e buona.
Inoltre, anche Ario Didimo sottolinea la coincidenza tra dio e ragione (lògos): il dio è
principio di intelligenza, razionalità, spiritualità immanente alla materia.
La presenza di una concezione finalistica, opposta al meccanicismo e al casualismo epicurei, è
motivata dall’identificazione del dio-natura con la ragione: dal momento che tutto è dio e dio
è ragione, è facile concludere che tutto è razionale, cioè come deve essere, quindi perfetto.
L’imperfezione delle singole cose trova perfezione nel disegno del tutto. A tale posizione si
connette il discorso sulla provvidenza (prònoia) coincidente con il finalismo universale. Il
ragionamento è piuttosto semplice:
•
•
•
la divinità ha il potere di plasmare e trasformare tutto;
la materia è assolutamente duttile, è in potenza qualunque cosa;
è la provvidenza divina che la foggia in un determinato modo ed in virtù di questa matrice
divina ogni cosa non può che essere fatta come è meglio che sia.
La provvidenza non ha nulla di trascendente, essa coincide con l’ordine razionale del
cosmo, con il suo artefice immanente e, in quanto natura, essa non si occupa dei singoli
uomini, ma della totalità della specie. La provvidenza non è personale, così come non lo è la
divinità. Essa finisce per rivelarsi ineluttabile necessità, fato (heimarmène), inteso come
serie irreversibile delle cause, ordine naturale necessario di tutte le cose, indissolubile
intreccio che lega tutti gli esseri, come il lògos secondo cui tutto ciò che è avvenuto e avverrà
è avvenuto e avverrà.
Il saggio stoico, dinanzi a questa considerazione, deve mantenersi sereno e fiducioso: infatti
l’ordine del cosmo, anche se può apparire inspiegabile, ingiusto o manchevole ha il sigillo
della divinità che sola conosce il fine, necessariamente buono, in quanto divino, cui esso
tende. L’uomo ha solo una visione parziale che non gli consente di attingere alla conoscenza
del fine globale.
Il consenso espresso nei confronti della divinazione si motiva sulla base della dottrina della
provvidenza divina:
L20-T4 La divinazione
Infatti gli stoici non ritengono che gli dei siano responsabili in alcunchè del fegato e
dei canti degli uccelli; né ciò può essere conveniente, né in alcun modo degno degli
dei, ma ritengono invece che il mondo abbia avuto fin dall’inizio una tale struttura
che eventi stabiliti siano precorsi da segni stabiliti, manifestantesi alcuni nelle viscere,
altri negli uccelli, altri nelle folgori, altri nei prodigi, altri ancora negli astri o nelle
visioni dei sogni, o nelle parole degli invasati. Se essi vengono bene interpretati, è
difficile ingannarsi; e se sono mal congetturati e mal interpretati risultano falsi non
per colpa della realtà, ma per imperizia degli interpreti.
Una volta però dato e concesso che esiste una forza divina che regge la vita
dell’uomo, non è difficile arguire in virtù di quale logica avvengano le cose che
vediamo di fatto avvenire. Quella stessa intelligenza divina fa sì che gli uccelli volino
ora da una parte, ora dall’altra, o si nascondano ora da una parte, ora dall’altra, e che
gli uccelli augurali cantino ora da destra ora da sinistra. (…)
[Cicerone, De divinatione, I, 52-53 = SVF II, 1210]
Cicerone offre spunti interessanti:
•
•
•
•
non sussiste un collegamento diretto tra le divinità e i segni da cui si traggono le profezie;
è il mondo ad essere rigidamente strutturato secondo una catena per cui gli
avvenimenti sono prestabiliti e così i segni che li precedono;
le errate interpretazioni dei segni sono dovute a manchevolezze umane, non a una qualche
anomalia del reale;
in ultima analisi, in quanto sono gli dei a reggere il mondo e a ordinarne gli avvenimenti,
benché non direttamente responsabili di visceri di animali e voli di uccelli, se questi sono
e avvengono in un dato modo è perché tale direzione è impressa alle cose dallo spirito
divino.
Le affermazioni di Cicerone sono in linea con quella che è una convinzione diffusa tra gli
esponenti dello stoicismo: c’è la divinazione in quanto ci sono dei. L’unica garanzia è
dunque la fede negli dei stessi. Ecco perché Cicerone attribuisce una profezia che non si
verifichi a un errore umano: negare il valore della divinazione equivarrebbe a invalidare lo
stoicismo stesso e, più in generale, mettere in scacco ogni possibile fede in una divinità
razionale e onnipotente gettando l’uomo nello sconforto e nel caos non retti più da alcuna
potenza ordinatrice.
L’immagine più completa e al tempo stesso originale del dio stoico è presentata poeticamente
da Cleante:
L20-T5 Zeus
Glorioso tra gli immortali, dio dai molti nomi, sempre onnipotente,
Zeus fondatore della natura, che con la legge governi il tutto,
salve! E’ giusto che ti salutino tutti i mortali.
Da te nascono e hanno in sorte l’imitazione del dio,
soli tra tutto ciò che vive e si muove sopra la terra.
Perciò ti celebrerò e canterò sempre il tuo potere.
Tutto il cosmo che si volge attorno alla terra
Ti obbedisce dove tu lo guidi, e volentieri ti è sottomesso,
tale è lo strumento che tieni nelle tue mani invincibili,
il fulmine a due punte, infuocato, immortale:
sotto i suoi colpi si compiono tutte le opere della natura,
e con esso dirigi la ragione comune che attraversa il tutto,
mescolata alle grandi e alle piccole luci,
e per esso, nella tua grandezza, sei il re supremo in eterno.
Nessuna azione si compie senza di te sulla terra,
e neanche nella volta celeste o nel mare,
tranne ciò che compiono i malvagi nella loro follia.
Ma tu sai anche normalizzare l’anomalo,
ordinare il disordine, ti è gradito anche ciò che è sgradito.
A tal punto hai armonizzato in uno il bene e il male,
che di tutto si è formata una sola ragione, immortale:
la sfuggono tra i mortali quelli che sono malvagi;
sciagurati, smaniano sempre per il possesso dei beni,
non vedono e non ascoltano la legge universale del dio,
mentre obbedendole avrebbero con la ragione una buona esistenza;
senza ragione invece si precipitano chi in un male chi in un altro,
(…)
Zeus, dispensatore di tutti i doni, signore delle nere nubi e del nitido fulmine
Proteggi gli uomini dalla loro penosa inesperienza.
Disperdila dalla nostra anima, padre, concedi
Il giudizio grazie al quali governi con giustizia tutte le cose,
in modo che, onorati, ti rendiamo onore,
celebrando sempre le tue opere così come è giusto
che faccia un mortale:né mortali né dei hanno maggior compito
che celebrare sempre la legge comune insieme con la giustizia.
[Cleante Inno a Zeus]
Il dio stoico, nella misura in cui si identifica con la natura intera, non potrebbe essere
personale. Tuttavia tenderà ad assumere tratti spirituali e personali e la preghiera, esclusa
dalla fede in un lògos impersonale, troverà un proprio spazio. Cleante invoca Zeus,
coagulando in lui tutti i caratteri del dio stoico e manifestando così un acceso
monoteismo:
•
•
•
•
•
•
come già Eschilo, Cleante chiama in causa la molteplicità dei nomi con cui Zeus è
chiamato, sottolineandone l’equivalenza e l’irrilevanza, dal momento che le caratteristiche
che vengono attribuite alla divinità unica le conferiscono assoluta potenza: è possibile
convogliare in una sola tutte le numerose figure divine adorate dai Greci;
Zeus è l’onnipotente fondatore della natura: la sua potenza vivificante è anche all’origine
dell’esistenza dell’uomo che perciò è tenuto ad adorarlo;
Zeus è legge a cui tutto il cosmo obbedisce ordinatamente: il mondo è ingabbiato in una
rete necessaria ordinata da Zeus; in questa logica egli è anche garante e dispensatore di
giustizia;
numerosi sono i riferimenti all’equivalenza Zeus (dio)-ragione: Zeus dirige la ragione
comune che attraversa il tutto, il mondo è armonia tale che di tutto si è formata una sola
ragione;
Zeus non solo governa il cosmo, ma lo guida in una direzione determinata, verso un fine
prescritto e buono;
gli uomini che seguono la legge-ragione di Zeus hanno un’esistenza felice.
Appare chiaro, anche nella sottolineatura della natura dell’uomo a “immagine e somiglianza”
della divinità, il legame diretto tra dio e la vita umana, sotto forma di doveri verso la divinità,
ma, soprattutto, nell’esistenza del saggio che si comporta rispettando la legge di Zeus,
vivendo secondo la ragione che lo accomuna al dio e accettando il mondo così com’è, sicuro
che la provvidenza divina lo conduce al bene. In questo aspetto la connessione stoica tra
teologia e morale perviene ai medesimi esiti di quella epicurea, pur procedendo per una strada
decisamente diversa.
L’attributo del fulmine è tratto dall’iconografia tradizionale di Zeus, ma si innesta sul corpo
della dottrina stoica presentandosi quale ideale raffigurazione della coincidenza della
divinità con il fuoco o pnéuma (soffio infuocato):
L20-T6 Dio e fuoco
Poiché tutti gli elementi che costituiscono il mondo risultano sostenuti dal calore,
anche il mondo nel suo insieme deve la sua conservazione attraverso un così lungo
lasso di tempo allo stesso identico elemento; e questa conclusione è tanto più valida
in quanto si deve ammettere che codesto elemento, identificatesi con il calore e con il
fuoco, permea l’intera natura e assomma in sé la forza procreatrice e la causa della
generazione in virtù della quale tutti gli uomini e quegli esseri le cui radici sono
trattenute dalla terra sono soggetti alle leggi della nascita e della crescita.
[Cicerone, De natura deorum,II,9,28]
•
•
Il fuoco è il principio trasformatore per eccellenza, che penetra ovunque in quanto calore:
tutti gli elementi naturali che costituiscono il mondo implicano il calore;
il fuoco-pnéuma è l’espressione fisica del lògos ordinatore e in quanto tale vivifica e
permea tutto: Crisippo identificava con Zeus “padre” le ragioni seminali, i semi generatori
dell’universo laddove Era rappresentava la materia. Gli dei del mito realizzano
plasticamente, opportunamente interpretati, l’opera creatrice che la concettualità stoica
attribuisce all’azione congiunta dei due principi.
Apparentemente la concezione materialistico-panteistica degli stoici che identifica la divinità
in un principio attivo che scorre in tutta la materia sembrerebbe escludere il politeismo. Si è
visto tuttavia (L20-T1) come la mitologia politeistica, allegoricamente interpretata come
espressione poetica di una verità fisica, possa essere accolta dagli stoici. La posizione
politeistica e quella monoteistica non sono mai intese dai Greci come antitetiche:
L20-T7 Il politeismo
Gli stoici affermano che vi sono alcuni demoni che hanno affetti e sentimenti
comuni all’umanità e vigilano sul corso delle umane vicende. Credono anche negli
eroi che sono le anime superstiti degli uomini virtuosi.
[Diogene Laerzio, Vitae philos., VII, 51=SVF II, 1102]
•
•
•
Il pantheon stoico si arricchisce di figure intermedie: demoni e eroi, con tratti
antropomorfici;
altre testimonianze riconoscono dei molteplici identificati con gli astri, parti privilegiate
del cosmo concepite come viventi e intelligenti;
va notato che solo il Dio-lògos è veramente eterno, gli altri hanno lunga vita, ma nascono
e muoiono nel corso delle conflagrazioni cicliche in cui l’universo è divorato dal fuoco
per rinascere rinnovato.
Parte quinta: conclusioni
La forte impronta etica della filosofia ellenistica si traduce in una riflessione religiosa che
cerca di delineare la ricaduta della credenza nel divino e delle manifestazioni di devozione
sulla condizione di vita del singolo: scopo dichiarato di Epicuro nella trattazione della
religione è quella di liberare l’umanità dall’oppressione in cui l’ha costretta da sempre la
superstizione e tale è la giustificazione etica della ricerca scientifica delle cause dei
fenomeni. Ciò non esclude da parte del seguace dell’epicureismo:
•
•
la fede negli dei, motivata razionalmente, indubitabile alla luce della nozione del divino
impressa in tutti gli uomini, della legge di compensazione e della necessità di enti
supremi;
la pratica di atti di devozione come attività propria del saggio non tesa al fine
utilitaristico di procurarsi la benevolenza divina, ma come atto dovuto a un’entità più alta
dell’uomo.
Anche le caratteristiche della divinità epicurea che, accanto all’immortalità, sono soprattutto
beatitudine e autosufficienza, possiedono una giustificazione etica:
•
•
escludendo il coinvolgimento divino nelle vicende umane, allontanano i falsi timori
ingenerati dalle narrazioni di giudizi dopo la morte, ma anche ogni ingenuo
provvidenzialismo;
la divinità è il saggio pienamente realizzato.
Notevoli sono le differenze che separano la teologia epicurea dalla coeva formulazione stoica,
anche se comune è l’intreccio di fisica, etica e gnoseologia nell’impostazione del discorso
sul mito e sul divino.
Nella nozione, centrale per lo stoicismo, di corpo, si intersecano inscindibilmente un
elemento materiale passivo e uno divino-attivo che porta a considerare:
•
•
il cosmo come coincidente con il divino che lo vivifica e che in virtù questo è assimilato
al fuoco;
conseguentemente, il dio come plasmatore dell’universo e regolatore del suo divenire.
Da questa situazione discendono:
•
•
•
l’equivalenza di dio con il lògos, la ragione, in quanto ordine razionale che muove
l’universo;
l’ingabbiamento del cosmo in una rete provvidenziale che esclude ogni forma di
indeterminazione;
la bontà del fine cui questo ordine immutabile tende, dal momento che è garantito dal
dio.
Così come nell’epicureismo, dalla visione del cosmo che deriva dalla sua adesione alla
filosofia il saggio ricava serenità quale effetto della scoperta di un ordine divino che regola il
tutto e che non può che essere buono. L’uomo, inoltre, possiede una caratteristica
partecipazione al lògos che lo avvicina alla divinità:
•
si tratta chiaramente di un dio che tutto pervade, scevro di ogni aspetto personale e
antropomorfico;
•
•
la teologia stoica non esclude tuttavia forme di politeismo, benché il dio-lògos mantenga
sempre una priorità assoluta. L’accettazione della tradizione si manifesta
nell’interpretazione allegorica cui lo stoicismo sottopone il mito per riformularne i
contenuti in modo che siano accettabili razionalmente e compatibili con la fisica stoica;
in linea con il fatalismo cosmico, ricevono approvazione le pratiche divinatorie.
Ricerche
Gli scritti di Epicuro sono raccolti in Epicuro, Opere, a cura di G. Arrighetti, Einaudi, Torino,
1973, accompagnati da un’agile e utile introduzione del curatore. I frammenti degli stoici
sono raccolti in Stoici antichi, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, Torino, 1989.
Per una presentazione esauriente e accessibile delle filosofie ellenistiche, e in particolare di
stoicismo e epicureismo, si veda A.A. Long, La filosofia ellenistica, Il Mulino, Bologna,
1985. Altrettanto apprezzabili sono D.Pesce, Introduzione a Epicuro, Laterza, Roma- Bari,
1997 e M. Isnardi-Parente, Introduzione allo stoicismo ellenistico, Laterza, Roma-Bari, 1993.
Interamente dedicato al problema della religiosità epicurea e della sua contrapposizione alla
superstizione è il testo di A.J. Festugière, Epicuro e i suoi dei, Coliseum, Milano, 1987.
Su Lucrezio e gli aspetti religiosi della sua poesia si veda l’antologia del De rerum natura,
Vita e morte nell’universo, a cura di A. Barigazzi, Paravia, Torino, 1974 [introduzione
generale e introduzione ai passi riportati del I libro del poema lucreziano]. Approfondita,
anche se più complessa è la raccolta di F. Giancotti, Religio, natura, voluptas. Studi su
Lucrezio, Patron, Bologna, 1989.
Sulla problematica religiosa nello stoicismo, una fonte chiara è sicuramente M. Pohlenz, La
Stoa. Storia di un movimento spirituale, La Nuova Italia, Firenze, 1978: Parte Prima [La
fondazione della filosofia del lògos. Le personalità e la dottrina],capitolo La fisica: il lògos
come creatore del mondo.
Parte sesta: Razionalità e misticismo [lezioni 21- 23]
Lezione n. 21: nuovi aspetti della concezione del divino nella filosofia post-ellenistica
Anche dopo la conquista romana dell’Oriente le scuole filosofiche consolidatesi durante l’età
ellenistica (Accademica, Peripatetica, Epicurea, Stoica) conservano e estendono la propria
influenza; a riscuotere il maggiore interesse presso i Romani della fine della Repubblica sono
principalmente Stoicismo e Epicureismo.
Con l’inizio dell’età imperiale si assiste invece a una considerevole ripresa delle correnti
pitagorico-platoniche; dalla seconda metà del I sec. a.C., il platonismo inizia una lenta e
inarrestabile avanzata destinata a culminare nella sintesi neoplatonica del III sec. d.C. La
fisionomia che il rinnovato interesse per il platonismo assume dal I sec. d.C. è stata
denominata con il termine di medioplatonismo.
Per individuarne alcuni caratteri è utile affidarsi alla testimonianza di un fondamentale
interprete e divulgatore di questa corrente filosofica, Plutarco di Cheronea.
È riportato di seguito un passo del trattato Sulla E di Delfi: interrogandosi sul significato della
E del tempio di Delfi, Plutarco la interpreta come segno per “ Ei ” che significa “Tu sei”: oltre
a suggerire all’uomo il famoso “conosci te stesso”, il dio lo accoglie indicandogli anche la
risposta più opportuna con cui rivolgerglisi: “Tu sei”, ovvero “Tu sei l’essere”. Questa
interpretazione è interessante soprattutto per il percorso speculativo che a essa conduce, e che
vale la pena di seguire nei diversi passaggi:
L21- T1 Riscoperta della trascendenza
Si tratta, per contro, di un modo, anzi del modo più compiuto, in sé e per sé, di
rivolgersi al dio e di salutarlo: pronunziare questa sillaba significa già installarsi nella
intelligenza dell’essere divino. Mi spiego: il dio, quasi per accogliere ciascuno di noi
nell’atto di accostarci a questo luogo, ci rivolge quel suo ammonimento « Conosci te
stesso », che vale indubbiamente ben più del consueto « Salve ». E noi, in ricambio,
confessiamo al dio: « Tu sei – Ei », e così pronunziamo l’appellativo preciso, veridico,
e che solo si addice a lui solo. In verità, a noi uomini non compete, rigorosamente
parlando, l’essere. Tutta mortale, invero, è la natura, posta in mezzo com’è, tra il
nascere e il morire; ella offre solo un fantasma e un’apparenza, fievole e languida, di
sé. Per quanto tu fissi la mente a volerla cogliere, gli è come se stringessi con la mano
dell’acqua. Più la costringi e tenti di raccoglierla insieme, e più le stesse dita, che la
serrano tutt’intorno, la fan scorrere e perdere. Parimente, la ragione insegua pure, a
sua posta, la piena chiarezza di ogni cosa soggetta alle varie influenze e al
cambiamento: essa resta delusa, sia volgendosi al suo nascere, sia al suo perire poiché
non riuscirà mai a cogliere nulla di stabile, nulla che esista realmente. « Certo, non è
dato immergersi due volte nello stesso fiume », al dire di Eraclito, né è quindi dato
toccare, due volte, nella stessa situazione, una sostanza mortale. Al contrario, pronti e
rapidi mutamenti «la disperdono e di nuovo la radunano » o, meglio, non « di nuovo»
e non « più tardi », ma « a un tempo » ella si costituisce e vien meno, « entra ed esce ».
Ond’è che tale sostanza mortale non porta a termine verso la via dell’esistenza tutto
quanto in essa entra nel divenire, per il semplice fatto che proprio questo divenire
non conosce tregua o riposo, mai. Così, dal germe, essa, in una trasformazione
incessante, produce l’embrione e poi il poppante e poi il bimbo, in seguito,
l’adolescente, il giovane, e poi l’uomo, l’anziano, il vecchio, distruggendo via via i
precedenti stadi dello sviluppo e le varie età, per far posto a quelle che
sopraggiungono. Eppure noi – oh, che cosa ridevole! – non temiamo che una sola
morte, mentre, in realtà, abbiamo subito e subiremo infinite morti! Perché, non
solamente « la morte del fuoco - al dire di Eraclito – è nascita per l’aria, è la morte
dell’aria è nascita per l’acqua », ma la cosa è ben più chiara nel caso nostro: l’uomo
maturo muore, quando nasce il vecchio; e il giovane morì per dar luogo all’uomo
maturo; e così il fanciullo per il giovane; e il poppante per il fanciullo. L’uomo di ieri
è morto per l’uomo di oggi; e l’uomo di oggi muore per l’uomo di domani. Nessuno
persevera, nessuno è uno; ma noi diveniamo una moltitudine: intorno a non so quale
fantasma, intorno a un sustrato comune di argilla la materia circola e sguscia via. Del
resto, come mai, supponendo di perseverare in una identità, noi ci rallegriamo ora di
cose diverse da quelle che ci rallegravano prima? Come mai oggetti contrari suscitano
ora amore, ora odio, ora ammirazione, ora biasimo? Perché usiamo parole sempre
diverse e siamo soggetti a diverso sentire? Perché non sono mai uguali in noi né
l’aspetto, né la figura, né il pensiero? Senza cambiamento, certo, non si spiegano
questi stati ognora diversi; e chi cambia, quindi non è più lo stesso. Ma se uno non è
lo stesso non è semplicemente, ma diviene sempre nuovo e diverso dal diverso di
prima, proprio nel fatto che cambia. Sbagliano i nostri sensi, per ignoranza dell’essere
reale, a dar essere a ciò che appare soltanto. Ma allora che è l’essere reale? L’eterno.
Ciò che non nasce. Ciò che non muore. Ciò in cui neppure un attimo di tempo può
introdurre cambiamento. Qualcosa che si muove e che appare simultaneo con la
materia in movimento; qualcosa che scorre perpetuamente e irresistibilmente, come
un vaso di nascita e di morte: ecco il tempo! Persino le parole consuete, il « poi », il «
prima », il « sarà », l’ « accadde » sono la spontanea confessione del suo non-essere.
Infatti, è ingenuo e assurdo dire « è » di qualcosa che non è entrato ancora nell’essere,
o di qualcosa che ha già cessato di essere. Le nostre espressioni consuete, su cui
fondiamo per lo più la nostra nozione di tempo, cioè « esiste », « è presente » « adesso
», ci sfumano tutte, allorché il ragionamento le investe sempre più da presso. Il
presente, infatti, distanziato com’è necessariamente dal futuro e dal passato, si dilegua
come un lampo a coloro che vogliono coglierne il guizzo. Ma, se la natura misurata si
trova nella stessa relazione col tempo che la misura, nulla v’è in essa che sia stabile,
nulla che sia esistente; chè, anzi, tutto è soggetto alla vicenda della nascita e della
morte, sul comune ritmo del tempo. Ond’è che dire, dell’Essere vero, « Esso fu » «
Esso sarà » è quasi un sacrilegio. Tali determinazioni, invero, sono flessioni e
alterazioni di ciò che non nacque per durare nell’essere. Ma il dio (occorre dirlo?) « è
»; è, dico, non già secondo il ritmo del tempo, ma dell’eterno, ch’è senza moto, senza
tempo, senza vicenda; e non ammette né prima né dopo, né futuro né passato, né età
di vecchiezza o di giovinezza. No, Egli è uno e nell’unità del presente riempie il «
sempre »: ciò che in questo senso esiste realmente, quello « è » unicamente: non
avvenne, non sarà, non cominciò, non finirà.
[Plutarco, Sulla E di Delfi, 392 a-393b. Traduzione V. Cilento]
Dal testo emerge chiaramente una nuova concezione del divino, decisamente in contrasto con
quelle caratteristiche dell’età ellenistica e in particolare con quelle stoiche, che godevano della
maggiore popolarità. Plutarco vi perviene attraverso alcuni chiari passaggi, che marcano
progressivamente lo stacco:
•
•
•
al centro del discorso torna, con eco platonica e prima ancora parmenidea, l’essere e si
affaccia il problema: a chi compete l’essere ?
si evidenzia, sulla scorta delle stesse matrici di riferimento, la opposizione tra essere e
apparenza;
l’apparenza è immediatamente connotata attraverso il suo tratto distintivo, il divenire
opposto alla permanenza, evocato nella sua ricaduta in ambito gnoseologico (l’incapacità
della ragione di far presa su una materia sempre sfuggente, come suggerisce l’immagine
della mano che cerca invano di afferrare l’acqua) prima ancora che nel suo statuto
•
•
•
•
•
•
ontologico improntato all’instabilità e alla carenza (sottolineati con il riferimento al detto
eracliteo e al “non portare a termine verso la via dell’esistenza” ciò che in essa è
introdotto);
in conformità con una visione del divenire che lo interpreta come sospensione tra nascita
e morte (il riferimento primario è fin dalle prime battute l’uomo, al quale è negata
l’attribuzione dell’essere; la natura stessa è detta mortale) le sue manifestazioni più
significative sono colte nell’ambito dell’esperienza umana (non solamente «la morte del
fuoco - al dire di Eraclito – è nascita per l’aria, è la morte dell’aria è nascita per
l’acqua», ma la cosa è ben più chiara nel caso nostro):
• l’uomo vive in una trasformazione incessante che gli fa attraversare età successive,
morendo di volta in volta alle precedenti; una osservazione analoga, anche se
meno usuale (l’uomo di ieri è morto per l’uomo di oggi; e l’uomo di oggi muore
per l’uomo di domani) “accelera” il processo e rende ampiamente condivisibile la
sua lettura “filosofica”: nessuno persevera, nessuno è uno; noi diveniamo una
moltitudine;
• tipica dell’esperienza umana è anche l’incostanza dei giudizi, legata all’instabilità
delle designazioni linguistiche o al diverso sentire (oggetti analoghi suscitano
reazioni opposte e oggetti opposti analoghe reazioni); l’incoerenza non investe
l’uomo solo per quanto riguarda l’aspetto o la figura, allargandosi invece anche
all’ambito del pensiero: se ne conclude che nessuno è semplicemente, ma diviene
sempre nuovo e diverso;
l’uomo non può, per via del suo plurimo coinvolgimento nelle vicende del divenire,
attribuirsi l’essere;
si ripropone quindi l’interrogativo di partenza: allora che è l’essere reale?;
riproponendo la tecnica della descrizione ontologica di Parmenide, Plutarco lo caratterizza
innanzitutto negativamente, dichiarandolo estraneo all’avvicendamento temporale e
innanzitutto proprio al nascere e al morire;
l’essere reale ha i caratteri che sono stati negati alla natura mortale: se questa si
caratterizzava come disgregata nella molteplicità fino a polverizzarsi (è il caso dell’
“accelerazione” del processo di nascita e morte) e qualitativamente improntata alla più
imprevedibile eterogeneità, il vero essere è uno e semplice (è situato nell’unità del
presente e riempie l’eternità senza conoscere vicenda alcuna);
la dicotomia essere/apparenza, permanenza/mutamento si esprime dunque, nel momento
in cui non si tratti semplicemente di qualificare l’essere, ma di attribuirlo a dei referenti
specifici, nella coppia divino/mortali.
Lo spazio dedicato da Plutarco alla caratterizzazione del divino come “vero essere” e il fatto
stesso che si avverta la necessità di riguadagnare dimostrativamente questo punto sono già
indice di un contesto storico-culturale decisamente mutato rispetto all’età ellenistica:
riemerge, e con un ruolo prioritario, la componente propriamente metafisico-teologica
della filosofia.
Il medioplatonismo, pur nella diversità delle personalità che lo animano, presenta questo tratto
inconfondibile, che svolge nella direzione di un recupero della dimensione del
soprasensibile e dell’immateriale, ossia dei traguardi fondamentali della “seconda
navigazione” platonica.
Al panteismo stoico, implicante il coinvolgimento del divino nelle vicende del divenire
cosmico, Plutarco oppone una drastica affermazione di trascendenza del divino, la cui
denominazione come “essere” in senso forte (vicina all’Ego sum qui sum biblico, oltre che a
Platone e Parmenide) marca con forza l’alterità rispetto all’uomo e all’intera natura, tutta
mortale.
Per comprendere a fondo il pensiero filosofico e religioso di Plutarco occorre anche tenere
conto del contesto culturale e religioso nel quale matura e con il quale deve necessariamente
confrontarsi:
•
•
•
•
Plutarco non specifica come siano conciliabili l’idea del divino filosoficamente acquisita e
il politeismo della religione popolare greca; la accetta comunque come patrimonio sacro
tramandato da una trazione antichissima; anche rispetto alle divinità straniere segue
l’indirizzo comune greco, improntato al sincretismo;
quando si imbatte in tradizioni mitiche che attribuiscono agli dei comportamenti amorali o
le ignora o le reinterpreta servendosi dell’allegoria;
crede nell’immortalità dell’anima individuale, sulla scia di Platone, ma anche in quanto
iniziato ai misteri di Dioniso;
ha fede nella mantica, nelle sue forme più svariate; dedica parecchi scritti alla difesa e
all’interpretazione di questa arte e riveste personalmente un ruolo di primo piano in questo
ambito (è per almeno un ventennio sacerdote delfico).
Alla storia della religione e della problematica teologica in generale Plutarco dedica alcuni
testi particolarmente interessanti nell’ambito dell’antropologia culturale; vi sono contenute
numerose informazioni a proposito di oracoli e riti misterici: in generale questi scritti
esprimono la complessa spiritualità del tardo paganesimo e il suo intreccio con l’indagine
filosofica medioplatonica e il suo rinnovato impegno in campo metafisico-teologico.
L’atteggiamento di Plutarco dimostra come il medioplatonismo si configuri certamente come
ripensamento della metafisica (e della cosmologia) platonica, ma alla luce anche degli
apporti del misticismo orientale (nel caso di Plutarco in particolare della sapienza e della
religione egiziane) e delle dottrine demonologiche.
È proprio il forte accento posto sulla trascendenza del divino a giustificare l’ampio ricorso del
medioplatonismo ai demoni (esseri a metà fra divini e umani), per garantire l’interazione fra l’
“essere vero” e il mondo mortale degli uomini e della natura. La demonologia dunque non
risponde soltanto a un’esigenza religiosa; anche in ambito metafisico e ontologico si afferma
la necessità di concepire il soprasensibile e il divino in modo gerarchico:
•
•
•
•
sul piano propriamente mistico-religioso si prospetta una gerarchia che distingue un dio
supremo, alcune divinità secondarie a esso subordinate (alcune incorporee, altre, come gli
astri, visibili) e infine i demoni;
anche nell’ambito dei demoni si possono operare delle differenziazioni, per esempio fra
quelli che non hanno mai avuto commercio con i corpi e quelli che sono invece anime
liberate dal ciclo delle reincarnazioni, o fra quelli in cui è maggiormente presente
l’elemento misto (che fa sì che i demoni siano soggetti al divenire e anche alla morte) e
quelli in cui questo è meno presente (non è esclusa per i demoni la possibilità di diventare
dei secondari);
contemporaneamente, il pensiero filosofico-teologico si indirizza anche autonomamente
nella direzione di una concezione del soprasensibile come strutturato secondo successive
ipostasi: anzi, numerose sono le testimonianze medioplatoniche che anticipano, più o
meno direttamente, la scansione delle ipostasi proposta da Plotino (Uno, Noùs -Intellettoe Anima);
nel caso specifico di Plutarco basta porre accanto all’anima e all’intelletto (che il filosofo
di Cheronea si preoccupa di distinguere accuratamente, per rompere definitivamente con
l’immanentismo stoico)il dio supremo, che è anche l’essere e l’uno supremo (cfr. T1).
Lezione n. 22: Estasi e teurgia
Con la designazione di Corpus Hermeticum si indica un gruppo di scritti in gran parte
risalenti ai primi secoli dell’era cristiana e attribuiti a Ermete Trismegisto (figura di divinità
risultante dall’assimilazione del greco Hermes all’egizio Thoth, caratterizzata con l’attributo
di “tre volte grande” per sottolinearne il ruolo di mistico rivelatore e interprete di misteri). È
certamente difficile rintracciare i riferimenti comuni dei diciassette trattati del Corpus, il più
celebre dei quali è senz’altro il primo, intitolato Poimàndres.
Le dottrine fondamentali rivelano una significativa compresenza di elementi orfico-pitagorici,
platonici e mistico-orientali; teologia, cosmologia e antropologia sono funzionali alla
centralità dell’escatologia: l’iniziazione e la liberazione dal corpo conducono al
ricongiungimento con la divinità.
Il carattere eminentemente soteriologico dell’ermetismo determina l’urgenza di una precisa
definizione dei termini del rapporto uomo-divinità e della loro comunicazione. Ecco come si
configurano in un testo emblematico:
L22- T1 La visione del bene
Per la visione del bene non avviene come per il raggio del sole che, essendo
fiammeggiante, abbaglia gli occhi e li fa chiudere; al contrario tale vista tanto più
illumina, quanto più può accoglierla chi è capace di ricevere l’emanazione della luce
intelligibile. Essa è più acuta del raggio solare nel penetrare in noi, ma non danneggia
ed è totalmente piena di immortalità. Coloro che possono attingere un po’ di più a
questa visione quando sono caduti nel sonno e sono distaccati dal loro corpo,
giungono fino alla visione più bella di tutte […]. Quando tu non potrai più dire nulla
di lui; solo allora lo vedrai; poiché la conoscenza di Dio è divino silenzio e cessazione
di tutte le nostre sensazioni. Infatti chi ha compreso Dio, non può apprendere
nient’altro, chi lo ha contemplato, non può contemplare altro, né può udire parlare di
altro, e non può neppure muovere il proprio corpo, poiché privato di ogni
sensazione, di ogni movimento del corpo, rimane immobile. Questa bellezza divina,
dopo aver illuminato con la sua luce tutto l’intelletto, illumina anche tutta l’anima e,
traendola fuori del corpo verso di sé, muta l’uomo in essenza. È infatti impossibile
[…] che l’anima che ha contemplato la bellezza del bene sia innalzata fino a Dio
mentre si trova nel corpo. [Corpus Hermeticum, X, 4-6]
Nel testo:
•
•
•
si riscontra una forte sottolineatura della trascendenza divina e del conseguente dualismo
Dio-mondo, in continuità con le acquisizioni del medioplatonismo e anzi nella direzione
di una loro accentuazione;
sul piano antropologico, il dualismo si traduce nell’opposizione anima/corpo, presentata
secondo i canoni classici di matrice orfico-pitagorica prima ancora che platonica (è il caso
dell’interesse per l’incremento delle capacità cognitive nelle situazioni in cui l’anima è
maggiormente sciolta dai legami con il corpo: Coloro che possono attingere un po’ di più
a questa visione quando sono caduti nel sonno e sono distaccati dal loro corpo, giungono
fino alla visione più bella di tutte);
sempre per quanto riguarda l’antropologia, è possibile rintracciare almeno un chiaro
indizio della distinzione anima/intelletto, tipica dell’opposizione medioplatonica
all’immanentismo: la bellezza divina investe in primo luogo l’intelletto, poi estende la sua
azione sull’anima, che libera dai vincoli corporei;
•
•
•
il principio divino è descritto tramite caratterizzazioni in positivo, ma anche guadagnato
negativamente (privandolo cioè dei tratti tipici della realtà contingente e sottolineandone
così la alterità rispetto a essa) o attraverso il ricorso a immagini, principalmente legate al
campo semantico della luce, particolarmente adatta a significare il processo di diffusione
per emanazione;
il tentativo di avvicinamento al divino condotto per queste vie non intende comunque
scalfire la fondamentale ineffabilità del divino, inesprimibile nella sua inarrivabile
trascendenza: in ultima analisi la conoscenza di Dio è divino silenzio;
l’incolmabile distanza fra finito e assoluto può essere superata soltanto dall’unione
mistica, che si realizza nella singolare forma di una esperienza estatica che investe
innanzitutto l’intelletto, per poi attirare a sé l’anima, sciogliendola dal corpo, e mutare
l’uomo in essenza.
La soteriologia ermetica configura il processo di approssimazione al divino come liberazione
e distacco dalla corporeità; in continuità con la linea orfico-pitagorica e con l’accentuazione
medioplatonica del ruolo dell’intelletto, il cammino di purificazione si caratterizza
innanzitutto come cammino di conoscenza e primariamente di conoscenza di sé; è attraverso
questa che l’uomo si dirige verso Dio, come spiega il testo seguente:
L22- T2 Il divino nell’uomo
-Ma perché colui che ha conosciuto se stesso si dirige verso Dio, secondo il
discorso di Dio?
-Perché […] di luce e di vita è costituito il padre di tutti gli esseri, dal quale
nacque l’uomo.
-[…] Luce e vita, questo è il Dio e padre, dal quale fu generato l’uomo. Se dunque
tu riconosci lui nella sua vera natura, cioè costituito di luce e di vita, e comprendi
che tu derivi da tali elementi, tu ritornerai alla vita.
[Corpus Hermeticum, I, 21]
Riconoscersi luce e vita significa dunque riconoscersi parte della divinità, trovare il divino
che è nell’uomo per seguirne le tracce, fino al ricongiungimento estatico con la sua origine.
Il ruolo giocato dall’intelletto in questo contesto è certamente decisivo:
•
•
•
•
l’intelletto è il mezzo fondamentale per intraprendere l’itinerario di purificazione, dal
momento che questo prende le mosse da un atto conoscitivo con il quale l’uomo investe se
stesso;
mentre guida l’uomo alla scoperta dei suoi caratteri inconfondibili, l’intelletto si ritrova
annoverato fra questi: oltre che l’affermazione della comunanza dio-uomo nell’essere
entrambi costituiti di luce e vita, nel Corpus Hermeticum si trova l’affermazione per cui
dove c’è anima, vi è anche intelletto, come dove c’è vita, c’è anche anima;
è chiaro quindi che il riferimento alla vita implica quello all’intelletto, come del resto
conferma l’immagine della luce, tipicamente deputata a rappresentare la luce intelligibile;
aggancio fondamentale dell’essere umano con la trascendenza, l’intelletto non può che
essere il protagonista dell’unione estatica (cfr. T1).
La dottrina ermetica dell’intelletto è in realtà molto complessa e di difficile interpretazione:
spesso ad esempio è considerato uno strumento in possesso soltanto di coloro che onorano il
dio; probabilmente con ciò si vuole alludere al fatto che l’intelletto, pur essendo
potenzialmente a disposizione di tutti gli uomini, è coltivato soltanto da pochi e alla
convinzione per cui sul perfezionamento delle capacità di penetrazione conoscitiva incide
positivamente o negativamente anche una migliore o peggiore condotta morale.
A conferma della posizione di primo piano occupata dalla figura dell’intelletto anche in forme
di avvicinamento al divino in cui forte, oltre all’elemento propriamente speculativo, è la
tensione mistico-religiosa, è opportuno prendere in considerazione una fonte che presenta
molte analogie con il Corpus Hermeticum, quella rappresentata dagli Oracoli caldaici.
Il titolo fa riferimento all’antica sapienza mesopotamica (come l’ermetismo si collegava a
quella egizia) e introduce un’opera scritta in esametri e pervenuta attraverso numerosi
frammenti conservati nelle opere dei tardi neoplatonici; vi si riscontra l’intento di comunicare
un messaggio rivelato, in cui si intrecciano filosofemi di marca medioplatonica o
neopitagorica e narrazioni mitologiche o addirittura fantastiche.
Anche in questo contesto non manca il riferimento al dio supremo come Intelligibile e
all’intelletto come mezzo di elevazione alla sua trascendenza:
L22- T3 Il ruolo dell’intelletto
Esiste un certo Intelligibile che devi concepire col fiore dell’intelletto; poiché se dirigi
verso di lui il tuo intelletto e cerchi di concepirlo come se concepissi un oggetto
determinato, tu non lo concepirai; poiché egli è la forza di una spada luminosa che
brilla di tagli intellettivi. Non bisogna dunque concepire questo Intelligibile con
veemenza, ma grazie alla fiamma sottile di un sottile intelletto, che misura ogni cosa
eccetto questo Intelligibile; e non bisogna concepirlo con intensità, ma, portandovi il
puro sguardo della tua anima distolta <dal sensibile>, tendere verso l’Intelligibile un
intelletto vuoto <di pensiero>, per imparare a conoscere l’Intelligibile, dal momento
che sussiste fuori <delle apprensioni> dell’intelletto <umano>.
[des Places, Oracles Chaldaïques, fr.1, p.66]
Secondo gli Oracoli:
•
•
•
non è possibile raggiungere il divino con i metodi consueti della filosofia, miranti ad
accertarne la natura (se dirigi verso di lui il tuo intelletto e cerchi di concepirlo come se
concepissi un oggetto determinato, tu non lo concepirai );
confrontandosi con un oggetto del tutto eminente, l’intelletto deve riconoscere che misura
ogni cosa eccetto questo Intelligibile, il quale sussiste fuori <delle apprensioni>
dell’intelletto <umano>;
dunque per imparare a conoscere l’Intelligibile occorre tendere verso di esso un
intelletto vuoto e distolto da ogni contenuto sensibile.
Quello che è designato come fiore dell’intelletto è dunque una facoltà che dell’intelletto
comunemente e filosoficamente considerato esclude tanto la metodologia quanto i contenuti,
configurandosi piuttosto come qualità soprarazionale di unione mistica, in cui la mente
umana, sciolta dal corpo, si svuota ulteriormente dei suoi contenuti razionali, in un “fare il
vuoto” che è funzionale al “riempimento” da parte del divino e all’assimilazione a esso.
L’insufficienza del veicolo puramente razionale è ulteriormente rimarcata, nel caso della
sapienza caldaica, dalla chiara sottolineatura che neppure il fiore dell’intelletto, ossia
l’intelletto svuotato e aperto all’illuminazione divina, è un mezzo sufficiente per il
conseguimento dell’unione con il divino: è indispensabile l’apporto della ritualità e della
teurgia, ossia di quella particolare arte magica che mira a evocare gli dei e ad agire su di essi,
assicurando una mediazione fra il dio supremo e l’uomo e così rispondendo insieme
all’urgenza dell’ansia di salvezza e alla necessità di tenere ferma l’inadeguabile trascendenza
della divinità.
Sottolineare l’importanza della componente magico-rituale nella sapienza caldaica e, più in
generale, nelle forme di concezione del divino caratteristiche del tardo paganesimo è
fondamentale per comprendere le diverse tendenze e scuole che si sviluppano nell’ambito del
neoplatonismo, e che si differenziano soprattutto in relazione al maggiore o minore peso
attribuito alla speculazione razionale e alla pratica teurgica nel processo di avvicinamento e
assimilazione con il vero essere del dio supremo.
Lezione n. 23: La sintesi di Plotino
La sintesi filosofica di Plotino, che è stata definita “il più astratto sistema speculativo
concepito dal pensiero occidentale” pone al centro della riflessione il problema dell’essere e
muove da un rigoroso monismo, che richiama quello parmenideo: tutto è riconducibile
all’Uno, che trascende essere e pensiero e si identifica con la divinità.
La ricerca ontologico-metafisica di Plotino si pone sulla linea della speculazione classica
platonica e aristotelica; è possibile rintracciare anche interessanti contributi attinti dalla
tradizione arcaica (Parmenide, Eraclito, religione tradizionale olimpica e ellenistica), mentre
decisa è l’opposizione nei confronti delle correnti irrazionalistiche di provenienza orientale.
Ciononostante, la stessa speculazione plotiniana risente del confronto con queste matrici
culturali mistico-orientaleggianti:
•
•
•
sia pure con le dovute riserve, anche nel discorso di Plotino si può identificare una
componente non trascurabile di misticismo;
la battaglia condotta contro le correnti gnostiche e la loro tendenza a moltiplicare gli
intermediari fra l’uomo e il divino non esclude che lo stesso neoplatonismo assuma per
certi aspetti i caratteri di una forma di gnosi salvifica;
il lessico profetico e oracolare influisce sul carattere del linguaggio plotiniano, spesso
immaginifico, analogico, altamente simbolico, la cui arditezza supera di gran lunga la
“poesia filosofica” di Platone e il suo impiego del mỳthos in campo speculativo.
Anche prendendo in considerazione i punti-cardine della dottrina neoplatonica nella versione
proposta dal suo principale interprete, si rintracciano con facilità temi sviluppati, oltre che
nell’ambito propriamente speculativo dal medioplatonismo, anche nel quadro di forme di
sapienza mistico-religiosa quali quelle attestate dal Corpus Hermeticum e dagli Oracoli
Caldaici. Secondo Plotino:
•
•
•
•
•
c’è un netto dualismo fra mondo sensibile e mondo intelligibile, del quale si sottolinea la
trascendenza;
il mondo soprasensibile è strutturato gerarchicamente, secondo tre ipostasi: Uno, Noùs e
Anima;
dalla prima ipostasi deriva la seconda e dalla seconda la terza, senza che il grado
superiore, fluendo fuori di sé, si disperda e subisca una diminuzione, un impoverimento:
l’emanazione si precisa, proprio per questa caratteristica, come processione;
il mondo sensibile e la materia che lo costituisce derivano dalla processione della sostanza
intelligibile: il sensibile è nel soprasensibile, il corpo nell’anima, la materia nello spirito,
fino ai limiti dell’acosmismo (cioè della evanescenza del mondo naturale);
dal momento che tutto deriva dall’Uno, è possibile che ritornare in esso: l’itinerario di
unificazione con il divino richiede innanzitutto di abbandonare le suggestioni del mondo
sensibile per rientrare in sé e identificarsi con l’anima, quindi di riconoscere la
derivazione dell’anima dallo Spirito e dello Spirito dall’Uno, fino all’unione estatica con
esso.
Pressoché tutti questi punti essenziali, fatta eccezione per la specifica dottrina della
processione delle ipostasi, trovano anticipazioni significative o addirittura puntuali nella
tradizione filosofica ma anche sapienziale e mistica dell’età tardo antica.
I riferimenti-chiave per Plotino sono dunque certamente quelli della filosofia classica, nel cui
solco intende inserirsi, e della filosofia ellenistica, intesa come referente prevalentemente,
seppure non esclusivamente, polemico, ma anche quelli del contesto culturale e religioso
contemporaneo.
Un esempio significativo di questa duplice presenza si riscontra prendendo in considerazione i
passi plotiniani riguardanti il cammino dell’anima che si indirizza verso l’Uno, il divino.
L23- T1 La vera purificazione
Che vale allora la pretesa di rendere impassibile l’anima per virtù di filosofia,
quand’ella sia radicalmente immune da ogni affezione? Ecco: poiché quella specie
di parvenza, penetrando in essa e precisamente nella sua parte affettiva provoca
l’affezione conseguente, vale a dire, l’irrequietezza; poiché, inoltre, s’unisce alla
irrequietezza l’immagine del male atteso, così una siffatta parvenza assunse il
nome di passione e sorse allora l’esigenza filosofica di eliminarla del tutto e di
non lasciarla allignare. Fin tanto che questa ci sia – si pensa – l’anima non sarebbe
perfettamente sana; ma, dopo la sua scomparsa, l’anima si comporterebbe
impassibilmente, giacché la causa stessa della passione, vale a dire quella
parvenza che l’assedia, si è ormai bell’e dileguata: gli è come se uno, per estirpare
i fantasmi dei sogni, costringesse a vegliare l’anima allora che volga verso il suo
fantasticare; oppure come se uno ritenga che le immagini sorgenti, per così dire,
dal di fuori, abbian causato le passioni e le consideri stati passivi dell’anima. Che
senso ha intanto la «purificazione dell’anima» la quale non è stata giammai
contaminata; che senso ha l’espressione «distaccarla dal corpo»? Ecco,
«purificazione» si è lasciarla sola, senza che abbia contatti con cose estranee,
senza che miri fuori di sé, senza che mutui opinioni altrui – quale che sia il modo
delle opinioni -; «purificazione» importa sia il non vedere le immagini delle
passioni, come s’è detto, sia il non ricavare passioni da quella fonte. Ma l’anima
volta sull’altra via – in alto – dalla bassura non è forse purificazione e, aggiungi
pure, «separazione» almeno per quell’anima che non sta più nel corpo come se gli
appartenga e non somiglia ella forse a «luce che non è nel fango»?
[Plotino, Enneadi, III, 6, 5. Traduzione di V.Cilento]
Il testo consente di inquadrare la posizione di Plotino circa la purificazione dell’anima rispetto
alle precedenti trattazioni dell’argomento; l’ambito cui attingere per il confronto è,
dichiaratamente, quello delle trattazioni filosofiche:
•
•
l’insistenza sulla tematica e sulla terminologia della impassibilità richiama l’ideale stoico
dell’apatia;
il tema della purificazione dell’anima attraverso il distacco dal corpo e del raccogliersi
dell’anima in se stessa sono trattati con accenti che esplicitamente richiamano il modello
platonico, in particolare il Fedone, il Teeteto, l’ Alcibiade I.
Plotino riconosce come questi precedenti storici vadano nella medesima direzione della sua
concezione del cammino di ritorno dell’anima all’Uno e ne valuta il contributo:
•
•
•
lo stoicismo è certamente apprezzato in quanto propone un itinerario catartico, ma risente
del difetto caratteristico delle filosofie ellenistiche, consistente nell’affermazione del
primato della prassi;
il neoplatonismo plotiniano viceversa sottolinea la evanescenza della prassi rispetto alla
teoria, della quale rappresenta una estenuazione, dotata di un grado inferiore di realtà;
risentendo dell’influenza di Platone e soprattutto di Aristotele, con le sue decise
affermazioni sul primato della vita teoretica, Plotino oppone all’azione, sempre
condizionata da un oggetto esterno di riferimento, l’intelligenza con la sua autosufficienza
e il suo “stare in sé” (nel testo in esame è significativo lo stacco qualitativo fra
l’estenuante, per quanto fondamentale, esercizio della veglia finalizzato a estirpare i
fantasmi dei sogni e il volgersi sull’altra via –in alto -);
Complesso è anche il rapporto con Platone:
•
•
•
•
•
•
•
il Fedone platonico è direttamente richiamato dalla descrizione della purificazione
dell’anima come lasciarla sola, senza che abbia contatti con cose estranee, senza che miri
fuori di sé ;
alla base di questo itinerario catartico c’è la tesi dell’Alcibiade I dell’identificazione
dell’uomo con la sua anima, un’anima che si serve di un corpo: anche per Plotino il vero
uomo è l’anima, che si estende e si prolunga nella corporeità come nella sua immagine;
la purificazione non può avere come obiettivo che la separazione, ovvero la condizione
di quell’anima che non sta più nel corpo come se gli appartenga: il richiamo è in questo
caso al Teeteto e alla descrizione della “fuga dal male” come fuga dal mondo della
corporeità;
per Plotino l’anima deve rendere evidente la sua alterità rispetto al mondo sensibile e
stabilire il suo primato: la coppia metaforica luce/fango esprime in maniera emblematica
la superiorità assoluta della componente spirituale, proposta anche descrivendo la
funzione strumentale del corpo rispetto all’anima: il saggio si serve del suo corpo come di
uno strumento, ma può smettere di servirsi del proprio corpo come interromperebbe il
suono della lira, per passare al canto senza accompagnamento;
anche rispetto al modello platonico è però possibile riscontrare, se non modifiche
sostanziali, almeno sottolineature diverse:
non è trascurabile il fatto che in Plotino non si colga il duplice movimento ascendentediscendente tipico della dialettica platonica: mentre Platone evidenzia l’importanza, dopo
l’elevazione al primo principio anipotetico, di ritornare sui propri passi , illuminando lo
stesso cammino di una nuova luce, Plotino insiste su una ascesa irreversibile il cui
culmine coincide con la perfetta assimilazione all’Uno e l’estraneità rispetto a tutto il
resto;
in generale, in Plotino è più marcata la spinta trascendentistica, la cui intensità si spiega
solo tenendo conto del contesto storico-culturale tardo antico e della inquietudine religiosa
che lo percorre.
Fuggiamocene nella nostra patria
E.R. Dodds, indagando l’universo spirituale della tarda antichità (Pagani e cristiani in
un’epoca di angoscia, La Nuova Italia, 1970), pone l’accento sull’ansia soteriologia che lo
percorre: il mondo del terzo secolo è impoverito sul piano intellettuale, insicuro su quello
materiale, carico di paura e di odio; si affaccia dunque prepotentemente il bisogno di una via
di fuga, che può essere icasticamente sintetizzato con le parole pronunciate da Agamennone,
nell’Iliade omerica: “Fuggiamocene nella nostra patria” (Iliade 140).
Si tratta in effetti di una frase ripresa, con un nuovo significato, da Plotino (ma la ripresa dello
stesso passo dell’Iliade si trova anche in Gregorio di Nissa e nel De Civitate Dei di Agostino):
per quanto la citazione sia dall’Iliade, Plotino prosegue facendo riferimento all’Odissea e in
particolare alla fuga di Odisseo da Circe e da Calipso come allontanamento che permette di
sfuggire alle lusinghe della bellezza sensuale. Il ritorno in patria è dunque il ritorno
dell’anima in se stessa, la sua emancipazione dal mondo della corporeità e dell’esteriorità. Il
delirante spettacolo delle vicende storiche non è dunque la vera realtà: è il luogo dell’azione,
ma l’azione non è che l’ombra della contemplazione; il senso di disorientamento può essere
vinto trasformando la continua peregrinazione fra le vicende del mondo rispetto alle quali
l’anima è straniera in un viaggio di ritorno verso la patria interiore.
Il testo che segue descrive più dettagliatamente in che cosa consista per l’anima volgersi
sull’altra via –in alto -:
L23- T2 Immergersi nella contemplazione
Ma se, per il fatto che Egli non è niente di tutto questo, tu cadi
nell’indeterminatezza con il tuo pensiero, fissati tuttavia lì e da quella
prospettiva comincia a contemplare. Contempla, però, senza scagliare al di fuori
il tuo pensiero. Poiché Egli non se ne sta in un punto qualunque, lasciando ogni
altro luogo deserto di sé, ma a chi riesce a toccarlo Egli è lì presente, e a chi non
riesce non è presente. Pure, come nel resto non è dato pensare qualche cosa a chi
ne pensa qualche altra e ad essa si applica, ma non deve costui connettere nulla a
ciò che va pensando perché possa proprio trasformarsi nell’oggetto pensato, così
pure occorre procedere anche in questo campo poiché non è dato, a chi abbia già
nell’anima l’impronta di un’altra cosa, pensare quell’Uno finchè tale impronta è
ancora lì operante; anche perché l’anima tutta presa e dominata da altri oggetti
non si presta più ad essere impressionata dall’impronta dell’oggetto contrario;
per contro, come è stato detto a proposito della materia, che cioè questa vuol
essere spoglia di ogni qualità, se intende accogliere le impronte di tutte le cose,
così, anzi in un grado ben più alto, l’anima deve restarsene nuda di forme, se
intende davvero che nulla si insedii lì a far da impaccio alla piena inondante ed
alla folgorazione che si riversa su lei da parte della Natura primordiale. Se è
così, essa deve staccarsi da tutte le cose esteriori, volgersi verso la sua intimità,
completamente, non inclinarsi più verso qualcosa di esterno, ma estinguendo
ogni conoscenza (e, precisamente, dapprima solo attraverso l’intima
disposizione, poi, di fatto, anche nella stessa nostra configurazione mentale),
spegnendo altresì la conoscenza del proprio essere, l’uomo deve immergersi
nella contemplazione di Lui.
[Plotino, Enneadi, VI, 9, 7. traduzione di V. Cilento]
Alcuni aspetti dell’esperienza
dell’itinerario di purificazione:
•
•
contemplativa
ribadiscono
i
caratteri
fondamentali
necessità, da parte dell’anima, di staccarsi da tutte le cose esteriori, volgersi verso la sua
intimità, completamente, non inclinarsi più verso qualcosa di esterno;
contemplazione intesa come concentrazione del pensiero su se stesso (senza scagliare
al di fuori il tuo pensiero) e in quanto tale, in quanto “per sé” e non “per altro”, superiore
all’azione, sempre indirizzata verso un oggetto esterno a sé.
L’aspetto centrale del testo riguarda però il ruolo del pensiero, dell’intelligenza, nella
contemplazione:
•
•
la contemplazione incomincia quando il pensiero, considerando l’alterità dell’Uno-divino
rispetto a qualsiasi altro oggetto e tuttavia proponendosi di fissarsi su di esso, cade
nell’indeterminatezza;
proprio questa indeterminatezza rappresenta la condizione ineliminabile per raggiungere
con il pensiero l’Uno: come la materia deve essere spoglia di ogni qualità, per accogliere
le impronte di tutte le cose, così, anzi in un grado ben più alto, l’anima deve restare nuda
•
•
di forme, e non può applicarsi a nessun altro oggetto per potersi trasformare nell’oggetto
pensato;
occorre quindi estinguere ogni conoscenza: quanto Plotino vuole significare specificando:
dapprima solo attraverso l’intima disposizione, poi, di fatto, anche nella stessa nostra
configurazione mentale è chiarito nel trattato precedente (VIII) della sesta enneade e
consiste in quella che Dodds chiama disciplina della negazione: si tratta di cancellare
innanzitutto il mondo corporeo, poi i riferimenti spazio-temporali, infine l’intreccio
interno delle relazioni;
l’ultima consapevolezza a scomparire è la conoscenza del proprio essere: viene così
rimosso l’ultimo ostacolo per la piena inondante e la folgorazione, che rappresentano il
vertice dell’esperienza contemplativa: lo svuotamento è dunque funzionale a accogliere la
piena, lo spegnimento di ogni conoscenza alla folgorazione.
L’oltrepassamento del pensiero, necessario per l’anima che voglia immergersi nella
contemplazione dell’Uno, si lega strettamente al fatto che tale contemplazione sfoci
nell’assimilazione all’Uno. Infatti:
•
•
•
l’Uno non è pensiero: non gli si può attribuire (il riferimento polemico è Aristotele)
nemmeno il pensiero di sé, perché non è il pensiero a dare valore all’Uno, ma viceversa;
inoltre, distinguere l’uno che pensa dalla sua essenza che sarebbe invece oggetto del
pensiero, equivale a contraddire la semplicità dell’Uno; Platone afferma invece
giustamente che l’Uno è “al di sopra dell’Intelligenza” (Enneadi, VI, 7, 37);
è veramente “santo” solo ciò che trascende il pensiero: anche a sostegno di questa tesi
Plotino richiama Platone (Enneadi, VI,7, 39);
avvicinandosi e assimilandosi all’Uno e alla sua sacralità, l’anima deve dunque
gradualmente abbandonare l’abito del pensiero.
Il testo che segue presenta un duplice interesse: mette a fuoco più approfonditamente la
gradualità dell’abbandono dell’attitudine intellettuale e la sua finalizzazione non alla cieca
irrazionalità, ma all’assimilazione alla stessa Intelligenza e quindi a ciò che è sopra di essa;
inoltre, permette di seguire la costruzione di un’immagine particolarmente significativa in
Plotino, quella dell’itinerario all’interno del tempio (qui soltanto accennata attraverso la
correzione dell’immagine del palazzo sostituendo al padrone di casa un dio).
L23- T3 Oltre il pensiero
A questo punto l’anima viene a trovarsi in condizione da disprezzare anche il
pensiero che in altri tempi le era così caro (il pensiero infatti è un movimento,
però essa ora non vuole più muoversi). Essa non parla affatto di colui che vede,
ma contempla, poiché essa stessa è diventata Intelligenza e si è come
spiritualizzata ed è entrata nello spazio intelligibile; e, appena entrata in esso e
possedendolo, essa pensa l’intelligibile, ma dopo averlo visto abbandona ogni
cosa, simile a chi, essendo entrato in un ricco e nobile palazzo, va contemplando
all’interno ad una ad una quelle cose belle prima di vedere il padrone di casa; ma,
una volta che lo abbia visto e ammirato, non alla stregua di una statua, ma di una
cosa degna veramente di esser vista, lascia da parte tutte le altre cose e guarda lui
solo; e poi, guardando e non staccando mai lo sguardo, a forza di guardare non
vede più l’oggetto della sua visione, ma mescola la sua visione col suo oggetto,
cosicché quello che prima era per lui oggetto di visione diventa ormai visione e
così dimentica tutti gli spettacoli. Forse il nostro esempio conserverebbe meglio
l’analogia se non fosse un uomo quello che attende il visitatore della casa, ma un
dio che non apparisse agli occhi del corpo, ma riempisse l’anima del
contemplante.
[Enneadi, VI, 7, 35, 1-20. Traduzione di V. Cilento]
La tangenza con l’Uno, oltre che come piena inondante e come folgorazione (per questa
designazione il riferimento è ancora a Platone, al Simposio e all’immagine della scintilla nella
VII Lettera), si caratterizza come estasi. Affrontando questo argomento Plotino propone il suo
itinerario di avvicinamento al sacro (delineato con l’immagine dell’ingresso nel tempio e nei
suoi luoghi più riposti): è in questo contesto che si colgono le maggiori assonanze con le
forme della religiosità contemporanea, ma si evidenzia anche lo scarto ineliminabile che
caratterizza l’originalità del discorso plotiniano.
L23- T4 L’estasi
Ora, poiché non erano due, ma egli stesso, il veggente, era una cosa sola con
l’oggetto visto (non «visto» sicché, ma «unito»), chi divenne tale, allora, quando si
fuse con Lui, ove mai riuscisse a ricordare, possederebbe presso di sé una immagine
di Lui. Egli però era già uno di per sé, in quel momento, e non serbava in sé nessuna
differenziazione né in confronto a se stesso né in rapporto alle altre cose; poiché non
c’era in lui alcun movimento: non animosità, non brama di nulla erano in Lui, asceso
a quell’altezza; ma non c’era nemmeno ragione né pensiero alcuno; non c’era
neppure lui stesso, insomma, se è proprio inevitabile dire questa enormità! E invece,
quasi rapito o ispirato, egli è entrato silenziosamente nell’isolamento o in uno stato
che non conosce più scosse e non declina più dall’essere di Lui e non si torce più
verso se stesso compiutamente fermo, quasi trasformato nella stessa immobilità.
Persino le cose belle, egli le ha ormai valicate; anzi, egli corre già al di sopra del bello
stesso, al di là del coro delle virtù: somiglia a uno che, penetrato all’interno
dell’invarcabile penetrale, abbia lasciato alle spalle le statue rizzate nel tempio; quelle
statue che, quando egli uscirà di nuovo dal penetrale, gli si faranno innanzi per prime,
dopo l’intima visione e la comunione superna non con una statua, non con una
immagine, ma con Lui stesso; quelle statue che sono, per certo, visioni di
second’ordine.
Pure lì non ci fu certo una visione pura e semplice ma una visione in un senso ben
diverso: estasi, dico, e semplificazione estrema e dedizione di sé e brama di contatto e
quiete e studio di aggiustarglisi ben bene; solo così si può vedere ciò che si trova nel
penetrale; ma se uno guardi in altra maniera, tutto dilegua per lui.
[Plotino, Enneadi, VI, 1, 9. Traduzione di V. Cilento.]
Certo, rispetto al modello cui Plotino intende programmaticamente riferirsi, ossia quello
platonico, non mancano caratteri di indubbia originalità: la visione intellettuale di Platone è
superata nell’intensità trascendentistica e unitiva dell’estasi plotiniana, che risente della
sensibilità tardo-imperiale e del suo misticismo.
Il misticismo plotiniano si caratterizza però per il suo carattere fortemente razionalistico:
•
•
l’estasi si caratterizza come esperienza innanzitutto e esclusivamente intellettuale:
non presenta dunque una componente fisiologica, né tantomeno necessita di essere
accompagnata dalla gestualità rituale ;
è un processo naturale, una conquista dell’ascesi umana radicata nella strutturale
derivazione dell’anima dall’Uno: eliminando ogni forma di alterità fino al
raggiungimento dell’estasi unitiva, l’anima non fa che ripercorrere a ritroso le tappe della
processione metafisica dell’Uno;
•
Plotino rifiuta ogni forma di arcana mediazione fra umano e divino: il divino non si fa
incontro all’umano; è l’anima umana che con le sue sole forze deve innalzarsi fino
all’Uno, senza poter sperare di abbreviare il cammino attraverso rivelazioni extra-razionali
o propiziazioni ritualistiche.
Proprio quando, come nel testo presentato sopra, maggiormente si avvicina al linguaggio delle
iniziazioni misteriche e impiega immagini tratte dalle liturgie sacre, Plotino se ne serve per
caratterizzare inconfondibilmente il suo misticismo razionalistico, che risponde all’ansia
soteriologica del tempo con la proposta di un itinerario ascensivo puramente intellettuale
fondato sull’essenza trascendente dell’anima.
Se Plotino rifiuta drasticamente qualsiasi forma di mediazione irrazionale fra umano e divino,
altre correnti del Neoplatonismo recuperano l’elemento teurgico, centrale negli Oracoli
Caldaici, cercando un legame con il pensiero greco del passato (è il caso di Giamblico e dei
suoi discepoli, ma anche della scuola di Atene) oppure privilegiando la componente teurgica
in maniera pressoché esclusiva, a svantaggio dell’elemento razionale (così accade per la
scuola di Pergamo e Giuliano l’Apostata).
Parte sesta: conclusioni
Il patrimonio filosofico e sapienziale maturato nell’età post-ellenistica fino alla sintesi
neoplatonica del III sec. d.C. è di particolare interesse per quanto riguarda l’evoluzione della
concezione del divino e del rapporto fra l’uomo e la divinità.
Il medioplatonismo, come si ricava dai testi di un suo emblematico rappresentante, Plutarco,:
•
•
•
•
•
riporta al centro della filosofia la problematica metafisico-teologica;
attraverso l’indagine ontologica, afferma la trascendenza del divino e lo caratterizza come
vero essere;
recupera la dimensione del soprasensibile e dell’immateriale, traguardo della “seconda
navigazione” platonica eclissato dalle filosofie ellenistiche;
concepisce il soprasensibile e il divino in maniera gerarchica;
assorbe numerosi aspetti del misticismo orientale e delle dottrine demonologiche, utili per
spiegare l’interazione fra la trascendenza divina e il mondo degli uomini e della natura.
Il Corpus Hermeticum e gli Oracoli Caldaici si fanno interpreti di una tradizione misticosapienziale in cui centrale è l’attesa soteriologica e quindi il possibile congiungimento
dell’uomo con il divino:
•
•
•
•
•
l’incolmabile distanza fra finito e assoluto può essere colmata soltanto dall’unione
estatica;
per conseguirla, l’uomo deve rintracciare il divino che è in lui e seguirne le tracce;
aggancio fondamentale dell’uomo con la trascendenza, l’intelletto riveste un ruolo
fondamentale per il conseguimento dell’esperienza mistica;
il riferimento all’intelletto è però estremamente sfumato nei suoi contorni: il fiore
dell’intelletto che la sapienza caldaica coinvolge nell’unione estatica sembra escludere
tanto la metodologia quanto i contenuti dell’intelletto comunemente e filosoficamente
considerato;
in ogni caso, l’avvicinamento puramente razionale al divino è insufficiente: un ruolo
decisivo è invece giocato dalla pratica rituale e teurgica.
La sintesi filosofica di Plotino:
•
•
•
•
si colloca sulla linea della speculazione ontologico-metafisica di Platone e Aristotele;
si oppone alle correnti irrazionalistiche di provenienza orientale;
ciononostante, risente del confronto con queste matrici culturali, sia per quanto concerne
le modalità espositive, sia per quanto riguarda la concezione del divino;
una irriducibile originalità caratterizza comunque la speculazione plotiniana circa la
concezione dell’itinerario di ricongiungimento dell’anima al principio divino: con nuove
sottolineature sono ripresi itinerari catartici precedentemente descritti dalla tradizione
filosofica; è riconosciuta la necessità di un oltrepassamento dell’intelligenza per il
conseguimento dell’unione estatica, ma il misticismo, per quanto innegabile, mantiene
inconfondibili tinte razionalistiche.
Ricerche
Per mettere a fuoco il clima spirituale dell’età imperiale è decisamente utile ricorrere a E. R.
Dodds, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia, La Nuova Italia, Firenze, 1970.
Dello stesso E. R. Dodds vale la pena citare anche il saggio sul tema specifico della teurgia e
del suo rapporto con il Neoplatonismo contenuto in appendice a I Greci e l’irrazionale, La
Nuova Italia, Firenze, 1973.
Per approfondire metafisica, antropologia e etica del Medioplatonismo si può fare riferimento
al quarto volume della Storia della filosofia antica di G. Reale, che al Medioplatonismo e alla
riscoperta della metafisica platonica dedica la sezione seconda della seconda parte; la stessa
storia della filosofia può inoltre offrire un’importante guida nel mettere a fuoco le dottrine
essenziali contenute nella letteratura ermetica e oracolare (sezione quarta della parte seconda
nel volume quarto), nonché una presentazione efficace del sistema plotiniano, con particolare
riguardo alle matrici culturali di riferimento e agli sviluppi successivi a Plotino (parte terza
dello stesso volume).
Per quanto riguarda specificamente il Neoplatonismo sono consigliabili N. D’Anna, Il
Neoplatonismo. Significato e dottrine di un movimento spirituale, Il Cerchio, Palestrina, 1988,
e M. L. Gatti, Plotino e la metafisica della contemplazione, Vita e Pensiero, Milano, 1996.
Tra le edizioni delle Enneadi plotiniane si può consigliare almeno quella a cura di G. Faggin,
Rusconi, Milano, 1992; l’edizione comprende anche la Vita di Plotino di Porfirio e una
iconografia plotiniana a cura di G. Reale.
Certamente accessibile è l’Introduzione a Plotino, Laterza, Bari, 1984, di M. Isnardi Parente:
particolarmente interessante, in relazione alle tematiche della contemplazione e del
misticismo razionalistico di Plotino, è l’ultima parte di questa sintetica presentazione del
filosofo, che pone a confronto la dottrina plotinana dell’estasi con i suoi precedenti e con i
suoi analoghi contemporanei in ambito sia pagano sia cristiano.