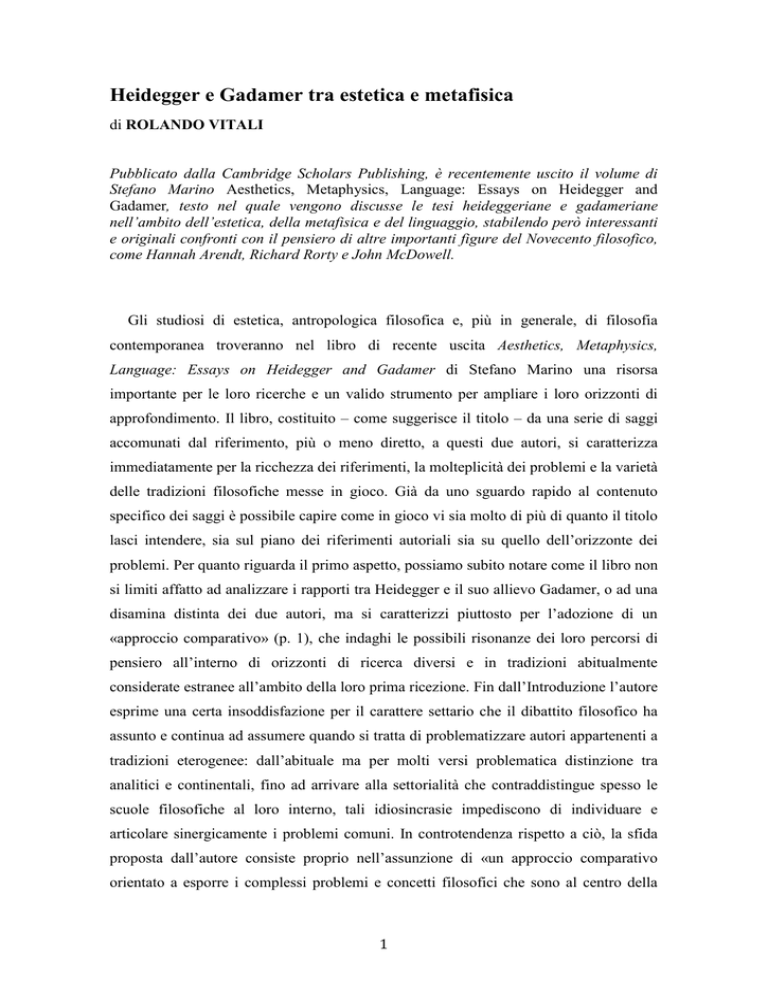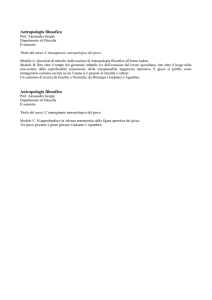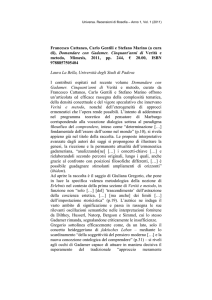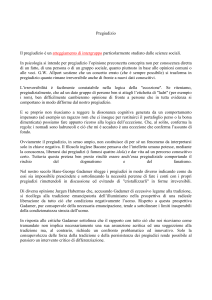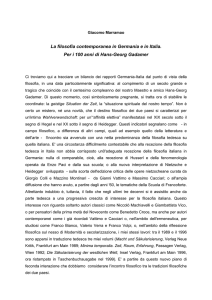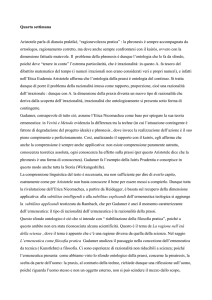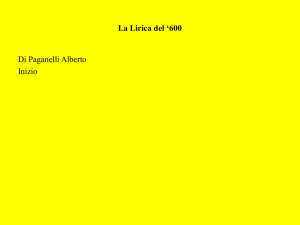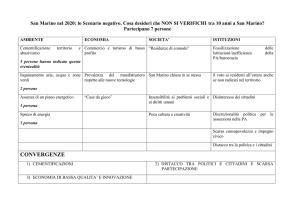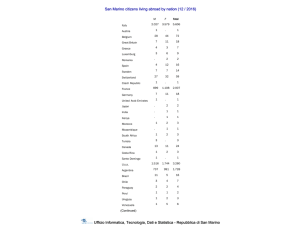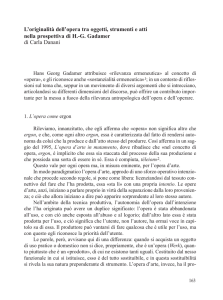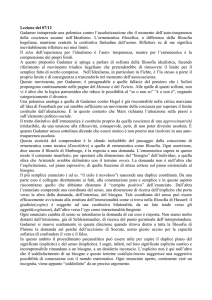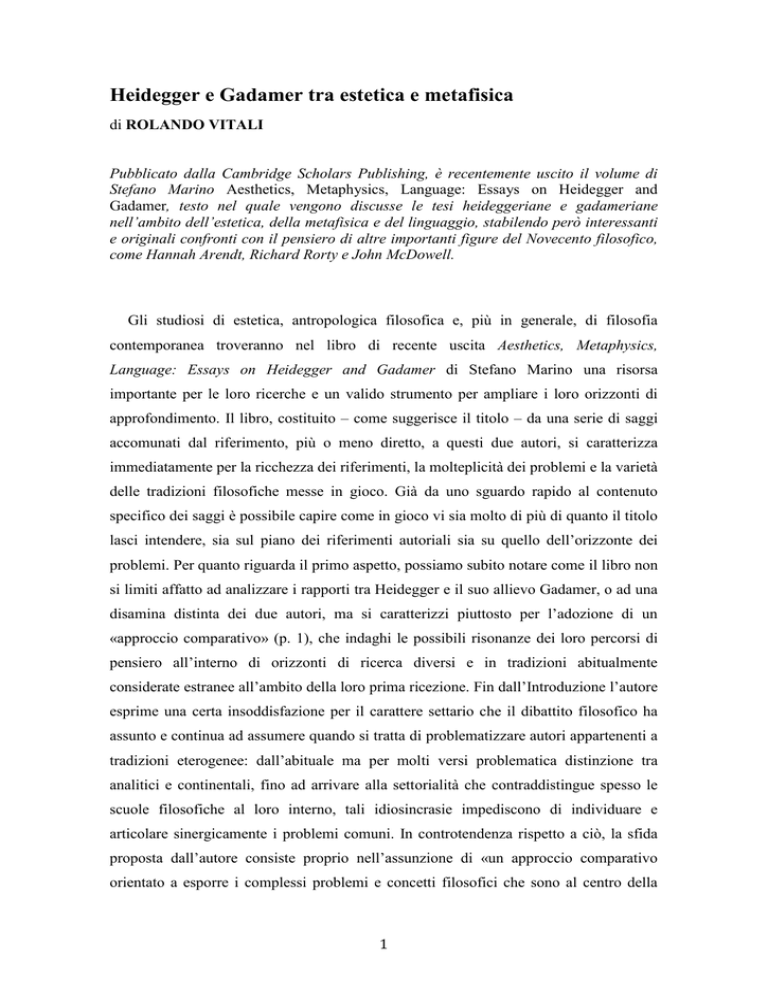
Heidegger e Gadamer tra estetica e metafisica
di ROLANDO VITALI
Pubblicato dalla Cambridge Scholars Publishing, è recentemente uscito il volume di
Stefano Marino Aesthetics, Metaphysics, Language: Essays on Heidegger and
Gadamer, testo nel quale vengono discusse le tesi heideggeriane e gadameriane
nell’ambito dell’estetica, della metafisica e del linguaggio, stabilendo però interessanti
e originali confronti con il pensiero di altre importanti figure del Novecento filosofico,
come Hannah Arendt, Richard Rorty e John McDowell.
Gli studiosi di estetica, antropologica filosofica e, più in generale, di filosofia
contemporanea troveranno nel libro di recente uscita Aesthetics, Metaphysics,
Language: Essays on Heidegger and Gadamer di Stefano Marino una risorsa
importante per le loro ricerche e un valido strumento per ampliare i loro orizzonti di
approfondimento. Il libro, costituito – come suggerisce il titolo – da una serie di saggi
accomunati dal riferimento, più o meno diretto, a questi due autori, si caratterizza
immediatamente per la ricchezza dei riferimenti, la molteplicità dei problemi e la varietà
delle tradizioni filosofiche messe in gioco. Già da uno sguardo rapido al contenuto
specifico dei saggi è possibile capire come in gioco vi sia molto di più di quanto il titolo
lasci intendere, sia sul piano dei riferimenti autoriali sia su quello dell’orizzonte dei
problemi. Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo subito notare come il libro non
si limiti affatto ad analizzare i rapporti tra Heidegger e il suo allievo Gadamer, o ad una
disamina distinta dei due autori, ma si caratterizzi piuttosto per l’adozione di un
«approccio comparativo» (p. 1), che indaghi le possibili risonanze dei loro percorsi di
pensiero all’interno di orizzonti di ricerca diversi e in tradizioni abitualmente
considerate estranee all’ambito della loro prima ricezione. Fin dall’Introduzione l’autore
esprime una certa insoddisfazione per il carattere settario che il dibattito filosofico ha
assunto e continua ad assumere quando si tratta di problematizzare autori appartenenti a
tradizioni eterogenee: dall’abituale ma per molti versi problematica distinzione tra
analitici e continentali, fino ad arrivare alla settorialità che contraddistingue spesso le
scuole filosofiche al loro interno, tali idiosincrasie impediscono di individuare e
articolare sinergicamente i problemi comuni. In controtendenza rispetto a ciò, la sfida
proposta dall’autore consiste proprio nell’assunzione di «un approccio comparativo
orientato a esporre i complessi problemi e concetti filosofici che sono al centro della
1
[sua] indagine da differenti punti di vista, ampliando così l’orizzonte filosofico e
producendo una prospettiva più esauriente» (p. 1).
Già con il primo saggio – il più denso e corposo dell’intero libro – vediamo questo
metodo direttamente all’opera: partendo da alcuni riferimenti a Gadamer presenti in
Mind and World di John McDowell, Marino ricostruisce rigorosamente una genealogia
del concetto di «seconda natura» e delle sue diverse ramificazioni. I problemi fatti
propri da McDowell, come quello del rapporto tra mente e corpo, il tentativo di superare
un paradigma cartesiano e dualistico del loro rapporto, così come l’elaborazione di un
sapere capace di pensare la costituzione specifica dell’umano nel mondo naturale e
culturale, trovano nel concetto di «seconda natura» un proficuo terreno di elaborazione.
Grazie alla ricca ricostruzione delle fonti messa in gioco da Marino, scopriamo come sia
all’interno della tradizione dell’antropologia filosofica tedesca della prima metà del
Novecento che si debba rintracciare il primo terreno di elaborazione di questi problemi.
Tuttavia, mentre l’affinità con Gadamer e con l’orizzonte di problemi dell’ermeneutica
viene esplicitamente riconosciuta da McDowell, Marino fa notare come la ricchezza e
complessità di riflessioni sullo statuto dell’umano, portate avanti da autori come
Scheler, Plessner e Gehlen, venga invece dimenticata dall’autore di Mind and World. Se
infatti, nello stabilire la differenza tra mondo e ambiente, necessaria all’elaborazione del
concetto di seconda natura, McDowell ammette di «appropriarsi della nozione
gadameriana di ambiente» e della centralità del «ruolo del linguaggio nel dischiuderci il
mondo», nel farlo «non si chiede nemmeno se Gadamer sia stato influenzato da altri
autori» (p. 21) nell’elaborazione di tali nozioni: in questo modo, viene così rimosso
l’apporto, fondamentale per l’elaborazione del concetto di seconda natura e della
differenza uomo/animale da parte di Gadamer, delle prospettive aperte dall’antropologia
filosofica, ma anche dalla etologia degli ambienti animali di Jakob von Uexküll. È
proprio per queste lacune che, secondo Marino, l’elaborazione di McDowell continua a
restare impigliata in alcune dicotomie che potrebbero essere invece superate attraverso
un confronto più serrato con la tradizione dell’antropologia filosofica e della
fenomenologia a essa legata. L’autore fa notare come, ad esempio, McDowell
«identifichi semplicemente la Bildung con lo spazio logico delle ragioni senza
analizzare altre dimensioni della nostra esperienza del mondo (comprese le pratiche
simboliche ed estetiche) e, soprattutto, non spieghi in che modo le capacità concettuali e
linguistiche siano “legate alla struttura corporea che è caratteristica della nostra specie”»
(p. 33), lasciando così parzialmente indeterminato il contenuto del suo progetto
2
filosofico. Secondo Marino, infatti, se da un lato «il concetto di natura in quanto tale
[…] non è sufficiente per gli ambiziosi obiettivi del progetto filosofico di McDowell»,
dall’altro lato proprio una sua ricostruzione genealogica che «intraprenda nuovi tentativi
di fusione di diversi orizzonti filosofici» potrebbe «migliorare e rafforzare il
naturalismo della seconda natura di McDowell» (p. 33).
Il secondo saggio, a differenza del primo, si limita apparentemente al confronto tra i
due autori del titolo, generalmente accomunati in una stessa tradizione: ma, anche in
questo caso, i risultati del contributo non sono affatto scontati. Se, infatti, per una certa
vulgata critica, il pensiero di Gadamer non rappresenta altro che uno sviluppo di alcune
intuizioni fondamentali di Heidegger, il saggio di Marino mostra come, per più di un
aspetto ma anche e soprattutto rispetto a questioni fondanti, il percorso di pensiero di
Gadamer non solo si distanzi a posteriori, ma si sviluppi originalmente da
considerazioni divergenti da quelle del suo maestro di gioventù. Se allora, da un lato,
sarebbe sbagliato non riconoscere il primato del confronto con il pensiero di Heidegger
per la formazione di Gadamer, dall’altro Marino fa notare però i molteplici elementi di
originalità del secondo. Alcune considerazioni, come la diversa valutazione dell’apporto
di discipline come la filologia per il pensiero filosofico, lo conducono ad esempio a
criticare i caratteri essenziali della ricezione heideggeriana di alcuni grandi autori come
Platone. Un altro punto di divergenza, collegato a quello appena citato, viene
individuato in una più generale valorizzazione da parte di Gadamer della tradizione
umanistica e nel suo rifiuto di una cesura radicale quanto unilaterale con quest’ultima. È
a partire da un’analisi più approfondita di quest’ultimo punto che viene in luce quella
che è probabilmente la differenza decisiva e spesso dimenticata tra i due autori, vale a
dire un «disaccordo fondamentale riguardo la questione concernente la storia
dell’Essere» (p. 59). Se Heidegger, infatti, «critica l’umanesimo perché “rimane
metafisico”, vale a dire “o si fonda su una metafisica o pone se stesso a fondamento di
una metafisica”» (ibidem), Gadamer, al contrario, sulla base del suo rifiuto del carattere
destinale della storia dell’Essere, può giungere a considerazioni diverse e meno rigide
del suo maestro, arrivando, da un lato, a collocare la propria filosofia nel solco di una
rivalorizzazione della tradizione umanistica e, dall’altro, a criticare l’ipoteca metafisica
del pensiero heideggeriano dopo la “svolta”, smascherato dall’allievo come
surrettiziamente teologico. Esso, infatti, interpretando l’intera storia occidentale come
progressivo oblio dell’Essere, ripropone una prospettiva “totalitaria” e necessitante,
tipica della filosofia della storia di matrice cristiana che, nella lettura di Löwith,
3
partendo da Agostino giunge fino a Hegel. In questo modo, il saggio di Marino,
mettendo a fuoco la questione fondamentale della Kehre ed esplicitando la diversa
valutazione della tradizione filosofica occidentale, non solo restituisce nella loro
originalità le due prospettive filosofiche, troppo spesso confuse e sovrapposte, ma
permette anche di emendare il pensiero di Gadamer da alcune tendenze irrazionalistiche
di matrice heideggeriana.
In una certa misura, anche il terzo saggio, dedicato alla diversa ricezione in Gadamer
e Arendt della Critica del Giudizio kantiana, ripropone il tema della differente
valutazione della tradizione umanista: infatti è proprio la differente valutazione di
quest’ultima a determinare la lettura antitetica della terza Critica kantiana nei due
autori. Se per Gadamer, infatti, l’operazione kantiana inaugura la progressiva astrazione
e spoliticizzazione dei concetti, in origine propriamente umanistici, di sensus communis
e di gusto, Hannah Arendt, al contrario, sottolinea proprio il possibile impiego del
concetto kantiano di Giudizio per una nuova valutazione dell’uomo come zoon
politikon. Se per Gadamer Kant, collegando l’esercizio del Giudizio al libero gioco delle
facoltà dell’animo, apriva le porte alla soggettività dei giudizi estetici e cancellava la
dimensione storica, culturale e politica del giudizio di gusto, presente invece nella
tradizione umanistica, per Arendt, al contrario, con il concetto di Giudizio Kant avrebbe
«scoperto “l’elemento non soggettivo dell’intersoggettività”», inaugurando così una
prospettiva che, in contrasto con la tradizione precedente, basata sul primato del
theorein, mette al centro la praxis come dimensione propria dell’esserci dell’uomo.
Il quarto saggio (scritto a quattro mani da Marino insieme a Carlo Gentili),
concentrandosi sul rapporto gadameriano con l’estetica della tragedia e la filosofia del
tragico, mostra in che senso debba essere intesa la valorizzazione del confronto con la
tradizione filosofica ed estetica dell’umanismo. Se da un lato, infatti, il contenuto
filosofico della tragedia esprime, nella maniera più perspicua, l’esperienza della
finitezza nel rapporto dell’uomo con il sapere, dall’altro il contributo teorico
gadameriano sulla forma-tragedia risulta essere estremamente utile per rispondere
all’annosa questione delle sue origini. In questo senso, l’analisi della forma-tragedia,
pur concernendo una specifica forma culturale, getta contemporaneamente luce sui
caratteri specifici dell’esserci umano: la sua trattazione diventa paradigmatica per
comprendere in che senso debba essere inteso il recupero di tradizioni culturali passate
da parte di Gadamer. Esso deve essere sempre, come in questo caso, rivolto a mettere in
luce la condizione più generale dell’esperienza dell’uomo, e mai limitarsi a contribuire
4
ad un sapere specialistico, per quanto importante esso possa essere. In questo caso, il
carattere fondamentale del sapere tragico, l’eschileo pathei mathos (“conoscere
attraverso il patimento”), diventa modello per la comprensione, fatta propria dalla
prospettiva ermeneutica, della «storicità interna dell’esperienza», propria di ogni sapere
concreto. Quest’ultima «nella sua essenza è esperienza della finitezza umana». Infatti,
se la più compiuta «esperienza della realtà si ha nel momento in cui l’uomo acquisisce
coscienza della propria finitezza”» (pp. 87-88), è proprio nel pathos, nell’esperienza del
dolore, che tale finitezza si rende presente. L’analisi gadameriana della tragedia greca
aiuta inoltre a comprendere più correttamente la prospettiva, inaugurata da Nietzsche di
una sua origine religiosa. Se, infatti, secondo importanti studiosi come Jean-Pierre
Vernant tale ricostruzione non è che congetturale e, in ultima analisi, arbitraria, la
riflessione gadameriana, attraverso un rigoroso confronto con Aristotele, permette di
comprendere meglio il valore del riferimento all’esperienza religiosa per la costituzione
della forma-tragedia. In questo modo, «la prospettiva storico-interpretativa di Gadamer
[…] ci permette di riconoscere le origini religiose della tragedia senza essere obbligati
allo stesso tempo a misconoscere gli autonomi valori estetici della tragedia» (p. 100).
L’ultimo saggio si può ricollegare al contributo inaugurale, nella misura in cui,
mettendo a confronto Heidegger e Rorty, ne ripropone l’approccio comparativo. Più in
particolare, il contributo, partendo dal riconoscimento che «il rapporto tra filosofia,
poesia e letteratura ha giocato un ruolo importante lungo l’intera storia della filosofia
occidentale» (p. 105), sottolinea l’affinità dei due autori proprio per quanto riguarda la
valorizzazione dell’esperienza poetica e letteraria. Ma non per questo ci si dimentica di
rilevare le importanti differenze tra i due autori: Marino fa innanzitutto notare la
parzialità della ricezione di Heidegger da parte di Rorty, che si preoccupa soprattutto di
valorizzare il confronto con le forme del linguaggio poetico da parte del filosofo
tedesco, rimuovendo però la sempre rigorosa distinzione heideggeriana dei compiti e dei
metodi del pensiero rispetto alla poesia. Heidegger, infatti, pur insistendo sulla
«“comunione di pensiero e poesia”» e proponendo il recupero di un domandare il vero
che si «accosti al dominio della poesia» (p. 108), non avrebbe però in nessun modo
accettato il rifiuto, attribuitogli proprio da Rorty, della dimensione “scientifica”, ossia
rigorosamente veritativa del pensiero filosofico (“scientifica”, naturalmente, in
riferimento alla fenomenologia come scienza di ciò che è originario e non in riferimento
alle scienze positive). Se da un lato, allora, non si possono non riconoscere l’originalità
e gli elementi di interesse presenti nella prospettiva filosofica generale di Rorty,
5
dall’altro lato la sua interpretazione di tematiche e prospettive heideggeriane risulta però
«parziale e incompleta»: infatti, non solo Rorty «non prende mai seriamente in
considerazione l’interezza del pensiero di Heidegger» (p. 115), ma trasforma la critica
heideggeriana al concetto di verità come adaequatio in un rifiuto della dimensione
veritativa e scientifica del pensiero tout court.
A questo punto il lettore avrà certamente compreso l’ampiezza delle tematiche e la
varietà di problemi che il libro prende in esame: il resoconto che abbiamo dato dei
diversi contributi non ha potuto inoltre prendere in considerazione tutti i riferimenti e le
sfaccettature messi in campo dall’autore. Nel muovere un appunto critico al libro, si
potrebbero prendere le mosse proprio da tale ricchezza, facendo notare come talvolta la
trattazione dei problemi e lo sviluppo concettuale del loro contenuto risulti un po’
sacrificata rispetto alla ricostruzione della loro genesi, al rinvenimento di analogie e ai
rimandi ad altri autori: la trattazione di concetti e problemi rischia allora talvolta o di
arrestarsi ad un livello espositivo, senza giungere ad un concreto sviluppo del loro
contenuto, o di risolversi in un appello programmatico. Nonostante questi rischi, però,
bisogna sottolineare la solidità concettuale del lavoro: è infatti grazie ad essa che
Marino si mostra capace di coinvolgere un numero così significativo di riferimenti e di
tematiche, di intrecciare tradizioni e orizzonti di pensiero così diversi, mantenendo però
sempre un’argomentazione chiara e precisa. Il libro, in questo senso, può rivolgersi agli
studiosi di estetica e di storia del pensiero e delle idee, sia di formazione anglosassone e
analitica, sia di matrice continentale maggiormente storicistica. L’ampiezza di sguardo e
la precisione dei riferimenti rendono infatti possibile una fruizione del libro che parta da
prospettive diverse e persino divergenti, che potranno trovare in esso non solo numerosi
spunti di interesse ma, forse, scoprire anche inaspettate affinità.
Rolando Vitali è attualmente è Fellow in Residence presso l’Archivio Nietzsche di
Weimar e dottorando all’università di Jena.
6