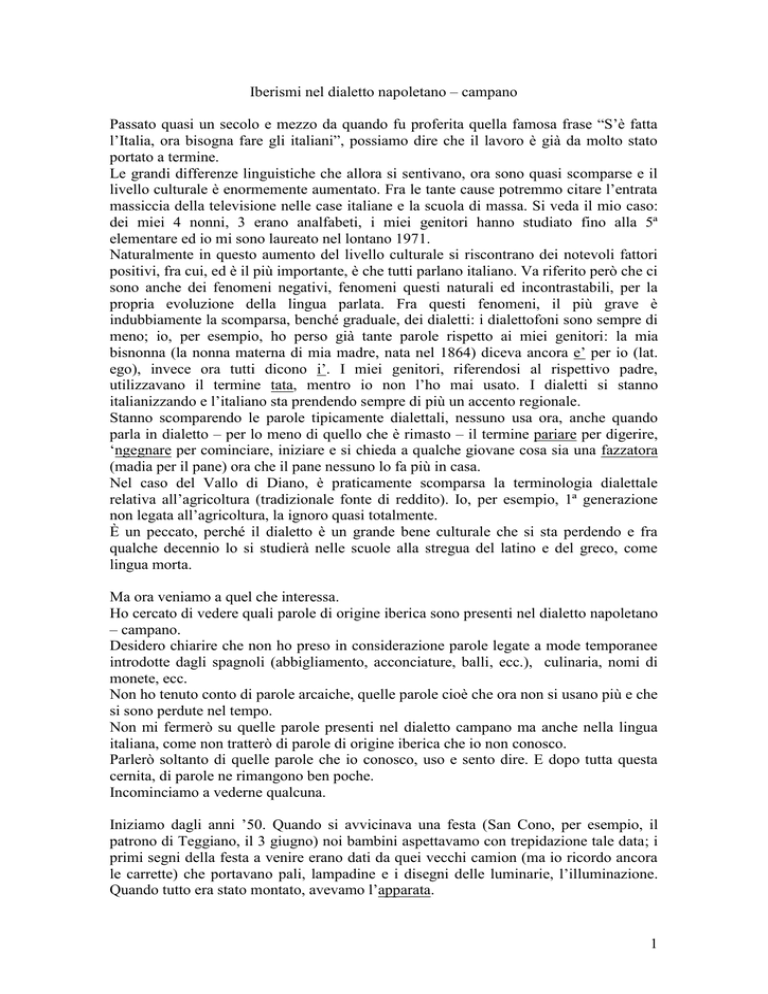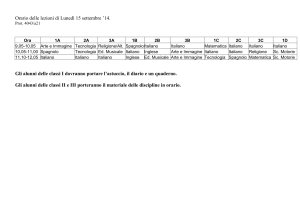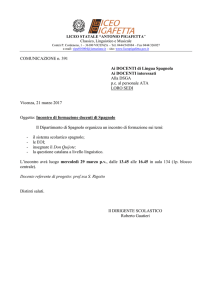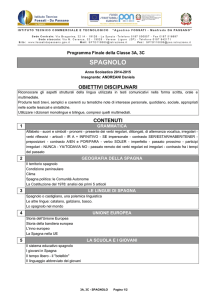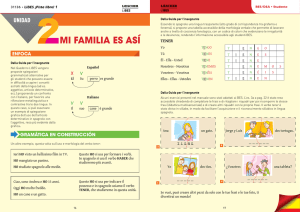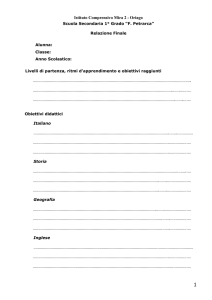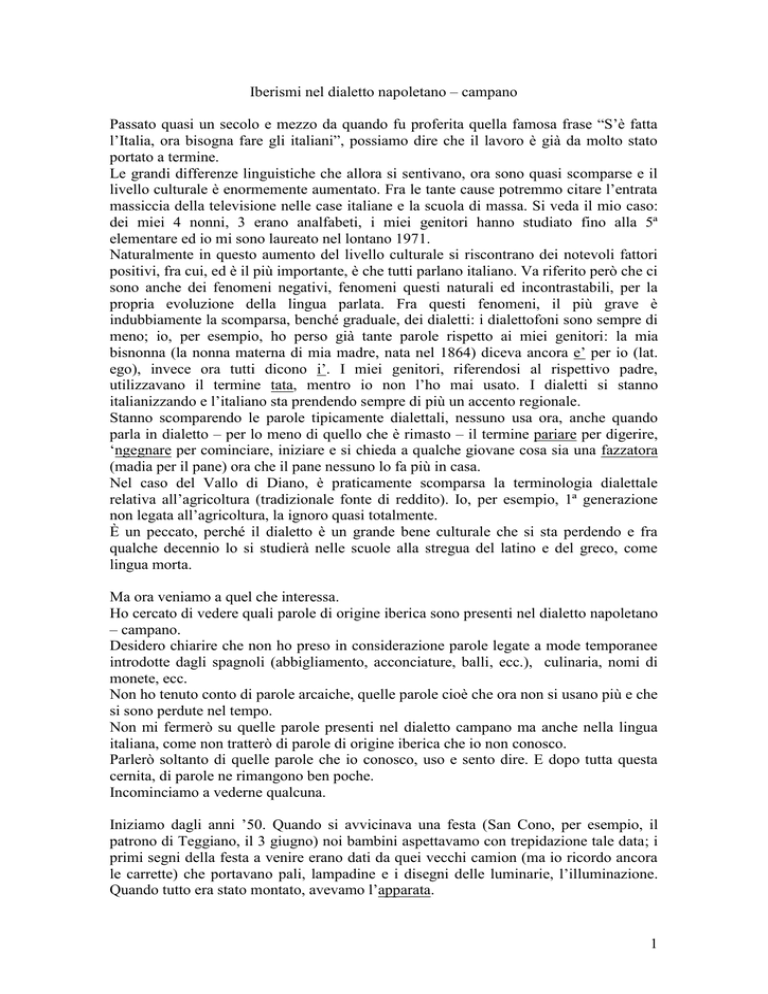
Iberismi nel dialetto napoletano – campano
Passato quasi un secolo e mezzo da quando fu proferita quella famosa frase “S’è fatta
l’Italia, ora bisogna fare gli italiani”, possiamo dire che il lavoro è già da molto stato
portato a termine.
Le grandi differenze linguistiche che allora si sentivano, ora sono quasi scomparse e il
livello culturale è enormemente aumentato. Fra le tante cause potremmo citare l’entrata
massiccia della televisione nelle case italiane e la scuola di massa. Si veda il mio caso:
dei miei 4 nonni, 3 erano analfabeti, i miei genitori hanno studiato fino alla 5ª
elementare ed io mi sono laureato nel lontano 1971.
Naturalmente in questo aumento del livello culturale si riscontrano dei notevoli fattori
positivi, fra cui, ed è il più importante, è che tutti parlano italiano. Va riferito però che ci
sono anche dei fenomeni negativi, fenomeni questi naturali ed incontrastabili, per la
propria evoluzione della lingua parlata. Fra questi fenomeni, il più grave è
indubbiamente la scomparsa, benché graduale, dei dialetti: i dialettofoni sono sempre di
meno; io, per esempio, ho perso già tante parole rispetto ai miei genitori: la mia
bisnonna (la nonna materna di mia madre, nata nel 1864) diceva ancora e’ per io (lat.
ego), invece ora tutti dicono i’. I miei genitori, riferendosi al rispettivo padre,
utilizzavano il termine tata, mentro io non l’ho mai usato. I dialetti si stanno
italianizzando e l’italiano sta prendendo sempre di più un accento regionale.
Stanno scomparendo le parole tipicamente dialettali, nessuno usa ora, anche quando
parla in dialetto – per lo meno di quello che è rimasto – il termine pariare per digerire,
‘ngegnare per cominciare, iniziare e si chieda a qualche giovane cosa sia una fazzatora
(madia per il pane) ora che il pane nessuno lo fa più in casa.
Nel caso del Vallo di Diano, è praticamente scomparsa la terminologia dialettale
relativa all’agricoltura (tradizionale fonte di reddito). Io, per esempio, 1ª generazione
non legata all’agricoltura, la ignoro quasi totalmente.
È un peccato, perché il dialetto è un grande bene culturale che si sta perdendo e fra
qualche decennio lo si studierà nelle scuole alla stregua del latino e del greco, come
lingua morta.
Ma ora veniamo a quel che interessa.
Ho cercato di vedere quali parole di origine iberica sono presenti nel dialetto napoletano
– campano.
Desidero chiarire che non ho preso in considerazione parole legate a mode temporanee
introdotte dagli spagnoli (abbigliamento, acconciature, balli, ecc.), culinaria, nomi di
monete, ecc.
Non ho tenuto conto di parole arcaiche, quelle parole cioè che ora non si usano più e che
si sono perdute nel tempo.
Non mi fermerò su quelle parole presenti nel dialetto campano ma anche nella lingua
italiana, come non tratterò di parole di origine iberica che io non conosco.
Parlerò soltanto di quelle parole che io conosco, uso e sento dire. E dopo tutta questa
cernita, di parole ne rimangono ben poche.
Incominciamo a vederne qualcuna.
Iniziamo dagli anni ’50. Quando si avvicinava una festa (San Cono, per esempio, il
patrono di Teggiano, il 3 giugno) noi bambini aspettavamo con trepidazione tale data; i
primi segni della festa a venire erano dati da quei vecchi camion (ma io ricordo ancora
le carrette) che portavano pali, lampadine e i disegni delle luminarie, l’illuminazione.
Quando tutto era stato montato, avevamo l’apparata.
1
Questa parola deriva dal verbo aparà nel senso di “adornare le chiese con paramenti
festivi o funebri, ornare” da cui anche adornare con luci le vie principali del paese –
tuttora in uso – da dove passa la processione.
Il verbo aparà deriva dallo spagnolo aparar, con il significato di “aggiustare; rendere
uniforme, lineare; rendere più piacevole alla vista; togliere quello che è diseguale”.
In queste feste, con l’illuminazione, la banda, le bancarelle [quasi tutte vendevano
torrone – torrone è un’altra parola d’origine spagnola (come noi abbiamo il torrone di
Benevento, così gli spagnoli hanno il torrone di Alicante) che qui non analizziamo,
perché è una parola che si è trasmessa in italiano] e con i fuochi d’artificio che
concludevano la giornata, era d’obbligo vestire i panni della festa; quei panni che si
usavano solo in occasioni speciali – una festa, la domenica, un matrimonio. Di questo
corredo faceva parte anche il fazzoletto da naso. Ma era quasi un accessorio, perché il
naso, mi si scusi l’immagine, nella maggior parte dei casi era pulito con le dita. Bene, il
fazzoletto da naso è tuttora chiamato maccaturo. Per maccaturo s’intende inoltre il
fazzoletto da testa usato dalle contadine, generalmente molto colorito e rigorosamente
nero quando le signore diventavano vedove.
Ebbene, anche il termine maccaturo è d’origine spagnola e deriva da mocador – che
significa appunto fazzoletto da naso – sostantivo del verbo mocar (soffiarsi il naso), a
sua volta dal latino muccus.
Restiamo sempre in questo ambiente di festa – festa di suoni, botti, rumori, chiasso,
baldoria, insomma di ammuina. Ecco qui un altro termine di origine spagnola che deriva
dal verbo amohinar, nel senso di “produrre confusione, stordimento, chiasso”. Forse gli
spagnoli sono rimasti davvero storditi quando, arrivati a Napoli, hanno udito come i
Napoletani parlavano tra di loro, e non certamente a bassa voce. E non si dimentichi
come doveva essere la festa di Predigrotta a quei tempi.*
E dal momento che abbiamo tirato in ballo Napoli, come un napoletano designerebbe
una persona violenta, prevaricatrice, facinorosa, arrogante e priva di scrupoli, insomma
un bravaccio, uno smargiasso, un camorrista? Certamente userebbe la parola guappo (in
teggianese uappu), anch’esso di origine spagnola, da guapo (parola, a dir il vero, più
usata in America Latina che in Spagna), ma che non ha un significato negativo come in
napoletano, tutt’altro, ha un significato estremamente positivo, nel senso di “coraggioso,
bravo, valoroso, che non ha paura del pericolo”. Certamente i napoletani, sentendo
questo termine dagli spagnoli, l’hanno interpretato male e gli hanno dato un significato
negativo, spregiativo.
* A mo’ di curiosità e per capire il reale significato di ammuina, si trascrive l’art. 27 del
Regolamento della Real Marina del Regno delle Due Sicilie del 1841, da applicare in
occasione di visite a bordo delle Alte Autorità del Regno: “Facite Ammuina”.
All’ordine Facite Ammuina: tutti chilli che stanno a prora vann’ a poppa e chilli che
stann’ a poppa vann’ a prora; chilli che stann’ a dritta vann’ a sinistra e chilli che stanno
a sinistra vann’ a dritta; tutti chilli che stanno abbascio vann’ ncoppa e chilli che stanno
ncoppa vann’ bascio passann’ tutti p’o stesso pertuso: chi nun tiene nient’ affà
s’aremeni a ‘cca e a ‘llà.
2
Il termine guappo, per un certo periodo, è stato quasi sinonimo di camorrista.
Ultimamente non lo si usa più in questo senso. Il termine camorra è ritornato
violentamente alla ribalta in questi ultimi tempi.
Ma cosa significa camorra? Questa parola ha lo stesso significato di mafia o
‘ndrangheta, cioè “associazione a delinquere, consorteria di malaffare, di malviventi”.
Gli storici sono tutti d’accordo nel dire che è nata sotto gli spagnoli e che si è affermata
potente nell’Ottocento e si è organizzata secondo leggi e gerarchie. Si diceva che è nata
sotto gli Spagnoli ed infatti questa parola deriva dallo spagnolo camorra, che però non
ha il significato che ha preso in napoletano, ma che significa “rissa, zuffa, alterco,
disputa, lite, baruffa, tafferuglio, ecc.”. La connessione semantica esiste, siamo nello
stesso campo semantico, come è identico il campo semantico tra guappo napoletano e
guapo spagnolo. Quanto al sostantivo camorrista, in spagnolo abbiamo sia il sostantivo
camorrista che camorrero.
Se un camorrista ci facesse qualche torto e noi potessimo fare giustizia con le nostre
proprie mani, certamente la prima cosa che faremmo, gli daremmo una solenne e sonora
bastonatura, cioè un “paliatone”, accrescitivo di “paliata”, a sua volta sostantivo del
verbo “palià”, che significa, appunto, bastonare, percuotere. Bene, questo verbo deriva
dallo spagnolo “apalear”, cioè battere con “palo”, che non ha niente a vedere con
l’italiano “palo”, perché “palo” in spagnolo significa “randello, legno, bastone”.
Ma ritengo che ci sia una differenza tra “palià” e “apalear”. “Palià” dà più l’idea di
picchiare con le mani, mentre “apalear” significa “percuotere con un randello, con un
legno”.
E se un “paliatone” non bastasse, potremmo continuare a picchiare questa camorrista,
ma questa volta non con le mani, bensì con i piedi. E se dobbiamo picchiare qualcuno
con i piedi, dove lo picchiamo? Bene, proprio in quel posto “dove la schiena cambia
nome” come dicono i portoghesi, cioè nel “tafanario”, un’altra parola che deriva dallo
spagnolo “tafanario”, col significato appunto di “deretano, sedere”.
E se dopo avergli dato una bastonatura e delle pedate, volessimo esporre sempre questo
camorrista al pubblico ludibrio, cioè facendolo andare e venire per la via principale del
paese, affinché possa raccogliere tutte le invettive del popolo, come si faceva
anticamente quando si metteva qualcuno al palo della gogna, allora lo tireremmo con
una “zoca”, cioè con una fune, una corda.
Ma che cos’è una “zoca”? Una fune, una corda, appunto, generalmente di sparto, usata
soprattutto, per quel che mi ricordo, per tirare gli animali (cavallo, asino, mulo, mucca)
o per legarli a qualche cosa (nella stalla, al pascolo) affinché non si allontanassero.
Ebbene, anche il termine zoca proviene dallo spagnolo “soga”, con lo stesso significato
di “corda, fune”. Si noti questo proverbio identico in spagnolo e italiano: “no se ha de
mentar la soga en casa del ahorcado”, “non parlar di corda in casa dell’impiccato”.
Attenzione però a non portare sempre questo camorrista in un luogo dove ci siano sassi,
pietre, ciottoli, perché qualcuno, forse preso da un raptus di giustizialismo “fai-da-te”,
potrebbe prendere un “mazzacane” e colpirlo. Ma cosa è un “mazzacane”? Un “grosso
sasso capace di ammazzare un cane”, in questo caso un malavitoso.
Ammazzare, uccidere, in spagnolo e portoghese si dice matar (si noti la parola italiana
matamoro, che deriva dallo spagnolo matamoros – letteralmente uccisore di mori – e
che significa millantatore, spaccone, gradasso o il termine “matador”, il torero che
uccide il toro a conclusione della corrida).
3
Io non so se ammazzare e matar hanno la stessa origine, cioè uccidere con una mazza,
gli etimologi non sono riusciti a spiegarlo. Comunque il termine “mazzacane” deriva
dallo spagnolo matacán, esattamente sasso capace di ammazzare un cane. Il passaggio
da mata a mazza potrebbe essere stato influenzato dall’italiano ammazzare.
Se questo malcapitato camorrista, dopo aver preso un paliatone (esiste anche la variante
palliatone con la doppia l), tante di quelle pedate nel tafanario e forse anche qualche
mazzacane in testa, dovesse soccombere, noi certamente gli daremmo una degna
sepoltura cristiana, con un bel funerale ed un bel “tavutu” (pronunciato alla teggianese).
Il “tavutu”, per chi non ha familiarità con il dialetto di queste parti, è la cassa da morto,
la bara.
Questa parola deriva dallo spagnolo ataúd, portoghese ataúde. In spagnolo e portoghese
queste parole non significano cassa da morto, ma piuttosto catafalco, ma siamo sempre
nello stesso campo semantico.
I termini portoghese e spagnolo derivano dall’arabo. Lo spagnolo e il portoghese hanno
moltissime parole d’origine araba. Gli arabi sono stati presenti in Portogallo sino alla
fine del XII secolo ed in Spagna sino alla fine del Quattrocento. Da notare che mentre in
Italia gli arabi hanno preso il nome di saraceni – che in arabo significa “orientale” -,
nella Penisola Iberica hanno preso il nome di Mori, termine già usato in latino,
“Maurus”, abitante della “Mauritania”. Infatti gli arabi che hanno occupato la Penisola
Iberica erano, come diremmo oggi, magrebini.
Bene, ora che il nostro camorrista è morto e sepolto, possiamo parlare anche d’altro. E
vorrei parlare di una parola bellissima, musicale, dolce, delicata, che dà l’idea perfetta
di quel che vuol esprimere. Mi riferisco al termine napoletano nennillo, un sostantivo
diminutivo, con la sua versione femminile nennella, diminutivo di nenna. Nennillo,
come si sa, significa “bimbo, fanciullino” e naturalmente nennella significa “fanciullina,
bimbetta” e nenna “bimba, bambina”. Ebbene queste parole derivano dallo spagnolo
niño e niña (da ricordare le tre caravelle di Colombo, la Niña, la Pinta e la Santa Maria,
e non la Nina, perché questa parola era scritta senza la tilde, quella lineetta ondulata che
si mette sopra la n – si veda la propria parola España – per dare un suono nasale –
palatale, come in italiano ogni, ignorante, segno), dicevo che queste parole derivano
dallo spagnolo niño e niña, che possono essere aggettivi e sostantivi con il significato
appunto di “bambino, bimbo, fanciullo, ragazzo, piccolo”.
Per il termine nenna, cioè il passaggio dalla i spagnola alla e, può essere intervenuto, per
un fenomeno di assimilazione o assonanza, il termine menna, “mammella”.
Una delle prime cose che noi notiamo in un bambino se è beneducato o maleducato.
Generalmente sono sempre i figli degli altri che sono maleducati, mentre i nostri sono
sempre educatissimi e se qualche volta fanno qualche marachella, è perché…
frequentano i figli degli altri. Una parola che noi usiamo spesso per indicare un bambino
beneducato è accrianzato, dello stesso gruppo dell’italiano creanza. L’aggettivo
dialettale accrianzato col suo rispettivo sostantivo accrianzatezza (ma esiste anche la
forma dialettale dell’italiano creanza che è crianza) deriva dallo spagnolo creanza che
significa educazione e questo termine è accompagnato sempre dagli aggettivi buena o
mala. Crianza, a sua volta, è il sostantivo del verbo criar che, oltre a significare creare,
significa anche allevare e, per estensione, educare. Contrariamente allo spagnolo dove
crianza può dare valore negativo o positivo secondo se è preceduto da buena o mala, in
dialetto ha preso solamente il significato di buona educazione, buona creanza, belle
maniere.
4
Se il bambino è alquanto vivace, irrequieto, non sta mai fermo, insomma ha l’argento
vivo addosso, che corre sempre, deve sentire molte volte questa frase da chi gli sta
vicino: attenzione, non correre sennò ti scapiezzi, nel senso che cadi e ti rompi la testa.
Il verbo scapezzà può avere due interpretazioni: la prima nel senso di correre come
animale liberato della cavezza (si veda scavezzacollo), ma in questo caso non si dà
l’idea della caduta e della conseguenza ferita alla testa, ma l’idea di scapezzà è più
quella di cadere e non necessariamente rompersi la testa – si può cadere e possiamo
ferirci in qualche altra parte del corpo. La seconda interpretazione è quella di tagliare la
testa e, di conseguenza, cadere di botto con la testa a terra. Nella prima interpretazione
si dà l’idea della cavezza e nella seconda l’idea di testa. Testa in spagnolo si dice cabeza
ed in portoghese cabeça ed in questo caso il verbo sarebbe descabezar, formato da
cabeza e dal prefisso des di origine latina che esprime l’idea di separazione,
allontanamento, ablazione, azione contraria, come l’italiano s (legare → slegare).
Quindi, in base a quanto detto, mi sembra più verosimile che derivi dallo spagnolo.
Un sinonimo di scapezzà è un altro verbo d’origine iberica: derrupà, nel significato di
crollare, precipitare, cadere rovinosamente, derivato molto probabilmente dalla forma
spagnola derrumbar (portoghese derrubar). Questi due verbi alla forma attiva
significano demolire, abbattere, rovesciare, atterrare, ma alla forma intransitiva
significano crollare, franare, cadere, abbattersi, precipitare. Quindi è molto più
probabile questa spiegazione che farlo derivare dall’italiano dirupare.
Per scapezzà e derrupà, come si è visto, ci sono due interpretazioni. Ed io,
evidentemente, ho scelto quella che mi sembra più plausibile. Ora mi viene un dubbio:
nce l’aggiu ‘ngarrata o nun ‘nce l’aggiu ‘ngarrata? Forse non sarebbe questo il termine
più appropriato, perché ‘ngarrà significa “cogliere nel segno, indovinare, riuscire in una
cosa, prendere la giusta via” in cui c’è molto di casuale, aleatorio, forse anche qualcosa
di intuitivo, ma non significa affatto qualcosa di studiato, meditato, riflettuto, come è il
caso della mia scelta sulle anzidette parole.
Ma ho voluto usare ‘ngarrà perché questa è un’altra parola d’origine spagnola, derivante
da engarrar, termine ormai caduto in disuso e sostituito dal quasi identico agarrar che
significa, come anche in portoghese, afferrare, aggrappare, prendere, abbrancare e nel
senso lato e figurato, ottenere, conseguire. Il passaggio semantico da ottenere,
conseguire a cogliere nel segno, indovinare, riuscire in una cosa non è grande e quindi è
perfettamente comprensibile questo cambiamento.
Dopo tutti questi verbi ritorniamo di nuovo ad un paio di sostantivi. Negli anni 60/70,
alcune persone lungimiranti, e fra queste ce ne erano molte che erano rientrate dal
Venezuela per godersi i frutti del loro lavoro all’estero, prevedendo quello che sarebbe
accaduto all’agricoltura,invece di investire i loro risparmi comprando terreni, hanno
comprato degli appartamenti, non molto grandi, in città, e parlando di questa zona,
hanno comprato a Salerno, molti, mi ricordo, a Pastena, perché Pastena allora era
periferia e l’appartamento costava meno che al centro. Allora si sentiva molto questa
frase: mi sono comprato un quartino a Salerno. Questo suffisso diminutivo –ino lasciava
già intendere che si trattava di un appartamento di non grande dimensione, ubicato per
lo più in qualche palazzone che, allora come ora, crescevano come funghi (e chi non si
ricorda di quella bella canzone di Adriano Celentano “Il ragazzo della via Gluck”)?
Ebbene questi emigranti rientrati dal Venezuela che investivano nell’acquisto di un
quartino non immaginavano che questo termine fosse di origine spagnola.
5
Infatti quartino deriva dallo spagnolo cuartillo, diminutivo di cuarto, sostantivo che
significa appartamento, abitazione o anche stanza. Anche in portoghese quarto significa
stanza, camera, vano.
Collegato alla casa, all’abbellimento della casa, troviamo un altro termine, riggiola. Le
riggiole erano presenti solo nelle case dei ricchi e non nelle misere abitazioni dei
contadini o degli artigiani. La riggiola infatti indicava la piastrella maiolicata e dopo, in
un secondo momento, ha preso anche il significato più modesto di piastrella di
terracotta per pavimentazione. Riggiola deriva dallo spagnolo rajola / rejola, termine
che ora in Spagna è caduto in disuso.
Ora, se mi si permette, vorrei andare a qualche ricordo di carattere personale. Mio padre
faceva il sarto, e della terminologia dialettale connessa a questo mestiere ho visto che ci
sono per lo meno un paio di parole di origine iberica. La prima è ciappa, con il suo
diminutivo ciappetta, col significati di “fermaglio, gancio”. Il termine ciappa riflette
foneticamente lo spagnolo chapa, avendo preso la grafia italiana con il raddoppiamento
della p (il raddoppiamento della consonante è tipico dei dialetti meridionali,
contrariamente a quanto accade, per esempio, nel dialetto veneto, dove la consonante è
quasi sempre semplice – uno degli errori dei bambini italiani meridionali è, per
esempio, scrivere le parole che terminano in –zione con la doppia z; il classico esempio
è eccezzione con la doppia z).
Chapa in spagnolo ha moltissimi significati.
Vorrei soltanto far notare una cosa: in napoletano la frase ommo cu’ ‘e ciappe significa
uomo di vaglia, di prim’ordine; lo spagnolo hombre de chapa significa uomo serio,
assennato, giudizioso.
Si usava ciappa anche per indicare il punto di sutura chirurgico dopo un intervento.
Il secondo termine è capisciola, dallo spagnolo capichola (mentre il suono affricato
sordo palatale cha della parola chapa spagnola si è mantenuto in dialetto – ciappa – qua
il suono affricato sordo palatale cho (chapicola) in dialetto si è trasformato in un suono
fricativo sordo palatale scio (capisciola). In spagnolo capichola indica un tessuto di seta
grossolano, un tessuto di seta a cordonetto, una specie di filato di rete stracciato; se ben
ricordo capisciola in dialetto significa una semplice striscia di tessuto per legare qualche
cosa, per esempio un sacco, un fagotto, o per stringere un pezzo di tessuto usato per
arginare la fuoruscita di sangue da una ferita di un dito.
E siccome tutte le cose belle terminano a tavola, vorrei terminare queste mie righe con
un termine di culinaria. Il termine spagnolo è escabeche, usato anche in portoghese. Che
cosa è l’escabeche? È una salsa di condimenti soffritti per pesce fritto ed include, fra
l’altro, cipolle, pomodori, olio d’oliva, aceto, alloro. La locuzione avverbiale dialettale a
scapece significa appunto il modo di condire un certo tipo di piatto, che può essere
pesce, zucchine o qualcos’altro con questa salsa. Io non me ne intendo di culinaria; è
possibile che qualche ingrediente si sia perso per strada dalla Spagna a Napoli o che in
Italia ne sia stato aggiunto qualcun altro che originariamente non c’era, ma la ricetta
basica è sostanzialmente la stessa.
GIUSEPPE MEA
6