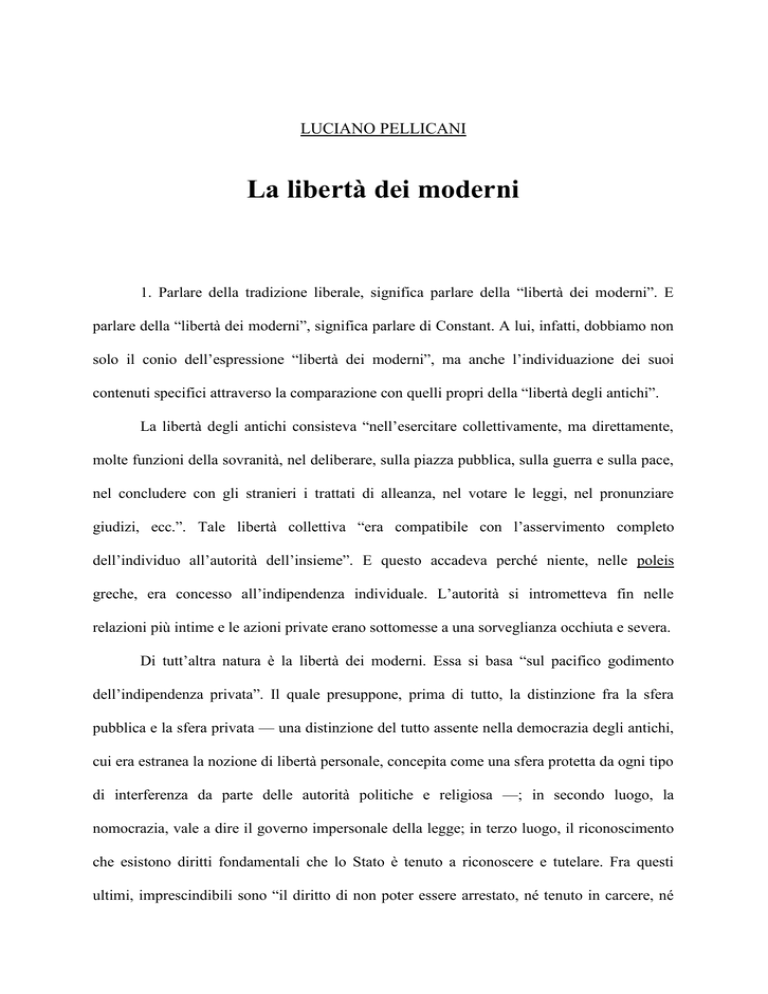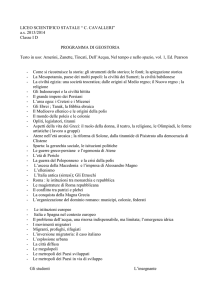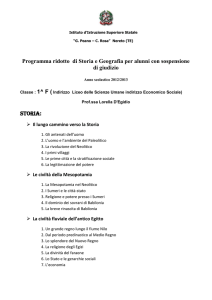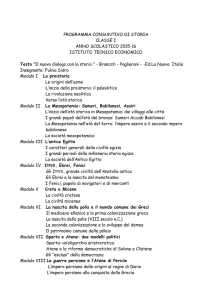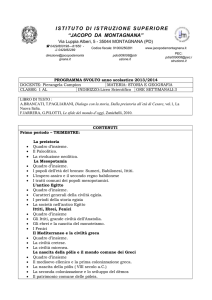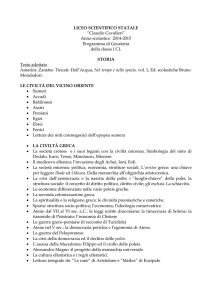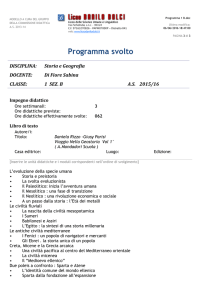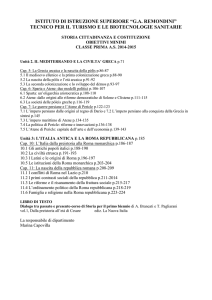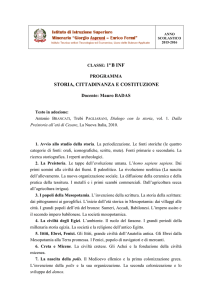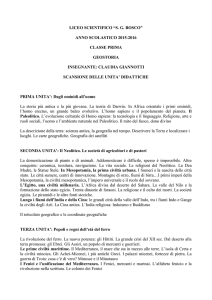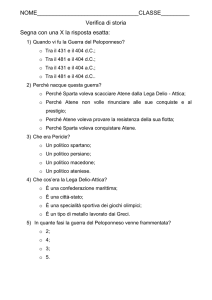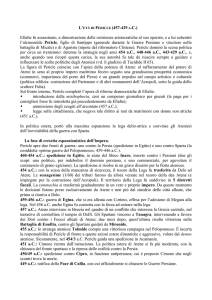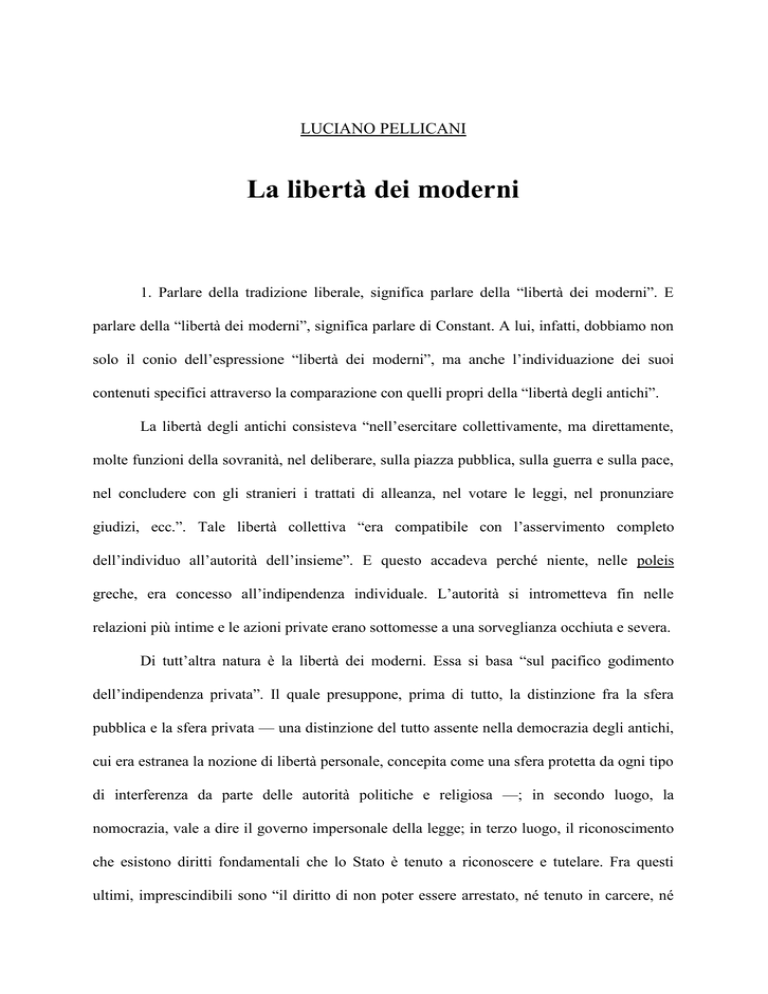
LUCIANO PELLICANI
La libertà dei moderni
1. Parlare della tradizione liberale, significa parlare della “libertà dei moderni”. E
parlare della “libertà dei moderni”, significa parlare di Constant. A lui, infatti, dobbiamo non
solo il conio dell’espressione “libertà dei moderni”, ma anche l’individuazione dei suoi
contenuti specifici attraverso la comparazione con quelli propri della “libertà degli antichi”.
La libertà degli antichi consisteva “nell’esercitare collettivamente, ma direttamente,
molte funzioni della sovranità, nel deliberare, sulla piazza pubblica, sulla guerra e sulla pace,
nel concludere con gli stranieri i trattati di alleanza, nel votare le leggi, nel pronunziare
giudizi, ecc.”. Tale libertà collettiva “era compatibile con l’asservimento completo
dell’individuo all’autorità dell’insieme”. E questo accadeva perché niente, nelle poleis
greche, era concesso all’indipendenza individuale. L’autorità si intrometteva fin nelle
relazioni più intime e le azioni private erano sottomesse a una sorveglianza occhiuta e severa.
Di tutt’altra natura è la libertà dei moderni. Essa si basa “sul pacifico godimento
dell’indipendenza privata”. Il quale presuppone, prima di tutto, la distinzione fra la sfera
pubblica e la sfera privata — una distinzione del tutto assente nella democrazia degli antichi,
cui era estranea la nozione di libertà personale, concepita come una sfera protetta da ogni tipo
di interferenza da parte delle autorità politiche e religiosa —; in secondo luogo, la
nomocrazia, vale a dire il governo impersonale della legge; in terzo luogo, il riconoscimento
che esistono diritti fondamentali che lo Stato è tenuto a riconoscere e tutelare. Fra questi
ultimi, imprescindibili sono “il diritto di non poter essere arrestato, né tenuto in carcere, né
condannato a morte, né maltrattato in alcun altro modo, a causa della volontà arbitraria di uno
o più individui; ... il diritto di esprimere la propria opinione, di scegliere il proprio lavoro e di
esercitarlo; di disporre della propria proprietà e perfino di abusarne; ... il diritto di unirsi con
altri individui, sia per ragione dei propri interessi, sia per professare il culto che l’individuo
preferisce;… il diritto, per ognuno, di esercitare la propria influenza sull’amministrazione del
governo, sia concorrendo alla nomina di tutti o di alcuni dei funzionari, sia con rimostranze,
petizioni, domande, che l’autorità è in qualche modo obbligata a prendere in considerazione”.
Ma Constant non si è limitato a distinguere con insuperata precisione la libertà dei
moderni — vale a dire la libertà liberale — dalla libertà degli antichi. Ha avanzato anche una
spiegazione sociologica della genesi delle due libertà.
La libertà degli antichi era strettamente legata a una specifica situazione storica,
caratterizzata dalla guerra permanente fra le poleis. Donde l’identificazione del cittadino con
il soldato, con tutte le sue inevitabili conseguenze: la militarizzazione degli spiriti, la
disciplina draconiana, l’assorbimento dell’individuo nel gruppo, ecc. Insomma, le poleis
erano organizzate come gigantesche caserme. E lo erano precisamente perché nella Grecia
antica tutto era dominato da Polemos e dai suoi tirannici imperativi funzionali. Esempio
estremo e paradigmatico al tempo stesso: Sparta; dove, per l’appunto, ogni cosa fisica e
morale era subordinata, scientemente e programmaticamente, alle esigenze della guerra
permanente, con il risultato che ai “liberi cittadini” fu imposta una corazza istituzionale dalla
quale non potevano uscire.
Di tutt’altra natura è il contesto entro cui ha preso forma la libertà dei moderni.
Mentre nei tempi antichi — scrive Constant — l’acquisizione delle risorse scarse avveniva, di
regola, ricorrendo alla forza, nei tempi moderni il pacifico commercio è riuscito a sostituire la
guerra; e ciò ha progressivamente modificato la cultura dei popoli europei a motivo di una
“virtù” che è inerente al commercio medesimo. Infatti, “il commercio ispira agli uomini un
intenso amore per la libertà individuale, Il commercio provvede ai loro bisogni, soddisfa i
loro desideri, senza l’intervento dell’autorità” . In tal modo, è nato un tipo antropologico — il
borghese — ben diverso dal cittadino-soldato; un tipo antropologico tutto orientato verso il
pacifico godimento dei frutti della sua intraprendenza e che mal tollera ogni interferenza
dello Stato nei suoi affari. Utilizzando il lessico di Marx, ciò equivale a dire che la “base
materiale” della libertà liberale è la società borghese, la “società dell’industria, della
concorrenza generale, degli interessi privati perseguenti liberamente i loro fini” ; dunque, la
società centrata sul mercato e sulle sue istituzioni fondamentali: la proprietà privata, il
contratto, le guarentigie giuridiche poste a protezione della libera iniziativa in tutti i campi. Il
che significa che è stato il primato del commercio che ha fatto emergere un tipo di
organizzazione sociale — la società borghese — entro la quale è nata e si è sviluppata la
libertà liberale. E significa altresì che, su questo specifico punto, la posizione di Marx non è
molto distante da quella di Constant: per entrambi infatti, la libertà liberale si è presentata
sulla scena legata indissolubilmente alla società borghese; e la società borghese, a sua volta, è
legata al riconoscimento dei diritti dell’uomo da parte dello Stato. Tant’è che nella Sacra
famiglia Marx descrive lo Stato moderno come lo Stato che, proclamando i “diritti universali
dell’uomo”, riconosce che la sua “base naturale” è la “società civile, l’uomo della società
civile, cioè l’uomo indipendente” .
2. Prima di esaminare le condizioni strutturali che hanno reso possibile, nell’Europa
occidentale, la formazione della società borghese, senza cui la libertà liberale non avrebbe
potuto né attecchire né, tanto meno, crescere, conviene ricordare che il discorso di Constant si
inserisce nel grande dibattito che aveva diviso l’intellighenzia francese nel secolo dei Lumi: il
dibattito su Sparta e Atene. Si tratta di un dibattito la cui importanza non verrà mai
sufficientemente sottolineata, In esso, infatti, troviamo i grandi temi etico-politici — la
libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, ecc. — e le opzioni fondamentali che, a partire dalla
Rivoluzione
francese,
sfoceranno
nello
scontro
che
ha
così
profondamente
e
drammaticamente segnato l’esistenza storica dell’Europa: lo scontro fra la democrazia
liberale e la democrazia totalitaria . Indossando il mantello di Licurgo o quello di Solone, i
philosophes si schierarono pro o contro la civiltà moderna. Tant’è che è stato giustamente
osservato che l’Atene di quel dibattito altro non era, a ben guardare, che Parigi. Di qui il fatto
che gli estimatori della società borghese, con in testa Voltaire, si dichiararono “ateniesi” e
accusarono Rousseau e tutti gli altri partigiani di Sparta di essere ostili alla civiltà moderna e
alla libertà individuale .
Constant si schiera con la massima decisione dalla parte di Atene. Atene, davanti al
suo sguardo, rappresenta la prima incarnazione storica della libertà dei moderni. A tal punto,
che egli non esita a sostenere che Atene fu, a petto delle altre poleis e massimamente di
Sparta, una realtà sui generis, una vera e propria anomalia sociologica. Infatti, nel celebre
discorso del 1819 leggiamo: “Di tutti gli Stati antichi, Atene è quello che più rassomigliò ai
moderni, In tutti gli altri, la giurisdizione sociale era illimitata. Gli antichi come diceva
Condorcet, non avevano alcuna nozione dei diritti individuali. Gli uomini non erano, per così
dire, che delle macchine di cui la legge regolava le molle e faceva scattare i consegni. Lo
stesso asservimento caratterizzava l’epoca d’oro della Repubblica romana; l’individuo si era
in qualche modo perduto nella nazione, il cittadino nella città”. Ma ad Atene le cose si
svolgevano diversamente. In quella città, la libertà dei moderni, la libertà personale come
“tempio sacro”, non era affatto sconosciuta. Anzi, quanto meno nell’età di Pericle, essa era
riuscita a germogliare in forme molto simili a quelle che avrebbe assunto nell’Europa
occidentale e negli Stati Uniti. E ciò era accaduto in quanto — è sempre Constant che parla
— “il commercio aveva fatto sparire presso gli Ateniesi molte di quelle differenze che
distinguono i popoli antichi dai popoli moderni. Lo spirito dei commercianti di Atene era
simile a quello dei commercianti dei giorni nostri.” . Era dominato dal calcolo e da un
“estremo amore per l’indipendenza individuale”. Inoltre, lo spirito borghese aveva intaccato
lo spirito tribale a tal punto che gli Ateniesi mostravano una singolare disponibilità a
conferire i “diritti di cittadinanza a chiunque, trasferendosi presso di loro con la sua famiglia,
iniziasse un mestiere o impiantasse una fabbrica”.
Come si vede, è falso dire che Constant abbia affermato che gli antichi non conobbero
la libertà liberale. Nel discorso del 1819 troviamo l’esplicito riconoscimento che ci fu quanto
meno una polis che riuscì a pensarla e a istituzionalizzarla: l’Atene di Pericle. Né si può dire
che l’analisi di Constant costituisca una distorsione ideologica della realtà storica.
Già dovrebbe essere sufficiente la lettura del celebre Epitafio di Pericle per toccare
con mano che gli Ateniesi coltivarono un ideale di libertà molto simile a quello della
tradizione liberale. La “scuola dell’Ellade” vi è descritta come una città “aperta a tutti” dove
vige il più scrupoloso rispetto della legalità e ai cittadini è garantito, “nelle private
controversie, uguale trattamento”, così come è garantito l’accesso alle cariche pubbliche in
base al merito; in aggiunta, si sottolinea con orgoglio che i cittadini di Atene, a differenza di
quello che accadeva nelle altre poleis, potevano vivere “in piena libertà” curandosi “nello
stesso tempo e dei loro interessi privati e delle questioni pubbliche”; e potevano altresì
“rendere la propria persona adatta alle più svariate attività”.
Fra le “svariate attività” alle quali potevano liberamente dedicarsi gli Ateniesi, quelle
commerciali ebbero un posto così grande da indurre Karl Polanyi a scrivere che, capire la
democrazia ateniese, “vuoi dire capire il posto che vi occupò il mercato” e che non si può
intendere l’originalità di tale democrazia se non si tiene costantemente presente un fatto di
“importanza cruciale”, e cioè che “Pericle abbracciò la causa dell’umile istituzione del
mercato”. In effetti, mille indizi suggeriscono che, a partire dal momento in cui Atene
divenne il “centro di un mercato universale” dove regnavano sovrane la legge e la libera
iniziativa, il “lato economico della vita finì per sopraffare quello politico” e il “denaro
divenne sempre più il centro dell’esistenza , con grande disappunto degli aristocratici; i
quali, in aggiunta, dovettero assistere, impotenti e pieni di rancore, all’ascesa al pieno potere
politico della borghesia, poiché — come si legge in un frammento dell’Eolo di Euripide —
“la ricchezza sollevava gli uomini peggiori ponendoli fra i più elevati”. Gli aristocratici
dovettero anche assistere alla democratizzazione e alla metamorfosi dell’areté, un tempo
ritenuta “accessibile a coloro soltanto che l’avevano nel loro sangue divino. Nell’Atene di
Pericle, grazie al fatto che, come ci informa Platone, “tutti godevano della maggior libertà di
parola” e che si era formato un ampio mercato dei libri e degli educatori l’areté divenne un
bene a disposizione della nuova classe egemone: l’aristocrazia del denaro. C’è di più: con il
predominio dell’economia di mercato, si verificò il “declino dello spirito militare e il
graduale scomparire del cittadino-soldato. Un nuovo tipo cominciò a predominare, un tipo
certamente non ignoto ai nostri giorni, il tipo dell’uomo che desidera soltanto la vita
tranquilla e la prosperità dei suoi affari”. E questo, come era logico che accadesse, portò
all’affermazione della “pari dignità del pubblico e del privato” e alla “valutazione positiva
dell’iniziativa individuale” e delle attività produttive. E portò parimenti alla elaborazione di
“una filosofia del diritto alla felicità nella libertà, in un clima di eguaglianza formale per tutti
dove la legge era sovrana nel garantire a ciascuno quella che oggi diremmo la libera
esplicazione della propria personalità”.
Da tutto ciò risulta in termini sufficientemente chiari che Constant aveva colto nel
segno quando indicava nell’Atene di Pericle il luogo genetico della libertà dei moderni. E
risulta altresì che Popper aveva ragione nel descrivere il conflitto fra Sparta e Atene come il
conflitto fra la “società chiusa” e la “società aperta”. Due modelli di organizzazione sociale si
confrontarono e si scontrarono durante la guerra del Peloponneso: la caserma spartana e il
mercato ateniese, la società collettivistica e la società individualistica, la libertà degli antichi
e la libertà dei moderni. Ciò è tanto vero che uno dei più autorevoli studiosi della civiltà greca
ha così commentato la concezione periclea della democrazia: “La libertà di comportamento
fu il tratto distintivo della spiritualità ateniese. Contrapponendola nel modo più netto a
Sparta, Pericle rivelò che Atene non voleva essere uno Stato militare, in cui tutta la vita del
singolo era costretta all’addestramento livellatore della caserma... Lo spirito di libertà
dominava tutta la vita cittadina. Atene disdegnava parimenti di chiudersi agli influssi degli
stranieri e anche all’interno non conosceva controlli e tutele o inutili intromissioni nella vita
privata. Lo Stato lasciva libero ogni cittadino di regolare la sua personale esistenza secondo i
propri gusti... Per la prima volta nella storia universale non solo venne riconosciuto il diritto
dell’individuo a una vita privata all’interno della comunità, la il libero sviluppo della
personalità fu addirittura iscritto fra i fini dello Stato... Nell’Atene di Pericle, all’ideale del
governo del popolo, s’intrecciò il principio fondamentale del liberalismo moderno, che cioè
ciascun cittadino, all’interno dell’organismo statale, deve conservare la libertà di pensare e di
agire autonomamente e di manifestare con franchezza la propria opinione, mentre lo Stato ha
da immischiarsi quanto meno nella vita privata dei singoli”.
3.L’esito della guerra del Peloponneso ebbe conseguenze catastrofiche per il primo
esperimento di “società aperta” che sia stato mai compiuto, anche se non tutto di quella
straordinaria esperienza, andò perduto. La filosofia, nata nelle colonie greche ed emigrata con
i sofisti ad Atene sopravvisse e, diventata la “tradizione dell’antitradizione", continuò in
qualche modo a “lavorare” con il suo spirito critico la civiltà occidentale. Ma non sopravvisse
la libertà cittadina,
“scomparsa a favore di un Impero mondiale organizzato
burocraticamente, nel cui ambito non v’era posto per il capitalismo politico”. Bisognerà
attendere il Basso Medioevo per assistere alla rinascita della società borghese.
Tale rinascita iniziò con la riapparizione sulla scena della figura della città-stato, la
quale modificò il panorama dell’Europa occidentale a tal punto da indurre Toynbee a scrivere
che “uno osservatore straniero che avesse studiato la Cristianità occidentale in qualunque data
a partire dall’inizio del XII secolo fino a tutto il XIV avrebbe potuto pronosticare che la
struttura politica della Cristianità occidentale si avviava ad essere una riproduzione della
struttura del mondo greco-romano” Con una precisazione: che le nuove città-stato che presero
a coprire a macchia di leopardo l’Europa occidentale erano città-mercato. Nate dalla
rivoluzione comunale, esse divennero, per usare una felice immagine di Alfred Weber, le
“crisalidi del primo capitalismo”. Ora, dire capitalismo significa dire tutta una serie di
condizioni politico-giuridiche senza le quali l’economia di mercato non può né crescere, né,
tanto meno, svilupparsi. Tali condizioni coincidono, almeno in parte, con la costellazione di
diritti che, come abbiamo visto, Constant considerava costitutivi della libertà dei moderni,
primi fra tutti i diritti di proprietà.
L’istituzionalizzazione dei diritti di proprietà dei sudditi è la chiave per intendere la
singolare curvatura che ha assunto la parabola della civiltà occidentale a partire dalla
rivoluzione comunale. Grazie ad essa, infatti, sono emersi, per tappe successive e attraverso
una infinita teoria di conflitti di interessi e di valori, due fenomeni di enorme importanza
storica: la rivoluzione permanente capitalistica e la formazione della società dei cittadini. Ciò
risulta con la massima evidenza una volta che si confronti la condizione dei sudditi
dell’Europa medievale con quella dei sudditi del mondo islamico.
Nel XII secolo il viaggiatore andaluso lbn Jubair visitò la Palestina. Dopo essersi
compiaciuto della superiorità della civiltà alla quale egli apparteneva — un compiacimento,
sia detto per inciso, tutt’altro che ingiustificato, dal momento che non c’era una sfera
culturale nella quale i musulmani non erano all’avanguardia —, lbn Jubair non poté non
constatare che i suoi correligionari, a dispetto del fatto che la Sharia proibiva esplicitamente
di vivere in una terra dominata dagli infedeli, preferivano essere governati dai Franchi a
motivo della “loro equità”, La cosa, naturalmente, molto ferì l’orgoglio del musulmano lbn
Jubair. Ma, d’altra parte, come avrebbe potuto essere diversamente? Infatti, nel Dar al-Islam,
la proprietà dei sudditi era sottoposta a tali vessazioni che il dominio degli infedeli non
poteva non sembrare, agli Arabi della Palestina, il “regno della giustizia”. Il principio sul
quale era nati e si erano consolidati gli Stati islamici era quello esplicitamente formulato dal
celebre visir Nizam-al-Mulk nel suo Syaset-Name: “Il suolo del regno e i suoi abitanti
appartengono al sultano”. Sicché, il sultano, “ombra di Dio sulla terra”, poteva disporre a suo
piacimento dei beni dei sudditi, i quali, sia in punto di principio che in punto di fatto, non
erano altro che concessioni, revocabili à merci. E, in effetti il ministero delle finanze degli
Stati musulmani operava — giusta l’efficace definizione di Engels — come un “ministero del
saccheggio”. La brutalità con la quale i sudditi venivano spogliati dei loro averi non aveva
limiti. “Le vergate, la gogna, l’incarcerazione, le catene — si legge nell’opera di uno storico
musulmano del XIV secolo” dedicata al Sultanato di Delhi —, erano tutti validi mezzi per
ottenere il pagamento. E se i contadini, disperati, abbandonavano i loro villaggi, le “autorità
davano loro la caccia come se si trattasse di selvaggina”. Quanto ai mercanti e agli artigiani,
essi ricorrevano a mille espedienti per occultare i loro beni; il che, per altro, non era
sufficiente per metterli al riparo da quella che era la regola generale del sultanismo: “Il visir
confiscava la proprietà del governatore che cadeva in disgrazia... e il governatore si
appropriava dei beni degli ufficiali inferiori e dei privati cittadini”. Evidentemente,
Montesquieu non esagerava quando descriveva il dispotismo orientale come il regno
dell’arbitrio e della paura.
Le conseguenze, catastrofiche sotto tutti i punti di vista, della totale assenza di
garanzie poste a tutela dei beni dei sudditi sono state illustrate come meglio non si potrebbe
da lbn Khaldun. “Vessare la proprietà privata — si legge nella Muqqadima —, significa
uccidere negli uomini la volontà di guadagnare di più, riducendoli a temere che la spoliazione
è la conclusione dei loro sforzi. Una volta privati della speranza di guadagnare, essi non si
prodigheranno più. Gli attentati alla proprietà privata fanno crescere il loro avvilimento. Se
essi sono universali e se investono tutti i mezzi di sussistenza, allora la stagnazione degli
affari è generale, a causa della scomparsa di ogni incentivo a lavorare. Al contrario, a lievi
attentati alla proprietà privata corrisponderà un lieve arresto del lavoro. Poiché la civiltà, il
benessere e la proprietà pubblica dipendono dalla produttività e dagli sforzi che compiono gli
uomini, in tutte le direzioni, nel loro proprio interesse e per il loro profitto. Quando gli
uomini non lavorano più per guadagnare la loro vita e cessa ogni attività lucrativa, la civiltà
materiale deperisce e ogni cosa va di male in peggio. Gli uomini per trovare lavoro si
disperdono all’estero. La popolazione si riduce. Il Paese si svuota e le sue città cadono in
rovina. La disintegrazione della civiltà coinvolge quella dello Stato, come ogni alterazione
della materia è seguita” dall’alterazione della forma.
Stando così le cose, non può certo sorprendere il fatto che la civiltà islamica sia
scivolata, lentamente ma inesorabilmente, nel pantano della stagnazione; né, tanto meno, il
fatto, di segno opposto, che, a partire dal XII secolo, l’Europa occidentale abbia iniziato la
marcia che l’avrebbe portata a costruire e mettere in moto la macchina dello sviluppo
economico, scientifico e tecnologico e a creare la prima — e, per ora, l’unica — civiltà dei
diritti e delle libertà. Come ha riconosciuto uno storico arabo contemporaneo, già all’epoca
delle Crociate, l’Europa era diventata una “società distributrice di diritti”. Certamente, la
nozione di cittadino non esisteva ancora, ma i signori feudali, i cavalieri, il clero, l’università,
i borghesi e persino i contadini avevano tutti dei diritti ben stabiliti. Nell’Oriente arabo, la
procedura dei tribunali era più razionale; tuttavia, non c’era alcun limite al potere arbitrario
del Principe. Lo sviluppo delle città mercantili, come l’evoluzione delle idee, non poteva non
essere ritardato”. Insomma, a dispetto della generale arretratezza in cui si trovava, l’Europa
medievale aveva un enorme vantaggio a petto della civiltà islamica: quello di essere riuscita
ad istituzionalizzare tutta una serie di contro-poteri che limitavano l’autorità del Principe e
che garantivano, in vario modo e in varia misura, i diritti dei sudditi. Fra i quali, di
importanza fondamentale furono — conviene ripeterlo — i diritti di proprietà. Non a caso,
già a partire da Guglielmo d’Ockham, non c’è pensatore politico occidentale — unica
eccezione: Hobbes — che non insista sul concetto che, ove il Principe non rispetti i diritti di
proprietà, cessa di essere un sovrano legittimo e si trasforma in un tiranno o in un despota.
Persino un campione dell’assolutismo, quale fu Bossuet, proclamò essere la proprietà privata
“sacra e inviolabile”.
4.Quando ci si interroga sulle cause che hanno permesso all’Europa occidentale di
sfuggire alla “trappola dispotica”, non si può non vedere “nell’anarchia feudale” il fattore
decisivo. Fu l’assenza di quella che Lewis Mumford ha chiamato la Megamacchina ciò che
rese possibile la nascita e il consolidamento delle città-mercato. Grazie a queste “isole
borghesi in mari feudali”, emerse uno dei tratti più caratteristici della struttura della società
europea: il pluralismo politico-economico. Certo, a partire dalla costruzione degli Stati
nazionali, buona parte delle città borghesi dovettero piegare la testa davanti ai monarchi. Ma,
come ha recentemente sottolineato Finer nella sua monumentale storia dei regimi politici, i
sovrani europei “non operarono su una tabula rasa”. Al contrario, si trovarono di fronte una
intricata selva di autonomie, di corpi intermedi e di interessi solidamente costituiti che
impedirono loro di diventare ciò che pure desideravano essere: padroni, legibus soluti, dei
popoli sui quali regnavano. La concentrazione del potere nelle loro mani fu notevole, ma non
tale da giustificare la qualifica di sovrani assoluti, che pure è stata loro attribuita. Tant’è che
uno storico contemporaneo non ha esitato ad affermare che il loro assolutismo “fu solo una
aspirazione”, non già una realtà effettiva. E questo perché — come si può leggere nel Saggio
sui costumi di Voltaire — “in Europa ogni provincia, ogni città aveva i suoi privilegi. I
signori feudali combattevano spesso questi privilegi, e i re cercavano parimenti di sottoporre
alla loro potenza i signori feudali e le città. Ma nessuno vi riuscì”. Di qui il fatto che, anche
all’epoca del così detto assolutismo, l’esistenza storica dell’Europa occidentale è stata
caratterizzata dalla dialettica “Stato-società civile”. Lo è stata a tal punto che Lorenz von
Stein è giunto ad interpretare la storia della civiltà occidentale come una “lotta ininterrotta
dello Stato con la società e della società con lo Stato”.
Ora, è proprio dalla dialettica “Stato-società civile” che è emersa la tradizione
liberale, cioè a dire quella tradizione di pensiero e di ingegneria istituzionale animata
dall’idea che i cittadini hanno diritti inalienabili, che i governanti sono tenuti a riconoscere e
a rispettare, esercitando la loro autorità entro il perimetro disegnato dalle leggi e dalla
Costituzione. Fra tali diritti, quelli concernenti la proprietà dei mezzi di produzione hanno
svclto — e svolgono — un ruolo di decisiva importanza. La ragione di ciò risulterà di
evidenza solare una volta che si tenga presente che i mezzi di produzione sono — giusta la
definizione coniata da Marx — le “sorgenti della vita”. Il loro controllo, pertanto, significa il
controllo della vita. Il quale diventa totale e senza scampo se i mezzi di produzione sono
concentrati nelle mani di un unico soggetto. E’ per questo che Proudhon, partito dalla
convinzione che la proprietà privata era un furto, giunse alla conclusione opposta, e cioè che
la proprietà privata era la libertà, così argomentando: “Lo Stato costituito nella forma più
razionale e più liberale e animato dalle intenzioni più giuste è anch’esso una grande potenza
capace di schiacciare tutto intorno a sé, ove non gli si ponga un contrappeso. E quale può
essere questo contrappeso? Lo Stato deriva tutta la sua potenza dalla adesione dei cittadini.
Lo Stato è la riunione degli interessi generali appoggiati dalla volontà generale e servita, al
bisogno, da concorso di tutte le forze individuali. Dove trovare una potenza capace di
controbilanciare questa formidabile potenza dello Stato? Non v’è che la proprietà.... Servire
da contrappeso al Potere pubblico, bilanciare lo stato e in questo modo assicurare la libertà
individuale: tale sarà, dunque, nel sistema politico, la funzione principale della proprietà”.
Alla luce delle parole di Proudhon, si capisce perché tutti i teorici liberali da Locke a
Constant, abbiano tanto insistito sul nesso “libertà-proprietà privata”. Ma si capisce anche
perché il liberalismo, a partire dalla seconda Rivoluzione francese — quella giacobina —, sia
stato contestato frontalmente in nome dell’eguaglianza sostanziale e della universalizzazione
dei diritti di cittadinanza. Il primo liberalismo fu, in effetti, il credo di emancipazione della
borghesia. Nacque classista proprio in quanto identificò la figura del cittadino con il
proprietario. Sul punto, la prosa di Constant è di una franchezza offensiva. “La proprietà sola
— si legge nei suoi Principes de politicue, recentemente pubblicati — rende gli uomini
capaci di esercitare i diritti politici. Solo i proprietari possono essere cittadini”. Ergo: la
massa dei non-proprietari, vale a dire la stragrande maggioranza della popolazione, doveva
essere esclusa dalla fruizione dei diritti politici e tenuta debitamente distante dal processo
decisionale, poiché — è sempre Constant che parla — “quando i non-proprietari hanno dei
diritti politici, accade una di queste tre cose: o non traggono impulso che da se stessi e allora
distruggono la società, o la traggono dall’uomo o dagli uomini al potere e sono strumenti di
tirannide, o lo traggono da coloro che aspirano al potere e sono strumenti di una fazione”.
Ciò che sfuggiva completamente a Constant era che, una volta proclamata l’idea “dei
diritti individuali, indipendenti dalla società”, essa non tollerava esclusioni di sorta. Era
un’idea a vocazione universalistica, che non poteva essere limitata a una classe privilegiata;
un’idea che esigeva una organizzazione della società e dello Stato tale da garantire a tutti gli
uomini, quale che fosse la loro condizione economico-sociale, quanto meno la fruizione di
alcuni diritti fondamentali.
E, in effetti, questo è stato, a partire dalla costituzione del movimento operaio e
socialista, il grande problema che ha travagliato l’Europa per generazioni e generazioni.
Attraverso un drammatico processo di selezione storica, due sono state le soluzioni saggiate:
quella rivoluzionaria e quella riformista.
La prima è risultata affatto incompatibile con la libertà dei moderni. E’ accaduto ciò
che aveva lucidamente previsto Max Weber. L’abolizione della proprietà privata e del
mercato ha reciso alla radice la ratio e, con essa, la possibilità stessa di una economia
autopropulsiva. Al suo posto, è sorta una versione aggiornata dell’oikos, vale a dire
un’economia naturale, condannata ad operare sulla base di “sentenze dittatoriali regolanti
univocamente il consumo”. Inoltre, come logica conseguenza della socializzazione integrale
dei mezzi di produzione, è sorta “la dittatura dell’impiegato non quella dell’operaio” in
quanto la sostituzione della “mano invisibile” del mercato con la “mano visibile” dello Stato
onniproprietario è sfociata nella restaurazione della “gabbia d’acciaio”. Né si può dire che la
restaurazione della “gabbia d’acciaio” sia stata una conseguenza non voluta della Rivoluzione
bolscevica. Tutto il contrario: la distruzione totale della società civile, attuata attraverso una
guerra di spietato sterminio contro la borghesia e i coltivatori diretti, fu “scientificamente”
pianificata in omaggio all’idea che mercato e comunismo erano realtà inconciliabili. Tant’è
che, all’indomani della collettivizzazione delle campagne, Bucharin osservò compiaciuto:
”Lo Stato nel nostro Paese non è affatto separato dalla società civile da una muraglia cinese:
l’uno trapassa nell’altra e le innumerevoli — e anche molto ampie — organizzazioni della
nostra società civile sono, da un certo punto di vista, organi periferici dello Stato. Infatti, nel
nostro Paese lo Stato è sociale e la società civile è statale. Fra loro c’è differenza... Ma nello
stesso tempo fra di loro c’è anche unità, ed è prima di tutto unità di scopo. Per questo la
Costituzione non ammette altri partiti politici: essa si basa sul principio che la questione su
dove andare (indietro, verso il capitalismo, o avanti, verso il comunismo) non può essere
oggetto di discussione”.
Neanche si può dire che il bolscevismo abbia tradito l’originario progetto di Marx. E
questo perché in Marx non solo si trova, ripetuta mille e una volta, l’idea che la costruzione
del socialismo esige “l’abolizione della proprietà privata” e “l’accentramento di tutti gli
strumenti di produzione nelle mani dello Stato”; si trova anche una condanna senza appello
della libertà dei moderni. Nella Questione ebraica, Marx apre “un vero e proprio abisso fra
liberalismo e socialismo”, così argomentando. Che cosa sono i diritti dell’uomo e del
cittadino, solennemente proclamati dalla Rivoluzione francese, se non “i diritti del membro
della società civile, cioè dell’uomo egoista, dell’uomo separato dall’uomo e dalla comunità”?
E che cosa è la libertà liberale, se non la “libertà dell’uomo in quanto monade isolata e
ripiegata su se stessa”? E qual è mai lo scopo delle guarentigie giuridiche, se non quello di
proteggere con l’usbergo della legge l’egoismo del borghese? “Nessuno dei così detti diritti
dell’uomo — incalza Marx — oltrepassa l’uomo egoista, l’uomo in quanto è membro della
società civile, cioè dell’individuo ripiegato su se stesso, sul suo interesse privato e sul suo
arbitrio privato, e isolato dalla comunità”. La stessa emancipazione della società civile —
rarissimo esempio di inversione della marcia verso la schiavitù iniziata con la nascita dello
Stato — è vista da Marx come il trionfo dell”’egoista indipendente”, quindi come corruzione
morale e alienazione.
Alla luce del devastante attacco alla libertà dei moderni condotto dal giovane Marx,
non può certo sorprendere il fatto che nel Manifesto si inciti il proletariato a “distruggere tutte
le sicurezze private e le guarentigie private finora esistite”, cioè a dire a fare tabula rasa dello
Stato di diritto. Difficile immaginare un programma più reazionario di quello ideato da Marx
e realizzato con satanica spietatezza da Lenin e dai suoi diadochi: l’annientamento di tutte le
istituzioni e di tutti i contro-poteri che hanno permesso ai popoli d’Occidente di sfuggire al
terribile destino dei popoli che non hanno conosciuto altra forma di dominio che quella
dispotica.
Di tutt’altra natura è stata la soluzione faticosamente elaborata nel seno della
socialdemocrazia europea. Ai partiti dell’internazionale socialista sono occorsi decenni per
liberarsi dell’accecante fascino esercitato dal messianesimo marxiano. Ma, alla fine, hanno
capito che sopprimere il mercato significa non solo sopprimere la razionalità economica;
significa, anche e soprattutto, sopprimere l’autonomia della società civile a petto dello Stato,
senza la quale l’idea stessa di libertà non è neanche concepibile. E hanno capito che Bernstein
aveva ragione quando, dopo aver sottolineato le grandi potenzialità di sviluppo democratico
proprie delle istituzioni dello Stato moderno, invitava i suoi compagni di lotta a concepire il
socialismo come un movimento di riforme politiche, economiche e sociali, erede legittimo e
continuatore storico del liberalismo. E, in effetti, l’azione riformatrice dei partiti
socialdemocratici ha avuto come fine la socializzazione del mercato, non già, come voleva il
marxismo, la sua soppressione. Istituendo il Welfare State, essi hanno allargato il perimetro
borghese della democrazia liberale e, accanto alle libertà civili e politiche, hanno fatto valere
un tipo di libertà — la libertà dalla soggezione all’indigenza e alle iatture sociali — affatto
estranea alla tradizione liberale classica, tutta centrata sulla figura del cittadino-proprietario.
La democrazia ha così acquistato il significato di teoria e prassi della universalizzazione dei
diritti di cittadinanza. In tal modo, grazie sia alla prodigiosa crescita della ricchezza che
all’energica azione dei “moderni tribuni della plebe” — i sindacati e i partiti operai —, è stato
possibile realizzare l’integrazione positiva del “proletariato interno” della civiltà occidentale
nella Città liberale e lo Stato ha cessato di essere il “comitato d’affari della borghesia”: è
diventato, in qualche misura, una agenzia impegnata a garantire a tutti i membri della
comunità politica quei diritti e quelle libertà un tempo riservati esclusivamente ai cittadiniproprietari.