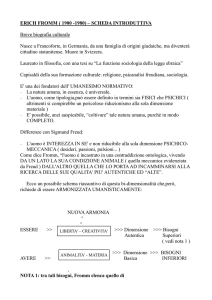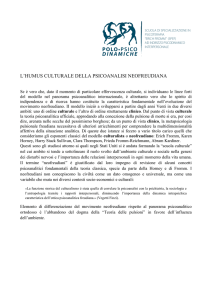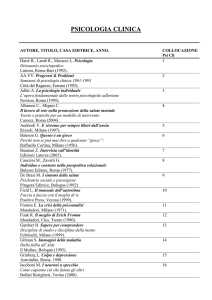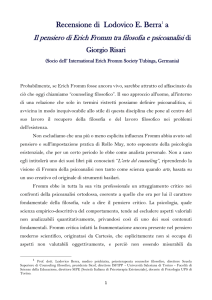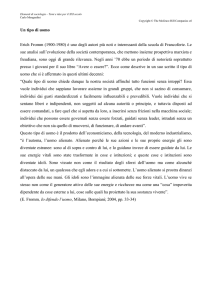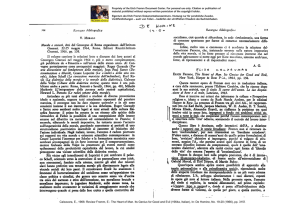Idolatria e lavoro
IDOLATRIA E LAVORO
IL CASO DELL’ILVA DI TARANTO ALLA LUCE DELLE
TEORIE DI ERICH FROMM
Gabriele Anastasio, Chiara Benelli
1. Etimologia della parola “crisi” e sua evoluzione nel Novecento.
L’uomo sta attraversando una crisi in ogni sua capacità e dimensione? E questa crisi è
veramente una delle peggiori mai viste nella storia dell’umanità? Forse ogni periodo storico, proprio
perché nuovo per l’essere umano, lo porta ad una crisi?
Ma qual è il vero significato della parola crisi? Vogliamo prima di tutto soffermarci su questa
parola, spiegando la sua etimologia. Questo vocabolo ormai è entrato nel linguaggio comune e lo si
usa riferito a qualsiasi situazione: grave crisi del sistema economico, crisi di governo,
occupazionale, politica, dell’uomo, della collettività, di coppia, dei valori (anche il Papa si può
concedere l’essere in crisi), crisi climatica, energetica, crisi demografica, insomma una crisi di
dimensione individuale e relazionale, che sembra fare da sostegno alla crisi del sistema del Paese crisi Italia (nel 2001-2002, in riferimento all’Argentina, si è coniato il neologismo Paese – crisi nel
senso di nazione che attraversa momenti particolarmente difficili, soprattutto per quanto riguarda la
situazione economica e finanziaria), dunque una crisi a tutto tondo, la crisi dell’uomo moderno.
Idolatria e lavoro
L'etimologia della parola crisi deriva senza dubbio dal verbo greco krino, che vuol dire
separare, dividere, in senso più lato, discernere, giudicare, valutare. Questo verbo era utilizzato in
riferimento alla trebbiatura, all’ultima fase della raccolta del grano, cioè quando si doveva separare
la granella del frumento dalla paglia e dalla pula (involucro che riveste il chicco di grano). Da qui
deriva il primo significato di separare, ma anche quello traslato di scegliere, come capacità di
giudizio, perciò con una valenza positiva.
Lo slittamento semantico della parola inizia nel XVI secolo, con il significato di “fase della
vita individuale e collettiva particolarmente difficile da superare e suscettibile di sviluppi più o
meno gravi”, significato che sottolinea la sfumatura negativa che il vocabolo avrà soltanto nel
secondo Novecento. Infatti in questo periodo la parola crisi ha come primo significato quello di
cambiamento, ancora inteso in termini positivi. Tuttavia è interessante notare come coesista un’altra
accezione della parola, il significato figurato: “profonda perturbazione nell’esistenza di una persona
che produce effetti più o meno gravi e dolorosi” e “turbamento vasto e profondo nella vita di una
collettività, di un gruppo, di una società, di uno Stato (e anche nella vicenda delle attività spirituali:
arte, letteratura), momento difficile e decisivo che preannuncia e determina mutamenti,
trasformazioni ingenti”. È interessante notare che questo significato figurato, sviluppatosi nel corso
del Novecento, sia presente come prima accezione ai nostri giorni sia a livello soggettivo che
sociale. Questa connotazione, prettamente psicologica, sancisce un ulteriore passaggio del termine
“crisi”, dal significato greco legato alla sua origine agricola ad una risemantizzazione di carattere
psicologico. Tuttavia la parola si lega anche all’ambito economico, soprattutto in seguito al crollo
della borsa di Wall Street del 1929 ed esce fuori una nuova accezione “crisi economica: improvviso
passaggio da una situazione di prosperità economica a uno stato di depressione”.
Si arriva poi ai giorni nostri per avere principalmente due accezioni del termine, una
economica ed una psicologica, che hanno una posizione diversa nei due più importanti Dizionari
Italiani, nel Sabatini-Coletti il significato economico è al primo posto, lasciando al quarto posto
quello psicologico. Al contrario nel Devoto-Oli si ha come significato generale quello psicologico.
Dunque, possiamo dire che la parola “crisi” è passata con gli anni ad indicare una condizione
negativa, in quanto vuole significare un peggioramento, un deterioramento, una incrinatura di una
situazione. Invece possiamo coglierne anche una sfumatura positiva (legata al suo originario
significato) in quanto momento di riflessione, di valutazione, di discernimento, che può trasformarsi
nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, perciò crisi come occasione di
cambiamento, miglioramento, crescita, ripresa, riscatto, riferito al singolo, come alle collettività.
Idolatria e lavoro
Oltre al suo significato originario, che rimandava alla realtà concreta delle cose (la
trebbiatura), la voce è passata attraverso un lento processo di astrazione fino a giungere alle
contemporanee definizioni presenti nei nostri vocabolari.
È comunque presente nel sostrato semantico una idea di evoluzione, delle cose, della
situazione, di una condizione fisica e psichica nel tempo.
Possiamo notare come l’evoluzione negativa sia avvenuta attraverso il Novecento, secolo di
importanti cambiamenti, di tre guerre mondiali, due “calde” e una “fredda”, secolo della Grande
Crisi del 1929, dello scontro di grandi ideologie, come il capitalismo, comunismo e fascismo che
animarono la lotta politica e secolo della valorizzazione delle differenze di genere, infatti irrompe
l’emancipazione sociale e civile della donna.
Insomma il XX secolo è il secolo delle masse, che risentono l’influenza di questi fattori:
crescita sorprendente della popolazione, urbanizzazione, alfabetizzazione, consumismo e taylorismo
(teoria economica dell’organizzazione scientifica del lavoro).
Ma il XX secolo è anche e soprattutto il secolo della psicoanalisi, infatti viene pubblicato nel
1900 L’interpretazione dei sogni di Freud.
Questi concetti hanno potato a collegarci alla crisi dell’uomo moderno spiegata da Erich
Fromm e al concetto positivo di crisi, sintetizzato da Albert Einstein.
Fromm ed Einstein, due importanti uomini del XX secolo, ebrei, costretti a rifugiarsi negli
Stati Uniti, legati a due apparenti differenti discipline, ampliano il loro concetto di crisi, non
rimanendo legati alla loro singola esperienza, ma andando oltre il luogo comune.
Fromm parla di crisi dell’uomo moderno, riferita all’alienazione ed alla burocratizzazione, e
di socialismo umanistico come reazione alla crisi e tentativo di recuperare una dimensione autentica
umana. Egli riesce a fare una analisi dell’interazione tra fattori economici e ideologici. Ma allora
questa crisi è veramente necessaria per salvare l’uomo dalla sua alienazione?
A questa domanda risponderemo più avanti, adesso ci interessa sottolineare come anche nel
XX secolo uno scienziato potesse pensare la parola “crisi” in senso positivo e non fosse influenzato
dall’ evoluzione semantica negativa del termine.
Nel Il mondo come io lo vedo (1931), un testo che raccoglie scritti non strettamente scientifici,
ma riflessioni sui grandi temi della vita, lo scienziato Einstein supera il suo campo di azione per
spaziare negli altri ambiti della conoscenza. Forse anche per questa ragione il suo pensiero è in
grado di parlare all’uomo contemporaneo, testimone di una crisi a 360 gradi, come abbiamo
accennato sopra. In questo testo la parola “crisi” viene definita una “benedizione” e questo a noi,
che ne stiamo vivendo il momento drammatico, suona da subito come provocazione, solo perché
ormai abbiamo dimenticato il suo originario significato: scegliere, giudicare, dal greco krino, con
Idolatria e lavoro
accanto la filosofia hegeliana, in cui le soluzioni che fanno procedere la civiltà costituiscono sempre
l’esito di un conflitto necessario e quindi di una crisi dello status quo.
Einstein, ebreo, sarà costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti in seguito alle leggi razziali,
dunque la sua definizione come “benedizione” non può assumere una connotazione cinica; egli,
quale figura geniale, va oltre il contingente. Riesce a cogliere il significato autentico della parola ed
intendere la crisi come sfida, apertura di opportunità e leva di progresso. Per Einstein il vero
pericolo è attribuire alla crisi la responsabilità dei propri fallimenti e quindi rimanere prigionieri
della propria inattività e questo a scapito del talento, della creatività, della ricerca di vie d’uscita.
L’unica crisi pericolosa diventa allora “la tragedia di non voler lottare per superarla”, come lo
scienziato scrive, dimensione che ci richiama subito l’ignavia descritta da Dante nell’Inferno.
Eccone una breve citazione:
“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse
cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta
progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’
nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi
supera sé stesso senza essere ‘superato’.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e
dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di
uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza
crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere
nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per
tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”.
2. Breve storia dell’Ilva di Taranto, emblema della crisi dell’uomo moderno
Sono ormai alcuni anni che, attraverso i media, siamo bombardati da notizie di un’economia in
crisi. Questa è, in realtà, soltanto lo specchio di una crisi molto più profonda, che coinvolge tutto il
sistema politico, di valori, etico e morale su cui si è fondata la cultura e la società in cui oggi
viviamo o, almeno, tentiamo di sopravvivere.
A differenza di quanto si cerchi di far credere, i segnali del crollo del nostro sistema non sono stati
improvvisi e inattesi, ma arrivano da lontano, come dimostra la profonda attualità che hanno ancora
oggi gli scritti che Fromm ha pubblicato fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso.
Il caso dell’Ilva di Taranto, con tutta la sua drammaticità, è a nostro avviso l’emblema di
questa situazione e l’esemplificazione delle conseguenze inevitabili della malattia socio-culturale su
cui Fromm aveva più volte richiamato l’attenzione.
Idolatria e lavoro
La vicenda è nota, ma conviene qui ripercorrerne brevemente le tappe.
L’Ilva, nata dalla dismessa Italsider, è il più importante polo siderurgico italiano e fra i primi
in Europa. Le sue fabbriche, concentrate principalmente nella zona di Conegliano in Liguria e a
Taranto in Puglia, sono state costruite nel 1961, danno lavoro a quasi 17.000 dipendenti e creano un
indotto annuo stimato, nella sola zona pugliese, in circa 310 milioni di euro. A Taranto, l’immenso
stabilimento è stato costruito fra due quartieri, uno dei quali è fra i più popolosi, Tamburi con
10.000 abitanti. Una scelta folle quella di costruire una grande industria a ridosso di una città, una
scelta tipica di una stagione «sviluppista» e industrialista in cui non si teneva affatto conto dei
problemi della salute e del territorio.
Questa enorme ricchezza produttiva non è, infatti, priva di conseguenze. A partire soprattutto
dagli inizi del 2000 i distretti di Genova e di Taranto sono stati al centro di vari processi, spesso
conclusi con condanna, per inquinamento ambientale. Studi epidemiologici hanno portato infatti
alla luce come la produzione industriale fosse responsabile di un vasto fenomeno di inquinamento
che ha determinato un aumento esponenziale di patologie tumorali e neurologiche nelle zone che
ospitano gli stabilimenti.
Dopo vari processi e vicissitudini, nel 2012 il GIP del tribunale di Taranto ha disposto il
sequestro degli impianti, con un’ordinanza in cui si afferma che “chi gestiva e gestisce l'Ilva ha
continuato nell'attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le
più elementari regole di sicurezza” (“Il gip: «Ilva mossa da logica del profitto. Sequestro per
tutelare la vita umana», in La Repubblica on line, 27 luglio 2012).
I periti nominati della Procura di Taranto calcolano in sette anni un totale di 11.550 morti causati
dalle emissioni (in media 1.650 l’anno) soprattutto per cause cardiovascolari e respiratorie e 26.999
ricoveri, soprattutto per cause cardiache, respiratorie, e cerebrovascolari. Le concentrazioni di
agenti inquinanti e la proporzione di decessi e malattie è altissima nei quartieri Tamburi e Borgo,
quelli più vicini alla zona industriale.
In tempi recenti, in conseguenza di tutto questo, abbiamo assistito all’instaurarsi di una
situazione paradossale in cui, soprattutto in Puglia, cittadini, operai e sindacati si sono mobilitati in
difesa del loro diritto al lavoro, difendendo così, però, un lavoro che porterà inevitabilmente la
morte.
L’azienda dovrebbe provvedere ad una serie di interventi nell’arco di tre anni, favorendo il
risanamento, l’”Aia”, autorizzazione integrata ambientale”, ma i costi sono altissimi.
Le nostre domande sono:
Si può difendere un lavoro che uccide?
Qual è la società che può permettere che questo avvenga?
Idolatria e lavoro
È possibile davvero considerare questa situazione “solo” come la conseguenza della crisi
economica in atto o, al massimo, di un problema di scelte politiche?
Ilva è simbolo dello sviluppo economico e della società contemporanea, in cui spesso
l’intelligenza soffoca la ragione. L’intelligenza di cui parla Fromm è quella delle macchine e dei
computer, che utilizzano in modo efficiente dei dati immessi dall’esterno.
La ragione, che tende a farci comprendere e scoprire l’essenza della realtà che ci circonda,
degenera e fa sì che l’uomo moderno non agisca creativamente, ma prenda la realtà così com’è.
Nella vita individuale e sociale, la ragione è necessaria per prevedere e la previsione è talvolta
necessaria anche per l’esistenza fisica (non solo l’intelligenza è il pensiero al servizio della
sopravvivenza biologica). Per Fromm la ragione vacilla e il realismo “dei suoi e dei nostri giorni” è
pura ideologia, egli infatti scrisse: “Che realisti sono quelli che stanno giocando con armi che
possono portare alla distruzione di tutta la civiltà moderna, se non addirittura della terra stessa?”
(Fromm 1955, pag. 168). Questo pensiero è attuale, potremmo pensare la stessa cosa per i dirigenti
e fondatori dell’Ilva. Essi sono indagati per «disastro ambientale doloso e colposo», l’azienda ha
infatti disperso sostanze nocive nell’ambiente provocando malattia e morte, come una guerra.
Fromm nasce nel 1900, al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale aveva quindici
anni, ma anche allora il giovane adolescente si chiedeva: “Come è possibile che tante persone
apparentemente ragionevoli impazziscono di colpo? Perché la guerra?” (Kohury, 1962).
3. L’interpretazione psico-sociale della crisi contemporanea
Il caso dell’Ilva di Taranto ci riporta al significato del lavoro per l’uomo. L’uomo deve
lavorare per vivere, è stato definito “l’animale che produce”, ma il lavoro per l’uomo non è soltanto
una necessità, è un’attività che lo separa dalla natura, sviluppando le capacità di cooperazione e di
ragione, lo rende un essere sociale e indipendente. Nel processo lavorativo l’uomo riesce a
modellare e cambiare se stesso, quanto più il lavoro si sviluppa tanto più si sviluppa la sua
personalità. Il lavoro permette all’uomo di produrre, ma anche di consumare, di possedere. Nel
capitalismo contemporaneo si può assistere ad un fenomeno di massa: la produzione di massa e il
consumo di massa. Nel XIX secolo l’uomo spendeva solo quanto poteva, dal XX secolo tutti sono
invitati a spendere quanto più possono e prima di aver risparmiato abbastanza per pagare i loro
acquisti (questo ha generato la crisi economica in America). Nel sistema di valori dell’uomo
moderno, secondo Fromm, le cose sono più in alto dell’uomo. È facile pensare questo dei dirigenti
dell’Ilva: nel moderno processo di quantificazione e astrattizzazione tutto viene contabilizzato,
Idolatria e lavoro
numerato, messo in bilancio, così l’uomo individuale sparisce, così anche la vita degli operai viene
strumentalizzata dai “capi” al fine di accumulare sempre più denaro e potere, anche a scapito della
salute e del benessere. L’uomo moderno è cieco, non riesce a vedere le cose nella loro concretezza e
individualità, perché tutta l’attenzione viene rivolta all’aspetto quantitativo ed economico. L’uomo
è merce per un altro uomo, è un rapporto tra due astrazioni, il datore di lavoro usa coloro che
impiega. Fromm afferma: “Non si trova più molto amore o molto odio nelle relazioni umane
odierne. C’è piuttosto una superficiale cordialità ed una più che superficiale correttezza, ma dietro
questa superficialità ci sono distanza e indifferenza” (Fromm 1955, p.153).
Possiamo affermare che i dirigenti dell’Ilva fossero alienati, ma anche gli operai in quanto
l’alienazione diventa per Fromm universale nella società capitalistica contemporanea. La classe
operaia ha partecipato dal XIX secolo alla produzione crescente di tutto il sistema economico, il suo
potere sociale ed economico è aumentato in rapporto al salario e non solo, anche al suo ruolo umano
e sociale nella fabbrica. Il lavoro in questa società alienata diventa un dovere e un’ossessione.
Fromm parla di società alienata, ma cosa vuol significare questo termine?
Deriva dal latino alienus (altro) e fa riferimento a colui o a ciò che è altro, viene usato per
indicare il disagio dell’uomo nella moderna civiltà industriale. I primi studi in cui si ritrova questo
concetto sono quelli di Rousseau, Hegel, per Fromm questo termine indica una dimensione
esistenziale in cui l’uomo ha perduto la propria identità e conosce se stesso come un estraneo. La
persona alienata ha perduto il contatto con se stessa, non riconosce se stesso come il centro del suo
mondo e come il creatore dei propri atti, ma i suoi atti sono il suo padrone al quale egli obbedisce e
a cui può tributare venerazione. Per spiegare meglio il termine e il processo di alienazione, Fromm
si rifà al concetto di idolatria. L’idolatria è uno stato di completa alienazione in cui l’uomo si
sottomette ad un oggetto che egli stesso ha creato; il monoteismo è all’opposto dell’idolatria, ma
purtroppo nei secoli è regredito verso l‘idolatria e l’uomo proietta il suo potere di amore e di
ragione in Dio e non li sente più come suoi poteri e perciò prega Dio di dargli qualcosa di quello
che lui uomo ha proiettato in Dio. In questo senso ogni atto di adorazione sottomessa è un atto di
alienazione e idolatria, quello che di frequente si chiama “amore” spesso è un fenomeno idolatrico
di alienazione, in questo modo non si adora né Dio né un idolo ma un’altra persona. In questo senso
“l’amore” per il proprio lavoro che conduce alla morte può essere considerato un atto di idolatria e
perciò di alienazione? Possiamo rispondere con una frase di Fromm: “Chiunque sia schiavo delle
proprie passioni irrazionali è alienato. Chi è mosso principalmente dalla brama di potere o di
denaro non è più capace di sentire la propria potenziale ricchezza, non sa conoscersi e quindi è
alienato” (Ivi p.124). Allora il termine alienazione qui prende più il significato del linguaggio
Idolatria e lavoro
giuridico, ovvero un atto con il quale un soggetto attribuisce ad un altro una proprietà o un diritto
sui beni del proprio patrimonio.
L’alienazione come noi la troviamo nella società moderna è quasi totale, essa invade le
relazioni dell’uomo col suo lavoro, con le cose che consuma, con lo Stato, con i suoi simili e con se
stesso. “L’uomo ha creato un mondo di cose fatte da lui come non era mai esistito prima, ha
inventato una complicata macchina sociale per amministrare la macchina tecnica da lui costruita”.
(Ivi p.125).
Nell’uomo moderno coesistono dunque una serie di aspetti dell’alienazione: l’atteggiamento
davanti alle autorità (che si presenta invisibile, alienata), il continuo livellarsi del gusto individuale
a quello della collettività, la cosiddetta toghetherness, cioè la rinuncia alla propria individualità per
far parte della folla e il “principio di non frustrazione”, riferito soprattutto ai bambini e ai giovani
che devono ottenere subito tutto ciò che desiderano.
L’alienazione investe non solo il momento della produzione, ma anche quello del consumo. Il
sentimento di insignificanza che è avvertito dall’uomo moderno è ben evidente nel ruolo del
consumatore (per esempio il cliente di un grande magazzino non riceve più alcuna attenzione
personale, egli è importante solo come “cliente astratto” non come “individuo concreto”). Il cliente
è manipolato dalla pubblicità, che esercita la sua influenza attraverso le emozioni, essendo una
suggestione, induce subdolamente a comprare. Fromm scrive in Fuga dalla libertà (1941) che la
pubblicità è un vero pericolo per la democrazia e la sua immoralità è maggiore della letteratura
oscena che viene censurata, mentre nel suo libro L’istinto sociale (1991) sottolinea come la
pubblicità, assieme agli slogan, alle figure carismatiche del leader ecc., induca uno stato di
dormiveglia semi-ipnotico. Egli tuttavia non nega che una società più evoluta abbia bisogno di
consumi maggiori e di necessità più raffinate, ma sottolinea che l’attuale “brama di consumo” non
ha nulla a che vedere con i bisogni umani autentici. La realtà del consumo, che Fromm descrive,
porta a tre meccanismi di fuga: l’autoritarismo, la distruttività e il “conformismo da automi”,
adottato dalla maggioranza dagli individui “normali” nelle società industriali contemporanee, in cui
all’io subentra un “super-io collettivo”. Ma è possibile che tutta una società sia malata, che sia
alienata? Purtroppo la risposta di Fromm è affermativa: vizi e difetti non cessano di essere tali
soltanto perché condivisi da milioni di persone e fa la distinzione tra “deficienza” e “nevrosi”. La
prima è riferita alla malattia mentale sociale, la seconda a quella individuale. Con la deficienza una
persona non è in grado di esprimersi liberamente e spontaneamente, se questa situazione riguarda
tutte le persone di una data società vuol dire che la “deficienza è divenuta socialmente strutturata”.
La società funziona come l’individuo nell’atto in cui struttura le difese-fuga dalla conoscenza e
dalla coscienza e si rifugia nei propri meccanismi di difesa sociali.
Idolatria e lavoro
La cultura del consumo e la pericolosità della pubblicità è descritta anche dall’economista
Stefano Bartolini in Manifesto per la felicità (2010). I media, e in particolar modo la pubblicità,
giocano un ruolo centrale nello stimolare la diffusione dei valori consumistici e la cultura del
consumo genera povertà relazionale. Come diceva Fromm, psicoanalista e sociologo, c’è
connessione tra il prodotto pubblicizzato ed emozioni positive: “compro dunque sono”.
Fromm introduce un nuovo metodo di indagine per capire la società e la cultura in cui
viviamo, la “psicoanalisi umanistica”, che analizza non solo le componenti dei processi sociali,
quelle esteriori socializzate o desocializzate, ma anche quelle profonde, emotive e dinamiche,
socializzanti e desocializzanti.
Le guerre, per esempio, non sono solo il frutto della distruttività inconscia dell’uomo, ma la
risposta sta anche nelle reali condizioni di vita delle nazioni dal punto di vista politico, sociale ed
economico. Il nascere dei regimi autoritari non è solo il frutto dei poteri carismatici di un capo che
riesce ad assoggettare i cittadini, così come, se il narcisismo dell’individuo può essere alla base del
dittatore e della sua capacità di irretire una nazione, il narcisismo di gruppo, di una società,
favorisce il propagarsi di ideologie razziste. L’uomo è protagonista della storia, anche quando
decide la propria disfatta. Egli perde la propria libertà nel senso in cui “fugge da”, “delega”, come il
bambino nel processo di crescita rispetto alla madre. Il processo di maturazione delle nazioni e delle
masse può essere paragonato al processo di crescita del bambino, che provando angosce, la paura
dell’incognito, dell’autonomia, delle responsabilità, può interrompere questo processo di crescita e
ridelegare alla madre il destino della propria vita, in una dipendenza rassicurante e beata. Secondo
Fromm queste paure vengono vissute nello stesso modo dall’uomo come gruppo sociale: la libertà
tanto cercata in realtà fa paura e l’uomo ricerca una protezione che lo salvi.
Come precedentemente accennato, il caso dell’Ilva di Taranto appare, oggi, un caso esemplare
delle conseguenze inevitabili di un percorso politico e culturale che non può avere alternative. Oggi
un uomo senza lavoro è un escluso, un “fallito” agli occhi della società, un “non uomo” privo di
diritti. In un solo colpo, perde ciò che caratterizza la ragione del suo esistere. Come scrive sempre
Fromm (1991, p. 21) “[…] l’uomo ha una duplice esigenza: quella di entrare in relazione con gli
altri, e quella di appropriarsi delle cose”. Privo di un lavoro che lo renda socialmente riconosciuto e
gli procuri uno stipendio in grado di garantirgli di poter acquistare, l’uomo non può più soddisfare
né l’una né l’altra di queste due esigenze. È morto socialmente, prima ancora che biologicamente e,
a quel punto, la morte fisica non è più così irragionevole come potrebbe apparire. Non è più così
difficile capire come, se privi di una struttura sociale che riesca a sostenere il peso di un tale
isolamento e/o di valori alternativi, una persona possa decidere di suicidarsi, come nel caso dei tanti
Idolatria e lavoro
piccoli e medi imprenditori che hanno scelto questa soluzione negli ultimi anni, o scelga di
desiderare un lavoro che lo ucciderà.
Ma, tornando alle domande che ponevamo, qual è la società che può permettere che questo
avvenga?
Un tentativo di risposta può essere fatto alla luce delle teorie di Fromm. Nel suo libro I
cosiddetti sani (1996), questo autore aveva già evidenziato come l’evoluzione dell’uomo fosse stata
fondata sul lavoro; ma il lavoro porta all’emancipazione dell’uomo solo nel momento in cui viene
considerato come attività quasi fine a se stessa. Nel corso della storia, tale visione si è modificata,
nello stesso modo in cui la nostra cultura ha privilegiato la dimensione dell’avere rispetto a quella
dell’essere, per usare altri termini cari a Fromm. In questo senso, anche il lavoro si è trasformato,
cessando di essere un’attività per diventare un prodotto e, come tale, oggetto di scambio economico.
Questo cambiamento ha comportato che nella dimensione lavorativa non fosse più
indispensabile che la realizzazione di un prodotto fosse fonte di piacere, ma è andata ad incentivare
una visione consumistica in linea con la società contemporanea.
Il lavoro è merce di scambio, la mia competenza in cambio di un compenso in denaro, e la mia
efficienza è misurata solo in base a quanto produco nel minor tempo possibile, incrementando il
profitto. È evidente come un meccanismo di questo tipo riduca molto i margini di una responsabilità
sociale, che richiederebbe come prioritario il dovere di mettere in sicurezza gli impianti e di
garantire la salute di dipendenti e cittadini. Non è difficile ammettere la possibilità, per quanto
penalmente sanzionabile anche nella nostra società, che la dirigenza di un’impresa, in vista della
ottimizzazione dei profitti, “sacrifichi” la sicurezza dei propri lavoratori. Del resto, esempi analoghi
si ripetono continuamente nella cronaca: basti pensare al caso Thyssen Krupp dove, pochi anni fa,
un incidente portò alla morte di alcuni operai e risultò che le conseguenze tragiche dell’episodio
erano state determinate dal fatto che, essendo la fabbrica in dismissione, erano state sospese le
verifiche di controllo e di sicurezza le cui spese sarebbero state maggiori dell’eventuale rimborso
dovuto in presenza di un incidente.
Ma se, pure in una logica aberrante, è possibile “comprendere” la posizione del proprietario
dell’impresa, come è possibile capire le motivazioni degli operai, dei cittadini, che, contro ogni
evidenza, chiedono di morire pur di aver un salario?
Non è possibile, a nostro avviso, capire il senso di tutto questo se non ritornando alla teoria
già accennata per la quale il lavoro è diventato un idolo.
Il ruolo dell’idolo è molto complesso e funzionale a mantenere vivo il senso di identità della
persona e, come detto, tutto ciò rafforza la natura stessa dell’uomo. Scrive Fromm (ivi, p. 20,
corsivo dell’autore)
Idolatria e lavoro
“Prima di ogni altra cosa l’uomo è una creatura sociale. La sua costituzione fisica
è tale da costringerlo a vivere in gruppi, il che significa che egli è in grado di cooperare
con gli altri […]. Presupposto di tale cooperazione è la sua salute mentale. Per essere
psichicamente sano, ovvero per sopravvivere a livello psichico (e indirettamente anche
fisico), l’uomo deve entrare in relazione con gli altri e ha bisogno di un quadro
orientativo che gli consenta di comprendere la realtà, finalizzato a fornirgli uno schema di
riferimento relativamente costante in una realtà altrimenti caotica. Questo quadro
orientativo lo mette al contempo in grado di comunicare con gli altri”.
Avevamo già sottolineato come questa trasformazione del lavoro in un idolo fosse uno degli
aspetti che emergevano nel desiderio di mantenere un lavoro nonostante debba comportare la morte;
ma, in una sorta di circolo vizioso, questa stessa condizione impedisce che sia possibile uscire da
quest’ottica aberrante. Per farlo, bisognerebbe riuscire a destituire il fenomeno dell’idolatria nei
confronti del lavoro, ma ciò è difficile, in quanto “l’idolo è […] quella figura sulla quale un
soggetto trasferisce la propria potenza e le proprie forze. Più un idolo si rafforza, più il soggetto si
impoverisce. A quel punto si può mantenere il contatto con se stessi solo se si è in contatto con
l’idolo” (ivi, p. 65).
5. Conclusioni
È innegabile riscontrare, nei giorni in cui viviamo, una situazione drammatica. Ciò che più
disarma, alla luce della situazione attuale, non è tanto la situazione pur pesante di crisi economica,
che priva migliaia di persone non solo delle risorse minime necessarie alla sopravvivenza, ma della
stessa loro dignità. Ciò che più preoccupa è il senso di scoraggiamento, la mancanza di speranza,
che sopprime ogni spinta di ripresa. Assistiamo, oggi, ad un presente che Fromm ed altre persone
“illuminate” avevano previsto nei minimi dettagli, ma che, nonostante questo, non siamo riusciti ad
evitare.
La malattia psichica dell’uomo contemporaneo, quella stessa che lo porta a “desiderare” di
morire per un salario, non è altro che l’espressione della malattia psichica della società in cui
viviamo; la salute dell’uno non è possibile senza la salute dell’altra, e viceversa. Come diceva il
nostro autore (1996, p. 67):
“A mio avviso sarebbe […] corretto dire «mens sana in societate sana»: a
prescindere da qualche eccezione, una mente sana può albergare solo in una società sana;
ne consegue che il problema della salute psichica dell’individuo non può essere scisso da
quello della salute psichica della società”.
Idolatria e lavoro
È chiaro ora che la risposta alla nostra domanda iniziale su quale società potesse permettere
che delle persone decidessero coscientemente di morire pur di lavorare è: lo può fare solo una
società psichicamente malata, quella che Fromm individuava come una società necrofila.
Si tratta, come ancora oggi alcune eminenti personalità ci ricordano, di una società che si è
nutrita di un falso concetto di progresso, visto come onnipotente, e alienante, sfruttamento delle
risorse del mondo, nella illusoria convinzione che tutto questo non comporti danni o, almeno, non
comporti danni immediati. Il soddisfacimento immediato di un bisogno è più importante della sicura
distruzione della nostra stessa specie.
Tutto questo, fortunatamente, non è irreversibile. Basta non perdere altre occasioni, basta
ripetere, forte, chiaro, che la crisi in cui viviamo può avere un senso positivo: basta ricordare che il
termine crisi ha una valenza positiva che abbiamo dimenticato e che, ora, sarebbe il caso di
riscoprire.
In Fuga dalla Libertà Fromm parla di coraggio, il “coraggio di essere abbastanza forti e sani
da vivere saltuariamente contro corrente”, riferito all’uomo maturo che nasce dal processo di
liberazione dalla dipendenza e di responsabilizzazione nella realtà. Anche la società matura può
attraversare un simile processo di autonomia e responsabilizzazione, un processo di crescita reale a
livello collettivo. Questo coraggio viene espresso anche in Manifesto per la felicità: il progetto di
società relazionale è un’utopia o una realtà possibile? Esistono esperimenti riusciti in vari settori
della vita economica e sociale, esempi ben noti di aziende, città, forme di economia sociale, che
promuovono la vita relazionale e il benessere, tuttavia manca un progetto di società relazionale che
li comprenda tutti.
Ci sono tanti elementi che ci sottolineano ogni giorno gli effetti negativi del mondo che
abbiamo creato, ma ce ne sono altrettanti che indicano un cambiamento che lascia aperta una
speranza per il futuro. Tante persone non credono più nel progresso così come ci era stato sempre
raccontato e, come diceva Borges: “Non credo più nel progresso. Che sia un progresso?” (Olmi,
2013).
Bibliografia
Bartolini, S. (2010), Manifesto per la felicità, Roma, Donzelli
Idolatria e lavoro
Einstein, A. (1956), The world as I see it, ed. It., 1975, Il mondo come io lo vedo, Roma,
Newton Compton
Fromm, E. (1941), Escape from Freedom, ed. it., 1991, Fuga dalla libertà, Milano, Ed. di
Comunità
Fromm, E. (1955), The sane Society, ed. it. 1960, Psicoanalisi della società contemporanea,
Milano, Ed. di Comunità
Fromm, E. (1990), Die Entdeckung des geselischaftlichen Unbewuẞten, ed. it. L’inconscio
sociale, Milano, Mondadori
Fromm, E. (1996), Die pathologie der Normalitat, ed. it. I cosiddetti sani. Patologia della
normalità, Milano, Mondadori
Khoury, G. (1962), intervista su La Stampa, Torino
Olmi, E. (2013), intervista a Che tempo che fa, RAI3, 13/1/2013