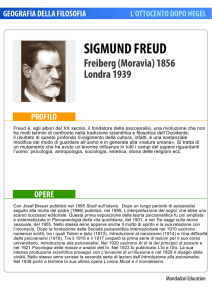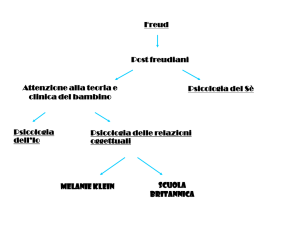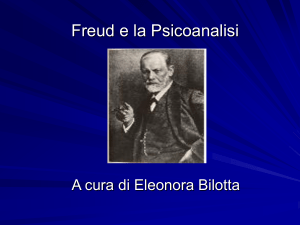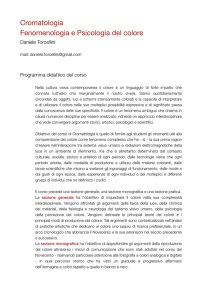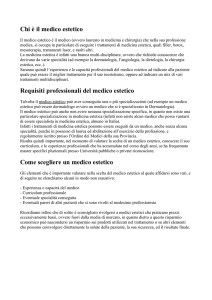Angelo Trimarco
La parabola del teorico
sull'arte e la critica
Introduzione di Stefania Zuliani
Introduction by Stefania Zuliani
CRITICAL GROUNDS #03
1
3
Arshake • Reinventing Technology
Via Giuseppe Pisanelli, 4 | 00196 Rome, Italy
www.arshake.com
contacts [email protected]
ISSN - 2283-3676
Direttore Editoriale / Editorial Director Elena Giulia Rossi
Critical Grounds
Progetto Editoriale Diretto da / Editorial Project Directed by
Christian Caliandro e Antonello Tolve
Comitato Scientifico / Scientific Committee
Alexandra Antonopoulou
Francesca Bacci
Giselle Beiguelman
Nina Czegledy
Francesca Gallo
José Jiménez
Eva Kekou
Christiane Paul
Eugenio Viola
E-book/design Cristian Rizzuti
Traduzione Italiano/Inglese Francesco Caruso
Copyright © Arshake, A. Trimarco e S. Zuliani per i testi.
Copyright © Arshake, A. Trimarco e S. Zuliani for text.
ISBN - 978-88-98709-02-1
Le pubblicazioni edite da Arshake sono sottoposte al preliminare vaglio scientifico di
un comitato di referee anonimi e si avvale quindi della procedura peer review. / Arshake
pubblications are submitted for peer-review to a scientific committee of undisclosed
members.
La Parabola del Teorico
CRITICAL GROUNDS
- 03 -
Angelo Trimarco
La parabola del teorico
sull'arte e la critica
Introduzione di Stefania Zuliani
7
8
Indice / Index
Introduzione / introduction
di / by Stefania Zuliani11
Gli anni settanta
1. Lo sfiorire del teorico
2. L’arte dopo la filosofia (e altre considerazioni)
3. Convergenze sull’antropologia
Intermezzo
1. Mukařovský. Il legame obliquo
2. Hauser. Il corso tortuoso della dialettica
31
47
63
75
91
Terminabile, interminabile
1.
2.
3.
4.
Sulla critica interminabile
Il motto di spirito, il poetico
La storia con Freud
Storia dell’arte, storia delle cose
99
109
115
129
Biografia / Biography
151
Bibliografia / Bibliography
153
10
Introduzione
Un bilancio, una proposta
A proposito di un libro interminabile
di Stefania Zuliani
La cronologia, innanzitutto: è il 1982 quando La parabola del teorico
(Sull’arte e la critica è l’ambizioso sottotitolo) viene pubblicato dalle
romane edizioni Kappa nella collana Figure diretta da Filiberto Menna,
fondatore nello stesso anno dell’omonima rivista (Figure. Teoria e critica
dell’arte, appunto), che nel corso del decennio fu spazio d’elezione per
il confronto tra i protagonisti e i temi del dibattito critico più aggiornato
e dissidente, in Italia e non solo. Erano passati solo quattro anni dal
cruciale convegno di Montecatini, davvero gli stati generali della critica
d’arte1, un incontro affollato e intenso che nell’ampio e non sempre
sereno presentarsi delle voci e dei metodi, ancora apparentemente
(modernamente) saldi e taglienti, aveva di fatto sancito l’avvenuto
ingresso nella stagione postmoderna, una latitudine dagli incerti confini
e dai discorsi plurali, irriducibile ad una risolutiva definizione, ad una
direzione univoca. Una condizione a tal punto segnata dalla differenza
da poter essere interpretata, in Europa e negli Stati Uniti, secondo
orientamenti persino contraddittori, talvolta semplificati in schematiche
ma efficaci opposizioni: «postmodernismo poststrutturalista» vs.
«postmodernismo neoconservatore»2 o, ancora, «postmodernism of
resistence» vs. «postmodernism of accomodation»3, per riprendere
1 Teoria e pratiche della critica d’arte è il titolo del convegno, curato da Egidio Mucci e da Pier
Luigi Tazzi nel maggio del 1978. Gli atti, a cura dei due studiosi, verranno pubblicati l’anno
successivo (Mondadori, Milano). Tra i numerosi interventi, segnaliamo quelli di Amman, Barilli,
Bonito Oliva, Buchloh, Dorfles, Calvesi, Eco, Lyotard, Maltese, Menna, Millet, Pleynet, Restany,
oltre quello dello stesso Trimarco. Cfr. A. Trimarco, Italia 1960-2000. Teoria e critica d’arte,
Paparo edizioni, Napoli 2012, pp. 113ss.
2 Così H. Foster, R. Krauss,Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, Art Since 1900: Modernism,
Antimodernism, Postmodernism, Thames and Hudson, London 2005, trad. it. E. Grazioli, Arte dal
1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, Zanichelli, Bologna 2006, pp. 596-599.
3 D. Crimp, On the museum’s ruins, MIT Press, Cambridge MA- London 2000 (1993), p. 4.
11
le proposte teoriche sostenute dalla rivista statunitense «October»4.
Il Convegno di Montecatini del 1978 aveva dunque rappresentato un
punto di non ritorno, non solo e non tanto per il delinearsi di tesi dagli
esiti inconciliabili – e basterà pensare al «lassismo critico» proposto da
Lyotard, certo distante dalla rigorosa «critica della critica» sostenuta con
ostinazione dallo stesso Menna5 come dalle posizioni di Gillo Dorfles,
anche in quest’occasione attento a riflettere sulla possibilità di un giudizio
assiologico6 – quanto per il carattere involontariamente conclusivo di una
discussione che dichiarava, di fatto, l’impossibilità di un unico e definitivo
discorso sul metodo aprendo alla scena del rischio, alle incertezze di una
navigazione le cui rotte andavano di volta in volta stabilite e sperimentate.
Senza improvvisazione, però, utilizzando con lucidità strumenti teorici
magari flessibili ma non per questo estemporanei e immotivati.
Ed è proprio muovendo dalla consapevolezza che il farsi della critica,
pur rigettando con decisione «il totalitarismo dei metodi»7 non poteva
affidarsi ad una sensibilità puramente soggettiva e neppure cedere alla
tentazione di limitarsi ad affiancare soltanto l’opera d’arte con la scrittura
critica, intesa anch’essa come produzione di assoluti «testi di godimento»
(Barthes), che Angelo Trimarco ha scelto di raccogliere nell’architettura
solida de La parabola del teorico i risultati e le prospettive di un lavoro
critico avvezzo alla fatica delle teoria, all’esercizio di una ragione
analitica che, scongiurato definitivamente il «fantasma della metafisica»,
fosse in grado di rimettere in questione il soggetto e la complessità delle
sue relazioni, fuori da ogni rigido dettato storicista ma non senza una
irrinunciabile sensibilità dialettica, «contro discorso» non denunciato
eppure sempre attivo nel pensiero di Trimarco. È certo significativo che
ad aprire il volume sia il saggio più recente tra quelli che costituiscono
l’impalcatura tripartita del libro – Gli anni Settanta, Intermezzo,
Terminabile, interminabile – un contributo del 1981, ragionatissimo,
fitto di note e di rimandi, di eterogenei riferimenti (da Althusser a
Portoghesi, da Devade ad Habermas) che fin dal titolo, Lo sfiorire del
teorico, segnalava con precisione inequivocabile una tesi e indicava, per
sottrazione, se non una prospettiva almeno un campo di possibilità per
la critica d’arte, chiamata a fare i conti non tanto con l’azzeramento dei
valori, con il troppo discusso e persino banalizzato crollo delle ideologie,
quanto con una diversa lettura della storia e, quindi, della storia dell’arte,
4 Sul ruolo della rivista americana nel dibattito critico di questi anni si veda M. G. Mancini,
October. Una rivista militante, Luciano Editore, Napoli 2014.
5 Cfr. F. Menna, Critica della critica, Feltrinelli, Milano 1980.
6 G. Dorfles, È ancora possibile un giudizio assiologico?, in E. Mucci e P. Tazzi, a cura di, Teorie
e pratiche della critica d’arte, cit., pp. 12-14.
7 Infra, p. - 128.
12
sottratta ai vincoli di un continuismo ottuso e riduttivo: «Non è un caso –
scriveva Trimarco – che sia saltato, di recente, uno dei confini più sicuri
della storia dell’arte, quello tra l’Avanguardia e il Novecento, appunto.
D’altra parte l’arte concettuale ha mostrato l’inutilità, la non necessità,
di riferirsi all’Avanguardia nell’elaborare la più decisiva proposta di
smaterializzazione dell’oggetto artistico»8.
Così, La parabola del teorico prende l’avvio da un’esplicita dichiarazione
di crisi – lo sfiorire appunto della critica, che poi diverrà, nel corso degli
anni e della scrittura di Trimarco, «dimagrimento» e «collasso», in un
sinistro processo di riduzione mai però veramente, definitivamente
luttuoso – senza per questo rinunciare nel corso del suo svolgimento a
individuare percorsi praticabili, pensieri non nostalgici di trasformazione
in grado di sottrarre l’arte e la critica dalle nebbie di un paesaggio
indeterminato e privo di gerarchie, dove, sotto l’insegna del ritorno
del soggettivo, si giungeva inesorabilmente «al pareggiamento del
linguaggio interiore e del linguaggio privato e pubblico, del silenzio
e del rumore, dell’Infanzia e della Storia»9. Una ricerca, questa di un
possibile ambito di azione per il pensiero critico, indebolito, forse,
ma non meno necessario, che si declinava in un percorso ovviamente
discontinuo eppure coerente nei nessi e nelle prospettive. L’attenzione
all’arte concettuale e, in particolare, al contributo di Joseph Kosuth,
una delle costanti (e delle anticipazioni sorprendenti) della riflessione
critica di Trimarco, è senz’altro indicativa di una disposizione per nulla
rinunciataria rispetto all’urgenza della critica, che nello spazio dell’arte
può trovare nuove radici e altri strumenti, lontano da ogni misticismo,
fosse pure quello implicito nelle tesi più radicali dell’arte concettuale,
di cui, ed è dato interessante, già nel 1973, anno a cui risale L’arte dopo
la filosofia (e altre considerazioni), seconda stazione della Parabola,
Trimarco sospettava i limiti e le interne fratture, evidenziando la lettura
cognitiva implicita nella lezione di Kosuth. Prendendo le distanze dalle
posizioni di Migliorini, dal canto suo convinto degli esiti ascetici del
pensiero di Kosuth, Trimarco suggeriva infatti qui una maggiore cautela
nel valutare il portato conoscitivo dell’arte concettuale, addirittura
anticipando quello spostamento verso il contesto che Kosuth avrebbe
dichiarato soltanto qualche anno più tardi nelle pagine del saggio The
artist as anthropologist (1975). Del resto, l’apertura all’antropologia,
una delle questioni che avrebbe attraversato il dibattito critico negli
ultimi decenni del secolo scorso informando, tra l’altro, le tesi espresse
da Hal Foster in The return of Real (1996), una proposta accolta in Italia
8 Infra, p. - 43.
9 Ibidem.
13
con entusiasmo forse un po’attardato grazie alla traduzione del 200610,
trovava già spazio e discussione nelle pagine della Parabola del teorico,
dove la Convergenza sull’antropologia più che essere il titolo del terzo
capitolo della Parabola è, a tutti gli effetti, una precisa indicazione di
metodo riconoscibile in differenti luoghi del discorso teorico proposto
da Trimarco in questo volume (e non soltanto)11. La necessità, più volte
sottolineata, era quella di aprire il campo della critica ad altri saperi e
ad altre discipline, contrastando la rigidità di ogni approccio dogmatico
o strettamente (solamente) filologico grazie al costante dialogo con
le elaborazioni e le acquisizioni teoriche maturate in ambiti differenti
– dall’urbanistica alla linguistica, dalla psicoanalisi alla sociologia,
dall’estetica alla filosofia politica, e ancora – individuando di volta in
volta transiti e connessioni efficaci, puntuali, motivati. Non un gioco
di suggestioni, di enciclopediche analogie, ma un foucaultiano lavoro
di archeologia e di archivio, orientato a riconoscere procedure utili a
restituire all’opera il suo valore di oggetto di conoscenza e di strumento
di interpretazione della realtà.
La psicoanalisi, in questo senso, rappresenta per Trimarco, che nel 1974
aveva pubblicato L’inconscio dell’opera. Sociologia e psicoanalisi
dell’arte12, un modello e un metodo d’elezione giacché la critica
freudiana mette in crisi non soltanto ogni idea di ragione unitaria ma
problematizza anche «i progetti parziali, legati alla frantumazione dei
linguaggi, che pretendono d’innalzare la verità del proprio discorso
a verità onnicomprensiva»13. Ad essere centrale è la nozione di
sovradeterminazione e, quindi, di sovrainterpretazione, che Trimarco
rivendica come risorsa indispensabile per un lavoro critico che si vuole,
o, meglio, che è interminabile, mettendo da un canto in luce come
l’incertezza e la caducità non significhino insufficienza e mancanza
ma negazione dell’assoluto e, dall’altro, riflettendo sulle strategie di
normalizzazione (di riduzione e di addomesticamento) di questo infinito
potenziale. In questo senso va letta, ad esempio, la critica condotta nelle
pagine del capitolo intitolato appunto Sulla critica interminabile al
progetto iconologico di Ernst Gombrich, centrato sull’individuazione del
significato dominante e quindi finalizzato al conseguimento di un risultato
definitivo, conclusivo e perciò indiscutibile. Diversamente, la lezione
10 H. Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento, Postmedia books,
Milano 2006.
11 Per una ricognizione generale sul pensiero critico di Trimarco si veda Lavori in corso. Giovani
critici in dialogo con Angelo Trimarco, a cura di S. Zuliani con una premessa di A. Bonito Oliva,
Plectica, Salerno 2011, in particolare il saggio di A. Tolve, La ginestra o il fiore della critica
d’arte, pp. 71ss.
12 Officina Edizioni, Roma 1974.
13 Infra, p. - 100.
14
freudiana, riattraversata da Trimarco senza trascurare la curvatura operata
da Lacan, si offre come pratica critica aperta, un processo interpretativo
– inclusione, esclusione – in grado di accogliere la deformazione. La
direzione è, in ogni caso, trasversale, mai diretta e, per questo, capace di
intercettare significati e relazioni imprevisti, tangenti: anche quando si
misura in un serrato, densissimo corpo a corpo teorico con l’estetica di
Mukařovský, la cui ricezione in Italia è stata tardiva e lacunosa, Trimarco
non può non sottolineare che «il rapporto tra significante e significato,
tra opera-cosa e oggetto-estetico è una relazione obliqua, è un rapporto
indiretto», insistendo sull’obliquità come condizione e garanzia dello
spostamento che l’oggetto artistico compie rispetto al già noto, sfuggendo
ad ogni deterministico rapporto con le condizioni storiche e sociali (e non
a caso è «tortuoso» il corso della dialettica di Hauser, altro autore che
nella Parabola trova ulteriore occasione di analisi e di ripensamento).
Insomma, attraverso una molteplicità persino vertiginosa di riferimenti
e di temi, di analisi testuali e di velati ma riconoscibili spunti polemici,
il discorso sull’arte e sulla critica qui condotto da Trimarco si offre
innanzitutto come un argine alle derive (postmoderne?) di una critica
senza teoria e sceglie la strada, faticosa, impegnativa, anche irta
di ostacoli e di incognite, di un continuo allargamento dei confini
disciplinari che non significa però, va chiarito, una rinuncia allo specifico
critico ma la messa in questione delle rigidità, dei rassicuranti perimetri
metodologici che costringono l’opera ad abdicare alla propria tensione
eversiva azzerandone la profondità, il carattere comunque eterologico. In
questo senso, l’itinerario – obliquo, tortuoso, interminabile – che viene
qui suggerito mantiene inalterata la propria paradossale attualità: per
quanto frutto di una condizione epistemologica ancora molto distante
dallo scenario globale contemporaneo, dalle inquietudini identitarie e dai
conflitti del global art world, oggetto di indagine da parte di Trimarco
in alcuni importanti saggi dei primi anni del 200014, La parabola del
teorico, proprio perché così fortemente impregnato degli umori degli
anni Settanta del secolo scorso, specifico e urgente, conserva intatto il
suo carattere di militanza, il suo essere un elogio della critica e dell’arte
come esercizio di pensiero, pratica di conoscenza e messa in discussione
dello status quo. Al di là, quindi, della distanza che ci separa da alcune
esperienze critiche e artistiche oggi forse dimenticate – penso a Karel
Teige e alle sue tesi sul mercato dell’arte o, ancora, al gruppo di Peinture
e alla sua raffinata proposta teorica – a restare vivo è il rigore di una
ricerca che non si sottrae al rischio, che si vuole parziale per scelta e
non per approssimazione, un modello che si afferma ancora efficace non
14 Cfr. almeno A. Trimarco, L’arte e l’abitare, Editoriale Modo, Milano 2001; Post- storia. Il
sistema dell’arte, Editori Riuniti, Roma 2004; Galassia. Avanguardia e postmodernità, Editori
Riuniti, Roma 2006.
15
solo per l’anticipazione di alcune questioni e per l’attenzione precoce
ad alcune figure – Kubler, con la sua «traversata antropologica» non
smette di interrogarci – ma per la capacità di affermare senza enfasi la
necessità di non abdicare ad un’osservazione consapevole e lucida sul
nostro tempo, per sottrarlo all’indeterminatezza di un eterno presente
e restituirlo alle tensioni e ai turbamenti, agli sprofondamenti e alle
lacerazioni della storia. Senza nostalgie teleologiche, ovviamente,
ma con la determinazione di chi non vuole soccombere alle seduzioni
del contemporaneo presentism (Bishop), di quello che Bruno Latour
definisce il mostruoso «Tempo della simultaneità», terreno di coltura
per ogni fondamentalismo15. Nella certezza che obliqua e interminabile,
faticosa e irrinunciabile è la traiettoria di un pensiero del dialogo e della
conoscenza dell’altro.
15 Cfr. B. Latour, P. Weibed, Making Things Public. Atmospheres of Democracy, MIT Press,
Massachusset 2005.
16
18
Introduction
An Assessment and a Proposal
About an Interminable Book
by Stefania Zuliani
First, some chronology: it was 1982 when the Rome-based Kappa
editions published La parabola del teorico [The Theorist’s parabola*]
(with On Art and Criticism as its ambitious subtitle). The book was hosted
in the collection Figure, directed by Filiberto Menna, who in that very
year had published a journal with the same title: Figure: Teoria e critica
d’arte [Figures: Art Theory and Criticism]. In the following decade,
this journal would become a privileged space where, within and outside
Italy, the protagonists and the themes of the most up-to-date and nonconformist critical debate would meet. Only four years had passed since
the crucial Montecatini conference (1978) – indeed the general assembly
of art criticism1. This packed and lively meeting saw the encounter of
several and often vehemently contrasting opinions and methods that,
according to the categories of modern art criticism, were at that time still
seemingly solid and sharp. In fact, this conference signaled the entrance
in the post-modern season, a land of blurred boundaries and multiple
discourses that could not be subsumed under one single definition or
taken to one single direction. Diversity was so typical a trait of it that
in Europe and in the US it was interpreted in ways that were almost
contradictory and sometimes simplified according to schematic but quite
effective oppositions: «poststructuralist postmodernism» vs. «neocon
* The Italian word «parabola» refers to both the English words «parable» (a story, a fable)
and «parabola» (the geometric figure, especially in its descending part). [Note of the Translator].
1 Teoria e pratiche della critica d’arte [Theory and Practices of Art Criticism] is the title of the
conference, organized in May 1978 by Egidio Mucci and Pier Luigi Tazzi. They also edited the
proceedings published in the following year by Mondadori. Among the various contributions, I
would like to point out those by Amman, Barilli, Bonito Oliva, Buchloh, Dorfles, Calvesi, Eco,
Lyotard, Maltese, Menna, Millet, Pleynet, Restany, and Trimarco. See Trimarco, Angelo, Italia
1960-2000: Teoria e critica d’arte, Naples: Paparo edizioni, 2012. Pp. 113ff.
19
postmodernism»2, or «postmodernism of resistance» vs. «postmodernism
of accommodation»3, to quote the theoretical terminology of the American
journal October4. Thus, the 1978 Montecatini conference represented a
point of no return: not only because some of the opinions expressed in
that occasion were irreconcilable – here one may just think to Lyotard’s
«critical laxity», a very distant position from the rigorous «criticism of
criticism» pertinaciously held by Menna5 as well as from Gillo Dorfles’
reflections on the possibility of an axiological critical judgment6 – but
rather because of the unwittingly conclusive quality of a discussion that,
as a matter of fact, declared the impossibility of finding a single and
definitive discourse on the method of art criticism. On these premises,
the field was opened to hazard and to an uncertain navigation whose
routes had to be mapped out and experimented each time. Still, this had
to be done without improvising and by applying knowingly theoretical
tools that could certainly be flexible but should not be improvisatory or
whimsical.
Moving from the awareness that on the one hand the critical gesture must
reject any «totalitarianism of methodologies»7 but on the other should
not embrace a merely subjective sensibility nor yield to the temptation to
limit itself to juxtapose critical writing next to the work of art, an activity
seen as production of «texts of bliss» (Barthes), in the solid architecture
of his La parabola del teorico, Angelo Trimarco has gathered the results
and the perspectives of a critical work used to the labor entailed in the
theoretical speculation and to the exercise of the analytical reasoning
that, cast away once and for all the «phantom of metaphysics», was able
put again into question the subject and the complexity of its relations.
Trimarco does so outside the rigid schemes of historicism but at the
2 See H. Foster, et al., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames and
Hudson, London 2004.
3 D. Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge, Mass.-London: MIT Press, 2000 [1993]. 4.
4 On the role that this American journal has played in the contemporary critical debate, see M. G.
Mancini, October: Una rivista militante, Luciano Editore, Napoli 2014.
5 Cf. F. Menna, Critica della critica, Feltrinelli, Milano 1980.
6 G. Dorfles, È ancora possibile un giudizio assiologico?, in E. Mucci, P. L. Tazzi, eds. Teorie e
pratiche, cit.
7 Infra, p. - 128.
20
same time does not abandon dialectic sensibility, an implicit «counterdiscourse» that is always present in his thought. It is quite telling that
the essay opening the tripartite structure of the book – Gli anni Settanta;
Intermezzo; Terminabile, interminabile – is the most recent among
those collected there. It is a most carefully reasoned 1981 contribution,
rich with endnotes and heterogeneous references (from Althusser to
Portoghesi, from Devade to Habermas), that from its very title, Lo sfiorire
del teorico [The Withering of Theory], unambiguously supports a thesis,
and envisages a certain domain of possibilities for art criticism. In this
essay, art criticism is invited to reckon not as much with the dissolution
of values or with the over-discussed and even trivialized collapse of
ideologies, but rather with a different reading of history – and therefore
of art history – delivered from a dull and reductive sense of continuity:
«Not by chance – wrote Trimarco – one of the most fixed boundary of art
history, that between Avant-Garde and Novecento, has just been recently
broken. On the other hand, conceptual art has shown the uselessness, the
non-necessity of using Avant-Garde as point of reference for advancing
the ultimate proposal of de-materialisation of the artistic object»8.
Thus, La parabola del teorico begins by explicitly announcing a crisis –
indeed a withering of theory that over the years and in Trimarco’s writings
will become a «slimming down» and a «collapse», all encompassed in a
rather sinister process of reduction that still never reaches its gloomy
end – but nevertheless attempts at detecting viable critical paths and at
formulating thoughts that are not nostalgic and are able to dispel the fog
which has rendered the landscape of art and criticism a land with no
directions or hierarchies; a place where, under the label of ‘going back to
subjectivity’ one inevitably landed where «interior and private and public
language, silence and noise, Childhood and History hold an even course»9.
This quest of a new field of application for critical thought, perhaps
weakened but still necessary, moved along a discontinuous path whose
connections and directions were nevertheless coherent. The attention
placed on conceptual art and, more particularly, on Joseph Kosuth’s
contribution – one of the recurring references in Trimarco’s writings as well
8 Infra, p. - 43.
9 Ibidem.
21
as one of his surprising theoretical forerunners – shows that Trimarco’s
attitude toward the urgency of criticism is all but defeatist: in the realm
of art, criticism can find new roots and new tools, far from any form of
mysticism, even that mysticism contained in the most radical tenets about
conceptual art, whose limits and internal gaps Trimarco already detected
in his 1973 «L’arte dopo la filosofia (altre considerazioni)» [Art after
Philosophy (other reflections)], the second section of the Parabola del
critico, when he emphasised the cognitive aspects reflected in Kosuth’s
interpretation. Distancing himself from Migliorini, who was persuaded
of the ascetic quality of Kosuth’s thought, Trimarco asked for more
caution I considering the cognitive value of conceptual art. In so doing,
he was anticipating that shifting toward context that Kosuth would have
espoused only some years later in his essay The Artist as Anthropologist
(1975). The idea of opening the field to anthropology – a critical issue
debated in the last decades of the twentieth century and which shaped the
theses Hal Foster expressed in his The Return of the Real (1996), which
in Italy were received with enthusiasm only after its late translation in
200610 – was discussed in the Parabola del critico, where the expression
«Convergenza sull’antropologia [Converging upon Anthropology]»,
besides being just the title of its third section, undoubtedly offered a
precise methodological indication, which could be detected in different
parts of the theoretical discourse Trimarco offered in his book (and
elsewhere)11. The point was, as it was often emphasized, that of opening
the field of art criticism to other areas of study and to other disciplines.
Thanks to a continuous dialog with the processes and the theoretical
acquisitions made in other fields – from urban studies to linguistics, from
psychoanalysis to sociology, from aesthetics to political philosophy,
and many others – and by detecting each time effective, precise, and
well-supported intersections, it was possible to contrast the rigidity of
any dogmatic or exclusively philological approach. To be sure, this had
not to end up into a game of suggestions or encyclopedic analogies, but
10 H. Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento, Postmedia books,
Milano 2006 [orig. publ.: MIT Press, Cambridge, Mass 1996].
11 For a general overview of Trimarco’s critical thought see S. Zuliani, ed. Lavori in corso.
Giovani critici in dialogo con Angelo Trimarco, With a foreword by A. Bonito Oliva, Plectica,
Salerno 2011, and especially the essay by A. Tolve, entitled La ginestra o il fiore della critica
d’arte, 71-80.
22
rather to produce an archaeological and archival work à la Foucault that
is oriented to determining and mapping those procedures can give back
to the work of art its value as object of knowledge and instrument for the
interpretation of reality.
In this perspective, for Trimarco, who in 1974 published L’inconscio
dell’opera. Sociologia e piscoanalisi dell’arte [The Artwork’s
Unconscious: Sociology and Psychoanalysis of Art]12, psychoanalysis
represents a model and a privileged method of investigation, as Freudian
criticism not only throws into crisis the notion of unitary reason but
also calls into question “those biased endeavors that, founded on the
dissolution of languages, claim to put the ‘truth’ of their own discourse
on the pedestal of an all-embracing truth”13. Central to his thesis is
the Freudian notion of overdetermination, and therefore of overinterpretation, which Trimarco affirms to be an essential resource for a
critical work that we may want to be, or that actually is, interminable. In
so doing, on the one hand he highlights how uncertainty and transience
do not amount to deficiency or lack, but rather to a negation of the
absolute, while on the other he reflects on the strategies of normalization
(that is of reduction and regulation) of that infinite potential. In this
vein one should read the chapter entitled «Sulla critica interminabile
[On Interminable Criticism]» where Trimarco moves some criticism
to Ernst H. Gombrich’s iconological project, centered, as it is, on the
identification of the prevailing meaning of artworks and therefore aimed
at achieving results that are final, ultimate, and unquestionable. Quite
differently, Freud’s teachings, which Trimarco reads also in the light
of some Lacanian insights, offer themselves as a form of open critical
practice, an interpretative process – inclusion, exclusion – that is capable
of receiving deformation. Such interpretive operation is always indirect,
never frontal, and for this very reason capable of grasping meanings
and relations that are tangent and unexpected, also when it engages a
close and intense theoretical dialog with Mukařovský’s aesthetics, whose
reception in Italy has been tardive and fragmentary. Trimarco cannot help
underlying that «the relationship between signifier and signified, between
12 Officina Edizioni, Roma 1974.
13 Infra, p. - 100.
23
artwork-thing and aesthetic object is oblique and indirect», stresses upon
obliquity as the condition and guarantee of the deviation from acquired
knowledge performed by the artwork, and distances himself from any
deterministic relation between it and the social and historical conditions
of its creations – not by chance he finds «tortuous» the path along which
moves Hauser’s dialectic, another author that in the Parabola del teorico
is reexamined and reassessed.
In sum, through a staggering amount of references and themes, textual
analyses and veiled but recognizable polemical prompts, the discussion
on art and criticism that Trimarco brings up appears first of all to be a
remedy against the (postmodern?) drifting away of a criticism without a
theory and chooses to beat a wearing and challenging path, dotted with
obstacles and wild cards, consisting in the progressive widening of the
disciplinary boundaries. It must be made clear, however, that such an
option does not entail to give up to the task of the art critic, but rather to
put into question the rigidity and the reassuring methodological fences
forcing the artwork to relinquish its subversive potential and to annihilate
its independent nature. In this sense, the critical itinerary envisaged here
– transversal, tortuous, interminable – maintains unaltered its paradoxical
topicality. La parabola del teorico is the product of epistemological
conditions largely different from the contemporary global scenario, from
those issues of identities and from those conflicts of the global art world
to which Trimarco devoted some important essays at the beginning of
this century14. But the very fact of being heavily imbued with the spirit of
the 1970s, an age pressed by urgent and specific matters, maintains the
book militant quality, its praise of criticism and art as reflective practices,
forms of knowledge, and ways of bringing into question the status quo.
Therefore, setting aside the distance that separates us from those critical
and artistic endeavors that nowadays have probably been forgotten – I am
thinking of Karel Teige and his theses on the art market, or to the group
revolving around the journal Peinture and its sophisticated theoretical
tenets – what is alive in Trimarco’s book is the idea of a research that
does not shy away from risk and whose judgments may be one-sided
not because of lack of critical attention but as they aim at being so.
14 See at least, A. Trimarco, L’arte e l’abitare, Editoriale Modo, Milano 2001; Id. Post-storia. Il
sistema dell’arte, Editori Riuniti, Roma 2006.
24
This research has proven effective not only as it has anticipated future
discussions on some key issues and recalled the attention, before others
did, on some important figures of critics – Kubler and his «anthropological
crossing» has never ceased to question us – but also because it has been
able to affirm advisedly the necessity of maintaining our eyes fixed on
our time, in order to deliver it from the indefiniteness of an eternal present
and to bring it back to the tensions and upheavals and to the failures
and lacerations of history. Of course, there will not be any teleological
nostalgia, but determination will be needed for those who do not wish
to yield to the seductions of contemporary presentism (Bishop), of what
Bruno Latour has defined the monstrous «Time of Simultaneity», the
breeding ground of any fundamentalism15: this in the awareness that the
path of a thought that is dialogical and open to the knowledge of the
Other is transversal and interminable, laborious and indispensable.
15 Cf. B. Latour, P. Weibel, eds. Making Things Public: Atmospheres of Democracy, MIT Press,
London 2005.
25
26
LA PARABOLA DEL TEORICO
SULL’ARTE E LA CRITICA
Gli anni settanta
Lo sfiorire del teorico
1. La figurazione, il Witz, il colore, i generi, la professione, le tecniche,
la decorazione, il debole, l’effimero, il caduco, l’incerto, il provvisorio,
il frammento, il brano, il soffice, l’instabile, il discontinuo, la catastrofe,
l’indifferenza, la seduzione. Ognuno di questi sostantivi è anche una
figura che evoca nomi e persone, gesti e comportamenti di una situazione
comune, della condizione postmoderna: una nozione inventata dai
sociologi e portata allo splendore da Lyotard. Usata, perfino senza
ritegno, dall’architettura, sfiorata dalle arti figurative che, per conto loro,
preferiscono altri emblemi.
Sembra esistere un filo che scorre tra le esperienze dell’arte più recente:
un’esperienza, per la verità assai diversificata e in movimento, che ha
lo sguardo puntato sulla storia e il passato, sulla memoria e il remoto,
sul ricordo e l’inattuale. Dunque, l’arte torna liberamente a tessere le
proprie arguzie e a lavorare sulla propria dinastia senza rimozioni
né censure. Il territorio dell’arte, dell’architettura come della pittura,
diventa così l’infinito campo delle pronunzie che l’hanno animato.
L’intero campionario dell’arte, delle arti maggiori come della storia delle
cose, diviene un segmento interminabile, una riserva, una latitudine,
un orizzonte ritrovato e da attraversare. Perciò, indifferentemente, si
confondono l’Avanguardia, il Movimento Moderno, il Novecento mentre
si affacciano scritture lontane come il mosaico o la ceramica.
Le nuove generazioni ci avvertono, allora, che è intervenuto un taglio nel
sentiero dell’arte, che si è interrotto e come disperso il passo abituale.
Quella continuità che ha dominato gli anni Settanta, trafitti dalla
progressiva smaterializzazione dell’opera, dalla riflessione sulla nozione
di arte, dal rapporto fra produzione intellettuale e produzione materiale,
dal posto del soggetto a dalla funzione del teorico.
Il fascino perverso della favola, i fragili percorsi dell’anima, l’indifferenza
per i linguaggi, l’amore che è anche tentazione per l’ornamento, l’uso
frenetico delle mani, il pianeta dell’infanzia (privata e collettiva), il
disseminarsi del soggettivo, impongono, certamente, intervalli e misure,
cadenze e ritmi specifici al corpo della pittura recente. In misura differente
e con diversa calibratura, evidentemente.
31
2. L’arte degli anni Settanta è solcata dalla vertigine del teorico, dalla
teoria come progetto unitario. È l’incontro con i grandi sistemi: sfilano,
così, lungo i sentieri dell’arte immagini ormai amiche, la Semiotica, il
Marxsismo secondo Althusser (e con un amore per il Maotsetungpensiero),
Freud avec Lacan, la Sociologia, l’Antropologia e, talvolta, il desiderio
demartiniano per le terre del rimorso.
Basta ricordare Kosuth e quella sua idea dell’arte dopo la filosofia: vale
a dire la fine della filosofia come metafisica e come finzione a favore
dell’arte che esibisce il rigore delle proposizioni analitiche e della pratica
semiotica. O quell’accanimento sull’investigazione dell’arte e non di un
suo genere, pittura, scultura che sia.
Tuttavia poteva capitare (ed è capitato, come vedremo) che Kosuth si
impigliasse nel Mistico. Ma questa circostanza gli è servita più tardi
per mutare sistema, per spostarsi dalle teorie analitiche del linguaggio
dell’antropologia, dal Wittgenstein del Tractatus appunto al dialetto delle
culture marginali e dei saperi periferici.
Questo spostamento è avvenuto compiutamente dopo The Tenth
Investigation, del 1975, proprio per l’intrecciarsi di due temi: la riduzione
dell’arte concettuale a stile e forma, a una variante dell’arte di avanguardia,
del modernismo. E insieme la necessità di cogliere nessi più precisi tra
arte, antropologia, storia1. Eludendo, però, il candore dell’arte di protesta
che è estetizzazione dell’azione politica (con un ricordo benjaminiano
non esplicitato).
La critica di Kosuth è rivolta al Modernismo, identificato con lo
scientismo e la logica della neutralità, con l’obiettività e le mitologie
che le sono connesse con la contemplazione e l’attitudine a stare fuori,
con la vocazione al disimpegno. Ma cosa significa per l’artista stare
dentro, essere impegnato, come intendere che l’arte è prassi? Kosuth,
con grande consapevolezza, non soltanto critica il mito scientista del
modello fisicalista ma anche certe zone (in vero molto ampie) della stessa
ricerca antropologica. «Poiché l’antropologo è al di fuori della cultura
che studia non è parte della comunità. Ciò significa che qualunque effetto
1 È un «public statement», pronunziato da Kosuth nel gennaio del 1975 in occasione della
mostra alla galleria Castelli di New York, ora riportato (alla nota 2 della parte III) in The artist as
anthropologist, «The Fox», 1, 1975, p.30.
32
egli abbia sulla popolazione che sta studiando è simile all’effetto di un
atto di natura. Egli no è parte della matrice sociale». La distanza da
questo modello antropologico avviene attraverso la riflessione di Stanley
Diamond e Bob Scholte (infatti «l’antropologia marxista di Diamond e
Scholte non è inclusa in questa generalizzazione…In verità, il loro ruolo
di antropologi richiede che siano impegnati»). La critica di Diamond e di
Scholte allo scientismo è, naturalmente, rifiuto «dell’inevitabile progresso
nel nome della scienza» divenuta «ideologia consacrata», negazione che
lo scienziato possa «permettersi di restare in gran parte indifferente al
proprio ambiente esistenziale, sociale, storico e filosofico», insistenza
sul fatto che lo scientismo «rimane largamente indifferente alla storicità
della prassi scientifica», dal momento che il «suo scopo trascendentale è
quello di stabilire e verificare leggi formali e verità eterne». Per questo
Diamond, radicalmente, dice che «l’antropologo deve essere uno storico».
Da questo punto di vista non fa meraviglia il paradosso di Kosuth:
«L’artista è un modello dell’antropologo impegnato». Non fa meraviglia
questo stretto legame che attraversa l’Are e l’Antropologia, l’Artista
e l’Antropologo. Ecco, dunque, il senso della proposta, The artist as
anthropologist. In senso che, privilegiando l’arte come prassi e come
analisi all’interno della cultura, la promuove a modello della stessa
antropologia (almeno di quella impegnata).
Così, ancora una volta, Kosuth, con raffinata destrezza, ripropone l’arte
come modello. Solo che questa volta, alla metà degli anni Settanta, l’arte
viene dopo lo scientismo e la stessa antropologia accademica (come anche
la chiama). Mentre l’arte dopo la filosofia era, si è ricordato, alla fine
degli anni Settanta, l’elogio del rigore e della tautologia, l’esplicitazione
di protocolli e di procedure verificabili. Era un voltare pagina con la
filosofia e l’idealismo, con l’estetico.
La critica al modernismo e allo scientismo colpisce con pari rigore l’iperrealismo, il Photo-realism, e lo statuto della storia e della critica dell’arte.
Il Photo-realism, infatti, interiorizzando totalmente l’ironia pop, diventa
la glorificazione dell’obiettività fotografica e della oggettività meccanica,
la «perfetta visione burocratica dell’obiettività». Così, «l’obiettività
meccanizzata, dipinta a mano, del Photo-realism, finisce in una frode
senza problemi, naturalmente, quando ci si rende conto che gli imbrogli
selezionati di una realtà intravista sono glorificati».
33
Il discorso sulla storia e la critica meritano, senza dubbio, un’attenta
riconsiderazione. Perché questo rinnovato e persistente rifiuto? Lo storico
e il critico si comportano come l’antropologo accademico, lavorano
concetti e nozioni con la stessa impassibilità e oggettività dello scienziato,
sono disimpegnati («dis-engaged»). Siamo alla questione. «Il motivo per
cui tradizionalmente non si è considerato artista lo storico dell’arte e il
critico è che a causa del Modernismo (Scientismo) il critico e lo storico
dell’arte si sono sempre mantenuti in una posizione esterna alla prassi…
ma facendo ciò resero la cultura natura. Questa è una delle ragioni per
cui gli artisti si sono sentiti lontani (alienated) dagli storici dell’arte e dai
critici».
Ancora una denegazione dalla funzione della storia e della critica, dunque.
Le ragioni adesso sono un po’diverse dai tempi di Art after philosophy,
come si dirà più avanti distesamente. A quel tempo il rifiuto investiva
l’ovvietà mediativa della critica, il suo essere considerata essenzialmente
strumento e tramite tra l’artista e il pubblico, fra la produzione e il
consumo. Adesso perché la storia e la critica dell’arte lavorano all’interno
di un paradigma scientista non meno burocratico e ufficiale del Postrealism. Allora come oggi, comunque, perché la storia e la critica non
sono arte.
Con molta lucidità (e lungimiranza) Kosuth, alla metà degli anni
Settanta, teorizza la fine del Modernism, solcato dalla perversione dello
scientismo e l’apertura al Post-Modern, come para-Marxist situation:
come condizione che rende possibile questa nuova figura. The artist as
anthropologist, e, insieme, differenti procedure culturali2. Un percorso
che, pur diversamente scandito, è tuttavia prossimo all’esperienza di
Art-Language che, negli stessi anni, prende a frequentare il materialismo
dialettico3.
Il cammino di Kosuth e di Art-Language è, dunque, singolarmente
opposto alla storia di Support/Surface, il gruppo di Cane e Devade che,
a partire dagli anni Settanta sperimenta la possibilità di pensare il corpo
2 J. Kosuth, The artist as anthropologist, cit., pp. 26, 30n., 5, 19, 26, 24, 25, 26, 29. Sulla
posizione di Diamond e Scholte si v. almeno il volume Antropologia radicale, a cura di Dell
Hymes, trad. it., pref., di M. Callari Galli, Milano 1979. Sulla questione arte uguale critica, si
cfr. F. Menna, Critica della critica, Milano 1980 (in particolare il cap. Contro l’interpretazione).
3 Il testo è Dialectical materialism, in «Extra», 2, 1974.
34
della pittura con Marx e Freud. Si dice con chiarezza, già dal primo
numero, di Peinture, cahiers théoriques, che un artista consapevole non
può lavorare al di fuori delle filosofie che riflettono la lotta di classe: lotta
di classe che la pratica pittorica, a sua volta, media all’infinito attraverso
il suo codice e la complessità dei suoi strumenti disciplinari. La pittura,
così da esercizio e riflessione sulla propria specificità si fa ora attenta
alle relazioni con le altre pratiche significative, si chiede in che misura
può trasformare sé da objet réel in objet de connaissance. In definitiva
in che modo la peinture può diventare un campo di lavoro dialettico
che prova sopra di sé le contraddizioni del reale determinato. Dunque,
la pittura è, althusserianamente, «pratica significante relativamente
autonoma» che s’inscrive nel «processo di conoscenza dialettica»: una
pratica surdeterminata dall’historie matérielle (in evidente polemica
con le concezioni meccanicistiche e riflessiologiche del marxismo). Un
campo dialettico perpetuamente in lotta, violato dalle contraddizioni, mai
conciliabile: un’ipotesi che coniuga Lenin a Mao e prende distanza dal
referto di Althusser che giudica astratto e descrittivo il celebre saggio
Sulla contraddizione4.
In vero, l’apertura al pensiero di Mao, alla questione orientale, diventa,
com’era prevedibile dopo il Maggio, printemps rouge, certamente sguardo
sulla rivoluzione culturale, ma, anche più specificatamente, riflessione
sulle teorie della pittura dell’antica Cina. Marc Devade non mostra dubbi
quando presenta la traduzione di un testo di Shi Tao, un luogo di confronto
utile a produrre le «basi teoriche della modernité», a rompere perciò con
la tradizione del modernisme. Infatti, «le matérialisme antique chinois tel
qu’il se transcrit dans les peintures anciennes pouvait servir à produire
une ropture-décalage destinée à analyser-subvertir l’evolution et la
tradition du modernisme». Una mentalità giudaico-cristiana, idealistica,
4 L. Althusser, Per Marx, trad. it., introd. di C. Luporini, Roma 1969, p. 76, n. 1. La risposta
di Sollers è in Sul materialismo, trad. it., pref. di P. A. Rovatti, Milano 1973, p. 63. Lo scritto
di Sollers è stato largamente utilizzato e discusso da Pleynet e Devade. Si v. di Pleynet almeno
l’introduzione, Contraddizione principale, contraddizione specifica, limitazione della lettura
a L’insegnamento della pittura, trad. it., Milano 1974 e di Louis Cane, A propos de «Sur le
matérialisme» de Philippe Sollers, in «Peinture, cahiers théoriques», 8-9, 1974. È abbastanza
interessante per questi e altri problemi che discuteremo seguire anche il dibattito avviato da Cane
e Devade su L’insegnamento della pittura. Cfr. L. Cane, Purquoi lire et travailler le livre de
Marcelin Pleynet: «L’enseignement de la peinture», in «Peinture», 2-3, 1972 e M. Devade, La
peinture et son double, in «Peinture», 4-5, 1972.
35
rassicurante5.
La distanza da Althusser tocca ancora un altro nodo, la questione del
soggetto. È a questo punto che scatta il dispositivo Freud/Lacan: un
dispositivo che, come si sa, è attivo anche in Althusser quando parla
della surdeterminazione («Storicamente e teoricamente è rivelatore
il fatto che Althusser, per dare conto di una difficoltà obiettiva del
funzionamento della dialettica materialistica, abbia dovuto “passare”
attraverso il riferimento freudiano: prova che essa non può essere scritta
nel linguaggio di una vecchia coscienza di se, di un antico dominio del
discorso in cui, continuamente, la dialettica idealistica si reintroduce»,
avverte Sollers, nume tutelare di Peinture), quando all’interno di Lire
le Capital sottolinea «la profondità di un secondo, del tutto diverso
discorso, il discorso dell’inconscio»6. Il soggetto di Supports/Surfaces
non è, però, un soggetto pieno, unificante, è semplicemente le sujet de la
peinture, il soggetto produttore della pittura. Così, all’inizio degli anni
Settanta, Supports/Surfaces pongono la questione della pittura come
pratica significante, come critica della svista empiristica (la distinzione
fra tableau e peinture) e idealistica, come rottura, coupure, décalage,
abbandono definitivo del modernismo. La modernità, il moderno, si
apre, invece, per il gruppo di Peinture come discorso serrato contro
le esperienze recenti dell’arte e la storia tenace che le sorregge, in
sostanza, contro un esercizio che non tiene conto delle trasformazioni
con le quali Marx, Nietzsche, Freud hanno segnato il corpo del mondo.
Il bersaglio immediato è, naturalmente, la régression arcaïque dell’iperrealismo, la reductio pseudo-théoriciste dell’arte concettuale, letti come
momenti della «fase declinante dell’imperialismo americano» e degli
alleati europei7. Esperienze lontane, oltre che da Marx, Nietzsche, Freud,
necessariamente anche dalla «radicale trasformazione» introdotta da
Cézanne nel sistema specifico della storia della pittura e da Lautrémont
5 M. Devade, Note sure «La Chine» et la modernité, in «Peinture», 8-9, 1974, p.119. Del resto
Peinture ha mostrato, a più riprese, testi filosofici artistici e politici cinesi; v. Textes philosphques
de la Republique populaire de Chine, in «Peinture», 4-5, 1972 e Textes philosphques de la
Republique populaire de Chine (2), in «Peinture», 6-7, 1973.
6 L. Althusser e E. Balibar, Leggere il Capitale, trad. it.. Milano 1971, p. 16.
7 M. Devade, La Peinture vue d’en bas, in «Peinture», 8-9, 1974, p. 19.
36
in quello della letteratura8.
Alla svista empiristica e idealistica, Cane e Devade (insieme a Sollers
e Playnet), l’intera formazione di Supports/Surfaces alleata di Tel
Quel, oppongono una pratica e una teoria materialistica e dialettica del
funzionamento della peinture e dei suoi meccanismi di produzione. E,
con grande lucidità, riaprono il tema delicato dei rapporti con il pubblico,
il mercato, i luoghi di esposizione, i modi di comunicazione. Ci sono
almeno due testimonianze che vale la pena di raccogliere, sono del ’73.
La prima, di Devade, riguarda la fondazione di Art Press, la seconda, di
Cane, riguarda Contemporanea e altre mostre fatte in Itala. La fondazione
di una nuova rivista, pur con tutte le contraddizioni che reca (ma il sistema
della pittura lavora appunto l’infinito delle contraddizioni), è per Devade,
fondamentalmente una tattica per forzare «un champ hégémonique qui
censurait toute analyse matérialist e historique psycanalitique de l’art»,
un «compromis dialectique donc avec un appareil de production sur la
base d’un travail pictural nouveau destiné à faire passer pratiquement la
théorie la plus avancée». Non meno esplicito Louis Cane. Certo, le grandi
mostre, il mercato, le gallerie intrappolano, smorzano le tensioni, rendono
ogni cosa omogenea all’altra: sono, appunto, luoghi di contraddizioni.
Contraddizioni secondarie, secondo il dettato di Mao, rispetto a quella
principale: al taglio idealismo/materialismo borghesia/proletariato.
Tuttavia «la scelta di questo terreno è determinata dal concentramento
di gallerie, musei, organi di stampa specializzata, ecc., che ne cinge e
ne delimita la geografia. Ciò significa che noi dobbiamo muoverci e
lottare attraverso queste stesse “istituzioni”. È in questo senso che va
considerato superato ed inefficace qualsiasi tentativo corporativista di
creare dei “circuiti paralleli” che agiscano contro il mercato dell’arte,
come anche sono superati i problemi piccolo-borghesi connessi al mito
della non-recuperabilità commerciale dell’oggetto fisico, il quadro, la
pittura stessa intesa come pezzo di tela, legno, colore, plastica, ecc.»9.
Alla metà degli anni Settanta, da provenienze diverse. Kosuth e ArtLanguage, Supports/Surfaces danno scacco al Modernism e si affacciano
8 Sulla «rottura» operata da Cézanne e da Lautréamont si v. Playnet, L’insegnamento della
pittura, cit., e Lautréamont, trad. it., Napoli 1971.
9 M. Devade, Note sur la situation idiologique et politique en peinture, in «Peinture», 8-9, 1974,
p. 192, e L. Cane, Qualche contraddizione nel campo della pittura, ciclostilato, 1973, p. 1.
37
sulla realtà inquieta e difficile del Post-Modern o della Modernità. Una
latitudine, il Post-Modern o la Modernità, che s’inscrive nell’ordine del
discorso marxiano, scandito, di volta in volta (come si è ricordato), nei
ragionamenti dell’antropologia di Diamond e Scholte o, più radicalmente
nell’intreccio di Lenin e Mao, Althusser e Lacan. A questa data, in
conclusione, s’incontrano il «controdiscorso» di Cane e Devade, di
Sollers e Pleynet con la «linea analitica» di Kosuth e Art-Language10. Ma
l’incontro dura un momento, giusto il tempo che occorre per tornare a
separarsi, per prendere, ognuno, la propria strada. Una via che conduce,
nuovamente, dall’altra parte.
A prendere l’altra via questa volta è proprio Peinture: il cammino condurrà
presto al di là dei grandi sistemi, oltre il marxismo e la psicoanalisi,
lontano dalla semiotica e dall’utopia della trasformazione sociale. I primi
avvisi sono già del ’74: li offre ancora Sollers, Psicoanalisi e semiotica:
alcune tesi. E le tesi sono brucianti. «L’avvenire della psicoanalisi è
quello di venire a porsi, sempre più “al posto” della religione. Di essere
la verità… di questa illusione»11. La critica al potere della psicoanalisi,
alla sua sacralità, al suo governo assoluto rinvia ai veleni di Deleuze e
Guattari, alla tomba di Edipo. Ma, quel che più conta, è che la psicoanalisi
diventa, come più tardi il marxismo, un modello globale, asfissiante, di
controllo, uno sguardo totalizzante, un’ideologia carceraria.
Il cammino di Peinture, ancora una volta, è strettamente collegato al
destino di Tel Quel, ai suoi sommovimenti, alle scomuniche alle dipartite
furenti, alle svolte radicali. La più clamorosa, nel ’77, è l’assunzione del
modello americano dopo lo sfiorire del vento dell’est, dopo che la Cina
è sempre più perduta. E, insieme, l’abbandono di Marx, Lenin, Mao,
Althusser per amore dei nuovi filosofi, di Lévy, di Benoist.
La rotta suggerisce, ora, che la ragione è totalitaria, che lo Stato è
sempre repressione, che «non esiste reale differenza tra il pensiero
tecnocratico, quello del “desiderio” e il socialismo», che il «socialismo
non è l’alternativa del capitalismo bensì la sua forma meno riuscita, ossia
semplicemente concentrazionaria», che la «barbarie dal volto umano
10 Si v. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Torino 1975, pp.
96-113.
11 Ph. SOLLERS, Psicoanalisi e semiotica: alcune tesi, in Psicoanalisi e semiotica, a cura di A.
Verdiglione, Milano 1975, p. 136.
38
è innanzitutto una ripresa e un approfondimento dell’analisi del fatto
totalitario come fatto moderno», che il «razionalismo e la sua punta
sistematizzata, il marxismo, fungono da religione del nostro tempo», che
il Gulag è l’emblema della nostra condizione razionale, che Solženicyn è
il dante del nostro tempo (secondo l’immagine di Lévy) o Arnaud12.
Questo mutamento scuote Tel Quel e, in misura meno clamorosa ma non
meno profonda, tocca Peinture, la segna e la indirizza diversamente. Del
resto, anche al di là del clamore dei nuovi filosofi, si vive in Francia,
come del resto da noi la crisi del marxismo: crisi di modelli, rifiuto del
socialismo reale, difficoltà ad articolare un pensiero trasparente, contrasti
sempre più duri fra intellettuali e partito, fra vertice e base. Il caso di
Althusser è davanti agli occhi, tra eresia e scomunica. Il suo pamphlet,
Quel che deve cambiare nel partito comunista, è un viatico: si legge
appunto del «partito modellato sull’apparato di Stato e sull’apparato
militare», si fa sapere che «tutto si decide al vertice», si invita a «uscire
dalla fortezza», a stabilire rapporti meno filistei con le masse13.
Certo, dal millenovecentosettantasette, la Modernità non può essere più
identificata da Cane e Devade, da Pleynet con la stella del marxismo.
La peinture non è più una pratica significante ricollegata, secondo i
propri modi di riproduzione, alle altre forme del sociale. L’autocritica di
Marceline Pleynet, del resto, diventa un transito obbligato. Rileggendo
adesso, L’enseignement de la peinture, Pleynet ne critica la trama che
lo sorregge: la suggestione, appunto, che l’arte possa essere partecipe
«dell’organizzazione complessiva della struttura sociale, politica,
ideologica ed economica»14. E Devade, dal canto suo, sottolinea che
l’intervenire sulla pittura ora «vuol dire rivendicare quel che costituisce
la specificità del pittore, ossia il fatto che egli lavora nel mutismo, più
vicino alla materia non detta e che non dice niente salvo metterla in conto
alle parole». La questione, perciò, è proprio questo legame tra mutismo
e parola, verbalizzazione e silenzio («Anziché prendere la parola,
il pittore fa silenzio e dal fondo della sua sofferenza lancia i gesti del
12 Ph. Sollers, La rivoluzione impossibile, in I nuovi filosofi, introd. Di W. Pedullà, nota di M.
d’Eramo, Cosenza 1978, pp. 144, 145, 146, 147, 148.
13 L. Althusser, Quel che deve cambiare nel partito comunista, trad. it., Milano 1978.
14 M. Pleynet, La scena dell’arte, in L’arte e la psicoanalisi, a cura di A. Verdiglione, Milano
1979, p. 195.
39
colore»). Ora il discorso investe l’unicità della pittura e il commento che
tenta di doppiarne il silenzio: l’accusa è rivolta, irrimediabilmente, alla
parola e alla tradizione logocentrica della nostra cultura. Una civiltà che
privilegia la parola ma anche lo sguardo, gli occhi non meno del verbo:
«L’occhio calcola i resti, cifre, decifra. Attraverso l’occhio il discorso
congiungerà il gesto alla parola per frane il suo rapporto, per rimetterne
nel senso comune dello sguardo, della comunicazione quel che sfugge e
che nessuna parola soddisfa». Invece, conclude Devade, «il gesto unico
della pittura non può essere decifrato: l’uno non è un numero»15.
Il mutamento è evidente: il pourmarxsismo e Mao lasciano il posto a
Foucault, a Derrida, a Sollers ormai nuovo filosofo. Con la conseguenza
che la pittura è sempre più vicina all’assenza e al silenzio, al mutismo, e
la critica, il commento, sono nuovamente esiliati nel dominio del Logos.
Sollers, rileggendo Lévy, non ha esitazioni: «L’intellettuale…da ora in
poi potrà essere solo “metafisico, artista, moralista”. Non stavamo forse
per giudicare colpevole una simile affermazione? Di vergognarcene? E
ora eccola: è il dissenso del nostro tempo ed è antico e nuovo come ogni
resistenza al Principe che pretende, grazie alla nostra rinuncia, di regnare
eternamente in questo mondo. Sottolineo il termine “artista” senza il
quale, a mio avviso, i due altri non significano più nulla»16. Ma artista,
lo sappiamo da tempo, significa dispendio, rottura del senso Spaltung,
traccia, vertigine, dissenso.
Non c’è dubbio, tuttavia, che l’arte e la pittura continuano a essere
investita da uno spessore teorico forte, da responsabilità marcate, da
un surplus di decisioni che, come vedremo, le generazioni più recenti
abbandoneranno. L’arte degli anni Settanta gioca, comunque, un ruolo
critico di primo piano. E non solamente l’arte concettuale o peinture. Si
pensi, per un momento, all’art sociologique di Fischer, Forest, Thénot:
al loro progetto di una pratica utopica negativa e socio-analitica. All’idea
dell’arte come pedagogia negativa, alla strategia d’attacco ai media
(tanto da meritare perfino un elogio di McLuhan), all’animazione come
modello d’incontro. La domanda è la stessa, anche se i riferimenti sono
15 M. Devade, La pittura… più da vicino, in L’arte e la psicoanalisi, cit., pp. 188, 193.
16 Ph. Sollers, La rivoluzione impossibile, cit., p. 149.
40
diversi: «Comment penser le matérialisme aujourd’hui?»17.
3. C’è Clemente come riprova. Una sua opera. Foucault occupa il centro
del quadro e tutt’intorno, ai lati e in alto, la sua mano reca frammenti
scrupolosamente dipinti. Un’archeologia del sapere e del pensiero e
insieme i pensieri dell’archeologia, avverte l’autore con uno dei suoi
Witz.
Così, il declino del teorico costituisce, radicalmente, il tratto che distingue
il lavoro degli artisti dell’ultima generazione. Lo sfiorire del teorico reca
con sé l’abbandono dei grandi temi: il Soggetto, la Smaterializzazione
dell’opera, la Pittura come valore d’uso, l’Ideologia, l’Arte come
segmento per niente privilegiato nella griglia della storia delle cose, il
Reale e l’Iperreale, la Simulazione.
Si sa, da tempo, di Baudrillard, dell’angelo di stucco («Lo stucco è la
democrazia trionfale di tutti i segni artificiali, l’apoteosi del teatro e della
moda…Nelle chiese e i palazzi, lo stucco sposa tutte le forme, imita
tutte le materie, i tendaggi di velluto, le cornici di legno, le rotondità
carnali dei corpi. Lo stucco…specie di equivalente generale») e del
trompe l’oeil («Nel trompe l’oeil non si tratta di confusione con il reale;
si tratta di produrre un simulacro con la piena consapevolezza del gioco
e con l’artificio…mimando e oltrepassando l’effetto di reale, gettare
un dubbio radicale sul principio di realtà»), della seduzione, perché se
ne riparli con accanimento18. Tuttavia non si può rivolgere un pensiero
alla soluzione finale: al suggerimento che «…l’arte è ovunque, poiché
l’artificio è al centro della realtà. Così l’arte è morta, perché non soltanto
la sua trascendenza critica è morta, ma perché la stessa realtà, interamente
impregnata d’una estetica che dipende dalla sua stessa strutturalità, s’è
confusa con la propria immagine». Ancora una volta l’arte muove perché
è ovunque, nel cuore come ai margini della realtà. Solo che adesso la
morte dell’arte no esprime più la tensione a bruciare lo spazio che la
separa dalla vita, non inscena questa separatezza, ma cinicamente dice
17 H. Fischer, Théorie de l’art sociologique, Tournai 1977 e H. Fischer, F. Forest, J.-P. Thenot,
Collectif art sociologique. Théorie- Pratique-Critique, Musée Galliera, Paris 1975 (il giudizio di
McLuhan del 2 agosto 1972 è a p. 49).
18 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, trad. it., Milano 1979, p. 63 e Della seduzione,
trad. it., a cura di P. Lalli, Bologna 1980, p.90.
41
che la realtà e l’immagine, il vero e il falso, il naturale e l’artificiale,
sono parimenti simulacri e finzioni («il vecchio slogan “La realtà supera
la finzione”, che corrisponde ancora allo stadio surrealista di questa
estetizzazione della vita, è superato: niente più finzione alla quale la vita
possa confrontarsi, sia pure vittoriosamente – è la realtà intera passata al
gioco della realtà – disincantamento radicale, stadio cool e cibernetico
che succede alla fase hot e fantasmatica»19.
La morte dell’arte ha perduto, dunque, la sua forza utopica (la fine
dell’arte come sistema di tecniche specializzate e scissura dell’esistenza)
per divenire l’orizzonte in cui s’inscrivono le finzioni, in cui cessa la
distinzione, qualunque distinzione, fra l’arte e i media. La curvatura, forse
meglio, che segnala l’illimitata occupazione dei media, il loro dominio.
Il problema, allora, per le nuove generazioni non è tanto quello di
preparare trappole e innescare micce, aprire varchi e luoghi inediti, nella
latitudine della morte dell’arte, né quello di continuare, utopicamente,
a dare battaglia alla galassia dei media, quanto quello di lavorare il
patrimonio dell’arte, questo artificio che è la sua storia, liberamente e
con indifferenza.
L’indifferenza dei linguaggi, la loro equivalenza, nate dallo sfiorire
del teorico, caratterizzano senz’altro la linea dell’arte postmoderna,
il Post-Modern. L’indifferenza e l’equivalenza dei linguaggi è,
fondamentalmente, la caduta dei valori e della loro gerarchizzazione.
Valori inestimabili sono stati, per oltre mezzo secolo, l’Avanguardia e
il Movimento Moderno. In sostanza, la tendenza che ha definito l’arte
buona e l’arte cattiva, l’architettura di ricerca e l’architettura della falsa
coscienza. Avanguardia e Movimento Moderno sono diventati garanzia
di sperimentazione e, perfino, di sensibilità progressiva. Certo, nell’arte
postmoderna, Transavanguardia o Nuovi Nuovi, non c’è quella rabbia
e quella violenza che serpeggia nella geografia dell’architettura, dove
l’attacco allo star system e allo stato funzionalista del Movimento Moderno
19 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, cit., pp. 89,87.
42
segna momenti di innegabile incandescenza20. Questo comportamento
più pacato e sereno nei confronti dell’Avanguardia si spiega con il fatto
che, da più di vent’anni, i conti con la tradizione del nuovo sono stati
elusi né rimossi. Del resto lo conferma, in tempi più recenti, la stessa
esperienza storiografica. Non è un caso, infatti, che sia saltato, di recente,
uno dei confini più sicuri della storia dell’arte contemporanea, quello tra
l’Avanguardia e il Novecento, appunto. D’altra parte l’arte concettuale
ha mostrato l’inutilità, la non necessità di riferirsi all’Avanguardia
nell’elaborare la più decisa proposta di smaterializzazione dell’oggetto
artistico.
Ora, la storia dell’arte, tutta intera la storia dell’arte, si presenta al vaglio
degli Anni Ottanta come uno sconfinato cielo di segni e di figure, di
risoluzioni e di scarti, persistenze linguistiche assolutamente indifferenti
ed equi-valenti. Cadono, così, le gerarchie e si azzerano i valori, si
cancellano i privilegi e le remore, i rimorsi e i pentimenti. Questi materiali
e queste memorie diventano solamente tessere del gioco, momenti e
transiti incerti. Come tessere, non meno provvisorie, sono i referti e i
ricordi delle culture basse, i loro sistemi di tecniche. E ancora. Insieme
al repertorio delle forme della storia dell’arte e della cultura materiale
ritroviamo scandalosamente, pezzi di autobiografia e schegge di privato,
quel lento fluire della soggettività, gli inciampi del ricordare e il velo
della favola. Il ritorno del soggettivo, dunque, come pareggiamento del
linguaggio interiore e del linguaggio pubblico, del silenzio e del rumore,
dell’Infanzia e della Storia. Bonito Oliva, rileggendo Nietzsche, ricorda
che «Zarathustra non vuole perdere nulla del passato dell’umanità, vuole
gettare ogni cosa nel crogiuolo». E «questo significa non avere nostalgia di
niente, in quanto tutto è continuamente raggiungibile, senza più categorie
temporali e gerarchie di presente e passato, tipiche dell’avanguardia che
ha sempre vissuto il tempo alle spalle come archeologia e comunque
come reperto da rianimare»21.
20 P. Portoghesi, Dopo l’architettura moderna, Bari, 1980. Si cfr. almeno Ch. Jenks, The
language of Post-Modern Architecture, London 1977, Late-modern Architecture, New York 1980
e C. Ray Smith, Supermannerism. New Attitudes in Post-Modern Architecture, New York 1977.
Ricognizioni puntuali sono in C. De Seta, Origini ed eclissi del Movimento Moderno, Bari 1980
(in particolare la presentazione) e M. L. Scalvini, Prima e dopo il Post-Modernism, in «Op. Cit.»,
maggio 1980.
21 A. Bonito Oliva, La Transavanguardia italiana, Milano 1980, p. 54.
43
La critica al tempo lineare, rettilineo, uniforme e l’idea dell’arte come
simulacro («Il simulacro sta agli antipodi del travestimento e dello
spettacolo: la sua doppiezza è senza colpa, il suo velo è trasparente. La sua
innocenza è appunto connessa al fatto che non nasconde nulla, o meglio
non nasconde il nulla», suggerisce Perniola), eclettismo e Supermannerism
sottolineano, in varia misura e con diversa consapevolezza, la fine di
un’esperienza che ha fissato nella profondità e nell’originalità il suo
modello e la sua verità. Una ricerca che ha guardato al passato come cifra
e come nostalgia e non come a un gioco in cui si potessero prendere nelle
maglie i sacri concetti e le nozioni inviolabili. Ora, invece, il Mannerism,
mille volte invocato in questi anni per l’eresia e la sovversione del
suo «spazio», ricompare sulla scena in compagnia di Supermann e il
Trauerspiel barocco si riaffaccia proprio per quell’infinito rimando della
copia alla copia, della finzione alla finzione22.
Di recente Habermas, riconducendo il problema alla radice, ha innescato
nel dibattito il nero del neoconservatorismo: il problema, in sostanza,
investe una questione di fondo, la svolta conservatrice per via della perversa
«alleanza del postmoderno col premoderno». L’attacco al moderno
è, fondamentalmente, vagheggiamento del lontano e dell’arcaico,
dell’evocazione (Bataille, Foucault, Derrida), è tensione verso «un’etica
cosmica della problematica ecologica» (Jonas, Spaemann), è infine una
politica della scienza che acceleri «il progresso tecnico, la creatività
capitalistica e una ammirazione razionale». È quel disegno, insomma,
che, delimitando rigorosamente (e rigidamente) la scienza, la morale e
l’arte in ambiti specifici da affidare ad esperti di settore, fa che «della
modernità culturale» rimanga «solamente ciò che si può ottenere dal
moderno sacrificando il progetto moderno». Il nodo per Habermas è
quello di ritentare il progetto moderno, puntando, magari con più cautela,
ancora su una linea unitaria di intervento e sulla forza dell’utopia che è
propria dell’arte, sull’implacabile rifiuto degli specialismi e delle regioni
separate23.
22 M. Perniola, La società dei simulacri, Bologna 1980, pp. 171, 170.
23 J. Habermas, Moderno, Postmoderno e Neoconservatorismo, trad. it., in «Alphabeta», marzo
1981, p. 17. Si v. anche Theorie des Kommunicativen Handelns, Frankfurt am Mein, 1981.
Estremamente positivo è il giudizio di Thomás Maldonado, Il movimento moderno e la questione
«post», in «Casabella», nov.-dic. 1980.
44
La posizione di Habermas è una difesa estrema del moderno, dell’arte
d’avanguardia, del pensiero negativo e dei suoi recenti approfondimenti.
Ma è in parte nostalgica: è l’evocazione di ciò che è andato perduto e
si è consumato, di un modello che non è più riproponibile. Il declino
del teorico è, appunto è l’orizzonte lungo il quale questo progetto si è
assottigliato, si è sfibrato fino a morire. È quella curvatura che si dice di
un sapere incerto e caduco, che parla il linguaggio dell’Unsicherheit e
della Vergänglichkeit. Un sapere che suggerisce all’arte di non mettersi
al posto della filosofia o della scienza, di non occupare i recinti di Utopia.
(1981)
45
L’arte dopo la filosofia (e altre considerazioni)
«… L’arte è analoga a una posizione analitica, e … solo un’arte
tautologica può tenersi a distanza da presupposti filosofici»24. Kosuth,
dunque, senza preamboli ci segnala la strada che intende percorrere, i
suoi interessi, le ragioni e i racconti che ha scelto, lungo i quali lavora.
Cerchiamo di registrare questi motivi: li indicherei anzitutto nella critica
alla filosofia hegeliana nell’adesione, insieme, al positivismo logico, alla
filosofia analitica. Ma (ed è questo un punto che dovrà essere calcolato
con precisione) bisognerà accertare anche tutti gli spostamenti, gli
slittamenti che Kosuth compie all’interno dello stesso universo logico
e analitico. Ma andiamo avanti con ordine, e quindi ripartiamo da
Hegel. Giacché si capisce che Kosuth rovescia, e radicalmente, l’ipotesi
hegeliana, il cammino dello Spirito Assoluto. In Hegel, si sa, è la
filosofia che viene dopo l’arte. Arte, Religione, Filosofia sono, infatti,
i movimenti attraverso i quali lo Spirito viaggia per divenire in sé e per
sé (il grande vetro dell’autocoscienza). «La forma di questo sapere è, in
quanto immediata (il momento della finalità dell’arte), da una parte un
dirompersi in un’opera di esistenza esterna e comune...; dall’altra parte,
essa è l’intuizione concreta e la rappresentazione dello spirito assoluto in
sé come dell’ideale; - della forma concreta, nato dallo spirito soggettivo,
nella quale l’immediatezza naturale è soltanto segno dell’idea». Mentre
la filosofia, si continua a leggere nell’Enciclopedia, è «l’Idea che pensa se
stessa col significato che, la verità che sa, la logicità, essa è l’universalità
convalidata dal contenuto concreto come dalla sua realtà. La scienza
è, per tal guisa, tornata al suo cominciamento»25. La perlustrazione, del
resto, di altri testi, della Fenomenologia dello spirito, per esempio, o, più
specifici per il nostro discorso, dell’Estetica, conferma punto per punto
l’assunto già registrato nell’Enciclopedia. La critica che Kosuth muove
alla filosofia, in quanto sapere assoluto, non riguarda soltanto, a pensarci
24 J. Kosuth, Dopo la filosofia, trad. it. (e soltanto la prima parte del testo pubblicato da Art
International, oct.-nov.-dic. 1969) in «Data», n. 3, aprile 1972. Tutte le citazioni si riferiscono a
questa traduzione.
25 G. W. Hegel, Enciclopedia, trad. it., III ed., Bari 1951, parr. 556 e 574 (rispettivamente alle
pp. 504 e 527-28).
47
bene, la sua assolutezza. Riguarda e investe, in maniera più decisiva e
estrema, il significato stesso della filosofia in quanto sapere scientifico.
Col sapere filosofico, nel discorso hegeliano, la scienza torna al suo
cominciamento. Per Kosuth, invece, perché ci sia sapere la filosofia deve
morire e al suo posto deve splendere l’arte. «L’influenza hegeliana ha
portato la maggior parte dei filosofi contemporanei ad essere poco più
storici della filosofia, Bibliotecari della verità, per così dire. Si comincia
ad avere l’impressione che non c’è più niente da fare; e certamente,
una volta realizzate le indicazioni del pensiero di Wittegenstein e della
filosofia da lui influenzata e a lui successiva, non è più il caso di prendere
in seria considerazione in questa sere la filosofia continentale».
Kosuth lavora, esplicitamente, su due fronti: critica la filosofia hegeliana
con gli argomenti e gli strumenti messi a punto dalla filosofia analitica
ma, al tempo stesso, ne radicalizza le posizioni teoriche, giacché ritiene
infruttuosa l’ipotesi che la filosofia possa continuare a svolgere un ruolo
interamente critico. «Possiamo considerare una qualunque particolare
teoria filosofica…come la rivelazione di qualche parte della struttura di
un dato linguaggio», aveva detto Ayer, un autore vitatissimo da Kosuth.
Ma ora, seconda l’artista americano, anche questo compito, indicato
precocemente dal Tractatus wittgensteiniano, si è esaurito. Perciò Kosuth
può concludere che, se la filosofia analitica è una «filosofia a una sola
marcia», la filosofia continentale (la fenomenologia e l’esistenzialismo,
segnatamente) no dispone neanche di questa sola marcia.
Si è detto che Kosuth rovescia l’ipotesi hegeliana e radicalizza
l’argomentazione wittgensteiniana e del positivismo logico sul ruolo
del discorso filosofico. D’altra parte, come vedremo, Kosuth no è meno
radicale (e questa volta proprio nei confronti della filosofia analitica)
sulla funzione dell’arte. A proposito rovescia di centottanta gradi l’ottica
del neopositivismo. Riprendiamo ancora da Ayer. «Ci disporremo a
dimostrare che, nella misura in cui sono significative, le affermazioni
di valore sono normali affermazioni scientifiche; e, nella misura in cui
non risultano scientifiche, non sono significative nel senso letterale
della parola ma sono semplicemente espressioni di emozioni, che non
possono essere né vere né false. Nel sostenere questa prospettiva, per il
momento ci possiamo limitare al caso delle affermazioni etiche. Quanto
diciamo di queste si troverà che vale, mutatis mutandis, anche nel caso
48
delle affermazioni estetiche»26. Ayer, dunque, nel 1946, riafferma una
nozione centrale della filosofia analitica: la netta distinzione tra enunciati
scientifici ed espressioni emotive. Le proposizioni della scienza da una
parte e, dall’altra, le affermazioni etiche, la metafisica, la parola dei poeti.
«La differenza fra chi si serve del linguaggio in modo scientifico e chi se
ne serve emotivamente, non sta in una produzione d’enunciati che non
possono ispirare emozioni contrapposta a una produzione d’enunciati
privi di senso, ma nel fatto che alcuni si preoccupano fondamentalmente
di esprimere proposizioni vere e altri di creare opere d’arte»27. Ayer, in
conclusione, sulla linea Russell-Wittgenstein-Carnap-Richards (per
citare nomi emblematici) conferma che il discorso dell’arte è un discorso
emozionale, sintomo di una condizione emotiva, mai attraversato né
sfiorato dal discorso logico. Una linea che, come sappiamo, troverà altre
conferme (e, quel che più conta, specifiche per le nostre ipotesi). Infatti è
sicuro che Morris ha offerto, nell’ambito del disegno teorico fino ad ora
registrato, un contributo fondamentale alla riformulazione del discorso
estetico. Nei documenti specifici, Aesthetics and the Theory of Sign e
Science, Art and Technology, Morris, infatti, si domanda quale sia lo
statuto segnico del discorso estetico (che è discorso non intorno all’arte
ma sulle opere d’arte). Il discorso estetico, in quanto discorso che lavora
in particolare sulla struttura segnica, rinvia alla dimensione sintattica. I
segni che costituiscono il discorso estetico sono segni iconici: segni, ciò,
che incorporano dentro di sè alcuni tratti, alcune proprietà, dell’oggetto
designato. «In altre parole (adesso è Dorfles che parla di Morris),
il segno estetico è un segno iconico in cui il designatum è un valore
(value). Considerato sotto questo aspetto, l’artista è colui che si vale di
un medium in maniera tale da fargli assumere il valore d’una esperienza
significante; e l’opera che ne deriva ha – come icone – la proprietà che
il valore designato è incorporato nell’opera stessa… Per questo l’arte si
può considerare come quel linguaggio che serve alla comunicazione di
26 A. J. Ayer, Linguaggio, verità e logica, trad. it., a cura di G. De Toni, Milano 1961, pp. 128-29.
27 A. J. Ayer, op. cit., p. 28.
49
valori»28.
Il discorso estetico, dunque, comunica e presenta valori, ma non li discute,
non può porre, in altri termini, asserzioni come la scienza. Il progetto
di Charles Morris, in sostanza, non sposta l’ottica dell’arte (o discorso
estetico) intesa come discorso emozionale. Tuttavia non c’è dubbio che,
rispetto ai dati precedenti, arricchisca la dimensione estetica di indicazioni
e sollecitazioni che non possono essere trascurate. E poi (sottolineature
decisiva) che il segno, e quindi anche quello estetico (però talvolta
c’è anche qualche incertezza), è una totalità. Leggiamo direttamente i
Lineamenti. «… Implica è un termine della sintattica, designa e denota
sono termini della semantica, esprime è un termine della pragmatica. E
siccome le varie dimensioni sono soltanto aspetti di un processo unitario
ci saranno talune relazioni fra i termini delle varie branche e saranno
necessari segni distintivi per caratterizzare queste relazioni e con ciò
il processo di semiosi come un tutto. Segno è un termine strettamente
semiotico, nel senso che sintattica o semantica o pragmatica da sole non
bastano a definirlo; invece tutti i vari termini delle sotto-discipline sono
semiotici solo se intendiamo semiotico nel senso più largo»29.
Senz’altro la nozione di segno come totalità deve essere prontamente
collegata con un’altra nozione (di Wittengenstein), ampiamente
richiamata da Kosuth: la nozione di contesto. «Il significato di una parola
è il suo uso nel linguaggio» dice una celebre proposizione delle Ricerche
filosofiche. «E non è possibile non sentire una tal quale aria di famiglia…
fra il contestualismo di Wittengenstein da un lato e, dall’altro, per
esempio: quanto già diceva Ferdinand de Saussure sul valore linguistico,
sulla lingua come sistema, sull’uso di modelli come quello offerto dal
gioco degli scacchi», per riprendere una nota di Rossi-Landi30. Infatti,
anticipando un po’le cose, sono appunto le nozioni di segno come totalità
e di contesto o sistema che Kosuth utilizza per la propria strategia, per
riformulare, contro le filosofie analitiche, il discorso artistico.
28 G. Dorfles, Simbolo e metafora come strumenti di comunicazione in estetica, in AA.VV., Il
pensiero americano contemporaneo, a cura di F. Rossi-Landi, Milano 1958, p. 64. Dorfles ha
ripreso e ampliato in lavori successivi la trama di questa rigorosa ricerca. Per i problemi in esame
si cfr. anche Morpurgo-Tagliabue, L’Esthétique contemporaine, Milano 1960, pp.219-275.
29 Ch. Morris, Lineamenti di una teoria dei segni, trad. it., introd. e comm. di F. Rossi-Landi,
Torino 1954, pp. 23-25.
30 F. Rossi-Landi, Il linguaggio come lavoro e come mercato, Milano 1968.
50
È inevitabile, a questo punto, almeno un riferimento alla Langer: l’arte,
per la Langer, è «simbolo di un sentimento…, è la creazione di forme
simboliche del sentimento umano»31. Certamente la Langer approfondisce,
come soltanto Richards aveva saputo fare tra il Venti e il Trenta, il
discorso dell’arte in senso specifico, soprattutto la decodificazione del
linguaggio musicale. Tuttavia non si discosta dalla traiettoria segnata
dalle filosofie analitiche: accoglie, perciò, la distinzione carnapiana tra
linguaggio scientifico e linguaggio libero, distingue nettamente i simboli
discorsivi dai simboli non discorsivi. E l’arte, naturalmente, è un simbolo
non discorsivo. Anzi, per la precisione non si potrebbe neanche dire che
l’arte sia un simbolo presentativo, visto che la Langer afferma che la
musica non lo è. Quando parliamo dell’arte, pertanto, ci troviamo di
fronte a un simbolismo emozionale: la conclusione non può che essere
questa, ancora una volta. Naturalmente non sono mancati tentativi
(che non sempre, però, sono stati valutati con la dovuta attenzione) di
dissenso e di rifiuto di questa tendenza: la storia delle idee estetiche
registra, infatti, una tenace querelle tra la teoria emozionale e la teoria
cognitiva dell’arte. L’arte, dunque, è un veicolo di conoscenza (e di quale
conoscenza?). Giustamente Dorfles, tra i primi ha ricordato il contributo
della Dorothy Walsh, The Cognitive Contento of Art. Per la Walsh l’arte
è «delineazione del possibile», dato che il possibile è una categoria
comune sia all’esperienza artistica che a quella scientifica o filosofica.
In questa prospettiva l’arte non è più né realtà puramente soggettiva né
espressione di emozioni o di stati d’animo e neppure l’oggettivazione
del reale («Essere possibile significa essere compossibile con un qualche
contesto esistenziale o concettuale»).
Gli scritti teorici di Kosuth, le sue dichiarazioni, non offrono sufficienti
spie per confermare, sul piano filologico, questo complesso reticolato
di riferimenti. Tuttavia è innegabile che se non si tiene conto e non
si ricollega la tematica di Kosuth al vivo di questo dibattito – teoria
emozionale o cognitiva del discorso artistico – difficilmente se ne potrà
comprendere la portata innovativa. Soltanto inserita in questa griglia è
possibile considerare Art after philosophy come un testo di semiotica
dell’arte: precisamente l’ultima scena di un dibattito iniziato negli anni
31 S. K. Langer, Sentimento e forma, trad. it., Milano 1965, p. 57.
51
venti e, forse, anche prima. L’ultima scena che proclamava appunto
l’arte un’esperienza da porre alla stessa altezza dei discorsi scientifici.
L’arte ha, dunque, uno statuto segnico simile a quello della logica e
della matematica. In questo senso l’arte viene dopo la filosofia: perché,
finalmente, analoga a una proposizione scientifica.
Kosuth per il suo progetto pretende che si tengano ben distinti l’arte e
l’estetica. «L’estetica concerne le opinioni sulla percezione del mondo in
generale» a differenza dell’arte che non stabilisce relazioni con il mondo,
che non è mediazione, ma è invece tautologia. «Solo un’arte tautologica
può tenersi a distanza da presupposti filosofici». Ecco ricomparire
l’ombra acerrima del nemico: la filosofia continentale, fenomenologia
ed esistenzialismo, che è senz’altro una filosofia dell’opacità e della
mondanità, della corporeità e del sensorio, dell’estasi. Perciò Kosuth la
rifiuta. Perché avverte che l’arte per diventare conoscenza deve liberarsi
di qualsiasi memoria di realtà e di mondanità, di referenzialità, deve
diventare tautologia e assumere lo statuto di proposizione analitica. In
verità, Kosuth è estremamente rigoroso e preciso su questo punto. L’arte
(insiste) «… non è propriamente l’attività di costruire proposizioni
artistiche, ma un elaborare, uno sviscerare tutte le implicazioni di tutti gli
aspetti del concetto arte». Il piano è, così, elaborato: non si tratta neppure
di costruire proposizioni artistiche quanto di sviscerare in ogni sua faccia
il concetto arte. Per questo Kosuth non esita a dire che «essere artisti
significa interrogare la natura dell’arte» e non una sua specificazione, la
pittura o la scultura. Fare pittura, scultura, è il modo estetico di fare arte:
cioè, che è lo stesso, non è fare arte.
Joseph Kosuth, nel 1970, nell’Introductory Note by Amerian Editor di
Art-Language (un documento del resto abbastanza frequentato) rende
àncora più esplicito, polemicamente il suo punto di vista, insistendo su
tre nozioni-chiave: estetico, reattivo, concettuale. «L’estetico prende in
considerazione l’elaborazione dei dati percettivi e, data l’immediatezza
dell’esperienza, l’arte è ricondotta a un semplice punto di partenza
umano per voli percettivi, allineandosi così (e competendo) con le fonti
naturali delle esperienze visive… L’artista è pertanto escluso dall’attività
artistica…, non è concettualmente implicato nella costruzione della
proposizione artistica». L’artista non svolge così alcuna funzione critica,
è soltanto uno strumento per l’elaborazione di stimoli, non partecipa
52
alla costruzione della proposizione artistica. Kosuth intende la nozione
di estetica come aisthesis, etimologicamente appunto come «analisi
della percezione». Per il secondo punto, l’arte reattiva, Kosuth è ancora
più deciso: «L’arte reattiava è l’immondezzaio, per lo più, delle idee
artistiche del XX secolo: rimandi di ogni genere, evoluzionismi, pseudostoricismi, culto della personalità, eccetera; la maggior parte delle quali
possono essere agevolmente descritte come una successione di azioni
inconsulte dominate dall’angoscia»32. L’arte reattiva si fonda sul come,
si fonda, cioè, sull’abilità e la tecnica, sull’esterno (sui materiali). Non
lavora, dunque, sulla natura dell’arte, non costruisce dall’interno, non
sviscera tutte le implicazioni dell’idea dell’arte. Il nodo è invece un altro:
è l’Art as idea as idea. Infatti, «tutte le indagini a cominciare dalla prima
(1966) hanno avuto come sottotitolo Arte come idea, come idea»33.
L’investigazione di Kosuth si pone, dunque, su un’altra frontiera:
«L’arte concettuale… è una ricerca condotta dagli artisti che capiscono
che l’attività artistica non è esclusivamente limitata alla strutturazione
di proposizioni artistiche, ma comprende l’indagine sulla funzione,
il significato e l’uso di ogni e tutte le proposizioni (artistiche), e la
loro collocazione all’interno del concetto del termine generico arte».
Affermazione, quest’ultima, di notevole spessore in quanto esprime
la consapevolezza di non svolgere soltanto un operazione sintattica o
semantica. L’insistenza sull’uso delle proposizioni artistiche, oltre che
della funzione e del significato, indubbiamente mostra come a Kosuth
non sia sfuggito il senso della lezione morrisiana. Il significato della
nozione di uso e di contesto, l’accentrare tutta la questione sulla natura
dell’arte, sono certamente «episodi» che devono essere analizzati con
attenzione e rigore.
Incominciamo dalla natura dell’arte. Si è ricordato che, per Kosuth,
essere artista significa interrogare la natura dell’arte. Ma qual è la
natura dell’arte? E soprattutto come un artista può individuare la natura
dell’arte? La risposta alle due domande è, in sostanza, una sola, si capisce.
E riguarda, appunto, la natura dell’arte: un concetto che è a priori. Per la
formulazione di quest’ipotesi Kosuth segue la linea che slitta da Kant
32 J. Kosuth, Nota introduttiva del redattore americano, trad. it. in «Data», aprile 1972 (tutte le
citazioni si riferiscono a questa traduzione).
33 J. Kosuth, Function, Funzione, Funcion, Fonction, Funktion, Torino 1970.
53
a Ayer (con tutti gli opportuni aggiustamenti). Dice Ayer, concludendo
il capitolo su L’«a priori»: «Abbiamo… mostrato che le verità della
ragion pura, le proposizioni che sappiamo valide indipendentemente
da ogni esperienza, sono tali solo a causa della loro mancanza di
contenuto fattuale. Dire vera a priori una proposizione equivale a dire
che è una tautologia. E le tautologie, benché ci possano servire da guida
nell’indagine empirica intesa al sapere, in se stesse non contengono
alcuna informazione intorno a dati di fatto»34. Kosuth, dunque, attraverso
Ayer, definisce la natura dell’arte come a priori e, al tempo stesso, colloca
sullo stesso piano le proposizioni artistiche con le verità della ragione
pura. La strategia è ormai evidente: stabilire un raccordo tra arte, logica,
matematica. Raccordo che può essere stabilito, ripeto, proprio perché
le proposizioni che costituiscono i rispettivi universi di discorso sono
a priori. Le proposizioni artistiche, come ogni altra verità a priori, sono
tali perché sono tautologiche. «La tautologia non ha condizioni di verità,
perché è incondizionatamente (bedingungslos) vera; e la contraddizione
a nessuna condizione è vera». Mentre «la verità della tautologia è certa»,
avverte Wittgenstein35. Kosuth, ripercorrendo i territori analitici, può così
concludere che le «proposizioni dell’arte non sono di carattere materiale,
ma linguistiche, e cioè non descrivono il comportamento di oggetti fisici
o mentali, ma esprimono definizioni dell’arte o le conseguenze formali
di definizioni dell’arte. Perciò possiamo dire che l’arte segue una logica
perché… la caratteristica di una ricerca puramente logica è quella di
interessarsi alle conseguenze formali delle nostre definizioni (dell’arte)
e non hai dati del fatto empirico…L’arte ha in comune con la logica e
la matematica il fatto di essere una tautologia; e cioè l’idea dell’arte (o
l’opera) e l’arte sono la stessa cosa e possono essere apprezzate come
arte senza uscire dal contesto dell’arte per una verifica».
Diviene, così, fondamentale la nozione di contesto (come, del resto, si
è ricordato). «L’arte esiste unicamente come contesto, questa è la sua
natura, non ha altre qualità», dirà nel ’70 Kosuth in un lavoro che, per
tanti versi, costituisce il punto-limite della sua esperienza teorica e
34 A. J. Ayer, op. cit., p.100.
35 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. it., a cura di Colombo, paragrafi 4.461
e 4.464 a p. 217. Si cfr. anche la trad. proposta da Amedeo G. Conte per l’edizione einaudiana
alle pp. 38-39.
54
operativa. A Migliorini questo testo sembra addirittura un ripensamento
di Art after Philosophy. Vediamo perché. La proposizione incriminata è
la seguente: «Data la natura del soggetto il contesto finale e definitivo è
completamente sconosciuto (se non in termini personali) e non può esistere
in alcuna maniera che sia attinente ad una Gestalt o una qualsiasi altra
entità iconica ivi sottesa». Secondo Migliorini, «il contesto, l’essenza,
l’éidos, a questo punto, rifiutano dunque una forma, e nessuna funzione
(nessuna proposizione unitaria) può definire la proposizione arte: l’arte
rifiuta insomma la definizione dell’arte. Il logos, come in Plotino, ha
solo la funzione di indicare l’anéideon, quel privo di forma che è, qui, la
vecchia nozione di arte»36.
In questa prospettiva Migliorini ritiene di poter rilanciare, addirittura, un
profetico aforisma di Sol LeWitt. «Gli artisti concettuali sono dei mistici
piuttosto che dei razionalisti. Essi balzano a conclusioni cui la logica
non può giungere». Function, Funzione, Funcion, Fonction, Funktion,
secondo questa lettura, denunzia uno sbandamento preoccupante verso
l’ascetismo e il misticismo, il logos che plotinianamente si limitava
soltanto a indicare l’anéideon, il privo di forma.
Certo, il rilievo di Migliorini è incontestabile. Tuttavia, per comprendere
fino in fondo lo sforzo teorico dell’artista americano, bisognerà cercare
di sondare proprio questo abbandono ascetico e irrazionale, emotivo.
L’abbandono emotivo, ascetico, il viaggio verso Plotino, è, alla resa dei
conti, lo scotto doloroso che Kosuth deve pagare per rendere trasparente
la sua tesi. La progressiva, ostinata, caparbia, liquidazione di qualsiasi
referenzialità, di ogni dato esterno, materiale e formale, la riduzione delle
proposizioni artistiche alla tautologia, l’affermazione dell’arte come idea,
come idea sono tappe di un progresso riduttivo che culmina nel rifiuto
dello stesso contesto come Gestalt o entità iconica (iconic entity). Adesso
36 E. Migliorini, Conceptual art, Firenze 1972, p. 163. Per una ricognizione complessiva
dell’esperienza concettuale mi sembra ragionevole ricordare i lavori di K. HONNEF, Concept
art, Köln 1971, di C. Millet, Textes sur l’Art Conceptuel, Paris 1972, di Wedewer-Fischer,
Konzeption-Conception, Köln 1969, di Aloisio-Menna, Analisi delle proposizioni concettuali
(intervento tenuto in occasione del Convegno «Critica in atto», Incontri Internazionali d’Arte,
Roma 1972), di R. Barilli, Le due anime del concettuale, in «Op. Cit.», n. 26, 1973, di G. Dorfles,
Valori socio-estetici nelle tendenze concettuali (il sunto di questo complesso intervento detto a
Belgrado in occasione dell’assemblea generale dell’AICA, è stato pubblicato in «NAC», agostosettembre 1973). Molto approssimativo è invece il libro di Ursula Mayer, Conceptual art, New
York 1972, perché congela in un’unica categoria – il concettuale – temi e risoluzioni che hanno
poco (o niente) a che fare.
55
l’arte non si dà più come definizione dell’arte, come proposizione che
sviscera tutte le implicazioni di tutti gli aspetti del concetto arte. «L’arte
in questo caso si riferisce solo alla successione degli elementi (o diretti,
o impliciti) nei loro rapporti con un’indagine».
Rifiutato il contesto come Gestalt o entità iconica è chiaro che salta la
stessa articolazione tra sintattica, semantica e pragmatica a favore della
orizzontalità degli elementi. La negazione del contesto è, dunque, il
punto-limite del lavoro teorico di Kosuth: un luogo che, come si è detto,
lo spinge verso il misticismo e la rarefazione del logos, verso l’ascesi e la
perdita della conoscenza.
Kosuth, in latri termini, non approfondisce la linea Wittgenstein-Morris,
come invece, in un primo momento, sembra disposto a fare. Non
approfondisce, cioè, nozioni come segno-totalità, contesto, uso. Lascia
cadere nel corso della ricerca le implicazioni dialettiche che, come si è
precisato, costituiscono l’ossatura di Morris e del secondo Wittgenstein,
il Wittgenstein delle Ricerche logiche. Così, in particolare rispetto a
queste acquisizioni capitali, Kosuth fa alla fine due passi indietro. Non
soltanto non lavora all’interno di queste traiettorie quanto, addirittura,
le trascura e le abbandona. Si direbbe, in conclusione, che Kosuth per
eccessiva trasparenza (per voler dare all’arte una trasparenza eccessiva)
abbia superato gli argini di sicurezza, condividendo la profezia di Sol.
Dunque, Kosuth ha commesso lo stesso errore di visuale dei mistici che
per purgare il copro lo negano e per pregare Dio lo annullano come uomini.
Così, Kosuth per amore dell’arte si rivolge all’anéidon, per assegnare alle
proposizioni artistiche dignità (uno statuto logico e semiotico), la stessa
dignità che la filosofia analitica aveva assegnato alle proposizioni della
matematica e alle verità della logica, rarefa talmente il concetto-arte che
risulta inafferrabile e sconosciuto.
Kosuth invece di spingere l’indagine, lascia in sospeso Wittgenstein, verso
l’approfondimento del legame linguaggio/lavoro, per esempio, o anche
verso l’accertamento del senso che svolge lo stesso linguaggio analitico
all’interno della struttura di potere capitalistica, fa retrocedere la ricerca,
in modo deludente, verso un originario magma informe, verso una meta
completamente sconosciuta. L’uscita mistica rende, pertanto, precario e
incerto anche un altro passaggio della teoria di Kosuth, un punto in verità
assai importante. Centrale non solamente per la formulazione dell’arte
56
concettuale. Alludo al rapporto arte-pubblico-critica. Al ruolo nuovo che
la critica è chiamata a svolgere, smesso l’abito banalmente mediativo:
la cerniera tra galleria (e anche artista) e pubblico. L’arte concettuale
«riassume in sé anche la funzione del critico, rendendo superflua la
mediazione. Il sistema artista-critico-pubblico aveva la sua ragion
d’essere in quanto gli elementi visivi della costruzione del come davano
all’arte un aspetto di intrattenimento, donde la presenza del pubblico».
L’arte concettuale, invece, non ha un pubblico esterno, per così dire: il
pubblico è costituito dagli stessi artisti, dai partecipanti. Non esiste più,
per Kosuth un pubblico separato dai partecipanti. Esistono soltanto i
partecipanti che interrogano la natura dell’arte, gli artisti insomma. «In
un certo senso, pertanto, l’arte diventa seria come la scienza o la filosofia,
che non hanno certo un pubblico. Nella misura in cui si partecipi o no,
l’arte concettuale diventa più o meno interessante. Nel passato, lo status
privilegiato dell’artista lo confinava a svolgere il ruolo di un grande
sacerdote o di uno stregone dell’industria dello spettacolo».
Arte e critica, così, non sono più due operazioni distinte ma una sola
attività. E, al tempo stesso, Kosuth, riconducendo l’arte alla critica e la
critica all’arte tenta di superare la grave impasse della relazione arte/
pubblico.
L’arte concettuale non si rivolge a un pubblico esterno, non richiede
partecipazione che non sia quella degli addetti ai lavori. Il pubblico
è all’interno, ora. È la stessa famiglia degli artisti. Pubblico e artisti
coincidono. Con questa mossa Kosuth pone l’arte concettuale sull’altra
sponda rispetto a quelle esperienze che, negli anni Sessanta (o poco
prima), avevano cercato, invece, di risolvere i rapporti arte/pubblico
chiedendo e sollecitando proprio l’intervento attivo, costante, vitale del
pubblico. Dalla crisi dell’oggetto, dalla caduta dei linguaggi oggettuali, il
problema è stato appunto quello di coinvolgere, di rendere compartecipi
gli spettatori, di infrangere la loro pigrizia, di sospingerli a un ruolo
attivo, di renderli, finché possibile, attori dell’evento, del rito, che non
deve soltanto sfiorare lo sguardo, né correre veloce sulla pelle, ma deve
lasciare tracce e segni duraturi.
L’arte, in questi dintorni, si pone nei confronti dello spettatore come
struttura dell’immaginario, come palese irritazione dello spirito, se
si volessero usare le parole di Max Ernst. Lo spettatore aiuta l’artista
57
nell’esercizio dell’estasi, dall’uscita fuori di sé voglio dire, e l’artista,
con il suo gesto, con la riappropriazione della corporeità, con lo slargare
la dimensione dell’arte riferendosi al mondo e alla natura, sollecita
lo spettatore/attore a partecipare alla nascita di un’altra realtà, alla
rigenerazione della sensibilità. L’arte accorcia (o si illude) la distanza
dalla vita, vuole divenire vita, ma non lo può per via che è arte, cioè
linguaggio. Così, patisce fino all’ultimo la frustrazione, annulla nella sua
vertigine ogni mediazione, richiede un contatto diretto e immediato. Fa
esplodere la funzione della critica.
Kosuth lavora, invece, in direzione opposta. Sa benissimo che il rapporto
immediato arte/pubblico è una leggenda, una soluzione acritica (anche
se generosa). Perciò, per evitare la trappola dell’immediatezza, riassorbe
la critica e il pubblico all’interno della stessa operazione artistica o,
meglio ancora, del concetto arte. Ma se la soluzione avanzata dall’arte
che interviene direttamente e immediatamente sul mondo si apre a
un’esperienza mistica, d’altro canto l’arte concettuale, nella pronunzia
di Kosuth, non è esente da rischi e da disagi. Perplessità e disagi che
diventano ancora più marcati quando pensiamo alle conclusioni di
Function, Funzione, Funcion, Fonction, Funktion. L’uscita mistica, il
logos che può indicare soltanto l’anéidon, riducono inevitabilmente il
ruolo, la possibilità e la funzione della critica. Se, in ultima istanza l’arte è
il privo di forma, se il contesto finale è sconosciuto, l’artista nuovamente
diviene il grande sacerdote dell’evento. In questo caso il sacerdote evoca
il Logos che, invece di essere linguaggio, è un principio oscuro e nebuloso.
E partecipa a sé e al pubblico (costituito da artisti) questo mistero. Allora
il problema non è tanto quello di formare il pubblico soltanto con gli
artisti, con quelli che partecipano realmente all’arte, quanto di evitare
l’ascesi e il misticismo. Diversamente la stessa funzione critica, pur
riscattata dal banale ruolo di intermediaria, torna a essere inventario o
catalogo di visioni, il registro su quale il sacerdote-artista annota il suo
silenzioso contatto con il Logos.
Così, tristemente, l’Arte dopo la filosofia, l’ultima scena del dibattito tra
teoria cognitiva e emotiva dell’arte, diventa soltanto un transito verso
il misticismo di Function, Funzione, Funcion, Fonction, Funktion?
Francamente, pur insistendo su questa difficoltà, non ridurrei, tuttavia,
l’intero discorso di Kosuth a quest’epilogo, come mi sembra faccia
58
Migliorini. Il misticismo è, certamente, il punto-limite della teoria
di Kosuth. Ma la teoria, nella sua complessità, non si riduce a questo
punto. D’altra parte la riflessione più recente dell’arte concettuale sembra
più orientata verso Art after Philosophy che in direzione di Function.
E questo significa che si è cercato di riguadagnare la lezione cognitiva
della proposta di Kosuth, vagliando ogni indicazione emersa. Infatti è
abbastanza interessante, per limitarci a un esempio, il modo con il quale
lo stesso Kosuth rilegge Duchamp: una lettura che ha offerto e offre
sollecitazioni e scatti diversi. Indicativa è la stessa riconsiderazione di Ad
Reinhardt37. Del resto non può essere un caso che Duchamp e Reinhardt
siano diventati, in questi ultimi anni un polo obbligato per gli artisti e i
critici delle nuove generazioni: non è un caso se li ritroviamo alla testa
del viaggio che si avvia a percorrere la «linea analitica»38. Senza che per
questo si dica, poi, semplicisticamente che Duchamp o Reinhardt siano
artisti concettuali o, addirittura, i padri del concettualismo.
A questo punto non si può non accennare, proprio per rendere trasparente il
discorso, al tema della riflessione, giacché la riflessione sembra, appunto,
caratterizzare le ultime ricerche dell’arte. Il momento della riflessione
era, in verità, già attivo nelle zone più mature e meno selvagge dell’arte
povera, della Land Art, dell’arte di comportamento39. La nuova pittura,
ora, gioca le sue carte, quando non è il ritorno del rimosso, proprio come
«riflessione sulla pittura». Ma vi è una differenza fondamentale tra la
riflessione sulla pittura di Cane o Devade e la riflessione metalinguistica
dell’arte concettuale. «L’arte concettuale affronta il problema disciplinare
al primo livello. Essa cioè si interessa essenzialmente al concetto di
Arte situato a monte delle forme specifiche delle pratiche artistiche,
37 Segnaliamo rapidamente i contributi più significativi dei concettuali sul caso Duchamp.
Anzitutto Kosuth, in Art after Philosophy. Poi T. Atkinson, Concerning Interpretation of the
Bainbridge-Hurrel, in «Art-Language», n. 1, 1970. Dello stesso autore e sullo stesso numero
di «Art-Language», si veda Duchamp’s Concepts of Transubstantiation ed ancora la nota
all’Introduction, n. 1, vol. 1, 1969. E. Migliorini, Lo scolabottiglie di Duchamp, Firenze 1970, ha
ripreso e analizzato con rigore il discorso dei concettuali su questo punto.
38 F. Menna, Per una linea analitica dell’arte moderna, in AA. VV., La riflessione sulla pittura,
Acireale 1973.
39 Sulla questione si cfr. almeno A. Bonito Oliva, Il territorio magico, Firenze 1971, F. Menna,
Dibbets una rotazione di 360 gradi, in «Qui arte contemporanea», n. 9, 1972. Importante il
saggio di G. Dorfles, Il simbolismo del tempo nell’arte, in «Archivio di Filosofia», Roma 1973,
che costituisce la premessa teorica di quest’altro scritto, La componente temporale nell’arte
statunitense contemporanea, in «Qui arte contemporanea», n. 11, 1973.
59
mentre la Nuova Pittura pone esplicitamente il problema della disciplina
pittorica»40. La Nuova Pittura fa, cioè, esattamente quello che l’arte
concettuale rigetta: è, cioè, analisi di un linguaggio specifico, la Pittura,
delle sue articolazioni. Si passa, così, nuovamente dal metalinguaggio
alla riflessione sul linguaggio specifico.
Della Nuova Pittura (sotto questa etichetta si nascondono non pochi
pasticci) l’esperienza più sottile è rappresentata, evidentemente, dal
gruppo di Peinture. Di questo lavoro va sottolineato in particolare la
tensione teorica: una tensione che nasce all’incrocio tra il pourmarxismo
althusseriano e la psicoanalisi lacaniana, fra il maoismo di Tel Quel,
le illuminazioni di Sollers e l’acutezza di Pleynet. Ed è appunto
questo pensiero, per diversi aspetti, il contrappunto teorico dell’arte
concettuale.
Insistendo, infatti, sull’approdo mistico di Kosuth, ci si è rammaricati
del fatto che l’artista americano, invece di sospingere l’eredità
Wittgenstein/Morris (segno-totalità, contestualità, dialettica dei livelli
semiotici), sia regredito al Logos e al privo di forma. Approfondire la
lezione di Wittgenstein e di Morris significava, si è detto, affrontare il
tema dell’idealismo e del solipsismo del metalinguaggio, il rapporto
tra analiticità e dialetticità. Problematica, questa, che occupa il centro
del lavoro di Cane e Devade, di Peinture. Louis Cane, per ricondurre al
minimo le citazioni e concludere, segnala che «la pittura è solo un lavoro
personale il cui processo specifico non si riconosce se non attraverso
la sua dialettica nell’insieme sociale contraddittorio». O ancora che
si dà la possibilità «attraverso la pittura (di) riflettere una pratica e un
lavoro dialettico nelle infinite possibilità offerte storicamente dal codice
pittorico»41. La via dialettica di Peinture e di Supports/Surfaces è,
senz’altro, il correttivo più energico all’uscita mistica di Kosuth: al mito
dell’analiticità che si contempla come in uno specchio.
Kosuth, Cane, Devade, Art after Philosophy (senza saltare la zona
d’ombra di Function), Peinture e Supports/Surfaces costituiscono i
transiti obbligati per una rifondazione della pratica e della teoria della
40 F. Menna, op. cit., manca la pagina (il testo infatti non reca numerazione).
41 L. Cane, Per terra, piegata, con il colore, in «Data», nn. 7-8, 1973, pp. 78 e 82. Si rinvia
complessivamente ai contributi di Cane, Devade, Sollers, Pleynet comparsi in questi anni su
Peinture. Indispensabile, si è detto, L’enseignement de la peinture.
60
pittura: per ridefinire la rete tra la specificità linguistica dell’opera e
l’alterità che la costruisce, per abbandonare definitivamente i territori
della presenzialità.
(1973)
61
Convergenza sull’antropologia
1. Certo non si esce dal modello della Presenza e dell’Estasi, dall’attacco al
mondo e alle sue maglie, dalla conquista di nuovi materiali e di rinnovate
sollecitazioni sensoriali e psichiche. Apparentemente, sembra proprio
così. ad ascoltare ci si accorge invece come all’interno di questi «due
modelli culturali in conflitto», tra Presenza e Assenza, dei meccanismi si
inceppano mentre altri, di diverso segno, s’innescano e vanno in moto.
Cioè, come il modello della Presenza possa essere minacciato e percorso,
nel suo stesso spazio, dall’ombra inquieta dell’Assenza. Per questo ha
ragione Natalini: «La linea che divide l’Assenza dalla Presenza si poteva
tracciare solo sul muro di museo e poteva dividere solo nomi incisi su
piccole lapidi fragili»42. Addirittura, è probabile che questa linea non si
possa tracciare neppure sul muro di un museo.
Un’ombra può essere appunto questa convergenza sull’antropologia, che
si annunzia da molteplici avvisi: una pratica diversificata di architetti e
artisti che interrogano margini abbondanti di cultura, zone inesplorate,
un paesaggio di oggetti e di tecniche di strumenti e di esercizi, di rituali
e di simboli dispersi e decaduti. Che si misurano (ed è il punto difficile
ma affascinante) con una cultura altra. E, da questa alterità, sperano
rifondare gli stessi loro campi disciplinari, il corpo della pittura e il
sistema dell’architettura.
La sorpresa viene, come sappiamo, da Kosuth. The artist as anthropologist
organizza uno spostamento radicale della direzione teorica dell’arte
concettuale, dell’idea che l’arte è analoga a una proposizione analitica
«giacché possiede uno statuto simile a quello della logica e della
matematica». Adesso, invece, «l’artista come antropologo opera
all’interno del contesto socio-culturale… È totalmente immerso ed ha un
impatto sociale. Le sue attività danno corpo alla cultura»43.
La dimensione antropologica interviene, dunque, a mettere in questione
le certezze delle proposizioni analitiche, la lucentezza dell’arte come
tautologia, a collegare la concettualità alla prassi, la ragione analitica
42 A. Natalini, Presenza/Assenza in Refrattario, in Assenza/Presenza: un’ipotesi per l’architettura,
a cura di F. Irace, Ascoli Piceno 1979, p. 57.
43 J. Kosuth, The artist as anthropologist, cit., p. 26.
63
alla ragione dialettica e al suo fondamento socio-culturale. Diviene un
transito per riaffacciarsi sulla «politica dell’esperienza».
Ma, mal di là di Kosuth (e del suo esempio), questa volta, si vuole
insistere più puntualmente su un’altra occasione che questa convergenza
suggerisce: sulla relazione, appunto, tra alcune opere e alcuni nomi che
la rassegna rubrica nell’Archivio della Presenza con quei nomi e quelle
opere disseminati nei territori delle arti figurative. Penso, da un lato, al
Superstudio, a La Pietra, a Dalisi, e sull’altro argine, a Claudio Costa,
a Paradiso, a Simonds o ai Poirier (per certe cose), e a pochi altri. E
penso a loro non tanto (o forse per niente) per la capacità che mostrano
di continuare a costruire manufatti e oggetti con le proprie mani, quanto
per il rigore con il quale sfondano i confini della loro disciplina per dare
voce e aprire varchi «ai saperi assoggettati».
Ripartiamo ancora da Natalini, da una sua recente incursione (sua e del
Superstudio o almeno di una parte): una linea che vive sotto la costellazione
della didattica e s’indirizza verso la cultura materiale e la storia delle
cose. «L’antropologia culturale, la ricerca dell’uomo e le sue produzioni
mentali e materiali, i tentativi di modificazione cosciente dell’ambiente e
di noi stessi, sono tutte le parti di un processo di educazione permanente
che ci coinvolge completamente».
Dunque, il paradosso e l’euforia, i falsi sillogismi e l’utopia che avevano
caratterizzato l’esperienza dell’architettura radicale lasciano il passo, ora,
ad un’indagine sull’origine e sui processi lavorativi di utensili, di oggetti
e di luoghi dimenticati, addirittura cancellati. «…Ci interessa mettere in
luce l’aspetto primario della progettazione degli attrezzi agricoli dove,
dalla zappa alla forma del territorio, ogni oggetto è caratterizzato dal
suo valore d’uso, e dove ogni trasformazione si realizza attraverso una
conoscenza globale della realtà su cui si opera»44. Giacché, suggerisce
La Pietra, «l’oggetto veniva costruito facendo riferimento al suo uso, ai
materiali, al significato simbolico e religioso, e alla capacità creativa del
suo fabbricatore». Una dimensione riscontrabile anche (o ancora) oggi
ai bordi delle grandi città, al fianco delle metropoli dove se ne stanno
«gli eredi di quei sapienti manipolatori di materiali…, uomini liberi che
operano segnando come unico parametro lo sfruttamento del territorio,
44 A. Natalini, A. Poli, C. Toraldo Di Francia, Viaggio con la matita tra gli artefatti del mondo
contadino, in «Modo», 1978, 7, pp.49, 51.
64
che poi sono i rifiuti (accumulati nelle discariche) di una società che si
stanca troppo presto degli oggetti che fabbrica». Ed ancora (ma su un
registro forse un po’diverso) vorrei ricordare l’esperienza di Riccardo
Dalisi e di Costa, di Antonio Paradiso che, demartinianamente, si volge a
«testimoniare» il dramma dei tarantati, il loro dolore senza fine e la loro
teatralità. Ma stavo dicendo del lavoro di Dalisi a Camastro Alto Sauro,
una comunità montana disseminata tra le alture della Lucania, e di Costa
a Montegrifo, sulle colline di Genova.
Un esempio, questo di Dalisi, destinato, mi pare, ad ampliare gli spazzi
della sua stessa ricerca verso un progetto che investe non soltanto
momenti privilegiati, l’infanzia o la vecchiaia, ma un’intera fascia di
umanità, portatrice di un sistema di tecniche ancora vive e operante.
L’attenzione si sposta, allora, con decisione sulla storia delle cose e sul
sistema delle tecniche. Un movimento, questo, attivo anche in Costa
fino a sollecitare e motivare quel lento, caparbio, lavoro di selezione e
schedatura di materiali e di oggetti, ti utensili. Tanto da animargli l’idea
affascinante (ma anche rischiosa) di un museo45.
Una lunga, interminabile, scansione di cose e di latitudini di tecniche
collegata a modi di produzioni e di vita ormai dimenticati e travolti, una
temporalità diversa e una zona di storia sommersa vengono, dunque,
fatte emergere e vagliate, analizzate e (se è possibile) riutilizzate per
tornare a visitare le specifiche pratiche artistiche. Ecco perché di questa
insistita convergenza antropologica mi interessa solamente la riflessione
sul sapere rimosso, questo sconfinato campo, rovescio silenzioso della
cultura egemone e, insieme, fondamento inaccessibile di qualunque
sapere non totalitario. Ombra che minaccia, all’infinito, il lucido modello
della Presenza e fa che la barra, Assenza/Presenza, non possa essere mai
segnata né tracciata.
2. Ma ritorniamo a Dalisi e, partendo dai monti della Lucania, cerchiamo
di graffiare nel fondo del suo discorso la trama teorica che lo sostiene: la
45 R. Dalisi, L’artigiano è un ready made, in «Modo», 1978, 8. «Al centro della Basilicata la
comunità montana di Camastra Alto Sauro…(è) una zona fra le più intatte di tutta la penisola: è
una occasione importante per una sperimentazione sull’artigianato che investe sia i piani culturali
sia le forma del lavoro» (p.53). A. Caminati, C. Costa, Montegrifo. Museo di antropologia
(sezione Arte Moderna), settembre 1975 (ciclostilato). Interessante il contributo di A. M. Cirese,
Oggetti, segni, musei, Torino 1977 (specialmente la parte seconda).
65
critica allo strutturalismo che fa delle costanti e delle invarianti la stella
che guida alla comprensione del sapere.
«L’uomo non può conoscere se stesso se non proiettandosi nella città, così
il fanciullo non si svilupperà in maniera integrata, superando ogni forma
educativa di tipo intellettualistico, se non abituandosi a sentirsi come
facente parte dell’intera dinamica della città». Ogni progetto pedagogico
serio ha, dunque, come orizzonte la città, giacché lo spazio urbano è un
sistema di comunicazione, un’inesauribile sorgente di informazioni e di
figuralità da decifrare. la socialità, l’erotismo (come suggerisce Barthes),
sono la linea che l’attraversa e la segna, la marca. l’esperienza progettuale
è, così, un lavoro che nasce come riflessione sulla città, come scrittura
che ritesse, nuovamente, la maglia urbana: uno spazio che non è soltanto
fisico, pura dimensione geografica, ma latitudine sociale e itinerario del
desiderio.
Riflessione sulla città e lavoro pedagogico costituiscono, fin dall’avvio,
i transiti della ricerca di Riccardo Dalisi. La scuola, l’università, almeno
dal 1964, sono infatti l’asse di questo discorso: della relazione scuola/
società (città, voglio dire). I progetti per la scuola media di Bologna
(’64) e per la facoltà di scienze e farmacia all’università di Messina
(1966) sono, senz’altro, momenti decisivi. e quando, nel ’67, Dalisi, in
modo più disteso, torna a proporre la questione non ci sono più dubbi
né incertezze. «In un certo senso possiamo definire come facente parte
della scuola quell’elemento urbano, quell’insieme di relazioni, di fatti,
di comunicazioni visive che si recepiscono, nell’insieme dei legami
percettivi tra la scuola, in quanto spazio fisico-educativo, ed il complesso
delle immagini, dall’intorno più o meno immediato, fino agli spazi che
caratterizzano l’ambiente familiare dell’allievo»46. La dialettica scuola/
città è evidente. La scuola non è un semplice attrezzo della città, un
servizio e una funzione (più o meno specializzata), non è un luogo dove si
imbandisce il banchetto della cultura egemone. La scuola è radicalmente
scena urbana.
Allora diviene chiara, per esempio, la polemica di Dalisi sulla scelta
carismatica del topos, sull’incondizionato «valore strategico della
localizzazione», sulla stessa mitizzazione di spazi privilegiati, il centro
46 R. Dalisi, Forma (intervallo) Spazio, Napoli 1967, pp. 57, 64.
66
storico (dopo Urbino). La questione non riguarda la relazione dentro/fuori
la città: in gioco è l’intersezione università/città. Infatti «l’intersezione
è assai più di un rapporto diretto e non è integrazione che comporta
un’assimilazione ed assorbimento. Essa è compresenza di due o più
entità eterogenee di cui ognuna tende a modificare sostanzialmente l’altra
pur mantenendo la propria individualità. Essa crea un terzo elemento (il
punto di intersezione). Sono dunque in ballo unità ed eterogeneità, una
tensione a modificare ed un termine di passaggio».
Dalisi gioca sull’eterogeneo, sulla differenza piuttosto che sull’identità
e l’assimilazione, sulla tensione più che sulla quiete, sulla produzione di
un terzo elemento che non è l’addizione dell’eterogeneità/unità ma è il
momento della diversità che fa esplodere la tentazione della pacificazione.
«Quando i sistemi di intersezione diventano complessi e dinamici specie
quando uno dei termini tende ad acquistare significato e consistenza
attraverso le intersezioni, nascono l’imprevedibilità ed il disordine come
elementi strutturanti l’insieme».
L’imprevedibilità e il disordine sono, certamente, nozioni che in modo
ricorrente frequentano lo spazio teorico e la pratica di Dalisi. Direi da
sempre. Ma in questi anni (gli anni Settanta) imprevedibilità, disordine,
discontinuo, eterogeneo, divengono strumenti e spie insostituibili di
questa manovra, fondano il discorso. È da questa postazione che Dalisi
affronta ed interpreta lo strutturalismo (certe pretese formalizzanti dello
strutturalismo).È interessante il modo con il quale vengono ribaditi alcuni
punti-chiave. Vediamo.
Per Riccardo Dalisi il tema capitale non è la ricerca delle invarianti e
delle costanti. «Per me le costanti sono soltanto i punti di intersezione
di linee di sviluppo, sono in funzione delle varianti e non viceversa…
Un segno appare come costante, ma ciò che lo rende vivo è il gioco
delle trasformazioni dei significati che gli ruotano intorno». Il rapporto
segno/contesto è, perciò, un legame dinamico: «Contesti diversi mutano
il significato di qualsiasi segno, è quindi nella diversità e nel dinamismo
del contesto che va ricercato il senso del segno»47.
Il problema della mutazione, i continui slittamenti del segno, la dialetticità
del contesto, i movimenti all’interno (e fuori, soprattutto), la struttura
47 R. Dalisi, L’architettura della imprevedibilità, Urbino 1970, pp. 89, 7, 8.
67
come sistema di trasformazione costituiscono la rete sottesa a questo
discorso. È questa consapevolezza che consente a Dalisi di scansare il
rischio di ridisegnare la città, il territorio o porzione, isole, della città
a tavolino, sul foglio. O di denegare la disciplina (perché logorata)
traducendola in momento animativo ed evento teatrale, in esperienza
comportamentale.
Certo, anche per Dalisi la disciplina, lo strumento antico, subisce scosse
e turbamenti violenti, viene sospinta lungo gli argini dell’animazione e
dell’analisi del vissuto. ma una distinzione s’impone. La precisazione che
la ricerca di Dalisi sceglie immediatamente come ruolo d’intervento un
contesto storico-sociale, una configurazione urbana, ben caratterizzati:
il quartiere Traiano, a Napoli, un’area larga d’emarginazione del
sottoproletariato, una zona precisa di subcultura.
L’analisi investe, allora, uno spaccato puntuale della città (per composizione
di classe e per sfruttamento) e il rapporto inevitabile che quest’isola ha
con il resto dell’area metropolitana. Dalisi non propone una riscrittura
del Traiano e delle sue connessioni con la città su carta, non ci offre
una salvazione utopica di questa condizione di espropriazione culturale
e politica. Ci propone, invece, un’indagine che mira a sconvolgere
dall’interno la logica dell’emarginazione e della violenza attraverso
un lavoro che coinvolge direttamente i bambini, i vecchi, la gente che
abita questo lazzaretto. Cioè, attraverso una lenta ma continua presa di
coscienza del degrado morale e politico (urbano, direbbe semplicemente
Lefebvre) al quale una spietata gestione della città li ha ridotti.
Il Traiano, nella zona flegrea, ideato da una quarantina di architetti,
diviene in breve tempo (e non senza ragioni) un ghetto di 50.000 abitanti.
Anzi bisognerà aggiungere che già nel disegno iniziale viene pensato
come un dormitorio: infatti non viene dotato né di attrezzature né di
servizi e neppure ci si preoccupa di collegarlo in qualche maniera al resto
del tessuto urbano. siamo alla fine degli anni ’60.
L’intervento di Dalisi (e del suo gruppo, formato prevalentemente dagli
studenti della facoltà di architettura)è degli anni Settanta. E si svolge a
diversi livelli: ma, fin dall’avvio, l’azione è rivolta ai bambini, al loro
vissuto, alla loro creatività. «A paragone dello stato generale di incertezze
e di crisi della cultura ufficiale, la subcultura del sottoproletariato sembra
invece provvista di una sua continuità e di un suo senso. Specie dove
68
trapela nella sua genuinità, cioè nei fanciulli e nei ragazzi, essa appare
fertile e autentica; ha molto da insegnare (come ha molto da insegnare
la cultura dei primitivi). È letteralmente sorprendente la vivezza e la
complessità dell’immaginazione sottoproletaria-infantile»48. Dalle prime
battute, dunque, l’architettura d’animazione praticata da Dalisi è analisi
del vissuto e delle potenzialità creative (represse dalla cultura alta), è
analisi di classe. Ed è, al tempo stesso, un modo di ribaltare l’esperienza
del fare architettura. Questa pratica colpisce,m infatti, alla radice la
disciplina come strumento di configurazione urbana disceso dal cielo della
specializzazione, dal capitale e dalla burocrazia dei partiti che ne esprime
la violenza. L’architettura di animazione è architettura di partecipazione,
in prima istanza: esprime l’esigenza di una crescita dell’urbano sollecitata
dal basso, dai bisogni e dai desideri degli emarginati, dall’orizzonte del
proletariato. Dalisi capisce con estrema lucidità che è qui, nella fascia
larga della cultura del proletariato e del sottoproletariato, che si determina
il destino della città, in suo uso differente, la sua riappropriazione.
Dal Traiano a Ponticelli, altra area della sofferenza napoletana, a
Pozzuoli, al centro storico di Salerno o alla subcultura di Mariconda (un
altro suburbio salernitano) il lavoro di Riccardo Dalisi, in questi anni, si
è arricchito di nuovi umori. Soprattutto ha fatto l’esperienza, a Ponticelli,
di un’altra situazione di espropriazione, quello dei vecchi.
I bambini e i vecchi, si sa, sono banditi dalla città del capitale perché
forze improduttive. L’incontro con questa realtà è assai stimolante: ben
presto, opportunatamente coinvolti, i vecchi di Ponticelli hanno intrapreso
una fruttuosa anamnesis, un ritorno alle loro origini, alla loro memoria
storica. Alla storia del quartiere, agli avvenimenti di cui sono stati
protagonisti (la guerra, la carestia, la miseria e il malgoverno), ai rapporti
interpersonali, all’esigenza di capire un po’di più. Alcuni di loro hanno,
poi, continuato il discorso adoperando altre forme di comunicazione: alla
parola (ellittica, stentata ma ricca, provocatoria e ironica) si è affiancato
il linguaggio plastico. Il modellare ( una forma artigianale, dunque)
diviene presto espressione privilegiata. E il modellato si popola di figure
che rinviano alle tradizioni popolari, a momenti scomparsi o rimossi, a
una lontananza che si tende ad archiviare o a consegnare ai canali del
48 R. Dalisi, Architettura d’animazione, Assisi-Roma 1975, pp. 50-52.
69
mercato, al consumo.
Le indicazioni offerte, questi esempi, credo che bastino a segnalare il
cammino di Riccardo Dalisi, il suo progetto. Per il nostro sguardo è
opportuno sottolineare, invece, due o tre cose: cose che attengono alla
questione stessa della pratica dell’architettura e alla teoria.
Avverte Mendini che «Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra
coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia
della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto
più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano»49. Il nodo è
appunto questo: cercare d’intendere il senso da attribuire alla forma, al
rapporto tra partecipazione e forma, animazione e drammaturgia (anche
inconscia, perché no?), creatività e linguaggio, tra evento e progettualità
che quell’accadimento teatralizza.
Dalisi è abbastanza esplicito. «La tecnica povera contesta la sottrazione
progressiva ed ineluttabile della partecipazione attiva dell’uomo alla
modellazione, alla costruzione dei propri progetti, del proprio spazio».
La tecnica povera, il linguaggio dell’architettura secondo Dalisi, non si
schiera sul fronte delle poetiche che sfruttano la povertà per ricostruire
oggetti, manufatti, abitazioni. È un linguaggio che non santifica
l’artigianato (o si dà come artigianato, ancora peggio), né ha in odio
la tecnologia in una rinnovata estasi pauperistica e francescana. «La
tecnica povera, nel rieducare gli strumenti sensoriali e percettivi, vuole
rifondare la ricerca tecnica e scientifica; presuppone un rinnovamento
del senso e del ruolo della scienza»: della scienza dell’architettura, prima
di tutto. E, subito dopo, Dalisi aggiunge (e vale la pena di riportare per
intero il passaggio) che la «tecnica povera richiama il problema della
partecipazione, anzi ne costituisce un capitolo fondamentale. Se nel
futuro la gamma delle esperienze che la tecnica dovrà alimentare, non
comprenderà in un’unica dinamica anche l’elaborazione e l’ideazione dei
non tecnici, non si potrà parlare di partecipazione. La tecnica povera è
in stato di rivolta sotterranea (e in futuro lo sarà apertamente), non per
soppiantare e distruggere, bensì per allargare e recuperare la sfera della
creatività nel lavoro e nella produttività. Rivendica quindi un mutamento
49 A. Mendini, Dalisi e l’imprevedibilità, in Architettura d’animazione, cit., p. 14.
70
strutturale dei rapporti di produzione e di gestione»50. Il senso e il ruolo
della scienza dell’architettura viene ridefinito, dunque, dal basso, come
momento di partecipazione e di gestione (anzitutto), del processo
produttivo, del piano. Della città, in una parola. Da quest’ottica appare
evidente, adesso, ed acquista forza e incisività la critica allo strutturalismo
delle costanti e delle invarianti. Mentre si precisano meglio le nozioni
di disordine e di mutazione, di segno e di contesto (e la loro relazione
plurale), l’idea di eterogeneità.
L’esperienza di Dalisi si colloca, così, in bilico, sulla soglia dell’architettura
e della sua denegazione, della progettualità e della pratica animativa.
Dalisi è però consapevole che l’identificazione dell’architettura con la
pratica sociale è ormai un frutto che va problematizzato secondo la critica
dell’immediatezza per ristabilire, in modo altrettanto problematico, il
disegno della distanza e della lucidità, del raffreddamento tra vissuto e
arte, fra animazione e architettura.
È questa lucidità, che, attraversando l’intero progetto, mette in questione
non soltanto (come si è detto) l’idea utopica del contro piano, della città
ideale, della città effimera, ma anche l’altra, giocata, immediatamente,
sull’animazione e la partecipazione, sulla ricchezza del vissuto e
sull’ascolto politico. L’ipotesi è, dunque, un scienza dell’architettura che
fondi il proprio linguaggio, eterogeneo, discontinuo e plurale, dal basso,
dalla (e con la) partecipazione di una cultura altra, emarginata e sfruttata,
espropriata. E non è un’ipotesi da poco.
(1976/1979)
50 R. Dalisi, op. cit., pp. 49,54.
71
Intermezzo
Mukařovský, il legame obliquo
1. Il ritardo con il quale sono state presentate alcune figure della cultura
cecoslovacca è, senz’altro, all’origine di incomprensioni, incertezze e
delusioni: Mukařovský, Teige, sono giunti da noi troppo tardi. E Kalivoda,
che per certi versi, è l’interprete più sensibile dello strutturalismo ceco
( ed appassionato esegeta di Mukařovský), ha finito per creare molta
confusione. Eppure voleva mettere ordine51.
Mukařovský (ed è questa, senza dubbio, una ricchezza) vive, all’incrocio
di molteplici esigenze, è il luogo di convergenza di interessi differenti, e,
al tempo stesso campo dal quale è possibile compiere altre incursioni e
sorprendenti sortite.
Il formalismo russo, la lezione delle Tesi (Mukařovský è uno dei
redattori), i rapporti con la fenomenologia e il sospetto fenomenologico,
l’ipotesi strutturalistica, il cammino verso la semiotica dell’arte e, infine
(o in principio), il bisogno di trovare legami sempre più stetti con il
marxismo sono i punti fondamentali della sua esperienza. Una rete così
aperta e complessa lascia, certamente, spazio a dubbi e a perplessità: in
verità, sembra che la teoria dell’arte mukařovskýana sia fatta a posta per
confezionare un prodotto ambiguo. Infatti si affaccia subito lo spettro
strutturalismo/marxismo insieme a quest’altro fantasma non meno
minaccioso: la questione della costanza antropologica, dell’estetica come
fondo antropologico.
I problemi, messi in fila, sono seri e decisivi. Perciò un punto di vista
corretto, il più corretto possibile, è quello che cercherà di ridurre (se
non di cancellare) il ritardo con il quale ci è stato restituito. È, dunque,
l’unico modo per evitare interventi selvaggi, in altalena tra il furore di chi
dice che Mukařovský ha risolto tutti problemi e l’astio di chi non esita a
51 J. Mukařovský, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, trad. it., introd. di
S. Corduas, Torino 1971. Nel ’73 venivano pubblicati, sempre da Einaudi, i fondamentali Studie
z estetiky con il titolo Il significato dell’estetica che comprende, oltre La funzione, un consistente
numero di saggi sulla semiotica delle arti. Non c’è dubbio che avere presentato Il significato
dell’estetica, nel ’71, mutilato dall’apporto semiotico ha contribuito a deformare l’immagine
teorica di Mukařovský. K. Teige, Il mercato dell’arte, trad. it., a cura di G. Pacini, Torino 1973.
Solo quest’anno Sergio Corduas ha curato per Einaudi due volumi di saggi di Teige, Arte e
ideologia. 1922-1933 e Surrealismo Realismo socialista Irrealismo. 1934-1951. R. Kalivoda, La
realtà spirituale moderna e il marxismo, trad. it., a cura di S. Corduas, Torino 1971.
75
sospingerlo tra i parenti di Croce e dell’idealismo.
2. Due sono, quindi, i movimenti che occorre compiere: anzitutto collocare
la figura teorica di Mukařovský nella sua storia. Poi, per quel che riguarda
i rapporti con la nostra cultura, insistere su qualche circostanza decisiva.
Per esempio sul fatto che, negli anni (subito dopo il ’70) nei quali è stato
tradotto, è attiva la proposta dell’utopia e dell’estetico, della profezia di una
società estetica. Soltanto all’interno di questa maglia si può comprendere
l’elogio di Mukařovský scritto da Barilli: un arrivo che viene salutato,
appunto, come un’altra conferma della rivincita dell’estetica. Una linea
che, muovendo da Baumgarten, tocca Schiller e Kant, si rafforza con
Ruskin e Morris, viene rilanciata da Dewey e, in altro contesto proprio da
Mukařovský. «La completa indipendenza dei due percorsi (di quello di
Dewey e di Mukařovský) sta ad attestare l’inevitabilità di certi traguardi
culturali, la necessità di rispondere con risposte analoghe (meglio:
omologhe) a situazioni culturali corrispondenti, anche se tali risposte
vengono redatte giovandosi di materiali tra loro diversi, a seconda degli
influssi che hanno agito su ciascuno dei due autori»52. Naturalmente,
non si può dimenticare che il rilancio dell’estetico viene organizzato
all’ombra di Eros and Civilization.
Tuttavia, non va trascurata neppure l’istanza semiotica: il lavoro attento
di rianalisi, sul piano teorico e critico, degli esiti della linguistica e delle
teorie dell’arte che, esplicitamente, pongono il problema dell’opera e
della sua costituzione (fabbricazione, insistevano i formalisti russi). il
problema è di non ridurre l’opera alla sua presenzialità, alla latitudine
orizzontale del suo intrico segnico, di spingere l’opera, senza rinunziare
al livello della favola e delle figure, dei tropi e dei passaggi retorici, verso
un’alterità costitutiva.
Quest’immagine, che certamente coesiste accanto all’altra, assume, come
è facilmente comprensibile, un valore e un ruolo decisivi. Basti pensare al
denso saggio del ’36, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti
sociali. Ora, si tratta di decidere se privilegiare l’intestazione o rivolgersi
al sottotitolo, non meno significativo, che lavora i rapporti tra semiologia
e sociologia dell’arte. In verità, dal punto di osservazione di chi scrive
52 R. Barilli, La rivincita dell’estetica, in «Marcatre», 61-62, nn.6-7, p. 64.
76
alcuni anni dopo la ripresa dell’estetico e la sua caduta, il problema
non è tanto quello di scartare come inutilizzabile il tema dell’estetico,
quanto di sottolineare alcune minacce e qualche impossibilità. Quanto
di insistere sulla rottura dell’opera come sistema chiuso, struttura che
si autodefinisce: una rottura che spinge la teoria dell’arte a fare l’ipotesi
che il livello semiotico è un piano che vive, dialetticamente in bilico, sul
versante di una realtà altra che lo costituisce. Vedremo, comunque, fin
dove anche questa lettura di Mukařovský potrà condurci.
3. La ripresa del discorso non può che individuare il significato
che assumono la funzione, il valore e la norma estetica. Bisognerà
avvertire, immediatamente, che Mukařovský si muove in una geografia
dichiaratamente antimetafisica. La funzione estetica, la norma, il valore
sono fatti sociali. Così come è opportuno tenere conto che «la funzione
estetica ha un campo d’azione più vasto della sola arte», anche se «nell’arte
la funzione estetica è la funzione dominante»53. Scartare l’equazione
funzione estetica/arte significa, evidentemente, tenere distinti i due
campi: il discorso sulla totalità dell’umano in quanto nesso di funzioni e
il discorso sull’arte come produzione che privilegia la funzione estetica
(ma non nega le altre). Mukařovský, quindi, prende subito distanza sia
dall’estetica metafisica sia dalle concezioni panestetistiche dell’arte. La
funzione estetica è in rapporto con la vita e il sociale, è soggetta alle
variazioni storiche, ai suoi mutamenti, alle impennate come alle cadute,
è, a secondo dei livelli di operazione, in relazione dialettica con le altre
funzioni.
Mukařovský delinea, così, con grande rigore una sociologia dell’estetico:
«La stessa arte, per quanto il predominio della funzione estetica e
l’autonomia che gliene deriva la isolino in misura considerevole dalla
realtà e la escludano da un rapporto attivo diretto con le forme e tendenze
della convivenza sociale... presenta una serie di complessi problemi
sociologici. Tanto più dunque la sfera estetica extra-artistica, alla quale
qui è volta in primo luogo la nostra attenzione, si inserisce nel sistema
complessivo della morfologia sociale e partecipa degli avvenimenti
53 J. Mukařovský, Il significato dell’estetica, cit., pp. 5, 10.
77
sociali»54. Dove va sottolineato che la nozione di isolamento non significa,
per l’arte, l’abbandono dell’esperienza, ma indica, precisamente,
l’impossibilità per qualsiasi produzione di eludere la dimensione sociale,
i fatti sociali.
Un’altra citazione ancora più esplicita dice: «La funzione estetica ha
un posto importante nella vita dei singoli e dell’intera società». Ma
la funzione estetica (lo ricordiamo) non è l’unica funzione né tutte le
altre le sono subordinate o gerarchizzate. Mukařovský vuole soltanto
precisare, magari con forza, che il confine tra funzione estetica e funzioni
extraestetiche è meno sensibile e marcato di quanto non si creda. Che,
al contrario, vi è un «continuo rapporto dinamico» tra le funzioni che
costituiscono l’esperienza umana: un movimento dinamico che si
configura come «antinomia dialettica»55.
Il progetto mukařovskýano assume, a questo punto, un volto più preciso.
La funzione estetica, per un verso, si correla alle altre funzioni e, per altre
cose, a secondo del ruolo e della specificità che gioca nella formazione
delle singole operazioni, fa da ponte tra l’arte e i fenomeni estetici. Una
duplicità d’intervento che mette in crisi, come sappiamo, le tentazioni
della metafisica e, al tempo stesso, revoca in dubbio la superiorità dell’arte
rispetto ai fenomeni estetici. Del resto se si tiene conto che la distinzione
tra arti maggiori e arti minori ha trovato la propria legalizzazione nella
vertigine metafisica (l’arte come espressione del Bello, della Verità o
dello Spirito), si capisce come sia efficace questa mossa.
La leggenda dell’estetico, il carattere dinamico e dialettico della funzione
estetica, la sua variabilità e mutabilità, l’apertura dell’opera verso il
mondo e il sociale sono, certamente, i motivi affiorati fino ad ora. Del resto
l’intenzione di Mukařovský è quella di fondare sociologicamente l’intero
progetto, come sappiamo. Infatti, come la funzione estetica è immersa
nei fatti sociali così anche la norma e il valore devono essere inscritti
nell’ordine del reale e del mondano. E non c’è dubbio che l’assunzione di
queste due nozioni (la norma e il valore), che nel corso del loro incedere
hanno subito una continua violenza metafisica, sottolinea la volontà
teorica di colpire le concezioni metastoriche dell’arte proprio nei punti
54 J. Mukařovský, op. cit., p. 20.
55 J. Mukařovský, op. cit., pp. 5, 8.
78
più esposti, nei transiti consacrati. La dichiarazione giunge puntuale a
suggerire che «la norma estetica, regolatrice della funzione estetica, non
è una regola immutabile ma un processo complesso e continuamente
rinnovantesi»56. L’idea della norma come processo, come perpetuo
rinnovamento e continua mutazione, come movimento, la svuota sia della
pretesa di valere come dogma o paradigma, come verità e regola assoluta,
sia anche come canone aureo: la distanzia, dunque, dalla metafisica come
dalla normatività del classicismo.
La funzione estetica è energia (energheia e non ergon), movimento,
così, parimenti, la norma, tradizionalmente paradigma o canone, diviene
processo, attività, tensione, mediazione. «Non soltanto la norma può
essere violata ma è anche pensabile il caso di due o più norme applicabili
allo stesso caso concreto e che misurino lo stesso valore. La norma si
fonda dunque sull’antinomia dialettica fondamentale tra una validità senza
eccezioni e una potenza soltanto regolativa o addirittura semplicemente
orientativa che implica la pensabilità della sua violazione». L’opera, per
progetto, ci insegna Mukařovský, si struttura come dialettica norma/
violazione della norma: «Esaminata dal punto di vista della norma
estetica, la storia dell’arte appare come la storia delle rivolte contro la
norma (le norme) dominante»57.
La norma non è, dunque, un principio immutabile, un emblema valido
per la misurazione di tutte le esperienze dell’arte. È variabile nel tempo
(«Ogni norma muta già per il solo fatto di venir sempre nuovamente
applicata e di doversi adattare ai nuovi compiti che la prassi le assegna»).
Le stesse norme lessicali, grammaticali, anche se con più lentezza, sono
soggette alla mutazione («Grazie allo scopo pratico della lingua e al fatto
che nella sua normale funzione (comunicazione) la lingua tende alla
creazione, le norme linguistiche sono molto più salde di quelle estetiche;
pur tuttavia, mutano anch’esse»). Come mutano le norme giuridiche,
che sono misure ancora più salde e certe. Mukařovský compie anche un
altro passo: si sforza (lui avverte che ricorre a uno «schema grezzo») di
relazionare la norma, anzi le norme, ai diversi strati sociali. «Si affaccia
insinuante l’ipotesi che la gerarchia dei canoni estetici sia in diretta
56 J. Mukařovský, op. cit., p. 19.
57 J. Mukařovský, op. cit., pp. 25, 31.
79
relazione con quella dei diversi strati sociali: la norma più giovane, che
occupa la sommità, sembra corrispondere allo strato più alto della società;
a strati socialmente più bassi corrisponderebbero poi canoni sempre
meno giovani»58. Il passaggio di generazioni, la dinamica dei gruppi, le
promozioni sociali, sono, tutti, motivi da tenere presenti. C’è da dire (e
Mukařovský lo ha detto) che questo schema è assai approssimato, grezzo:
averlo dichiarato non lo assolve, si capisce. Uno schema simile è talmente
generico da suscitare non pochi sospetti: il più serio è che il rapporto non
può essere tra strati sociali ma fra classi. Da questo sguardo l’estetica
materialistica di Mukařovský (il nesso strutturalismo/materialismo,
tanto decantato da Kalivoda) risulta deludente, fragile, incerto. Non ci
sono dubbi, allora, sulla variabilità della norma estetica, sul suo destino
dinamico e antidogmatico. Le perplessità aumentano, invece, a proposito
della fondazione sociologica. La relazione tra funzione estetica, norma
sociale, gli strati sociali, è una relazione francamente assai generalizzante.
Così come precaria è la stessa nozione di fatti sociali invocata fin dal
titolo.
La norma è, naturalmente, strettamente collegata al valore estetico:
su quest’ultimo raccordo si fonda la concezione noetico-filosofica
dell’estetica. Il collegamento norma/valore ci porta ad una svolta,
inevitabilmente, soprattutto se si pensa agli esiti e alle riprese recenti.
Cominciamo con una citazione. «Anche il valore estetico... il cui campo
d’azione è specialmente l’arte, nella quale la norma estetica viene
piuttosto violata che osservata, appartiene per sua natura all’ambito dei
fenomeni sociali. Non soltanto la variabilità della valutazione estetica
attuale ma anche la stabilità del valore estetico obiettivo deve essere
desunta dal rapporto tra l’arte e la società»59. Il valore estetico, dunque,
non è un valore alto, a statuto metafisico, ma per sua natura appartiene
alla dimensione sociale. Non ha, perciò, una stabilità definita per tutte
le volte né una consistenza universale: è variabile, soggetto a cadute e a
modificazioni, ad accidentalità. Non è una grandezza costante.
Mukařovský si adopera, in ogni modo, ad approntare un sistema di
appoggi per dimostrare la mutabilità del valore estetico. Appronta,
58 J. Mukařovský, op. cit., pp. 29, 40.
59 J. Mukařovský, op. cit., p. 79.
80
infatti, un organigramma di situazioni, attraverso le quali, analizzando
i materiali, le intenzioni, le mosse, si dimostri che il valore estetico «è
determinato da un lato dallo sviluppo immanente della stessa struttura
artistica..., dall’altro dal moto e dagli spostamenti della struttura della
convivenza sociale»60. Per noi non è tanto interessante criticare questa
o quell’analisi (per tanti versi ingenua risulta oggi l’indagine sui
materiali utilizzati dagli artisti) quanto richiamare ancora l’attenzione
sull’insuccesso sociologico. Certamente è un merito, per Mukařovský,
avere sottolineato il legame dialettico che solca il valore estetico e la
struttura della convivenza sociale. Tuttavia questo gesto è insufficiente
e inadeguato a motivare sociologicamente il valore estetico. Questa
insufficienza si lega a uno scarso approfondimento della lezione di
Marx, che filtra attraverso mediazioni e referenze indirette. Manca,
infatti, in Mukařovský, una riflessione specifica sull’opera di Marx e di
Engels, una lettura di prima mano. E questa mancanza ha lasciato segni,
evidentemente. Una mancanza attenuata dalla lettura dei Quaderni
filosofici di Lenin (tradotti in ceco all’inizio degli anni ‘30), una lettura
che lo ha condotto, appunto, a Marx e a Engels.
Ma c’è ancora un altro luogo che occorre analizzare con molta pazienza:
lo slittamento del valore estetico verso la dimensione antropologica,
più precisamente il nesso tra estetico e costituzione antropologica. È
una meditazione ulteriore di Mukařovský (del 1939), è la risposta alla
domanda se il valore estetico può essere universale. Anche in questa
circostanza Mukařovský si guarda dall’affidare il valore estetico a una
cifra metafisica, a una fondazione mitica. Il valore estetico è sempre
un valore storico, legato alla costituzione antropologica dell’umano. In
fondo il punto di partenza è collegato a un sospetto di Marx. «È vero che i
cambiamenti del valore estetico che lo storico registra possono apparirgli
come la prova della relatività fondamentale di questo valore e che è
possibile trovare una giustificazione per qualsiasi opera. Ciò nonostante
il suo compito è di tracciare una linea coerente del processo dell’arte e in
questo lavoro egli incontra ad ogni passo opere che esercitano ancora un
influsso attivo molto tempo dopo che hanno lasciato lo studio dell’artista.
60 J. Mukařovský, op. cit., p. 57.
81
In queste opere il valore universale appare come un fattore potente»61.
La lunga citazione vuole sottolineare che il problema dell’universalità
del valore nasce dall’esigenza, tutta concreta, di dare conto del fatto
che un’opera può essere vitale anche oltre i confini storici che l’hanno
prodotta. Perché l’epos è «norma e modello irraggiungibile», si era già
chiesto Marx. Ma la risposta marxiana, sostenuta con vigore, tra i primi,
da Lukács, è guidata dall’idea che «Marx e Engels hanno scoperto le
leggi della società gentilizia e della dissoluzione di essa». Soltanto per
questa ragioni, che sono naturalmente ragioni determinate, «l’arte greca,
in quanto espressione dell’infanzia normale nell’ambito dell’evoluzione
del genere umano, viene ad occupare il suo vero posto storico»62. Che
è, ricordiamolo, un posto privilegiato. Ma, a differenza di Hegel, per il
quale l’arte greca costituiva la vera arte, anzi l’unica, Marx e Engels,
negli abbozzi dei loro discorsi sull’arte, non sono così pessimisti (sono
ancora termini lukácsiani) verso l’arte loro contemporanea.
Comunque sia, il problema ha, nello stesso pensiero marxiano un
precedente che non può essere trascurato. Mukařovský non lo discute:
forse la motivazione storica per giustificare l’universalità del valore
estetico gli sarebbe sembrata inadeguata. Perfino contenutistica. Il valore
estetico universale, pur essendo variabile, non trae la propria universalità
dal concreto storico. «La sua variabilità in ritorni sempre rinnovati a una
determinata costante, cioè alla costituzione generale dell’uomo». Le
indicazioni sulla costanza antropologica dell’uomo sono assai illuminanti,
in verità: si precisa, anzitutto, che «la costituzione antropologica in se
stessa non ha nulla di estetico; essa è perciò in una tensione qualitativa
con le sue realizzazioni estetiche, e ogni realizzazione scopre un nuovo
aspetto della costituzione generale dell’uomo». E, subito dopo, si
legge che «anche è possibile che il valore estetico universale... possa
malgrado la stabilità di questo suo sostrato dare impulsi ai cambiamenti
e rivolgimenti nel processo dell’arte»63.
La tensione mukařovskýana è rivolta, dunque, a sottolineare come la
costanza antropologica non sia una condizione estetica e come l’opera,
61 J. Mukařovský, op. cit., p. 129.
62 G. Lukács, Contributi alla storia dell’estetica, trad. it., Milano 1957, p. 143.
63 J. Mukařovský, op. cit., pp. 139, 140.
82
in sostanza, non si riduca alla ripetizione di questo sostrato generale
dell’uomo. Il rapporto tra l’opera e il fondo antropologico non è una
relazione tautologica, una semplice notizia intorno all’inaccessibilità
antropologica dell’umano. Tuttavia, se Mukařovský evita di ridurre
l’opera a tautologia (tentativo che del resto non supera la buona volontà)
non evita, sicuramente, la trappola del contenutismo. «Il postulato di una
norma estetica generale legata alla costituzione antropologica dell’uomo
ci appare come un evidente residuo eterogeneo dell’estetica contenutistica
metafisica nel sistema della teoria strutturale»64. Il rilievo, corretto, è di
Kalivoda. Se, però, la critica di Kalivoda è condividibile, la soluzione
avanzata per correggere Mukařovský è francamente peggiore del male.
Basterà questa conclusione: «… L’estetico stesso si manifesta appunto
come uno specifico valore antropico puro, come una manifestazione
estrema della costante antropologica dell’uomo, manifestazione vuota
e pertanto anche essenzialmente non di classe»65. Indubbiamente siamo
fuori di qualsiasi tentazione contenutistica. Però è altrettanto vero che
l’estetico come valore antropico puro, non di classe (anzi «l’estetico è in
grado di liberare l’uomo dai suoi limiti di classe»), è un valore metafisico,
una credenza mistica addirittura.
4. Il rischio che comporta la costanza antropologica, il fondo
antropologico, non è sfuggito a Mukařovský se, nel corso della sua
ricerca, ha abbandonato questo concetto per puntare sulla funzione. Lo
spostamento non è casuale né immotivato, evidentemente. L’obiettivo è
esorcizzare il fantasma della metafisica.
Sullo strutturalismo (1946) e soprattutto Sulla concezione cecoslovacca
della teoria dell’arte (1947) segnano una svolta in questa direzione.
Ora i punti di analisi sono i rapporti tra la struttura e l’holismo, la
relazione tra struttura e dialettica, la falsità del legame forma/contenuto,
l’insistenza sul nesso arte/lingua, la sottolineatura che l’arte è segno e non
espressione, l’attenzione alla semioticità interna dell’opera, il problema
della funzione e, infine, l’antica questione arte/società. E, questa volta, il
legame arte/società viene avvistato come rapporto arte/classi sociali. Ma,
64 R. Kalivoda, La realtà spirituale moderna e il marxismo, cit., p. 62.
65 R. Kalivoda, op. cit., p. 68. Precisi, a proposito, i rilievi di M. Costa, Teoria e sociologia
dell’arte, Napoli 1974, pp. 19, 32.
83
giova dirlo, si tratta soltanto di un accenno. Magari da esibire all’istante:
«Il marxismo... ha mostrato che il rapporto tra l’opera e la società è
nella sua essenza attivo: l’arte è portatrice della tendenza della società,
eventualmente di una parte della società (classe) e partecipa attivamente
alla formazione della sua ideologia e alla difesa dei suoi interessi»66. Dove
è chiaro che, inevitabilmente, si affaccia anche il tema dell’ideologia.
I nuclei da mettere in evidenza sono adesso immediatamente due:
l’opera come struttura e l’opera come segno. La configurazione della
struttura è, almeno nelle intenzioni, formulata in chiari termini dialettici
in aspra polemica con l’holismo che concepisce la struttura come tutto.
«Lo strutturalismo invece concepisce l’unità del tutto come dovuta ai
rapporti reciproci tra le componenti, e non soltanto ai rapporti positivi
(concordanze e accordi) ma anche a quelli negativi (opposizioni e
contrasti); perciò il concetto di struttura è in essenziale relazione con il
pensiero dialettico». L’indicazione è ancora più rigorosa se colleghiamo
la citazione con quest’altro brano: «I rapporti tra le componenti, proprio
perché dialettici, non possono dedursi dal tutto; il tutto non è nei loro
confronti prius ma posterius e la loro individuazione quindi non è una
questione di speculazione astratta ma empirica»67.
D’accordo, senz’altro, sulla nozione di struttura come sistema di
relazioni, si dissente, invece,. E proprio per l’invocato carattere dialettico
delle relazioni che la costituiscono, sulla sua empiricità. La struttura,
certamente, non è un prius rispetto alle relazioni che la costituiscono,
ma non può essere neanche un posterius. Perché se fosse così sarebbe il
risultato di una somma, di un’addizione. Se, dunque, Mukařovský sfugge
alla trappola della Struttura/Tutto non sfugge, però, alla suggestione della
Struttura/Addizione: le due facce, in conclusione, della stessa svista. La
svista dell’adialetticità della struttura.
La dialetticità della struttura è, tuttavia, affermata e inseguita da
Mukařovský marcandone il movimento incessante e il cambiamento
(«L’equilibrio interno tra le componenti è continuamente spezzato
e ricostruito e l’unità della struttura ci appare come un equilibrio di
energie»), al punto da dire che «ad ogni attimo la struttura è e non è la
66 J. Mukařovský, op. cit., p. 214.
67 J. Mukařovský, op. cit., p. 206.
84
stessa». Mukařovský si sforza, così, di non imprigionarla nella propria
configurazione(«La chiusura della struttura (è) soltanto relativa», avverte).
Non solo. Ma tenta anche di collegarla agli «impulsi evolutivi esterni».
Tanto da dire, riferendosi alla creazione artistica, che la «struttura non è
soltanto la composizione interna dell’opera... ma anche e prima di tutto
la tradizione viva di una data arte»68. Indicazione importante che rinvia
a una significativa acquisizione di Šklovskij. «Come regola generale
aggiungo: un’opera d’arte viene percepita sullo sfondo di altre opere
d’arte in relazione ad esse. La forma di un’opera d’arte viene determinata
dal suo rapporto con le altre forme che l’hanno preceduta»69. Il saggio
di Šklovskij, Rapporti tra gli artifici della costruzione della trama e i
comuni artifici stilistici del ’19, segna, come ragionevolmente suggerisce
Ejchenbaum, il «passaggio dalla poetica alla storia letteraria»70. Per
ritornare a Mukařovský, dopo il richiamo a Šklovskij, va registrato ancora
un altro spostamento: la sottolineatura della «natura sovra individuale,
sociale» della struttura, appunto. Mossa che fa slittare il progetto dalla
struttura come sistema di relazione dialettica tra gli elementi che la
costituiscono a una dimensione che, rompendo il proprio limite, si apre al
sociale e al collettivo. In quest’orizzonte si colloca, allora, l’affermazione
che «l’essenza principale dell’arte… non è l’opera d’arte individuale ma
l’insieme delle consuetudini e delle norme… La singola opera d’arte sta
a questa struttura sopraindividuale come la manifestazione linguistica
individuale sta al sistema linguistico, che anch’esso è proprietà di tutti
e oltrepassa colui che in un dato momento fa uso della lingua»71. Con
questo nuovo rapporto (la relazione opera d’arte/sistema linguistico)
Mukařovský pone, in maniera assai fruttuosa, la questione dell’opera
come struttura linguistica. Questa consapevolezza non è nuova, in verità.
Mukařovský l’ha formulata, per la prima volta, nel ’34, L’arte come fatto
semiologico: uno scritto nel quale viene ripreso il complesso discorso
dei formalisti russi reinterpretato all’ombra delle Tesi. Il collegamento,
quindi, con questo saggio, precoce, è inevitabile.
68 J. Mukařovský, op. cit., pp. 207-208.
69 V. Šklovskij, Una teoria della prosa, trad. it., Bari 1966, pp. 40-41.
70 B. Ejchenbaum, Il giovane Tolstoi. La teoria del metodo formale, trad. it., Bari 1968, p. 159.
71 J. Mukařovský, op. cit., p. 208.
85
In apertura di discorso Mukařovský delinea con chiarezza il suo punto
di vista. «La scienza dei segni (semiologia di Saussure, sematologia per
Bühler) deve essere elaborata in tutta la sua ampiezza: come la linguistica
contemporanea (cfr. le ricerche della scuola di Praga cioè del Circolo
Linguistico di Praga) amplia il campo della semantica studiando da questo
punto di vista tutti gli elementi del sistema linguistico, non escluso i suoni,
così risultati della semantica linguistica devono essere applicati a tutte le
altre serie di segni ed essere distinti secondo i loro caratteri specifici»72.
È indicata, appunto, la necessità di una semiotica dell’arte: manovra che,
secondo l’insegnamento dei formalisti e dello strutturalismo, significa
liquidazione di tutte quelle teorie che riconducono l’opera allo stato
d’animo dell’autore e alla psicologia dei personaggi, alla fruizione del
lettore e dello spettatore, alla genesi socio-politica. Sono gli anni, questi
dopo il ’30, che, tramontate le esperienze dell’avanguardia, in Russia, si
affacciano prepotentemente sulla scena le idee e i precetti zdanoviani.
L’oggetto artistico come oggetto semiotico, si è detto, non si esaurisce
nell’articolazione interna dei suoi elementi, i quali, mobili quanto si
voglia, sono inevitabilmente giocati nel recinto della struttura. «L’opera
d’arte è un segno autonomo, caratterizzato soltanto dal fatto di mediare
tra i membri di una comunità», continuo a dire Mukařovský. Dove,
innanzitutto, è da chiarire il senso, da attribuire all’autonomia del segno
e, poi, la sua caratterizzazione (quella di consentire la mediazione con
il sociale). Mukařovský, come si è accennato, riprende alcune nozioni
saussuriane: anzitutto l’indicazione capitale del segno come rapporto
significate/significato. Vediamo come avviene lo spostamento dei concetti
saussuriani dal livello specifico della teoria della lingua alla teoria
dell’arte. «L’opera-cosa…non funziona che come simbolo esteriore (il
significane nella terminologia di Saussure) al quale corrisponde nella
coscienza collettiva un significato (che a volte chiamiamo “oggetto
estetico”) dato da ciò che hanno in comune gli stati di coscienza
soggettivi stimolati nei membri di un dato collettivo dell’opera-cosa». Il
rapporto tra significante e significato, tra opera-cosa e oggetto-estetico è
una relazione obliqua, è un rapporto indiretto. «Dalla natura semiologica
dell’opera discende che non si deve mai usare un’opera d’arte come
72 J. Mukařovský, op. cit., p. 141.
86
documento storico e sociologico»73 . In questo senso (e soltanto così) si
deve intendere l’autonomia del segno: nel senso che il “qualcosa” a cui si
riferisce, il significato, non è univocamente determinato. Il segno, in altri
termini, non coincide con il significato né l’opera, perciò, può mai essere
il rispecchiamento, il riflesso, della realtà. Mukařovský, ricollegandosi,
appunto, alla tradizione saussuriana e alla tematizzazione linguistica
della scuola di Praga, rifiuta con energia la teoria dell’arte come riflesso
e come rispecchiamento.
Non c’è dubbio che la proposta prende l’avvio, tra l’altro, da quel celebre
punto, il quinto, del paragrafo Sulla lingua poetica delle Tesi, dove si dice
senza tentennamenti che «il principio (nel testo: indice) organizzatore
dell’arte, in funzione del quale essa si distingue dalle altre strutture
semiologiche, è che l’intenzione viene diretta non sul significato ma
sul segno stesso…Il segno è una componente dominante in un sistema
artistico»74. L’autonomia del segno, invocata da Mukařovský, apre
dunque alla riconsiderazione dell’opera come oggetto semiotico, come
indagine sulla struttura linguistica che la costituisce: un oggetto che,
comunque, non si riduce alla propria interna semioticità ma che si ribalta
costantemente all’esterno verso il significato o oggetto estetico. Soltanto
il segno che è l’opera non combacia con il significato, con l’oggetto
estetico depositato nella coscienza collettiva, nella rete dei gruppi sociali
e delle classi.
L’operazione di Mukařovský non si ferma, in vero, neanche a questa
considerazione teorica. Si spinge, nell’intenzione di chiarire al massimo la
natura dell’opera come segno, ad un’ulteriore distinzione: la distinzione
tra segno autonomo e segno comunicativo. Ormai sappiamo come
intendere il segno autonomo. Il segno comunicativo si definisce proprio
in opposizione al segno autonomo. «Un’opera poetica con funziona
soltanto come opera d’arte ma contemporaneamente come “parola”
che esprime un dato stato d’animo, un pensiero, un’emozione, ecc.»75.
73 J. Mukařovský, op. cit., pp. 142, 143, 144.
74 Il Circolo Linguistico di Praga, Le Tesi del ’29, trad. it., introd. di E. Garroni, Milano 1966, p.
78. Sui complessi rapporti tra lingua poetica e linguaggio standard si v. di Mukařovský, Standard
language and poetic language, in A Prague School reader on esthetics, literary structure and
style, a cura di P. L. Garvin, Washington 1964.
75 J. Mukařovský, op. cit., p. 144.
87
Il segno comunicativo è, dunque, un segno che svolge una funzione
secondaria, un ruolo pratico. L’ipotesi s’inscrive e rinvia al lungo,
tormentato, lavoro dei formalisti. Ejchenbaum, ricostruendo la teoria del
metodo formale, a proposito di questa distinzione, richiama i contributi di
Jakubinskij. Nel primo dei suoi lavori, Sui suoni del linguaggio poetico,
1916, Jakubinskij delinea la questione in termini evidenti: «Se il parlante
persegue un fine meramente pratico, avremo a che fare con un sistema
linguistico pratico (di pensiero linguistico) in cui gli elementi della
lingua (i suoni, le particelle morfologiche) non posseggono alcun valore
autonomo e sono semplici mezzi. Ma sono pensabili (e di fatto esistono)
anche altri sistemi linguistici in cui il fine pratico si attenua (senza
peraltro sparire completamente) e gli elementi linguistici assumono un
valore autonomo»76. Da Jakubinskij a Šklovski, a Jakobson (citando per
emblemi) la questione, come si sa, giunge ai praghesi, che, nelle Tesi,
individuano come proprietà specifica del linguaggio poetico (rispetto alla
lingua della comunicazione) l’accentuazione di un «elemento di conflitto
e di deformazione» e l’attuazione dei diversi piani della lingua poetica.
Siamo giunti, così, alla distinzione tra funzione poetica e funzione
comunicativa77.
Mukařovský, nell’area di questi riferimenti, lavora per dimostrare che
l’«opera d’arte ha...una duplice funzione semiologica, autonoma e
comunicativa, dove la seconda è riservata soprattutto alle arti tematiche»78.
In breve: pittura e letteratura sono arti tematiche mentre, invece, la
musica e l’architettura sono arti atematiche. E la distinzione è legata alla
maggiore o minore comunicabilità dell’oggetto artistico, naturalmente.
5. L’indicazione del 1928 di Tynjanov e Jakobson per la continuazione
dei lavori è decisiva perquel richiamo all’analisi della «correlazione
della serie letteraria con le altre serie storiche» senza perdere di vista
76 La citazione di Jakubinskij è in E. Ejchenbaum, op. cit., p. 147.
77 Il Circolo Linguistico di Praga, op. cit., pp. 71-75. Sulla questione si rinvia a L. Rosiello,
Struttura, uso e funzioni della lingua, Firenze 1965, a G. C. Lepschy, La linguistica strutturale,
Torino 1966 (cap. III), a M. GRANDE, Il problema della lingua poetica nella Scuola di Praga,
in «Nuova Corrente», 1971, n.56.
78 J. Mukařovský, op. cit., p. 145.
88
però le «leggi immanenti ad ogni sistema»79. Mukařovský muove da
questa esigenza, non c’è dubbio, anche se non lo dichiara esplicitamente:
esigenza che, come si è registrato, spinge molto oltre. Il problema per
Mukařovský non si circoscrive, infatti, alla semplice correlazione della
serie letteraria o artistica con quella storica. La questione diviene un’altra:
questa volta è il significato ad appartenere al sociale, è l’oggetto estetico
ad essere dislocato nella coscienza collettiva e nella dinamica dei conflitti
sociali.
L’opera, si è detto, è un segno autonomo. E, in quanto segno, è una
relazione significante/significato: soltanto che questa relazione non
si costituisce come rapporto univoco, diretto, come due facce che
combaciano perfettamente. Con questa manovra Mukařovský, più di
quarant’anni fa, pone il problema del significato come «qualcosa» che non
determina l’opera. L’accento è spostato in modo palese sul significante.
Solo che il significante rinvia, per statuto logico, al significato. Ma è un
rinvio obliquo, che segue la mossa del cavallo raccomandata da Šklovski.
Se la tematizzazione dell’estetico, della funzione, della norma e del valore
estetico lasciano uno spazio considerevole alle incursioni della metafisica,
se la stessa nozione di struttura è aperta allo scacco dell’empirico (la
struttura è un posterius), il discorso sull’oggetto artistico come oggetto
semiotico è, invece, il luogo sul quale maggiormente si può contare. Il
punto suscettibile di incrementi e scatti.
L’avere insistito, vigorosamente, sulla tensione sociale della struttura,
sulla sua estroversione, è certamente un merito notevole. Avere, poi,
centrato il legame significante/significato come nesso obliquo e indiretto
è senz’altro un contributo irrinunciabile.
L’opera-segno, dunque, rimanda a un’alterità (il significato che vive nella
comunità) per eludere la tentazione di rimanere imprigionata nel lucido
congegno delle correlazioni strutturali. Ma quest’alterità non si pone
come un significato che la costituisce geneticamente. Il mito della genesi
storico-sociale, ora, è decisamente cancellato. L’obliquità del legamento
opera/significato dà garanzia che l’oggetto artistico non è la ripetizione
79 J. Tynjanov, R. Jacobson, Problemi di studio della letteratura e del linguaggio, in I Formalisti
russi, a cura di T. Todorov, pref. di R. Jacobson, trad. it., Torino 1969, p. 149.
89
del già noto, di una trama storico-concettuale definita80.
(1974/1975)
80 «Come ogni segno, l’opera può avere con la cosa significata un rapporto indiretto, per esempio
metaforico o in altro modo obliquo» (J. Mukařovský, op. cit., p. 144).
90
Hauser. Il corso tortuoso della dialettica
1. Riprendiamo, per un momento il discorso dal principio, dalla Storia
sociale dell’arte (e siamo alla metà degli anni ’50). Il progetto è quello
di stringere in un rapporto dialettico il nesso tra arte e società. Per Hauser
la vita delle opere d’arte non è rinchiusa in una compiuta autosufficienza
microcosmale ma rinvia, necessariamente, a un contesto extrartistico, a
una genesi storico-sociale.
Il contributo di Hauser all’elaborazione di questo taglio storico
attraversa due varchi difficili: lo scontro con modelli che si fondano sulla
«compiutezza microcosmale» dell’opera e il rifiuto netto del sociologismo
e del contenutismo becero. La critica alla «compiutezza microcosmale»
dell’opera d’arte non investe solamente le concezioni di discendenza
romantica, l’art pour l’art, le stesse istituzioni poetiche di fine secolo,
ma anche quelle teorie che riducono i linguaggi artistici al congegno
dei rapporti interni. Sfilano, così, tra gli altri, Croce, Riegl, panofsky,
responsabili, per ragioni diverse, di avere privilegiato il momento
dell’autonomia se non proprio dell’indipendenza dell’opera rispetto
alla genesi storico-sociale. Invece, «la storia dell’arte, se vuole capire
il fenomeno dei mutamenti dello stile, non può assolutamente evitare il
salto dell’opera d’arte chiusa alla realtà aperta, extrartistica»81. Sul fronte
della critica al contenutismo e al sociologismo dialettico, Hauser assume
come bersaglio polemico il mito dell’equivalente sociologico: la certezza,
cioè, che esista sempre una relazione diretta fra la produzione dell’arte,
la realtà sociale e la lotta di classe. «sarebbe un grave errore vedere nelle
condizioni sociali dell’Atene contemporanea le premesse necessarie
o anche soltanto le premesse ideali della nascita di un’arte simile e
così alta», avverte Hauser in un celebre passaggio. Transito che viene
ulteriormente specificato quando aggiunge che «il valore artistico non ha
alcun equivalente sociologico: tutt’al più, la sociologia può ricondurre
alla loro origine gli elementi di cui si compone un’opera d’arte, ma questi
81 A. Hauser, Le teorie dell’arte. Tendenze e metodi della critica moderna, trad. it., Torino 1969,
p. 213.
91
elementi possono essere gli stessi in opere di qualità diversissima»82.
La sociologia, dunque, non è in grado di dare conto della qualità e del
pregio dell’opera (e della sua complessa organizzazione). Può solamente
riconoscere dell’opera le premesse sociali e le articolazioni, non meno
difficili e reticolari.
Hauser, nella Philosophie der Kunstgeschichte, 1958, sospinge più avanti
la sua ipotesi, insistendo sulle diverse motivazioni che costituiscono
l’opera d’arte: «Essa è condizionata tre volte: psicologicamente,
sociologicamente e dal punto di vista storico-stilistico»83. La tensione,
adesso, è rivolta all’analisi più rigorosa e puntuale dei «fini e limiti
della sociologia dell’arte» (come si intitola l’introduzione), a una
maggiore attenzione teorica verso il rapporto arte/ideologia, lasciato con
troppa cautela in ombra nella Storia sociale dell’arte, alla ripresa della
psicoanalisi e alle relazioni con il marxismo.
La critica alla teoria del rispecchiamento, al legame meccanico tra arte
e struttura economico-sociale, si arricchisce ora di un argomento nuovo:
«Lo stimolo sociale che sta dietro a una manifestazione spirituale può
essere anche inconscio e operare inconsciamente». Anzi lo stimolo
sociale «opererà tanto più fortemente, quanto meno consciamente è
stato espresso e quanto meno intenzionalmente cerca o sembra cercare
consensi». Il sociale diviene, dunque, una genesi inconscia, che lavora
nascostamente e che si offre nella ricchezza e nella molteplicità delle
mediazioni: «In arte… il modo di esprimersi indiretto, ideologico, non è
soltanto il più efficace, ma anche il più rivelatore per la storia dello stile,
perché i princìpi sociali diventano veramente determinanti stilistiche
soltanto quando non possono essere espressi direttamente»84. L’attenzione
alla genesi inconscia del sociale, alle articolazioni intermedie (Engels),
all’ideologia come falsa coscienza, sposta, senza dubbio, l’asse del
discorso. I punti di riferimento si aprono così a ventaglio: insieme a
Marx debuttano Nietzsche e Freud. La nozione di ideologia come falsa
82 A. Hauser, Storia sociale dell’arte, trad. it., II ed., v. I, p. 150. Il brano conclude il capitolo
Classicità e democrazia, che presenta, a tutta prima, un «problema sociologico insolitamente
arduo»: l’inconciliabilità della democrazia, liberale e individualistica, con lo stile classico (p.
137).
83 A. Hauser, Le teorie dell’arte. Tendenze e metodi della critica moderna, cit., p. 23.
84 A. Hauser, op. cit., pp. 33, 34.
92
coscienza richiama certamente il concetto freudiano di razionalizzazione
e le nietzschiane maschere del soggetto. Nell’intrico della falsa
coscienza e del suo smascheramento, dei meccanismi inconsci, della
razionalizzazione e dell’ideologia, l’arte gioca, secondo Hauser, un ruolo
decisivo: è un sistema capace di modificare la parzialità dell’ideologia, la
sua falsa coscienza, le sue inafferrabili (sfuggenti) razionalizzazioni. «La
storia è il conflitto dialettico tra l’ideologia e l’idea di verità, fra volere e
sapere, fra il desiderio di mutare la nostra esistenza e l’inerzia… di questa
esistenza»85. I simboli dell’arte sono in grado di mettere allo scoperto e
superare i difetti dell’ideologia, l’inerzia che impedisce al desiderio il
mutamento. L’arte è, perciò, utopicamente, negazione dell’ideologia e
smascheramento della falsificazione, desiderio di vincere la parzialità.
Secondo un insegnamento che ritrova in Mannheim e poi in Bloch punti
di raccordo esemplari: una lezione che sarà attiva, con rinnovata lucidità
e acutezza di esiti, nella Sociologia dell’arte del ’74, il suo lascito
testamentale oramai.
Il percorso hauseriano, dalla Storia sociale dell’arte e Le teorie dell’arte, si
sposta, dunque, dal livello arte/società al più delicato nodo arte/ideologia,
lungo una linea che coinvolge la psicoanalisi e, per certe suggestioni,
Nietzsche. Ora c’è un punto che va discusso: ed è precisamente quel
luogo dal quale siamo partiti. Il rifiuto, cioè, di assegnare alla qualità
e al pregio artistici equivalenti sociologici. Decisione dialetticamente
sapiente, come si è ricordato, ma che, tuttavia, per il modo com’è stata
formulata lascia spazio a numerosi problemi. La sociologia dell’arte
è in grado di spiegare le premesse sociali e la genesi delle differenze
stilistiche di Rubens e di Rembrandt ma non il mistero della loro arte,
sottolinea Hauser secondo modelli ermeneutici consueti. Questo compito
(indagine sul mistero) spetta invece all’estetica. Ma, così facendo, Hauser
non affida all’estetica un compito assolutamente ingrato: l’ufficio di
decifrare nozioni (il mistero, la grandezza) sfuggenti, ineffabili, ambigue,
metastoriche? Col risultato di minacciare la stessa idea dell’arte come
totalità dialettica e di abbandonarsi a pericolose sortite neoromantiche?
85 A. Hauser, op. cit., p. 43. Su questi temi e, più in generale, sulla posizione teorica di Hauser
rinviamo al nostro saggio, L’inconscio dell’opera. Sociologia e psicoanalisi dell’arte, Roma
1974.
93
2. Non è un caso che la riflessione sulla dialettica e sulla totalità sia uno dei
momenti più significativi della Soziologie der Kunst. La critica hauseriana
si rivolge alla validità illimitata della dialettica, anzitutto. E poi alla sua
riduzione, da parte di Hegel, alla filosofia dell’identità, l’identità di vero e
di realtà («La realtà però non è né razionale né irrazionale, bensì estranea
alla ragione; essa corrisponde alla ragione o la contraddice a seconda del
rapporto dialettico in cui viene posta con essa»)86. O anche (ed è l’altra
variante della filosofia dell’identità) all’idea dell’automovimento dello
spirito e della società.
La pratica hauseriana della dialettica, di contro all’identità e alla continuità,
apre al discontinuo e alle cesure: «Il passaggio dalla tesi all’antitesi, dalla
contraddizione alla conciliazione, dalla chiarificazione al superamento,
include da qualche parte un salto immediato». Perciò «l’unica forma
adeguata e chiara in cui si può rappresentare il movimento dialettico da un
grado all’altro è il rinviare alle fratture nella catena delle mediazioni»87.
La dialettica, dunque, ha un decorso imprevedibilmente tortuoso giacché
«il processo storico non è un processo indirizzato in senso univoco, un
processo deducibile direttamente e senza cesure dalla sua origine»88
La dialettica, così rivisitata, ha, comunque, come prospettiva e telos la
pienezza dell’umano, la totalità contro la frammentazione e l’alienazione
della società tardo capitalistica, post-industriale.
L’arte, in questo progetto, svolge un ruolo singolare, direi privilegiato.
Basta una citazione. «La proprietà attribuita alla “totalità dialettica”
da parte del marxismo ortodosso, cioè che i suoi singoli momenti
“portano in sé la struttura del tutto”, in realtà la mostrano soltanto le
opere d’arte. I singoli costituenti nell’opera d’arte sono della medesima
specie della loro totalità e unità; soltanto qui batte in essi la medesima
vita che nell’organismo di cui sono membri»89. Perché l’arte debba essere
esperienza privilegiata tra le produzioni culturali resta, naturalmente, un
problema, una resistenza umanistica (forse).
86 A. Hauser, Sociologia dell’arte, trad. it., v. II, p. 101.
87 A. Hauser, op. cit., p. 103.
88 A. Hauser, op. cit., p. 9.
89 A. Hauser, op. cit., p. 106.
94
3. La ricerca di Hauser è stata, dunque, per quasi trent’anni, un lavoro
incessante, assiduo, di messa in questione di una disciplina, la teoria
sociale dell’arte e del suo statuto. Analisi dei limiti delle tecniche e
degli strumenti che, di volta in volta, adopera. Distanza, in parte, dalla
stessa trama concettuale, fondamentale per una storia sociale dell’arte,
d’ispirazione marxiana: le nozioni, appunto, di dialettica e di totalità. E,
tuttavia, non c’è dubbio che, all’altezza degli anni Ottanta, la sua proposta
risulta poco soddisfacente. In sostanza, Hauser non riesce a organizzare
un discorso accettabile (talvolta dà l’idea di non preoccuparsene) proprio
su quel terzo livello che avevano individuato Le teorie dell’arte, la
dimensione storico-stilistica. Nella Sociologia dell’arte a questo piano
del discorso non si fa neanche un cenno: eppure la tortuosità della
dialettica, gli scarti e le mosse del discontinuo, avrebbero dovuto offrire
possibilità nuove per la risoluzione di questi problemi. Una risoluzione
(e vale soltanto come indicazione) che ha invece avviato, per tempo,
Francastel, ponendo il pensiero plastico all’incrocio di esigenze teoriche
multilaterali, dalla sociologia alla linguistica, all’antropologia. Gli Studi
di sociologia dell’arte del ’70 e l’Esthétique et etnologie del ’68 non
c’è dubbio che, insieme a La figure et le lieu, costituiscono una svolta
rispetto alle posizioni, pur così ricche di umori, di Arnold Hauser.
Ma, in vero, non è sui limiti di quest’esperienza che si vuole concludere il
preambolo su Hauser. Quanto sulla circostanza che in Hauser si corrode
uno dei punti di forza delle teorie sociologiche dell’arte d’ispirazione
marxiana: l’illusione che l’arte, attraverso una sapienza dialettica, possa
rappresentare il significato ed esprimerlo nella sua compiutezza. Il
cammino tortuoso della dialettica, i varchi che il discontinuo apre nel
tessuto della storia, le lacune e i bianchi, sono spie che suggeriscono
una relazione con il significato difficile e mai a senso unico. È singolare,
perciò, la convergenza di Hauser con Mukařovský, che muove da
riferimenti e da ambiti teorici differenti. La tortuosità della dialettica, i
suoi impervi itinerari, sono così prossimi all’obliquità mukařovskýana:
all’idea che il rapporto tra opera e significato (un significato naturalmente
collocato nella coscienza collettiva e nel sociale) è, appunto, indiretto, un
legame laterale.
Il lungo viaggio di Mukařovský intorno al nodo strutturalismo,
semiotica, marxismo, e la riflessione di Hauser sulle categorie centrali
95
della tradizione marxiana, si ritrovano, alla fine, a pensare la stessa
questione: l’impossibilità di configurare il significato come «qualcosa»
immediatamente rappresentabile. Non c’è dubbio, poi, che la messa in
discussione del significato indica lo sfiorire di uno dei punti fondamentali
degli ultimi grandi sistemi, semiotica e marxismo, o del loro possibile
intreccio. Averlo indicato e patito, per Mukařovský come per Hauser, non
è, certamente, un semplice fatto.
(1978)
96
Terminabile, interminabile
Sulla critica interminabile
1. In verità, non si tratta di mettere la critica al posto dell’arte e nemmeno
di pensare la critica come arte. Il punto è un altro, ed è di ordine
epistemologico: investe i modi di produzione di questa pratica sociale, la
sua struttura di relazione, i percorsi che disegna, la dichiarata pretesa di
porsi come metodo globale e le stesse suggestioni totalizzanti alle quali
non riesce a sfuggire malgrado tutte le cautele. Un’analisi, dunque, del
linguaggio critico e dei suoi riti di egemonia e di governabilità assoluta,
in questo caso della governabilità assoluta, senza residui, dell’arte. La
revisione del linguaggio della critica s’inscrive, allora, nel più articolato
discorso sulla crisi della ragione, nel dibattito che individua nel metodo
un nemico da combattere e ripensa talvolta la scienza «molto più vicina
al mito di quanto una filosofia scientifica sia disposta ad ammettere»90.
Un progetto che, d’altra parte, non può non essere consapevole anche
dei rischi che innescano, su un fronte opposto, le voci rizomatiche e la
marginalità i bordi silenziosi e le tessiture fragili del mito.
Dunque, l’arte non c’entra (e non ci deve entrare), neppure se la si
assume come modello di decostruzione. Un modello, questo del poetico,
al quale Baudrillard assegna il compito di sterminare la linguistica e la
psicoanalisi, perché vive oltre «la barra di equivalenza fra ciò che è detto
e ciò che vuol dire…(e oltre) la barra della rimozione fra ciò che è detto
e ciò che è taciuto, rimosso»91. Un modello, questo dell’arte, al quale
(e proprio all’opposto) è stato assegnato il compito, nella pronunzia
della psicoanalisi come arte, di funzionare da dispositivo denegativo
nei confronti della psicoanalisi come scienza, presenza positivistica e
paradigma scientista. Una produzione, questa dell’arte, che vive, così,
ancora come nostalgia di assoluto, l’assoluto della totale simbolizzazione
della morte, piuttosto che come trasparenza d’infinito e azzurro del cielo.
2. Non la critica al posto dell’arte e nemmeno la critica come arte,
l’arte della critica (dunque). Ma piuttosto la critica come strega
90 P. K. Feyrabend, Contro il metodo, trad. it., Milano 1979, p. 240.
91 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, cit., 1979, p. 32.
99
metapsicologica, secondo il detto di Freud: «Non si può avanzare di un
passo se non speculando, teorizzando – stavo per dire fantasticando – in
termini metapsicologici»92.
Ma cosa significa dire esattamente che la critica è una strega metapsicologica,
la quale non rimuove il fantasticare e sembra, anzi, stabilire proprio
un’aria di famiglia tra teorizzare e fantasticare? Forse la ripresa (e di
questa ripresa del resto le tracce sono molteplici) di una dialettica tra
astrattezza delle forme e materialità dei contenuti, fra il temperato, dolce,
calore della fantasia e la rigidità ordinatrice dell’intelletto? Insomma, un
ritorno a Kant, magari sotto travestimenti sofisticatissimi?
Per la via di Freud, in verità, il ritorno a Kant sembra improbabile,
addirittura impossibile, giacché la critica freudiana è propriamente
critica della macchina, kantiana e postkantiana, che si svolge nel segno
di un soggetto costituente che risarcisce le scissure e unifica le fratture
che scuotono il sistema, garantendo la pienezza della ragione. Con
Freud, non soltanto viene scossa l’idea della ragione unitaria, ma anche i
progetti parziali, legati alla frantumazione dei linguaggi, che pretendono
d’innalzare la verità del proprio discorso e verità onnicomprensiva. La
critica freudiana colpisce, dunque, non solamente la rappresentazione
unitaria e totalizzante della ragione ma anche le procedure più caute e
accorte, nel nome di un linguaggio che non si pone come il linguaggio
della verità93.
Allora (ed è la prima indicazione) la critica come strega metapsicologica
non è e non aspira ad essere linguaggio unitario e scrittura di verità,
discorso capace di ridurre nel proprio spazio la pluralità dell’oggetto:
quel testo che Bachtin ha pensato come intreccio e scansione infiniti di
piani94.
La critica come strega metapsicologica è essenzialmente linguaggio
dell’incertezza, Unsicherheit, precarietà e caducità, Vergänchlickeit.
Ma non caducità e incertezza come insufficienza e mancanza, come
interferenza perturbatrice e lutto per la sua fine ma, precisamente come
92 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), in Opere 11 (1930-1938), trad. it.,
edizione diretta da C. L. Musatti, Torino 1979, p.508.
93 Interessanti considerazioni sono contenute nel saggio di Rella, Il discredito della ragione, in
AA. VV., Crisi della ragione, a cura di A. Gargani, Torino 1979.
94 M. Bachtin, Il problema del testo, in AA.VV., Michail Bachtin , trad. it., Bari 1977.
100
correttivo, forse meglio sterminio, dell’esigenza di eternità.
Ecco perché la critica come strega metapsicologica ritiene oramai
insufficienti (e inadeguate) le stesse proposte che si limitano a mettere
in questione l’oggettività, l’impassibilità, la coerenza del metodo.
Proposte che ci giungono per altro dai territori della psicostoria, da
Alain Besançon che, più di altri, si è sforzato di ridefinire il ruolo e il
compito dello storico postfreudiano95. Certo l’irruzione del soggettivo
corrode lo schermo sempre più opaco che distanzia il critico e lo storico
dal documento e dal testo. Senz’altro il ricorso alle nozioni di transfert
e di controtransfert scuote il distacco e la professionalità del critico e
soprattutto dello storico. Ora, i fantasmi dello storico s’intrecciano e si
sovrappongono, attraversano il testo: ripercorrendo il testo, il critico non
sfugge alla domanda sul proprio isolamento, sul suo sguardo silenzioso
e giudicante. Non c’è dubbio che l’uso di questi strumenti freudiani
abbia scomposto la compattezza dei testi, abbia insinuato il veleno della
discontinuità, aprendo uno spazio più duttile e mobile all’ascolto. Perché
di ascolto si tratta, proprio come avviene nell’incontro tra analizzato e
analista. Un ascolto fluttuante, oscillante pur se vigile, pronto a cogliere le
sfumature e i margini più che il senso, disposto a inseguire il labirinto dei
testi in infiniti spostamenti, come in una deriva. E questa deriva, questo
slittare sregolato tra i testi, non è che un analogo delle libere associazioni,
un concetto sostitutivo che conclude il circolo dell’analogia tra storico
e psicoanalista o, ancora meglio, che stringe la relazione testo-storico/
analizzato-analista.
Soltanto a queste condizioni è possibile far parlare i testi, leggerli («La
psicoanalisi è un modo di ascoltare? La storia deve essere un modo di
leggere»), rendere conto della ramificazione progressiva del reticolo di
significati, interpretarla. Ma cos’è che bisognerà leggere? Di certo non
l’orizzontalità del testo, la trama che si offre allo sguardo e lo ferisce, ma
quel secondo discorso, il non detto originario, che si annida al di sotto
degli enunciati e della superficie dei documenti e delle scritture.
L’apertura sullo scenario immaginario dello storico e sulle distese
fantasmatiche del critico, l’ascolto fluttuante, come l’unico metodo capace
di intricarsi nella progressiva ramificazione della rete dei significati, la
95 A. Besançon, Storia e psicoanalisi, trad. it., pref. di S. Moravia, Napoli 1975.
101
sovradeterminazione della parola, del documento e dei testi, il rinvio
a una profondità del discorso, la relatività dell’interpretazione («Se si
potesse comprendere a fondo un solo sogno, diceva Freud, la psicoanalisi
sarebbe terminata. Se si potesse ottenere l’interpretazione completa di
un evento, la storia intera vi sarebbe contenuta»), sono nodi importanti
e, tuttavia, insufficienti (si è detto). Insufficienti (e inadeguati) perché
tagliano ancora nettamente il testo in superficie e profondità, in una
trama visibile e in un non detto invisibile, legalizzando così quel «resto
enigmatico e silenzioso che gli (al linguaggio) sta dietro e che esso non
produce», nell’illusione, avverte Faucault, che esiste «al di là delle analisi
strutturali, formali o interpretative del linguaggio, un campo finalmente
affrancato da ogni positività in cui si possono liberamente esprimere
la libertà del soggetto, la fatica dell’essere umano o di un destinazione
trascendentale»96.
3. La relatività dell’interpretazione, la ricchezza sovradeterminata
del testo, la messa in gioco della pienezza del significato vengono,
comunque, come limitate dal discorso ad una realtà altra, a quel secondo
e più profondo discorso, il discorso dell’inconscio: una profondità che
l’ascolto fluttuante del critico o dello storico tende a disvelare in una
progressione infinita. È evidente, in questo movimento, la vicinanza di
Freud alla tradizione dell’ermeneutica e alla concezione dell’inconscio
come creatività: un rischio che, però, non può essere eluso, con una
manovra opposta, dalla mossa di Ernst Gombrich (decisamente riduttiva).
Evidentemente non ci sono rapporti filologicamente accertabili tra
la psicostoria di Besançon e Gombrich97: comune è solo il punto di
partenza, Freud. Differenti il metodo, le intenzioni, la prospettiva.
Gombrich può diventare, così, l’altro polo del discorso: il versante in
cui le nozioni di interpretazione e di significato vengono calibrate
in maniera radicalmente diversa. La strategia gomberichiana lavora,
infatti, il campo dell’interpretazione come un sapere definito, scartando
la congettura a favore della comprensione esauriente dell’opera e
96 M. Foucault, L’archeologia del sapere, trad. it., Milano 1971, p.130.
97 Il testo di Gombrich al quale ci si riferisce in particolare è Aspirazione e limiti della psicoanalisi,
in Immagini simboliche. Studi sull’arte nel Rinascimento, trad. it., Torino 1978. Per un riscontro
più puntuale rinviamo ai nostri Itinerari freudiani. Sulla critica e la storiografia, Roma 1979.
102
l’incompletezza dell’ipotesi per la completezza della dimostrazione.
Siamo, dunque, distanti dalla besançoniana relatività dell’interpretazione
completa dell’evento: per Gombrich l’interpretazione è la «ricostruzione
di una prova perduta», attraverso la quale l’iconologo non soltanto deve
individuare la storia raccontata dall’opera, ma soprattutto «deve arrivare
al significato di quella storia in quel particolare contesto». Il campo
dell’interpretazione diviene, allora, il luogo del significato dominante,
quel «significato che ci propone di esprimere o intento principale del
quadro».
È evidente che la stessa rilettura di Freud (alla quale Gombrich non
manca di riferirsi) risulti alla fine estremamente impoverita e riduttiva. Il
punto della discordia è, senz’altro, la nozione di iperdeterminazione: «…
Le scoperte della psicoanalisi hanno certamente contribuito all’abitudine
di trovare, in una data opera, tanti livelli di significato». Ma l’essenziale
è altrove: non consiste tanto nell’individuare «le catene di causazioni…
le leggi di natura sottese al gioco degli eventi» quanto nel distinguere tra
queste serie infinite di cause e il significato dell’opera e delle cose. Ed è
proprio questa essenzialità che distingue lo storico dall’iconologo, che ne
delimita i compiti («L’iconologo si occupa di questo – del significato –
nella misura in cui può essere definito. Lo storico deve essere consapevole
della complessità ed elusività di quelle»).
Non c’è dubbio che la pratica goberchiana dell’iconologia, centrata
sul significato dominante, sull’analisi univoca della relazione simbolo/
contesto, sulla precedenza (logica) delle istituzioni linguistiche e del
codice, dei generi e dei programmi, sia un modo forte di sottolineare
la comunicabilità dell’opera e la sua storicità. E insieme di affrancare
l’iconologia dalle tentazioni mistiche e dalle fughe archetipologiche,
di porre al riparo il simbolo dalla suggestione delle costanti inconscie
collettive. Tuttavia l’attacco portato alla nozione di sovradeterminazione,
il suo ridimensionamento, è, come si è accennato, funzionale all’idea
dell’interpretazione come strategia del significato dominante e della
completezza, della meta raggiunta. È una maniera di interrompere quel
rapporto tra sovradeterminazione e sovrainterpretazione indicato da Freud
nella Traumdeutung: «Nello stesso modo in cui ogni sintomo nevrotico, e
il sogno stesso, sono passibili di sovrainterpretazione, anzi la esigono per
essere totalmente compresi, così anche ogni autentica creazione poetica,
103
sorge da più di un motivo, da più di un impulso nell’anima del poeta e
ammette più di un’interpretazione»98.
4. Il gioco dell’interpretazione oscilla, così, tra profondità e superficie, tra
una radicalità mai raggiungibile e una possibilità di cogliere un significato
dominante, tra l’ascolto e il lavoro paziente sui materiali, sul programma
e sul codice: freudianamente, fra interminabilità e terminabilità.
La domanda adesso è su Lacan, precisamente su una dimenticanza: «Era
Lacan che scopriva l’opera di Freud oppure l’opera di Freud mutilata
almeno dalla metà della sua sostanza che serviva da passaporto a Lacan?
Partito alla ricerca della metà mancante, non mi fu difficile scoprire
che la teoria lacaniana era basata su un’esclusione, una dimenticanza
dell’affetto»99. A questa mutilazione, all’esclusione dell’affettività,
indicata per tempo da André Green come la parte mancante di Freud in
Lacan, al suo risarcimento, è dedicato il lavoro di Franco Fornari, che, tra
l’altro, si pone come una «nuova proposta per la psicoanalisi dell’arte»100.
L’avvio è, naturalmente, centrato sull’interpretazione: «Sarebbe…
un grave equivoco ritenere di poter costruire una interpretazione sulla
mera supremazia della catena significante, distaccata dalla verticalità
semantica del significato»101. Per sfuggire a questo equivoco, per eludere
l’arbitrarietà dell’interprete e delle sue scelte non resta, suggerisce
Fornari, che limitarne le possibilità. Una limitazione possibile, però,
soltanto se si ristabilisce l’ordine del discorso freudiano, mettendo a
posto giusto il significante e il significato. «Si deve a Jacques Lacan se
la psicoanalisi della seconda metà di questo secolo ha preso la strada del
linguaggio. Riconosciuto questo merito di base, ritengo di dover precisare
che, mentre il fallo (cioè uno dei coinemi) è per Lacan significante di
significanti, nella mia costruzione teorica è uno dei diversi significati»:
ed è questa, insiste Fornari, una profonda diversità102. L’opposizione tra le
culture del testo sacro e le culture grammaticalizzate è la mossa decisiva,
98 S. Freud, L’interpretazione dei sogni (1899), in Opere 3, trad. it., cit., Torino 1966, p. 247.
99 A. Green, Il discorso vivente, trad. it., Roma 1974, p. 8.
100 F. Fornari, Coinema e icona. Nuova proposta per la psicoanalisi dell’arte, introd. di F.
Menna, Milano 1979 e I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio, Torino 1979.
101 F. Fornari, Coinema e icona, cit., p. 1.
102 F. Fornari, I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio, cit., pp. 14-15.
104
dunque, per aprirsi all’affetto, per poterlo costruire come semiosi, per
parlare di una semiosi affettiva («È… innegabile che, dopo Freud, gli
affetti sono diventati linguaggi»).
Alla supremazia del significante Fornari oppone la verticalità semantica
del significato, dunque. Ma questa è la croce: come si costruisce il
significato, qual è lo statuto della semiosi affettiva, quali i meccanismi e
la grammatica? E ancora. Qual è il rapporto tra la semiosi affettiva, e le
altre pratiche discorsive, gli altri enunciati? Perché è proprio il significato
e la sua verticalità, questa sconfinata latitudine notturna, a limitare
l’arbitrarietà dell’interprete, a recintare lo stesso campo dell’interpretare,
a sospingerlo verso la sua terminabilità? La scena costruita da Fornari è
precisa ed articolata. Prende l’avvio dalla scoperta freudiana del sogno
come linguaggio: «Partendo dalle invarianti affettive che presiedono
al simbolismo onirico si arriva a postulare unità elementari del
significato affettivo paragonabili alle unità elementari sonore (fonemi)
e commensali alla costituzione dei significati lessemici, rispetto ai quali
vanno intesi come metasemantemi»103. Tuttavia Fornari si affretta a
marcare la differenza tra i fonemi e le unità elementari del significato
affettivo, i coinemi appunto: mentre i fonemi sono unità distintive e non
significative, i coinemi, invece, «sono unità minimali originariamente
portatrici di senso affettivo (per questo sono “donatori di senso”) a degli
strati del mondo, intesi come entità brute prive di senso». I coinemi sono
perciò significativi ma non distintivi, sono conflusivi, sono «qualcosa
di extralinguistico, che tuttavia è essenziale per la costituzione del
linguaggio, allo stesso modo in cui l’inconscio è extracosciente ma decide
dei contenuti della coscienza»104. I coinemi, parentemi ed erotemi, sono
invarianti precostituite, sono «immagini-parole, che ci pre-esistono e che
ci giungonodall’aldilà della storia», sono «pre-immagini–pre-parole che
fanno capo ad una esteriorità genetica, caratterizzata dai modi strutturali
esterni al tempo, alla storia e alla razionalità dell’uomo occidentale», sono
i «binari entro i quali, e solo entro i quali, può esercitarsi l’arbitrarietà
dell’interprete»105.Continuando. i coinemi sono idee affettive innate,
103 F. Fornari, op. cit., p. 13.
104 F. Fornari, op. cit., pp. 352-356.
105 F. Fornari, Coinema e icona, cit., pp. 4, 2.
105
relativamente trascendenti; col fatto che questa trascendenza, prossima
alle idee platoniche, si coglie, però solamente attraverso i suoi derivati
nella produzione infinita dei segni e dei significanti. Infatti «i coinemi e
le strutture elementari coi nemiche devono intendersi come preconfezioni
linguistiche o anche come ipotesi affettive linguistiche, che sono iscritte
nel codice genetico sotto forma di mondo interno originario destinato a
integrarsi, attraverso processi di esternalizzazione, su stati del mondo dei
quali costituiscono la simbolizzazione affettiva primaria»106.
Il disegno di Fornari è, chiaramente, quello di allargare, oltre il sintomo
nevrotico e il lapsus, i denotati simbolici del sogno, l’intervento della
psicoanalisi. Ecco cosa propone, esattamente, la coinoanalisi: «…
Avviarla (la psicoanalisi) a diventare teoria linguistica e ermeneutica, che
studia la regolarità di tutte le pratiche di discorso umano»107. In definitiva,
ogni simbolo verbale ha una duplice referenza, ogni segno e quindi ogni
icona hanno una doppia semantica («La teoria della semiosi affettiva
postula che ogni simbolo verbale è preceduto da un simbolo coinemico»).
L’affettività e la sua organizzazione grammaticale sono, così, centro di
ogni produzione di parola: un centro situato fuori/dentro la parola, accanto
e lontano dal corso delle pratiche discorsive, dei linguaggi (compreso il
linguaggio corporeo). Un nucleo, questo costituito dalle unità elementari
notturne, che decentra la parola e l’icona ma che, tuttavia, ha bisogno
della loro materialità diurna per venire alla luce e inverarsi.
Non ci sono dubbi, Fornari ripropone, contro l’insegnamento di Lacan,
una doppia semiosi (con regole e grammatiche specifiche), insiste sulla
discontinuità della regione notturna e di quella diurna, ripensa la loro
complessità secondo una marcia a delfino. Ma è proprio discontinuo
questo tragitto del notturno alla luce del giorno, dalla selva al campo?
Lasciamo, per un altro momento, in sospeso questo problema per capire
meglio (prima) in che modo l’analisi coinemica rivive l’esperienza
dell’arte.
«Così interrogare l’arte in rapporto alle sue origini coi nemiche significa
interrogarla ai confini della significazione, dove la significazione stessa
106 F. Fornari, I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio, cit., pp. 355.353. Più di
recente, in Il codice vivente (Torino 1981), si legge addirittura che i «coinemi costituiscono una
specie di riserva naturale selvatica» (p. 42)
107 F. Fornari, Coinema e icona, cit., p. 2.
106
mostra il suo esistere attraverso la lacerazione tragica di un indistinto nel
quale si scopre la commensalità ubiquitaria e silenziosa della nascita e
della morte», avverte Funari, sottolineando, subito dopo, come «l’analisi
coinemica porta dunque fatalmente ad una lettura tragica dell’arte,
perché l’Altro non appare più solo come decentrato rispetto al soggetto,
e promotore di segni da un luogo non visto e non sospetto: l’Altro è in
realtà un análogon, commensale alla parola e all’immagine, come parola
dentro ogni parola, immagine dentro ogni immagine». Interrogare l’arte,
la poesia o la pittura non importa, significa, allora, per l’analisi coinemica
andare oltre i suoi valori formali, l’immanenza e la sua struttura, per
cogliere i procedimenti delle movenze affettive, la radice e il centro,
le unità notturne, significa, appunto, far scattare, accanto agli specifici
dispositivi semiotici, la semiosi affettiva: infine, significa parlare il doppio
statuto dell’immagine e della parola, questa duplice referenza, la doppia
semantica. Per esempio, significa aggiungere a tutto quello che si sa (e
si potrà sapere) sulla riduzione cézanniana della pittura al cilindro, alla
sfera e al cono anche il fatto che, a livello onirico, «il cilindro e la sfera
sono simbolizzanti dell’elemento maschile (cilindro) e dell’elemento
femminile (sfera). Il cono, quale mescolanza di sfericità e verticalità,
può essere visto coi nemicamente come accoppiamento dell’elemento
maschile con l’elemento femminile»108.
5. Adesso ritorniamo a quella domanda lasciata in sospeso: alla questione
della discontinuità. Certo, esistono regole e grammatiche differenti che
presiedono all’organizzazione di questa doppia semiosi affettiva e della
semiotica diurna. Tuttavia la relazione tra le distese dell’affettività e
le diverse pratiche linguistiche, questa commensalità, è compromessa
proprio dall’avere postulato alcuni significati, poche invarianti, quegli a
priori che Fornari chiama appunti coinemi. D’accordo per il doppio statuto
dell’immagine o della parola. Solo che (e a questo punto le perplessità
crescono) il piano semiotico è ricondotto a dei significati pre-costituiti,
a immagini pre-esistenti, ai denotati simbolici del sogno. Insomma, alla
madre, al padre, al fratello, al bambino, agli organi sessuali maschili e
femminili, alla castrazione, al rapporto sessuale, alla nascita e alla morte,
108 F. Fornari, op. cit., pp. 3, 197.
107
al corpo umano. Col risultato di stabilire nuovamente un rapporto lineare,
di continuità tra il linguaggio della notte e quello del giorno, fra la semiosi
affettiva e gli enunciati.
La discontinuità è,dunque, soltanto apparente, certo è invece il tracciato
univoco che dal regno delle Madri conduce all’universo dei discorsi:
una linearità che ripara dai margini dell’arbitrio dell’interprete e fa dello
stesso atto interpretativo un’operazione saldamente picchettata. È vero,
la marcia a delfino di Fornari si pone in mezzo a un guado: nel mezzo di
chi consegna l’interpretazione allo scenario immaginario dell’interprete,
di chi, lacanianamente, la dissolve nelle catene del linguaggio dell’altro,
o di chi, accanitamente, la riduce all’analisi del significato dominante,
visibile, solo che gli strumenti di indagine sono calibrati ed efficaci. Ma
di questa medietà la fornariana marcia a delfino sconta tutte le ambiguità
e i disagi: l’idea tenace che i coinemi sono donatori di senso, binari che,
raffreddando l’ascolto dell’interprete, regolano il cammino accidentato
dell’interpretazione, assegnandole una meta e un termine. Riducendola,
direbbe Freud, ad archeologia109.
(1980)
109 «… Mentre per l’archeologia la ricostruzione coincide con la meta e il termine di tutti gli
sforzi, per l’analisi la costruzione è soltanto un lavoro preliminare» (S. FREUD, Costruzioni
nell’analisi (1937), in Opere 11, cit., p. 544).
108
Il motto di spirito, il poetico
1. I rischi sono una frequentazione destoricizzata di Lacan, la sua
suggestione di una di una scittura eccentrica impossibile, la tentazione di
ripeterne il fascino. In questo modo ha funzionato Lacan per la teoria e la
critica dell’arte. E non solamente per la critica d’arte, in verità. Così, fuori
contesto, le analisi su il risveglio di primavera, sul Sosia o sul barocco,
la stessa domanda Qu’est-ce qu’un tableau? sono diventate occasioni di
meccanica applicazione ad altre situazioni e ad altri territori.
Si tratta, invece, di non considerare le analisi su Plauto e Molière, sul
barocco e la pittura, come specifiche di un discorso sulla teoria delle
arti, ma di collegarle piuttosto dentro la rete che Lacan lavora per il suo
ritorno a Freud. È con questa rete, allora, e non con i singoli nodi, tagliati
e recisi, che la critica delle arti dovrà misurarsi: è, appunto, di questo
ritorno a Freud, al senso di Freud, che dovrà calcolare gli spostamenti e
le ombre.
Il problema è di cogliere l’oggetto. «La prima parola che Lacan vuole
dire: innanzitutto Freud ha fondato una scienza. Una scienza nuova,
che è la scienza di un oggetto nuovo: l’inconscio», a ricordato subito
Althusser110. È, dunque, a questo oggetto nuovo che la teoria delle arti e
la critica dell’arte (in particolare) dovranno guardare quando vorranno
riflettere sulle strutture profonde che traversano il testo, sulla costituzione
stessa della testualità, sull’inconscio dell’opera. Facendo fuori, così, non
solamente l’antico mestiere del biografo, l’inconscio dell’autore o dei
personaggi, ma anche i più sofisticati intrecci delle metafore ossessive e
delle maglie mitologiche personali o collettive.
Per la critica dell’arte uno dei cammini più sicuri per costeggiare questo
oggetto inedito è certamente il Witz, il motto di spirito. È proprio la sua
diversità, infatti, che, del resto, Freud non ha mancato di sottolineare
(«La diversità più importante è nel loro atteggiamento sociale. Il sogno
è un prodotto psichico assolutamente asociale… il motto invece è la più
sociale di tutte le funzioni psichiche che mirano al profitto di piacere»),
che, come vedremo, lo rende prossimo all’esperienza del linguaggio
110 L. Althusser, Freud e Lacan, trad. it., in «aut-aut», maggio-giugno 1974, p.75.
109
poetico. Se si aggiunge, poi, la riflessione sulla struttura formale del Witz,
una riflessione che da Freud a Lacan a subito oscillazioni e variazioni
sensibili, questa prossimità diventa sempre più pensabile.
«Per trascurata che sia dal nostro interesse…, Il motto di spirito e
l’inconscio rimane l’opera più incontestabile perché la più trasparente,
in cui l’effetto dell’inconscio ci sia dimostrato fino ai confini della sua
finezza; e il volto che ci rivela è quello stesso dello spirito nell’ambiguità
che il linguaggio gli conferisce, in cui l’altra faccia del suo potere regale
è la “punta” per cui l’intero suo ordine si annienta in un solo stante, punta in cui la sua attività creatrice svela la sua assoluta gratuità, in cui la
sua dominazione sul reale sia esprime nella sfida del nonsenso, in cui lo
humor, nella grazia malvagia dello spirito libero, simboleggia una verità
che non dice la sua ultima parola»111. Questa indicazione (che è del ’53)
viene ripresa e più puntualmente calibrata nelle lezioni 6, 13, 20 dicembre
del 1957 dedicate alle formazioni dell’inconscio («Ciò che chiamiamo
inconscio è il significante in azione», dirà ora esplicitamente Lacan).
Il motto di spirito è una scansione decisiva dell’altalena incessante della
produzione dell’inconscio, per via del lavoro inesauribile sul significante
e sulla metafora, per la capacità di debordare dall’ordine del significato e
dal rigore del codice. «Il fatto è che Freud afferra le relazioni strutturali
tra il motto di spirito e l’inconscio. Su che piano? Unicamente sul piano
formale. Freud si affida alla tecnica del motto di spirito, la tecnica del
significante». Tanto da chiedere se quel celebre esempio freudiano,
familionari (familiari/milionari), è soltanto un atto mancato o creazione
poetica, un lapsus o un sottile intricato esercizio metaforico. Certo è che
la condensazione offre un esito, quel familionari appunto, che è incongruo
e sfugge al codice, un resto che, proprio per questo, assume valore di
messaggio e appare sul significante come qualcosa di nuovo, come un
caso particolare della funzione di sostituzione.
Lacan, riprendendo la suggestione di Freud, si chiede qual è la fonte di
piacere che procura la battuta di spirito, il Witz. La risposta è che non è
adeguato privilegiare soltanto la stagione dell’infanzia, quando “giocare”
con le parole è senz’altro piacevole e gratificante. L’invito è a cogliere,
piuttosto, il nesso che l’esercizio formale del motto stabilisce con le
111 J. Lacan, Scritti, trad. it., a cura di G. Contri, vol. I, Torino 1974, p. 263.
110
leggi che strutturano l’inconscio: la libertà creatrice, il suo carattere
di arbitrarietà: «Si potrebbe dire che il motto di spirito vi fa nascere
un essere di poesia». Creazione, lievitazione di senso, accanimento
sul significante e sulla dimensione della metafora sono, certamente, le
valenze del Witz: quella specificità che, si è detto, lo rende prossimo al
linguaggio poetico e, più in generale, delle arti. E che insieme lo distanzia
dal comico centrato in prevalenza sull’imitazione e sulla ripetizione, sul
doppiaggio e sul fenomeno del sosia112.
2. L’importanza del motto di spirito nell’accostare le produzioni
dell’inconscio («… Per cogliere l’ordine dell’inconscio freudiano è
necessario attraversare una via che non sia la presa concettuale; ed è
proprio del motto di spirito l’introdurre… uno spirito irriducibile, sia alla
funzione del giudicare che i rigori concettuali»), la sottolineatura della
sua poeticità, insistenza sull’infinito esercizio metaforico, sono momenti
che sollecitano la teoria e la storiografia dell’arte a una riflessione
ulteriore, riannodando (del resto) fili mai spezzati. Il Witz, infatti, è uno
spazio che la teoria dell’arte pratica già dagli anni Venti, con Vygotskij
e Bachtin (Vološinov e non è poi Bachitn?) per smontare il progetto
della psicoanalisi dell’arte come trama biografica e recinto di contenuti
definitivi e universali e per aprire, al tempo stesso, alla testualità e alla
storia. «Quello che noi tentiamo, è di pervenire a una pura e impersonale
psicologia dell’arte indipendentemente dall’autore e dal lettore, prendendo
in esame soltanto la forma e il materiale dell’arte»113. La rilettura lacaniana
del motto di spirito credo che coinvolga, direttamente, quel nodo centrale
per la critica dell’arte, la relazione iconologia/psicoanalisi lungo l’argine
segnato dalle ricerche di Kris e di Gombrich, ricerche rubricabili, almeno
per quel che ci riguarda, alla voce, appunto, motto di spirito. All’idea
(per essere più precisi) di riutilizzare il dispositivo freudiano dentro il
sistema dell’arte figurativa, delle immagini visive: di provare dunque le
tecniche del Witz all’interno di un genere specifico, la caricatura («… La
caricatura è in fondo una forma grafica di motto di spirito»). Il punto dal
quale muove Kris è senz’altro freudiano: l’Herabsetzung della caricatura,
112 (1956-1959) Seminari di Jacques Lacan, raccolti e redatti da J. B. Pontalis, trad. it., Parma
1979, pp. 64, 54, 56, 58, 62, 65.
113 L. S. Vygotskij, Psicologia dell’arte, trad. it., Roma 1972, p. 23.
111
la degradazione di ciò che è elevato, lo smascheramento, la sua forza di
ribellarsi contro l’autorità («In questo fattore sta anche il fascino della
caricatura, della quale ridiamo anche quando non è ben riuscita, solo perché
le attribuiamo il merito di ribellarsi contro l’autorità») inscrivo questo
processo in un’economia psichica che tende al risparmio di energia e al
raggiungimento del piacere che come nel Witz, deriva da una liberazione
di aggressività e dal gioco sapiente della forma. Ma il rapporto con il
motto di spirito è sorpreso da Kris anzitutto nella rete che la retorica del
Witz stabilisce con il linguaggio del sogno e il sistema dell’inconscio e,
ad un altro livello, con l’infanzia. Legami, questi, fra caricatura, motto,
sogno, infanzia, garantiti dalla fragile logica del processo primario
e dei suoi intricati, difficili, itinerari. Tuttavia, «nel motto di spirito e
nella caricatura il processo primario rimane al servizio dell’Io»: un
avviso che misura la distanza di Kris da Freud e pone il motto di spirito
e la caricatura in lontananza dal linguaggio onirico, immerso nel fluire
perverso del processo primario. Comunque, se l’impiego controllato del
processo primario e la regressione controllata limitano il processo di
Kris, l’intenzione di ricollegare Witz, caricatura, processo primario resta
una acquisizione fondamentale: «Il processo primario (aggiunge Kris)
deve avere uno strumento su cui esercitarsi. Non può produrre un giuoco
di parole che non sia celato nel linguaggio. E allo stesso modo neppure
il caricaturista può seguire totalmente la propria fantasia. Egli è legato
alla grammatica del suo linguaggio che è la forma; una grammatica,
aggiungiamo, che differisce ampiamente dalla grammatica della lingua
parlata e di cui manca sinora un’analisi adeguata»114. Un’analisi che lo
stesso Kris ha solamente sfiorato. Mentre Gombrich, che alla grammatica
del linguaggio visuale ha offerto contributi decisivi, ha però di recente,
come si è ricordato, proposto una lettura assai riduttiva della teoria
freudiana dell’interpretazione.
3. L’attacco lacaniano al Witz marca, si è detto, l’affinità con il poetico
(«Col motto di spirito cerco di risvegliare nell’altro il linguaggio con tutto
ciò che comporta, allo stato latente, di creazione di senso»): un’affinità
che ci aiuta a discutere le conclusioni di Kris e di Gombrich soprattutto,
114 E. Kris, Ricerche psicoanalitiche sull’arte, trad. it., pref. di E. H. Gombrich, Torino 1967,
pp. 172, 173, 193.
112
la loro prudenza, stando al riparo dell’irruzione del processo primario e
delle sue leggi, in attesa della verità che ci dica l’ultima parola. Ma, al
tempo stesso, questa affinità ci fa ripensare anche le risoluzioni di chi,
sottolineando la differenza radicale tra il poetico e il Witz, rilancia il poetico
come modello di destrutturazione totale, si s-terminio dell’economia
politica come di quella libidica. «In questa prospettiva, altri venti
storici assumono un’importanza capitale: gli anagrammi di Saussure, lo
scambio/dono di Mauss: ipotesi più radicali, a lungo termine, di quelle
di Freud e di Marx, prospettive censurate proprio dall’imperialismo delle
interpretazioni freudiana e marxista», dice Baudrillard.
Così, il poetico, scivolando fra testualità senza resto e senza bordi e
s-terminio di ogni regola e legge («… Nel poetico esso – Baudrillard
intende il significato – si diffrange e irradia nel processo anagrammatico,
non cade più sotto il colpo della legge che lo erige, né sotto il colpo
del rimosso che lo lega, non ha più nulla da designare, nemmeno
l’ambivalenza d’un significato rimosso»), riconferma, drammaticamente,
la sua inscrizione positivistica o la sua infinita nostalgia d’assoluto,
l’assoluto della morte e delle operazioni senza equivalenza e senza
accumulazione: «… Il poetico… non tace nulla, e nulla ritorna ad
assillarlo. Perché ciò che è sempre rimosso e taciuto è la morte»115. Per
sfuggire a questa svista non resta alla critica dell’arte che soffermarsi
proprio su questa affinità, indicata da Freud e lavorata da Lacan, tra il
motto di spirito e il poetico, evitando assimilazioni indebite nel nome del
primato dell’economia dell’inconscio come cancellazioni e terminazioni
nel segno dell’irriducibilità della morte. Pensare la distanza tra opera
e fantasma è diventato, probabilmente, per la critica la domanda più
assillante.
(1979)
115 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, cit., pp. 11, 243. Un passo dopo: «… Il nulla,
la morte, l’assenza, è apertamente detta e risolta: finalmente la morte si manifesta, finalmente è
simbolizzata, mentre in tutte le altre formazioni discorsive non è che sintomatica».
113
La storia con Freud
1. L’attenzione di Peter Szondi alla ricostruzione della storia
dell’ermeneutica proposta da Dilthey pone una serie di questioni decisive,
non c’è dubbio. Il testo di Dilthey esaminato da Szondi, nel tentativo di
valutare gli apporti alla fondazione di un’ermeneutica critica e materiale
della letteratura, è Die Entstehung der Hermeneutik, apparso nel 1900,
in apertura di secolo, e, fatto singolare per il destino delle polemiche che
attraverseranno il Novecento, quando Freud portava a termine la prima
stesura della Traumdeutung.
Il giudizio dello studioso ungherese sul senso dell’esposizione diltheyana
si può così riassumere: la ricostruzione che la Die Entstehung propone
della storia dell’ermeneutica segue un modello continuista, adatto a
risolvere le tensioni positive, talvolta divergenti, che hanno occupato i
metodi interpretativi, ma soprattutto conveniente a una nozione astorica
dell’intendere. L’arte dell’interpretazione si è, infatti, sviluppata per
Dilthey «in maniera affatto progressiva, regolare e lenta» e, come per
ogni arte, la sua storia ha concorso innanzitutto alla «esposizione delle
sue regole. La scienza ermeneutica è sorta dal conflitto di queste regole,
dall’opposizione tra i diversi modi di interpretare delle opere fondamentali
e dalla conseguente necessità di fondare quelle regole»116. La tesi
diltheyana del «decorso regolare» appare, invece, commenta Szondi, «non
poco problematica»: il mutamento storico, infatti, «non si lascerà certo
ridurre al fatto che grazie al progressivo approfondimento dell’indagine
ermeneutica ora è stato trovato nell’analisi dell’intendimento “un sicuro
fondamento” per la formulazione di regole: nella storia, piuttosto, lo
stesso concetto di intendimento si modifica, così come si modifica la
concezione dell’opera»117.
La storia dell’ermeneutica testimonia, perciò, un conflitto non
placato tra due intenti, presenti alternativamente nei metodi elaborati
dall’interpretazione dei testi obsoleti, il grammaticale e l’allegorico.
Questi tentano procedimenti oppositivi, pur nella comune «messa da
116 W. Dilthey, Die Entstehung der Hermeneutik, trad. It., in Ermeneutica e Religione, a cura di
G. Morra, Bologna 1970, p.54.
117 P. Szondi, Introduzione all’ermeneutica letteraria, trad. it., Parma 1979, pp. 14-15.
115
parte» della distanza storica fra testo e lettore. Infatti, «l’interpretazione
grammaticale mira a quel che un tempo s’è inteso dire, e vuol conservarlo
o sostituendo all’espressione verbale – in termini linguistici: al segno –
divenuto storicamente ostico un segno nuovo, oppure affiancando questo
a quello in una glossa. L’interpretazione allegorica, invece, s’accende a
contatto col segno ormai ostico, al quale assegna un nuovo significato
derivante non dalla sfera di idee del testo ma da quella del suo esegeta».
Lo scontro tra i due metodi esegetici e il loro alterno prevalere inducono
a una più approfondita coscienza della storicità dell’intendere, a una
«risalita, al di là delle regole, verso un’analisi dell’intendimento», merito
che lo stesso Dilthey riconosceva a Schleiermacher nel cammino verso
una fondazione filosofica dell’ermeneutica118. Il «decorso regolare»
diltheyano, nella lettura di Szondi, omologa astrattamente i poli di una
«dialettica interna» per la quale «il campo dell’ermeneutica si apre alla
storia stessa», nel nome di una virtuosità filologica che, in qualche modo,
bloccherà la fondazione della scienza dell’interpretazione al continuiamo
storico in ogni senso. I due punti chiave della Die Entstehung restano,
sul piano di una riconsiderazione della genesi e dello sviluppo
dell’ermeneutica il convergere delle differenze dei metodi nel corso
della storia verso «la formazione e l’ordinamento delle regole» come
«sicuro fondamenta» della comprensione e, sul piano delle intenzioni
epistemologiche, il progetto di un sapere storico che sia prima di tutto
«un’interpretazione valida in senso universale», che risponda al «bisogno
di una comprensione profonda e universalmente valida», quel bisogno,
appunto, da cui è nata la virtuosità filologica119. Un’ermeneutica scientifica
è adeguatamente fondata dalla sintesi della virtuosità filologica e della
«geniale facoltà filosofica», capace di affiancare alla consapevolezza
e all’uso delle regole la «relazione vivente» con il processo stesso
della creazione: «Nell’intuizione vivente del processo creativo»
Schleiermacher per primo «riconobbe la condizione per la conoscenza
dell’altro processo, che comprende in un insieme di segni scritti la
totalità di un’opera e da questa l’intenzione e la mentalità dell’autore». Il
fine ultimo dell’ermeneutica è, difatti, di «comprendere l’autore meglio
118 P. Szondi, op cit., pp. 21,15. Sul prevalere del modello della continuità che «vanifica
l’ermeneutica» in Dilthey, cfr. G. Vattimo, Le avventure della differenza, Milano 1980, p.182.
119 W. Dilthey, op cit., p.55.
116
di quanto egli stesso si è compreso. Questa affermazione è la necessaria
conseguenza della teoria della creazione incosciente»120.
La divaricazione tra ermeneutica letteraria e ermeneutica filologica, che
Szondi fa valere contro il persistente filologismo diltheyano (persistente,
a suo avviso malgrado l’adesione a Schleiermacher) privilegia l’elasticità
dei testi sull’interpretazione, le regole e i criteri della ricostruzione
filologica, tanto da fondare la storicità dell’intendimento121. Divaricazione
del resto condivisa, ma sostanzialmente tradita da Dilthey, nell’ipotesi di
Szondi.
«Secondo il principio della indissolubilità di apprensione e valutazione
– precisa la Die Entstehung - la critica letteraria accompagna
necessariamente il processo ermeneutico, al quale è immanente. Non v’è
comprensione senza percepire un valore – ma il valore viene verificato
oggettivo e universalmente valido solo mediante un confronto. E ciò
suppone anche la determinazione delle norme valide per il genere (ad
es. per il dramma). La critica filologica da qui procede. La finalità
generale dell’opera viene stabilita e vengono escluse le parti che
con quella sono in contraddizione… La critica (letteraria) è dunque
la condizione preliminare della critica filologica: essa infatti è volta
contro l’incomprensibile e l’insignificante, e la critica (letteraria) trova
un ausilio nella critica filologica, della quale è l’aspetto estetico»122. Il
lavoro filologico è, allora, una pratica ermeneutica di inclusione e di
esclusione, un intervento ausiliare che verifica e rende visibile, evidente e
accertabile una forma, un valore, l’unità propriamente estetica percepita,
dice Dilthey, dal momento letterario del processo ermeneutico. Il lato
letterario/estetico e il lato filologico si dispongono, così, in perfetta
specularità e concorrono a restituire un modello di conoscenza attraverso
il comprendere, che poggia sul presupposto della certezza del senso. La
unitarietà del senso, la definitività della forma, rimane il nocciolo teorico
della simmetria e dell’equivalenza dell’estetico e del filologico o, in altri
termini, dello scarto filologico e della ricostruzione filologica dentro
l’atto interpretativo. «Ogni storiografia veramente vivente e non soltanto
120 W. Dilthey, op cit., pp. 69,76.
121 P. Szondi, op. cit., p.17.
122 W. Dilthey, op cit., p. 86.
117
colorante la vita, è critica… Nella storia succede che ciò che fa spettacolo
e balza agli occhi non è il più importante. Le nervature sono invisibili», si
legge nel Briefwechsel di Yorck, ripreso nelle note pagine heideggeriane
di Sein und Zeit. Ciò che è veramente storico, ciò che si espone «a
partire dall’apertura (“Verità”) autentica dell’esistenza storica», non
ammette la riduzione all’ontico o, come suggerisce Yorck, all’oculare,
in cui si fanno perfettamente visibili la forma e la pienezza computa
del senso. Ricondurre il sapere storico alla palpabilità, al tessuto delle
pure presenze, non aprirsi al silenzio della storia autentica, significa fare
ancora filologia pura e dimentica l’essenziale differenza tra l’ontico e lo
storico: laddove, dice Heidegger, «l’ontico è solo una regione dell’ente.
L’idea dell’essere abbraccia “ontico” e “storico”. Essa è ciò che si deve
lasciar genericamente differenziare».
In questo senso le ricerche di Dilthey, per Yorck, «accentuano troppo poco
la differenza specifica fra ontico istorico (Historisch)»: infatti, ancora
il Briefwechsel, «il procedimento comparativo viene fatto valere come
metodo delle scienze dello spirito. Qui dissento da lei… La comparazione
è sempre stata estetica, inerisce sempre alla forma». Specificare che
l’insieme è una connessione di forze non impedisce, allora, di applicare al
concetto di storia la categoria della forma, sia pure «in maniera traslata»,
in continuità con la tradizione dell’indagine storica che ha sempre
difeso la grande ocularità del corpo e della forma, costruendosi su basi
«antiquarie ed estetiche nel corso del grande movimento dominante,
quello della costruzione meccanica»123. In questa prospettiva, che rimane
quella di una ricostruzione storica del significato unitario e compiuto e
della restituzione scientifica dell’unità del senso, il momento estetico
del processo ermeneutico continua ad essere una variante apparente del
filologismo puro, secondo l’avvertimento di Yorck. Nell’individuare il
valore, l’ermeneutica letteraria offre al comprendere una presenza piena
di cui l’ermeneutica filologica si assume il compito di rendere oculari
i percorsi e le connessioni, gli elementi, i monumenti scritti, che la
costituiscono. Se il compito di una scienza ermeneutica come appare
universalmente valido è quello di rivivere il processo di una creazione
inconscia, se il conoscere storico si compie nell’atto dell’intendere, nel
123 M. Heidegger, Essere e tempo, trad. it., a cura di P. Chiodi, Milano-Roma 1953, pp. 412, 408,
414, 411.
118
disvelamento totale di un senso nascosto, nel rendere, cioè, completamente
visibile alla coscienza ciò che è inconsciamente prodotto, la letteratura
rappresenta un luogo privilegiato di questo comprendere. Le ragioni sono
due e impongono in modo forte all’intendere la ricerca della certezza
del senso, nel testo diltheyano. In primo luogo perché soltanto «nel
linguaggio l’interiorità dell’uomo trova la sua espressione completa,
esauriente e oggettivamente comprensibile». Poi perché in una società
«piena di menzogna» l’opera di uno scrittore, come di un grande inventore,
religioso o filosofo, «non può in ogni caso che essere l’espressione vera
della propria vita interiore»124. La trasparenza e la ricchezza con le quali il
senso interno si offre linearmente in senso esterno, il nesso fitto e diretto
tra le intenzioni e le espressioni, la buona volontà di verità, potremmo
dire con una parola di Nietzsche, aiutano in modo decisivo il corretto
comprendere, l’uso e la funzione adeguati dell’ermeneutica scientifica,
nel progetto della Die Entstehung. Il processo interpretativo esige una
ricchezza di segni e l’esclusione, nella costituzione del senso che gli si
offre, del suo mascheramento e della sua deformazione.
Il continuiamo storico, invocato polemicamente da Szondi nei confronti
di Dilthey, che avrebbe ricondotto la storia dei metodi interpretativi
al progressivo affinarsi di tecniche capaci di fondare una scienza
universalmente valida, un sapere storico i cui contenuti rispondono a un
ideale di oggettività, e che perciò, nella critica di Szondi, sottintende una
concezione astorica dell’intendimento e un legame riconoscibile con la
tradizione filologica, è allora solo il completamento o l’esito di una logica
identificativa del senso, di una fiducia nella pienezza significativa, di un
progetto di dissoluzione dei procedimenti e delle tecniche per cui il senso
stesso non può che darsi incerto, fluttuante e deformato, di un’esclusione
radicale della filosofia per la quale, come diceva Nietzsche, «tutto ciò che
è profondo ama la maschera».
2. Nello stesso anno di stampa della Die Entstehung, nel 1900, la
Traumdeutung di Freud elaborava un modello del conoscere per l’analisi
del lavoro del sogno, della Traumarbeit, che assume, proprio al contrario,
come imprescindibili artefici della «configurazione del sogno» la povertà
124 W. Dilthey, op cit., pp. 53-54.
119
dei segni, dei contenuti del sogno e la deformazione (Entstellung) del
senso, dei pensieri del sogno. L’interpretazione del profondo, di ciò
che non è riconducibile, si direbbe con Yorck, alla unicità oculare, è
ricostruzione del processo di mascheramento, di travestimento che appare
nel gioco di segni limitati, di un numero esiguo di contenuti onirici.
Habermas comprende, nella critica al nesso Dilthey/Freud, che
indubbiamente Freud ha orientato l’interpretazione dei sogni (o l’atto
dell’interpretare in generale) «al modello ermeneutico del lavoro
filologico», e che, tuttavia, va chiarito come anche la filologia, rivolta a
ricostruire le «connessioni di simboli», come nell’esempio diltheyano,
«rimane limitata ad un linguaggio in cui si esprime ciò che è inteso
consapevolmente», al significato modellato sul lavoro unificante della
coscienza. «Ma il lavoro di interpretazione dell’analista si distingue da
quello del filologo non solo attraverso l’articolazione di un particolare
ambito oggettuale; esso esige un’ermeneutica specificamente allargata,
che di contro all’usuale interpretazione delle scienze dello spirito tenga
conto di una nuova dimensione». Al modello filologico diltheyano Freud
oppone, sicché, un’ermeneutica del profondo, capace di «cogliere non
solo il senso di un testo eventualmente deformato ma il senso della
deformazione stessa del testo, la trasformazione di un pensiero latente
del sogno in quello manifesto; deve allora ricostruire ciò che Freud ha
chiamato il lavoro del sogno»125.
L’ermeneutica del profondo è, dunque, adatta a comprendere la
deformazione del testo ma anche il senso di questa deformazione.
Così, è evidente come l’indicazione di Habermas aiuti a capire che
l’interpretazione del deformato, la tematizzazione dell’Entstellung, non
aspiri nel progetto della Traumteutung a ricomporre la forma del testo, il
pensiero autentico del sogno, il senso vero ma nascosto, latente travestito
e immediatamente irriconoscibile, deformato appunto, nei contenuti del
sogno e nei segni manifesti. Anzi il fatto che l’ermeneutica freudiana
ponga il problema della deformazione e, al tempo stesso, del senso di
questa deformazione, indica che intende la deformazione, l’Entstellung,
come un tipo di produzione, di lavoro, quello del sogno nel testo di Freud,
che non la eccede né aspira a superarla, ma che, al contrario, la mantiene
125 J. Habermas, Conoscenza e interesse, trad. it., Bari 1970, pp. 211, 210, 216.
120
come un modo specifico di produzione. Il senso della deformazione,
per la Traumdeutung, è così la sua conservazione: l’interpretazione non
compie, infatti, un movimento che va dal deformato al formato, ma
allude a un modello del conoscere capace di cogliere e di costituire la
deformazione, appunto.
Leggiamo nella Traumdeutung, agli inizi del capitolo sesto sul lavoro
onirico: «La prima cosa che appare chiara a chi confronti contenuto e
pensieri del sogno è che è stato fatto un enorme lavoro di condensazione.
Il sogno è scarno, misero, laconico, in confronto alla mole e alla ricchezza
dei pensieri del sogno». La sproporzione tra contenuto e pensieri del
sogno si dà anzitutto nella condensazione (Verdichtung), in quanto un
contenuto, elemento o segno del sogno, condensa, manifesta più pensieri,
più significati. Ma, aggiunge Freud, la quota di condensazione nel lavoro
onirico è indeterminabile: il senso del sogno rimane incerto. Perciò
«siamo stati costretti a indicare che non si è veramente mai certi di aver
interpretato fino in fondo un sogno; persino quando la soluzione appare
soddisfacente e priva di lacune, rimane pur sempre possibile che nello
stesso sogno si manifesti qualche altro significato». La interminabilità
dell’analisi sarà ripresa da Freud, come si sa, nei testi del ’37, in
Analisi terminabile e interminabile e in Costruzioni dell’analisi, dove,
radicalmente, l’interpretazione è lo stesso linguaggio dell’Unischerheit.
Ogni contenuto del sogno si presenta, dunque, come sovradeterminato.
Ma il percorso analitico conduce, aggiunge la Traumdeutung, «da un
elemento del sogno a più pensieri del medesimo»e, all’inverso, «da un
pensiero a più elementi»: se la determinazione multipla inscrive in un
elemento più pensieri provoca anche «uno spostamento dell’attenzione
da ciò che si intende dire veramente, verso qualche cosa che è contiguo
dal punto di vista associativo». Si istituisce, così, tra i contenuti del
sogno, i segni, un movimento di contiguità, che Lacan chiamerà l’asse
metonimico, uno scorrimento di significati sempre in posizione obliqua
rispetto a un significato, a un pensiero del sogno che dovrebbe pienamente
apparire nei contenuti del sogno: la certezza del senso dilegua dietro il
lavoro di decentramento dei contenuti del sogno.
Freud, infatti, nella sezione dedicata alla Verschiebung avverte che «gli
elementi, i quali si impongono nel contenuto del sogno come componenti
essenziali, non svolgono affatto la stessa parte nei pensieri del sogno.
121
Come correlato, possiamo annunciare la proposizione anche in senso
inverso: ciò che nei pensieri del sogno è palesemente contenuto essenziale,
non viene necessariamente rappresentato nel sogno. Il sogno è per così
dire diversamente centrato»126. La sproporzione, che condensazione e
spostamento, «i due artefici alla cui attività possiamo principalmente
attribuire la configurazione del sogno», segnano tra contenuti e pensieri
il sogno, è dunque la stessa produzione deformante del profondo: il
risultato è che il contenuto onirico non rimanda a un nucleo di pensiero,
che, infine, tra segno e senso non si dà mai un rapporto di somiglianza e
univocità, nel lavoro dell’inconscio e nell’atto di interpretarlo.
Dunque, il profondo ama la maschera. L’indicazione di Nietzsche così
ritrovata nella freudiana Traumdeutung si amplifica nel rinnovamento di
uno spazio nuovo per il lavoro interpretativo, il luogo del linguaggio, dove
superficie e profondità si dissolvono, al più indicano, in linea puramente
logica, l’asse del segno (metonimico) e l’asse del senso (metaforico)127.
Soltanto per questo l’ermeneutica del profondo, di cui parlava Habermas
a proposito del lavoro analitico della Traumarbeit, segna una rottura
franca con l’ermeneutica filologica e l’ideale di un sapere in grado di
restituire, in contenuti universalmente validi, la certezza del senso.
3. Paul Ricoeur ha toccato, a nostro avviso questo punto per il conoscere
storico in generale, assegnando alle produzioni storiche il movimento
deformativo tipico dell’inconscio freudiano. L’interpretazione della
cultura deve rivelare, dice Ricoeur, «nella sua universale significazione
il modello del sogno». Se il sogno possiede un senso, e di tipo peculiare,
l’interpretazione del sogno assolve alla funzione di modello per «analoghi
culturali» e «il valore della psicoanalisi sta nella misura in cui l’arte, la
morale, la religione sono figure analoghe varianti della maschera onirica».
Le produzioni culturali che specificamente rappresentano le «maschere
del desiderio» esigono il metodo della Traumdeutung: se questo «non è
126 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, cit., pp. 259, 273, 282.
127 Ci si riferisce, naturalmente, alla lettura lacaniana di Freud. Si cfr. in particolare Funzione e
campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi (1953), La cosa freudiana (1955), L’istanza
della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud (trad. it., in Scritti, cit., vol. I). Sull’inconscio
e la condizione del linguaggio si veda, all’interno del team lacaniano, J. Laplancge - S. Leclaire,
L’inconscio. Un saggio psicoanalitico, trad. it., Parma 1980, pp. 36-46 (con la relativa replica di
Lacan alle pp. 93-113).
122
mai stato tradito, ma solo esteso e approfondito, il motivo è che il tema
stesso del travestimento, centrale nella Traumdeutung, è venuto a trovarsi
esteso e approfondito in tutti i registri in cui gli istinti spingono ciò che li
rappresenta e li costituisce»128. E tuttavia, se la deformazione si produce
per la connessione profonda delle due direttrici che il lavoro dell’inconscio
ha indicato, la metafora e la metonimia, tutti i livelli dell’esistenza storica
(non solo quelli dell’arte e dei miti dove sovrabbonda una pulsione
creativa) vanno adeguatamente decifrati richiamandosi all’intreccio
costante dei due luoghi logici, quello del rapporto dei segni e quello della
metafora che in questi s’inscrive.
La struttura linguistica del senso storico esige che si tengano insieme, nel
lavoro interpretativo, l’esame metonimico o dei nessi sintattici e l’esame
metaforico o del valore simbolico. Non è estraneo, allora, l’intenso lavoro
di Ricoeur sul freudismo e sul legame tra la Traumdeutung e l’ermeneutica
della cultura, quando Le conflit des interprétations suggerisce un incontro
un complemento reciproco tra indagini strutturali e indagini ermeneutiche,
a proposito del conoscere storico.
In che senso, si chiede Ricoeur le considerazioni strutturali«sono la tappa
necessaria, oggi, di qualsiasi intelligenza ermeneutica? Più in generale,
come si articolano ermeneutica e strutturalismo?», pur avvertendo che
«l’articolazione di questi due modi di comprendere pone più problemi di
quanto non ne ponga la distinzione tra di essi. Il problema è troppo nuovo
perché noi possiamo andare oltre dei discorsi esplorativi».
Ricoeur riconosce la possibilità o la persistenza di una gerarchia
nell’ordine del linguaggio, ma individua nella parola il luogo di una
produzione reale, dove appunto si compie continuamente lo scambio tra
«la struttura e l’avvenimento». Fuori del grado della parola la storia è
in crisi, si potrebbe dire. La convergenza dei metodi è adatta, perciò,a
conoscere il movimento attivo. Non c’è analisi strutturale, continua
Ricoeur, «senza intelligenza ermeneutica del trasferimento di senso
(senza “metafora”, senza translatio), senza questa donazione indiretta
di senso che istituisce il campo semantico, a partire dal quale possono
essere identificate delle omologie strutturali... All’inverso, però, non c’è
neppure l’intelligenza ermeneutica senza riferirsi ad una economia, ad
128 P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, trad. it., Milano 1966, pp. 185-186.
123
un ordine, in cui la simbolica significhi. Presi per se stessi, i simboli
sono minacciati dalla loro oscillazione tra l’ispessimento immaginario
o l’evaporazione nell’allegorismo; la loro ricchezza, la loro esuberanza,
la loro polisemia, espongono i simbolisti ingenui all’intemperanza e alla
compiacenza129.
Il problema della deformazione del senso, in verità, era già stato, in qualche
modo, al centro del saggio su Freud, quando Ricoeur esponeva il progetto
di un procedimento riflessivo spinto dalle scoperte psicoanalitiche: «Il
luogo filosofico del discorso analitico», suggeriva allora, «è definito
dal concetto di archeologia del soggetto»130. È necessario dopo Freud
tornare all’ossessione dell’arcaico, non come punto del tempo, ma come
ciò che, allontanato o rimosso, ci costituisce autenticamente. L’idea è
quella di una ferita del cogito, dell’evidenza immediata dell’Io penso, io
sono, del suo definitivo spossamento. Dopo Freud è, perciò, necessaria
una «epoché rovesciata»: «Non si tratta in effetti di una riduzione alla
coscienza, quanto piuttosto di una riduzione della coscienza; la coscienza
cessa di essere ciò che è meglio conosciuto per diventare essa stessa
problematica; vi è d’ora innanzi una questione della coscienza, del
divenir cosciente (Bewusstwerden), al posto della cosiddetta evidenza
della coscienza (Bewusstsein)». Allo spossamento della coscienza
consegue, dunque, l’abbandono della nozione dell’oggetto come evidenza
intenzionata, come «falsa evidenza di correlato della coscienza»: questo
deve «a sua volta cessare di guidare l’analisi» ma rinviare a un quadro
profondo e complesso di costituzione che ne ripropone in termini difficili
il problema della genesi. L’ipotesi di un’archeologia del soggetto, valida
a fondare un’archeologia concreta, non va oltre l’approfondimento delle
forme dell’intendere riferito al dinamismo della coscienza nel modo
dell’individualità, del singolo. Né accetta, del resto, una radice messa
in questione della costituzione soggettiva del senso, della costituzione
dell’oggettività sulla base di un principio unitario e sintetico, quale
risulterà comunque la coscienza riconquistata nel suo spessore vitale
dalle fasi della riflessione. Riflettere, avverte Ricoeur, è abbandonare e
riprendere. La diagnosi archeologica del soggettivo porterà alla conquista
129 P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, pref. di A. Rigobello, trad. it., Milano 1977, pp.
69-70, 94, 75.
130 P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, cit. p. 461.
124
di una coscienza, prima ferita poi risanata, carica infine degli umori della
vita e del desiderio. «Che cosa è un esistente che ha un’archeologia?»,
è la domanda fondamentale. Lo statuto della rappresentazione, dopo il
processo archeologico, cade, suggerisce Ricoeur, «sotto le leggi della
doppia espressività; la rappresentazione non obbedisce solo a una legge
di intenzionalità per cui è l’espressione di qualcosa, ma a un’altra legge
per cui è manifestazione della vita, di uno sforzo o di un desiderio...
La rappresentazione è allora suscettibile di una duplice indagine, da un
lato di una gnoseologia (o di una criteriologia), se la rappresentazione è
considerata come rapporto intenzionale regolato da quel qualcosa che
in esso si manifesta, dall’altro di una esegesi del desiderio che in esso
si nasconde». L’archeologia del soggetto riconosce, così, la dipendenza
del cogito dalla posizione del desiderio, che non è colta mai direttamente
nell’esperienza immediata («... Non è affatto una dipendenza sentita, è
una dipendenza decifrata, interpretata attraverso i sogni, le fantasie, i
miti, che costituiscono in qualche modo il discorso indiretto di questa
tenebra muta»).
Quando, poi, la proposta archeologica da ristretta diventerà generalizzata
e Ricoeur elaborerà, per l’analogia tra sogni, ideali e illusioni, una
archeologia della cultura, questa non potrà che ripetere le premesse
teoriche dell’archeologia del soggetto: il ritrovamento in una «riemergenza
dell’antico», in «una strategia del principio del piacere, forma arcaica
dell’umano», al di sotto delle sue razionalizzazioni, idealizzazioni,
sublimazioni, di nuclei sintetici che danno conto della storia, sia pure
di una storia di travestimenti e di negazioni. Questa strategia consente a
Ricoeur, non c’è dubbio, di ripetere sostanzialmente le impostazioni, per
tanti versi ingenue, della psicoanalisi freudiana (e non solo freudiana)
della storia: «Sotto il titolo di “ritorno del rimosso”, Freud ha visto ciò
che si potrebbe chiamare un’arcaicità di cultura, prolungando l’arcaicità
onirica nelle regioni sublimi dello spirito. Le ultime opere, L’avvenire
di un’illusione, Disagio nella civiltà, Mosè e il monoteismo, denunciano
con cresciuta insistenza la tendenza regressiva della storia dell’umanità.
Si tratta dunque di un aspetto che, anziché affievolirsi, non ha smesso di
125
rafforzarsi»131. La storia di Freud, poi di Ricoeur, finisce col tradire l’idea
di un processo come spazio reale di costituzione di sensi irrimediabilmente
deformati, che pure la Traumdeutung aveva molto prima annunciato.
L’incontro dell’ermeneutica di Ricoeur con Freud intravede, certamente,
ipotesi mature per i problemi della considerazione storica, come
quelle appunto sottolineate da Le conflit des interprétations, ma si
arresta, nell’atteggiamento archeologico, a un’ossessione dell’arcaico
come spossessamento della coscienza e del senso soggettivo. Il senso
oggettivo, invece, dato ancora nella rappresentazione, resta ciò che
è costituito a partire da un cogito, seppure attraversato dai ritrovati
cammini della vita e del desiderio. La psicoanalisi della storia insegue,
così, più il tracciato della psicoanalisi freudiana della cultura che la via di
deformazione del senso, indicata dalla Traumdeutung nella connessione
metafora/metotimia. Freud è, dunque, convertito nelle semplici analisi
dei dinamismi psicologici del soggetto individuale e collettivo.
Il territorio archeologico, infatti, non è solo l’antico e il dimenticato,
la radice atemporale dell’inconscio che restituisce alla prima fase
dell’itinerario ascetico e riflessivo, come ha detto Ricoeur, un cogito
fallito, ma è innanzitutto lo spazio del frammento, del segno obliquo,
del monumento muto, del puro contiguo, di quel che è immediatamente
svuotato di un’unità significativa, della scheggia, infine del contenuto
povero del sogno che non rappresenta mai il pensiero del sogno ma
ne mantiene una sproporzione incolmabile. Il territorio archeologico
è il luogo di un irreversibile mascheramento, quel profondo che trama
all’infinito il senso deformato. Così che le forme non sono che provvisori
e secondari effetti di superficie, sviste momentanee che l’arresto della
storia impone come regimi di verità.
4. Senz’altro le riflessioni più recenti sui problemi del sapere storico,
che, in qualche modo, affrontano la categoria dell’inconscio e i risultati
della psicoanalisi, rifiutano la prospettiva, che ha vissuto a lungo dopo
Freud, di trasferire gli esiti dell’analitica del soggetto nell’esame delle
formazioni storiche, secondo il modello della psicoanalisi applicata.
L’attenzione va progressivamente spostandosi alle componenti logiche ed
131 P. Ricoeur, op. cit., pp. 466-467, 498-499, 499-500, 487-488. Per una diversa lettura del Mosè
si rinvia a P. C. Bori, Una pagina inedita di Freud. La premessa al romanzo storico su Mosè, in
«Rivista di storia contemporanea», I, 1979, pp. 1-17.
126
epistemologiche che le ricerche di Freud ancora oggi possono suggerire
per una nuova forma del comprendere. Si dibatte, perciò, il grosso
problema della quota personale, della scena fantasmatica del soggetto del
comprendere, si insiste sulla possibilità d’uso delle categorie del lavoro
psicoanalitico, prima fra tutte quella del transfert/controtransfert, nella
ricerca sui metodi. Si dice che il lavoro storico, come quello scientifico
in generale, si costruisce, comunque, tra due dimensioni inconsce, quella
dello storico e quella delle fonti.
La discussione è animata e complessa, ma dagli esiti difficili e ambigui.
Un più corretto e ravvicinato bilancio della psicoanalisi come scienza
non evita, del resto, un’aspirazione neutralistica, tra gli storiografi, e
non sfugge agli ideali di oggettività attivi nell’ermeneutica condivisa
da Dilthey. È, certamente, il risultato delle indagini di Friedländer, che
aspirano a una storia totale: in questo esempio la psicostoria critica gli
schemi consumati del modello biografico ma riassume nel concetto di
coerenza strutturale propria il legame verticale che attraversa opera,
personalità dell’autore, gruppo sociale132.
Più critica, senz’altro, la posizione di Besançon, che oscilla tra l’irruzione
del soggettivo (l’inconscio dello storico) e le prospettive, mai raggiunte,
di una simmetria tra fantasma e fantasma, una corrispondenza tra il
campo fantasmatico dello storico e quello della realtà storica interrogata.
La scommessa della psicostoria, secondo Besançon, è che le risposte
ai due problemi, quello dell’inconscio del testo e dell’inconscio dello
storico, devono essere ricercate insieme. Così come il silenzio del testo,
l’analizzato, s’impone allo storico come oggetto d’ascolto e lo impegna
a un’attenzione fluttuante, adatta a inseguirne la deriva, lo scorrimento
incessante.
La deviazione scientista come l’idea di una storia totale sono, dunque,
travestimenti dell’atteggiamento conoscitivo che tradiscono la resistenza
che lo storico oppone inconsciamente alla storia. Il problema rimane,
tuttavia, il controllo del controtransfert, evidente nell’atto dell’intendere,
l’utilizzazione cosciente del gioco fantasmatico. L’analisi dell’inconscio
132 Si cfr. S. Friedländer, Storia e psicoanalisi, trad. it., Roma 1977. a proposito si legge:
«L’opera dunque porta in se stessa la propria coerenza strutturale, l’impronta decisiva della
società ambiente, come quella della personalità dell’autore, e, talvolta, vi si può ritrovare perfino
l’eco di archetipi fondamentali che risorgono dal più profondo dell’inconscio. È in seno all’opera
che si realizza l’integrazione che mostra la via di una vera storia totale» (p. 103).
127
dello storico, del quoziente soggettivo evita distorsioni, ma ha, per
l’interminabilità dell’interpretazione, dei limiti. L’ipotesi è che il lavoro
storico è «un’adguazione laboriosa, e alla fine convincete, fra ciò che
è reperito all’interno e ciò che è reperito all’esterno... Ogni uomo
contiene tutti gli uomini, può reagire a tutti i testi che hanno lasciato e
comprenderli. Questa vastità dell’essere umano, possessore virtuale di
tutte le configurazioni mentali di cui un altro essere umano è capace;
questa unità e fissità del genere umano che permette, per principio,
di comprendere gli uomini separati da noi dai secoli e dai mari, sono
postulati più vecchi della psicoanalisi, ma legati in essa, alla scoperta
dell’inconscio»133.
Dire, dopo Freud, che la storia è surdeterminata non significa solo
respingere, per un sapere storico affinato, il totalitarismo dei metodi. Esiste
una storia psicoanalitica, direbbe la psicostoria, perché necessariamente
esistono altre storie, altri modi di comprenderla. La scommessa della
determinazione plurale della storia riguarda la misura del senso e della
propria logica interna, alla quale è chiamato a rispondere ciascuno dei
modelli dell’interpretare. Anche la psicoanalisi.
(1980)
133 A. Besançon, Storia e psicoanalisi, cit., pp. 84-85.
128
Storia dell’arte, storia delle cose
1. Civiltà materiale, vita quotidiana, cultura materiale sono nozioni
ricorrenti nella storia e nelle altre scienze umane da diversi anni, ormai
lo sappiamo. Così come si è consapevoli dell’incertezza semantica
che accompagna questi dispositivi. «Insomma , si può dire subito che,
nonostante il suo significato globale appaia evidente..., la nozione
di cultura materiale continua ad essere, di fatto, imprecisa e insieme
contraddistinta dall’illusione della trasparenza; essa è comunque carica
d’un insieme di connotazioni abbastanza diverse, di cui sembra non
siano stati ancora fatti né recensione particolareggiata né il bilancio»134.
Bilancio che, appunto, tentano i nostri autori: recensione per certi versi
puntuale perché coglie la storia semantica della cultura materiale dalla
preistoria ai suoi arrangiamenti nell’area dell’archeologia, della storia
economica e sociale, della storia delle tecniche, ma per un altro lato (che
è quello che ora c’ interessa) assai deludente. Deludente perché in questa
sfilata la storia dell’arte viene nuovamente rimossa.
Il destino della storia dell’arte nei confronti della cultura materiale o della
storia delle cose, se si preferisce, è davvero singolare: ora si dice, con
risibile boutade, che la Cappella Sistina vale quanto un cassettone (poco
più poco meno) ora, per via di un altro delirio, si afferma la poesia della
Pittura o dell’Architettura contro la prosa dell’oggetto. Non si esce, cioè,
dalla svista di un materialismo ingenuo o dalla grandeur dell’idealismo.
2. «Supponiamo che il nostro concetto dell’arte possa essere esteso a
comprendere, oltre alle tante cose belle, poetiche e non utili di questo
134 Questo testo, scritto in collaborazione con Arcangela Cascavilla, Antonio d’Avossa,
Maria Rosaria De Rosa, si riferisce ad una più ampia ricerca che si sta svolgendo nell’ambito
dell’insegnamento di Storia della critica d’arte dell’Università di Salerno. I primi risultati sono
stati letti al Congresso nazionale di Storia dell’Arte del C.N.R. (Roma, 11-14 settembre 1978) e
di recente pubblicati negli Atti, a cura di Corrado Maltese (Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Roma 1980).
R. Bucaille, J. M. Pesez, Cultura materiale, Enciclopedia Einaudi, vol. IV, Torino 1978, p.271. Si
cfr. anche D. Moreno, M. Quaini, Per una storia della cultura materiale, in «Quaderni storici»,
31, genn. - apr. 1976, la voce Oggetto di Cesare De Seta, Enciclopedia Einaudi, vol. 9, Torino
1980, il contributo di Tomás Maldonado, La ricollocazione storica dell’oggetto d’uso, negli Atti
del Congresso nazionale di Storia dell’Arte, citati, La Storia della cultura materiale di Pesez, in
La nuova storia, a cura di J. Le Goff, trad. it., Milano 1980.
129
mondo, tutti in generale i manufatti umani, dagli arnesi di lavoro alle
scritture»135.
Non c’è dubbio che lo sfondamento dei confini teorici della storia dell’arte,
proposto da Kubler negli anni ‘70, si avvale di strumenti e di tecniche,
di concetti e di analisi dell’universo antropologico: un esercizio che non
comporta solamente la consueta verifica interdisciplinare ma implica,
radicalmente, la possibilità di ribaltare il punto di vista, di passare dalla
storia dell’arte come storia dei prodotti altri ad una più generale storia
delle cose.
Nel 1975 Kubler, sfidando i colleghi americani critica quella che sembrava
ormai la parola d’ordine, la massima teorizzata negli anni ‘50 da Phillips
e Willey e definitivamente consacrata nel ‘70: «L’archeologia americano
o è antropologia o non è niente»136. In realtà, questa formula, asserita con
tanta certezza, riesce solo a testimoniare l’assenza di un metodo specifico
al quale l’archeologia possa riferirsi nell’urgenza di individuare una teoria
alla quale possa ricollegarsi. Comunque, viene indicata come teoria altra
antropologia generale. E tuttavia è inevitabile che il credo americanista
ponga subito degli interrogativi relativi all’analisi e alla differenziazione
dei prodotti di scavo e alla classificazione dei reperti archeologici.
Questi problemi, secondo Kubler, possono essere risolti solo se si accetta
di trasformare tale formula in un’ipotesi meno dogmatica e più aperta:
«L’archeologia del Nuovo Mondo è tanto antropologia quanto tutto
quello che non è incluso nell’antropologia»137. Si tratta, in tal caso, di
far reagire la storia dell’arte e l’antropologia in un’ipotesi di etnostoria,
dove i modelli dell’antropologia (la differenziazione nello spazio è
individuazione delle culture altre) si accompagnino ai modelli storici di
differenziazione nel tempo tra culture diverse, ma anche tra i momenti
diversi della stessa cultura.
Evidentemente Kubler sospetta che l’antropologia sia sprovvista di
strumenti di analisi storica – la sua critica investe soprattutto il funzionario
malinowskiano degli anni ‘40 e le sue basi antistoriche – è in questa
direzione l’esempio dell’analogia etnologica, un modello poco attento
135 G. Kubler, La forma del tempo, trad. it., introd. di G. Previtali, Torino 1976, p.7.
136 G. Kubler, «Storia» o «Antropologia» dell’arte?, trad. it., introd. di G. Previtali, in
«Prospettive», 6, 1976, p. 9.
137 G. Kubler, op. cit., p. 10.
130
alle questioni di lunghe durate e ai problemi relativi ai meccanismi di
mutamento culturale, viene indicato come un caso esemplare delle
procedure antropologiche. Così, l’urgenza di riguadagnare i momenti
della storia conduce l’autore all’interno delle discipline da sempre
preoccupare di elaborare teorie relative al tempo storico (quelle
umanistiche), mentre, su un altro versante, l’antropologia stessa viene
riattraversata per individuare le tappe di una riflessione sui problemi
della cultura (e Kroeber diventerà un riferimento essenziale).
Senza dubbio è l’antropologia, attenta alle differenze nello spazio tra
culture diverse e dunque non omogenee, aprendosi ai problemi del tempo
storico, non può non rilevare l’insufficienza dei modelli tradizionali della
storia dell’arte quasi sempre giocati sulla continuità dei temi e delle
forme, sull’ipotesi evoluzionistica di un processo per accrescimento e
non per cambiamento, sulla rimozione del discontinuo, degli intervalli
e delle cesure. L’elemento di rottura e di messa in discussione di tali
procedure, nel percorso kubleriano, diventa la panofskyana nozione di
disgiunzione138 che, usata originariamente per caratterizzare il rapporto
tra l’arte classica e il medioevo, viene ora indicata come il modello dello
sviluppo storico in generale, riletto (quest’ultimo) come svolgimento nel
tempo di periodi di differente lunghezza, non sovrapponibili né omogenei
e, dunque, tra loro discontinui. Inoltre in una tappa di ricognizione nei
territori della storia dell’arte (criticando la tendenza iconologica), Kubler
ricerca altre definizioni dell’arte, e indica il modello/ Focillon come il
punto di partenza per un’ urgente revisione teorica.
Così, le informazioni che intorno agli anni ‘40 questo autore, attraverso
la mediazione di Bergson, fornisce sul tempo artistico nei suoi rapporti
con il più generale tempo storico, le ipotesi sulla natura della storia
(come durata differenziata e sovrapposizione di realtà non omogenee),
la definizione di forme del tempo come modi di coesistenza di serie
138 «Ogni volta che nel maturo e tardo Medio Evo un’opera d’arte prende in prestito uno
schema da un significato classico, a questo schema si attribuisce quasi sempre un significato
non classico, solitamente cristiano; ogni volta che nel maturo e tardo Medio Evo un’opera d’arte
prende in prestito un tema dalla poesia, dalla lagenda, dalla storia o dalla mitologia del mondo
classico, questo tema è senza eccezioni rappresentato secondo uno schema formale non classico,
solitamente contemporaneo.» (E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze, trad. it., Milano 1971, p.
105). Questo «principio di distacco» aveva costituito per Kubler un momento di riflessione già
nel 1961, in una recensione alla I edizione del testo panofskyano (G. Kubler, Disjunction and
Mutational Energy, in «Art News», LIX, n. 10, 1961, pp. 34-35).
131
non identiche ma dotate di durate non omologabili tra di loro (il tempo
dell’economia, della politica, dell’arte), infine l’individuazione non
di una ma di più storie diventano altrettanti percorsi obbligatori delle
proposta kubleriana139.
I momenti dell’itinerario di Kubler, teso ad individuare i confini
dell’etnostoria e a definirne i caratteri, sono già tracciati nel 1972 con
La forma del tempo,dove viene esplicitamente richiesto un allargamento
di campo fino al punto da «far coincidere l’universo delle cose fatte
dall’uomo con la storia dell’arte, con la conseguente e immediata
necessità di formulare una nuova linea di interpretazione nello studio di
queste stesse cose»140. Tuttavia i metodi dell’interpretazione costituiscono
proprio l’elemento più debole dell’intera dimostrazione, mentre centrale
diventa l’individuazione dei modelli per la suddivisione/differenziazione
delle cose. Si tratta del concetto di sequenza che dovrebbe caratterizzare
sia le differenze tra gli oggetti sia il processo del loro sviluppo temporale.
Nel tentativo, poi, di approntare tecniche di misurazione adeguate alla
natura della sequenza (discontinua al suo interno e nel rapporto con altre
serie), Kubler rivela l’insufficienza dei modelli tradizionali della storia
che «non conosce una tavola periodica degli elementi, né classificazioni
per tipi e specie: c’è soltanto la misura solare del tempo e qualche
vecchio sistema di raggruppamento degli eventi, senza però alcuna
teoria di struttura temporale»141. Come modello alternativo viene indicata
un’ipotesi relativa ai periodi, alle loro lunghezze e durate: l’indizione, la
generazione, il secolo. Adesso il punto di riferimento diventa Kroeber
e l’analisi condotta in collaborazione con la Richardson sulle durate e i
periodi di trasformazione della moda femminile142.
139 H. Focillon, Vita delle forme,in Scultura e pittura romantica in Francia, trad. it., introd.
di E. Castelnuovo, Torino 1972, pp. 223-227. quasi negli stessi anni, le indicazioni di Focillon
verranno assunte da Bastide all’interno di un diverso orizzonte teorico: la sociologia dell’arte
(R. Bastide, Art et societé, pref. di J. Duvignaud, Paris 1977). C’è da rilevare che Kubler, nel
momento in cui salta tale riferiemnto, trascura i problemi relativi al rapporto tra l’arte e le altre
istituzioni sociali. Si cfr. A. D’ Avossa, Roger Bastide, un’estetica sociologica come problematica
dell’immaginario, in «Misure critiche», dic. 1978.
140 G. Kubler, La forma del tempo, cit., p. 7.
141 G. Kubler, op. cit., pp. 115-116.
142 A. L. Kroeber, L’ordine dei mutamenti della moda, in La natura della cultura, trad. it., introd.
di F. Remotti, Bologna 1974, pp. 619-627 e A. L. Kroeber e J. Richardson, Tre secoli di moda
femminile, un’analisi quantitativa, in A. L. Kroeber, op. cit., pp. 669-670.
132
Senz’altro Kroeber costituisce una stazione obbligatoria della traversata
antropologica operata da Kubler proprio per l’attenzione che questo
autore rivolge alla mediazione del punto di vista delle scienze naturali
e delle discipline umanistiche .E, poi, perché, nel progetto kroeberiano,
è evidente il tentativo di pervenire a una visione estetica della civiltà,
nella quale i problemi della storia dell’arte assumo una centralità e una
rilevanza innegabili143.
Certamente l’indicazione che la civiltà costituisca un ordine che va
ricondotto all’interno della natura, dalla quale affiora attraverso una
rottura, un’evoluzione emergente (torna ancora la lezione bergsoniana),
un salto, una discontinuità, permetterà a Kubler di ricondurre la storia
dell’arte nella latitudine della storia delle cose, ma anche di sottolinearne
le differenze. Su un altro versante l’ipotesi che il metodo più pertinente
per i fenomeni culturali sia l’approccio storico-descrittivo, contrapposto
a quello analitico-scentifico, sarà un ulteriore elementi di mediazione.
L’informazione, poi, che gli elementi culturali intanto sono riconoscibili
in quanto sono riferiti a un modello di base, e l’individuazione oltre che
dell’appartenenza anche della posizione all’interno del modello, potrà
costituire il punto di partenza per la classificazione degli oggetti in
sequenza, attraverso l’analisi delle loro caratteristiche comuni144.
Tuttavia è necessario rilevare subito che la sequenza nella prospettiva
di Kroeber si configura a partire da un modello di base che viene
esplicitamente riconosciuto come modello inconscio. Questo nudo
teorico consente, infatti, di cogliere le differenze tra le serie, mentre, in
un’altra direzione, analizzando un singolo segmento culturale (la moda),
l’uso del modello inconscio permette di determinare le relazioni tra i
diversi elementi del costume e di stabilire le leggi di evoluzione della
sequenza145.
Non c’è dubbio che nel percorso kroeberiano esiste pure uno sforzo teso
143 A. L. Kroeber, Lo «stile» nello studio comparato delle civiltà, trad. it., in L. Bonin e A.
Marazzi, Antropologia culturale, Milano 1970, pp. 329-345 e sopratutto A. L. Kroeber, Style and
Civilizations, Berkeley and Los Angeles, 1963.
144 Per una prima lettura della teoria kroeberiana si rinvia all’introduzione che Remotti ha scritto
per La natura della cultura.
145 Rileggendo tali indicazioni e certamente forzandone l’interpretazione, Lévi-Strauss definirà
strutturali queste analisi sulla moda, anche se l’approach di Kroeber è descrittivo e storico e non
scientifico (Cfr. F. Remotti, introd. cit., p. XXIX).
133
a definire i compiti della storia e i modelli dell’analisi storica. «La storia
è sempre, a modo suo, interpretativa;... perciò si occupa di relazioni
funzionali;... è per sua stessa natura ricostruttiva; e non può mai fare a
meno, a lungo andare, di interpretazioni». E ancora: «... In realtà tutta
la vera storia non è altro che un’interpretazione ottenuta mediante la
descrizione dei fenomeni in termini di contesto»146.
Distrutto l’ingenuo modello realistico, che postula l’oggettiva realtà
del fenomeno da registrare, ordinare, classificare, Kroeber apre una
prospettiva di natura strutturale: «La preoccupazione principale, tuttavia,
non è quella di rintracciare gli spostamenti spazio-temporali di un’unità
invariabile e fissa..., bensì di seguire i mutamenti di questa unità o sistema
nelle sue forme e nelle sue funzioni, di individuarne i derivati, le perdite
e le aggiunte..., le sistematizzazioni e le semplificazioni, le mancate
accettazioni, le associazioni di prestigio, le modificazioni stilistiche, le
cristallizzazioni e i mutamenti rivoluzionari»147.
Il ruolo di struttura viene qui giocato dalla nozione di modello:
«L’attaccamento alle forme e alle successioni dei fenomeni stessi, nella
loro reale concatenazione o nelle loro reali contiguità, consente un
riconoscimento di modelli che è affine alla formulazione degli stili»148.
La nozione sotto accusa diventa il fattore-tempo, che una certa storia ha
per troppo tempo privilegiato: «L’elemento temporale non è il fattore più
distintivo della storia – come si ritiene e si afferma ancora spesso, ma con
superficialità. Nella storia la determinazione spaziale è importante quanto
la determinazione temporale... L’elemento temporale tende ad essere
spesso una delle incognite che occorre ricercare, anche se l’obbiettivo
fondamentale è pur sempre una configurazione qualitativa, uno stile o una
fisionomia, rispetto ai quali la collocazione spazio-temporale aderisce
come una proprietà. Storie particolari possono sopprimere o considerare
costante, ora il tempo ora lo spazio... E come altrimenti si può designare
l’etnografia... se non soprattutto come un resoconto di un particolare stile
culturale, di un brano di storia senza tempo?»149.
146 A. L. Kroeber, Storia ed evoluzione, in La natura della cultura, cit., p. 170.
147 A. L. Kroeber, op. cit., p. 173.
148 A. L. Kroeber, op. cit., p. 179.
149 A. L. Kroeber, op. cit., pp. 181-182.
134
Non si può non rimarcare che i suggerimenti di Kroeber relativi alla
storia e l’urgenza di definire gli elementi per una teoria d’analisi storica
diventeranno centrali nell’itinerario di Lévi-Strauss (ancora una volta si
insisterà sul carattere interpretativo della storia e il modello assumerà una
chiara cifra strutturale).
Il disinteresse per le proposte kroeberiana sulla storia e l’irrilevanza
del rapporto fenomeno/modello rende estremamente difficile a Kubler
il compito di stabilire modi di differenziazione tra gli oggetti, tanto da
essere costretto ad usare strumenti sospetti o almeno poco pertinenti.
Inoltre, l’attenzione ai fenomeni disposti in sequenza e alle misurazioni
delle loro variazioni richiede che la teoria individui una legge di sviluppo
della serie indipendentemente da altri tipi di condizionamenti.
In Kroeber questa funzione sarà svolta dalla nozione di stile, alla
quale si chiede di sottolineare una successione come sequenza e di
porsi contemporaneamente come modello di differenziazione e di
discriminazione. E sarà proprio il concetto di stile ad essere investito,
nell’ipotesi kroeberiana, dai caratteri di discontinuità, sia nella relazione
tra fenomeno e modello che nei rapporti con gli altri stili. Ma la nozione
di stile rientra nell’insieme di quegli strumenti teorici espulsi dal
vocabolario kubleriano: «Tutta l’immensa letteratura artistica esistente
è radicata nei labirinti della nozione di stile: le sue ambiguità e le sue
inconsistenze riflettono tutta l’attività estetica nel suo insieme. Stile
riscrive una figura specifica nello spazio più che tipo di esistenza nel
tempo»150. Tale rifiuto viene assunto, direttamente, dal lavoro di Schapiro,
un riferimento obbligato per ripensare il concetto di stile151. Kubler,
però sottolinea in negativo il significato di questa proposta, avvertendo
che Schapiro «passa in rivista le principali teorie correnti sullo stile,
per concludere sconsolatamente che “una teoria dello stile adeguata ai
problemi psicologici e storici non è stata ancora formulata”»152. Eppure
già nel 1968 Uspenskij suggeriva una lettura di Schapiro (che in realtà
non liquida la nozione di stile, ma ne sottolinea l’intera problematicità)
in una più pertinente direzione semiotica, per verificare se in questa
150 J. Kubler, La forma del tempo, cit., p. 10.
151 M. Schapiro, Style, in Anthropology today, a cura di A. L. Kroeber, Chicago-London, 1953.
152 J. Kubler, La forma del tempo, cit., pp. 10-11, nota 1.
135
prospettiva sia possibile sciogliere certi disagi teorici.
A partire dall’indicazione di Schapiro, che tende a privilegiare l’accezione
collettiva dello stile, inteso come produzione socio-culturale, rispetto ad
altre definizioni che puntano sul lato privato e individuale, Uspenskij
concede lo statuto di semiotico soltanto al primo tipo di approccio, in
quanto capace di porre e di differenziare i due piani dell’espressione
e del contenuto: «La peculiarità della differenziazione stilistica
dipende sostanzialmente dal fatto che i differenti stili che si possono
considerare come sistemi minimi (microlinguaggi) di comunicazione,
sono caratterizzati dalla variabilità, vale a dire costituiscono delle
varianti all’atto della realizzazione di un certo sistema d’ordine più
genenrale (microlinguaggi) o, in altre parole, come dei sottolinguaggi
sostanzialmente equivalenti di una stessa lingua»153. L’apertura alla
semiotica consente a Uspenskji di sorprendere nello stile un fenomeno
di natura strutturale, analizzabile con strumenti linguistici e di superare
al tempo stesso le polemiche sulla definizione dell’ambigua nozione di
stile154.
Registrando l’assenza di questi decisivi nodi teorici, la proposta di
Kubler risulta debole proprio nel punto focale dell’intera dimostrazione:
l’individuazione dei criteri di distinzione degli oggetti all’interno
della storia delle cose e la definizione dei modelli di differenziazione
tra serie diverse. La contrapposizione offerta tra oggetti della scienza
(utili) e oggetti dell’arte (inutili), con richiami evidentemente kantiani,
rigerarchizza gli oggetti in precedenza scomposti sotto un’unica rubrica e
attribuisce connotazioni supplementari e privilegiate ai prodotti artistici,
la qualità, l’unicità, l’inutilità. Così che la storia dell’arte, pur dislocata in
una storia più generale di cui condivide i modi di esistenza e di sviluppo
nel tempo, finisce con l’essere se non un caso particolare almeno un caso
speciale.
Ma non basta. Il progetto di Kubler si rivela non solo inadatto a
153 B. A. Uspenskij, Problemi semiotici dello stile alla luce della linguistica, in J. M. Lotman,
B. A. Uspenskij, Semiotica e cultura, trad. it., introd. di D. Ferrari-Bravo, Milano-Napoli 1975,
p. 37.
154 Per i problemi della storia dell’arte, che deve la sua specificità proprio alla utilizzazione del
concetto di stile, e soprattutto per il superamento della dicotomia stile individuale/stile epocale
attraverso l’ipotesi stile/struttura si cfr. R. De Fusco, Storia e stuttura. Teoria della storiografia
architettonica, Napoli 1970.
136
fornire calibrati modelli di differenziazione per l’analisi delle singole
sequenze, ma anche poco pertinente a conservare alla storia il carattere
di discontinuità che la teoria vuole salvare a ogni costo. Il discontinuo,
tematizzato da Kubler, conserva l’omogeneità degli elementi della
serie (in cui le posizioni sono determinate in anticipo e soprattutto già
registrate), così che la storia della sequenza continua a svolgersi lungo
una traiettoria orizzontale a partire da una preistoria quasi mitica fino
ai tempi più recenti. In tal modo, assegnando discontinuità soltanto agli
intervalli tra le serie e conservando la continuità delle forme , di cui
sono sempre previste le possibili variazioni, la teoria kubleriana finisce
per riconsegnare al discontinuo gli stessi caratteri della continuità:
omogeneità e linearità.
Le contraddizioni dell’ipotesi di Kubler sembrano ascriversi al limite
teorico dell’intera proposta che registra l’assenza di un incontro corretto
con i modelli della linguistica. Infatti la specificità del prodotto artistico,
che un’attenzione ai modi di costruzione dell’oggetto avrebbe meglio
configurato, è ricalcata su schemi ormai abbandonati anche dalla più
consapevole storia dell’arte: le singole serie non hanno carattere di sistema,
le differenze di sequenze non si connotano come differenze di strutture. Il
cammino di Kubler rientra, perciò, anche nei modi tradizionali delle storia
dell’arte, come testimonia, tra l’altro, l’analisi di un testo sull’architettura
spagnola, scritto nel ‘59, quando gli interessi antropologici erano già
dichiarati155. Qui il discorso si limitava all’attribuzionismo e all’indagine
tipologica degli edifici esaminati nella loro insularità di pianta, mentre
ritornano consuamti modelli storiografici legati ai concetti di scuola,
personalità e stile.
3. Diventa, pertanto, urgente, nel tentativo di dare altri fondamentali
alla proposta kubleriana (un atlante della storia delle cose), percorrere
sentieri diversi, nei territori dell’antropologia, alla ricerca di più corrette
configurazioni dell’oggetto. La culturologia e l’ecologia culturale
ci offrono, senz’altro, la possibilità di praticare una nozione di cosa
meno compromessa da residui kantiani e ridefinita da connotazioni
materialistiche.
155 G. Kubler, M. Soria, Art and Architecture of Spain and Portugal and their American
Dominions, Pelican History of Art, 1959.
137
Per White la cultura consiste di «oggetti materiali – arnesi, utensili,
ornamenti, amuleti, ecc. – atti, credenze e atteggiamenti che funzionano
in contesti caratterizzati dal simboleggiare»156. Quest’intricata rete di
rapporti costituisce il sistema attraverso il quale viene controllata l’energia
e sfruttata al servizio dell’uomo. La legge dell’evoluzione culturale
che White formula pone l’accento sull’importanza determinante degli
strumenti tecnologici, rispetto ai quali i sistemi sociali e filosofici sono
aggiunte ed espressioni: «Altri fattori rimanendo costanti, la cultura si
evolve coll’aumentare della quantità di energia catturata e sfruttata pro
capite per anno, o coll’aumentare dell’efficienza dei mezzi strumentali
adibiti nell’impiego dell’energia»157. La produzione culturale è così
indicata come una variabile dipendente dalla sua base materiale, mentre
le leggi di trasformazione culturale sono riferite alle più importanti leggi
di trasformazioni tecnologica.
La strategia materialistica di White riceve ulteriori precisazioni dalla
distinzione operata all’interno della struttura culturale, pensata come una
relazione di relazioni: il sottosistema tecnologico, quello sociologico e
quello ideologico. «Il sistema tecnologico è composto dagli strumenti
materiali, meccanici, fisici e chimici e dalle tecniche relative al loro uso,
mediante i quali l’uomo, in quanto specie animale, affronta e domina il
suo habitat naturale. Troviamo qui gli arnesi della produzione, i mezzi
di sussistenza, i materiali di ricovero, gli strumenti di offesa e difesa. Il
sistema sociologico è costituito da relazioni interpersonali espresse in
modelli di comportamento, così collettivi come individuali. In questa
categoria troviamo i sistemi sociali, di parentela, economici, etici, politici,
militari, ecclesiastici, occupazionali e professionali, ricreativi ecc. Il
sistema ideologico è composto da idee, credenze, conoscenze, espresse
nel linguaggio articolato o in altra forma simbolica. Mitologie e teologie,
leggende, letteratura, scienze, saggezza popolare e buon senso comune
danno luogo a questa categoria»158. L’interazione delle tre categorie vede la
tecnologia assolvere a un ruolo determinante: infatti, «un sistema sociale
è una funzione di un sistema tecnologico... C’è un tipo di pensiero per
156 L. A. White, La scienza della cultura, trad. it. , Firenze 1969, p. 329.
157 L. A. White, op. cit., p. 333.
158 L. A. White, op. cit., p. 330.
138
ogni tipo di tecnologia»159. E ancora. «I sistemi sociali sono... determinati
dai sistemi tecnologici, e le filosofie e le arti esprimono l’esperienza così
come è definita dalla tecnologia e rifratta dai sistemi sociali»160. I tratti
culturali reagiscono, così, uni con l’altro immediatamente e direttamente:
«Una zappa è prodotto culturale. Esso agisce direttamente su – e influenza
altri – prodotti culturali come la divisione del lavoro fra i sessi, le usanze
relative alla residenza, le abitudini alimentari, le credenze religiose e le
cerimonie, e così via»161.
Anche se, nel tentativo di delimitare i confini della culturologia ed
indicare i suoi oggetti di analisi, White tende inevitabilmente a identificare
la cultura con le visioni del mondo e il prodotto culturale con l’atto di
conoscenza, l’oggetto di cultura è riguadagnato alle sue basi materiali e al
suo rapporto con le tecnologie, situandosi a un livello differente rispetto
agli strumenti di produzione, ma certamente non separato né privilegiato.
Che, poi, la dimostrazione tenda a rilevare una scienza della cultura come
continuum che ha in sé le sue leggi è provato da enunciazioni di casualità
nomotetiche con caratteri di prevedibilità: «Il principio di causa ed effetto
opera nel regno dei fenomeni culturali come in ogni altro campo della
nostra esperienza. Ogni data situazione culturale è stata determinata da
altri eventi culturali. Se certi fattori sono operanti, si realizza un certo
risultato. All’inverso, certe realizzazioni culturali non possono essere
effettuate, per quanto caldamente possono essere desiderate, se i fattori
necessari alla realizzazione non sono presenti operanti»162.
Nel rapporto a due termini che White stabilisce tra cultura e tecnologia,
Steward163 introduce un terzo elemento, l’habitat, al quale viene
assegnato il compito di spiegare le differenze tra culture diverse, come
pure di ricercare le cause del cambiamento culturale, con formulazioni
alternativamente sincroniche e diacroniche. L’ecologia culturale registra
la tendenza delle culture ad evolversi secondo linee sostanzialmente
simili quando si trovano in situazioni tecnico-ambientali analoghe. Se
159 L. A. White, op. cit., p. 331.
160 L. A. White, op. cit., p. 351.
161 L. A. White, op. cit., pp. 114-115.
162 L. A. White, op. cit., p. 370.
163 J. H. Steward, Teoria del mutamento culturale, trad. it., Torino 1977.
139
i mutamenti delle culture sono fatti risalire a nuovi adattamenti resi
necessari dal cambiamento della tecnologia e delle soluzioni produttive.
Steward è pure attento a come le tecniche vengono usate da ambienti
diversi comportando assetti sociali differenti. Accanto alle variabili
tecnico-economiche, diventano ora determinanti le variabili tecnicoambientali, in grado di modificare culture storicamente determinate.
L’analisi, che nella proposta della culturologia tendeva a marcare la
lettura diacronica su scala globale164, nell’ipotesi di Steward individua
i tagli orizzontali e verticali della storia, puntando non sulle continuità
culturali ma piuttosto sui tratti specifici, i buchi e le fratture del tessuto
storico. Il percorso dell’ecologia attraversa non blocchi omogenei di
culture ma tipi culturali, «costellazioni particolari di tratti tra di loro
interconnessi casualmente, che sia dato di ritrovare in due o più culture,
ma non necessariamente in tutte»165. Così, l’individuazione dei livelli di
integrazione socioculturale,corrodendo una presunta unità delle culture
nazionali, salva la specificità e il discontinuo: «… Il concetto di livelli può
essere utilizzato come strumento analitico per lo studio del mutamento
all’interno di qualsiasi sistema socioculturale particolare, dal momento
che ogni sistema si compone di parti che si sono sviluppate a stadi diversi
e attraverso processi diversi e che, benché specializzate da un punto di
vista funzionale nella loro dipendenza dal tutto, continuano a integrare
certe porzioni della cultura»166.
Inoltre la cultura, non più identificata con le filosofie/visioni del mondo,
in maniera più decisa viene riscritta nel nucleo culturale (insieme degli
elementi che sono più strettamente connessi con le attività di sussistenza
e con le soluzioni economiche) e assume, posta accanto agli strumenti di
produzione e alle tecnologie, lo stesso ruolo di protagonista nel processo
di cambiamento socioculturale.
La ridefinizione dell’oggetto culturale come oggetto tecnico-materiale
e l’apertura su modelli d’indagine storica attenti alla discontinuità
164 «Il funzionamento di ogni particolare cultura sarà naturalmente influenzato dalle condizioni
ambientali locali. Ma, considerando la cultura nel suo complesso, possiamo fare la media di tutti
gli ambienti per formare un fattore costante che può essere dalla nostra formula dello sviluppo
culturale» (L. A. White, op. cit., p. 333 n. 3).
165 J. H. Steward, op. cit., p. 35.
166 J. H. Steward, op. cit., p. 76.
140
costituiscono, certamente, le linee più interessanti del discorso di Steward,
anche se bisogna rilevare che l’analisi ecologica, diretta alla ricerca di
leggi, recupera i modelli ricorrenti più che le differenze.
Harris, dal canto suo, facendo reagire questi due universi teorici
(culturologia ed ecologia culturale) mette fine alle sterili polemiche
sull’unilinearità o sulla multilinearità dell’evoluzione culturale e legge in
questi tentativi il progetto di pervenire a una scienza della cultura capace
di rendere conto sia della continuità che delle trasformazioni: «Non si
insisterà mai abbastanza sul fatto che la riabilitazione della strategia del
materialismo culturale… dipende… dalla possibilità che l’impostazione
dia origine a ipotesi esplicative fondamentali, sottoponibili ai collaudi
della ricerca etnografica e archeologica, modificabili se necessario,
e incorporabili in un corpus di teoria capace di spiegare i caratteri più
generalizzati della storia universale, e le particolarità meno comuni di
culture specifiche»167. All’incrocio tra questi due poli, il materialismo
culturale apre la strada alla nozione di cultura materiale, dove torna
il concetto di cosa, ridefinita, però come oggetto di produzione. Nella
lettura di Kula la storia della cultura materiale si occupa, infatti, dei
«mezzi e dei metodi praticamente impiegati nella produzione, cioè di
questioni relative alla produzione e al consumo nel più ampio significato
di questi termini»168.
4. In questa prospettiva diventa, naturalmente, centrale l’attenzione
all’archeologia, perché è in grado di fornire ulteriori informazioni sullo
sviluppo culturale e sulle civiltà sepolte. «Questa relazione, avverte ancora
Harris, ha recato vantaggi in due direzioni; ha svolto cioè una funzione
chiare sia nel mettere a disposizione delle questioni nomotetiche i risultati
dell’archeologia, sia nel consentire l’utilizzazione dei frutti positivi della
strategia cultural-materialistica nello svolgimento e dell’interpretazione
167 H. Harris, L’evoluzione del pensiero antropologico, trad. it., introd. di C. T. Altan, Bologna
1971, p. 924.
168 W. Kula, Problemi e metodi di storia economica, trad. it., Milano 1972, pp. 61-66, cit. in A.
Carandini, Archeologia e cultura materiale, Bari 1975, p. 98. Per il dibattito sulla «lunga durata»
cfr. inoltre AA. VV., La storia e le altre scienze umane, a cura di F. Braudel, trad. it., Bari 1974. La
proposta di analisi della cultura materiale che si ponga esolusivamente come ricognizione sulle
tecniche è avanzata da Braudel, nel 1967, in Capitalismo e civiltà materiale, trad. it., Torino 1977.
141
della ricerca archeologia»169.
Non c’è dubbio che Carandini, tra i primi, ha colto questo nodo quando
sottolineato che «il metodo archeologico non appare più come uno
strumento erudito per lo studio di determinate società antiche, bensì un
metodo di ricerca per lo studio della storia reale umana dalla preistoria ai
giorni nostri, metodo che ci insegna a scoprire ed intendere il linguaggio
delle cose, mezzi non soltanto di produzione e di sostentamento ma anche
di comunicazione di messaggi»170.
La nozione di cosa, ridefinita dal materialismo culturale come oggetto
di produzione, riceve ora una calibratura più precisa inscrivendosi nella
meraviglia dell’universo segnico. È determinante, come vedremo, la
lezione di Lévi-Strauss. Infatti, esplicitamente, Carandini, nell’affermare
che le cose sono «significanti di significati», richiama quel celebre
passo lévistraussiano dell’Elogio dell’antropologia dove è detto che
«le tecniche prese isolatamente possono sembrare un dato grezzo»
mentre invece vanno intese «come l’equivalente di altrettante scelte che
ogni società sembra fare … nell’ambito di una serie di possibilità»; ad
esempio «un certo tipo d’ascia di pietra … (può) essere un segno: in un
determinato contesto esso sostituisce … l’utensile diverso che un’altra
società utilizzerebbe per gli stessi scopi»171.
L’idea che le cose si organizzano in sistemi e che tali sistemi debbono
essere decifrati con modelli di analisi semiotici viene, però, ridotta da
Carandini ad una questione di semplice «parallelismo linguistico»: si
passa, così, dai monemi e fonemi della lingua ai fenomeni e factemi delle
cose. Questa risoluzione, semioticamente ingenua, riduce la stessa portata
teorica dell’antropologia strutturale. Lévi-Strauss ci ha insegnato che «la
lingua è il sistema significante per eccellenza; non può non significare;
e il tutto della sua esistenza sta nel significato. Invece il problema va
esaminato con un rigore crescente, man mano che ci si allontana dalla
lingua per considerare altri sistemi»172. Ed ancora, come ha ribadito
di recente nell’introduzione a La linguistica e le scienze dell’uomo di
169 H. Harris, op. cit., p. 909.
170 A. Carandini, op. cit., pp. 100-101.
171 C. Lévi-Strauss, Elogio dell’antropologia, in Razza e storia e altri studi di antropologia, a
cura di P. Caruso, Trad. it., Torino 1967, p. 58, cit., in A. Carandini, op. cit., p. 105.
172 C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, trad. it. Milano, 1966, pp. 62 -63.
142
Jakobson, «il linguaggio, come ogni altra istituzione sociale, presuppone
delle funzioni mentali operanti a livello inconscio».
Solo riconoscendo questo carattere della lingua e, più in generale, dei
sistemi semiotici «ci si mette in grado di raggiungere dietro alla continuità
dei fenomeni, la discontinuità dei principi organizzatori che normalmente
sfuggono alla coscienza del soggetto parlante o pensante»173.
Cosa significa, in sostanza, questo inteso transito se non l’individuazione
di livelli di discontinuità radicali al di sotto di «zona di storia, ciascuna
delle quali è definita da una frequenza propria, e da una codificazione
differenziale del prima e del poi»174. Non c’è dubbio che lungo quest’argine
si rivelano inadeguati e mancanti, come si è accennato, il discontinuo
kubleriano (che salva l’omogeneità della sequenza) e la multilinearità
dell’evoluzione culturale si Steward, che registra più le ricorrenze che le
differenze.
Si dimostra non meno inadeguata la manovra di Carandini. E, su un registro
un po’diverso, risulta difficile la tesi di Barilli, che, da una posizione
culturologica, aggredisce il discorso semiotico per la propensione a
«considerare la produzione non nel suo darsi in atto, nel suo aggredire –
lavorare – trasformare l’ambiente, ma nel momento in cui essa diviene il
fatto, cioè un dato informativo, codificabile e trasmissibile … il culturale
viene così coartato nel solo aspetto conservativo, nell’accumulo, nella
banca o memoria dei dati»175.
Tanto che Segre, rileggendo gli stessi autori di Barilli (cioè Uspenskij
e Lotman) avverte, dal canto suo, che «questa grande banca semiotica
della cultura ha comunque dei testi come imput, ancora dei testi come
output. Si vorrebbe allora esaminare il funzionamento di accumulo dei
testi (o meglio dei loro contenuti) e di produzione di nuovi testi. Su
questo problema Lotman è altrettanto realista che per quello dei rapporti
col mondo rappresentato: egli usa testi per descrivere la produzione
173 C. Lévi-Strauss, Introduzione a R. Jakobson, La linguistica e le scienze dell’uomo, trad. it.,
Milano 1978, p. 14.
174 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, trad. it., Milano 1964, p. 281. Sul problema della
discontinuità e della multi linearità storica si cfr. anche la recente discussione tra C. Lévi-Strauss,
M. Augé, M. Godelier, Anthropologie, Historie, Idéologie, in «L’Homme», juil – déc. 1975, pp.
177 – 188- così ancora in un articolo del 1968 : «Non c’è una ma delle storie, una polvere di
storie» (La grande aventure de l’ethnologie, in «Le Nouvel Observateur», n. 166).
175 R. Barilli, Difficoltà di un approccio semiotico alla cultura, in «Op. Cit.», n. 35, 1976, ora in
AA. VV., Estetica e società tecnologica, a cura di R. Barilli, Bologna 1976, pp. 52 -53.
143
culturale»176.
Sorprendenti risultano, invece, per l’approfondimento del nostro discorso,
che le ricerche di Leroi-Gourhan, che, utilizzando gli esiti delle scienze
naturali e della linguistica, dell’antropologia come dell’archeologia
per rileggere il sistema degli oggetti come sistema di relazioni e per
analizzare la strutture formali che lo costituiscono, evita le tipiche e
pericolose gerarchizzazioni tra l’oggetto d’uso e l’oggetto d’arte. La
riflessione sull’oggetto, infine, è accompagnata dalla riformulazione
di un’estetica del comportamento umano direttamente collegata con le
tecniche di fabbricazione177.
«Il senso qui dato alla parola estetica è abbastanza vasto… Se si tratta di
ricercare effettivamente ciò di cui la filosofia ha fatto la scienza del bello
nella natura e nell’arte, bisogna porsi…in una prospettiva paleontologica
in senso generale, prospettiva nella quale il rapporto dialettico fra la natura
e arte segna segna i due poli dell’aspetto zoologico e di quello sociale.
Non si tratta, in tale prospettiva, di limitare all’emotività essenzialmente
uditiva e visiva dell’homo sapiens la nozione di bello, ma di ricercare
in tutta la profondità delle percezioni il mondo come si costituisce nel
tempo e nello spazio un codice delle emozioni che assicura al soggetto
etnico l’essenziale dell’inserimento affettivo nella sua società»178.
Il procedimento di rilettura attivato da Leroi-Gourhan tiene in primo
luogo i due criteri principali che garantiscono la composizione di quel
«tessuto di relazione fra l’individuo e il gruppo, vale a dire tutto quello
che si riferisce al comportamento estetico»179: la tecnica e il linguaggio
176 C. Segre, Semiotica, storia e cultura, Padova 1977, p. 19.
177 A. Leroi-Gourhan, Évolution et techniques. L’homme et la matière, Paris 1943 e 1971, in
particolare I capitoli dedicati alle tecniche di fabbricazione (pp. 162-326); Il gesto e la parola,
trad. it., 2 voll., Torino 1977; Ethnologie et esthétique, in «Disque Vert», n.1, Bruxelles 1953;
L’homme, «Encyclopédie Clartés», vol.4 bis, Paris 1956 (spcialmente La vie esthétique, fasc.4860
e Le domaine de l’esthétique, fasc. 4870); L’art sans l’écriture, Institut d’Ethnologie, Paris 1968.
Sul rapporto storia-etnologia si v. il breve intervento Ethnologie évolutive ou ethno-histoire?,
in AA.VV., Ethnologie et Histoire. Paris 1975. Per questa tematica si rinvia a C. Bromberger,
Ethnologie, linguistique, esthétique. Note sur le «ethnique» e a L. Perrois, Fondaments d’une
approche systematique des arts traditionnels, entrambi in AA.VV., L’homme hier et aujourd’hui.
Recueil d’études en homage à André Leroi- Gourhan, pref. di M. Sauter, Paris 1973.
178 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., vol. II, p. 317. C’è da sottolineare (ma non
può essere questo il luogo per affrontare il discorso) che questo codice «è fondato su proprietà
biologiche comuni all’insieme degli esseri viventi, quelle dei sensi che permettono una percezione
dei valori e dei ritmi» (p. 317).
179 A. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 315.
144
considerati nella loro comune origine. E, ancora più precisamente,
relazionando la tecnica, linguaggio ed estetica, come «tre manifestazioni
fondamentali della qualità di un uomo…strettamente interdipendenti»180,
l’etnologo giunge alla determinazione di un codice specifico per lo studio
dell’oggetto.
Per Leroi-Gourhan l’oggetto è insieme forma e senso. Ora, è
dell’organizzazione delle forme, del loro schema coerente che bisogna
trovare la formula, ed è alla sintassi propria del linguaggio manuale, i
cui le produzioni plastiche sono le forme, che va a raccordarsi lo studio
sistematico dell’oggetto che non può iniziare che attraverso un’analisi
morfologica dettagliatamente estesa: dove, «evidentemente, il codice
plastico non è analogo ad un sistema linguistico, è piuttosto un sistema
di correlazioni che solo una analisi minuziosa di tutte le variabili che si
rapporto all’oggetto può permettere di definire»181.
L’analisi che segue la progressione «materia-forma-stile» – precedute
dall’esame, sotto differenti angolazioni, di quella parte che si rapporta
alla materia e all’attrezzatura (fabbricazione dell’oggetto) e di quella
parte che si relaziona alla forma, alla composizione e alla struttura
geometrica dell’opera – sceglie tutti i dati propriamente morfologici per
procedere all’inchiesta etno-stilistica che assume, in questa prospettiva,
il ruolo di stazione terminale. Ma se la materia, prima stazione della
progressione, insieme alle tecniche di fabbricazione, svolge il ruolo di
supporto di forma e se è dalle sue leggi che possono essere tratti quei
princìpi utili a costruire un’estetica funziona ledi cui Leroi-Gourhan si
preoccupa di rendere una definizione che affonda le radici nell’equilibrio
che si istituisce tra la funzione e la forma dell’oggetto, resta decisivo,
per configurare l’indagine, attraverso la fondamentale nozione di stile
180 A. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 322.
181 L. Perrois, Fondements d’une approche systematique des arts traditionnels, cit., p. 283.
145
etnico182.
Lo stile etnico, definito come «il modo proprio di una collettività di
assumere e di contrassegnare forme, valori e ritmi»183, rappresenta quella
invariante strutturale, quel minimum (come ama dire Leroi-Gourhan)
che rende conto dell’aspetto più reale del valore dell’etnia: «Questa
particolarità etnica che trasforma la banale enumerazione di asce, soffietti
e formule matrimoniali nella espressione dello spirito di un popolo, non
può rientrare nella classificazione verbale, rappresenta uno stile che ha
un suo valore proprio e che investe la totalità culturale del gruppo»184.
Infatti se nessun gruppo umano si ripete due volte, ogni etnia è diversa
da se stessa in due momenti della propria esistenza. L’assorbimento di
uno stile, nella vita quotidiana, nelle sue produzioni e nelle innumerevoli
variabili che caratterizzano la continuità o la discontinuità, è un fatto
profondo destinato a segnare per sempre le generazioni successive:
«Certi atteggiamenti, certi gesti di cortesia o di comunicazione, il ritmo
del passo, il modo di mangiare, le pratiche igieniche, hanno toni etnicic
che si trasmettono attraverso le generazioni. Nelle pratiche figurative
come la musica, la danza, la poesia o l’arte plastica, si produce una
netta separazione fra la base comune e le varianti individuali perché
la figurazione comporta gli stessi livelli operazionali; si può vedere
sopravvivere per lunghi secoli l’ossatura della figurazione in un genere
musicale o plastico grazie alla possibilità che esso offre agli individui di
organizzare varianti personali senza alterarne l’architettura»185.
La complessità di questa nozione e, contemporaneamente, l’estensione
182 «L’analisi degli oggetti di uso pratico come utensili, macchine, motori, case, città, lascia
intravvedere proprietà estetiche particolari, direttamente legate alla loro funzione. È certo che
un giudizio sull’adattamento in senso positivo o negativo di una forma alla funzione assegnatale
equivale in pratica alla formulazione di un giudizio estetico. È anche sorprendente constatare che
tranne poche eccezioni, se non sempre, il valore estetico assoluto è direttamente proporzionale
all’adeguamento della forma alla funzione… L’analisi estetica funzionale è dunque il più delle
volte solo la misura dell’approssimazione funzionale… Il “momento” estetico si colloca sul
percorso di ogni forma, nel punto in cui questa si avvicina di più alla formula: l’amigdala molto
evoluta, il raschiatoio molto curato, il coltello di bronzo perfettamente adattato al suo uso specifico
lasciano trasparire in eguale misura la qualità estetica dell’incontro fra funzione e forma… Ogni
fabbricazione è un dialogo fra l’artefice e la materia e apre un altro margine di approssimazione
funzionale» (A. Leroi-Gourhan, op.cit., vol. II, pp. 349, 352, 354, 358).
183 A. Leroi-Gourhan, op. cit., vol. II, p. 326.
184 A. Leroi-Gourhan, op. cit., vol. II, p. 323.
185 A. Leroi-Gourhan, op. cit., vol. II, p. 325.
146
del campo che prevede, lasciano concretamente intravedere che la
personalità estetica, lo stile etnico, specialmente nelle sue manifestazioni
e produzioni materiali «non è per nulla inafferrabile e si può concepire
un metodo analitico altrettanto preciso di quello della tecnologia e della
sociologia descrittiva». Infatti, continua Leroi-Gourhan, «le gamme dei
gusti, degli odori, del tatto, dei suoni, dei colori rivelano una estensione e
differenze molto caratteristiche; la distanza che separa in una determinata
cultura le posizioni naturali e gli atteggiamenti in una società dà la
misura della trascuratezza collettiva; la forma degli utensili si presta a
una analisi funzionale e precisa, come l’integrazione spaazio-temporale
degli individui nel loro ambiente domestico e più generale. Più in là
sono disponibili i metodi di studio delle arti; agli effetti di una ricerca
comparata sarebbero d’altronde da organizzare perché lo stile etnico è
una espressione complessiva»186.
Dunque, Leroi-Gourhan costruendo un quadro morfologico dell’insieme
degli aspetti che caratterizzano la linea di costruzione degli oggetti, e
ponendo princìpi metodologici, attraversati dalla nozione di stile etnico,
costruisce un nucleo di riflessioni sicuramente assumibili come punto
di partenza per un rinnovamento dello studio delle arti plastiche, dagli
oggetti d’uso agli oggetti d’arte, soprattutto a causa della loro sistematicità
e della costante preoccupazione di esplorare in tutte le direzioni di
ricerca restando quanto più possibile legati all’oggetto stesso, alla sua
specificità187.
5. Storia dell’arte o storia delle cose sono, in conclusione, gli aspetti,
simmetricamente rovesciati, della stessa svista teorica: l’idea che si
diano blocchi compatti e omogenei di storia e non piuttosto zone di
storia scandite da frequenze proprie e da discontinuità radicali, da una
codificazione differenziale del prima e del poi. La questione, allora, non è
certamente quella di contrapporre la storia dell’arte alla storia delle cose
(e viceversa) ma di affrontare, ridefinendo il campo della storia dell’aree
186 A. Leroi-Gourhan, op. cit., vol. II, p. 326.
187 Avvisa Perrois: «C’è da sottolineare che non si fa mai (nelle analisi di Leroi-Gourhan) menzione
della funzione delle figure, né del loro significato riconosciuto o supposto. Le considerazioni
etnologiche, se sono indispensabili alla conoscenza del fenomeno etnico, vengono dopo le analisi
dell’oggetto per partecipare, infine, a una sintesi che finora mancava principalmente di questi
elementi di base» (op. cit., p. 285).
147
e della storia delle cose come territorio della comunicazione, un apparato
concettuale adatto ad analizzare gli oggetti (opere d’arte, manufatti,
arnesi, eccetera) secondo gli specifici gradi di semplicità o complessità
semiotica.
È semplicemente un’indicazione che potrebbe aiutarci a colmare la
tradizionale scissione tra storia alta e storia bassa (e tra i rispettivi
metodi d’indagine) evitando, al tempo stesso, la riduzione all’identità
indifferenziata della categoria oggetto-di-produzione.
(1979)
148
Aloisio L.
Altan C. T.
Althusser L.
Amman J.-C.
Artaud A.
Atkinson T.
Augé M.
Ayer A. J.
Bachtin M.
Balibar E.
Barilli R.
Barthes R.
Bastide R
Bataille G.
Baudrillard J.
Benoist J. M.
Bergson H.
Besancon A.
Bishop J.
Bloch E.
Bois Y. A.
Bonin A.
Bonito Oliva A.
Bori P.C.
Braudel F.
Bromberger C.
Bucaille R.
Buchloh B. H. D.
Bühler K.
Calvesi M.
Caminati A.
Cane L.
Carandini A.
Carnap R.
150
Biografia / Biography
Angelo Trimarco ||| Nato nel 1941, è
storico e critico d’arte. Ha insegnato a
lungo all’Università di Salerno Storia e
teoria della critica d’arte. Attualmente
è
presidente
della
Fondazione
Filiberto Menna – Centro studi d’Arte
Contemporanea. È socio ordinario della
Società italiana di Storia della critica
d’arte.
Studioso del sistema dell’arte della
modernità, della sua crisi e dei suoi più
recenti mutamenti, pratica un pensiero di
confine tra arte, architettura e filosofia,
tra teoria della critica d’arte ed estetica.
Come critico militante ha curato e
collaborato con saggi e interventi in
catalogo a numerose mostre. Nel 1986
è stato commissario all’Undicesima
Quadriennale d’Arte di Roma e, nel 1993,
alla Biennale di Venezia.
Historian and art critic Angelo Trimarco
(b. 1941) has taught History and Theory
of Art Critique for many years as the
University of Salerno. He is currently
chairman of the Filiberto Menna
Foundation and Centre for Contemporary
Art Studies. He is also a member of the
Italian History of Art Critique Association.
Trimarco is a Modern Art scholar – of
its crisis and recent development and
change – and has a vision which could
be placed somewhere between art,
architecture and philosophy or even as one
that embraces both the theory of art and
aesthetic critique. As a militant critic, he
has curated and contributed to essays and
articles for numerous exhibitions. He held
the position of Commissioner at both the
11th Rome Quadriennale (1986) and the
1993 Venice Biennale.
151
152
Bibliografia / Bibliography
Monografie
- L’inconscio dell’opera. Sociologia e psicoanalisi dell’arte, Officina Edizioni, Roma
l974.
- Itinerari freudiani. Sulla critica e la storiografia dell’arte, Officina Edizioni, Roma
l979.
- La parabola del teorico. Sull’arte e la critica, Edizioni Kappa, Roma l982.
- Surrealismo diviso, Officina Edizioni, Roma l984.
- Confluenze. Arte e critica di fine secolo, Guerini, Milano l990; Confluencias. Arte y
critica en la postmodernidad, Julio Ollero Editor / Instituto de Estética, Madrid l991.
- Il presente dell’arte, pref. di G. Dorfles, Tema Celeste Edizioni, Siracusa l992.
- Materiali critici, Loffredo Editore, Napoli l993.
- Napoli ad arte l985/ 2000, Editoriale Modo, Milano l999.
- Opera d’arte totale, Luca Sossella Editore, Roma 2000; ristampa 2001.
- L’arte e l’abitare, Editoriale Modo, Milano 200l.
- Napoli. Un racconto d’arte 1954/2000, Editori Riuniti, Roma 2002.
- Post-storia. Il sistema dell’arte, Editori Riuniti, Roma 2004.
- Galassia. Avanguardia e postmodernità, Editori Riuniti, Roma 2006.
- Filiberto Menna. Arte e critica d’arte in Italia. 1960/1980, La Città del Sole, Napoli
2008.
- Ornamento. Il sistema dell’arte nell’epoca della megalopoli, Mimesis, Milano-Udine
2009.
- Surrealismo. Scritti 1970-2010, a c. di M. R. De Rosa, M. Passaro, A. Trotta, S.
Zuliani, Paparo Edizioni, Napoli 2011.
- Italia 1960-2000. Teoria e critica d’arte, Paparo Edizioni, Napoli 2012.
Presentazioni in catalogo
- Uno spazio vitale precario instabile, in G. Celant (a c. di), Arte povera più azioni
povere, cat. della mostra, Rumma editore, Salerno 1969.
- Senza titolo, in F. Irace (a c. di), Assenza/Presenza: un’ipotesi per la lettura
dell’architettura, D’Auria Editore, Ascoli Piceno 1979.
- Moderno, Postmoderno, in G. Guercio (a c. di), Rooted rhetoric. Una tradizione
dell’arte americana, Guida editori, Napoli 1986; trad. ted., con il titolo Modern/
Postmodern zum Beispiel Joseph Kosuth, in «New art in Europe», Oct/Nov 1986.
- È di scena Freud - Some comments on Freud, and language, in Joseph Kosuth.
Interviews 1969-1989, Edition Patricia Schwarz, Stuttgart 1989.
- Linea d’ombra, in N. Vitale, A. Tecce (a cura di), Plastica, foto di Mimmo Jodice e
Francesco Jodice, Napoli Electa, Napoli 1990; trad. ingl., in «Modo», Ott./Nov. 2002.
153
- Due modelli, in XLV Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia. I
Punti cardinali dell’arte, a c. di A. Bonito Oliva, Marsilio, Venezia 1993.
- Il lato «mancino dell’arte, in Hermann Nitsch, O.M. Theater, Napoli, Casina
Vanvitelliana del Fusaro, edizioni Morra, Napoli 1995.
- Sub specie lucis, in Artinmosaico, a c. di A. Mendini, Skira editore, Milano 1996.
- Matters of the end of the century, in Form/Synthesis. Painting and Sculpture, curator
Pattricia Woodlin, Harriet & Charles Luckman Five Arts Complex, Los Angeles,
California State University 1997.
- L’opera d’arte, in A. Bonito Oliva (a c. di), Minimalia. Da Giacomo Balla a..., Bocca
Editori, Roma 1997.
- Exsercicis de meditacio, in Fabio Mauri. La meva cosina Marcella i la guerra civil,
Fundacio la Caixa 1999.
- Elogio della purezza e dell’immortalità in opere senza tempo, in G. Guercio (a c. di),
De Dominicis. Raccolta di scritti sull’opera e l’artista, Umberto Allemandi & C, Torino
2003.
- New materials, new ideas / Nuovi materiali, idee nuove, in Plastici desire’s subject
Plastica soggetto del desiderio, a c. di A. De Angelis, Editoriale Modo, Milano 2003.
- Allan Kaprow, in Living Theatre. Labirinti dell’immaginario, a c. di L. Mango, G.
Morra, Edizioni Morra, Napoli 2003 (trad. ing).
- «Più una cosa è uguale più è americana», in Global Warhol, Electa, Milano 2003.
- Il nome di Moholy-Nagy, in Renato Barisani. Materie ad arte, a c. di S. Zuliani,
Fabbrica del Lunedì, Napoli 2004.
- Università degli Studi di Salerno. Istituto di Storia dell’Arte. Filiberto Menna e i
«chierici vaganti, in S. Zuliani (a c. di), La costruzione del nuovo. Salerno 1966/1976.
Documenti Immagini Testimonianze, cat., Edizioni 10/17, Salerno 2005.
- La fotografia come esperienza dell’abitare/Photography as the experience of
habitation, in Obiettivo Napoli. luoghi memorie immagini, a c. di G. Laurino, Electa
Napoli, Napoli 2005.
- Il cugino Pons, collezionista / Le cousin Pons, collectionneur, in A. Demma (a c. di),
La Commedia umana di Balzac. Omaggio al romanziere assoluto, Skira, Milano 2009.
- Mostre & dintorni. Considerazioni, in S. Zuliani (a c. di), La mostra è aperta. Artisti
in dialogo con Harald Szeemann, Edizioni Fondazione Filiberto Menna, Salerno 2010.
- Per una riflessione di gruppo, come premessa, in S. Zuliani e A. Tolve (a c. di), Per
Gillo Dorfles, Edizioni Fondazione Filiberto Menna, Salerno 2012.
Contributi in volumi e in riviste
- Duchamp e le tecniche del corpo, in «Proposta», n. 2-3, 1973.
- L’arte dopo la filosofia (una riflessione), in «Proposta», n. 8-9, l973.
- Jung. Arte, linguaggio, archetipi, in «NAC. Notiziario Arte Contemporanea», n. l2,
l974.
- Arte (come linguaggio) e desiderio, in «Quadrangolo», n. 4, ottobre-dicembre l975,
pp. 85-88.
154
- Per Mukarovsky, in «Proposta», n. l6-l7, l975.
- Gombrich e i limiti dell’iconologia, in «Quadrangolo», n. 8/9, ottobre l976- marzo
1977.
- Bataille e la ‘svolta’ di ‘Tel Quel’, in «Op. cit.», n. 40, settembre l977.
- L’iconologia oltre la semiotica?, in E. Mucci, P. L. Tazzi (a c. di), Teoria e pratiche
della critica d’arte, Feltrinelli, Milano l979.
- Dell’arte...ai bordi, in A. Verdiglione (a c. di), L’arte La psicoanalisi, Milano,
Feltrinelli l979.
- Il motto di spirito, il poetico, in A. d’Agostino (a c. di), Effetto Lacan, Roma, Lerici
l979.
- Sulla critica interminabile, in A. Bonito Oliva (a c. di), Autonomia e creatività della
critica, Roma, Lerici l980.
- Dietro l’angolo c’è il Posmodern, in «Percorsi», n. 1, gennaio 1981.
- Il pubblico, il museo, la città, in «Figure. Teoria e critica dell’arte», n. 2-3, 1982.
- Dall’America. Warhol e Kosuth, in «Op. cit.», n. 56, gennaio 1983.
- La festa, l’ornamento, in «Op.cit.», n. 6l, settembre l984.
- Il pensiero della somiglianza. A proposito di Magritte e la Pubblicità, in «Grafica», n.
0, febbraio l985.
- Arte oggi: concettualismo e tendenze costruttive, in «Op. cit.», n. 67, settembre 1986.
- La via neoconcettuale/ The way of Neo-conceptualism, in «Metamorfosi», n. 6-7, l987.
- senza titolo, in P. Gilardi (a c. di), L’arte e la critica per la costruzione del nuovo,
CIPED, Torino 1987.
- L’uscita dal postmoderno, in «Figure. Teoria e critica dell’arte», n. 0, aprile l988.
- Freud e la scena tragica, in R. Meccia (a c. di), Il teatro come pensiero teatrale,
Napoli, ESI 1989.
- Elogio della figurazione, in L. Giordano (a c. di), Sanguineti. Ideologia e linguaggio,
Napoli, ESI 1991.
- La scrittura e la cucina, in S. Sinisi (a c. di), Scritti in onore di Filiberto Menna,
Bulzoni, Roma 1991 riedito col titolo I segni della pittura, in M. Di Maio (a c. di),
Roland Barthes. Teoria e scrittura, ESI, Napoli 1992.
- Documenta lX, in «Op.cit.», n. 85, settembre l992.
- La follia. Per esempio Leonora Carrington, in M.T.Chialant e E. Rao (a c. di), Per una
topografia dell’altrove, Napoli, Liguori Editore l995.
- Il dono della ragione, in U. Todini (a c. di), Pasolini e l’antico, Napoli, ESI l995.
- La critica d’arte dopo la fine dei «grandi racconti», in «Op. cit.», n. 96, maggio l996.
- Fine secolo, più rassicurazione che follia, in L. Vergine (a c. di), La scena del rischio.
Follia e rassicurazione nelle arti di oggi, Umberto Allemandi, Torino l998.
- Considérations sur Manet, in Michel Foucault. Trajectoires au coeur du présent, sous
la direction de L. D’Alessandro et A. Marino, L’Harmattan, Paris l998.
- Piet Mondrian, in «Secondo tempo», libro ottavo (fascicolo monografico dedicato a
Filiberto Menna), Marcus Edizioni, Napoli, 2000.
- Premonizione, in E. Villa, Critica d’arte 1946-1984, a c. di A. De Luca, con uno scritto
di A. T., La Città del Sole, Napoli 2000.
- Anish Kapoor, in «Modo», n. 211, maggio 2001.
155
- Era di giugno, a Losanna. Post-Human, in M. T. Chialant, (a c. di), Incontrare i
mostri. Variazioni sul tema nella letteratura e cultura inglese e angloamericana,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.
- La critique dans le temps du virtuel, in «Ligeia. Dossiers sur l’Art», n. 45-46-47-48,
juillet-dècembre 2003.
- L’arte come pratica decostruttiva, in A. Cuomo (a c. di), Architettura Arte Museo,
Gangemi, Roma 2004.
- Post-histoire. L’«estetica della sparizione» e il privilegio dell’arte, in «Il pensiero.
Rivista di filosofia», nuova serie, XLIII, 2004.
- «Arte concettuale», «pensiero visivo», in L. Pizzo Russo (a c. di), Rudolf Arnheim Arte
e percezione visiva, Centro Internazionale di Estetica, Palermo 2005.
- Spazio della vita, teatralizzazione, arte povera, in S. Zuliani (a c. di), Figure dell’Arte
1950-2000, Editoriale Modo, Milano 2005.
- Lea Vergine, La Body art. Conversazione con Angelo Trimarco, in S. Zuliani (a c. di),
Figure dell’Arte, Editoriale Modo, Milano 2005.
- Freud. Sull’arte e la critica, oggi, in R. Conforti (a c. di), La psicoanalisi tra scienze
umane e neuroscienze. Storia, alleanze, conflitti, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli
2006.
- Le stazioni, il museo, in S. Zuliani (a c. di), Il museo all’opera. Trasformazioni e
prospettive del museo d’arte contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 2006.
- André Breton, Claude Lévi Strauss. Sulla «natura dell’opera d’arte», in M. Mafrici e
M. R. Pellizzari (a c. di), Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica, tomo II,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2007.
- L’arte pubblica come figura dell’abitare, in E. Cristallini (a c. di), L’arte fuori dal
museo. Saggi e interviste, Gangemi Editore, Roma 2008.
- La vita come opera d’arte. Per esempio, Salvador Dalì, in S. Zuliani (a c. di), In prima
persona. Scritti d’artista e critica d’arte, La Città del Sole, Napoli 2009.
- Kitsch e museificazione, in M. Carboni (a c. di), Divenire di Gillo Dorfles, Castelvecchi,
Roma 2010.
- Le «style nouveau». L’ornement, in A. Laserra (dir.), Album Belgique, P. I. E. Peter
Lang, Bruxelles 2010.
- Foucault, Manet e la pittura del XX secolo, in P. Balmas, A. Capasso (a c. di), Arte e
le teorie di turno. Omaggio ad Achille Bonito Oliva, Electa, Milano 2011.
- Amalfi. «Arte povera più azioni povere», in G. Celant (a c. di), Arte Povera 2011,
Electa, Milano 2011.
- C’era una volta l’atelier (e c’è ancora), in S. Zuliani (a c. di), Atelier d’artista. Gli
spazi di creazione dell’arte dall’età moderna al presente, Mimesis, Milano-Udine 2013.
- Riconsiderando la cartografia del virtuale, in P. Giannangeli, A. Tolve (a c. di), L’età
soffice. Teoria e pratica dell’arte nell’epoca dei new media, Quodlibet, Macerata-Roma
2014.
156
Bibliografia / Bibliography
158
Arshake / Critical Grounds
questo libro è stato messo in rete nel Dicembre 2014
this book was released online in December 2014
Prima di stampare questo libro per favore pensate all’ambiente
Please consider the environment before printing this book
160