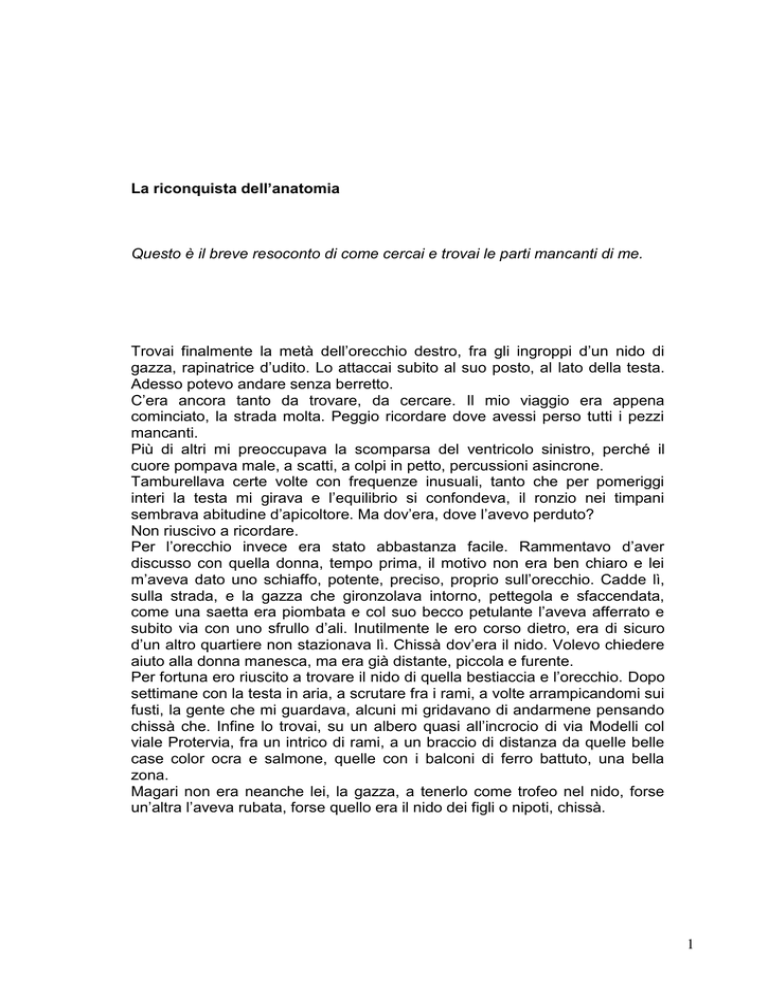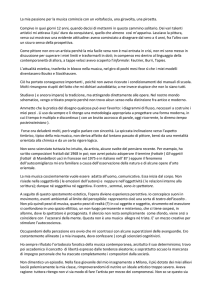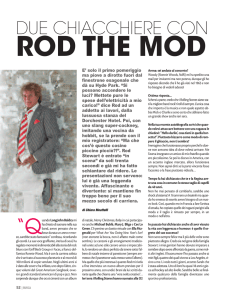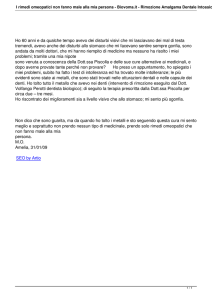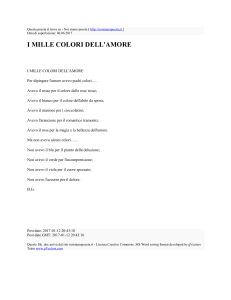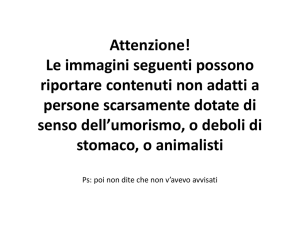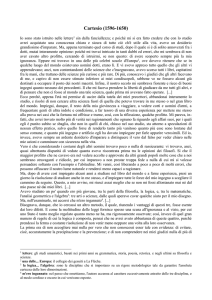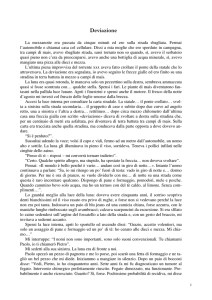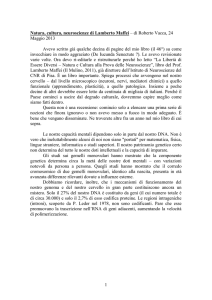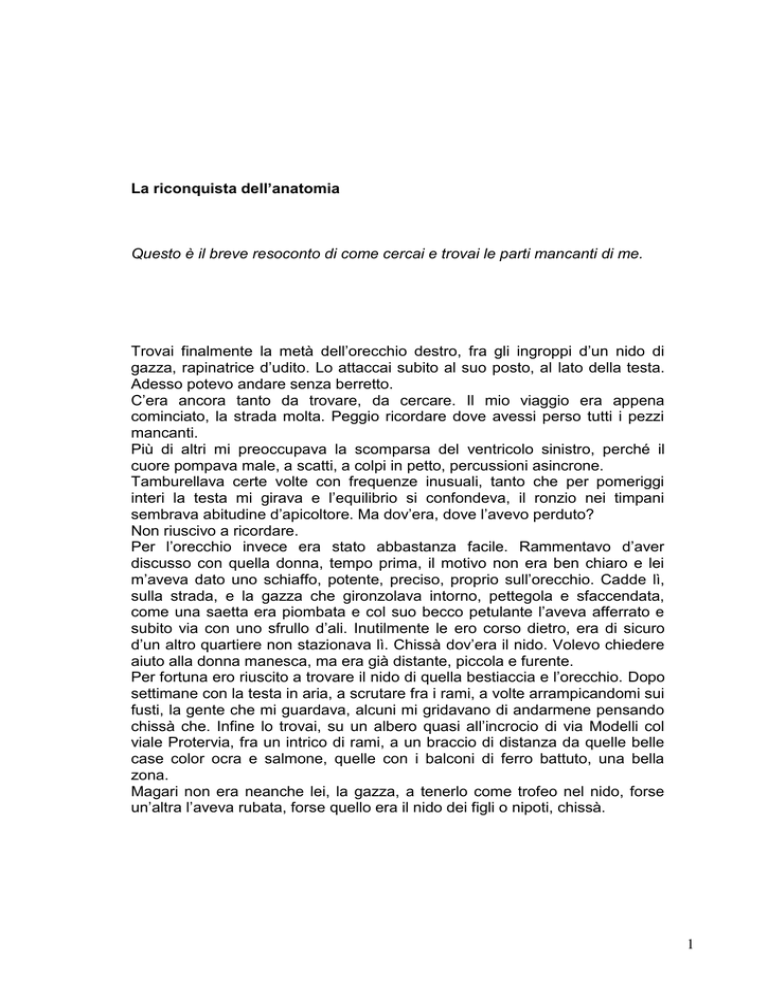
La riconquista dell’anatomia
Questo è il breve resoconto di come cercai e trovai le parti mancanti di me.
Trovai finalmente la metà dell’orecchio destro, fra gli ingroppi d’un nido di
gazza, rapinatrice d’udito. Lo attaccai subito al suo posto, al lato della testa.
Adesso potevo andare senza berretto.
C’era ancora tanto da trovare, da cercare. Il mio viaggio era appena
cominciato, la strada molta. Peggio ricordare dove avessi perso tutti i pezzi
mancanti.
Più di altri mi preoccupava la scomparsa del ventricolo sinistro, perché il
cuore pompava male, a scatti, a colpi in petto, percussioni asincrone.
Tamburellava certe volte con frequenze inusuali, tanto che per pomeriggi
interi la testa mi girava e l’equilibrio si confondeva, il ronzio nei timpani
sembrava abitudine d’apicoltore. Ma dov’era, dove l’avevo perduto?
Non riuscivo a ricordare.
Per l’orecchio invece era stato abbastanza facile. Rammentavo d’aver
discusso con quella donna, tempo prima, il motivo non era ben chiaro e lei
m’aveva dato uno schiaffo, potente, preciso, proprio sull’orecchio. Cadde lì,
sulla strada, e la gazza che gironzolava intorno, pettegola e sfaccendata,
come una saetta era piombata e col suo becco petulante l’aveva afferrato e
subito via con uno sfrullo d’ali. Inutilmente le ero corso dietro, era di sicuro
d’un altro quartiere non stazionava lì. Chissà dov’era il nido. Volevo chiedere
aiuto alla donna manesca, ma era già distante, piccola e furente.
Per fortuna ero riuscito a trovare il nido di quella bestiaccia e l’orecchio. Dopo
settimane con la testa in aria, a scrutare fra i rami, a volte arrampicandomi sui
fusti, la gente che mi guardava, alcuni mi gridavano di andarmene pensando
chissà che. Infine lo trovai, su un albero quasi all’incrocio di via Modelli col
viale Protervia, fra un intrico di rami, a un braccio di distanza da quelle belle
case color ocra e salmone, quelle con i balconi di ferro battuto, una bella
zona.
Magari non era neanche lei, la gazza, a tenerlo come trofeo nel nido, forse
un’altra l’aveva rubata, forse quello era il nido dei figli o nipoti, chissà.
1
Adesso dovevo riflettere. Mi sedetti su una panchina del viale. Dovevo fare un
piano, decidere come agire. Di sicuro non potevo continuare con pezzi
mancanti, ero inesatto, incompleto, anche se ero nato con tutto a posto.
E questa non era neppure la mia città, la mia casa. La conoscevo certo,
avevo passato parecchio tempo della mia vita sulle sue strade, ma non era la
mia città. La mia era lontana, a leghe da lì.
Quindi dovevo organizzarmi. Per prima cosa presi una stanza in un
alberguccio, come si dice, economico ma pulito. Non potevo permettermi
troppi lussi.
L’orecchio era alla fine un fatto recente nel computo del trascorrere della mia
vita e anche l’ultimo, quindi dovevo ricordare cosa era successo prima, mesi
prima, anni prima.
Perché la perdita di pezzi è un fatto che si svolge nel tempo, a volte con un
trauma, altre così delicatamente che neanche te ne accorgi e ti trovi senza
alluce, o gomito o ti manca addirittura tutta la cistifellea. Sono cose che
accadono a tutti. Ad ogni modo avevo deciso di riprendermeli, i miei pezzi,
tutti.
Seduto su una sedia in quell’ albergo mi organizzai.
Ricordavo abbastanza bene dove potessero essere la milza e tre metri di
intestino. Proprio in questa città. Ricordavo la via, la casa.
Ci sarei andato il giorno dopo, era già sera e preferii mettermi a letto,
riposare. Chiusi gli occhi.
La mattina dopo era fresca e ben soleggiata, un bell’ autunno.
La casa dove dovevo andare non era distante da lì, anche se più indietro nel
tempo, due anni buoni.
A pensarci sentivo ancora i crampi, le ferite da stiletto nella pancia e nello
stomaco. Quel dolore non mi aveva abbandonato per giorni interi e la
sensazione del dolore ancora di più, avevo sofferto grandemente quel
periodo.
Non mi fu difficile trovare la via, il numero civico, 44, salire i tre piani di scale,
trovarmi davanti alla porta. Tuttavia il nome sulla targhetta accanto non era
quello che cercavo. Chi abitava adesso lì, non certo il mio vecchio ex amico,
cosa avrei detto a chi veniva ad aprire ?
Suonai,attesi. Venne ad aprirmi una donna, una vecchia signora, mingherlina,
sottile, tanto da essere quasi trasparente per la gran luce che veniva dalle
sue spalle da un lampadario con molte lampadine.
Mi presentai, con ansia, perché avevo capito che non c’erano più in quella
casa le persone che mi avevano fatto perdere milza e un pezzo d’intestino.
Una in particolare. Comunque raccontai a quella sconosciuta cosa ero venuto
2
a fare, a sommi capi, le cose essenziali. Quasi sussurrai quando le dissi che
cercavo qualche pezzetto di me, magari era scivolato in un angolo nascosto,
dietro a qualche armadio, dentro un baule, chissà.
Lei ascoltò con interesse e un paio di volte fece di sì con il capo, come se
avesse capito la situazione, e che anzi non le sembrava strana, normale
quasi. Che anche lei avesse pezzi sparsi in giro?
- Eh – disse alla fine- gli amici sono cosa rara, e spesso si prendono grossi
abbagli. Ma entri, entri pure – si fece da parte lasciandomi il passo.
Alla prima occhiata capii che lì dentro tutto era diverso da come lo ricordavo
e che quella donna abitava da sola. La casa era grande. L’arredamento era
stato cambiato totalmente.
Sembrava leggermi nel pensiero.
- Quando sono arrivata ho rinnovato tutto quanto. Ho raccolto alcune cose
che i vecchi inquilini avevano lasciato prima d’andarsene.- mi conduceva
lungo corridoi e stanze con tappezzerie di carta chiara e fiori violetti, divani di
tessuto damascato, lampadari a più bracci, mobili lucidi.
- Credevo che forse qualcuno sarebbe venuto a riprenderseli, ma ormai..è
passato tanto tempo.
- Due anni- dissi prontamente.
- Già, due anni. Ho messo tutto in uno scatolone, lì dentro.- indicava la porta
di un ripostiglio. Dietro, a terra, c’era una grande scatola di cartone. Mi
inginocchiai e frugai dentro.
Un trapano, un caschetto arancione, due paia di pinze, una grande squadra,
diversi giri di filo elettrico, una trottola rotta, un pupazzetto di legno senza la
testa. Sotto a tutto un fagotto, un cartoccio di carta scura e spessa.
Lo scartai in fretta. Eccoli li. La milza, l’intestino. Aggrovigliati uno nell’altro,
scuri, secchi. Non importava, li avevo trovati.
La signora sorrideva quando mi rimisi in piedi.
- Ha avuto fortuna, sa? Non è facile recuperare le cose perdute, specie quelle
preziose perse per colpa degli amici che ci hanno voltato le spalle.- Già, e quando se ne ha proprio bisogno.Lei fissava a terra, triste. – Quando se ne ha bisogno, tanto bisogno.- Ho avuto fortuna, sì – dissi - non m’aspettavo che sarebbe finita così fra noi
due…- Oh – mi interruppe con un gesto della mano - non voglio sapere nulla di
quello che è successo, è una cosa sua e così deve rimanere per sempre. E
poi, sinceramente non m’interessa. Venga, l’accompagno.Mi fece strada verso l’uscita. Passando per un corridoio mi fermai vicino ad
una finestra. La ricordavo. Mi avvicinai ai vetri e guardai fuori.
3
- Sono splendidi, vero?- chiese la signora avvicinandosi- per questo sono
venuta ad abitare qui.Sotto la finestra, in una piccola corte si alzavo al cielo i rami pieni di foglie di
due maestosi lecci.
- Sì – risposi
- Vede, questa casa e quelle vicine spariranno, ma loro due no,
sopravvivranno anche ai mattoni e alla malta. Le loro radici sono più
profonde.- Solo noi potremmo farli sparire, tagliarli.- Sì, ha ragione. Ma non lo faremo.- riprese la strada verso la porta - no, non
lo faremo.Appena giunto nell’atrio misi a posto le parti mancanti e subito mi sentii
meglio. Ero soddisfatto, contento anzi. Quella faccenda era chiusa, avevo
riavuto milza e intestino, tre metri di intestino. E non avevo intenzione di
riperderli.
Poi vagai per giorni in quella città, camminai di nuovo sulle sue strade, i
selciati scuri e lisci, quelli di porfido. Passavo le ore nel tentativo di ricordare,
nella stanza d’albergo dove stavo seduto inseguendo inutili ricordi, al banco
del pesce, alle edicole, al negozio del barbiere, senza meta insomma.
Non m’interessava molto dov’erano spariti l’alluce e il ginocchio, in fondo
zoppicando potevo andare, piuttosto la metà del polmone m’impensieriva e il
rene. Da tempo non potevo più correre perché mi mancava il fiato e le
camminate lunghe mi stancavano troppo. Potevo fare solo tragitti brevi, poi
fermarmi, rifiatare, riandare.
Così spesso finivo nel giardino comunale. Lì c’erano un sacco di panchine,
brevi sentieri, muretti bassi. L’aria era sempre buona.
Ogni città importante deve avere un bel giardino comunale, anzi, la
grandezza di una città io la misuro per i suoi giardini.
Stavo seduto guardando la gente che passava oppure oziava o meglio, stava
bene sotto i tetti di foglie. Come facevo io, anche se il mio fine era riportare a
galla i posti delle mie perdite anatomiche.
Bambini giocavano a rincorrersi, le madri parlottavano e ridevano quasi
sottovoce, la mano davanti alla bocca.
Avevo la netta sensazione che lì, in quella città, non avrei trovato altri pezzi di
me e al momento non avevo altre idee.
Così me ne stavo tranquillo, osservando, pensando all’esiguità dell’essere
umano con la potenza dei fusti e delle chiome intorno.
4
Era talmente grande la differenza e lo smacco dell’esistere che mi chiedevo
come potessero vivere assieme uomini e alberi sullo stesso mondo e solo
uno dei due era sicuramente autonomo, non aveva bisogno dell’altro.
E nei giardini migliori, quelli meglio attrezzati, ci sono le serre. Hanno una
struttura di ferro battuto, color verde rugginoso fuori secolo, e una marea di
vetrate, spesso appannate perché dentro la respirazione è potente.
L’aria è sempre densa, umida e pesante, si fa fatica a respirare, come
ingoiare grossi bocconi. E il polmone che mi mancava certo non mi aiutava.
Ma erano un gran conforto i vasi allineati di orchidee, begonie e tulipani, con
la targhetta col nome in latino, gran daffare di Linneo, e le margherite poi…
Ad un tratto, boccheggiando, con la vista intontita e vacua come ubriaco, un
baleno, un’immagine. Ricordai. Il polmone. Ecco dov’era rimasto.
Avevo avuto il giusto convincimento, certo, non era lì, in quella città.
Dovevo spostarmi, andare a cinquanta leghe distante.
Corsi, come potei col tamburo aritmico nel petto e senza fiato, all’alberghetto.
Presi le mie cose, pagai, salutai e sempre di corso raggiunsi la stazione dei
pullman. In quella città i pullman sono allegri, pitturati di blu, arancio, lavanda.
Spaziosi e comodi, motori potenti, non si fermano mai, avevo sentito dire.
Presi un biglietto e aspettai la partenza. Dopo un’ora partii, assieme ad altre
persone, donne graziose, uomini distinti. Uscimmo dalla città, attraversammo
la periferia.
Qui le case erano di due piani con un giardino davanti, costruite su lunghi viali
di cipressi e olmi, freschi e ombrosi.
La circonvallazione del Destriero, il viale della Rincorsa, la strada delle
Campanule. Bei posti.
Passammo contrade solari, fra piccole valli, e laggiù i borghi e i paesi famosi
per i loro aranceti, le viti, i pizzi lavorati da donne pazienti, gli intarsi d’artigiani
su buon legno dolce.
Ancora più spettacolari i campi con quella luce che si preparava alla
malinconia dell’autunno inoltrato.
Mi misi comodo e socchiusi gli occhi, la strada era tanta.
Così ascoltavo il chiacchiericcio intorno, le belle parole usate con garbo, le
risposte intelligenti, le voci musicali e il buon uso della nostra lingua.
Anche l’aria era tiepida in quel mezzo torpore.
Il pullman faceva numerose fermate intermedie, io dovevo scendere al
capolinea. Alcuni passeggeri scendevano, altri salivano. Questi però avevano
abiti più modesti, gli uomini col cappello di paglia, le donne col fazzoletto in
capo e le gonne a fiori.
Ora il chiedere e rispondere o solo l’appunto o la considerazione era più
semplice, senza fronzoli e abbellimenti, parole secche e immediate.
5
La lunga strada dritta adesso era più sconnessa, le ruote spesso
sobbalzavano su qualche buca. E il paesaggio sembrava più cupo, la terra
spaccata d’un rosso bruno incolto. Non ascoltavo più i dialoghi degli astanti, i
loro veloci monosillabi.
E giù, a pelo d’orizzonte quelle che sembravano nubi scure era l’eterna coltre
che copriva Arsapietra, la città delle industrie, distante, perduta. Ancora oltre
le colline fino a Passo Superbo, con i suoi paesetti e il suo cielo terra d’astori.
Io venivo da uno di quelli, a cinquanta e più anni di distanza. Mi chiesi se
c’era ancora qualcuno lassù.
Rimanemmo solo in due, io e l’autista. Tutti erano scesi.
Arrivammo al capolinea, alla piazza della città.
Un grosso villaggio, a dir il vero, con case bianche grattate dall’aria salmastra
che subito riempiva il naso e si attaccava al viso.
I gabbiani urlavano.
Non lo ricordavo così mal messo, cespugli spuntavano dagli angoli delle case
dove nessuno s’era premurato a strapparli. In fondo erano passati quasi
quindici anni da quando me ne ero andato. Forse a vedermi anch’io ero come
quel posto, rugoso e indolente.
I pochi passanti andavano lenti con le mani in tasca, senza meta, pensai.
Il pullman dopo una breve sosta se ne andò, senza passeggeri.
Girai due angoli che ricordavo bene e subito lo schiaffo del blu del mare.
Il posto sorge su una collina, digrada con le sue strade ripide fino alla
spiaggia di giaietto, al piccolo molo.
Lì girano i gabbiani, in circoli ampi, più stretti, verticali si tuffano in acqua.
Dovevo cercare una persona, un uomo, e sapevo dove trovarlo.
Dov’era sempre stato, seduto fuori dalla porta di casa; un’abitazioncella di
pochi metri quadri e lui là, a fissare l’acqua e l’orizzonte.
Era l’uomo delle misure, così lo chiamavano.
Perché tutta la sua vita era stata una stima, un calcolo, una ricerca di regola
ineluttabile. E per far questo nella sua tana d’animale solitario aveva riempito
ogni spazio di strumenti precisi; goniometri e calibri, microscopi e vetrini,
righelli e sfere , codici e tabelle unificate. Misurava le spirali delle conchiglie,
l’oscillazione delle onde, i giri dei gabbiani e l’alternarsi delle folate di vento.
Aveva cassetti pieni di carte con appunti, osservazioni notturne,
considerazioni subacquee, migrazioni di stormi, florescenza di piante, calcoli
di meccaniche astrali. Così diceva quando si decideva a parlare con
qualcuno, quel paio di volte che andava a comprare qualche provvista.
Non avevo mai saputo come si procurasse il denaro necessario. Si diceva
che avesse una figlia che lo aiutava.
6
Eccolo lì infatti, al suo posto. Il mare era a cento metri dai suoi piedi, la
lanterna intermittente a duecento, sulla destra.
Mi vide, fece un sorriso storto.
-Sei tornato, dunque.Mi sedetti accanto a lui su una pietra bianca.
-Sono tornato perché mi manca qualcosa.-E credi di trovarla qui?Le parole sono stente in quei luoghi, i saluti frettolosi come se non ci fosse
mai stato un tempo di lontananza e del ricordo.
Rimasi in silenzio a fissare lontano. Perché ero venuto lì? Adesso la
sicurezza di prima stava svanendo.
Forse avevo sbagliato.
-Non lo so- disse l’uomo – non lo so proprio. Ti posso aiutare dicendoti di
guardarti attorno. Se credi che questo sia il posto, allora qualcosa c’é.Rimanemmo in silenzio per parecchio.
Gridi di gabbiani, le onde.
Mi alzai.
-A proposito, cosa ti manca?-Tre quarti del polmone- risposi.
-Ah, brutta storia i polmoni. Sono quelli più perduti, lo sapevi? Ho le
statistiche da qualche parte, tutti i polmoni vanno a perdere. E l’aria? Come si
fa dopo a respirare, eh? Come si fa?-Male- dissi – molto male.
Ripresi la stradina per tornare alla piazza.
Non c’erano pullman fino al mattino dopo, dovevo rimanere lì. Mi guardai
attorno. Solo anime senza sguardo.
Non me la sentivo di fermarmi per la notte in qualche albergo. Decisi di
vagare, di seguire i miei passi lenti.
Metro dopo metro andavo convincendomi che il posto era sbagliato, solo una
tappa, un passaggio.
Continuai a girare, a sedermi su qualche sasso, a guardarmi intorno e non
incontrare nessuno. Così venne la sera e venne la notte.
L’uomo delle misure aveva ragione. Qualcosa di mio c’era lì; il ginocchio e
l’alluce, incassati fra due sassi sotto un grande olmo.
Ricordai alla fine che tanto tempo prima, un giorno, corsi per ore come un
forsennato, su e giù per il paese con la morte nel cuore e alla fine distrutto mi
sedetti proprio sotto quell’albero e lì rimasi per un tempo infinito tenendomi la
testa fra le mani.
Perché avevo capito che quello non era il mio posto, un giorno, uno qualsiasi,
guardandomi attorno mi chiesi: Cosa faccio qui? C’erano le persone care, gli
7
amici acquisiti, la nicchia del vivere quieto, una ragazza amata, anche. Ma
non era il posto giusto, non casa, non per sempre. Erano ormai troppi gli
stridii degli uccelli, lo sbatacchiare dell’acqua il rotolare sommesso ma
incessante e perpetuo dei ciottoli a pel di riva. E l’aria di sale e le piante di
sale e i sorrisi di sale, troppo mare e cielo.
Dovevo partire e fu difficile farlo, una tragedia spiegarlo a chi aveva creduto in
me per tanto tempo.
Ricordai che presi il pullman, quello color lavanda e oro, con gli sguardi
rancorosi di tante persone sulla schiena e uno carico d’odio che ancora era
impresso nei miei occhi. Me ne andai.
Passai la notte fredda raggomitolato sotto quell’olmo, ogni tanto muovendo la
gamba stupendomi del bel movimento dell’articolazione.
All’alba discesi verso la spiaggia per salutare l’uomo delle misure per l’ultima
volta, di sicuro non sarei mai ritornato. Ma lui non era fuori dalla porta della
sua casa. Lo vidi più in là, sotto la lanterna che scrutava il mare. Fui tentato di
chiamarlo, avevo già il braccio alzato nel saluto, ma non dissi nulla, rimasi un
po’ a guardarlo.
D’un tratto la sua testa si girò dalla mia parte, come se sentisse la mia
presenza.
Era lontano da me, ma forse c’era un mezzo sorriso su quel volto di legno.
Non so, la distanza era grande.
Andai alla piazza, cercai un mezzo che mi avrebbe portato nel posto dov’ero
adesso sicuro di trovare il polmone.
Dovevo andare ad Arsapietra.
Quanto lungo fu quel viaggio, eppure le leghe non erano molte. Ma la corriera
scassata e sporca, la gente che s’ammassava, spingeva, parlava forte e
rideva con quelle bocche dai denti rotti, gli sguardi lucidi e allucinati.
Erano quasi tutti ex contadini, avevano ancora sotto le unghie lo sporco di
terra ed erba, generazioni di coltivazioni s’erano appollaiate attorno ai loro
cuori.
Andavano a lavorare in città, nell’industria, al tramonto tornavano nelle case
che non avevano intenzione di lasciare, meglio un lungo viaggio che
rinunciare a una parte del giorno d’aria buona.
Già la periferia accolse tutti noi con la sua coltre scura e pesante, sembrava
sempre ricoperta da una nuvola enorme. Le lunghe strade di cemento, le
case a destra e sinistra, grigie, senza balconi, solo finestre coi telai rosso
ruggine. E chi camminava per quelle vie era ferrigno come l’asfalto e il cielo.
Scendemmo tutti al capolinea. Più in là, sulla destra, i grandi cancelli di una
fabbrica. Tutti andarono da quella parte, io rimasi solo, a guardarmi attorno.
8
Anch’io avevo lavorato lì. Prima di spostarmi nel paese del sale, prima di
spostarmi ancora nella bella città dei giardini e delle serre.
L’aria che stavo respirando adesso mi bloccava il polmone che ancora
funzionava, boccheggiavo. Non ce l’avrei fatta.
Era lì, adesso ne avevo la sicurezza, lì dentro, fra quelle mura, avevo perso
tre quarti di quello che non funzionava.
Però il posto era grande, labirintico.
Speravo di trovare ancora il mio collega, l’amico quasi, forse lavorava ancora
lì.
Mi fecero passare al controllo dei cancelli senza problemi. Una delle guardie,
un vecchio senza capelli e con lo sguardo torvo del rassegnato si ricordava
ancora di me. per fortuna aveva buona memoria, altrimenti sarebbe stato
impossibile entrare.
Mi confermarono anche che il mio collega lavorava ancora lì e aveva giusto
cominciato il turno. Andai di corsa verso gli spogliatoi, quella grande sala
dove tutti cambiavano i loro abiti grigi per altri d’una tinta solo più chiara.
Eccolo là, seduto su una panca di metallo intento ad allacciarsi le scarpe con
la punta di ferro.
-Ehi- gli gridai dal fondo.
Lui si girò. Per un attimo aggrottò le sopracciglia per mettere a fuoco.
-Tu- disse dopo avermi riconosciuto- Sei proprio tu.Corse verso di me e mi strinse fra le braccia.
-Ah, ah, come sono felice di vederti. Come mai sei qui, non avrai mica
intenzione di venire a lavorare di nuovo in questo posto?-Ah, Prometeo, Prometeo- dissi- così mi soffochi. Mettimi giù ti prego.Lui mi lasciò. Lo guardai, dal basso. Non era cambiato per nulla, gigantesco,
la pelle rugginosa gli occhi celesti . Ma i capelli erano più grigi che scuri
-Allora, cosa succede, cosa fai qui? Sono passati…ah, quanti anni?-Quasi trenta, Prometeo.
-Trenta – ripeté pensieroso come se volesse visualizzare il tempo – sono
tanti.-Già. E tu come stai, come te la passi?-Ma bene me la passo, che diamine. Lo sai che mi sono anche sposato.-Sposato tu? Ma dai..-Davvero, e ho anche un figlio. Ha quindici anni.-Sono successe di cose, da quando sono andato via.-Già, tante – adesso la sua faccia era diventata triste, pensierosa.
-Cosa è successo?-
9
-Vieni, sediamoci – disse lui indicando la panca vicino al suo armadietto- le
cose qui vanno sempre peggio. Ormai siamo controllati da gente cattiva,
senza cuore, lavoriamo in condizioni terribili, nessuno che ci difenda, nessuno
che ci ascolta. Tutta la città è così ormai. Siamo migliaia di operai e decine di
controllori, ex operai come noi, e qualcuno che comanda tutto, noi e i
controllori. –
-Ma non potete fare qualcosa, ribellarvi, non so…La sua faccia divenne ancora più triste, lo sguardo assente
-Qualcuno ci ha provato, dieci anni fa. Sono spariti, non ci sono più, anche le
loro famiglie. Tutto in un paio di giorni.-Ma – ero incredulo – vuoi dire che sono stati uccisi?-Non so, nessuno ha mai saputo nulla. Non ci sono più e basta. Avevano
preso di mira anche me, ma li ho fregati facendo quello che so fare bene.
-E cioè ?-Lo scemo. Il gigante ritardato. Ridevo facendo finta di non capire quando mi
chiedevano se conoscessi questo o quello, i capi della ribellione. Per un po’
mi hanno tenuto d’occhio, poi mi hanno lasciato in pace. E intanto quegli altri
erano spariti.Rimanemmo qualche momento in silenzio guardando le piastrelle del
pavimento.
-E tu, piuttosto, come mai sei qui?-Io sono venuto in cerca di qualcosa di mio.Mi guardò per un attimo dritto negli occhi. – Il polmone, vero?-Ma, come fai a saperlo?- ero sbalordito.
In quel momento suonò forte una lugubre sirena.
Prometeo si alzò di scatto. – Devo andare adesso, altrimenti sono guai. –
-Ma…-Ascolta, tu aspettami fuori, quando finisco il turno andiamo a casa mia.-Va bene- risposi.
-D’accordo, fra dieci ore ci vediamo fuori dai cancelli - e scappò di corsa
lungo il corridoio. Altri operai si unirono in fretta a lui. Oltrepassarono tutti una
grande porta d’acciaio in fondo.
Dieci ore, pensai, dieci ore.
Rimasi ancora un po’ seduto ripensando a quanto mi aveva detto l’amico. Le
cose erano peggiorate, ormai quella non era più una città per esseri umani.
Poi mi alzai e con calma raggiunsi la vetrata che dava sull’interno della
fabbrica. Su uno dei suoi interni.
Eccolo là, Prometeo. Con la sua asta pronto a incanalare la colata nel solco
giusto. Bardato come un palombaro con le protezioni d’amianto e la
10
maschera che lo copriva fin sulle spalle. Non potevo sbagliarmi, era il più
grande di tutti laggiù in fondo.
Scintille di ghisa, acciaio fuso e magnesio erano tutto intorno a lui. Le
districava e assoggettava, come vero padrone del fuoco, un titano
metallurgico.
Rimasi un po’ a guardare quel lavorio frenetico. Così ricordai quando anch’io
ero lì in mezzo a quegli uomini, diciassette anni avevo, proprio a fianco di
Prometeo, la guida di quel mondo. Mi aveva assistito, aiutato nei momenti più
gravi, forse anche salvato.
Poi uscii dai cancelli, dovevo solo attendere. Ora non rammento con
chiarezze cosa feci per quelle ore lunghe, fumigate d’aria scura. Vagai per
strade seguii con lo sguardo operai che passavano rapidi e sparivano nei
ventri di tutte quelle fabbriche. Seguii anche il corso dei binari, i treni con i
carichi di pani di nichel e acciai lucenti, fino alle stazioni, giù ai moli dove
gradi bracci di gru li caricavano su navi senza colore.
Il carbone bruciato dei treni si mischiava con quello delle ciminiere. Tutto era
scuro. I visi delle donne che vedevo camminare erano come quell’aria.
Nessun sorriso, solo rassegnazione. Come animali recintati, come piante
trapiantate in terre secche.
E ancora girovagai e aspettai. Finché tutto divenne troppo, non avevo più
aria, il fiato se ne andava, tutto scuro, sempre più nero.
-Ehi, ehi, apri gli occhi.Era Prometeo che mi scoteva il braccio. Ero disteso sulla panca fuori dai
cancelli, semisvenuto, le labbra crepate.
-Sei tu – dissi con l’intenzione di un sorriso.
-Certo che non dureresti un giorno a lavorare con me. Eppure quando sei
venuto qui la prima volta sembravi poter resistere a tutto.-Non era vero, dovevo farlo, o almeno darne l’impressione.-Già. L’avevo capito, sai? Un giorno mi son detto: quello non ce la fa, anche
se ha voglia da vendere.-Infatti non ce l’ho fatta.-Non è per tutti questo mondo. Io credo che ognuno ha il suo posto dove
stare e devo trovarlo e andarci a vivere.Rimanemmo un po’ in silenzio.
-E tu – gli chiesi- hai trovato il posto? Voglio dire, è questo il tuo posto?- feci
un gesto largo con braccio.
-Questo non è il posto di nessuno. Chiunque viva qui meriterebbe ben altroalzò le spalle.- Ma siamo tutti qua, è diventata la nostra vita. E poi io sto
bene, ho una famiglia e questo lenisce quasi tutte le scottature che mi faccio
lì dentro. Vuoi conoscere mia moglie e il ragazzo?-
11
-Prometeo, ti ringrazio, ma non ce la faccio più. Sto soffocando.-Già, ecco, questo è tuo.- mi porse una cassettina di ferro, pesante.
-Qui dentro c’è il tuo polmone. Cioè quel pezzo che hai lasciato prima
d’andartene.-Dimmi, cosa successe quella volta?-Successe che un giorno sei caduto a terra come un sacco vuoto, in mezzo
alla mensa. –
-Io non ricordo nulla.-Ti credo. Eri bianco come il marmo, con la bocca spalancata come un pesce
a riva. Io ti presi in braccio e ti portai in infermeria. Però avevo subito capito
che ti mancava un pezzo. E mentre ti davano le prime cure corsi indietro e
per fortuna trovai il polmone. S’era ficcato sotto un tavolo, incastrato fra le
gambe e la parete.-Perché non me lo hai dato subito?-Non c’eri più. Mi dissero che eri scappato, avevi anche acciaccato un dottore
e un infermiere. Sono venuto poi a cercarti a casa, ma era vuota, nemmeno i
vestiti nell’armadio, niente. Eri fuggito e non sapevo dove.Per un minuto non disse nulla, io cercavo di ricordare.
-La verità è che avevi paura. Paura di dover rimanere sempre in questa città,
in questa fabbrica. Te l’ho detto, non è un mondo per tutti, sicuramente non
era il tuo.Fischiò forte la sirena di fine turno. Altri gruppi d’operai erano in fila per
entrare.
-Dai – disse Prometeo – prendilo, è cosa tua.Mi tremavano un po’ le mani quando aprìì la scatola, quando presi fra le dita
il polmone e lo guardai come meravigliato.
Finalmente l’aria. Respirai gonfiando il petto. Subito tossii. Troppo tutto in un
colpo.
Prometeo rise. – Non soffocarti adesso, fai piano.Respirai tranquillamente.
-Cosa farai adesso?- mi chiese.
-Ho ancora una cosa che mi manca e poi…. poi non lo so.- Cos’è’ ? -Il ventricolo.-Sai dove trovarlo almeno?-Forse, ma ho tanta strada da fare.Quando ripresi la strada dopo aver salutato Prometeo e averlo guardato negli
occhi slavati per un lungo momento, mi sembrava che camminare fosse più
facile e agevole. e lo era sicuramente con due polmoni.
-Non metterti nei guai- dissi al gigante.
12
-Non preoccuparti. Farò come sempre se qui le cose si mettono male.-L’idiota.-Esatto, quello mi viene bene.-
Lasciai la città. Oh, come respiravo bene adesso, quanta aria entrava dentro
di me, quanti atomi. Passai la lunga periferia, poi presi certe strade bianche
polverose, poi sentieri larghi e ben segnati. Alzando gli occhi vedevo in alto
Passo Superbo e ricordavo le valli che lo formavano, i suoi paesucoli, uno in
particolare, una casa, una strada. Dovevo andare lì.
Di seguito i sentieri diventavano più stretti e ripidi, sassosi. Ogni tanto al
colmo di una collina una radura di arbusti, qualche abete, cespugli di rovi e di
ginepri. L’aria mi entrava fresca, stavo bene solamente respirando. La stessa
aria che respiravano le piante che vedevo attorno, gli arbusti che sfioravo con
la punta delle dita. Pensai che il loro bel colore brillante adesso che potevo
avere tutta quell’ aria stava entrando anche in me, di sicuro le mie guance
erano vive, colorate come la crosta di un buon pane.
Più salivo e più l’aria diventava fredda. Mi avvolsi nella coperta che avevo
nello zaino, la mia giacca di velluto non bastava a proteggermi.
Ad ogni respiro l’aria mi pungeva in fondo al naso e alla gola. Gli occhi
lacrimavano, la vista era sempre offuscata.
Forse vidi dei caprioli saltare in fondo ad una valletta.
Passai in boschetti aggrovigliati, senza sentieri. La testa adesso girava in
continuazione. L’altitudine? Più probabile il cuore dimezzato.
Alla fine eccolo là, Passo Superbo.
Il primo paese era Fiorenzo, ma mi tenni lontano dalle sue strade, perché non
volevo incontrare nessuno, anche se a dire il vero non notai movimenti,
persone. Due cavalli brucavano, un trattore fermo.
Più avanti Archelao, con le sue belle case di pietra bianca e i pozzi d’acqua
pura. Anche qui girai al largo. Vidi solo due donne chiacchierare ferme nelle
piazzetta vicino alla chiesa.
E finalmente ad una svolta ecco la valletta proprio ai piedi del passo.
E lì nel mezzo il mio paese. Quanti colori c’erano tutto intorno, mille rossi,
centinaia di verdi e viola, gialli a profusione. Sopra la cesta rovesciata del
cielo uniforme.
Scesi per la via principale.
13
La casa rimane sempre col proprio odore.
Vidi subito che tante edere avevano preso possesso dei muri e avevano
camminato fin su, ai tetti. E il silenzio. E l’immobilità.
Quasi corsi gli ultimi metri. Eccola lì, la mia casa.
Aveva le imposte sbarrate, la porta sbarrata.
Improvviso uno scoramento mi prese per tutto il corpo. Adesso cosa faccio,
mi chiesi, adesso che sono qui. Perché ci son venuto, cosa speravo di
trovarci? Sapevo già che non avrei trovato nessuno. Che tutti quei paesi
ormai erano quasi disabitati, moribondi, destinati a sparire, anche il loro
nome.
Camminai lentamente, strascicando le punte delle scarpe per la polvere della
strada. Non c’erano rumori. Gli uccelli, soli, parlavano fra di loro. Qualche
insetto.
Feci il giro, mi ritrovai di nuovo nei campi. A pochi passi il muro e il cipressi
che delineavano l’area dei morti.
Non volevo andare lì, non ne avevo motivo. Sapevo dov’erano i miei, di certo
nessuno li aveva cambiati di posto.
Mi sedetti, guardai a terra sconsolato.
In verità avevo sperato che questo paese fosse rinato, ricresciuto dopo che
me ne ero andato. Invece non c’era nessuno.
Quasi nessuno. Ad un tratto sentii una voce, di donna, una cantilena
accompagnata dalle note di un pianoforte. Non era lontana, due o tre svolte.
Mi alzai e corsi da quella parte e d’improvviso ricordai che in tutto il paese
solo un persona suonava il piano da piccola, una bambina della mia età.
-Dalia- stavo sulla porta della sua casa, lei era seduta in penombra, le mani
appoggiate alla tastiera di un pianoforte a muro.
Alzò gli occhi dai tasti, mi guardò un momento non riconoscendomi. Solo un
momento.
-Tu – disse alzandosi di colpo, correndo verso di me e abbracciandomi con
forza.
- Tu, tu, tu – sei qui, sei tornato. – Vieni siediti e raccontami tutto di te. Dalia aveva i capelli spettinati, di colore incerto fra il castano e la sabbia
bagnata. Indossava una vestina di cotone a maniche lunghe. Mi sedetti su
una sedia al tavolo massiccio in mezzo alla stanza. Dietro il grande camino
spento. Le raccontai cosa avevo fatto in quegli anni.
-Sono qui perché devo prendere qualcosa. Qualcosa che ho lasciato. Però
adesso non sono più sicuro…Lei mi guardava con occhi sgranati, scuri. Non diceva niente.
-Già, l’avevo immaginato. Anzi, me lo aspettavo da uno come te.-Cosa vuoi dire?-
14
-Sai, come hai visto se ne sono andati tutti. Quasi tutti. Siamo rimasti in dieci
solamente. Senza contare mia madre, di sopra, è a letto da anni, non si
muove più. Per questo sono qui.-Mi dispiace – mormorai.
Lei fece un gesto con la mano.
-Non preoccuparti, ormai ci sono abituata e ho imparato a non avere più
speranze per il futuro. Tanti che sono andati via hanno lasciato pezzi dei loro
corpi fra queste case .- fece un mezzo sorriso. – io sono rimasta qui e sono
tutta a posto, non ho perso niente.- divenne seria – ascolta, non lo so perché
ogni volta che qualcuno se ne va io trovo ginocchia, grovigli di vene o parti
della testa in mezzo ai campi o per la strada, però è così. –
-Dalia, vuoi dire che se fossimo rimasti qua, tutti quanti, non avremmo perso
nulla? – anch’io stavo sorridendo adesso- che l’aria della terra natia è più
forte di tutto e senza siamo persone a metà?-Io credo che tutti voi che siete andati avete fatto bene a farlo. Non era il
vostro posto, anche se ci siete nati. Si viene al mondo in una certa parte,
mica dopo siamo costretti a restarci. E te lo immagini…-Pero?Lei sospirò. Mise la sua mano sulla mia.- Però niente. Non c’è morale,
nessun insegnamento. In questi anni io ho solo raccolto i pezzi e messi da
parte.La guardai sbalordito- Vuoi dire che tu hai conservato tutto quanto?-E certo. Che dovevo fare? Buttarli via, lasciarli ai corvi, o ai cani?Ero emozionato, agitato. – E dove li tieni, dove li hai messi, Dalia.?-Sai – rispose lei- sarei tentata di non dirtelo. Altri negli anni sono tornati qui a
riprendersi i pezzi, pochi a dir la verità, e poi se ne sono andati. Nessuno si è
mai fermato. Di te mi dispiacerebbe che te ne andassi.Non sapevo cosa rispondere, rimanemmo in silenzio a guardarci le mani
appoggiate sul tavolo.
Poi lei alzò la testa, mi sembrava avesse gli occhi allegri. – Dai, scherzavo,
certo che te lo dico, come ho fatto con gli altri. Non è mio diritto decidere per
nessuno. Sono lassù- indicò con la mano la montagna alle nostre spalle.- A
Passo Superbo.-A Passo Superbo? – ripetei incredulo – perché lassù.
-Perché lassù c’è un’edicola, una croce, te la ricordi?-Certo la Madonna delle Rupi.-Esatto. Lì sotto ho scavato una buca, ci ho infilato una cassa, dentro ci sono
i pezzi. Mi sembrava il posto migliore, sopra tutte le valli, fra la neve.Non sapevo che dire, ma mi rodevo dall’impazienza.
-Puoi andare, se vuoi, non posso trattenerti. Io resto qui, sai la mamma…-
15
Le feci una carezza sulla guancia e scappai fuori. A Passo Superbo.
La strada è tutta in salita, un misero sentiero che col tempo stava sparendo
ripreso dalle piante. Corsi per lunghi tratti, altri camminai quando il cuore non
ce la faceva e sembrava mi scoppiasse.
Quasi al tramonto arrivai in cima, mi fermai un momento a guardarmi intorno.
Lo spettacolo era superbo, ma l’impazienza non mi lasciava immobile. Di
nuovo correndo raggiunsi la grande croce in legno. Sotto la piccola edicola
con la Madonna e il Bambino.
Avevo portato una vanghetta, mi misi a scavare come un forsennato. La terra
era dura, ma avevo tanta forza mentre il cuore batteva sempre più veloce.
Finalmente la cassa. La tirai fuori dalla buca che avevo scavato. Tolsi il
coperchio.
E rimasi a bocca aperta. Dentro c’era un groviglio indescrivibile di pezzi
umani, di fette di corpi. Con le mani frugai in mezzo. Ecco, il ventricolo. ma
era grande, enorme, come quello di un toro. Cercai ancora perché nella testa
era sorto un sospetto. Quanti cuori potevano esserci lì dentro?
Ne trovai un altro, e poi un terzo e un altro ancora, più piccolo, non era il mio.
Cinque, sei, sette cuori.
Ero disperato. Come potevo fare adesso, quale prendere?
Venne la notte, il freddo, il buio. Io rimasi lì, a frugare, a misurare, a provare.
Solo il lucore delle stelle mi dava un minimo di luce.
Dov’era il mio cuore, dov’era, maledizione a tutto?.
Era troppa la delusione, lo sconforto e la rabbia, la paura. Mi addormentai con
la guancia sul coperchio della cassa, le mani ancora all’interno.
All’alba aprii gli occhi, per un attimo non ricordai dov’ero. subito però mi resi
conto della realtà e di nuovo presi i cuori in mano.
-Dove sei, dove sei?D’un tratto mi accorsi di non essere solo.
Vicino a me Dalia, coperta da una lunga giacca scura.
-Dalia – le dissi – cosa succede, cosa faccio adesso?.
Lei sorrise, s’inginocchiò vicino, mi accarezzò il viso.
-Te l’avevo detto che avevo raccolto i pezzi di tutti. Anche gli altri hanno
lasciato un pezzo di cuore.-Ma qual è il mio?-Ha importanza, alla fine?La guardai, non capivo.
-Ascolta, chi ha lasciato qui i suoi pezzi o è già tornato oppure non lo farà più.
Sono sicura che tu sei l’ultimo.-Ma ci sono ancora tante cose qui dentro. E forse qualcuno ritornerà ancora.-
16
-Io credo proprio di no. Devo farti una confessione, sai. Ti aspettavo, da anni,
Ero sicura che saresti tornato, però ce ne hai messo di tempo. Sono venuti
prima di te gli altri e hanno preso i loro pezzi.-Ma come hanno fatto a riconoscere il proprio?Lei rimase in silenzio a guardarmi. Alle sue spalle spuntava una giornata
radiosa.
-Vuoi dire- dissi un po’ balbettando – che qualcuno potrebbe aver preso il mio
e lasciato il suo? Qualcuno che adesso sta vivendo con il mio cuore?Fece un debole cenno di assenso col capo.
-E gli altri, quelli che sono ancora qui dentro?-Quelli non verranno più.-Come puoi dirlo?-Sarebbero già arrivati. Hanno deciso di vivere così, una vita parziale. oppure
non ci sono più, sono morti senza i loro pezzi.Si sedette su un gran sasso bianco poco distante.
-Ascolta, chi viene qui vuol dire che vive male la sua vita e per continuare
deve avere tutti i pezzi. Ad un certo punto sentono di aver bisogno di queste
cose – indicò la cassa – è un po’ come quando prendi una botta in testa e poi
non ti ricordi alcune parti.- guardò il sole salire- e poi se ne vanno.La guardai. Guardai quella donna triste che aveva deciso di non aver più
speranza.
-Ma se io sono l’ultimo, come dici, cosa farai dopo?Mi guardò, sorrise.- Io starò qui, finirò qui. E poi c’è mamma…Di nuovo silenzio. Poi si alzò di scatto in piedi.- Allora, ti sbrighi? prendine
uno e mettilo a posto. Non puoi fare altro.-Io…Venne vicino a me, quasi infuriata. Cacciò le mani nella cassa e prese un
ventricolo, uno a caso. – Ecco, questo è il tuo. – disse offrendolo – mettilo nel
petto.Lo presi e lei con un calcio rovesciò la cassa. I pezzi si sparpagliarono fra
l’erba.
Si girò a guardare il sole.
17
Questo è il resoconto del viaggio che feci per ritrovare i miei pezzi. Ora me ne sto qui,
nella serra del parco, respiro tutti gli odori , il cuore pompa tranquillo e regolare.
Sorrido spesso. Ci sono centinaia di fiori, ogni giorno fanno la loro gara di bellezza.
Sulla destra, su un tavolo di ferro c’è un vaso, un pianta.
Il suo fiore sembra quasi un essere marino e di profezia; un anemone.
E’ una dalia.
Fuori c’è tutta la città.
E’ un bella città..
18