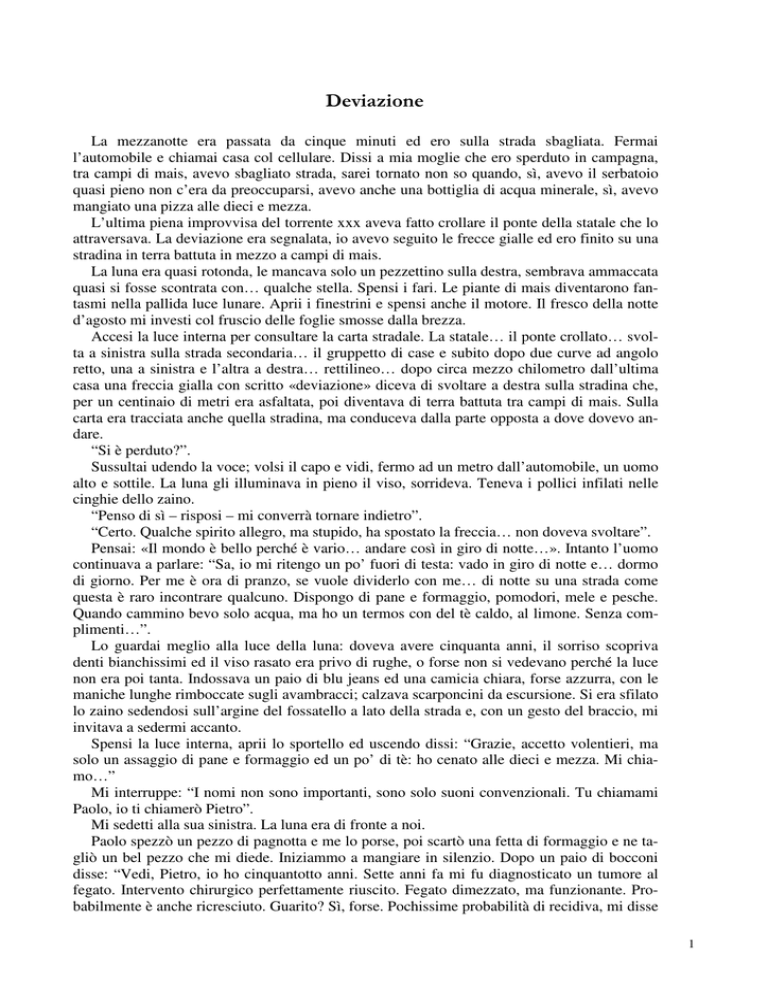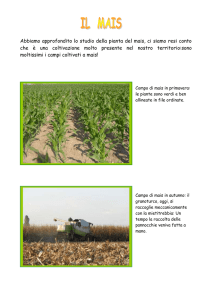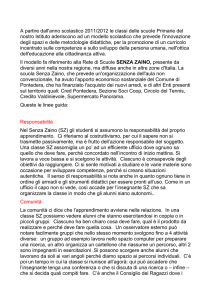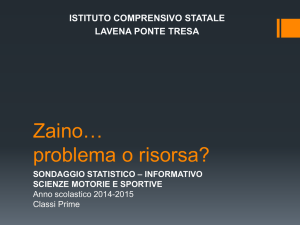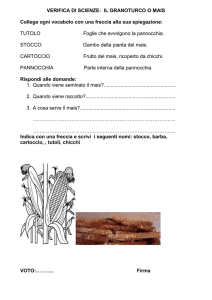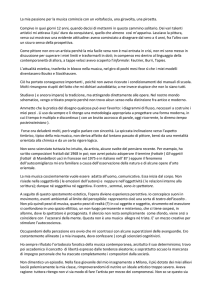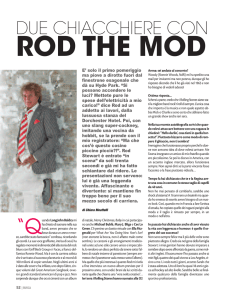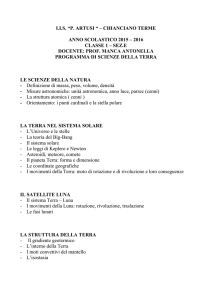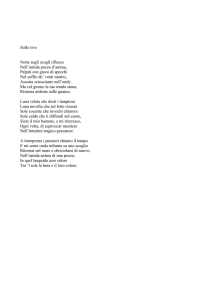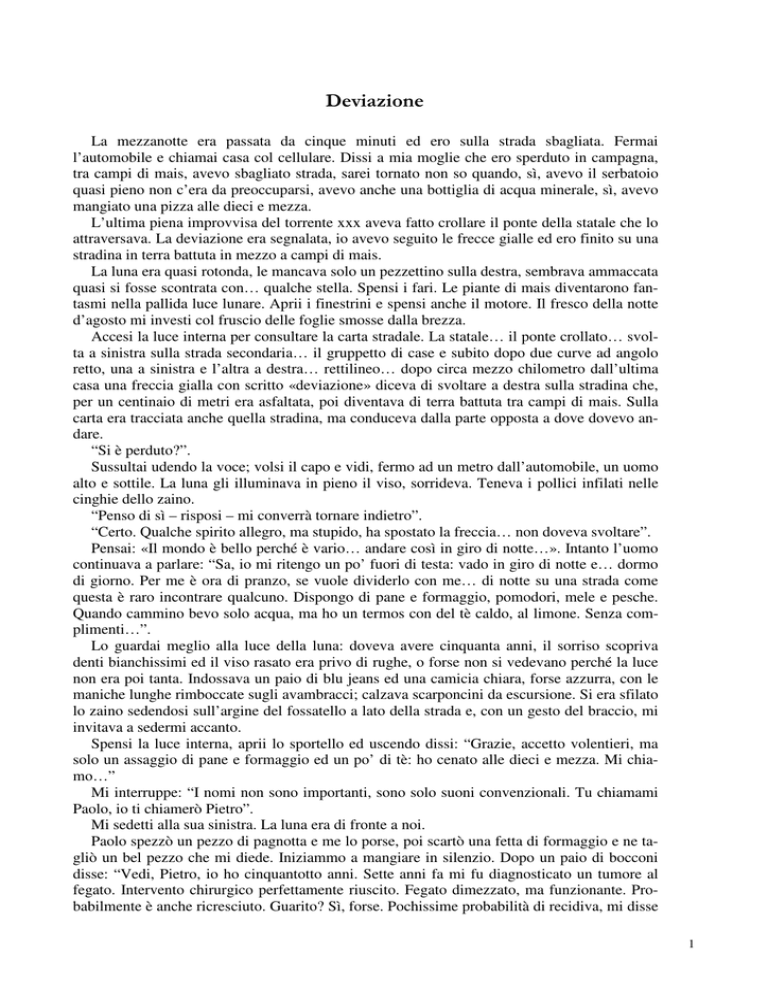
Deviazione
La mezzanotte era passata da cinque minuti ed ero sulla strada sbagliata. Fermai
l’automobile e chiamai casa col cellulare. Dissi a mia moglie che ero sperduto in campagna,
tra campi di mais, avevo sbagliato strada, sarei tornato non so quando, sì, avevo il serbatoio
quasi pieno non c’era da preoccuparsi, avevo anche una bottiglia di acqua minerale, sì, avevo
mangiato una pizza alle dieci e mezza.
L’ultima piena improvvisa del torrente xxx aveva fatto crollare il ponte della statale che lo
attraversava. La deviazione era segnalata, io avevo seguito le frecce gialle ed ero finito su una
stradina in terra battuta in mezzo a campi di mais.
La luna era quasi rotonda, le mancava solo un pezzettino sulla destra, sembrava ammaccata
quasi si fosse scontrata con… qualche stella. Spensi i fari. Le piante di mais diventarono fantasmi nella pallida luce lunare. Aprii i finestrini e spensi anche il motore. Il fresco della notte
d’agosto mi investi col fruscio delle foglie smosse dalla brezza.
Accesi la luce interna per consultare la carta stradale. La statale… il ponte crollato… svolta a sinistra sulla strada secondaria… il gruppetto di case e subito dopo due curve ad angolo
retto, una a sinistra e l’altra a destra… rettilineo… dopo circa mezzo chilometro dall’ultima
casa una freccia gialla con scritto «deviazione» diceva di svoltare a destra sulla stradina che,
per un centinaio di metri era asfaltata, poi diventava di terra battuta tra campi di mais. Sulla
carta era tracciata anche quella stradina, ma conduceva dalla parte opposta a dove dovevo andare.
“Si è perduto?”.
Sussultai udendo la voce; volsi il capo e vidi, fermo ad un metro dall’automobile, un uomo
alto e sottile. La luna gli illuminava in pieno il viso, sorrideva. Teneva i pollici infilati nelle
cinghie dello zaino.
“Penso di sì – risposi – mi converrà tornare indietro”.
“Certo. Qualche spirito allegro, ma stupido, ha spostato la freccia… non doveva svoltare”.
Pensai: «Il mondo è bello perché è vario… andare così in giro di notte…». Intanto l’uomo
continuava a parlare: “Sa, io mi ritengo un po’ fuori di testa: vado in giro di notte e… dormo
di giorno. Per me è ora di pranzo, se vuole dividerlo con me… di notte su una strada come
questa è raro incontrare qualcuno. Dispongo di pane e formaggio, pomodori, mele e pesche.
Quando cammino bevo solo acqua, ma ho un termos con del tè caldo, al limone. Senza complimenti…”.
Lo guardai meglio alla luce della luna: doveva avere cinquanta anni, il sorriso scopriva
denti bianchissimi ed il viso rasato era privo di rughe, o forse non si vedevano perché la luce
non era poi tanta. Indossava un paio di blu jeans ed una camicia chiara, forse azzurra, con le
maniche lunghe rimboccate sugli avambracci; calzava scarponcini da escursione. Si era sfilato
lo zaino sedendosi sull’argine del fossatello a lato della strada e, con un gesto del braccio, mi
invitava a sedermi accanto.
Spensi la luce interna, aprii lo sportello ed uscendo dissi: “Grazie, accetto volentieri, ma
solo un assaggio di pane e formaggio ed un po’ di tè: ho cenato alle dieci e mezza. Mi chiamo…”
Mi interruppe: “I nomi non sono importanti, sono solo suoni convenzionali. Tu chiamami
Paolo, io ti chiamerò Pietro”.
Mi sedetti alla sua sinistra. La luna era di fronte a noi.
Paolo spezzò un pezzo di pagnotta e me lo porse, poi scartò una fetta di formaggio e ne tagliò un bel pezzo che mi diede. Iniziammo a mangiare in silenzio. Dopo un paio di bocconi
disse: “Vedi, Pietro, io ho cinquantotto anni. Sette anni fa mi fu diagnosticato un tumore al
fegato. Intervento chirurgico perfettamente riuscito. Fegato dimezzato, ma funzionante. Probabilmente è anche ricresciuto. Guarito? Sì, forse. Pochissime probabilità di recidiva, mi disse
1
il Professore – bevve un sorso d’acqua e continuò – sei mesi fa il tumore si rifece vivo. Nel
polmone sinistro”.
Io ero rimasto immobile, riuscii a bere un sorso d’acqua dalla mia bottiglia. Intanto lui, Paolo, mangiando mi raccontava la sua storia. Dopo un po’ ripresi anch'io, lentamente e meccanicamente, a mangiare.
Aveva letto che cambiando modo di vivere potevano aumentare le possibilità di debellare
il tumore. Aveva rinunciato ad ogni tipo di cura. Si era spogliato dei suoi beni – un negozio
che vendeva elettrodomestici – donandoli alla moglie ed ai due figli che lo gestivano con lui
ed aveva detto loro: “Mi resta poco da vivere, fate finta che io sia morto oggi. Potete fare ciò
che vi pare, io prendo il mio zaino da escursionista e me ne vado. Camminerò verso sud e, se
arrivo in Sicilia, torno indietro. Ho aperto un conto corrente a mio nome con qualche migliaio
di Euro e l’estratto conto mensile arriverà qui da voi così potrete, se necessario, fare dei versamenti. Porto con me il Bancomat, così saprete più o meno dove sono. Io non vi cercherò e
voi non cercatemi perché sono morto”. Era partito.
Era in viaggio da ormai cinque mesi e da tre aveva deciso di camminare soprattutto di notte: c’era più silenzio e poteva pensare meglio, ma forse non pensava molto perché aveva scoperto le stelle, il vento, la pioggia, gli odori della terra, dell’erba, del mais.
Stava imparando, disse, “a sentire il corpo”: la stanchezza nelle gambe, nel collo, nelle
spalle; lo zaino che era più pesante da una parte e doveva sistemare meglio le cose dentro.
Apprezzava il piacere di bere acqua quando aveva sete. Il cibo aveva più gusto quando era
una necessità, non solo una “voglia” generata dall’abitudine di mangiare ad intervalli prefissati.
Stava imparando ad orientarsi con le stelle e con gli odori portati dal vento. Non teneva
conto della strada percorsa, camminava e, quando era stanco si fermava a riposare; allo spuntare dell’aurora, cercava un posto dove sostare. Evitava le città ed i paesi grandi, si fermava al
mattino in alberghetti, locande, pensioncine dove mangiava, dormiva, si lavava o si faceva lavare i panni, faceva la spesa e ripartiva a sera, quando cominciava a farsi notte.
Io ascoltavo in silenzio il suo racconto, che cosa si può dire ad uno che, anche se per finta,
è morto? Nulla.
La luna era giunta nel suo corso quasi alle nostre spalle. Paolo aveva smesso di parlare da
non so quanto tempo. Eravamo rimasti seduti in silenzio ciascuno con i suoi pensieri, o senza
pensieri. Nella mia testa di pensieri ce n’erano tanti, confusi, accavallati, scollegati, monchi,
tristi… dissi titubante, a bassa voce: “… e come stai ora…”. Mi rispose ridendo: “Io sto benissimo. Il tumore non so, sono c… suoi”.
Ci alzammo. Le gambe mi si erano irrigidite. Anche Paolo doveva essere nelle mie condizioni perché, come me, fece alcune flessioni per sgranchirsi. Si mise lo zaino in spalla, mi disse: “Ciao, Pietro. Auguri” e si avviò. “Auguri a te, Paolo. Ciao” risposi e rimasi a guardarlo
camminare verso la ancora lontana Sicilia.
Quando la sua figura si confuse con le ombre del mais risalii sull’automobile, feci una cinquantina di metri in retromarcia e trovai un ponticello sul fosso che mi consentì, dopo cinque
o sei avanti e indietro, di invertire il senso di marcia.
(agosto ’03)
F.B.
2