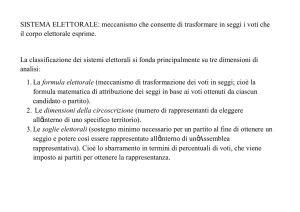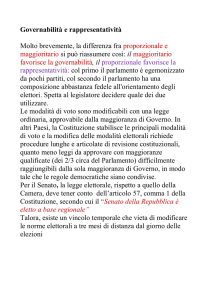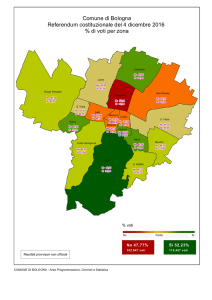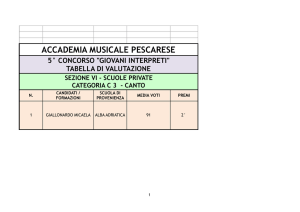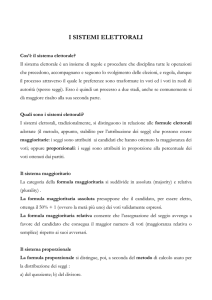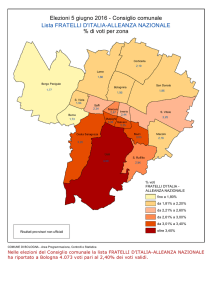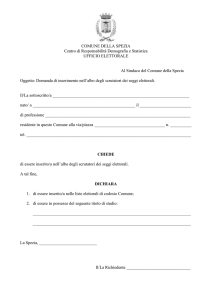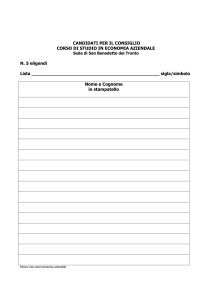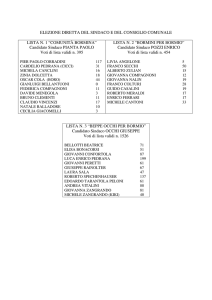MATERIALE DIDATTICO
PER L’ESAME DI SCIENZA POLITICA
INTRODUZIONE ALLA SCIENZA POLITICA
«Nessun sapere scientifico è mai nato
senza aver ordinato e precisato
il proprio vocabolario:
ché la terminologia fornisce le gambe
sulle quali una scienza poi cammina»
(Giovanni Sartori)
1. Verso una definizione di scienza politica
L’espressione “scienza politica” può essere usata in senso ampio
e non tecnico per denotare qualsiasi studio dei fenomeni e delle
strutture politiche condotto con sistematicità e con rigore,
appoggiato su un ampio e accurato esame di fatti ed esposto con
argomenti razionali. In questa accezione il termine “scienza”
viene adoperato come opposto di “opinione”, onde occuparsi
scientificamente di politica significa non abbandonarsi alle
credenze del volgo, non trinciare giudizi in base a dati non
accertati, rimettersi alla prova dei fatti.
In senso più ristretto e diventato più tecnico, l’espressione
“scienza politica” sta per “scienza empirica della politica”, ossia
indica un orientamento di studi che si propone di applicare
all’analisi del fenomeno politico, nei limiti del possibile, cioè
nella misura in cui la materia lo permette, ma con sempre
maggior rigore, la metodologia delle scienze empiriche più
sviluppate (come la fisica, la biologia, ecc.), soprattutto nella
elaborazione e nella codificazione fattane dalla filosofia
neopositivistica. Altrimenti dicendo, la scienza politica può
essere definita come lo studio empirico e generalizzante dei
fenomeni politici.
In questo senso più specifico di “scienza”, la scienza
politica si viene sempre più distinguendo da ogni ricerca rivolta
non già a descrivere e a comprendere quello che è ma a delineare
1
e quindi a prescrivere quello che deve essere, ricerca cui
conviene più propriamente e cui si suole dare ormai
comunemente il nome di “filosofia politica”.
Se si accoglie questa distinzione, le opere dei classici del
pensiero politico sono per la maggior parte opere in cui mal si
distingue ciò che appartiene alla scienza e ciò che appartiene alla
filosofia, mentre i politologi contemporanei tendono a caratterizzare le proprie opere come scientifiche per mettere l’accento
su ciò che le distingue dalla filosofia (N. Bobbio, Scienza
politica, in Dizionario di politica, diretto da N. Bobbio e N.
Matteucci, redattore G. Pasquino, Utet, Torino 1976, pp. 894-95).
2. Scienza politica e filosofia politica
Secondo Giovanni Sartori, la principale differenza tra filosofia
politica e scienza politica può essere individuata nella mancanza
di operatività o di applicabilità della prima, onde «la filosofia non
è [...] un pensare per applicare, un pensare in funzione della
traducibilità dell’idea nel fatto», mentre «la scienza è teoria che
rinvia alla ricerca, [...] applicazione, traduzione della teoria in
pratica», insomma «un progettare per intervenire, una
prasseologia» (G. Sartori, La politica. Logica e metodo in scienze
sociali, SugarCo, Milano 1979, p. 224). Ma, come rileva
giustamente Norberto Bobbio, «si potrebbe obiettare che, quanto
a operatività, non è detto che gli ideali siano stati nella storia dei
mutamenti politici meno “operativi” che i consigli degli
“ingegneri” sociali» (N. Bobbio, Scienza politica, in Dizionario
di politica, op. cit., p. 895).
In realtà, è allo stesso Bobbio che si deve la più accurata
individuazione delle differenze tra filosofia politica e scienza
politica. Scrive Bobbio: «Credo che nessuno oggi sia disposto a
chiamare scientifica nel significato pregnante di questo termine
una ricerca che non soddisfi o almeno non tenda con ogni sforzo
consapevole a soddisfare a queste tre condizioni:
a) sottoporre le proprie conclusioni a verifica empirica, o almeno
a quel tanto di verifica empirica che è possibile coi dati a
disposizione, e comunque, qualora i dati non siano sufficienti,
2
ritiri o affermi come problematiche le conclusioni raggiunte,
oppure metta in opera tutte le tecniche più accreditate e
applicabili al caso per aumentare la disponibilità dei dati, cioè per
accrescere la sua verificabilità;
b) valersi di tutte quelle operazioni mentali, come formulazioni
d’ipotesi, costruzioni di teorie, enunciazioni di leggi tendenziali,
che permettano di perseguire l’obiettivo specifico di ogni ricerca
scientifica, che è quello di dare una spiegazione del fenomeno
che si vuole indagare;
c) non pretendere di dare alcun giudizio di valore sulle cose di
cui ci si occupa e quindi di trarre prescrizioni immediatamente
utili alla prassi».
Continua Bobbio: «Queste tre condizioni fanno capo a tre
requisiti fondamentali di ogni ricerca che voglia ambire a farsi
chiamare scienza secondo il modello delle scienze per eccellenza,
le scienze naturali, e nel senso forte e nobile per cui l’età
moderna viene fatta coincidere con l’inizio, con lo sviluppo e col
trionfo della rivoluzione scientifica: a) il principio di
verificazione come criterio di validità; b) la spiegazione come
scopo; c) l’avalutatività come presupposto etico».
Considerando le tre principali forme di filosofia politica —
esemplarmente rappresentate all’inizio dell’età moderna da tre
opere che lasciarono una traccia indelebile nella storia delle idee
politiche: l’Utopia di Tommaso Moro (simbolo della filosofia
politica come ricerca della miglior forma di governo), il
Leviatano di Thomas Hobbes (simbolo della filosofia politica
come ricerca del fondamento dello Stato) e il Principe di Niccolò
Machiavelli (simbolo della filosofia politica come ricerca della
natura della politica) —, «si può osservare che a ciascuna fa
difetto almeno una delle caratteristiche della scienza politica, o,
con altre parole, nessuna delle tre adempie a tutte le condizioni di
una ricerca che possa dirsi a buon diritto scientifica. La filosofia
politica come teoria della miglior forma di governo è orientata
secondo valori ed ha carattere nettamente e consapevolmente
prescrittivo: non è avalutativa e non pretende di esserlo. […]
Nella filosofia politica come teoria del fondamento dello stato e
3
quindi dell’obbligo politico l’operazione principale e
caratterizzante non è la spiegazione ma la giustificazione,
intendendosi per “giustificazione” l’operazione mediante la quale
si qualifica un comportamento come (moralmente) lecito o
illecito, il che non si può fare se non richiamandosi a valori, o a
regole date che alla loro volta sono espressioni di valori. […]
Infine il problema della filosofia politica come ricerca della
natura della politica si sottrae ad ogni possibile verifica empirica
nella misura in cui pretende di determinare l’essenza della
politica, in quanto appunto l’essenza è per definizione ciò che sta
al di sotto o al di là dei fenomeni, delle apparenze, e che i
fenomeni stessi presuppongono per poter essere analizzati e
interpretati» (N. Bobbio, Considerazioni sulla filosofia politica,
«Rivista italiana di scienza politica», aprile 1971, pp. 370-71).
Secondo l’impostazione di Bobbio, il trattamento
filosofico è caratterizzato da almeno uno dei seguenti elementi:
1) un criterio di verità che non è la verificazione ma semmai la
coerenza deduttiva; 2) un intento che non è la spiegazione ma
piuttosto la giustificazione; 3) la valutazione come presupposto e
come scopo. Per il primo rispetto il trattamento filosofico non è
empirico; per il secondo si caratterizza come normativo o
prescrittivo; e per il terzo si precisa come un trattamento
valutativo e assiologico. I criteri costitutivi del metodo
scientifico, che sono il rovescio di quelli del trattamento
filosofico, consistono invece: 1) nel principio di verificazione; 2)
nella spiegazione; 3) nella avalutatività (G. Sartori, La politica.
Logica e metodo in scienze sociali, SugarCo, Milano 1979, pp.
218-19).
3. Considerazioni sul concetto di “scienza”
Come si è detto, l’accezione più comune e meno controversa di
scienza politica è quella che permette di identificare come
scienza politica distinta dalla filosofia ogni analisi del fenomeno
politico che si valga, nei limiti in cui ciò è possibile, delle
tecniche di ricerca proprie delle scienze empiriche, soprattutto
nella elaborazione fattane dalla filosofia neopositivistica.
4
Movimento filosofico-scientifico articolato e complesso, il
neopositivismo riflette la “crisi di verità” che ha colpito la
scienza tra il XIX e il XX secolo, quando si consuma il definitivo
passaggio dal paradigma scientifico empiristico-meccanicistico
— basato sull’idea che a partire dall’esperienza sia possibile
raggiungere la conoscenza della realtà oggettiva, delle leggi
naturali che regolano i fenomeni, intese come leggi
deterministiche in cui la causa determina con certezza l’effetto —
ad un nuovo paradigma scientifico, che alla ricerca di leggi
causali “certe” e “vere” sostituisce la spiegazione condizionale
del tipo “se….allora”, caratterizzandosi per l’accoglimento dei
principi del pluralismo scientifico e della connaturata parzialità
di ogni spiegazione di tipo teorico.
Il fatto è che vedere non è conoscere; cioè, noi non
possiamo attestarci sulla presunzione che ciò che può essere
osservato sia oggetto di conoscenza certa e unanime (o
consensuale): se così fosse non avremmo alcun bisogno di teorie
(intese come ipotesi di spiegazione della realtà), ma avremmo
soltanto problemi di accumulazione di dati osservativi, di sempre
maggiori informazioni. La scienza cresce anche per
accumulazione, ma non esiste conoscenza che non sia allo stesso
tempo anche interpretazione, e i fatti non si prestano a
interpretazioni univoche (poiché altrimenti non ci sarebbe alcuna
differenza tra teoria e realtà), ma autorizzano interpretazioni
pluralistiche e concorrenziali: ognuno di noi, in altri termini,
guardando alla stessa realtà, ne coglie aspetti diversi; di qui
l’insufficienza delle prospettive meramente incrementalistiche
(quelle che credono, positivisticamente, in una crescita continua
della conoscenza attraverso la semplice accumulazione di dati) e
la necessità di prendere atto della connaturata parzialità che
inerisce a qualsiasi spiegazione di tipo teorico, nel senso che ciò
che possiamo chiedere a una teoria non è la “verità”, quanto
piuttosto il maggior grado possibile di corrispondenza alla realtà
(anche perché ogni teoria è storicamente determinata dal livello
di conoscenze raggiunto nell’epoca in cui sorge).
5
4. Considerazioni sul concetto di “politica”
Oggi più di ieri la risposta al quesito canonico “che cos’è la politica?” appare problematica e incerta, dal momento che nessun
ambito della vita associata sembra sottrarsi alla politicizzazione e
questa tendenza appare come uno dei caratteri della
contemporaneità. La percezione dell’ubiquità della politica
accentua l’imbarazzo della teoria nel definirne e delimitarne il
significato. Se tutto è politica e la politica è ovunque diventa
problematico fissarne l’ambito e i confini, e l’oggetto “politica”
sfuma nella genericità e nell’indeterminatezza.
In particolare, merita rilevare, insieme con Pier Paolo
Portinaro, che «la pretesa di una fondazione “scientifica” della
politica ha trovato il più largo riconoscimento nel momento in
cui il concetto di politica perdeva la sua univocità e si apprestava
a divenire una nozione imprecisa e controversa» (P.P. Portinaro,
La teoria politica contemporanea e il problema dello Stato, in A.
Panebianco, a cura di, L’analisi della politica, Il Mulino,
Bologna 1989, p. 324). Il risultato, come ha osservato David
Easton, uno dei maestri della politologia contemporanea, è che
«se c’è un elemento distintivo della scienza politica occidentale
esso ancora consiste nella mancanza di un accordo su come
descrivere nel modo più esauriente il suo oggetto» (D. Easton,
Passato e presente della scienza politica negli Stati Uniti,
«Teoria politica», n. 1, 1985, p. 95).
Come è noto, sotto il profilo lessicale le ascendenze del
termine “politica” appaiono inequivocabilmente legate al titolo
dell’omonima opera aristotelica del IV secolo a.C. (Tà Politiká) e
alla famiglia di termini derivati da pólis. Come mette bene in
evidenza G. Sartori, «oggi siamo soliti distinguere tra politico e
sociale, tra Stato e società. Ma queste sono distinzioni e
contrapposizioni che si consolidano, nel loro significato attuale,
soltanto nel XIX secolo. […] Se per Aristotele l’uomo era un
“animale politico” (zoon politikón), la sottigliezza che spesso ci
sfugge è che a questo modo Aristotele […] esprimeva la
concezione greca della vita. Una concezione che faceva della
polis l’unità costitutiva (inscomponibile) e la dimensione
6
compiuta (suprema) dell’esistenza. Nel vivere “politico”, e nella
“politicità”, i greci non vedevano una parte, o un aspetto, della
vita: ne vedevano il tutto e l’essenza. […] Pertanto non è esatto
dire che Aristotele ricomprendeva la socialità nella politicità. In
verità i due termini erano per lui un termine solo: e nessuno dei
due si risolveva nell’altro per la semplice ragione che “politico”
sta per dire, insieme, tutte e due le cose. Non a caso Tommaso
d’Aquino ha autorevolmente tradotto zoon politikón con
“animale politico e sociale”, osservando che “è proprio della
natura dell’uomo che egli viva in una società di molti”».
Quanto più ci si allontana dal formato della polis e della
piccola città-comunità, tanto più gli agglomerati umani
acquistano una strutturazione verticale, gerarchica. Questa
verticalità era a tal punto estranea all’idea greca di politica che,
per renderne il senso, si è fatto ricorso per secoli a termini latini,
come principatus, regnum, dominium, gubernaculum. Il fatto che
tutta questa terminologia sia rifluita nella moderna nozione di
politica costituisce pertanto una sconvolgente inversione di
prospettiva. Noi trasfondiamo, oggi, la percezione della
verticalità (dell’elemento di strutturazione gerarchica) della vita
associata in una nozione che designava, in origine, la dimensione
orizzontale del vivere collettivo (G. Sartori, Politica, in Elementi
di teoria politica, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 241-45, passim).
Chi per primo intuisce che le nuove realtà dei moderni non
possono essere comprese con il vocabolario degli antichi è
Niccolò Machiavelli. Non a caso, la parola “politica” non
compare mai nel Principe, mentre egli usa frequentemente il
termine “Stato” e parla di un principe che esercita un “dominio”;
e il dominio è l’opposto della politica intesa, alla maniera dei
greci, come dimensione orizzontale del vivere collettivo. Quel
che più conta, però, è che Machiavelli è il primo a sostenere la
netta separazione e differenziazione della politica dalla morale e
dalla religione e ad affermare con forza, per tale via, l’autonomia
della politica. Per lui, come ben sottolinea Sartori, «moralità e
religione sono sì ingredienti essenziali della politica: ma a titolo
di strumenti. “Volendo un principe mantenere lo stato, è spesso
7
forzato a non essere buono”, ad operare “contro alla fede, contro
alla carità, contro all’umanità, contro alla religione”. La politica è
politica; tale per via di un imperativo che è proprio della politica.
Machiavelli non dichiara soltanto la diversità della politica dalla
morale; approda anche ad una vigorosa affermazione di
autonomia: la politica ha le sue leggi, leggi che il politico “deve”
applicare. Nel senso sopra precisato è dunque esatto che
Machiavelli, non Aristotele, “scopre la politica”» (G. Sartori,
Politica, in Elementi di teoria politica, cit., pp. 246-47).
Ciò che si chiama autonomia della politica non è altro che
il riconoscimento che mentre il criterio in base al quale si giudica
un’azione come moralmente buona o cattiva è il rispetto di una
norma il cui comando è considerato come categorico,
indipendentemente dal risultato dell’azione (“fai quel che devi e
avvenga quel che può”), il criterio in base al quale si giudica
un’azione come politicamente buona o cattiva è puramente e
semplicemente il risultato (“fai quel che devi perché avvenga
quel che vuoi”). I due criteri sono incommensurabili: questa
incommensurabilità viene espressa mediante l’affermazione che
in politica vale la massima “il fine giustifica i mezzi” (una delle
più convincenti interpretazioni di questa contrapposizione è
quella fornita da Max Weber, che ha operato una distinzione fra
l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità) (N.
Bobbio, Politica, in Dizionario di politica, cit., p. 735).
A partire dal XVI secolo cominciò, dunque, a delinearsi un
nuovo paradigma, incentrato su una nuova costellazione di
concetti, in primis quelli di “sovranità” e di “stato”. Non solo, ma
«tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo […] il concetto di
politica assunse un nuovo significato e con esso cambiarono la
concezione e il ruolo della scienza o arte [della politica]. Dopo
essere stata considerata per tre secoli la più nobile tra le scienze
umane, la politica emerse dalla rivoluzione come un’attività
ignobile, depravata e sordida: non più l’arma per combattere la
corruzione, ma l’arte di adattarsi a essa» (M. Viroli, Dalla
politica alla ragion di stato, Donzelli, Roma 1994, p. VII).
Dunque, possiamo dire che varia la competenza della
8
politica a seconda dei tempi e dei luoghi: aspetti della vita che un
giorno erano ritenuti politici non lo sono più oggi, e viceversa. Il
risultato è che, nel nostro tempo, il termine “politica” ha assunto
un’eccedenza di significati tra loro non conformi e talora assai
divaricati. «Oggi la parola è sulla bocca di tutti — commenta
ancora Sartori — ma non sappiamo più pensare la cosa. Nel
mondo contemporaneo la parola si spreca, ma la politica soffre di
crisi di identità» (G. Sartori, Elementi di teoria politica, cit., p.
252).
A questo punto, ci si potrebbe domandare, insieme con
Silvano Belligni: a che cosa si devono la crisi di identità e l’ambiguità crescente della categoria di politica? Secondo la
posizione che potremmo definire storicista o contestualista, il
termine “politica” «assume significati diversi perché rappresenta
“cose” diverse, allude a realtà inconfrontabili, che cambiano a
seconda dei contesti storici e dei milieux culturali». Agli antipodi
di questa posizione si colloca il punto di vista di quanti
sostengono che «il concetto di “politica” è generalizzabile e
valido sub specie aeternitatis […] che, quale che sia l’epoca e il
luogo a cui ci riferiamo e quali che siano le forme imperanti di
esercizio del potere e di relazioni sociali, se ne può sempre
estrarre e isolare via comparazione un nucleo di elementi
invarianti, un insieme di proprietà che si ritrovano in tutte le
comunità umane organizzate, […] la polis e l’impero, il sistema
feudale e comunale e lo stato-nazione, le società tradizionali e
quella industriale e postindustriale, le piccole comunità
dell’antichità e i grandi aggregati moderni». Secondo questa
prospettiva, insomma, «si deve ritenere che vi sia al fondo [del
concetto di “politica”] un nucleo generalizzabile che accomuna,
al di là di peculiarità contingenti, tutte le epoche storiche e tutte
le esperienze umane, e che sia possibile identificarlo: come un
serpente, la politica cambia nel tempo la propria pelle, ma
mantiene inalterata la propria sostanza interiore, la propria logica
strutturale» (S. Belligni, Cinque idee di politica. Concetti,
modelli, programmi di ricerca in scienza politica, Il Mulino,
Bologna 2003, pp. 19-22, passim).
9
In generale si può dire, insieme con Angelo Panebianco,
che «esiste una tendenza prevalente, nella scienza politica,
consistente nell’enfatizzazione di due aspetti della politica: 1) il
fatto che la politica ha a che fare con decisioni “collettive” o
“collettivizzate”, ossia con decisioni i cui effetti ricadono, sia
pure in modi e con intensità differenziate, sull’intera collettività e
che sono vincolanti per tutti coloro che ne fanno parte; 2) il fatto
che la politica rinvia comunque a un contesto in cui è sempre
presente, almeno sullo sfondo, almeno potenzialmente, la
possibilità del ricorso alla coercizione fisica, all’uso della forza».
«Quest’ultimo punto — continua Panebianco — è cruciale,
perché rivela il debito contratto dalla scienza politica nei
confronti di una specifica tradizione intellettuale: quella del
“realismo politico”. […] La politica ha a che fare, per questa
tradizione, con quella particolare forma di potere (in quanto
distinta da altre forme di potere sociale) cui è associato il
monopolio tendenziale dell’uso della forza. Ciò dà ai detentori
del potere politico una collocazione normalmente sovraordinata
rispetto ai detentori di altre forme di potere, mentre conferisce ai
conflitti che si accendono nella sfera politica una valenza
particolare: dai loro esiti dipendono decisioni che si impongono
con forza vincolante sulla collettività. È questa visione della
politica che la scienza politica recepisce, per lo più, dalla
tradizione del realismo politico» (A. Panebianco, Scienza della
politica, cit., pp. 617-18).
5. Le diverse accezioni del termine “politica”
Nella tradizione del pensiero politico che da Aristotele giunge
fino ai nostri giorni, il sostantivo “politica” significa spesso
riflessione sul governo della città o dello Stato e indica le opere a
tali questioni dedicate: non designa dunque direttamente un agire,
ma l’attività teoretica che lo interpreta e/o lo orienta. È in questo
senso, oggi invero un po’ desueto, di riflessione scientifica o
filosofica sulla cosa pubblica che, per esempio, va inteso il
termine nell’uso che ancora ne propongono gli Elementi di
politica di Benedetto Croce, la Introduzione alla politica di
10
Maurice Duverger o il Dizionario di politica di Bobbio e
Matteucci.
Ciò premesso, nel linguaggio odierno, il termine “politica”
viene declinato in almeno altre tre diverse accezioni. Per un
verso, esso designa una classe molto generale ed astratta di
pratiche e di rapporti sociali, una specie del comportamento
umano, una prassi, “una particolare maniera d’agire” (Max
Weber): il fare politica (come per esempio quando si afferma che
la politica è una cosa sporca, o si ammonisce: qui non si fa
politica, si lavora). Altre volte, il termine “politica” allude ad uno
spazio, una sfera, una sede, un campo, un ambito, un dominio
particolare (seppure dagli incerti e mutevoli contorni) in cui
quella precedente classe di azioni ha tipicamente corso: è in
questo senso, ad esempio, che si dichiara di volersi impegnare in
politica, o si contrappone la politica alla società, il politico al
sociale. In altri casi, infine, il termine si riferisce a più specifiche
e osservabili attività di formulazione e di esecuzione di
programmi e di decisioni pubbliche, come nelle espressioni
politica estera, politica economica, politiche sociali e simili.
Così stando le cose, è comprensibile e opportuno che per
indicare questi possibili livelli del discorso si ricorra a termini
differenziati. È quanto è avvenuto ad esempio nella lingua
inglese, che ha visto differenziarsi il suo lessico attraverso la
separazione tra politics, che corrisponde tendenzialmente (anche
se non completamente) alla prima e più estesa accezione del
termine italiano (quella prasseologica, che vede la politica come
una modalità dell’agire sociale), polity (o the political, anche se
si tratta di un’espressione non molto diffusa), che coincide grosso
modo con la seconda accezione (cioè con l’idea di politica come
sfera territorialmente e costituzionalmente definita e come
comunità organizzata al suo interno), e policy, che corrisponde al
terzo significato.
Nel nostro lessico invece (ma lo stesso può dirsi per il
francese politique e il tedesco Politik) ha continuato a dominare
fino a tempi recenti un unico termine, alimentando imprecisione
e malintesi. Un modo per ridurre l’ambiguità può essere allora
11
quello di mantenere il termine politica per designare una
modalità dell’agire sociale, il fare politica (la politics); di far
ricorso all’aggettivo sostantivato (il) politico (polity, the
political) per designare il campo di svolgimento, l’arena, il teatro
dell’azione (con speciale riguardo agli aspetti istituzionali),
riservando infine la locuzione politica pubblica, o il sostantivo
plurale le politiche, per indicare specifici corsi d’azione
governativa di natura settoriale (policy-policies).
Va da sé che sarebbe inutile ricercare una linea di
demarcazione troppo netta (e una uniformità d’uso) tra questi
codici linguistici, tra i quali intercorrono reciproci rimandi e
sovrapposizioni. Nondimeno, la distinzione lessicale è opportuna
perché consente di ridurre la polisemia dei termini con cui lavora
il politologo e di conferire maggiore precisione all’argomentazione. Si vedrà così che la maggior parte degli studiosi intende
per politica una prassi intenzionata (ossia dotata di scopi) che
struttura campi di svolgimento particolari. In altri termini, la
politica viene intesa come una modalità di (inter)azione che si
differenzia per certe caratteristiche (da identificare) da altri tipi di
agire sociale, a fronte della quale il politico si pone come
l’ambito derivato, lo spazio di esecuzione, il campo che
dall’azione politica viene variabilmente conformato e in cui si
muovono diversi tipi di attori e di istituzioni (S. Belligni, Cinque
idee di politica, cit., pp. 23-26, passim).
6. La nascita della scienza politica
La scienza politica contemporanea deve la sua nascita
all’incontro fra un processo storico e un’innovazione culturale.
Il processo storico è rappresentato dalla democratizzazione
delle società occidentali. Si può dire che così come la sociologia
nasce per fronteggiare cognitivamente l’avvento della società
industriale, allo stesso modo la scienza politica si afferma, a
cavallo fra Ottocento e Novecento, per rispondere alla sfida
intellettuale
rappresentata
dalla
democrazia.
La
democratizzazione delle società europee, nel corso
dell’Ottocento, rende progressivamente obsolete le vecchie
12
“scienze dello stato”. Con la democratizzazione la politica
“deborda” dai confini dello stato: l’identificazione fra “stato” e
“politica”,
propria
dell’età
pre-democratica,
perde
progressivamente di credibilità. Il problema della democrazia
diventa così il problema centrale per gli studiosi di politica.
Decifrare (e, nel loro caso, anche “demistificare”) la democrazia
è, ad esempio, il compito principale affrontato dalle teorie degli
elitisti italiani (Gaetano Mosca in primo luogo, ma anche
Roberto Michels e Vilfredo Pareto) cui, correttamente, si fa per
lo più risalire l’atto di nascita della scienza politica
contemporanea (la data di nascita convenzionale è il 1896, anno
della prima edizione degli Elementi di scienza politica di
Gaetano Mosca).
L’innovazione culturale è rappresentata invece dall’impulso che il positivismo, nell’Ottocento, e il neopositivismo, nel
Novecento, danno alle scienze sociali empiriche, sulla base dell’idea che sia possibile applicare al campo delle azioni e delle
istituzioni sociali metodi di studio, se non identici, quanto meno
analoghi a quelli sperimentati con successo nello studio dei
fenomeni naturali. È nel corso di questo sommovimento che
l’analisi della politica dà segni inequivocabili di volersi
emancipare dai suoi intensi legami con la riflessione filosofica e
giuridica per riorientarsi verso un modo di procedere più
sistematico e circoscritto nei temi da indagare, empirico nei
metodi di analisi e rigoroso nelle tecniche di controllo, meno
vincolato dalle ipoteche giuridiche e normative dell’allora
imperante “dottrina dello Stato” (A. Panebianco, Scienza della
politica, cit., p. 617; S. Belligni, Cinque idee di politica, cit., pp.
7-8).
7. I paradigmi del politico
In un secolo di scienza politica non si intravede, se non contingentemente e illusoriamente, una prospettiva interpretativa in
grado di egemonizzare la disciplina e di definirne l’ortodossia;
non emerge un programma di ricerca capace di orientare univocamente e stabilmente la formazione di teorie scientifiche cumu-
13
lative e di indicare alla comunità dei politologi in cosa credere,
come lavorare, cosa includere e cosa escludere dal campo dei
problemi e delle ipotesi di lavoro. Sembra lecito affermare che,
nel corso di tutto il Novecento, la scienza politica, diversamente
da altre scienze sociali, resta priva di un punto di vista dominante
condiviso dal collegio invisibile dei suoi cultori. D’altro canto,
dire che non si è affermato un paradigma politologico dominante
non equivale a sostenere che la scienza politica sia rimasta una
disciplina non-paradigmatica e prescientifica, ma semplicemente
prendere atto del fatto che essa si è strutturata e istituzionalizzata
nel corso dei decenni come una disciplina multi paradigmatica
(S. Belligni, Cinque idee di politica, cit., pp. 8-13).
8. Il paradigma statocentrico
Contrariamente alla tradizione classica, per la quale il “politico”
coincide col “sociale”, nell’età moderna la sfera della politica si
sopraeleva e si restringe, nel senso che viene ricondotta all’idea
di potere, di comando e, in ultima analisi, viene fatta coincidere
con «l’attività e l’insieme delle attività che hanno in qualche
modo come termine di riferimento la polis, cioè lo stato» (N.
Bobbio, Politica, cit., p. 728).
La riduzione del problema della politica a quello dello
stato sovrano, ossia l’idea che lo stato territoriale sia il parametro esclusivo, o comunque essenziale e irrinunciabile, dell’agire politico, risale agli sviluppi cinque-seicenteschi della teoria
politica moderna, è ricorrente nella tradizione del pensiero
politico e caratterizza quello che potremmo definire (non senza
una qualche forzatura) il paradigma statocentrico (o statalista).
9. Il power approach
Distaccandosi, in misura significativa, dalla linea interpretativa
tesa a porre l’entità statale come chiave di volta della politica,
alcuni studiosi hanno stemperato l’enfasi sull’autonomia e
sull’unitarietà dello stato a vantaggio di una più attenta considerazione sociologica delle dinamiche dei conflitti tra gruppi
14
sociali ed élites contrapposte. L’essenza della politica e la sua
finalità ultima vengono individuate, in questa prospettiva, nella
lotta incessante per il potere. Il rimando d’obbligo è qui alla
celebre definizione weberiana, secondo la quale per politica si
deve intendere, per l’appunto, «la direzione, oppure l’attività che
influisce sulla direzione di un’associazione politica, cioè, oggi, di
uno stato», o più perspicuamente «l’aspirazione a partecipare al
potere o a influire sulla ripartizione del potere, sia tra gli stati sia,
nell’ambito di uno stato, tra i gruppi di uomini compresi entro i
suoi limiti». E per stato, scrive ancora Weber, «si deve intendere
un’impresa istituzionale di carattere politico nella quale, e nella
misura in cui, l’apparato amministrativo avanza con successo una
pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima, in vista
dell’attuazione degli ordinamenti» (M. Weber, Economia e società, Milano, Comunità 1971, pp. 47-48).
Quello del potere, insomma, costituisce in questa chiave se
non il solo, comunque il principale perno concettuale su cui ruota
l’analisi di tutti i fenomeni e i comportamenti politici. «Nell’intero lessico della scienza politica — annotano due tra i più illustri
fautori del power approach, H.D. Lasswell e A. Kaplan — quello
di potere è forse il concetto più fondamentale: il processo politico
è la formazione, la distribuzione e l’esercizio del potere». Non
diversamente, Bobbio afferma perentoriamente: «Non c’è teoria
politica che non parta in qualche modo direttamente o indirettamente da una definizione di “potere” o da un’analisi del fenomeno del potere». E ancora: «Lo stato può essere definito come
detentore del potere politico, e quindi come mezzo e fine dell’azione politica degli individui e dei gruppi in conflitto fra loro, in
quanto è l’insieme delle istituzioni che in un determinato
territorio dispongono, e sono in grado di valersi al momento
opportuno, del monopolio della forza fisica per risolvere i
conflitti fra gli individui e fra i gruppi...in quanto ne possiede il
monopolio» (N. Bobbio, Stato, governo, società, Einaudi, Torino
1985, pp. 66-67).
Anche chi consenta sulla stretta interdipendenza, o addirtitura sull’interscambiabilità, tra la nozione di politica e quella di
15
potere non può tuttavia ignorare che quest’ultima è stata impiegata nella letteratura politologica e filosofica con diversi significati e accentuazioni, anche notevolmente difformi, a cui mette
conto di accennare almeno di passata. Si possono distinguere tre
concezioni fondamentali del potere:
1) la concezione sostanzialistica: il potere viene concepito come
una cosa che si possiede e si usa alla stregua di un qualsiasi altro
bene, come «l’insieme dei mezzi che permettono di conseguire
gli effetti voluti» (B. Russell) (mezzi che possono essere doti
naturali, come la forza e l’intelligenza, oppure acquisite, come la
ricchezza);
2) la concezione soggettivistica: per “potere” si intende non la
cosa che serve a raggiungere lo scopo, ma la capacità del soggetto di ottenere certi effetti, per cui si dice che «il fuoco ha il
potere di fondere i metalli» allo stesso modo che il sovrano ha il
potere di fare le leggi (J. Locke);
3) la concezione relazionale: per “potere” si deve intendere una
relazione tra due soggetti di cui uno impone all’altro la propria
volontà inducendolo ad agire in un modo in cui questi altrimenti
non agirebbe (R. Dahl) (S. Belligni, Cinque idee di politica, cit.,
pp. 73-78, passim).
La concezione più accreditata è senz’altro quella relazionale. Come fenomeno sociale, il potere è generalmente inteso
come una relazione tra azioni (potere attuale) o tra disposizioni
ad agire (potere potenziale). Nella seconda accezione è la
capacità di un attore di determinare la condotta di un altro attore;
nella prima è la determinazione da parte di un attore della
condotta di un altro attore. Si tratta evidentemente della stessa
nozione, coniugata come facoltà ovvero come esercizio.
Dire che il potere è una relazione di determinazione (attuale o potenziale) tra azioni equivale a dire che tra quelle azioni
corre un rapporto di “causa”. Difatti, è generalmente riconosciuto
che il potere sia una specie di causazione sociale. La nozione di
causa, in questo caso, va interpretata non in senso stretto (o deterministico), ma in senso probabilistico: affermare che A esercita
potere su B è affermare che l’azione x di A rende molto proba-
16
bile l’azione y di B.
Secondo alcuni autori, poi, qualsiasi rapporto di causazione tra azioni può definirsi potere, indipendentemente dal “senso” che gli attori implicati nella relazione, e in particolare l’attore
che esercita potere, attribuiscono al loro agire. Questa concezione
è però in netto contrasto con gli usi tecnici dominanti del concetto di potere, a cominciare dalla definizione classica di Weber.
Secondo tali usi la nozione di potere si àncora a uno specifico
orientamento di senso, che accompagna l’azione dell’attore che
esercita potere: l’intenzione, ossia la finalizzazione, da parte di
A, della propria azione x, per il conseguimento dell’azione y di
B. Conviene dunque definire il potere non già come causazione
sociale tout court, bensì come causazione sociale intenzionale.
Tuttavia, la suddetta conclusione non è ancora pienamente
soddisfacente, perché esclude dall’ambito del potere rapporti tra
azioni che, pur essendo privi del requisito dell’intenzione, sono
ciò nonostante molto simili alla causazione sociale intenzionale:
si pensi a quelle fattispecie di imitazione sociale non intenzionata
che sono tuttavia nell’interesse degli attori imitati o, ancor più
importante, si pensi alla cosiddetta regola delle reazioni previste,
su cui ha brillantemente richiamato l’attenzione C.J. Friedrich
(Man and His Government, 1963). Questa regola allude al fatto
che i soggetti operanti in un campo sociale (=una pluralità più o
meno numerosa di attori compresenti e interagenti) scontano
anticipatamente il potere degli altri attori, anche in mancanza di
un suo concreto esercizio; intesa nel suo significato originario
(anticipazione delle reazioni altrui alla propria azione), o nella
accezione più ampia che di essa ha dato H. Simon (non si
anticipano solo le reazioni alle proprie azioni, ma anche le azioni
altrui, per cui la propria azione è in realtà presa avendo riguardo
non solo alle sue dirette conseguenze, ma anche alle previste
iniziative altrui), essa dà nuovo significato alla distinzione tra
potere coercitivo e potere consensuale e permette di superare la
distinzione tra potere attuale e potere potenziale.
Sembra dunque opportuno allargare il campo del potere
anche alle relazioni nelle quali l’azione conseguente y di B,
17
benché causata in modo non intenzionale dall’azione x di A,
corrisponda tuttavia a un interesse di A. Il potere può dunque
essere definito come causazione sociale intenzionale e/o
interessata (M. Stoppino, Potere e teoria politica, Giuffrè,
Milano 2001, passim).
A questo punto è necessario fare un passo ulteriore e
interrogarsi più direttamente sulla natura del potere politico.
Infatti, anche se si ritiene che la politica sia essenzialmente
potere e lotta per il potere, non ne discende necessariamente che
ogni specie di potere sia politico. Anche se molto spesso con il
termine “potere” si intende in effetti alludere tout court al potere
politico, quest’ultimo va piuttosto considerato come una species
del genus potere, diversa da altre, con le quali è bensì in rapporto
spesso simbiotico, ma da cui va tenuto analiticamente distinto.
Ciò richiede di mettere a fuoco la differenza specifica del potere
politico da quelle forme di potere che politiche non sono.
Allo scopo di rinvenire l’elemento specifico del potere
politico conviene adottare il criterio di classificazione delle varie
forme di potere che si fonda sui mezzi di cui si serve il soggetto
attivo del rapporto per condizionare il comportamento del
soggetto passivo. In base a questo criterio si possono distinguere
tre tipi principali di potere:
1) il potere economico: è quello che si vale del possesso di certi
beni, necessari o ritenuti tali, in una situazione di scarsità, per
indurre coloro che non li posseggono a tenere una certa condotta,
consistente principalmente nell’esecuzione di un certo tipo di
lavoro;
2) il potere ideologico: è quello che si vale del possesso di certe
forme di sapere, dottrine, conoscenze e/o informazioni per esercitare un’influenza sul comportamento altrui;
3) il potere politico: è quello che si vale del possesso degli strumenti attraverso i quali si esercita la forza fisica (le armi d’ogni
specie e grado); è il potere coattivo per eccellenza, quello cui tutti
gli altri sono in qualche modo subordinati.
Che la possibilità di ricorrere alla forza sia ciò che distingue il potere politico dalle altre forme di potere non vuol dire che
18
il potere politico si risolva nell’uso della forza: l’uso della forza è
la condizione necessaria per la definizione del potere politico,
non ancora la condizione sufficiente. Non qualunque gruppo
sociale in grado di usare anche con una certa continuità la forza
fisica (un’associazione a delinquere, un gruppo sovversivo, ecc.)
esercita un potere politico. Ciò che caratterizza il potere politico
è l’esclusività dell'uso della forza rispetto a tutti i gruppi che
agiscono in un determinato contesto sociale, esclusività che è il
risultato di un processo svolgentesi in ogni società organizzata
verso la monopolizzazione del possesso e dell’uso dei mezzi con
cui è possibile esercitare la coazione fisica. Questo processo di
monopolizzazione va di pari passo con il processo di criminalizzazione e di penalizzazione di tutti gli atti di violenza che
non siano compiuti da persone autorizzate dai detentori e
beneficiari di questo monopolio.
Chi ha il diritto esclusivo di usare la forza su un determinato territorio è il sovrano. Siccome la forza è il mezzo più
risolutivo per esercitare il dominio dell’uomo sull’uomo, chi
detiene l’uso di questo mezzo ad esclusione di tutti gli altri entro
certi confini è colui che entro quei confini ha la sovranità intesa
come summa potestas, come potere supremo. Se l’uso della forza
è la condizione necessaria del potere politico, solo l’uso
esclusivo di questo potere ne è anche la condizione sufficiente.
Nell’ipotesi hobbesiana che sta a fondamento della teoria
moderna dello stato, il passaggio dallo stato di natura alla società
civile, ovvero dallo stato apolitico allo stato politico, avviene
quando gli individui rinunciano al diritto di usare ciascuno la
propria forza (diritto che li rende uguali nello stato di natura) per
rimetterlo nelle mani di un’unica persona o di un unico corpo (il
Leviatano, cioè il sovrano) che d’ora in poi sarà il solo autorizzato a usare la forza nei loro riguardi.
La supremazia della forza fisica come strumento di potere
rispetto a tutte le altre forme di potere appare evidente ove si
consideri che mentre vi sono gruppi politici organizzati che
hanno potuto consentire la demonopolizzazione del potere ideologico e di quello economico (nello stato liberal-democratico, ad
19
esempio, v’è libertà del dissenso e pluralità dei centri di potere
economico), nessun gruppo sociale organizzato ha sinora potuto
consentire la demonopolizzazione del potere coattivo, perché tale
potere è quello di cui ogni gruppo sociale ha bisogno per difendersi da attacchi esterni o per impedire la propria disgregazione
interna (S. Belligni, Cinque idee di politica, cit., pp. 78-90).
Bobbio riassume nel modo seguente i tre attributi differenziali del potere politico, che a suo avviso servono a distinguerlo
dai tipi di potere non politico e che ne fanno «il potere supremo
in un determinato gruppo sociale», il potere dei poteri,
sovraordinato rispetto a tutti gli altri:
1) l’esclusività: chi lo detiene non consente che nel suo ambito di
dominio si formino gruppi che possano contrastarne il monopolio
sanzionatorio;
2) l’universalità: il detentore è il solo che può prendere decisioni
legittime di qualsiasi natura suscettibili di valere erga omnes, per
tutta la collettività;
3) l’inclusività: il detentore è legittimato ad intervenire in ogni
sfera di attività comunitaria attraverso l’ordinamento giuridico.
Nonostante possibili autolimitazioni, quello politico è perciò in
via di principio, anche se non sempre di fatto, un potere totale o
totalitario (N. Bobbio, Stato, governo, società, cit., p. 68).
Tocca, infine, ricordare Weber, il quale, dopo aver definito
il potere (Herrschaft), distinto dalla mera forza (Macht), come il
potere che riesce a condizionare il comportamento dei membri di
un gruppo sociale emettendo comandi che vengono abitualmente
obbediti in quanto il loro contenuto è assunto come massima
dell’agire, distingue tre tipi puri o ideali di potere legittimo:
1) il potere tradizionale: il motivo dell’obbedienza è la credenza
nella sacertà della persona del sovrano, sacertà che deriva dalla
forza di ciò che dura da tempo, di ciò che è sempre stato e,
poiché è sempre stato, non c’è ragione di cambiarlo;
2) il potere legale-razionale: il motivo dell’obbedienza è la
credenza nella razionalità del comportamento conforme alla
legge, cioè a norme generali ed astratte che istituiscono un
rapporto impersonale fra governante e governato;
20
3) il potere carismatico: il motivo dell’obbedienza è la credenza
nelle doti straordinarie del leader, del capo (S. Belligni, Cinque
idee di politica, cit., p. 88).
10. L’analisi sistemica della politica
Tra i diversi modi di studiare i fenomeni politici, a partire dagli
anni Cinquanta ha preso quota, nell’ambito del comportamentismo, l’approccio cosiddetto sistemico. Sulla scorta degli insegnamenti provenienti dalla biologia e dalla cibernetica, il system approach propone una strategia concettuale unificata per
tutte le scienze, sia dell’uomo che della natura, imperniata sul
concetto di “sistema”. Trattare un oggetto come un sistema significa formulare due ipotesi semplici quanto realistiche: 1) che le
condizioni dell’oggetto a un momento dato sono il prodotto di un
continuo scambio di materia ed energia con il suo ambiente; e 2)
che una modifica delle condizioni di una parte dell’oggetto avrà
conseguenze prevedibili sulle condizioni di altre parti del
medesimo oggetto.
La prima condizione mette in rilievo le relazioni tra il
sistema e l’ambiente (environment) in cui esso è immerso, dal
quale è diviso da confini (boundaries), ma con il quale effettua
continue transazioni da cui esce trasformato. Lo scambio sistema-ambiente è rappresentabile come un circuito cibernetico, ossia come un flusso continuo di immissioni (inputs) che vengono
elaborate dal sistema e convertite in emissioni (outputs): queste,
ricadendo nell’ambiente, lo modificano e consentono al processo
di ripartire ad un nuovo livello (feed-back).
La seconda parte della definizione sopra richiamata mette
in evidenza le proprietà interne di un sistema, che, in estrema
sintesi, possono essere ridotte a tre: l’interdipendenza, l’unità,
l’autoregolazione.
In base al primo di questi attributi, un sistema (si pensi al
sistema solare, o al linguaggio, o senz’altro al sistema politico) si
distingue da un aggregato, ossia da una semplice sommatoria, da
una giustapposizione o vicinanza di parti (ad esempio, da una
catasta di legname, o da un mucchio di pietre), in quanto costitui-
21
sce «un ordine le cui differenti parti si sostengono mutuamente
tutte» (Condillac). Nessuna parte del sistema può cambiare significativamente senza costringere tutte le altre, e l’intero sistema, a
modificarsi. Vedere nell’interdipendenza il criterio di individuazione di un sistema significa porre al centro della definizione non
già i singoli enti e i loro attributi, ma i rapporti che li legano, la
loro sintassi.
Un sistema non è pertanto riducibile alla somma delle sue
parti e non può essere analizzato e compreso nei suoi comportamenti a partire dalle proprietà delle sue componenti, ma solo in
quanto unità-totalità.
In terzo luogo, ogni sistema è caratterizzato al suo interno
da attività di base (funzioni) che tendono a garantirne la stabilità
e la permanenza di fronte alle sollecitazioni e ai disturbi che
provengono dall’ambiente. Definiamo autoregolazione il processo omeostatico in base al quale un sistema tende a ricostituire
incessantemente il suo equilibrio e a mantenere nel tempo la sua
identità (ossia le sue funzioni fondamentali) pur in presenza di
stimoli che lo trasformano. Lo strumento fondamentale di cui un
sistema aperto (o vivente) dispone a tal fine è costituito dal meccanismo di retroazione (feed-back), in virtù del quale esso reagisce agli effetti prodotti nell’ambiente dalla sua azione precedente e si adatta al nuovo stato (S. Belligni, Cinque idee di politica, cit., pp. 117-24, passim).
In virtù della sua apparente capacità di semplificare e al
contempo di trattare unitariamente la vita politica, l’approccio
sistemico ha assunto e mantenuto a lungo una posizione
privilegiata nelle discipline politologiche. Tra gli anni Cinquanta
e i primi anni Settanta, la system analysis è divenuta se non il
paradigma dominante nella scienza politica di orientamento empirico, certamente uno strumento analitico di largo impiego,
capace di detronizzare per un lungo periodo le più blasonate
categorie di stato e di potere. Al punto che si è arrivati a sostenere che «chiunque intenda studiare scientificamente la politica
deve pensare, almeno implicitamente, che essa funziona come
una specie di sistema» (D. Easton).
22
Formulata per la prima volta da David Easton nel 1953, la
teoria sistemica della politica propone di analizzare la vita politica in chiave, per l’appunto, sistemica: la politica, secondo la
definizione datane da Easton, è «l’assegnazione imperativa di
valori per una società»; e il sistema politico è «l’insieme dei modelli di interazione attraverso cui vengono assegnati i valori in
una società e le assegnazioni vengono accettate come autoritative
dalla maggior parte delle persone della società il più delle volte».
Tracciate queste coordinate generali, esaminiamo più da
presso il sistema politico nel suo funzionamento tipico. In prima
approssimazione, il processo sistemico è schematizzabile come
un flusso stimoli-risposte, ossia come un processo di conversione
di immissioni (inputs) provenienti da un ambiente in emissioni
(outputs). La specificità del sistema politico rispetto ad altri
(sotto)sistemi risiede essenzialmente nel carattere delle sue
emissioni, vale a dire nella loro natura imperativa generalizzabile
all’intero contesto territoriale entro cui hanno corso: «Quando
parliamo di sistema politico vi includiamo tutte quelle interazioni
che riguardano l’uso di coercizione fisica legittima» (Almond e
Powell). Un sistema formula decisioni che sono qualitativamente
diverse da quelle degli altri sottosistemi, per il fatto che esse
hanno validità erga omnes, sono cioè vincolanti per la generalità
dei membri della società su cui il sistema politico ha giurisdizione. Tali ordini hanno inoltre un’elevata (per quanto variabile)
probabilità di essere accettati ed eseguiti, senza dover essere imposti con la forza, del cui monopolio legittimo pure il sistema
dispone (per inciso, si noterà che il sistema politico condivide le
proprietà che abbiamo in precedenza attribuito alle categorie di
stato e di potere politico, con le quali tale concetto è per questi
profili, ma solo per questi, interscambiabile).
Le decisioni autoritative (e le azioni che le realizzano) sono però il prodotto della fase terminale (di “uscita”) del processo
politico. Le fasi logicamente precedenti sono costituite dai momenti di immissione e di conversione. Il punto di avvio è dato
dagli input, che collegano “in entrata” il sistema politico al suo
ambiente e che costituiscono delle sfide a cui occorre rispondere.
23
Tali immissioni sono riducibili per astrazione a due classi di
attività fondamentali: inputs di domanda e inputs di sostegno.
Il processo politico è messo in moto quando gruppi o individui formulano una domanda politica. Le domande politiche
sono richieste più o meno generali ed esplicite di allocazioni autoritative di valori rivolte alle autorità pubbliche, che nascono
nell’ambiente di un sistema politico o al suo stesso interno (in
questo caso si dovrà parlare di withinputs, ossia di immissioni
endogene, che si formano entro le strutture del sistema politico).
Perché le domande vengano accolte e trattate dal sistema
politico è necessario che siano accompagnate da sostegno.
«Diciamo che A sostiene B quando A agisce a favore di B o
quando si atteggia favorevolmente nei confronti di B, sia
ques’ultimo una persona o un gruppo, un obiettivo, un’idea,
un’istituzione» (D. Easton). Nel primo caso si tratterà di azioni di
sostegno aperto e attivo; nel secondo caso, di atteggiamenti o
sentimenti di sostegno sommerso e passivo, che nel loro
complesso costituiscono la cultura politica (civic culture) di un
sistema. Più precisamente, il concetto di cultura politica riguarda
l’insieme degli atteggiamenti, delle credenze, dei valori politici,
delle inclinazioni psicologiche manifeste e latenti, che sul piano
cognitivo, affettivo e valutativo prevalgono in una popolazione o
in qualcuno dei suoi sottosistemi (si parlerà in tal caso di subculture), secondo modelli di distribuzione persistenti nel tempo.
Il conferimento o il ritiro del sostegno può riguardare livelli e aspetti diversi del sistema politico, gerarchicamente ordinabili, come la comunità politica, il regime, le autorità.
Per comunità politica si intende un gruppo di persone
tenute insieme dalla divisione politica del lavoro, dal fatto cioè di
condividere una comune dimensione politica di riferimento, al di
là delle specifiche tradizioni e culture che possono dividerle:
qualcosa che richiama la civitas dei Romani, o l’identità nazionale dei moderni.
Il regime invece è l’ordine costituzionale formale e materiale su cui una comunità si basa, l’insieme dei principi e delle
regole del gioco, scritte o non scritte (valori, norme e codici di
24
autorità e di comportamento) che presiedono alle interazioni
politiche in un dato spazio territoriale; per Easton, «la matrice
generale delle aspettative generalizzate entro i cui limiti le azioni
politiche sono normalmente considerate imperative».
Le autorità, infine, sono coloro che occupano i ruoli e le
strutture decisionali ai diversi livelli, in particolare (ma non
esclusivamente) quelle formali di governo: presidente, ministri,
parlamentari, alti burocrati, autorità locali.
In generale, la persistenza di un sistema politico dipende
essenzialmente dal mantenimento di un livello adeguato di sostegno, o, più precisamente, dalla capacità di amministrare e modulare i due differenti tipi di sostegno che un sistema politico ha
a disposizione: il sostegno diffuso e il sostegno specifico.
Per sostegno specifico si intende comunemente il consenso
alle autorità governanti che deriva dalla soddisfazione (effettuale
o virtuale) delle domande, o dalla realistica aspettativa che esse
saranno soddisfatte in tempi ragionevoli. Si tratta, in altri termini,
del risultato di un do ut des tra autorità politiche e destinatari o
beneficiari di provvedimenti o prestazioni pubbliche. Questa
transazione viene di regola concettualizzata (anche se non dai
teorici dei sistemi) mediante la nozione di scambio politico.
Tuttavia, l’evidenza dimostra che, a dispetto di prolungate
frustrazioni delle aspettative di soddisfacimento delle richieste
sociali molti sistemi politici hanno mantenuto un livello sufficiente di stabilità e di integrazione, senza dover ricorrere a una
repressione generalizzata e soprattutto senza crollare. La tolleranza nei confronti di esiti politici immediati non desiderati può
essere messa in relazione a un attaccamento di fondo alla comunità politica e al regime che fa premio sulla valutazione puntuale
dei benefici ricevuti e che è concettualizzabile nei termini di sostegno diffuso. Esso consiste nel credito, nel capitale di legittimità che il sistema ha accumulato, nella benevolenza e lealtà
accordategli dai cittadini sul medio-lungo periodo, indipendentemente dall’efficacia delle sue prestazioni quotidiane. La categoria di sostegno diffuso chiama evidentemente in causa la già
evocata dimensione culturale della politica, che nell’ambito della
25
teoria sistemica ha ricevuto una particolare attenzione soprattutto
ad opera di Gabriel Almond (S. Belligni, Paradigmi del politico,
cit., pp. 137-45, passim).
Tocca comunque osservare che, dopo il successo iniziale,
l’approccio sistemico ha progressivamente perso la sua centralità
nell’ambito degli studi politici, in ragione della difficoltà di
utilizzare il sofisticato schema eastoniano nelle ricerche empiriche, ma soprattutto a causa della crisi del comportamentismo.
Quando il comportamentismo si è esaurito, quando l’azione
politica ha ricominciato a essere concepita come azione intenzionale, guidata da motivi e scopi, invece che come “comportamento”, meramente reattivo a stimoli esterni, l’approccio sistemico ha perso appeal. La scienza politica si è allora indirizzata alla
ricerca di strumenti più adeguati allo studio dell’“azione dotata di
senso”.
11. L’approccio della scelta razionale
Il tentativo più ambizioso di superare l’indeterminatezza e la
frammentazione delle scienze politiche e di fornire una visione
unitaria e integrata dell’agire politico nel quadro di una più generale teoria dell’azione è quello basato sull’applicazione degli
strumenti e dei metodi dell’economista al processo decisionale
collettivo (o non di mercato).
Secondo questo indirizzo metodologico, economia e politica rimandano a una medesima teoria generale dell’azione sociale ed è pertanto non solo legittimo, ma necessario applicare alla seconda i postulati e i concetti propri della prima, nella sua formulazione classica e/o neoclassica. Al pari della scienza economica, cioè, anche la scienza politica può e deve basarsi sulle nozioni di equilibrio, di domanda e offerta, di scambio, di concorrenza, ricorrendo nell’analisi delle scelte collettive (politiche) alle
tecniche sperimentate nell’analisi dei processi di accordo volontario tra gli individui (di mercato).
Questo approccio viene comunemente considerato come
una specificazione della teoria della scelta razionale. Entrata
nella scienza politica grazie ai lavori pionieristici di autori come
26
A. Downs, M. Olson e W.H. Riker, la teoria della scelta razionale
ha guadagnato nell’ultimo trentennio una posizione di primo
piano, se non addirittura egemone, nella politologia contemporanea (oltre che in altre discipline sociali), grazie al rigore formale e all’elegante parsimonia del metodo razionale-deduttivo.
I presupposti assiomatici che caratterizzano l’approccio
della scelta razionale sono stati precocemente presentati e discussi con rigore sistematico da Anthony Downs, in un lavoro “seminale” risalente alla metà degli anni Cinquanta (Teoria economica
della democrazia), e successivamente ripresi, sviluppati e precisati da più autori.
A fondamento di tutta la costruzione sta l’assunto pre-teorico della scomponibilità del processo politico fino al livello della
scelta individuale, per cui l’individuo va considerato come l’unità analitica di base, in politica come in economia. L’opzione per
l’individualismo metodologico si contrappone agli approcci olistici che caratterizzano parte della teoria politica tradizionale, secondo i quali gli “atomi” e le “molecole” della politica sono costituiti non da individui singoli o aggregati in gruppi, ma da entità primarie superiori, come stati-nazione, classi sociali, comunità naturali o storiche di vario genere.
In secondo luogo, i moventi degli attori politici vanno riferiti alla stessa struttura assiomatica utilitaristica del self-interest
che serve a interpretare l’azione economica privata, secondo cui
l’individuo è riducibile ad un insieme di preferenze, egoistiche ed
edonistiche, a una funzione di utilità. Homo oeconomicus e homo
politicus condividono la stessa logica di scelta: economia privata
(mercato) e politica pubblica (mercato politico) sono solo sistemi
diversi di vincoli e incentivi. Sotto questo profilo, appaiono
destituite di fondamento tutte quelle teorie, positive e normative,
che considerano chi fa politica (operatore o dilettante) come
benefattore disinteressato e la politica come individual-mente
rivolta a realizzare il benessere sociale, il bene comune. La
politica è, invece, il trionfo dell’egoismo edonistico, riscattato
socialmente dall’intervento della mano invisibile o, in alternativa,
di regole istituzionali esogene.
27
In terzo luogo, dalla teoria economica viene altresì mutuato e trasposto al comportamento politico l’assunto della scelta
razionale. Anche l’homo politicus, come quello oeconomicus,
impronta il suo agire alla razionalità rispetto allo scopo: il “cittadino razionale” (politico o elettore) «affronta ogni situazione con
un occhio ai vantaggi e l’altro ai costi, con l’abilità di confrontarli, e con una spiccata tendenza a seguire la direzione in cui lo
conduce la razionalità». Egli tende cioè a perseguire, nell’ambito
delle sue specifiche prerogative e sfere d’azione, i propri obiettivi
in modo efficiente, con il minimo impiego di risorse, assegnando
un costo ad ogni evento e scegliendo opportunamente fra le alternative che si presentano» (A. Downs, Teoria economica della
politica, Il Mulino, Bologna 1988, p. 38).
Beninteso, assumendo a suo fondamento la razionalità dell’attore politico, l’approccio della scelta razionale è del tutto consapevole della presenza e dell’essenzialità delle componenti non
razionali nell’agire umano. Ma ritiene che gli uomini dispongano, in quanto razionali, della capacità di pianificare i rimedi atti a
scongiurare i rischi determinati dalle loro propensioni passionaliirrazionali: come Ulisse, che, sapendosi suggestionabile dal canto
delle sirene, si fa legare all’albero maestro, essi progettano vincoli istituzionali autoritativi (collettivi) per impedirsi di cedere alle
proprie inclinazioni auto ed etero-distruttive; assumono cioè impegni preliminari a cui, anche volendolo, non potrebbero sottrarsi, per resistere alla probabile debolezza del loro volere.
Per esempio, secondo il modello hobbesiano, lo stato di
natura è una situazione di conflitto permanente e di anarchia,
dove vigono «il dominio delle passioni, la guerra, la paura». In
siffatto scenario, la stessa conservazione della vita, che è per
l’uomo il fine preminente, è in sommo pericolo, nella misura in
cui ciascuno cerca di prevalere sugli altri, e la ricerca della pace
non paga, non essendo reciprocamente garantita. L’unica via per
rendere efficaci le leggi naturali, cioè per fare in modo che gli
uomini agiscano secondo ragione e non secondo passione, è
l’istituzione di un potere tanto forte da rendere svantaggiosa ogni
azione contraria. Questo potere irresistibile è lo stato. Dunque,
28
per impedire che la libertà individuale si risolva in un danno
collettivo (la “guerra di tutti contro tutti”), non bastando a scongiurare questa evenienza la presenza di istituzioni sociali spontanee (mercato, famiglia, consuetudini, buone maniere), gli individui progettano e costituiscono, attraverso un patto che è insieme
un pactum societatis e un pactum subiectionis, istituti artificiali
di tipo politico, il cui compito è di consentire la cooperazione e la
riproduzione sociale.
Va tuttavia rilevato che, controintuitivamente, la necessità
di regole e istituzioni politiche sembra nascere, più che dalle
anomalie individuali dovute a deficit di razionalità dei singoli,
soprattutto dai paradossi della stessa “razionalità strumentale”, la
quale, se non governata, in contesti interattivi governati da incertezza, conduce spontaneamente a risultati socialmente (e, di
riflesso, anche individualmente) non voluti, perversi, insoddisfacenti, come dimostrano assai bene il cosiddetto “dilemma del
prigioniero” e la teoria olsoniana del free rider (S. Belligni,
Paradigmi del politico, cit., pp. 95-99, passim).
Il “dilemma del prigioniero” è un gioco non cooperativo,
in cui cioè non sono consentiti la comunicazione e il coordinamento fra gli attori. In una versione ipersemplificata, ma sufficiente ai nostri fini, tale modello può essere riassunto nei termini
seguenti. Vi sono due prigionieri in attesa di processo impossibilitati a comunicare tra loro, ai quali sono offerte come opzioni
alternative la collaborazione col giudice inquirente o l’omertà.
Nel caso che essi si accusino reciprocamente del reato di cui sono
imputati, la pena sarà di cinque anni. Se manterranno il silenzio
entrambi verranno scarcerati dopo un anno, decorsi i termini di
carcerazione preventiva. Se solo uno dei due accuserà l’altro,
l’accusatore sarà libero subito, ma l’accusato dovrà scontare dieci
anni di carcere. L’esito del gioco, data la razionalità degli attori e
la mancanza di comunicazione tra loro, sarà di necessità
collettivamente insoddisfacente in forza dello stesso orientamento razionale-egoistico dei giocatori. Infatti, ciascuno dei due
prigionieri, per un verso, spera di sfruttare il silenzio dell’altro,
uscendo subito di galera; per altro verso, teme che il complice
29
parli, e di dover perciò scontare, col proprio silenzio, dieci anni
(il massimo) di pena. Entrambi adotteranno perciò un comportamento strategico teso a massimizzare l’utilità attesa: la strategia dominante sarà quella della reciproca delazione. Questa
scelta, in sé razionale, condurrà però al risultato sub-ottimale di
una condanna a cinque anni ciascuno, a fronte di un esito ottimale (in senso paretiano) di un anno ciascuno che sarebbe stato
ottenuto col comune silenzio.
Il “dilemma del prigioniero” descrive tipicamente l’esito
non voluto di interazioni sociali non controllate, soggette all’incertezza, dove l’intervento di un terzo super partes, nella veste di
coordinatore, o la presenza di un sistema di regole istituzionali,
potrebbero evitare gli effetti perversi dell’aggregazione spontanea delle preferenze individuali. Dal modello emerge insomma
con evidenza un possibile (per quanto a sua volta problematico)
ruolo regolatore della politica a fronte del “fallimento sociale”
delle interazioni volontarie o “negoziali” (S. Belligni, Paradigmi
del politico, cit., pp. 106-7, passim).
Il secondo dei contributi di matrice economica capace di
dar conto, teleologicamente, della funzione dell’autorità politica
è il modello del free rider (espressione traducibile in italiano con
“portoghese”, o “parassita”, o “profittatore”), proposto nel 1965
da Mancur Olson nell’ambito della sua teoria dei gruppi (ma per
più rispetti anticipato, da Hume fino a Downs) e divenuto molto
popolare anche tra gli scienziati politici. Partendo anch’egli da
un’idea di politica incentrata sul pa-radigma della scelta razionale
individuale, Olson mette a fuoco in forma semplice ed elegante il
nesso perverso che tende a istituirsi tra micromotivazioni degli
individui e macroconseguenze che ne derivano sulle grandi
organizzazioni (e in particolare sul sistema politico). Il nucleo del
paradosso olsoniano è che il ricorso a strategie individuali
massimizzanti dia luogo paradossalmente, all’interno dei “grandi
gruppi”, a risultati non ottimali per quanto riguarda la
disponibilità di beni pubblici.
Ma vediamo meglio il ragionamento di Olson. Gli individui si raggruppano in organizzazioni politiche cooperative per
30
ottenere, attraverso varie modalità di partecipazione, vantaggi
comuni, sotto forma di beni collettivi o pubblici, caratterizzati
cioè dalla non rivalità nel consumo e dalla non escludibilità dal
beneficio.
Non rivalità nel consumo significa che, nella loro forma
pura, i beni pubblici, una volta forniti ad un individuo, possono
essere forniti a tutti gli altri senza costo aggiuntivo, in quanto il
consumo di un individuo non è alternativo a quello di altri.
Non escludibilità dal beneficio significa indivisibilità di
tali beni e impossibilità di impedirne il godimento (ma anche
l’autoesclusione) a chiunque si trovi sotto la giurisdizione dell’agenzia che li produce. L’esempio tipico è quello di un faro che
illumina indifferentemente chi passa nel suo raggio di luce.
Esempi di beni collettivi forniti da organizzazioni private (come
un sindacato o un partito), oppure da agenzie pubbliche, sono i
contratti collettivi di lavoro, la difesa nazionale, l’igiene pubblica, ecc..
Date tali caratteristiche di un bene pubblico, nessun individuo ha convenienza a offrire spontaneamente il proprio contributo alla sua produzione. C’è, in altri termini, un contrasto strutturale tra l’interesse di una collettività (o di un gruppo) a fruire di
un certo bene pubblico in quantità ottimale e l’interesse individuale a non pagarne (sub specie di contribuzione monetaria, o
comunque di azione partecipativa) i costi di produzione, in
misura tale per cui i benefici marginali di ciascuno eguagliano i
costi marginali. Ne discende che nei grandi gruppi, ove ciascun
individuo ritiene fondatamente che il suo apporto alla produzione
del bene collettivo desiderato sia pressoché ininfluente per determinare l’esito finale, la tendenza sarà a non partecipare (o a sottocontribuire), nascondendo le proprie preferenze.
La produzione dei beni pubblici richiede pertanto —
questa la conclusione di Olson — l’adozione di incentivi selettivi
positivi o negativi; in particolare, in quel “grande gruppo” che è
la comunità statale tali incentivi tendono ad assumere la forma
negativa della coercizione (S. Belligni, Paradigmi del politico,
cit., pp. 107-9, passim).
31
12. Il neoistituzionalismo
L’offensiva comportamentista contro il concetto di stato ottiene
per un quindicennio una vittoria schiacciante nella comunità
scientifica, come testimonia il fatto che, dalla fine degli anni Cinquanta alla metà degli anni Settanta, il termine è pressoché scomparso dai lavori di scienza politica di matrice o di orientamento
anglosassone. Molti autori, legati soprattutto alla tradizione del
pensiero politico europeo-continentale, si sono tuttavia mostrati
scettici riguardo alla possibilità di sbarazzarsi con troppa disinvoltura di un concetto così blasonato e radicato nella mentalità
collettiva, sicché negli ultimi anni la reciproca implicazione tra
stato e politica è stata a più riprese riaffermata, soprattutto da una
prospettiva epistemologica e teorica collocata al crocevia tra
scienza politica, sociologia dell’organizzazione ed economia:
quella del neoistituzionalismo (S. Belligni, Paradigmi del
politico, cit., pp. 57-63, passim). Il neoistituzionalismo è un
approccio (cioè un insieme di principi metodologici, di concetti,
di modelli teorici e di criteri di rilevanza) sviluppatosi nella
seconda metà degli anni Ottanta (per opera di studiosi quali
Zucker, Scott, Powell, Di Maggio, Olsen e March) sulla base di
tre tratti distintivi.
Il primo è un marcato interesse verso gli aspetti formalizzati
e stabilizzati delle relazioni sociali: regole, norme, routine, procedure, strutture d’autorità, costituzioni, stati, regimi internazionali, ecc.. In secondo luogo, proprio in quanto focalizza la sua
attenzione sugli aspetti stabili e persistenti della vita sociale, il
neoistituzionalismo sottolinea l’importanza dei processi di lungo
periodo all’interno dei quali si svolge l’attività umana: il passato
conta, gli attori strutturano i loro piani più in base ai vincoli
contratti in passato che ai loro obiettivi futuri, il cambiamento
avviene all’interno di un tempo storico irreversibile e il presente
è path dependent, cioè si spiega solo alla luce degli eventi
trascorsi. Infine, il neoistituzionalismo si caratterizza per l’importanza attribuita all’analisi del contesto normativo e cognitivo
all’interno del quale l’azione si svolge: gli individui agiscono in
base alla percezione che hanno della realtà, al modo in cui
32
definiscono i problemi, alle soluzioni che hanno a disposizione, a
quanto viene percepito come giusto, legittimo e appropriato.
Detto altrimenti: l’homo politicus non esiste al di fuori di un
contesto istituzionale di qualche natura, che ne definisca ruolo,
obiettivi, strategie, interlocutori. L’analisi politica, pertanto, non
può prescindere dalla dimensione istituzionale: l’ordine sociale
non è mera interazione di individui, ma il prodotto di regolarità
istituzionalmente strutturate (L. Lanzalaco, Istituzioni, organizzazioni, potere. Introduzione all’analisi istituzionale della politica, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995).
13. Il paradigma dell’identità
Il paradigma dell’identità ritiene, in primo luogo, che l’azione
politica dell’individuo richiami necessariamente, come suo
termine ineliminabile di riferimento, una qualche sorta di appartenenza, naturale o costruita socialmente, che lo subordina moralmente, conferendo senso e valore ai suoi comportamenti. Per
conseguenza, fonti primarie di azione politica sono attori collettivi e non attori individuali: al centro della politica vi sono gli
interessi a lunga scadenza (i destini) e i contrasti dei popoli, delle
razze, delle classi, delle masse, o dell’umanità tout court, quali
vengono interpretati dai movimenti e dalle forme associative e
organizzative che li “costruiscono” e/o li rappresentano.
Tutto ciò comporta una netta presa di distanza quanto meno
dagli esiti più estremizzati dell’individualismo metodologico, che
considera gli individui uti singuli come le unità elementari del
politico, e della rational o collective choi-ce theory, che dalla
teoria economica mutua e traspone al com-portamento politico
l’assunto della scelta razionale, affermando che anche l’homo
politicus, come quello oeconomicus, impronta il suo agire alla
razionalità rispetto allo scopo (cioè tende a perseguire i propri
obiettivi in modo efficiente, con il minimo impiego di risorse,
assegnando un costo ad ogni evento e scegliendo opportunamente fra le alternative che gli si presentano). Secondo l’approccio delle identità collettive la partecipazione degli individui
all’azione politica, in quanto mediata da appartenenze sociali,
33
non è intelligibile soltanto, né principalmente, attraverso i moduli
della razionalità strategica, ma chiama in causa moventi di natura
solidaristica, ritualistica, affettiva, sacrale, elementi culturali e
simbolici irriducibili all’utilità.
In secondo luogo, l’approccio delle identità collettive enfatizza la natura e la vocazione conflittuale, armata, comunque mai
irenica della politica, il suo richiamare divisioni, turbamenti, lacerazioni, disordine, violenza, o comunque forti passioni di
gruppo. Nelle versioni estreme di questo approccio, la sottolineatura dell’insopprimibile ostilità esistente tra gli uomini fa della
lotta (o della guerra tout court) la relazione politica fondamentale
(come è testimoniato dall’abituale ricorso a categorie e a metafore desunte dal linguaggio e dall’esperienza militare e bellica).
Discende da tali premesse il terzo elemento caratterizzante
l’approccio delle identità collettive: la dimensione temporale in
cui l’agire politico si rende comprensibile non è la contingenza e
il breve periodo, ma la lunga durata, interpretata dalla tradizione
e dalla memoria storica (S. Belligni, Paradigmi del politico, cit.,
pp. 67-70, passim).
Un modo classico di definire la politica, situabile nell’ambito della prospettiva sopra delineata, consiste nel ricondurla
all’antitesi amico-nemico. Dal nesso tra politica, amicizia e
inimicizia (topos assai frequentato della storia del pensiero
politico, da Platone ad Aristotele, da Machiavelli a Hobbes, da
Rousseau a Hegel) emerge, per l’individuazione della categoria
del politico, la centralità della riflessione sul concetto di conflitto,
con la sua manifestazione estrema che è la guerra. E qui si danno
due orientamenti fondamentali: il primo assume il conflitto come
un fattore di segno radicalmente negativo, come una patologia
col-lettiva da espungere dal territorio del politico (il conflitto è
un male, quando non è il male); il secondo, viceversa, assume il
conflitto come l’essenza autentica, esclusiva e ineliminabile della
categoria del politico. Si tratta, come si vede, di due orientamenti
antitetici, anche se tocca osservare che, implicitamente o esplicitamente, almeno alcune delle dottrine riferibili al primo orientamento (si pensi a Saint-Simon), connettendo la realizzazione
34
dell’armonia definitiva nella storia con la fine della politica,
finiscono per riconoscere che la politica in realtà coincide con il
conflitto. Del resto, come nota Gianfranco Miglio (Guerra, pace
e diritto), sembra esservi uno stretto nesso semantico fra i più
antichi vocaboli usati dai Greci per indicare l’aggregazione
politica e il conflitto armato: polis e polemos — nella forma
arcaica ptolis e ptolemos — deriverebbero infatti da una comune
radice pt, non (e quindi pre) indoeuropea.
La paternità inequivocabile del filone delle concezioni conflittualistiche della politica spetta in questo secolo all’opera di
Carl Schmitt, il quale, nel saggio Der Begriff des Politischen
(1927), dopo aver rilevato che «la contrapposizione politica è la
più intensa ed estrema di tutte e ogni altra contrapposizione
concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti amico/nemico», conclude giudicando la distinzione amico-nemico «immanente ad ogni comportamento politico».
Ora, è fuor di dubbio che la concezione che esaurisce la
politicità nella conflittualità trascura il carattere di essenziale
ambivalenza del rapporto di tipo politico. Se per un verso, infatti,
la politica esclude e si fa, potenzialmente o in atto, inimicizia, per
un altro verso essa integra e aggrega. Certo, il rapporto politico è
un rapporto “chiuso”, che esclude chi non fa parte di quella certa
comunità, il quale perciò è straniero, fuori dai confini fisici e
affettivi del gruppo, e per ciò stesso nemico, effettivo o virtuale.
(Non a caso hostis — nemico pubblico, colui contro il quale
combattiamo pubblicamente una guerra, nella sua differenza
dall’inimicus, che è colui con il quale abbiamo rancori e odi
privati — sta anche per straniero: in Cicerone, per esempio). Ma
non c’è soltanto l’interazione (antinomia) tra amico e nemico, c’è
anche l’interazione (aggregazione) tra amico e amico. Nel
momento stesso in cui si assume la presenza dell’escluso, del
nemico (e quindi del conflitto), va logicamente compresa nel
politico la presenza dell’incluso, di colui che insieme ad altri
forma e dà luogo alla sintesi politica, cioè l’amico. Anzi, è l’idea
di solidarietà che (sempre logicamente) precede l’evento
35
dell’esclusione e la possibilità del conflitto: se prima non si
formano i raggruppamenti sulla base delle rispettive solidarietà
non è possibile alcuna lotta tra di essi. Il concetto di conflitto non
esaurisce, dunque, il concetto di politica.
Merita comunque osservare che la definizione di politica
come rapporto amico-nemico, inerendo costitutivamente a tale
rapporto l’uso della forza, non è affatto incompatibile con quella
che fa riferimento al monopolio della coercizione fisica legittima:
proprio in quanto il potere politico si caratterizza per l’esclusività
dell’uso della forza rispetto a tutti i soggetti che agiscono in un
determinato contesto sociale, esso è quel potere cui si fa appello
per risolvere quei conflitti la cui non soluzione, affrontandosi i
contendenti come “nemici”, avrebbe per effetto la disintegrazione
della sintesi politica. Ciò conferma come il vero problema della
politica non sia quello dell’eliminazione definitiva della conflittualità, ma quello dell’individuazione dei modi istituzionali
più efficaci per affrontare e risolvere i conflitti (S. Belligni,
Paradigmi del politico, cit., pp. 70-73; D. Fisichella, Lineamenti
di scienza politica, La Nuova Italia, Roma 1988, passim).
36
EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO
1. La rappresentanza proporzionale della Prima Repubblica
Dal 1946 al 1992 il sistema elettorale italiano è stato di tipo
proporzionale, applicato in circoscrizioni piuttosto grandi, con
scrutinio di lista, recupero dei resti e voto di preferenza. Più
precisamente, nelle diverse circoscrizioni per la Camera venivano
eletti all’incirca 20-22 deputati, ma nelle due circoscrizioni più
grandi, Roma e Milano, venivano eletti più di cinquanta deputati.
L’elettore votava per un partito e poteva attribuire da tre a
quattro preferenze, a seconda del numero di deputati da eleggere
in quella circoscrizione, esclusivamente per i candidati del partito
prescelto, scrivendone il cognome oppure il numero di lista. In
ciascuna circoscrizione i seggi venivano assegnati ai partiti che
avessero ottenuto un quoziente pieno in almeno una
circoscrizione, vale a dire all’incirca 60-65.000 voti, e raccolto
almeno 300.000 voti su scala nazionale. Questa doppia soglia,
tutt’altro che particolarmente elevata e drastica, servì però, ad
esempio, a tagliare fuori dal parlamento nel 1972 il Partito
socialista di unità proletaria (Psiup). Pur avendo ottenuto su scala
nazionale ben 648 mila voti, lo Psiup non riuscì ad ottenere
nessun quoziente pieno, vale a dire ad eleggere direttamente un
deputato in una circoscrizione. Naturalmente, molti altri piccoli
partiti rimasero fuori dal parlamento italiano nel corso del tempo,
e nelle stesse elezioni del 1972 sia il Manifesto (224 mila voti)
che il Movimento politico dei lavoratori (120 mila voti) e il
Partito comunista marxista-leninista (98 mila voti), ma il caso
dello Psiup è rimasto di gran lunga il più significativo; tanto più
che, al confronto, nel 1976 i liberali, con 478 mila voti, ebbero
cinque seggi e Democrazia proletaria, con 556 mila voti, ne ebbe
sei.
37
All’incirca un decimo complessivo dei seggi, grosso modo
63, venivano attribuiti, con il cosiddetto recupero dei resti nel
Collegio unico nazionale, ai partiti che avevano ottenuto i
migliori resti, vale a dire voti non utilizzati per l’elezione di
deputati nelle varie circoscrizioni, purché avessero superato le
due soglie di cui sopra. Cosicché, l’esito complessivo del sistema
elettorale italiano era sostanzialmente proporzionale, con una
adeguata corrispondenza fra percentuale di voti e percentuale di
seggi, con limitata sovrarappresentanza dei partiti grandi, quelli
al disopra del 15% dei voti, e limitata sottorappresentanza dei
partiti più piccoli non geograficamente concentrati. Le preferenze
espresse dagli elettori servivano a stabilire la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista di partito e quindi il loro ordine di
elezione (e, in caso di decesso e di dimissioni, l’ordine di
subentro).
Adottata dopo una lunga, intensa e appassionata
discussione in sede di Assemblea costituente, la rappresentanza
proporzionale venne subito criticata, e ben presto se ne propose
una riforma incisiva, se non truffaldina. Poco prima delle elezioni
del 1953, la maggioranza centrista (Pli, DC, Pri, Psdi) guidata da
Alcide De Gasperi fece approvare una riforma elettorale che le
sinistre immediatamente e sarcasticamente definirono “legge
truffa”. Il nuovo meccanismo, che mirava a rafforzare e
stabilizzare la coalizione di governo, era tecnicamente piuttosto
semplice. Alla lista o alla coalizione di liste che avessero
dichiarato preventivamente il loro apparentamento e che avessero
ottenuto il 50% più uno dei voti venivano attribuiti il 65% dei
seggi. Insomma, era un premio di maggioranza, per quanto
decisamente consistente, attribuito ad una maggioranza, per
quanto non cementata e non obbligata a governare insieme. La
legge truffa non scattò per mancanza di circa 57 mila voti, anche
grazie alle defezioni dai partiti minori di alcune importanti
personalità politiche; tra queste Gaetano Salvemini, che ebbe a
dichiarare: «Un partito che è al governo non può, alla vigilia di
ogni elezione, prendendo a norma i risultati delle elezioni
precedenti, proporre una nuova legge elettorale che gli assicuri
38
una maggioranza di mandati che altrimenti gli scapperebbe dalle
mani. Se così facesse, non offrirebbe una nuova regola di gioco,
ma vorrebbe barare al gioco. E chi lo aiutasse in quella manovra
si renderebbe complice di una truffa».
La legge truffa fu in seguito abrogata. Ebbe, comunque,
una conseguenza politico-istituzionale di rilievo. Dopo di allora,
risultò decisamente difficile proporre riforme nella e della
rappresentanza proporzionale. Anzi, la rappresentanza
proporzionale divenne sostanzialmente il codice operativo del
sistema politico e del sistema partitico italiani. Creò, mantenne e
riprodusse cospicue rendite di posizione e di opposizione, per
partiti e candidati, e notevoli aspettative per tutti coloro che
aspiravano ad accedere al parlamento. Dal punto di vista
operativo, la variante italiana di sistema elettorale proporzionale
pagava il prezzo di un’ampia rappresentanza delle varie opinioni
politiche con una notevole difficoltà nella formazione di
coalizioni di governo e con la crescente impraticabilità di
un’alternanza fra coalizioni.
Inoltre, lungi dall’essere uno strumento grazie al quale gli
elettori sceglievano i candidati preferiti all’interno della lista del
partito votato, e quindi temperavano il potere degli apparati di
partito, il voto di preferenza produsse una serie di inconvenienti
vieppiù gravi. Sul versante del rapporto fra candidati ed elettori,
il voto di preferenza incoraggiava il cosiddetto voto di scambio.
Con questo voto, l’elettore dava la sua preferenza al candidato in
cambio della promessa di risorse pregiate: un lavoro, una licenza
commerciale, una pensione di invalidità, l’intermediazione con
una burocrazia inefficiente e corrotta, politicamente sollecitabile.
Sul versante del rapporto fra candidati, il voto di preferenza
incoraggiava sia la competizione fra di loro all’interno della
stessa lista di partito che le intese fra alcuni di loro nella modalità
definita “cordata”. Più candidati si accordavano per fare
convergere le preferenze del loro specifico elettorato su candidati
amici che disponessero di voti di preferenza ugualmente
controllabili e attivabili che potevano essere riversati
vicendevolmente. Sul versante del partito, la conseguenza era che
39
le cordate di candidati, una volta entrate in parlamento, davano
vita a correnti organizzate, sotto la guida di un capocorrente
riconosciuto, alla ricerca di cariche di governo che
riproducessero le risorse politico-economi-che e il consenso
elettorale, con il conseguente inquinamento di tutto il processo
decisionale parlamentare e governativo.
Comprensibilmente, i partiti di governo, in primis la
Democrazia cristiana e ben presto il Partito socialista, erano
quelli maggiormente interessati al voto di preferenza e
maggiormente colpiti dalle sue conseguenze politicamente
negative, ma anche elettoralmente positive. Dal canto suo, il
Partito comunista faceva un uso sapiente del voto di preferenza
per eleggere candidati predeterminati grazie al controllo delle
preferenze esprimibili dai suoi iscritti. Per ragioni legate ad un
maggior ricorso al voto di scambio e ad una maggiore
personalizzazione della politica, era l’elettorato meridionale ad
esprimere la più elevata percentuale di preferenze. La carica di
corruzione insita nel voto di preferenza lo sottopose a numerose e
severe critiche, controbilanciate soltanto dal timore che
l’abolizione del voto di preferenza e il conseguente passaggio
alla lista bloccata consegnassero sia la selezione dei candidati
che, in special modo, l’elezione dei parlamentari completamente
nelle mani degli apparati dei partiti, dei loro segretari, dei
capicorrente. Ci sarebbe voluto un referendum popolare
abrogativo nel 1991 per ridurre il numero di preferenze ad una
sola, con l’obbligo di scrivere per esteso il cognome del
candidato prescelto al fine di evitare i molti brogli che avevano
contraddistinto il sistema (G. Pasquino, Il sistema e il
comportamento elettorale, in Id., a cura di, La politica italiana.
Dizionario critico 1945-95, Laterza, Bari 1995, pp. 135-38).
2. Il Mattarellum
Il termine Mattarellum, coniato e in seguito abitualmente
utilizzato da Sartori, si riferisce, con evidenti connotazioni
40
critiche e beffarde, alla legge elettorale elaborata dal deputato del
Partito popolare Mattarella nell’estate del 1993, a recepimento
dell’esito del referendum del 18 aprile 1993, giorno in cui 37
milioni di elettori (pari al 77,1%) si recarono alle urne e si
espressero quasi plebiscitariamente (82,7%) in favore del quesito
che mirava a rendere per tre quarti maggioritario (in collegi
uninominali) e per un quarto proporzionale il sistema elettorale
del Senato.
Il nuovo sistema elettorale per il Senato e per la Camera si
configurava come un sistema misto. I seggi spettanti a ciascuna
delle regioni, per l’elezione del Senato, e a ciascuna delle
circoscrizioni, per l’elezione della Camera, erano infatti assegnati
per tre quarti (75%) con il sistema maggioritario in un unico
turno di votazione e per un quarto (25%) con il sistema
proporzionale. Complessivamente, 232 senatori (su 315) e 475
deputati (su 630) erano eletti con il sistema maggioritario in
altrettanti collegi uninominali. I restanti seggi, 83 per il Senato e
155 per la Camera, costituivano la quota destinata al recupero
proporzionale. Questo si effettuava sul piano regionale per il
Senato e su base nazionale (con successiva restituzione alle
circoscrizioni) per la Camera.
Il voto per il Senato
Per l’elezione del Senato l’elettore riceveva un’unica scheda
nella quale erano riportati i nomi dei candidati in competizione
nel collegio. Accanto a ciascun nome appariva il simbolo del
partito o gruppo politico a cui apparteneva il candidato.
L’elezione del 75% dei senatori avveniva, come si è detto, con il
sistema maggioritario: era eletto il candidato che risultava più
votato in ciascun collegio, qualunque fosse il numero dei voti
ottenuti.
Tra i candidati non eletti nei collegi era ripartito, nell’ambito di ciascuna regione, il restante 25% dei seggi. A tale scopo si
teneva conto, per ciascun gruppo politico, del totale dei voti
validi ottenuti nella regione dai candidati non eletti
contraddistinti dallo stesso simbolo. I seggi erano assegnati
41
proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascun gruppo. All’interno
di ciascun gruppo erano proclamati eletti nell’ordine i candidati
che avevano riportato le più alte percentuali di voto nei rispettivi
collegi.
Il voto per la Camera
Per l’elezione della Camera l’elettore riceveva due diverse
schede. Con la prima scheda l’elettore votava per scegliere il
deputato del proprio collegio; in ciascuno dei 475 collegi
risultava eletto il candidato che aveva ottenuto più voti. Con la
seconda scheda l’elettore votava per una delle liste di partito
presenti nella circoscrizione e che concorrevano per
l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 155 seggi.
La ripartizione proporzionale avveniva tra le sole liste che
avessero ottenuto almeno il 4% del totale dei voti validi
sull’intero territorio nazionale.
Ciascun candidato per l’elezione nel collegio uninominale
doveva obbligatoriamente collegarsi con una o più liste che
partecipavano al riparto dei seggi proporzionali della
circoscrizione. Non erano ammesse perciò candidature non
collegate ad alcuna lista. Né era possibile alla stessa persona
candidarsi in più di un collegio uninominale, mentre era possibile
candidarsi, oltre che nel collegio, anche nella parte
proporzionale. Se ogni candidato doveva collegarsi ad una lista
non era, invece, obbligatorio l’inverso: potevano esservi, cioè,
liste che partecipavano soltanto alla ripartizione dei seggi della
parte proporzionale e che non presentavano propri candidati nei
collegi uninominali.
Dal punto di vista dell’elettore la doppia scheda consentiva
un’ampia libertà di scelta: l’elettore, infatti, poteva scegliere il
candidato che riteneva più adatto a rappresentare il proprio
collegio e, nello stesso tempo, poteva votare, sulla seconda
scheda, la lista (cioè il partito) che considerava più vicino alle
proprie idee.
La scheda per l’elezione dei candidati nei collegi
uninominali della Camera era simile a quella utilizzata per
l’elezione del Senato. Con una differenza: accanto al nome di
42
ciascun candidato poteva comparire più di un simbolo (fino a un
massimo di cinque). Qualora un candidato fosse collegato a più
di cinque liste doveva scegliere con quali simboli corrispondenti
essere contraddistinto sulla scheda. Il candidato collegato a più di
una lista poteva, invece, se lo riteneva, avvalersi di un simbolo
differente da quelli delle liste a lui collegate, per sottolineare il
valore unitario della candidatura.
La scheda per l’attribuzione dei seggi con il sistema
proporzionale riportava, accanto a ciascun simbolo, i nomi dei
candidati della lista circoscrizionale. Ciascuna lista non poteva
presentare candidati in misura superiore a un terzo dei seggi
spettanti alla circoscrizione (a seconda dei casi, dunque, le liste
erano formate da un minimo di uno a un massimo di quattro
candidati) ed era bloccata: se ad essa spettavano degli eletti,
questi venivano proclamati secondo l’ordine in cui i nomi
comparivano sulla scheda.
Come si è detto, potevano partecipare alla ripartizione
proporzionale solo quelle liste che avessero ottenuto almeno il
4% del totale nazionale dei voti espressi con la seconda scheda.
Una volta stabilito quali liste erano ammesse alla ripartizione
proporzionale, si trattava di distribuire tra di esse i 155 seggi.
Il meccanismo dello scorporo
È a questo punto che veniva introdotto il cosiddetto scorporo, un
meccanismo finalizzato ad accrescere le possibilità di conquista
dei seggi proporzionali per le liste che avessero riportato poche
vittorie (o nessuna) nei collegi uninominali.
Per far ciò si scorporava, cioè si sottraeva a ciascuna delle
liste una parte dei voti ottenuti nei collegi uninominali dagli eletti
collegati alle liste stesse: la sottrazione non riguardava, infatti,
tutti i voti ottenuti dai candidati vincitori nei collegi uninominali,
ma soltanto il numero minimo necessario per la vittoria, che
corrispondeva al numero dei voti ottenuto dal candidato arrivato
secondo, aumentato di un voto. Se il candidato eletto nel collegio
uninominale era collegato a più di una lista nella parte
proporzionale, la sottrazione (sempre ai soli fini dell’attribuzione
dei seggi proporzionali) veniva suddivisa tra le diverse liste
43
collegate in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna di esse (con la
seconda scheda).
Determinato nei modi appena descritti il totale nazionale
dei voti che ciascuna lista poteva utilizzare, si procedeva alla
ripartizione complessiva dei 155 seggi, stabilendo quanti di essi
spettassero a ciascuna lista. I seggi assegnati a ciascuna lista sul
piano nazionale venivano poi ripartiti fra le circoscrizioni,
tenendo conto dei risultati relativi conseguiti in ciascuna di esse.
Infine, una volta determinato il numero degli eletti che in ogni
circoscrizione spettava a ciascuna lista, venivano proclamati
deputati i candidati presenti sulla scheda secondo il loro ordine
nella lista stessa. Nel caso in cui il numero dei seggi cui una lista
aveva diritto fosse superiore, nella circoscrizione, al numero dei
candidati inseriti (da uno a quattro), venivano proclamati deputati
i candidati non eletti nei collegi uninominali, fra quelli collegati
alla lista considerata, che avevano riportato la più alta
percentuale.
3. La riforma elettorale del centro-destra
Vediamo gli elementi caratteristici dei nuovi sistemi elettorali
approvati dalla Casa delle libertà (Cdl). Il plurale è d’obbligo
perché anche in questo caso, come già con la legge Mattarella,
siamo davanti a due sistemi elettorali con alcuni elementi simili
ma con altri molto diversi.
Il sistema elettorale della Camera
Sia alla Camera che al Senato due sono gli elementi
caratterizzanti del nuovo sistema elettorale: il premio di
maggioranza e l’assegnazione del 100% dei seggi con formula
proporzionale. Alla Camera il premio va alla coalizione di liste, o
lista singola, che abbia ottenuto il maggior numero di voti a
livello nazionale. Ad essa spettano almeno 340 seggi (pari al
54% dei seggi totali). Dopo un’iniziale ripartizione solo
proporzionale dei seggi, che ha luogo in sede nazionale con
applicazione del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti,
44
si verifica se tale quota sia stata rispettata. Nel caso lo sia, il
premio di maggioranza non scatta. Qualora invece non lo sia, alla
coalizione (o lista) vincente sono attribuiti ulteriori seggi fino a
raggiungere la cifra di 340 seggi; seggi che sono contestualmente
sottratti alle coalizioni e/o liste singole perdenti, le quali si
dividono proporzionalmente 277 seggi. Dei 13 sedici rimanenti,
uno è assegnato al candidato vincente nel collegio uninominale
della Valle d’Aosta e 12 sono riservati ai rappresentanti degli
italiani residenti all’estero, questi ultimi eletti con metodo
proporzionale tra liste concorrenti e con voto di preferenza.
Alla Camera il premio è majority-assuring, tale cioè da
assicurare alla compagine vincente una maggioranza assoluta
(anzi, almeno il 54%) dei seggi; è inoltre eventuale, poiché scatta
solo se la compagine vincente non è riuscita a conseguire per via
proporzionale la quota prevista di seggi; è infine variabile nella
sua entità, poiché assegna solo il numero di seggi strettamente
necessario a far sì che la maggioranza raggiunga la cifra di 340.
Le coalizioni di cui parla la legge elettorale sono il
prodotto di dichiarazioni di collegamento reciproco tra le liste
presentate da partiti o gruppi politici organizzati. Questi ultimi
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il
nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo
della coalizione. Sulla scheda di votazione, però, le coalizioni
non hanno una loro autonoma visibilità, separata da quella delle
liste che le compongono, se non per il fatto che i contrassegni
delle liste collegate ad esse appartenenti sono riprodotti di
seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna.
In altri termini, le coalizioni non sono contraddistinte da un loro
simbolo, a meno che le rispettive liste lo inseriscano all’interno
del proprio. Questo perché gli elettori hanno a disposizione un
solo voto, con il quale scelgono solo una lista: i voti alla
coalizione altro non sono che la somma dei voti di tutte le liste
che ne fanno parte.
Alla ripartizione dei seggi accedono: a) le coalizioni che
abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi, purché
contengano una lista con il 2% o più dei voti; b) le liste singole
45
(ossia non collegate in coalizione) che abbiano conseguito
almeno il 4% dei voti validi; c) le liste collegate (ossia facenti
parte delle coalizioni di cui al punto a) che abbiano conseguito
almeno il 2% dei voti validi; d) per ciascuna coalizione, la lista
collegata con il maggior numero di voti tra quelle con meno del
2%. Queste sono le quattro soglie di sbarramento previste dal
sistema elettorale della Camera e valgono sia nel caso in cui il
premio di maggioranza scatti sia nel caso in cui non scatti.
Se superano la prima soglia ora menzionata, le coalizioni
concorrono all’assegnazione dei seggi, ed eventualmente del
premio, con i voti di tutte le liste che le compongono, quindi
anche con i voti di quelle che non sono in grado di superare lo
sbarramento e di ottenere dei seggi. Dopo aver distribuito (o
redistribuito, qualora sia scattato il premio di maggioranza) i
seggi tra le coalizioni (con almeno il 10% dei voti e contenti una
lista con almeno il 2%) e le liste singole (con almeno il 4% dei
voti), i seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti, ancora
a livello nazionale e con il metodo del quoziente naturale e dei
più alti resti, tra le liste che ne fanno parte purché con il 2% dei
voti. A questa ripartizione viene ammessa anche la lista con più
voti tra quelle che sono rimaste sotto il 2%. Infine, si provvede
alla distribuzione dei seggi così attribuiti alle 26 circoscrizioni in
cui è diviso il territorio nazionale, con un meccanismo tale da
garantire che ad ognuna di esse spetti il numero di seggi previsto
ai sensi dell’art. 56 della Costituzione. Altra caratteristica molto
importante della riforma è l’assenza del voto di preferenza. Infatti
le liste circoscrizionali sono “bloccate”, quindi per ciascuna di
esse sono eletti, nel rispettivo ordine di presentazione, candidati
in numero pari ai seggi assegnati alle liste medesime.
Il sistema elettorale del Senato
Come alla Camera, anche al Senato la competizione avviene (con
alcune eccezioni) tra liste bloccate di candidati, unite o no in
coalizione, e il voto è unico. Tuttavia, come prima anticipato, vi
sono importanti differenze inerenti al livello in cui ha luogo la
ripartizione dei seggi, alle modalità di assegnazione del premio di
46
maggioranza e all’entità delle soglie di sbarramento. Il primo
aspetto è decisivo: la ripartizione dei seggi avviene
separatamente in ciascuna regione. Non esiste cioè un livello
nazionale di riferimento. Ne deriva che anche il premio (o,
meglio, i premi) di maggioranza e le soglie sono applicati in sede
regionale. In pratica, non vi è alcuna garanzia che la coalizione o
lista col maggior numero di voti sul piano nazionale ottenga la
maggioranza assoluta dei seggi.
In 17 regioni (tutte tranne Molise, Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige) il sistema è analogo. L’attribuzione dei
seggi avviene in primo luogo in ragione proporzionale (anche qui
con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti) tra le
coalizioni di liste e/o le liste singole che hanno superato le soglie
di sbarramento, rispettivamente il 20% (purché all’interno della
coalizione vi sia almeno una lista che abbia raggiunto il 3%) e
l’8% dei voti. Si verifica quindi se la coalizione o singola lista
con il maggior numero di voti nella regione ha ottenuto almeno il
55% dei seggi spettanti alla regione medesima. Se è così, allora il
premio di maggioranza non scatta. Se non è così, il premio scatta
(sempre regione per regione) e alla coalizione o lista vincente
sono assegnati tanti seggi aggiuntivi quanti ne servono per
raggiungere la quota del 55%, mentre un pari numero di seggi è
sottratto alle altre coalizioni o liste. Che sia stato necessario o
meno assegnare il premio, una volta determinati i seggi spettanti
a ciascuna coalizione questi sono ripartiti internamente tra le liste
collegate che abbiano ricevuto almeno il 3% dei voti su scala
regionale. Anche in questo caso si utilizza il metodo del
quoziente naturale e dei più alti resti. E anche in questo caso le
liste sono bloccate. Per ogni lista sono eletti i candidati, secondo
il loro ordine di presentazione, in numero corrispondente ai seggi
attribuiti.
Circa i sistemi delle altre tre regioni, quello applicato in
Molise diverge dal modello appena descritto in quanto non è
prevista l’attribuzione di un premio di maggioranza; i due seggi
in palio sono dunque distribuiti proporzionalmente. La Valle
d’Ao-sta è costituita in un unico collegio uninominale in cui
47
vince il candidato che ottiene più voti, così come accade alla
Camera. Il Trentino-Alto Adige è costituito in sei collegi
uninominali, mentre la restante quota di seggi spettanti alla
regione (attualmente uno) è attribuita con metodo del recupero
proporzionale, ossia tra i gruppi di candidati non risultati eletti
nei rispettivi collegi uninominali. Vi è, infine, la circoscrizione
“estero”, dove si applica un sistema proporzionale di lista e i sei
senatori sono eletti con voto di preferenza.
4. Le critiche alla riforma elettorale del centrodestra
Il diritto della maggioranza a cambiare le regole di voto,
rivendicato dal centrodestra, esiste di fatto, tant’è vero che il
sistema elettorale non è materia costituzionale: se i costituenti
avessero voluto proteggere questa regola del gioco dalle insidie
del principio di maggioranza l’avrebbero costituzionalizzata,
invece non l’hanno fatto. Ma non v’è dubbio che, se si accetta la
legittimità dell’uso del principio di maggioranza in materia
elettorale, la conseguenza logica e politica è quella di inserire nel
sistema delle regole un elemento di permanente instabilità. Ogni
vincitore, infatti, sarà tentato di usare la posizione di vantaggio
che si trova ad avere pro tempore per acquisire benefici di parte
che gli consentano di non perdere le elezioni o di perdere meglio.
Non è difficile immaginare con quali conseguenze nefaste sulla
stabilità e sulla legittimità del sistema politico. Oltretutto, se si
afferma la percezione che il sistema elettorale possa essere
cambiato con relativa facilità, ne risulteranno vanificati gli effetti
di lungo periodo. Gli incentivi posti da un sistema elettorale sono
infatti una funzione della previsione di durata del sistema stesso:
cambiare di continuo le regole elettorali vuol dire impedire che
gli incentivi in esse contenuti sviluppino i loro effetti. Riforme
elettorali frequenti sarebbero prive di effetti sul sistema partitico,
se non quelle effimere connesse al conseguimento di benefici
immediati, perché i partiti, invece di adattarsi alle regole vigenti,
punterebbero a cambiarle. Per tutti questi motivi le regole del
gioco, anche se non protette da una norma costituzionale,
48
dovrebbero far parte di una convenzione non scritta che le
sottragga alla politica delle convenienze partigiane.
Purtroppo così non è stato. Nel caso di questa riforma gli
interessi di parte hanno chiaramente prevalso sugli interessi
generali, i soli che avrebbero potuto legittimare l’uso del
principio di maggioranza in una materia tanto delicata. Il nuovo
sistema elettorale nasce dalla convergenza di due precisi
interessi: da una parte quello di Berlusconi e di tutta la Casa delle
libertà a limitare le perdite in caso di sconfitta alle prossime
elezioni, dall’altra l’interesse in particolare dell’Udc di
riconquistare autonomia e spazio di manovra. Questi obiettivi
sono stati conseguiti eliminando i collegi uninominali, che nelle
due ultime elezioni politiche avevano fortemente penalizzato il
centrodestra (che ha ottenuto qui molti meno voti rispetto
all’arena proporzionale), cancellando (in nome del voto unico
alla lista di partito) il voto di coalizione, che premiava la
coesione delle componenti partitiche e la “sommabilità” degli
elettorati (versanti sui quali il centrodestra si è mostrato, ceteris
paribus, più debole del centrosinistra), e introducendo un sistema
sostanzialmente proporzionale.
Questa riforma elettorale consolida o indebolisce il
bipolarismo? Per certi aspetti il premio di maggioranza può
essere considerato l’equivalente funzionale del collegio
uninominale. Nel vecchio sistema era il collegio a tener insieme
le coalizioni, con il nuovo sistema sarà il premio. Con il premio
si vince ma per vincere i partiti devono coalizzarsi prima delle
elezioni così come bisognava fare per conquistare i seggi nei
collegi. Il premio quindi favorisce la formazione di coalizioni
pre-elettorali e rappresenta dunque un incentivo alla
conservazione di un assetto bipolare. Ma il premio contiene
anche un paradosso che è impossibile eliminare. Nel nuovo
sistema esso viene assegnato alla coalizione con più voti,
indipendentemente dal loro ammontare. Potrebbero essere anche
meno del 30%. Questo può incoraggiare alcuni partiti a tentare la
strada del terzo polo. Ma il problema non è risolvibile
semplicemente fissando una soglia (diciamo il 40%) per ottenere
49
il premio. Una soglia così alta diventa un incentivo a non entrare
in coalizione per non fare scattare il premio, così da trasformare
il sistema in un proporzionale senza correttivo. Non esiste via
d’uscita sicura da questo paradosso, il che spiega perché nessuna
democrazia oggi utilizza sistemi del genere.
Certo, oggi è difficile immaginare che alla Camera possa
nascere un terzo polo competitivo, in grado di conseguire sul
piano nazionale oltre il 30% dei voti. Ma domani non è detto,
soprattutto in presenza di un’ampia ristrutturazione degli
allineamenti partitici. E in ogni caso c’è il Senato, dove la
situazione è più favorevole a tentazioni “terzopoliste”. Qui il
premio è regionale e non nazionale. Per scardinare il bipolarismo
basta che ci siano uno o più partiti con un consistente
radicamento territoriale in una o poche regioni. Vincendo in
queste regioni avrebbero un numero di seggi sufficiente ad
impedire il conseguimento della maggioranza parlamentare a una
delle due coalizioni maggiori.
Quindi il premio, pur avendo una funzione simile a quella
del collegio uninominale, non rappresenta una garanzia che il
bipolarismo sopravviva. Ma anche se così fosse il bipolarismo
fondato sul premio di maggioranza sarà certamente un
bipolarismo più debole di quello fondato sul collegio. Che alla
fine si vinca o si perda, per avere seggi uninominali bisogna
comunque fare parte di una coalizione; con il premio di
maggioranza non è così. In questo caso la prospettiva di perdere
indebolisce ancor di più il vincolo di coalizione e aumenta
ulteriormente il potere di ricatto dei partiti “ribelli”. Infatti, visto
che perdendo non si incassa il premio e non si va al governo,
tanto vale star fuori e fare una campagna elettorale per conto
proprio tenendosi le mani libere per il dopo. Da questo punto di
vista un sistema proporzionale a premio di maggioranza
funziona, per i presunti perdenti, né più né meno come un
sistema proporzionale puro. Quindi, il bipolarismo fondato sul
premio di maggioranza funziona per la coalizione vincente ma
molto meno per quella perdente.
50
Ma anche se il bipolarismo sopravvivesse che bipolarismo
sarebbe? Migliore o peggiore dell’attuale? Su un punto
concordano quasi tutti: per migliorare le prospettive di
governabilità del paese occorrono coalizioni meno frammentate e
più coese, capaci quindi di dar vita a governi stabili e decidenti.
Al di là di ogni altra considerazione, coalizioni più coese vuol
dire coalizioni con meno partiti. Ma nemmeno su questo terreno,
quello della riduzione della frammentazione del sistema partitico,
è stato fatto un passo avanti decisivo. La soglia di sbarramento
del 2% alla Camera è troppo bassa. Per di più è stato previsto il
ripescaggio per il miglior partito di ogni coalizione che non arrivi
al 2%. E comunque questa soglia non scoraggerà le coalizioni a
presentare molte liste, poiché anche i pochi voti ottenuti da quelle
ben al di sotto del 2% saranno utili per aggiudicarsi il premio.
Dunque, avremo ancora a che fare con coalizioni molto ampie.
Con una differenza negativa rispetto al passato: le coalizioni
saranno altrettanto larghe, ma meno coese.
Per cominciare non ci saranno più candidati e simboli
comuni. Senza collegio uninominale spariscono i candidati di
coalizione e restano solo le liste di partito, e per di più senza voto
di preferenza. Con il 100% dei seggi assegnati
proporzionalmente aumenterà la competizione tra i partiti dentro
le coalizioni e quindi il tasso di litigiosità. La tendenza a
sottolineare gli elementi di diversità, anziché quelli di unità, sarà
maggiore per motivi di visibilità e di marketing elettorale. In
aggiunta, il potere di ricatto dei piccoli partiti aumenterà, non
diminuirà. Con il nuovo sistema qualunque partito sopra la soglia
di sbarramento potrà permettersi di stare fuori di una coalizione,
o solo minacciare di farlo, perché in ogni caso la sua
sopravvivenza parlamentare sarà garantita. Prima la minaccia di
non far parte di una coalizione era un’arma a doppio taglio: se
fossero rimasti fuori avrebbero fatto danni agli altri, ma
sarebbero spariti. Ora non è più così. L’assegnazione di tutti i
seggi con formula proporzionale garantisce che ogni partito
sopra-soglia abbia comunque una rappresentanza parlamentare
quasi pari al suo peso elettorale anche correndo da solo. In
51
sintesi, avremo coalizioni più deboli e partiti più forti: non
propriamente un viatico al rafforzamento della governabilità del
sistema.
Ma il vero pasticcio è il Senato, dove il problema di fondo
è l’assegnazione del premio di maggioranza a livello regionale e
non a livello nazionale. Ne potrebbero derivare quattro esiti
negativi: il primo è che si produca a livello nazionale una
maggioranza inferiore al 55%, anzi poco sopra al 50%, dei seggi
totali, e quindi talmente risicata da compromettere stabilità ed
efficienza del governo; il secondo è che l’esistenza stessa di una
maggioranza finisca per dipendere dal voto dei sei senatori eletti
dagli italiani eletti all’estero; il terzo è che il Senato esprima una
maggioranza diversa da quella della Camera; il quarto è che a
una maggioranza di voti non corrisponda una maggioranza di
seggi (R. D’Alimonte, A. Chiaramente, Proporzionale ma non
solo, «Il Mulino», LV, n. 423, n. 1, 2006, pp. 35-42, passim).
52