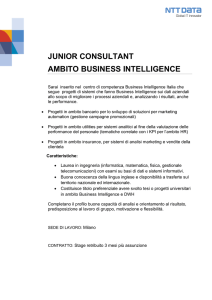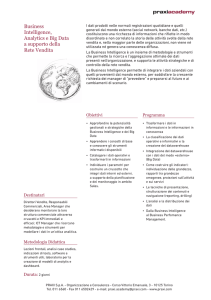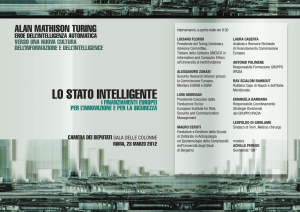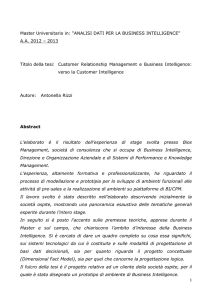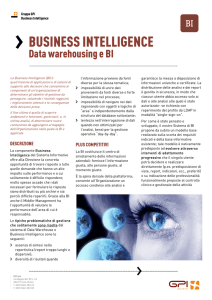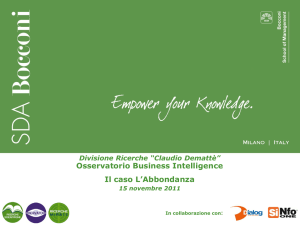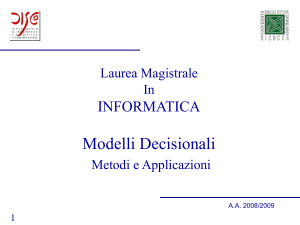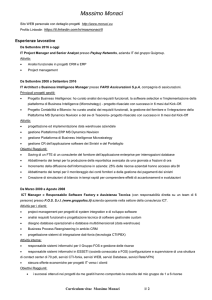XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
Intelligence Economica tra accademia e realtà
di Francesco Farina1
1. PREMESSA - 2. INTELLIGENCE E SICUREZZA ECONOMICA – 3. INTELLIGENCE ECONOMICA E ACCADEMIA – 4. LO
SPAZIO D’AZIONE DELL’INTELLIGENCE ECONOMICA – 5. SERVIZI DI INTELLIGENCE ECONOMICA E VALORE
ECONOMICO DEI BENEFICI – 6. CONCLUSIONI – BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Abstract
L’intelligence economica è una disciplina in continua evoluzione, non perfettamente
ascrivibile ai canoni accademici, ma che affonda le proprie radici su discipline scientifiche
assai note.
L’analista di intelligence economica è quella figura chiamata a realizzare i dettami di questa
disciplina, combinando l’azione di intelligence, storicamente legata alla tradizionale
protezione degli interessi politici e militari del Paese, all’azione di analisi ed elaborazione di
scenari, tipica invece del contesto scientifico, economico e aziendale.
L’intelligence economica, in Italia come in altri Paesi, ha avuto come principale elemento
propulsore la tutela degli interessi economici, scientifici e industriali, operazione la cui regia
può essere interpretata dagli organismi istituzionali, dalle aziende o dalla loro azione
coordinata.
La sicurezza e la competitività della singola azienda è elemento di una più importante
equazione della sicurezza e competitività del Sistema Paese; sembra pertanto naturale, come
avviene da diversi anni negli altri Paesi, che intelligence “istituzionale” ed intelligence
“aziendale” individuino modalità di incontro e condivisione di informazioni, nel rispetto della
riservatezza e dei propri ruoli. Partendo dallo scenario di riferimento, si individueranno attori,
conoscenze e competenze che potrebbero far parte di un sistema regolato di condivisione delle
informazioni, anche alla luce dell’esperienza internazionale.
Phd in Public Management & Governance, Coordinatore del Master di II livello in “Intelligence Economica” organizzato
dal CISPA (Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione) dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
1
1
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
1. Premessa
Quello di intelligence economica è un concetto in piena evoluzione che va implementandosi
in tutti i Paesi, siano essi industrializzati o in via di sviluppo, con obbiettivi e interessi diversi,
a seconda di quelle che sono le peculiarità nazionali da tutelare o da promuovere.
L’intelligence economica di uno Stato non può essere ricondotta alla sola azione dei suoi
Servizi di Informazione su tematiche economiche e finanziarie, ma deve identificarsi in un
sistema integrato di cui l’informazione è certamente il pilastro portante. All’interno del
sistema ci sono poi, da un lato, gli attori economici, pubblici e privati, nazionali e locali, che
definiscono gli obiettivi a cui collegare la richiesta di informazione; dall’altro, coloro che
dovranno utilizzare quella informazione per prendere le decisioni strategiche, siano esse
finalizzate ad un beneficio individuale o ad uno collettivo. Presupposto fondamentale,
affinché sussista e funzioni un sistema integrato di intelligence economica, è la definizione
degli obbiettivi comuni e l’allineamento su conoscenze e competenze che devono
caratterizzare gli attori dell’intelligence economica, aziende come istituzioni, decisori come
analisti.
2. Intelligence e sicurezza economica
E’ ormai prassi consolidata identificare lo sviluppo dell’intelligence economica nei Paesi
economicamente avanzati con la caduta del muro di Berlino e con la fine della Guerra Fredda.
La guerra economica in sé ha invece origini e sviluppi ben radicati nei secoli precedenti,
essendo sempre stata ragione, implicita o esplicita, delle guerre in campo militare. Il
cambiamento evidente del post guerra fredda è quindi la maggiore attenzione posta alla
correlazione tra economia e sicurezza, spostando la “potenza di fuoco” dal campo militare a
quello economico, con il controllo dell'informazione divenuto fattore determinante della
competizione globale.
Lo sviluppo dell’intelligence economica si ricollega quindi allo sviluppo e alla tutela della
ricchezza di una nazione, identificabile tanto nelle risorse naturali di cui questa dispone,
quanto nei suoi investimenti, frutto di attività di ricerca ed innovazione, intellettuale,
scientifica ed industriale.
Il processo di globalizzazione ne ha indubbiamente accelerato le dinamiche, con Stati e
aziende alla ricerca di vantaggi competitivi e concentrati sulla difesa dallo spionaggio
economico del proprio capitale scientifico ed intellettuale.
In tal senso, l’attività d’intelligence economica è andata sempre più assumendo un ruolo
chiave a supporto del processo strategico e decisionale di Stati ed imprese, seppur diversi
sono stati i tempi di reazione e le modalità di attuazione da parte dei singoli Paesi e dei
rispettivi Servizi Istituzionali e Agenzie.
Negli Stati Uniti il concetto di sicurezza economica nazionale trova evidenza con la prima
presidenza Clinton, ed in particolare con la National Security Strategy, che prescriveva che i
Servizi informativi USA dovessero seguire gli sviluppi politici, economici, sociali e militari in
tutte le parti del mondo, in tutti i settori in cui fossero coinvolti interessi americani e dove le
informazioni da fonti aperte fossero insufficienti. Una linea che ha portato ad una intelligence
macroeconomica anche a beneficio delle singole imprese, implicando quindi un passaggio da
un approccio difensivo, del periodo della guerra fredda, ad uno più offensivo.
Tra le principali iniziative messe in atto in quegli anni, oggi pressoché invariate, vanno
ricordate:
2
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
il National Economic Council, costituito nel 1993, che svolge attività di staff alla
politica economica del Presidente, ma anche di controllo delle linee strategiche da
questo definite, oltre a verificare la coerenza delle iniziative assunte dai vari
Dipartimenti delle Agenzie federali. In buona sostanza, si occupa quindi della
sicurezza economica;
l’Economic Espionage Act, la legge sullo spionaggio economico;
l’Advocacy Center, che venne creato nel 1993 al fine di sostenere le imprese
americane all’estero; costituisce uno dei centri più dinamici dell’intelligence
economica degli USA.
In Russia, sicurezza interna ed esterna, così come attività di spionaggio e di
controspionaggio, erano in capo al KGB; in seguito, con la scomparsa dell’Unione Sovietica,
e soprattutto dopo il tentativo di colpo di stato contro Gorbaciov, nel 1991 il KGB cessò di
esistere e l’intelligence della federazione russa è stata separata e fa capo a due istituzioni
diverse (FSB, Sicurezza interna e controspionaggio; SVR, Spionaggio Estero), lasciando
inalterato il servizio di intelligence militare. Entrambi fanno capo all’Amministrazione
Presidenziale e, in particolare, al Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Dopo il
1991 il focus dell’intelligence russa, prima orientato all’acquisizione delle tecnologie
strategiche, inizia a spostarsi anche sull’acquisizione di informazioni economiche ed
industriali.
Quello che ha sempre contraddistinto l’intelligence russa è il modello di reclutamento di
agenti destinati allo spionaggio, che non è presente in nessun altro Paese. Dei veri e propri
talent scout reclutano dei giovani brillanti nelle scuole secondarie e nelle università
occidentali. Gli agenti possono aspettare anche 20 o 30 anni prima di diventare operativi,
dopo che hanno fatto carriera nelle istituzioni o nelle industrie del loro Paese. La Russia è
molto attiva dal punto di vista delle tecnologie, ha una serie di stazioni di ascolto che coprono
l’intero globo, così come circa 160 satelliti in orbita per quanto riguarda l’IMINT (IMagery
INTelligence).
L’intelligence economica francese si è sempre caratterizzata per lo stretto rapporto tra lo
Stato e le grandi imprese, che condividono tra l’altro la formazione di dirigenti pubblici e
privati provenienti quasi interamente dalle Grandes Écoles, collaborazione che coinvolge
anche le associazioni di categoria e le università, accentuatasi soprattutto nei primi anni del
dopoguerra. Lo sdoganamento dell’intelligence economica in Francia si deve principalmente
al rapporto dell’allora Commissariat Général du Plan curato da Henri Martre (poi diventato
Centre d’analyse stratégique CAS dal 2006, e dal 2013 Commissariat général à la stratégie et
à la prospective CGSP), nel quale emergeva la prospettiva di migliorare le capacità offensive
e difensive dell’intelligence economica sia pubblica che delle imprese. Nel 1995, al fine di
dare attuazione alle raccomandazioni di Martre, venne istituito il Comité pour la
Compétitivité et la Sécurité Economique (CCSE), con compiti simili a quelli del National
Economic Council americano.
Il Regno Unito, contraddistintosi sempre per la riservatezza sull’organizzazione e sulle
attività dei Servizi di Intelligence, ha approvato nel 1994 il British Intelligence Services Act,
che ha precisato i compiti dell’apparato dell’intelligence britannica, autorizzandolo di fatto a
svolgere qualsiasi attività nei due settori, della sicurezza nazionale e del benessere economico
del Regno Unito, pur tenendoli separati, rispetto agli Stati Uniti che consideravano invece il
benessere economico come una componente determinante della sicurezza nazionale.
Anche la Germania è sempre stata molto attiva, con una forte integrazione tra il settore
pubblico e le imprese private, coordinate dalla diffusione di documenti che fissano le linee
guida delle strategie da seguire per l’intelligence economica e industriale nelle varie regioni
3
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
del mondo. I Servizi Tedeschi sono particolarmente attivi nel settore delle intercettazioni e
della “pirateria informatica”, in particolare grazie alla stretta collaborazione con la Siemens,
che permette l’afflusso di un’enorme quantità di notizie, che vengono analizzate e diffuse alle
istituzioni e alle imprese.
Verso la metà degli Anni Ottanta il BND (Bundes Nachrichten Dienst), il Servizio Federale di
Sicurezza Esterna, mise in atto il progetto “Rahad”, con il quale puntava ad accedere alle
banche dati di aziende e governi di tutto il mondo, riorientato nel 1991 dopo la guerra fredda
su obbiettivi economici, finanziari, tecnologici e commerciali.
Il Giappone, con il suo DRP (Department of Research and Planning), ha sempre attribuito
una grande importanza all’intelligence economica offensiva e allo spionaggio industriale,
coinvolgendo non solo le istituzioni dello Stato, ma anche le imprese, le banche, le Università
ed altri attori specializzati in reperimento legale ed illegale delle informazioni. Nonostante le
dimensioni del servizio di intelligence siano molto ridotte, l’intelligence economica
giapponese è una delle migliori del mondo.
In Cina la commissione statale per la scienza e la tecnologia (SSTC) istituita nel 1958 e
ristrutturata nel 1975, si dedica alla localizzazione, identificazione e raccolta di tecnologia per
perseguire il raggiungimento degli obbiettivi economici.
Sono tre i servizi di intelligence coinvolti anche nella raccolta di informazioni economiche e,
soprattutto, tecnologiche:
il Ministero per la Sicurezza dello Stato (MSS), che si occupa della sicurezza esterna;
il Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS), che si occupa della sicurezza interna e
del controspionaggio, ma effettua anche attività di intelligence nei riguardi degli
stranieri residenti in Cina;
il Dipartimento Militare di Intelligence (MID), che svolge attività di supporto in
campo TECHINT (TECHnical INTelligence) a favore degli altri servizi ed è
incaricato di raccogliere dati sulle tecnologie militari.
L’MSS riveste una particolare importanza per l’intelligence economica; secondo un rapporto
presentato dal Pentagono al Congresso USA, il MSS opera nel campo dell’intelligence
economica e tecnologica secondo tre modelli:
1. il reclutamento diretto di scienziati e di accademici, inviati poi all’estero di massima
per un periodo di sei anni;
2. l’acquisizione, da parte di imprese cinesi, di compagnie occidentali, per venirne in
possesso delle tecnologie;
3. l’acquisto di tecnologie tramite ditte cinesi, collegate con l’MSS. Secondo l’FBI,
questo metodo ha prodotto i maggiori risultati; sarebbero 3.000 le società cinesi
coinvolte nella ricerca tecnologica.
Negli Anni Novanta i Paesi più industrializzati si adeguavano quindi al nuovo paradigma
dell’intelligence, e anche in Italia, con l’allora Presidente Cossiga, se ne iniziava a parlare, in
particolare con la creazione di un gruppo di lavoro per la riforma dei Servizi anche per
favorire l’evoluzione di un concetto di intelligence economica non ancora ben definito, che
faceva riferimento esclusivamente alla sicurezza economica dello Stato, intesa come ricerca e
contrasto di pericoli che corre lo Stato a seguito di vicende economiche.
Questa visione restrittiva dell’intelligence economica derivava dal fatto che, andando ad
attribuire competenze economiche ai Servizi, si potevano generare conflitti con l’attività di
politica interna ed estera svolta dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione.
La vera svolta in termini di intelligence economica si è però avuta solo nel 2007 con la Legge
di riforma dei Servizi (Legge 124/2007), integrando la mission delle due Agenzie Italiane
4
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
ribattezzate con l’occasione AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, delegata a
svolgere attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di
informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia, e a individuare e contrastare al
di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a
danneggiare gli interessi nazionali) e AISI ( Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, con le
stesse deleghe ma per l’interno).
La legge 124/2007 ha quindi cercato di risolvere la diatriba legata alla attribuzione di
competenze economiche ai Servizi, che potessero generare conflitti con l’attività di politica
interna ed estera svolta dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione. La necessità era infatti
quella di mettersi al passo con gli altri Paesi per giungere ad un’integrazione culturale tra
l’attività svolta dai Servizi con quella politica e della Pubblica Amministrazione, oltre che alla
promozione della cultura di intelligence presso l’opinione pubblica.
3. Intelligence Economica e Accademia
La lettura delle esperienze internazionali mostra come lo sviluppo di attività accademica e
scientifica nel campo dell’intelligence economica sia andato di pari passo ai processi di
implementazione operativa ed organizzativa attuati dai Governi.
L’accademia infatti è solita studiare, analizzare e modellizzare fenomeni ed esperienze, al fine
di realizzare, soprattutto in campo economico, circoli virtuosi di crescita e innovazione. Lo
studio dell’intelligence economica non implica la costruzione ex novo di concetti e modelli,
ma serve soprattutto a dare una visione integrata e sistemica del perfezionamento di discipline
accademiche esistenti.
L’attività di intelligence in sé consiste nella ricerca, raccolta, sistematizzazione e analisi di
dati ed informazioni, ma, nella sua applicazione, non la si considera come mero strumento di
ricerca di informazioni sensibili, quanto piuttosto parte integrante di un processo strategico e
decisionale.
L’intelligence economica si è pertanto affermata come attività al servizio delle decisioni
strategiche, che contempla e richiama concetti, strumenti, metodologie, conoscenze e
competenze sviluppate in diversi contesti, commerciali come istituzionali, accademici come
operativi, scientifici come industriali.
Il Prof. Paolo Savona è solito inquadrarla come disciplina “onnivora”, in particolare di
contenuti delle materie di economia e management, ma in realtà i settori scientificodisciplinari da cui attinge sono numerosi, dalla matematica all’informatica, dalla geologia alla
geofisica, dall’antropologia alla genetica, dai sistemi per l’energia e l’ambiente alle
telecomunicazioni, dalla storia medievale alla psicologia sociale, dal diritto privato al diritto
penale, oltre ovviamente a tutti i settori delle scienze economiche e statistiche.
Lo sviluppo accademico dell’intelligence economica è quindi direttamente correlato alla sua
implementazione da parte dei Governi, e si concretizza generalmente quando si realizzano
quattro passi fondamentali:
I.
la diffusione della cultura di intelligence tra Amministrazioni Pubbliche, aziende e
opinione pubblica;
II.
l’inserimento dell’intelligence economica tra le leve strategiche per la definizione di
politiche economiche ed industriali di un Paese;
5
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
III.
l’adeguamento anche normativo delle mission e della sfera di azione dei Servizi e
delle Agenzie Istituzionali e la definizione di modalità di integrazione e
comunicazione con istituzioni e centri decisionali;
IV.
la realizzazione di sistemi di integrati di intelligence economica nei quali coinvolgere
e valorizzare Servizi ed Agenzie Istituzionali, aziende, Università e centri di ricerca,
organi strategici e decisionali pubblici.
La Francia, ad esempio, è il Paese che maggiore innovazione ha portato alla teorizzazione
dell’intelligence economica2; oltre ad aver sempre posto grande attenzione nella formazione
tanto dei manager pubblici quanto di quelli privati nelle proprie “écoles”, si è puntualmente
mossa con la promozione governativa di centri di ricerca e di attività formative in ambito
universitario e ha sviluppato una cultura accademica specifica sul tema. A titolo di esempio si
elencano alcuni dei principali corsi avviati da Università e Centri Studi francesi reputati
“migliori” nel 20103:
1) Master en Stratégie d’intelligence économique de l’École de guerre économique;
2) Mastèr espécialisé intelligence scientifique, technique et économique de l'ESIEE
(École supérieure d'ingénieurs en électonique et électrotechnique);
3) Mastère spécialisé intelligence économique et knowledge management du CERAM
(Sophia Antipolis);
4) Master en intelligence économique et stratégie d'entreprise du Groupe ESC Toulouse;
5) Mastère spécialisé en intelligence économique et stratégique de l'EISTI;
6) Master intelligence économique et communication stratégique de l'ICOMTEC
(Université de Poitiers);
7) Master en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (option
valorisation de l'information) de l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence;
8) Master en Intelligence Economique et Territoriale de l'Institut Ingémédia (Université
du Sud de Toulon et du Var);
9) Master en Intelligence économique et stratégies compétitives à l'Université d'Angers;
10) Master en Sciences économiques, Mention : Intelligence économique (Université de
Toulouse);
11) Master spécialisé en Intelligence Economique et Développement des entreprises à
l'École Européenne d'Intelligence Economique (EEIE);
12) Master spécialisé Intelligence Économique et Gestion de l'innovation IEGI de
l'université Jean Monnet.
L’Italia si presenta in netto ritardo rispetto ad altri Paesi, con un processo operativo e culturale
che, come osservato, ha potuto avere di fatto inizio solo a partire dal 2007.
Anche lo sviluppo di una accademia dedicata ha pertanto risentito di questo ritardo, con una
disciplina che fino a qualche anno fa è stata contemplata sempre in modo destrutturato e mai
sistemico, considerata per singole discipline, e come parte non caratterizzante di corsi di
intelligence “tradizionale”, di geopolitica, di business intelligence, o di marketing strategico;
tutti contenuti che la caratterizzano, ma che presi solo singolarmente non possono certo
contribuire a studiarne, analizzarne e descriverne il fenomeno.
Paolo Savona in occasione della lectio magistralis tenuta all’apertura della I edizione del Master in Intelligence Economica
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
3 Si veda: http://www.ie-lobbying.info/wiki/index.php/Classement_des_meilleures_formations_en_intelligence_économique .
2
6
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
Con l’apertura al concetto di sicurezza economica, e con l’inizio del processo di
trasformazione dei Servizi, anche in termini di recruitment e di perfezionamento delle aree di
competenza, si è cosi iniziato a colmare anche il “vuoto accademico”4.
I primi passi dell’Università Italiana, a fronte della nota “école de guerre economique”
francese nata nel 1997, si possono identificare con il primo Master di II livello in Italia su
Intelligence Economica attivato nel 2011 a cura dell’Università di Tor Vergata; certamente
testimonianza del processo in atto5, ma di fatto primo oggettivo riscontro di passaggio
accademico ben 14 anni dopo la nascita della principale scuola francese.
4. Lo spazio d’azione dell’Intelligence Economica
Abbiamo visto come l’intelligence economica, pur nascendo in contesto di “guerra”, diventi
un importante supporto per le decisioni strategiche da assumere in campo economico,
aziendale, commerciale, scientifico e industriale.
Il fatto stesso di affiancare la parola “economica” ad “intelligence”, impone di considerare il
beneficio economico che questa attività può generare, sia esso collettivo e riferito al sistema
Paese, il che ci porta nella sfera di attività e mission di Servizi di informazione e Agenzie
Istituzionali, o esclusivo, riconducibile quindi alle singole imprese, che ci porta invece verso
una intelligence aziendale.
Nella realtà è difficile sancire un confine netto tra intelligence cosiddetta “istituzionale” ed
intelligence “aziendale”, piuttosto i moderni servizi di intelligence istituzionali cercano forme
e modalità di collaborazione che possono essere più o meno integrate.
La tutela degli interessi economici, scientifici e industriali, è il filo rosso che mette d’accordo
tutti, siano essi attori pubblici o privati.
Ogni Stato orienta l’azione di intelligence economica a seconda delle proprie peculiarità da
promuovere o da tutelare, ed a seconda quindi del contesto economico e della congiuntura in
cui opera.
Uno Stato emergente e in crescita tenderà pertanto ad azioni di intelligence economica più
competitive per acquisire informazioni strategiche che siano di supporto allo sviluppo delle
proprie realtà aziendali ed industriali; uno Stato industrializzato e innovatore tenderà ad azioni
di intelligence economica più difensiva a tutela degli investimenti, delle ricerche, ed in
generale del capitale fisico ed intellettuale costruito con sacrifici e risorse.
Ci sono contesti in cui i Governi agiscono più da facilitatori di mercato, garantendo al suo
interno la leale e corretta competizione, altri in cui essi puntano tanto alla protezione quanto
all’espansione e promozione delle industrie nazionali (“campioni”) cercando di incidere
direttamente sui mercati e supportando il settore privato con ampi servizi e informazioni.
Il Giappone fu il primo Paese industrializzato a fare dell’“informazione” una fondamentale
leva del proprio sviluppo, rendendola, a differenza dei paesi anglosassoni, una risorsa
collettiva, puntando a sinergie su strategie tecnologiche, industriali e commerciali che sono
inscindibili dal sistema di intelligence economica offensivamente orientato.
Martre nel suo rapporto aveva cosi sintetizzato le cinque maggiori caratteristiche dell’uso
strategico dell’informazione6:
- un approccio globale e locale al mondo dei mercati;
Si veda anche L. Hinna in “A scuola di Intelligence Economica” - Articolo di L. Ciaccia – Formiche, 29.11.2012 http://www.formiche.net/2012/11/29/a-scuola-di-intelligence-economica
5 Si veda Relazione 2011 sulla Politica della Informazione per la sicurezza.
6 Potter E. H., Economic Intelligence & National Security, McGill-Queen's Press, 1998.
4
7
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
-
un approccio che è integrato con le strategie di ogni Paese che le aziende giapponesi
stanno tentando di capire;
- una strategia a lungo termine;
- un approccio integrato con le strategie delle multinazionali giapponesi;
- la diffusione selettiva della conoscenza.
Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un sistema asimmetrico e decentrato, con il più grande
mercato aziendale di intelligence, orientato maggiormente all’interesse singolo che a quello
collettivo.
L’amministrazione Clinton ha tentato in proposito di esercitare un maggior controllo sulle
sfide economiche rivolte agli Stati Uniti, attraverso tre comitati (sicurezza nazionale,
economia, e interno), tutti con uguale potere, e che riferiscono direttamente al Presidente. La
nuova struttura istituzionale rifletteva il desiderio a livello dell’esecutivo di organizzare
meglio i diversi canali e le diverse fonti di intelligence economica, ed ha implicato anche un
aumento della disponibilità dell’intelligence aziendale a cooperare con il Governo federale nel
modellare una strategia aziendale internazionale condivisa.
In contrasto con il sistema americano e simile a quello giapponese, il sistema tedesco è
caratterizzato da un ingente volume di informazione derivante da una rete fortemente
intrecciata e guidata da banche, compagnie assicurative e grandi gruppi industriali. A ciò si
aggiunge un sistema di camere di commercio, perfettamente coinvolto in tutti gli aspetti delle
politiche locali, provinciali e federali.
La Francia promuove lo sviluppo di “poles de competitivitée”, una sorta di cluster o distretti
territoriali, in cui organizzazioni, enti pubblici e aziende si uniscono e mettono a sistema
informazioni e ricerche per realizzare innovazione tecnologica ed industriale, e guadagnare
reciproci vantaggi competitivi. Al fine di ottimizzare la capacità di comunicazione e
coordinamento con le imprese per la raccolta e diffusione delle proprie conoscenze, la Francia
nel 1992 creò un’associazione per la promozione di intelligence economica e competitiva
(“l’Association pour la promotion de l’intelligence économique et concurrentielle”).
Le politiche di intelligence economica godono di maggiore interesse quando sussistono
situazioni di crisi, e governi ed aziende cercano un rilancio dell’economia in un contesto in
cui si fa più forte la contrapposizione verso le aziende straniere e si è più esposti allo
spionaggio economico industriale. In un mondo globalizzato, però, diventa anche complicato
stabilire quando un’azienda è straniera, basti pensare ad alcune multinazionali, quali General
Motors, Coca-Cola, Chevron, o IBM, McDonald’s, etc.; come si può fare azione di protezione
delle aziende nazionali quando queste, diversificando la produzione, le vendite e le proprietà
in tutto il mondo, diventano di fatto ad esse parificate e contribuiscono alla ricchezza dei
Paesi in cui operano?
L’intelligence economica opera quindi in un contesto globale, in cui sono venuti meno i
vantaggi competitivi tanto cari a Ricardo, e in cui vige invece costante una guerra economica,
dove gli Stati che sono militarmente amici, non lo sono nel contesto economico, dove
addirittura potrebbero essere i primi nemici ad esempio mettendo in atto azioni di spionaggio
economico.
Sulla base delle notizie ricevute da Wikileaks su nota dell'Ambasciata degli Stati Uniti a
Berlino, il 4 Gennaio 2010 il quotidiano norvegese Aftenposten scriveva che la Francia, più di
Cina e Russia, era il Paese più attivo in termini di spionaggio industriale nei confronti dei suoi
alleati europei, tanto che il danno che arreca all'economia tedesca, nel complesso, è maggiore
dei danni causati dalla Cina o dalla Russia.
8
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
5. Servizi di Intelligence Economica e valore economico dei benefici
Abbiamo visto come, che abbia impostazione difensiva o che si spinga ad intelligence
competitiva fino allo spionaggio economico, a seconda della collettività del beneficio offerto,
l’intelligence economica può essere classificata in istituzionale o aziendale.
L’intelligence istituzionale lavora al servizio dei governi e ha mission e sfera d’azione
differenti a seconda dei fini ultimi che il Governo vorrebbe raggiungere con i benefici ottenuti
dalle informazioni ricevute.
Quando il beneficio è collettivo ed è il Governo a commissionare i prodotti informativi, si
possono classificare sei tipologie di interesse da perseguire7:
1) il controllo delle attività dei servizi di intelligence estera e attività clandestine dirette
contro i loro interessi economici e commerciali;
2) la tutela dei reati contro la competitività del Sistema Paese;
3) il supporto alle decisioni strategiche di tipo economico-finanziario;
4) la verifica del rispetto degli accordi internazionali, supporto agli accordi commerciali,
tutela delle aziende nazionali da pratiche commerciali sleali, corruzione etc.,
5) l’attività di influenza e condizionamento di eventi, comportamenti e politiche di Paesi
esteri;
6) la ricerca di informazioni sensibili relative ad aspetti commerciali, organizzativi e
tecnologia, per favorire la competitività di aziende nazionali.
Le sei tipologie segnalate vanno in ordine crescente di “invasività” dell’azione di intelligence
e mostrano sostanzialmente il suo passaggio da una impostazione prettamente difensiva ad
una estremamente competitiva.
La prima tipologia è quella che tutti hanno a fattor comune, alla base del concetto di
salvaguardia della sicurezza economica nazionale, e della tutela degli interessi economici,
scientifici e industriali, in questo caso attraverso il controllo delle mosse dei servizi stranieri.
Alcuni Stati utilizzano i propri servizi di intelligence per prevenire e limitare le possibilità di
acquisto di proprie aziende strategiche da parte di società straniere; per contro ce ne sono altri
che li utilizzano per favorire l’acquisto da parte delle proprie.
La seconda, in parte appendice della prima, ha la funzione di tutelare la competitività dei
mercati e del Sistema Paese, minacciata da azioni illecite e dinamiche criminali, il cui
contrasto prevede azioni spesso congiunte di intelligence e polizia, a prevenire e contrastare
azioni illegali o criminali sui mercati da parte di concorrenti sleali o vere e proprie
organizzazioni criminali.
Trattasi di azioni che rientrano anche tra i compiti dell’intelligence istituzionale nel momento
in cui vanno a minare la solidità di un sistema produttivo e pertanto la sicurezza economica
nazionale. Particolare importanza stanno assumendo in tal senso i fenomeni della
contraffazione e del riciclaggio di proventi illeciti, con intrecci spesso internazionali, oltre ad
altre fattispecie delittuose quali frodi fiscali, truffe, appropriazioni indebite, reati fallimentari,
riciclaggio di proventi illeciti, usura e traffico di stupefacenti.
La terza tipologia è quella che rende più nobile l’attività di intelligence economica e la rende
maggiormente partecipe al processo strategico decisionale: i servizi di intelligence infatti,
attraverso le loro peculiari ed esclusive capacità di raccolta, se adeguatamente preparati
possono essere in grado di fornire preziose indicazioni, analisi di scenario e di prospettiva,
7
Si veda anche Porteous in Potter E. H., Economic Intelligence & National Security, McGill-Queen's Press, 1998.
9
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
valide per ottimizzare decisioni strategiche in materia di politica economica finanziaria ed
industriale.
Il supporto alle aziende in ottica difensiva è anch’essa prassi consolidata a quasi tutti i servizi
d’informazione; esso consiste nel supporto che l’intelligence, in modo più o meno esplicito,
dà alle aziende che si internazionalizzano in Paesi dalle situazioni geopolitiche e
geoeconomiche particolari, ma non solo.
La conclusione di accordi commerciali avviene spesso per lo screditamento del competitors
internazionali; trattasi quindi di attività sostanzialmente di controinformazione finalizzata ad
influenzare importanti decisioni economiche di Paesi stranieri con l’obbiettivo di
avvantaggiare imprese amiche, o favorire l’acquisto di risorse energetiche.
L’ultima tipologia è certamente quella che maggiori discussioni e problematiche genera, da un
lato, perché consiste nello spionaggio economico effettuato con metodologie riservate ai soli
servizi di informazione istituzionali, ma messe a disposizione di aziende amiche; dall’altro,
perché creare condizioni di vantaggio ai cosiddetti “campioni nazionali” crea comunque una
disparità di trattamento verso altre aziende nazionali concorrenti. La maggior parte delle
potenze occidentali sconfessa apertamente qualsiasi coinvolgimento in questa attività, ma
disse un celebre autore: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”.
Le aziende, oltre a godere del beneficio collettivo generato dall’intelligence istituzionale,
possono a loro volta mettere in atto attività di intelligence economica “aziendale”,
realizzandola al proprio interno tramite specifiche aree tendenzialmente riconducibili al
marketing strategico, o rivolgendosi a servizi di intelligence privata.
Rispetto ai servizi di informazione istituzionali, l’attività di intelligence delle aziende deve
limitarsi quasi esclusivamente alle sole fonti aperte, ma è anche in questo caso destinata al
supporto delle decisioni strategiche aziendali relative a produzione, vendite, marketing etc.
Le informazioni utili per una singola azienda sono sostanzialmente quelle relative a:
nuovi mercati di approvvigionamento o di sbocco nazionale ed estero;
fornitori e clienti nazionali ed esteri;
propri competitors nazionali ed esteri;
trend in atto, analisi di scenario e prospettiva.
Tali informazioni potranno essere usate sia in senso difensivo che competitivo, ed anche in
questo caso il passaggio da uso difensivo a competitivo rischia di sfociare in spionaggio
economico e industriale con le dovute conseguenze penali del caso.
L’”informazione”, quindi, è il pilastro portante del processo decisionale: migliore è la qualità
dell’informazione e potenzialmente più efficace sarà la decisione strategica ad essa
conseguente, seppure non sempre vi sia una correlazione diretta, ed in nessun caso la
decisione strategica è “obbligata” al risultato della attività di intelligence realizzata.
Deve esserci sempre implicito un beneficio economico, che può essere frutto dei maggiori
introiti derivanti da operazioni messe in atto da governi ed imprese nazionali, piuttosto che dei
costi risparmiati a seguito di azioni competitive o lesive della leale concorrenza da parte di
Governi ed imprese estere o da operazioni di spionaggio economico.
Ne consegue che le informazioni ottenute ed elaborate hanno un valore economico oltre che
commerciale che deve tener conto:
del costo di ricerca ed elaborazione;
della sua collocazione temporale;
del beneficio economico arrecato alla singola impresa o al Sistema Paese.
Lo spionaggio economico è certamente l’oggetto che viene messo più in risalto nelle attività
di intelligence, con Stati che talvolta sono vittime e altre protagonisti.
10
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
Porteous e Brander8, nel caso questo sia effettuato a cura dei servizi di informazione di uno
Stato a favore delle proprie imprese, dato il valore economico generabile, lo vedono
addirittura come forma di sussidio pubblico alle imprese.
Le nazioni più innovative sono quelle che più hanno da perdere, in quanto lo spionaggio
messo in atto andrà tendenzialmente a colpire i portatori di capitale intellettuale ed
innovazione tecnologica. Gli Stati Uniti in tal senso sono la nazione più esposta e che
maggiori risorse impegna sul controspionaggio. Furono proprio gli Stati Uniti a divulgare
questo aspetto, con la pubblicazione di alcuni libri che denunziavano l'attività di spionaggio a
danno delle loro aziende compiuta da Paesi amici e alleati, come la Corea del Sud, Taiwan e
Israele, ma anche Francia e Germania9. Nel 1993, il giornalista della Nbc Peter Schweizer con
“Friendly Spies”, raccontò le attività di spionaggio che amici e alleati svolgevano per
catturare soprattutto i segreti tecnologici, di uso civile e/o militare, delle imprese americane:
informazioni sulle strategie industriali e commerciali, sui brevetti, sulla partecipazione a gare
d'appalto.
Le aziende che beneficiano dell’opera di spionaggio risparmiano sugli investimenti in ricerca
e sviluppo, ma il danno complessivamente arrecato alle imprese ed alle nazioni vittime dello
spionaggio, sostiene Brander, sarà sempre superiore al beneficio generato.
Tra i casi più eclatanti si ricordano:
quello della “Hughes Aircraft” (società aerospaziale americana) dell’aprile del 1993,
che decise di non partecipare al Bourget Air Show in quanto avvisata d’essere stata
spiata dal servizio di intelligence francese (che puntava 49 compagnie americane)10;
nel 1992 i viaggiatori in business class americani furono informati di non volare con
Air France dopo la scoperta che il servizio di intelligence francese era solito
posizionare microspie in aereo utilizzando agenti infiltrati come passeggeri delle linee
aeree e come assistenti di volo11;
nel 1991 i servizi di intelligence della Germania Orientale furono accusati di
intercettare una compagnia estera di telecomunicazioni e di passare le informazioni
alle compagnie concorrenti tedesche;
nel 1980 gli agenti di intelligence giapponese furono sospettati, assieme alle
multinazionali giapponesi, di dirigere operazioni segrete contro le aziende di alta
tecnologia in California;
una compagnia sud coreana avrebbe pagato un impiegato della General Electric 1
milione di dollari all’anno per segreti commerciali concernenti la produzione sintetica
dei diamanti;
nel 2007 il campionato di Formula 1 è stato teatro del caso di spionaggio a danno della
scuderia Ferrari da parte della McLaren. Nigel Stepney, il capo meccanico, oltre ad
aver tentato un sabotaggio versando nei serbatoi delle vetture una polvere bianca
nell’aprile del 2007, consegna in McLaren un dossier di 780 pagine dettagliato dei
disegni tecnici della Ferrari F2007;
nel 1990 il gruppo Olivetti rimase coinvolto in una azione di spionaggio da parte di
due suoi dipendenti d’accordo con un’agente del KGB che cercava di acquisire il
sistema per proteggere i computer in uso alla NATO, non muniti di permessi del
Cocom (l’organismo atlantico che filtra la collocazione in aree sensibili di prodotti di
tecnologici a valenza strategica);
8
Potter E. H., Economic Intelligence & National Security, McGill-Queen's Press, 1998.
http://www.ilfoglio.it/soloqui/7066
10 Quinn-Judge, “U.S. Sends Warning on Corporate Spying”, Boston Globe, 30 Aprile 1993, 2.
11 James F. McCarty, “Cold War II Spies Target Trade Secrets”, Plain Dealer, 21 Marzo 1993.
9
11
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
gli OLED Tv sono al centro di diverse accuse di spionaggio tra LG e Samsung con
Samsung che accusa LG di spionaggio a seguito della presentazione di due prodotti
praticamente con tecnologie identiche al CES 2012 di Las Vegas (Consumer
electronics), oltre che tra la AU Optronics di Taiwan, contro la cinese Star
Optoelectronics Technology. In entrambi i casi i sospettati, che nel secondo caso sono
stati anche condannati, erano ricercatori e dipendenti passati alla concorrenza .
Nello spionaggio economico “tradizionale”, i passaggi di informazione passavano sempre per
mano di dipendenti o ricercatori complici; ma lo sviluppo della tecnologia e l’uso oramai
universale della rete ha allargato la modalità allo spionaggio elettronico, aprendo di fatto un
altro grande tema dell’intelligence economica che è la cyber war.
Gli importi dei danni causati agli Stati dalle azioni di spionaggio economico sono sempre
frutto di interpretazioni e stime, ma di difficile quantificazione.
L’Ufficio Scienze e Tecnologia della Casa Bianca aveva stimato un danno solo per
l’economia americana di oltre 100 miliardi all’anno. La Banca Mondiale afferma che, su un
“Prodotto Interno lordo” (PIL) globale di circa 70 miliardi di dollari nel 201, circa 400 milioni
di dollari sono stati persi a causa di atti di cyber crime.12
6. Conclusioni
Nonostante il ritardo con cui si è avviato il processo di implementazione dell’intelligence
economica, l’Italia sta progressivamente colmando quel gap normativo e operativo,
avvicinandosi per sfera d’azione e competenze agli altri Paesi.
Sul versante Servizi di Informazione, l’apertura voluta dall’allora direttore del DIS, il Prefetto
De Gennaro, e proseguita oggi dall’Ambasciatore Massolo, è stato il primo passo per la
promozione della cultura di intelligence presso aziende e opinione pubblica, andando
innanzitutto a sanare la percezione di una funzione quasi ignota ai più, spesso richiamata dalla
cronaca più per gli abusi di alcuni componenti del comparto che per l’effettivo ruolo e
funzione svolti per lo Stato e per la sicurezza collettiva.
Importante in tal senso è il lavoro svolto dalla scuola di formazione del DIS, e la
collaborazione promossa con le Università pubbliche, per sviluppare anche la cultura
accademica dell’intelligence economica. Sono stati avviati i primi Master Universitari e
proliferano Corsi, centri studi, blog, think tank, a dimostrazione di un cambiamento culturale
ben avviato.
Dal punto di vista operativo, dalla lettura delle Relazioni annuali al Parlamento emerge
l’impostazione difensiva dei Servizi Italiani, che segnalano puntualmente i trend in atto, le
minacce alla competitività da mire espansionistiche straniere e dai pervasivi insediamenti di
matrice mafiosa nei tessuti economici e produttivi, le minacce alla infrastrutture strategiche,
l’attenzione all’operato dei fondi sovrani, lo spionaggio economico e il rischio cybernetico
etc.
L’intelligence economica, però, come abbiamo visto, deve operare all’interno di un sistema
integrato, che oltre alla produzione di informazioni produca anche decisioni strategiche, e
quindi che, oltre ai Servizi di Informazione, veda collegati in una sorta di rete attori
economici, pubblici ed aziende, che costruiscono e contribuiscono all’intelligence economica
di un Paese. In tal senso si stanno sviluppando modalità di collaborazione e condivisione delle
informazioni con le aziende, in particolare con le Security delle grandi aziende strategiche,
Si veda anche: L’’impatto economico dello spionaggio informatico secondo Mcafee, di Niccolò De Scalzi in “Meridiani
Relazioni Internazionali” - http://www.meridianionline.org/2013/08/01/impatto-economico-spionaggio-informatico-mcafee/ .
12
12
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
mentre si è molto indietro con il coinvolgimento delle PMI, elemento caratterizzante del
sistema produttivo italiano. La maggiore semplicità a dialogare delle aziende a vocazione
internazionale, propense e abituate a confrontarsi con Servizi di Informazione italiani e
stranieri, si scontra infatti con l’approccio verso le piccole e medie aziende che operano nel
contesto nazionale, meno addentrate nel concetto di intelligence e diffidenti e restie a
condividere informazioni. Le Università in tal senso potrebbero essere quegli attori di
facilitazione tra le parti, che potrebbero contribuire a individuare modelli e strategie di
collaborazione, tipologia d’informazioni condivisibili nel rispetto dei rispettivi ruoli13.
Le PMI, come rilevato anche nelle Relazioni al Parlamento, costituiscono il fulcro delle
capacità di innovazione organizzativa, tecnologica e produttiva del Paese, il che le espone alle
mire espansionistiche, allo spionaggio economico, ed alle azioni lesive alla corretta e leale
competitività nei mercati. Singolarmente non sempre hanno forza, mezzi economici e
competenze per proprie azioni di intelligence economica, ma rappresentano e hanno
rappresentato per anni la peculiarità del tessuto produttivo italiano, quindi se non sono da
considerare singolarmente tra quelle cosiddette “strategiche”, dovrebbero esserlo certamente
nel senso di cluster, e rientrare a pieno titolo tra gli obbiettivi principali del sistema di
intelligence economica italiana, con il coinvolgimento di associazioni di categoria e attori
locali.
Gli Americani insegnano che la mancata collaborazione e l’assenza di sistema è un costo, così
come i Francesi danno quotidianamente segno delle azione unitaria con il Governo a
rafforzare le proprie mire espansionistiche; è sufficiente leggere delle operazioni di
acquisizione internazionali realizzate negli ultimi anni, e delle grosse commesse internazionali
acquisite nei vari settori dalle loro aziende, e della attenzione posta proprio sullo sviluppo dei
“poles de competitivité”.
La percezione è che, se l’intelligence economica si deve adattare e conformare alle peculiarità
del singolo Paese, proprio queste peculiarità sono quelle che meno si stanno tutelando in
Italia, non tanto per il lato operativo dell’intelligence economica, ma per il processo
decisionale che ne consegue. La crisi economica e soprattutto finanziaria delle PMI, la
svendita a Paesi stranieri, la totale assenza di una politica industriale ed energetica, mostrano
infatti le difficoltà non tanto a reperire informazioni strategiche, quanto piuttosto a prendere
decisioni strategiche, il che rende urgente chiudere quanto prima il cerchio dell’intelligence
economica, con l’allineamento anche in termini di competenze di tutti gli attori che ne fanno
parte.
L. Hinna in occasione del Seminario “L’Intelligence Economica
nelle ultime relazioni annuali di Governo e Comitato
Parlamentare di Controllo”, organizzato dal CISPA di Tor Vergata nell’ambito del Master di II livello in Intelligence
Economica presso ENEL lo scorso 13 Maggio.
13
13
XXVII Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 settembre 2013
Bibliografia essenziale
COISSARD S., FONTANEL M., ZECRI J.L., Intelligence économique et pôles de compétitivité: de
la gestion du capital informationnel à la création d’avantages compétitifs spécifiques, in
Management & Avenir, 2010/2 (n° 32);
FRAUMANN E., Economic Espionage: Security mission redefined, 1996;
HALBY E., Intelligenza economica e& tecniche sovversive. Le armi della nuova economia,
Franco Angeli, Milano, 2003;
IZZI S., Intelligence e gestione delle informazioni. Attività preventiva contro i traffici illeciti,
Franco Angeli, Milano, 2011;
JEAN C., SAVONA P. (a cura di), Geoeconomia. Il dominio dello spazio economico, Franco
Angeli, Milano, 1997;
JEAN C., SAVONA P., Intelligence Economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della
globalizzazione, Rubbettino Editore, 2011;
MARTRE H. (COMMISSARIAT
entreprises, 1994;
GENERAL DU
PLAN), Intelligence économique et Stratégie des
POTTER E. H., Economic Intelligence & National Security, McGill-Queen's Press, 1998;
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, Relazioni sulla politica
dell’informazione
per
la
sicurezza,
consultabili
su
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/la-relazione-alparlamento.html.
14