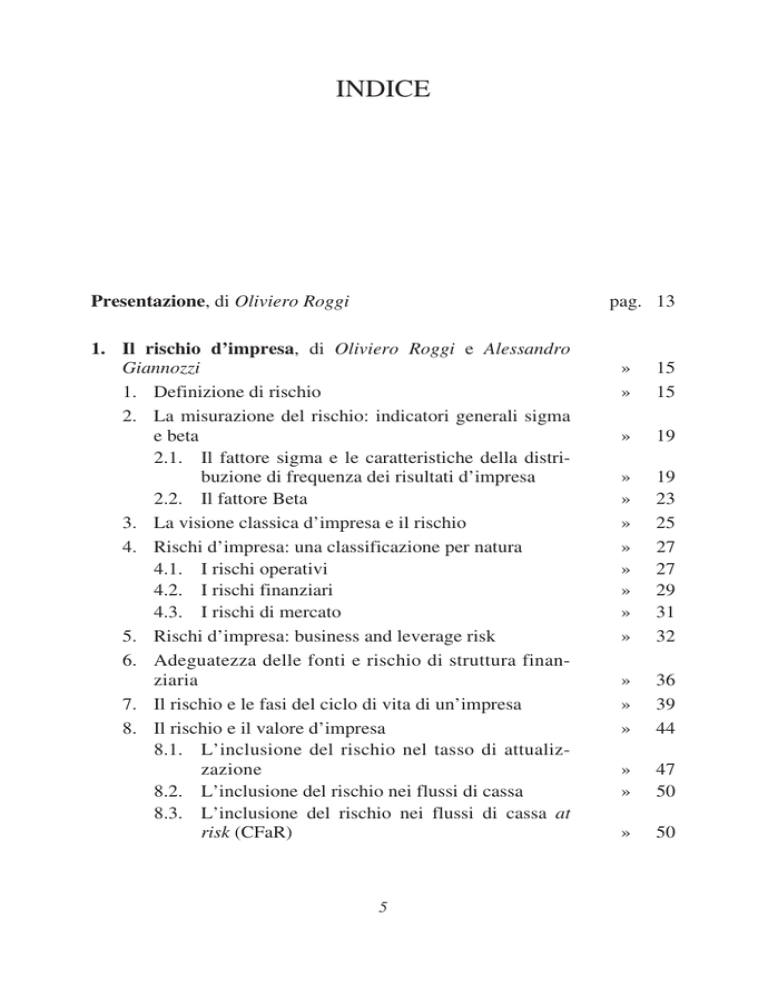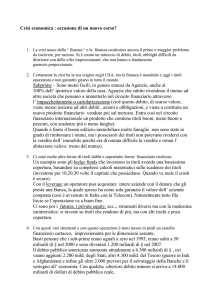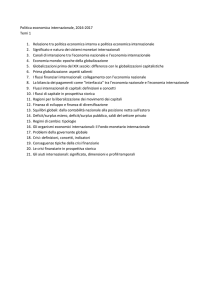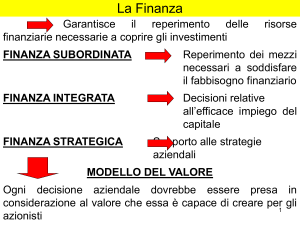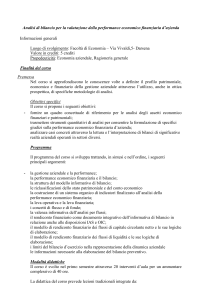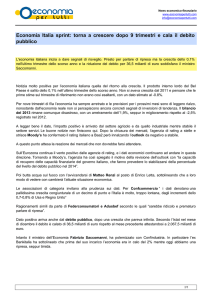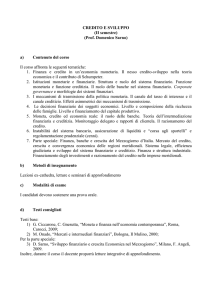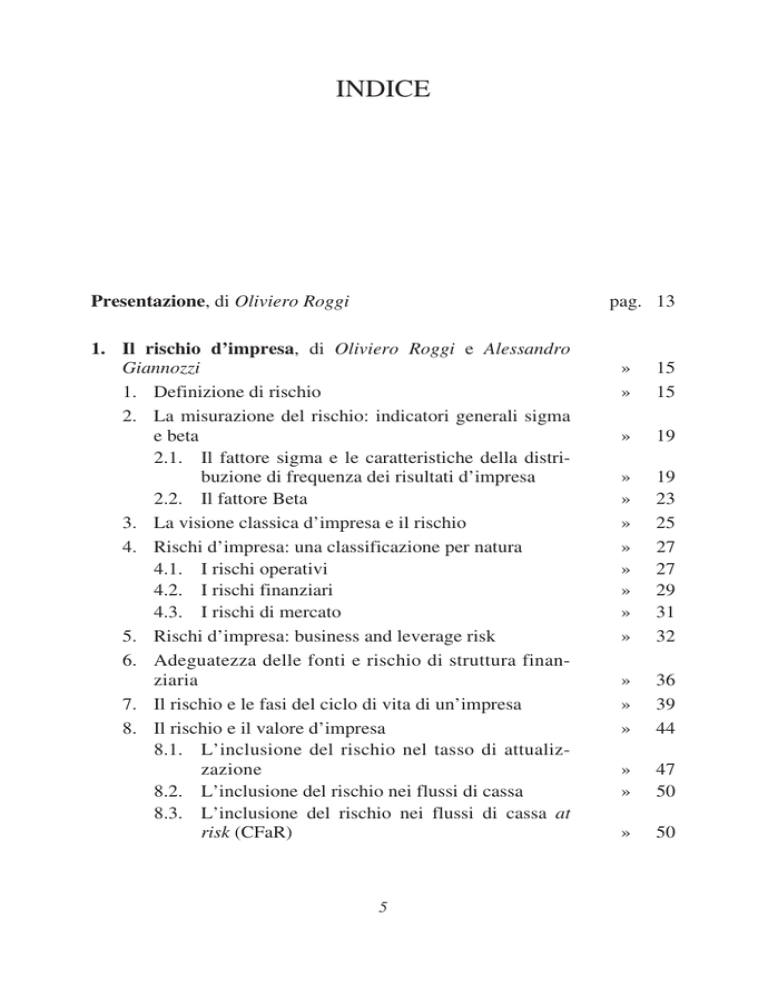
INDICE
Presentazione, di Oliviero Roggi
pag. 13
1. Il rischio d’impresa, di Oliviero Roggi e Alessandro
Giannozzi
1. Definizione di rischio
2. La misurazione del rischio: indicatori generali sigma
e beta
2.1. Il fattore sigma e le caratteristiche della distribuzione di frequenza dei risultati d’impresa
2.2. Il fattore Beta
3. La visione classica d’impresa e il rischio
4. Rischi d’impresa: una classificazione per natura
4.1. I rischi operativi
4.2. I rischi finanziari
4.3. I rischi di mercato
5. Rischi d’impresa: business and leverage risk
6. Adeguatezza delle fonti e rischio di struttura finanziaria
7. Il rischio e le fasi del ciclo di vita di un’impresa
8. Il rischio e il valore d’impresa
8.1. L’inclusione del rischio nel tasso di attualizzazione
8.2. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa
8.3. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa at
risk (CFaR)
5
»
»
15
15
»
19
»
»
»
»
»
»
»
»
19
23
25
27
27
29
31
32
»
»
»
36
39
44
»
»
47
50
»
50
9. Rischio di credito, insolvenza e costo del debito per
l’impresa
9.1. La definizione del rischio di insolvenza/credito
nella prospettiva del risk taker bancario: il rischio di credito
9.2. Le componenti del rischio di credito
9.3. La relazione tra perdita attesa e costo del debito: il pricing del prestito
2. Il corporate risk management. Analisi del rischio, il
capitale di dotazione e i soggetti prenditori, di Oliviero
Roggi
1. Evoluzione degli studi sul risk management e il trattamento dei rischi puri
2. Il risk management e le aree tipiche di intervento
2.1. Il risk management nell’accezione tradizionale
(Traditional Risk Management)
2.2. Il Project Risk Management
2.3. Il Financial Risk Management
3. Il processo di risk management
3.1. L’identificazione degli obiettivi di risk management e d’impresa
3.2. Il risk assessment
3.3. La stima dei rischi (Risk estimation)
4. Il valore d’impresa e la valutazione dei rischi. Il modello economico valutativo
4.1. Il modello economico valutativo
4.2. Gli effetti delle imperfezioni e l’allontanamento
dalla finanza neoclassica
5. Le principali strategie e tecniche di gestione dell’incertezza (risk treatment)
5.1. Risk Avoidance
5.2. Risk Transfer
5.3. Risk Retention
5.4. Risk Reduction, la diversificazione e le altre
policies
6. Il monitoraggio dei rischi sostenuti
6
pag. 52
»
»
53
55
»
60
»
63
»
»
63
65
»
»
»
»
65
65
66
67
»
»
»
68
69
72
»
»
80
80
»
83
»
»
»
»
84
85
86
86
»
»
87
89
7. Il retained risk e la necessità di un fondo di garanzia:
cenni
8. Il capitale di dotazione, il rischio e la garanzia patrimoniale
9. Il capitale investito, di dotazione e quello sociale
nella prospettiva classica della finanza aziendale
9.1. Il modello classico
9.2. Il modello assicurativo
10. I prenditori del rischio d’impresa, seniority e insolvenza
3. La valutazione dell’impresa e del suo capitale economico, di Oliviero Roggi
1. Premessa
2. Il concetto di valore d’impresa. Teoria e prassi professionale
3. Il valore d’impresa e il valore dell’equity. Una premessa
4. Le scelte del valutatore e il processo di stima del
valore
4.1. Gli obiettivi della valutazione, i valutatori e i
soggetti promotori
4.2. Le circostanze nelle quali si realizza la valutazione
4.3. La raccolta delle informazioni
4.4. La scelta del metodo di valutazione delle imprese
4.5. La determinazione del valore dell’impresa e la
redazione della relazione di valutazione
5. I fondamentali d’impresa. Variabili determinanti
nella valutazione diretta dell’impresa e del suo capitale proprio
5.1. Il metodo patrimoniale
5.2. Il metodo reddituale
5.3. Il metodo misto. “Stock e flussi di valore”
5.4. Il metodo finanziario. Il valore del tempo e dei
flussi finanziari
7
pag. 90
»
91
»
»
»
92
94
96
» 100
» 105
» 105
» 106
» 108
» 109
» 110
» 111
» 112
» 113
» 115
»
»
»
»
116
118
122
127
» 131
5.5. La valutazione delle operazioni di M&A. L’impatto delle sinergie sul valore intrinseco delle
imprese coinvolte
6. I metodi indiretti di valutazione del capitale economico delle imprese
6.1. I multipli di mercato e delle transazioni comparabili. Una definizione
6.2. Il Processo di calcolo di un multiplo generico
6.3. Come si scelgono le imprese comparabili
6.4. “Il valore dei propri simili”. La scelta del multiplo di mercato più adatto per il confronto con
imprese simili
6.5. I multipli delle transazioni di imprese simili. Il
valore d’impresa e i multipli impliciti
6.6. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del metodo
dei multipli
4. La leva fiscale nella valutazione della struttura finanziaria e del rischio di default, di Valentina Cioli
1. Premessa
2. La posizione della dottrina sul rapporto debito/capitale proprio
3. La criticità della variabile fiscale nella determinazione della leva finanziaria
4. Il rischio di default nella stima del costo del capitale
di debito
5. La situazione prima della riforma fiscale 1997 e le
opportunità offerte dalla normativa fiscale vigente
6. L’equazione della leva finanziaria sotto specifici scenari tributari
6. Conclusioni
5. Cartolarizzazione dei crediti e crisi dei mercati finanziari, di Francesco Ferragina
1. La crisi dei mercati finanziari e la cartolarizzazione
2. Gli elementi caratteristici di un’operazione di asset
securitization
8
pag. 141
» 144
» 145
» 146
» 147
» 148
» 153
» 154
» 157
» 157
» 160
» 163
» 168
» 171
» 178
» 182
» 187
» 190
» 197
2.1. La struttura dell’operazione
2.2. I rischi connessi a un’operazione di securitization
2.3. L’originator
2.4. Special purpose vehicle
2.5. Tecniche di Credit enhancement
2.6. Società di rating
2.7. Servicer
3. Alcuni esempi di strutture di cartolarizzazione
3.1. Le Collateralised Obligations (CO)
3.2. Le Asset Backed Commercial Paper (ABCP)
4. Conclusioni
Bibliografia
pag. 199
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
202
204
207
210
212
215
217
218
221
226
» 227
9
Al professor Ivano Paci
nostro Maestro
PRESENTAZIONE
Nel panorama delle discipline aziendali che si occupano della Finanza
Aziendale i temi del rischio, della struttura finanziaria e degli strumenti per la
mitigazione degli eventi aziendali negativi sono fortemente dibattuti e oggetto di insegnamenti di ogni genere e grado. Oggi presentiamo questo lavoro
collettaneo che, in continuità con Temi di finanza aziendale a cura di Ivano
Paci, vuole costituire un utile compendio per l’approfondimento sistematico
di alcuni temi centrali nella formazione dello studente undergraduate. Alcune letture sono però fruibili anche da studenti graduate, almeno per coloro
che non fanno della finanza aziendale l’oggetto principale di studio e lavoro.
Le recenti modifiche legislative in materia di diritto societario, l’introduzione di nuovi strumenti finanziari e l’evoluzione della disciplina a seguito
delle mutate condizioni dei mercati finanziari rendono opportuna l’illustrazione di alcuni argomenti di finanza aziendale non ancora accolti nei più diffusi manuali dedicati alla disciplina; sebbene la “Finanza Aziendale” sia costituita da un “corpus” ormai accettato di “oggetti” di indagine, di “principi”
ispiratori e di criteri di analisi, che attribuiscono alla disciplina medesima
un’apprezzabile unitarietà, si percepisce la necessità di questo compendio di
letture critiche. L’universalità di contenuti della manualistica, dominata dal
progressivo affermarsi delle impostazioni culturali e delle categorie concettuali di origine angloamericana, tende infatti a non tenere conto della specificità dei contesti istituzionali e ordinamentali, oltre che dei sistemi economici,
all’interno dei quali si svolge la vita concreta delle imprese.
La considerazione che precede, che si presterebbe a più ampio svolgimento, spiega l’origine di questo volume, destinato prevalentemente a finalità didattiche, che raccoglie nelle sue varie parti l’esposizione di argomenti
e temi di attualità che integrano quelli dei testi di base.
Si tratta di argomenti che completano e approfondiscono temi generali
(il rischio, e la valutazione delle imprese) o illustrano tecniche finanziarie
di recente introduzione nel nostro Paese (la cartolarizzazione) o danno noti-
13
zia sui rapporti fra scelte finanziarie e ordinamento tributario italiano. Naturalmente quelli contenuti nel testo sono alcuni degli argomenti che meriterebbero di essere illustrati.
Nel Capitolo 1, in alcune parti realizzate insieme ad Alessandro Giannozzi, si illustrano le principali definizioni e classificazioni di rischio, legando queste ultime al valore dell’impresa nell’ottica economicofinanziaria. Inoltre, si tenta di chiarire il rapporto tra rischio di credito, insolvenza e pricing del debito aziendale. Nel Capitolo 2 si introduce il corporate risk management e si illustrano i concetti e i processi necessari per
l’analisi del rischio, la quantificazione del capitale di dotazione di un’impresa, normalmente detto capitale di rischio, e i rischi assunti dai soggetti
finanziatori dell’impresa. L’obiettivo è di far comprendere come il rischio
d’impresa, generato dalle decisioni strategiche, debba essere identificato,
stimato e trattato con adeguati strumenti onde evitare conseguenze negative
capaci di deprimere i risultati d’impresa e non permettere il rispetto del
principio di massimizzazione del valore. Le fasi di identificazione, valutazione e trattamento del rischio sono ivi trattate in dettaglio. Nel Capitolo 3
è trattato il tema centrale della misurazione del valore e in particolare della
valutazione dell’impresa, tanto nella prospettiva del socio di capitale che
del finanziatore terzo. Nel Capitolo 4, Valentina Cioli produce alcune riflessioni utili a collocare il principio di massimizzazione del valore e di ottimizzazione della struttura finanziaria all’interno della vigente normativa
fiscale mostrando l’importanza della leva fiscale nelle scelte di finanziamento degli investimenti e le ricadute sul valore d’impresa.
Infine, nel Capitolo 5, Francesco Ferragina riprende e completa le riflessioni sulla cartolarizzazione contestualizzandole rispetto alla crisi finanziaria mondiale che proprio da tali strumenti ha tratto origini.
Ai singoli autori che da tempo collaborano con la cattedra di Finanza
aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Firenze va il mio
ringraziamento per il loro apprezzato impegno.
Questo volume è dedicato al professor Ivano Paci, nostro maestro, primo
docente della disciplina di Finanza Aziendale presso la nostra Facoltà. A lui
va la mia riconoscenza per il percorso umano e professionale vissuto insieme.
Oliviero Roggi
14
1. IL RISCHIO D’IMPRESA
di Oliviero Roggi e Alessandro Giannozzi*
1. Definizione di rischio
Ogni soggetto economico, in qualità di soggetto decisore, è naturalmente sottoposto all’incertezza e al rischio degli accadimenti futuri che lo
riguardano. Ancora tutt’oggi, né la ragione né l’esoterismo sono riusciti a
eliminare l’incertezza rispetto al futuro. Certo, gli strumenti logici e scientifici si sono evoluti al punto di divenire sofisticati modelli di simulazione
del futuro, ma nessuno di essi ha potuto eliminare quell’incertezza intrinseca nella condizione umana.
È l’incertezza nel prevedere fatti futuri che ci permette di introdurre
l’argomento trattato in questo libro: il rischio. Di esso si illustreranno le
manifestazioni generali e poi quelle specifiche del rischio d’impresa e in
particolare del rischio finanziario.
Prima di ciò, dobbiamo tentare di delimitare i confini logici ed epistemologici dei concetti di incertezza e di rischio. Lo faremo dopo aver richiamato le definizioni più comuni e quelle specifiche utilizzate nell’ambito delle discipline economico-finanziarie.
Il Vocabolario della Lingua Italiana Treccani (1991, p. 1479) riporta
per il concetto di rischio la seguente definizione: “Eventualità di subire un
danno connessa a circostanze più o meno prevedibili”.
In questa definizione si enfatizzano solo gli aspetti negativi del rischio
ovvero quelli connessi al verificarsi di un danno.
Il Dizionario Enciclopedico Treccani (1970, p. 424), invece, alla voce
“Rischio in economia”, riporta una definizione molto più vicina a quella
ormai utilizzata nella finanza e anche più prossima a quella antichissima
cinese: “Il rischio è indissociabile dalle operazioni economiche che, svolgendosi nel tempo, si basano su previsioni del futuro. Gli errori di previsio*
Il par. 1.9 è da attribuirsi interamente ad Alessandro Giannozzi, i rimanenti a Oliviero Roggi.
15
ne, positivi o negativi, sono infatti frequenti e si traducono sempre in perdite anche quando è possibile rettificare le previsioni stesse durante il corso delle operazioni”.
Il dizionario ideografico cinese illustra il rischio come la combinazione di due altri concetti rappresentati dagli ideogrammi della perdita
(pregiudizio) e dell’opportunità. Ciò a testimoniare che la variabilità
non prevista può recare effetti tanto positivi quanto negativi nel soggetto
che si accolla il rischio. Questa nozione è molto vicina a quella che utilizzeremo in questo libro.
Ai giorni nostri e nell’uso comune: “Il rischio è un concetto connesso
con le aspettative umane. Indica un potenziale effetto negativo su un bene
che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi
futuri. Nel linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di
probabilità di una perdita o di un pericolo. Nella valutazione del rischio
professionale il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di
un evento con l’impatto che questo evento potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento”1.
Uno sforzo di sistematizzazione è stato compiuto da alcuni autori (Floreani 2005, pp. 5 e ss.; Misani 1994). Sono state così elaborate anche distinzioni del concetto in esame assunte sulla base di differenti criteri dei
quali richiamiamo i principali:
• criterio sociologico e psicologico, secondo cui il rischio è un concetto
connesso con le aspettative umane. Indica un potenziale effetto negativo (sinistro) su un bene o una persona che può derivare da attività in
corso o da eventi futuri;
• criterio tradizionale-assicurativo: il rischio è inteso come l’insieme
delle possibili minacce. Reen (1998:51) definisce il rischio come la
“possibilità che si verifichino degli effetti avversi in seguito a eventi
naturali o azioni umane”. Questa criterio presenta uno spaccato parziale del rischio in quanto, di esso, considera solo la manifestazione
negativa (cosiddetti “rischi puri”, per esempio il rischio di incendio). Questi sono generalmente rappresentati dalla presenza di due
scenari: uno, in cui l’impresa non sperimenta alcun pregiudizio (non
si ha alcun effetto economico/patrimoniale/finanziario negativo per
l’impresa); l’altro è, invece, caratterizzato da eventi sfavorevoli capaci di generare danni molto elevati e pesanti ripercussioni sull’intero sistema aziendale;
• criterio statistico-finanziario, il rischio è inteso come aleatorietà stoca1
Voce “Rischio”, www.wikipedia.com.
16
stica, vale a dire come il possibile scostamento di una variabile aleatoria rispetto al suo valore atteso. Tale criterio nasce nell’ambito delle
scienze statistiche ed è uno dei cardini dalla teoria neoclassica della finanza di cui tratteremo più avanti;
• criterio manageriale, secondo il cui approccio “i rischi sono eventi futuri e incerti che possono influenzare il raggiungimento di obiettivi
strategici e finanziari di un’istituzione” (PricewaterhouseCoopers 1996,
pp. 6 e ss).
In questo caso, il rischio è essenzialmente visto come il possibile scostamento rispetto agli obiettivi prefissati di un soggetto, che generalmente
coincide con il management.
Gli studiosi di varie discipline interessate al fenomeno del rischio hanno tentato di dare una definizione generale di rischio senza giungere, peraltro, a una sintesi capace di racchiudere tutte le articolazioni del concetto,
nonché di chiarire il rapporto che esiste tra esso e il concetto di incertezza.
Vediamo in breve i principali contributi.
Già nei primi anni del secolo XXI, A. H. Willet nel suo principale lavoro scientifico, The Economic Theory of Risk and Insurance, tentò di dare
maggiore corpo alla definizione di rischio e di incertezza illustrando la
relazione che esiste tra i due concetti: “Risk and uncertainty are objective
and subjective aspects of appartent variability in the course of natural
events” (Willet 1901, p. 24) e cercando poi di illustrare meglio la differenza
tra i due concetti affermava: “It seems necessary to define risk with reference to the degree of uncertainty about the occurrence of a loss, and not with
reference to the degree of probability that it will occur. Risk in this sense is
the objective correlative of the subjective uncertainty. It is the uncertainty
as embodied in the course of events in external world, of which subjective
uncertainty is a more o less faithful interpretation” (Willet 1901, p. 8).
Frank Knight, nella sua opera principale Risk, Uncertainty and Profit
(1921, pp. 26 e ss.), introduce ulteriori elementi alla distinzione tra rischio e
incertezza. “Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the
familiar notion of Risk, from which it has never been properly separated.
The term ‘risk,’ as loosely used in everyday speech and in economic discussion, really covers two things which, functionally at least, in their causal
relations to the phenomena of economic organization, are categorically
different […]. The essential fact is that ‘risk’ means in some cases a quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and there are far-reaching and crucial differences in the bearings of the phenomenon depending on which of the two is
really present and operating […]. It will appear that a measurable uncer-
17
tainty, or ‘risk’ proper, as we shall use the term, is so far different from an
unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all. We shall accordingly restrict the term ‘uncertainty’ to cases of the non-quantitive type.
It is the true uncertainty and not risk, as has been argued, which forms the
basis of a valide theory of profit and accounts from the divergence between
actual and theoretical competition”.
L’autore, in parte riprende quanto asserito da Willet, in parte vi si discosta trattando i due concetti indipendentemente gli uni dagli altri e affermando la misurabilità del rischio contrapposta all’indeterminabilità dell’incertezza.
Altri autori, come Archer e D’Ambrosio (1967), riprendono Willet
precisando i concetti enunciati come segue: “la certezza è la perfetta conoscenza di una variabile futura, il rischio è definito dalla probabilità
oggettiva del manifestarsi di una variabile, l’incertezza è, a loro dire,
conseguenza dell’attribuzione di una probabilità soggettiva del verificarsi di un evento”.
Più recentemente Cattaneo (1999) chiarisce come i tre concetti siano
applicabili alle decisioni d’impresa giungendo a una classificazione rigorosa degli stessi all’interno delle dinamiche d’impresa. Egli riferisce che i tre
concetti possono essere differenziati rispetto alle tre caratteristiche essenziali di una decisione:
1. conoscibilità dell’ambiente nel quale la decisione è assunta;
2. presenza di alternative;
3. ordinabilità delle stesse.
Secondo Cattaneo decidere in condizioni di certezza significa operare
nella circostanza nella quale l’ambiente è conosciuto, vi sono alternative
per raggiungere l’obiettivo, le stesse sono note al decisore, e, in ultimo, tali
alternative sono ordinabili.
Le decisioni in condizioni di rischio sono invece caratterizzate da una
non perfetta conoscenza dell’ambiente, dall’individuazione esaustiva delle
alternative e dalla loro ordinabilità attraverso l’attribuzione di una funzione
di probabilità oggettiva della variabile casuale ricercata.
Le decisioni in condizioni di incertezza sono riconoscibili per il mancato soddisfacimento della prima e terza caratteristica, ovvero non è conosciuto l’ambiente, né l’ordine delle alternative. L’incertezza è, nelle parole
di Cattaneo (1999, p. 214), una “qualità di eventi futuri e deriva dalla non
perfetta conoscibilità delle alternative e dall’incapacità di dar loro un ordinamento”. In questo caso i soggetti decisori si debbono affidare, per la sti-
18
ma, a distribuzioni soggettive di frequenza delle manifestazioni future della
variabile casuale oggetto della stima stessa.
Tabella 1 – Decisioni e condizioni di certezza, rischio e incertezza
Condizione/caratteri
stiche delle decisioni
Conoscibilità
ambiente
Presenza
di alternative
Ordinabilità
alternative
Certezza
Sì
Sì
Sì
Rischio
No
Sì
Sì
Incertezza
No
Sì
No
Fonte: Nostra elaborazione da Cattaneo (1999)
Nella maggior parte dei lavori di finanza aziendale però si è persa la distinzione tra rischio e incertezza, al punto che spesso i due termini vengono
utilizzati come sinonimi. Tale confusione deriva probabilmente dal fatto
che, una volta stimata la funzione di probabilità con metodi oggettivi o
soggettivi, la variabilità è studiata con i medesimi strumenti, ovvero attraverso il calcolo della dispersione dei risultati intorno alla media e lo studio
della forma della distribuzione stessa.
2. La misurazione del rischio: indicatori generali sigma e beta
La misurazione dei rischi si è arricchita negli anni di tecniche sempre
più sofisticate che tuttavia si riferiscono indirettamente a due indicatori generali che qui sotto descriveremo: il fattore sigma e il fattore beta.
2.1. Il fattore sigma e le caratteristiche della distribuzione di frequenza dei risultati d’impresa
Lo studio delle caratteristiche della distribuzione di probabilità permette il calcolo del primo degli indicatori universalmente utilizzati per la
stima del rischio. Tale indicatore, noto come fattore sigma (σ) o rischio
totale, è misurato dallo scarto quadratico medio e/o dalla varianza. A tale
misura si associano, per completare una corretta lettura del rischio totale,
l’osservazione di altre caratteristiche della distribuzione di frequenza quali:
la media, moda e mediana e la curtosi.
In particolare, nell’ambito degli studi di risk management che ci apprestiamo a condurre, è rilevante la conoscenza della media, dello scostamento
19
dalla stessa (varianza o scarto quadratico medio), della curtosi e della
skewness o asimmetria.
In generale in finanza, per descrivere il rischio sostenuto nello stimare
una variabile aleatoria come il rendimento, anziché procedere a una sua
rappresentazione completa mediante la funzione di densità di probabilità, è
necessario identificare tre gruppi di indicatori sintetici e caratteristici. Questi sono rappresentati dagli:
• indicatori di posizione;
• indicatori di rischio (o di dispersione);
• indicatori di forma e simmetria.
Tutti questi indicatori contribuiscono a illustrare correttamente il rischio assunto da una soggetto decisore.
Infatti, sarebbe sicuramente avventato basare la propria decisione (per
esempio di investimento) solo sulla base dell’indicatore di posizione, il
rendimento atteso che, nel caso di una distribuzione normale, si manifesta
con i medesimi valori della moda e della mediana, assumendo il nome di
“valore atteso”2 o di “speranza matematica”. Accanto a questo valore atteso
sarà, invece, necessario calcolare anche la dispersione dei possibili risultati
intorno alla media e altre caratteristiche sotto citate.
Indicatori di posizione. Il principale indicatore di posizione è rappresentato dal valore atteso: la media ponderata delle modalità assunte dalla
variabile. In essa i coefficienti di ponderazione sono rappresentati dalle
probabilità associate a ciascuna modalità. Il valore così stimato corrisponde
sostanzialmente al risultato medio che un soggetto otterrebbe se ripetesse
all’infinito l’esperimento che coinvolge la variabile aleatoria presa in esame. Quanto abbiamo appena detto ci suggerisce intuitivamente perché il
“valore atteso”, noto anche in inglese come expected value [E(x)], venga
definito anche come “media aritmetica della variabile casuale”.
Il valore atteso della variabile aleatoria si ottiene:
•
nel discreto
•
nel continuo
;
.
Indicatori di rischio (o di dispersione): il sigma e la varianza. Per
valutare la dispersione dei rendimenti intorno alla media le scienze statisti2
Il Valore Atteso può essere definito come una media ponderata delle modalità assunte da
una variabile, dove i coefficienti di ponderazione sono rappresentati dalle probabilità associate a ciascuna modalità.
20
che ci vengono in aiuto con il concetto di varianza e quello derivato di
scarto quadratico medio. In statistica la varianza è un indice di dispersione
dei valori di una distribuzione intorno alla propria media. Viene solitamente
indicata con σ2 (dove σ è la deviazione standard o scarto quadratico medio).
Nell’ambito della statistica descrittiva la varianza è definita dall’espressione che segue:
dove μ rappresenta la media aritmetica dei valori xi. Nel caso di una variabile casuale X, si definisce la varianza VAR(X) come:
VAR[ X ] = E [( X − E [ X ]) 2 ] = E ( X 2 − E [ X ]2 )
dove E[X] è il valore atteso della variabile casuale X. In tale espressione
osserviamo come, poiché la differenza (X − E [X])2 elevata al quadrato fornisce sempre un risultato positivo, il suo valore atteso, ovvero la varianza di
X, sarà anch’esso positivo.
Accanto alla varianza, nell’ambito specifico dell’analisi del rischio di
un singolo progetto e/o di un portafoglio di attività, si è diffuso l’utilizzo
del concetto di perdita massima potenziale (PMP). Tale misura, in particolare, stima gli effetti negativi degli scostamenti dal valore medio. Essa
può essere definita come “il massimo livello di perdita con la sola esclusione degli scenari del tutto eccezionali” (Floreani 2005, p. 19). Si tratta
di una stima di probabilità della perdita massima effettuata una volta aver
definito un determinato grado di confidenza della stima (normalmente
l’1% oppure il 5%).
Rispetto allo scarto quadratico medio, che ricordiamo essere un indicatore di rischio complessivo, rileviamo un’importante differenza. La PMP,
infatti, tende a misurare solo le minacce e non le opportunità offerte dalla
variabilità degli accadimenti futuri. Ciò vuol dire che la “PMP” si riferisce
solo al cosiddetto downside risk. Ulteriore elemento di differenziazione fra
i due indicatori è rappresentato dal fatto che, mentre lo scarto quadratico
medio può essere calcolato sia in presenza di variabili causali discrete sia
continue, la perdita massima potenziale può essere stimata solo in presenza
di funzioni continue. Accanto alla PMP, è possibile misurare anche lo scenario estremo. In tale caso sarà misurata la perdita massima possibile
(PM) che corrisponde alla perdita che si verifica nella peggiore delle ipotesi prospettate dall’analista. La conoscenza di tale valore è di per sé poco
utile, in quanto lo scenario più catastrofico non è perfettamente individua-
21
bile e, laddove anche lo fosse, avrebbe generalmente delle infinitesime probabilità di realizzazione (per esempio, lo “scenario worst” dell’impresa α
avrebbe una probabilità di realizzazione pari allo 0,00001%).
Indicatori di forma e simmetria. Accanto alla varianza, scarto quadratico e perdita massima potenziale è necessario osservare la forma della
distribuzione di frequenza.
Un primo strumento è il calcolo della curtosi (Kurtosis). La curtosi è
un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla quale si verifica
un maggiore appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento (distribuzione leptocurtica). La più nota misura della curtosi è
l’indice di Fisher, ottenuto facendo il rapporto tra il momento centrato di
ordine 4 e il quadrato della varianza. Il valore dell’indice corrispondente
alla distribuzione normale (gaussiana) è 3. Un valore minore di 3 indica una
distribuzione platicurtica, mentre un valore maggiore di 3 indica una distribuzione leptocurtica.
In finanza, e in particolare nella stima del rischio, tale indicatore permette di valutare correttamente gli scostamenti dalla media. Infatti valori
alti di curtosi indicano una maggiore dimensione delle code e quindi un
maggiore rischio generato dalla presenza di consistenti eventi estremi.
Il concetto utile in questo gruppo è l’indicatore di simmetria
(skewness)3 cioè un indicatore che è in grado di segnalare se la possibile
dispersione dei valori della variabile aleatoria dipende maggiormente
dagli scenari negativi (asimmetria negativa) o dagli scenari positivi
(asimmetria positiva).
La distribuzione “tenderà” verso valori positivi (asimmetria positiva)
quando la mediana è minore della media. In questo caso, alcuni valori osservati, particolarmente alti, sposteranno la media verso destra. Da un punto
di vista finanziario, un’asimmetria positiva evidenzia la maggior probabilità
di ottenere rendimenti particolarmente elevati.
Analizzando con tutti gli strumenti sopra enunciati la distribuzione di
frequenza del rendimento di un’attività si giunge alla stima più circostanziata della sua rischiosità.
C’è da precisare che la variazione dei risultati intorno alla media non
ha, però, i medesimi effetti sull’impresa. Infatti, solo gli scostamenti verificatesi nella parte sinistra della distribuzione, quella normalmente formata
con scenari i cui risultati sono inferiori al valore atteso, costituisce un pro-
3
Si ricordi i coefficienti di asimmetria di Pearson e Fisher. Per un approfondimento cfr. Piccolo D. (2000), Statistica, Il Mulino, Bologna.
22
blema per l’impresa. Ciò poiché i rendimenti effettivi sono inferiori a quelli
attesi. Tali rischi, denominati downside risk, sono trattati con attenzione dai
risk managers in quanto portano l’impresa a ridurre gli utili e quindi le
aspettative future sull’impresa medesima.
Proprio per distinguere i rischi di perdita dalle opportunità di ottenere
un rendimento superiore a quello atteso, gli studiosi di risk management
hanno distinto i rischi in due gruppi. Si parla, di rischi puri quando si è in
presenza di scenari di perdita rispetto al risultato atteso, mentre si parla di
rischi speculativi quando la variabilità si manifesta simmetricamente con
risultati effettivi sia superiori sia inferiori a quelli attesi.
Il comportamento ideale degli addetti alla gestione dei rischi d’impresa
dovrebbe essere, quindi, quello di massimizzare le possibilità di incorrere
in “errori” positivi ottenendo performance superiori a quelle sperate e al
medesimo tempo coprire con polizze assicurative o altri strumenti di trasferimento del rischio i possibili eventi negativi, anche detti sinistri, che possono occorrere durante la vita dell’impresa.
2.2. Il fattore Beta
Il secondo strumento comune a tutti gli approcci per la stima della variabilità dei risultati d’impresa rispetto a un fattore esogeno alla stessa (per
esempio il rendimento del portafoglio di mercato o il prezzo del petrolio o
ancora l’indice di variazione dei prezzi delle materie prime), è il fattore
Beta, ovvero il rapporto tra la covarianza della variabile casuale ricercata
rispetto al fattore indipendente che genera la variazione e la varianza del
fattore medesimo.
Il fattore beta maggiormente conosciuto e utilizzato nella letteratura
aziendale per la stima del rischio è il beta azionario ovvero il rapporto tra la
covarianza del rendimento del titolo e di quello del mercato diviso la varianza del rendimento di mercato.
β=
Cov ym
Varm
=
σ ym
σ m2
Tale indicatore è utilizzato nel Capital Asset Pricing Model (Treynor,
1961; Sharpe, 1964; Lintner, 1965) per la definizione della relazione rischio-rendimento.
Si tratta di una misura relativa del rischio sostenuto dall’investitore che
viene utilizzata come stima del rischio sistematico d’un investimento in oc23
casione della quatificazione del rendimento atteso di un investimento mobiliare azionario4.
Il beta è strumento generico per lo studio della variabilità indotta da un
fenomeno su una variabile dipendente e rientra negli indici di relazione in
quanto composto, al numeratore, dalla covarianza della variabile dipendente con l’indipendente; e al denominatore, dalla varianza della variabile
indipendente. In questo modo il rapporto esprime la variabilità relativa del
rendimento di un’attività J specifica indotta dalla variazione dei rendimenti
di mercato.
Il beta può essere usato quindi per studiare l’effetto della variazione di
una qualsiasi grandezza esogena o endogena all’impresa su grandezze di
risultato quali: il reddito operativo, l’utile netto, il cash flow operativo, il
Free Cash Flow to Equity (FCFE), il Free Cash Flow to Firm (FCFF) o il
prezzo azionario.
I modelli di rischio rendimento che utilizzano l’analisi multivariata
fanno largo uso del beta che, in questo caso, è il fattore legato a ciascuna
variabile indipendente. Per esempio l’Arbritage Pricing Theory (Ross,
1976) studia i movimenti del rendimento di un titolo azionario al variare di
una pluralità di fattori di rischio sistematico che impattano sui risultati dell’impresa. Questi fattori sono, di fatto, i “fattori primi” ottenuti con un’analisi delle componenti principali.
I modelli fattoriali poi possono tentare di isolare la variabilità indotta
sul rendimento atteso di un titolo da variabili esogene quali il prezzo del
petrolio, l’indice generale dei prezzi all’ingrosso, quello dei prezzi al dettaglio, oppure altre variabili esogene responsabili del cosiddetto rischio di
mercato.
Nel caso dell’APT, dopo aver eseguito una Principal Component
Analysis con la quale si individuano i regressori, e la successiva regressione multipla per legare questi ultimi alla variabile casuale E(X), si ottiene:
E (X ) = a + β1 F1 + β 2 F2 + β 3 F3 + ....β n Fn + ε
dove F da 1 a N rappresentano i Fattori primi determinati con la PCA.
4
Treynor, Sharpe e Lintner giungono, indipendentemente gli uni dagli altri, a enunciare la
relazione che lega il rendimento atteso di un titolo al rischio sostenuto dall’investitore nell’investimento. Tale rendimento, afferma Sharpe, è pari alla somma tra il rendimento privo
di rischio (Rf) con il premio per il rischio. Questo secondo addendo è composto appunto dal
Beta (β) che moltiplica il premio per il rischio di mercato (Rm – Rf) ovvero il rendimento
differenziale di un portafoglio azionario ben diversificato rispetto a quello composto da soli
titoli risk free.
24
E ( X ) = R f + β1 ( E [ R ]1 − R f ) + β 2 ( E [ R ]2 − R f ) +
+ ... + β n ( E [ R ]n − R f ) + ε
Dalla quale si ricava il rendimento atteso con l’APM come generalizzazione del CAPM.
Nel caso di modelli multifattoriali con indicazione a priori dei regressori l’equazione si presenta nella forma in basso:
E (X ) = a + β1V1 + β 2V2 + ....β nVn + ε
dove le V da 1 a N rappresentano i fattori macroeconomici di rischio sistematico.
L’analisi del rischio utilizza di preferenza questa ultima tecnica in
quanto permette di stimare l’effetto sulla redditività dell’impresa indotto
dalla variazione di indicatori ai quali è possibile dare un’“etichetta”. Ciò
rende più facile l’interpretazione dei risultati e indirizza con maggior chiarezza il management nelle scelte di investimento e dividendo.
3. La visione classica d’impresa e il rischio
Impresa, dal latino impresum (participio passato di imprendere), nel
senso di “prendere sopra di sé”, indica l’atto di compiere gesta e azioni capaci di raggiungere un obiettivo prefissato. Nell’accezione giuridica l’impresa è definita indirettamente dal concetto di imprenditore all’art 2082 del
Codice Civile: “È imprenditore chi esercita professionalmente l’attività
economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”.
L’impresa è quindi connotata dall’esercizio professionale cioè sistematico
di un’attività economica volta alla realizzazione dell’oggetto sociale.
Il concetto di imprenditore è presente già nel secondo ottocento negli
studi J. S. Mill (1848) e di L. Walras (1874)5. Il concetto d’impresa si ritrova più tardi nei lavori di Knight (1921), laddove l’autore lega il concetto di
incertezza alla scelta della forma d’impresa quale strumento per l’organizzazione del sistema economico6.
5
Cfr. Mill J. S. (1848), Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to
Social Philosophiy, Parker, London; Walras L. (1874) Elements d’economie politique pure,
Economia, Paris.
6
Afferma infatti Knight: “It is this true uncertainty which by preventing the theoretically
perfect outworking of the tendencies of competition gives the characteristic form of ‘enterprise’ to economic organization as a whole and accounts for the peculiar income of the entrepreneur”. Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, VII, p. 48 e ss.
25
Nei medesimi anni gli scienziati aziendali italiani, e in primis Zappa
(1927), precisavano i tratti salienti del rapporto tra l’azienda e l’impresa.
Zappa intende l’azienda come la manifestazione oggettiva dell’impresa, e
quest’ultima: una “coordinazione economica in atto istituita e retta per il
soddisfacimento dei bisogni umani” (Zappa 1927, p. 30). Più tardi, Ceccherelli si riferisce all’azienda come a un “organismo produttivo soggetto ai
rischi e alle variabilità dell’ambiente economico che ne formano un sistema
perennemente perturbato” (Ceccherelli 1948, p. 64).
Dalla diversità delle definizioni emerge, però, un primo elemento comune, quello della finalità per la quale l’imprenditore da luogo all’impresa
attraverso la creazione e la gestione economica dell’azienda. Tale obiettivo
è il soddisfacimento dei bisogni di individui. La finalità sopra esposta può
essere raggiunta solo se l’imprenditore, e quindi l’impresa, si dota, par anticipation, dei fattori produttivi e organizza tali fattori in processi di trasformazione spazio/temporale capaci di soddisfare i bisogni attraverso la
fornitura di beni e servizi.
Questa circostanza per la quale l’imprenditore è obbligato ad anticipare
i bisogni percepiti dai consumatori si concretizza nel secondo elemento
comune alle definizioni finora citate, elemento prevalente nell’impresa manifatturiera: il rischio sostenuto dall’imprenditore nell’organizzare la
produzione. L’impresa, proprio per la necessaria anticipazione dei processi
di acquisizione dei fattori e di trasformazione degli stessi in prodotti finiti, è
caratterizzata da incertezza nella conduzione delle operazioni, incertezza
che diviene elemento costitutivo del rischio d’impresa.
L’organizzazione dell’impresa non può, dunque, essere un’attività filantropica proprio a causa del rischio che l’imprenditore deve assumersi per
soddisfare i bisogni altrui. Per questo egli ha il diritto di appropriarsi del
plusvalore generato nell’attività; plusvalore che poi dovrà distribuire agli
azionisti o trattenere all’interno dell’impresa per finanziarne lo sviluppo In
sostanza l’attività d’impresa è lucrativa. “Questo presupposto economico di
reddito potenziale, naturalmente connesso con l’attuazione del processo
produttivo, è quello che sprona l’imprenditore a costituire l’impresa e a
crearne l’organizzazione economico-tecnica, nonostante i rischi che
l’iniziativa presenta e che egli assume” (Ceccherelli 1961, p. 64).
L’impresa, in questa prospettiva, diviene un centro di funzioni economico-tecniche (Ceccherelli 1964; Fazzi 1982) di produzione, trasformazione dei beni, di adattamento di questi alle esigenze dei clienti, di produzione
dei servizi e infine quella produttiva dei finanziamenti.
Gli investimenti vengono scelti proprio svolgendo la funzione economico-tecnica di trasformazione. La scelta genera l’esigenza di impiego di
26
risorse che si concretizza nel fabbisogno finanziario, al quale il management da copertura attraverso le scelte economico tecniche relative ai finanziamenti ovvero le scelte di struttura finanziaria.
Da queste poche parole si evince come nella sua visione classica come in
una più recente come quella finanziaria (Damoraran 2006)7, nella quale
l’attenzione si focalizza sugli investimenti e i finanziamenti, l’impresa e rischio generato nella conduzione della stessa, siano concetti inscindibili. Non
esiste impresa senza rischio. Tale relazione può essere violata solo in occasione di particolari imprese quali quelle di erogazione. In tali imprese la forma societaria è scelta come utile strumento per l’erogazione dei servizi alla
collettività e la maggior parte delle volte non implica rischi per l’operatore.
4. Rischi d’impresa: una classificazione per natura
La natura dei rischi sostenuti dall’impresa è la più varia; volendo classificare i rischi secondo natura e genesi potremmo rifarci alla letteratura
principale (Misani, 1995; Metelli, 1999; Floreani, 2005, Shimpi, 2001), che
distingue tra rischi:
• operativi:
– operativi e di controllo;
– business risk;
• finanziari:
– interni (insolvenza, controparte, progettazione struttura finanziaria);
– esterni (tasso d’interesse, tasso di cambio su valute, inflazione);
• mercato.
Ognuno di essi può essere utilmente articolato in sotto classi omogenee
e in verità alcune manifestazioni di impresa generano rischi poi classificabili in più di un gruppo.
4.1. I rischi operativi
I rischi operativi sono gli scostamenti che si verificano dai risultati
attesi per effetto dello svolgimento delle attività operative d’impresa. Per
7
In questa prospettiva l’impresa può essere intesa come un organismo caratterizzato dagli
investimenti realizzati e dai finanziamenti. In particolare la si identifica come:
•
la somma dei progetti di investimento di cui la medesima necessita per lo svolgimento
delle proprie attività di produzione di beni e servizi;
•
la somma dei finanziamenti necessari alla copertura dei fabbisogni finanziari derivanti
dagli investimenti.
27
loro natura essi si manifestano a seguito delle decisioni di impiego delle
risorse e quindi attengono alle decisioni di investimento dell’impresa. Per
questo motivo essi incidono, oltre che sul flusso di cassa effettivo, prevalentemente sul lato sinistro del prospetto fonti/impieghi, quello degli impieghi appunto.
Tra i rischi operativi si ritrovano i rischi di controllo: errori, omissioni
di comportamenti, errata valutazione dei costi di struttura. Possono verificarsi inoltre rischi quali: errori di controllo di procedura, ribassi non attesi
di prezzi di vendita e sottrazioni di beni di proprietà dell’impresa tra cui anche il denaro. Inoltre, l’impresa può essere soggetta a rischi operativi relativi alla governance o alla contabilità. Un esempio del primo dei due ultimi
rischi operativi citati è la paralisi societaria innescata da conflitti tra gruppi
di azionisti e/o consiglieri di amministrazione. Rischi relativi alla contabilità sono invece quelli originati dalle politiche di bilancio e soprattutto dalle
scelte di adesione ai principi contabili internazionali.
Altra categoria propria dei rischi operativi è quella relativa ai rapporti
con i dipendenti. In tal caso le perdite possono essere originate dalle procedure di gestione del personale, da azioni legali, dall’inasprimento delle
vertenze sindacali, dalla perdita di risorse umane e di competenze strategiche detenute dal personale.
Sempre di maggior entità sono “ai giorni nostri” i rischi che l’impresa sostiene nell’organizzare i propri sistemi informativi. È sufficiente ricordare i
grandi “black out” informatici di Wall Street per comprendere quanto questi
rischi possano essere rilevanti a livello aziendale e addirittura di sistema.
In particolare, vi possono essere problemi di sincronizzazione del sistema informatico, di accuratezza del flusso di informazioni, di incapacità
di recupero di danni alle memorie. Inoltre i rischi possono venire da soggetti terzi a cui sono affidati servizi in outsourcing. Accanto a questi rischi
si configurano quelli relativi all’utilizzo della rete nella gestione del business: rischi di capacità di utilizzo, i rischi di frode, di utilizzo improprio
delle infrastrutture informatiche; ancora i rischi definiti “collo di bottiglia”
e la fuoriuscita involontaria di informazioni.
Esiste poi un secondo sotto-gruppo di rischi operativi detto di business. A tale insieme appartengono i rischi fortemente collegati con l’attività
svolta quindi agli investimenti realizzati. Fanno parte di questo gruppo business event risk, quali: il rischio di obsolescenza tecnica, quello di cambiamento degli assetti regolamentari, il danno di immagine e l’interruzione
del servizio. L’entità del danno generato dal manifestarsi degli eventi sopra
descritti dipende, tra l’altro, dal settore a cui appartiene l’impresa e, in alcuni casi, dalle peculiarità dell’impresa considerata (per esempio il rischio
28
regolamentare per un colosso come Microsoft è molto più accentuato di
quello di una piccola casa di software che operi in provincia e produca
software per la contabilità delle imprese locali). I rischi di sviluppo e fornitura dei prodotti (product risks) sono generalmente inclusi nei rischi operativi, almeno per gli scostamenti rispetto alle previsioni che si manifestano
in ragione di problemi imprevisti nello sviluppo e ingegnerizzazione del
prodotto, nella gestione del magazzino e anche nel packaging e nella distribuzione. L’impresa si sottopone a rischi operativi anche quando non prevede correttamente il comportamento dei principali competitors. Ciò si ripercuote sui prezzi di vendita dei prodotti e sulla quota di mercato che a loro
volta impattano negativamente sui risultati effettivi. La differenza tra questi
ultimi e i risultati attesi è capace di innescare rischi finanziari quali il
crunch delle linee di credito.
Accanto a questi rischi operativi possono verificarsi eventi negativi legati ai rapporti di partenariato e alleanza. Per esempio, la concentrazione dei fornitori o dei clienti, insieme alla gestione non oculata delle alleanze strategiche o all’errata individuazione di terzi cui affidare i servizi in
outsourcing, potrebbe compromettere il servizio prestato e, quindi, i flussi
di cassa attesi da esso. Inoltre sempre sotto il “cappello” dei rischi di business, possiamo trovare i cosiddetti rischi legali. Essi sono principalmente
riconducibili a eventi dannosi nei quali professionisti, dirigenti e top managers dell’impresa compromettono, con i loro comportamenti, il buon esito
di attività d’investimento rendendo impossibile l’incasso dei relativi flussi
di ritorno. Inoltre accanto a questi troviamo i rischi contrattuali e i cosiddetti rischi di controparte. Questi ultimi sono quelli sostenuti in conseguenza dell’affidamento di credito a clienti e fornitori.
4.2. I rischi finanziari
I rischi finanziari costituiscono il secondo gruppo di rischi sostenuti
dall’impresa. Essi sono identificabili come gli scostamenti dal risultato atteso che si originano a causa di cambiamenti nelle variabili finanziarie
(Metelli 1995). Questa definizione, senz’altro non esaustiva, ci permette
però di riferirsi alla totalità degli scostamenti che potenzialmente si verificano a causa delle decisioni di finanziamento. All’interno di tale gruppo è
poi possibile distinguere i rischi interni quali quelli di insolvenza, di controparte, di progettazione della struttura finanziaria; da quelli esterni, ovvero originati da eventi fuori dalla portata del management, ma che finiscono
per modificare il valore di stock dei finanziamenti o generare flussi non
29
previsti. Per illustrare questo secondo gruppo ci riferiremo principalmente
ai rischi di cambio (se la fonte finanziaria è espressa in valuta), di interesse,
di inflazione.
Tra i rischi finanziari interni ritroviamo il rischio di insolvenza. Esso si
manifesta quando un’impresa non è capace di fare fronte con i mezzi ordinari
alle esigenze di pagamento, esigenze che si manifestano per il normale trascorrere della vita d’impresa. Tale rischio è principalmente legato a condizioni di
mancato rispetto del rapporto organico tra investimenti realizzati e fonti finanziarie. Come avremo modo di vedere, l’impresa deve operare seguendo il principio dell’equilibrio finanziario. In particolare questo equilibrio ha la caratteristica di dover essere verificato costantemente per permettere la sopravvivenza
dell’impresa. L’adeguatezza della struttura finanziaria è quindi un fattore rilevante nella determinazione del rischio di insolvenza. Tale adeguatezza è definita sia in relazione al rapporto impieghi/fonti che a quello tra fonti di finanziamento alternative (il rapporto di leva finanziaria).
Al rischio di insolvenza dell’impresa, che costituisce una componente
del rischio di credito nella prospettiva della banca, dedicheremo il paragrafo 9; per il momento è utile ricordare come questo rischio renda necessaria
la costituzione di un fondo di garanzia per lo svolgimento delle operazioni,
il capitale sociale volto a tutelare proprio i terzi dagli esiti sfavorevoli dell’agire d’impresa.
Diverso, anche se spesso confuso con il precedente, è il rischio di liquidità. Esso si manifesta ogni volta che un’impresa presenta un’elevata
variabilità del saldo di cassa. Ciò può rendere difficile, se non addirittura
impossibile, il controllo della liquidità disponibile. In questo caso il rischio
si manifesta nella forma di un deficit di cassa che comporta uno smobilizzo
non previsto o rende necessario la negoziazione di un affidamento bancario
per effettiva elasticità di cassa. Ciò finisce per incidere sui risultati e quindi
sul valore d’impresa. In particolare, il rischio è elevato ogni qualvolta che
l’attivo circolante dell’impresa è composto da assets non prontamente liquidabili a fronte di esigenze di pagamento di breve termine.
Un altro tipo di rischio finanziario è quello legato al regolamento delle
transazioni. Sebbene non ci sia volontà di interrompere o di non effettuare
i pagamenti relativi alle attività di gestione, può accadere che la distanza
fisica o organizzativa degli operatori faccia sì che si presentino casi di insolvenza generati da cause tecniche di regolamento delle partite.
Per quanto riguarda gli altri rischi finanziari, quelli esogeni, principalmente ci riferiamo al rischio di cambio e a quello di interesse. Il primo si
manifesta quando il rapporto di cambio tra due monete nazionali viene a
modificarsi sostanzialmente. Tale evenienza può modificare i flussi di cassa
30
generati dai vari progetti di investimento che l’impresa sta realizzando o
quelli relativi agli interessi e quota-capitale annualmente dovuti sull base per
un finanziamento in valuta. Generalmente tale rischio si manifesta in presenza di realtà aziendali multi-nazionali e come rischio specifico finanziario
può essere anche molto rilevante quando l’impresa produce e vende in due o
più mercati caratterizzati da una diversa moneta di conto. In questo caso,
l’apprezzamento o il deprezzamento inatteso di una valuta può generare scostamenti anche di notevole rilievo rispetto a flussi di cassa attesi. Da ciò
emerge che il rischio di cambio ha natura duplice: è prevalentemente rischio
operativo quando gli scostamenti riguardano i minori incassi da ricavi in
Paesi terzi o maggiori costi di approvvigionamento o altre attività legate alla
gestione operativa; è finanziario quando gli scostamenti sono imputabili al
diverso apprezzamento di finanziamenti con i quali coprire gli investimenti.
In particolare il rischio ha natura squisitamente finanziaria quando lo scostamento è dovuto a variazione nel valore degli stock di finanziamento in
valuta o dei flussi di remunerazione dei finanziamenti in valuta8.
Ultima fonte di rischio finanziario a cui sono sottoposte le imprese, è il
rischio di tasso di interesse. Con tale concetto si definiscono gli scostamenti nei valori stock e nei flussi di risultato generati dalla variazione inattesa del tasso di interesse vigente sui mercati dei capitali. Tale situazione si
manifesta quando, per cause non controllabili dall’impresa, le condizioni
esterne inducono modifiche sostanziali del costo del denaro tanto da modificare l’entità del flusso di cassa disponibile. In particolare le politiche monetarie restrittive o permissive giocano un ruolo determinante nella scelta
del tasso d’interesse di ciascun Paese e sebbene esso si configuri come un
rischio esogeno (vedi più sotto), spesso si lega a uno indogeno quale quello
di struttura finanziaria squilibrata.
4.3. I rischi di mercato
Il terzo gruppo di rischi, detto dei rischi di mercato, è legato a fattori esogeni all’impresa non riferibili all’area dei finanziamenti. Si tratta
di rischi generati dalla fluttuazione del valore di mercato di alcune poste
8
Un caso ben noto di rischio finanziario legato al cambio è quello nel quale si sono imbattute centinaia di famiglie e di imprese italiane quando, per condizioni di mercato particolari,
risultava particolarmente conveniente accendere mutui in Franchi svizzeri. L’apprezzamento
di quest’ultima divisa ha portato a situazioni di rischio addirittura non sostenibili, tanto che è
dovuto intervenire il governo il quale ha predisposto misure per la conversione e consolidamento dei mutui esteri rischiosi.
31
di bilancio. In letteratura tali eventi sono anche detti rischi di posizione. In particolare, questi rischi sono presenti in imprese con attività finanziaria accentuata quali società finanziarie, le banche commerciali e
di affari, le imprese di gestione mobiliare e ogni altra impresa il cui oggetto sociale consista nella gestione di partecipazione azionarie e obbligazionarie in altre imprese o enti. In alcuni casi il rischio di mercato si
manifesta anche per alcune merci fungibili quali: l’oro e i metalli preziosi in generale o altre materie prime dette commodities. In questo caso, un’oscillazione imprevista dei prezzi di mercato può generare la necessaria svalutazione delle poste contabili con conseguenze negative sul
risultato d’impresa.
La panoramica sopra esposta non ha la pretesa di essere esaustiva; essa
può essere utilizzata, però, ai fini di una prima organizzazione e classificazione dei rischi cui un’impresa può andare incontro. Tuttavia essa risulta
inadeguata quando si vuole approfondire il problema del legame tra decisioni economico-finanziarie, rischio e valore d’impresa. Per fare, infatti,
luce sul rapporto che esiste fra tali grandezze è necessario rileggere i rischi
sopra descritti tentando di collegarli alle decisioni di investimento o di finanziamento.
Nel prossimo paragrafo impareremo a distinguere il business dal leverage risk e ha comprendere come esso venga ripartito tra i finanziatori
d’impresa. In questo caso, quindi, l’analisi sarà svolta nella prospettiva del
prenditore del rischio (azionista o obbligazionista) e non dell’impresa, come abbiamo finora fatto. Individuare i profili di rischio di ciascun investitore ci sarà utile quando tratteremo dell’entità e della natura dei capitali che
dovranno essere posti a garanzia dei rischi enunciati.
5. Rischi d’impresa: business and leverage risk9
Se volessimo rileggere l’impresa come centro dei rischi originati
dalle decisioni economico-finanziarie (investimento, finanziamento e
dividendo), l’articolato quadro disegnato nel paragrafo precedente andrebbe notevolmente a semplificarsi. I rischi sono infatti classificabili in
due classi omogenee:
• il business risk, ovvero la variabilità dei risultati conseguente agli atti
di investimento;
9
Per un approfondimento cfr. Conti C. (2006), Introduzione al Corporate Financial Risk
Management, Pearson, Milano, pp. 23 e ss.
32
•
il leverage risk, misurato dalla variabilità dei risultati a seguito delle
decisioni di finanziamento dell’impresa.
La somma delle due componenti, il rischio totale, grava sull’impresa e
costituisce, insieme alla rinuncia al consumo, la principale motivazione per
la quale gli investitori – azionisti o obbligazionisti che siano – pretendono
un rendimento.
Applicando pedissequamente la teoria neoclassica della finanza è possibile affermare che l’impresa si trova in posizione neutra rispetto ai rischi
assunti nella gestione, e ciò in quanto il rischio totale (asset risk) si trasferisce sui soggetti che finanziano l’impresa. Infatti, su di essi, quant’anche
soggetti razionali e dal portafoglio di investimenti ben diversificato, ricade
il rischio sistematico dell’investimento.
Limitandoci a osservare il rischio generato nelle attività d’impresa prima che esso “transiti” verso i suoi prenditori e trascurando, così, le politiche di diversificazione dei finanziatori, possiamo approfondire l’origine del
rischio d’impresa.
Il rischio totale d’impresa, detto asset risk, è scomponibile in business e leverage risk. I due tipi di rischio non hanno, tuttavia, le medesime caratteristiche in quanto, il business risk è connaturato all’esistenza
dell’impresa, mentre il secondo è un rischio eventuale, sebbene quasi
sempre presente.
Infatti, se come conseguenza della propria attività ogni impresa che necessiti di investimenti è soggetta al business risk, lo stesso non si può dire
per il leverage risk che emerge in modo pronunciato nel caso in cui l’impresa faccia uso di capitale di terzi. L’imprenditore può evitare di sopportare i rischi relativi al finanziamento degli investimenti non dotandosi di debito, oppure limitarne la portata e disegnando una struttura finanziaria capace di garantire solvibilità e sostenibilità. Si tratta dunque di un rischio
eventuale non presente nel “caso di scuola” in cui l’imprenditore finanziasse l’intero fabbisogno finanziario ricorrendo alle risorse proprie; in tal caso
i risultati dell’impresa sarebbero soggetti solo all’alea derivante da rischi
operativi generati dagli investimenti. Di conseguenza l’asset risk risulterebbe uguale al business risk e il valore dell’impresa (Vassets) uguale a quello
per i suoi azionisti (Vequity).
Rischio Totale = Asset Risk = Business Risk
Vassets = Vequity
Una struttura finanziaria interamente costituita da capitale proprio è,
però, un caso assai raro, più spesso confinato nelle ipotesi dei modelli rela33
tivi al rapporto tra struttura finanziaria e valore (Modigliani e Miller 1958 e
1963; Miller, 1977). Nella maggioranza dei casi, infatti, le imprese fanno
fronte al fabbisogno finanziario, ricorrendo in parte al capitale proprio, in
parte al capitale di terzi. In questo caso accanto al business risk sopra descritto, si affianca la variabilità dei risultati derivante dalle modalità con cui
l’impresa si finanzia. Tale variabilità è definita leverage risk. Il leverage
risk è dunque un rischio eventuale che l’impresa, e poi quindi i suoi finanziatori, si accollano per il ricorso al denaro di terzi.
In presenza di leverage risk e in assenza di posizioni di arbitraggio
(Modigliani e Miller 1958, Miller 1977), il rischio totale è quindi composto
da business e leverage risk. Questi, insieme, sono sopportati interamente
dai finanziatori dell’impresa secondo i criteri previsti dalla tutela dei creditori. Anche in questo caso, nella maggioranza dei casi, i residual claimers
sono innanzitutto gli azionisti sui quali ricadrà tanto il business risk che il
leverage risk generato dalle decisioni di struttura finanziaria.
Rischio Totale = Business risk + Leverage risk.
Per determinare il valore asset dell’impresa verrebbe naturale concludere che esso sia la somma del Vequity + Vdebts. Per la verità questa uguaglianza
non è verificata, principalmente a causa di alcune caratteristiche del debito
nella creazione di valore (Myers 1984).
In particolare gli interessi passivi, pagati dall’impresa come rendimento
dei capitali di terzi, sono fiscalmente deducibili e inoltre l’introduzione del
debito in impresa porta all’emergere del rischio di insolvenza e dei conseguenti costi del fallimento. Di conseguenza per calcolare il valore dell’impresa indebitata sarà necessario riprendere il “caso di scuola” sopra descritto dell’impresa unlevered per applicarvi i correttivi necessari per tenere
conto della presenza del debito.
Myers nel suo saggio del 1984 presenta il calcolo del valore di un’impresa indebitata come segue:
Vlevered = Vunlevered + BF – CF
dove il valore dell’impresa indebitata (Vlevered) è la somma algebrica del
valore dell’impresa priva di debito (Vunlevered), dei benefici fiscali associati
al debito (BF) e dei costi attesi diretti e indiretti del fallimento (CF). In sostanza il valore totale d’impresa, ma anche quello per i propri azionisti, potrà essere aumentato al crescere dell’indebitamento fino a quando il beneficio marginale del debito non eguaglierà il costo marginale del fallimento.
Nel caso di un’impresa unlevered, il Beta, che ricordiamo essere la misura utilizzata in Finanza Aziendale per misurare il rischio totale, sarà
34
uguale al Beta del capitale proprio in assenza di debito (βequity0,100), detto
anche Unlevered Beta (βunlevered).
In questo caso
βassets = βequity0,100 = βunlevered
Nel caso invece di presenza di debito, il rischio d’impresa, misurato
ancora dal Beta assets, sarà la media ponderata dei Betas delle varie fonti.
Esprimendo questa medesima relazione servendosi del Beta quale misura del rischio d’impresa possiamo scrivere:
β assets = β equity + β debts = β e
E
D
+ βd
E+D
D+E
dove βequity sarà un Beta Levered ovvero un indicatore di rischio dell’azionista di un’impresa indebitata e dove βdebts sarà la misura del rischio
dei portatori di capitale di terzi.
Il Beta del debito sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il credit
spread (CS). Poiché Il credit spread è a sua volta funzione del merito creditizio dell’impresa (Probability of Default) e della Loss Given Default.
Nel dettaglio è illustrato proprio come sia possibile calcolare il Beta del
debito in modo indiretto dal credit spread negoziato per un titolo obbligazionario. L’equazione si ridurrebbe infatti alla seguente:
βd =
Credit spread
( Rm − R f )
Nella circostanza di un’impresa solvibile il beta del debito è zero e il rischio di business e di leverage sono entrambi sopportati dall’azionista. Nel
caso invece di insolvenza, essa comporterà il trasferimento di parte del rischio dall’azionista al creditore, cosa che si manifesterà con l’incremento
del Beta Debts. In particolare ciò avviene quando le politiche di finanziamento dell’impresa non sono coerenti con quelle di investimento e si manifestano degli squilibri di struttura finanziaria.
Concludendo, il rischio di business e quello di leverage non hanno la
medesima natura e nemmeno sono riservati loro i medesimi trattamenti.
Il business risk è infatti insito nell’attività d’impresa e può essere abbattuto solo ricorrendo a politiche di diversificazione del proprio portafoglio di investimenti. Il leverage risk è invece un rischio accessorio derivante dalle decisioni assunte in materia di copertura degli investimenti e
dalle condizioni esterne all’impresa che possono modificare l’onerosità
delle fonti finanziarie.
35
Non è quindi possibile determinare una corrispondenza tra il business
risk e l’equity risk da una parte e il leverage risk e il debts risk dall’altra.
Infatti, in ipotesi di impresa solvibile, entrambi i rischi sono sopportati
dal azionista ogni qualvolta il patrimonio netto è capiente rispetto alla perdita massima potenziale. Nel caso contrario, il manifestarsi del rischio di
insolvenza fa sì che una parte sia del rischio di business sia di quello più
ampio di leverage ricadano sul finanziatore terzo generando debts risk.
6. Adeguatezza delle fonti e rischio di struttura finanziaria
L’importanza di un’adeguata politica di finanziamento è testimoniata
dagli approfondimenti teorici della Scuola italiana, la quale ha contribuito
al dibattito sviluppando il rapporto tra copertura degli investimenti e rischio
di struttura di finanziaria (Cattaneo 1976; Pivato 1983; Fanni Duemila).
Si debbono a questo periodo gli studi sul margine di struttura e di
tesoreria (Brugger 1980; Cattaneo 1976; Cheng 1985), lo sviluppo degli
indicatori di leverage e di copertura delle immobilizzazioni e di quelli di
liquidità.
Tra gli strumenti di più semplice utilizzo, sviluppati in quegli anni, ritroviamo il prospetto fonti-impieghi. Da esso è possibile evincere con chiarezza quali investimenti il management ritenga utili alla realizzazione della
mission e quali finanziamenti siano stati attivati. In particolare, tale prospetto è l’equivalente finanziario dello stato patrimoniale dell’impresa. Si
tratta di un documento extra-contabile non richiesto dalla normativa civilistica e fiscale, ma necessario per valutare l’adeguatezza delle fonti rispetto
agli impieghi. Nella sua forma a sezioni contrapposte il prospetto presenta,
seguendo il criterio di crescente liquidità dell’investimento, le poste relative
a cespiti e disponibilità aziendali necessarie all’impresa. Dai beni difficilmente liquidabili al bene liquido per eccellenza, la moneta, si iscrivono
nella parte sinistra del prospetto i valori finanziari dei vari investimenti.
Contrapposta agli impieghi troviamo la sezione delle fonti finanziarie. Si
tratta dei finanziamenti ottenuti dall’impresa presso terzi o presso i soci, finanziamenti che garantiscono l’acquisizione dei beni per il processo produttivo. Tali fonti sono ordinate per scadenza: partendo da quelle vincolate
all’impresa per un periodo pluriennale (per esempio: capitale proprio, riserve di utili, di rivalutazione, riserve libere) e raccolte presso gli azionisti, incontriamo le obbligazioni contratte per mutui bancari o per l’emissione di
titoli di debito direttamente sul mercato finanziario, per arrivare al debito
commerciale e finire con il debito a breve termine (aperture c/c bancario,
36
sconto di portafoglio commerciale). La natura e la composizione degli impieghi e delle fonti cambia al mutare della fase di sviluppo nell’impresa.
I finanziamenti debbono essere scelti tra le fonti disponibili secondo il
principio di adeguatezza. Si individuano tre tipi di adeguatezza delle fonti
agli impieghi:
a. orizzontale;
b. verticale;
c. economica.
L’adeguatezza orizzontale è di gran lunga la più trattata in letteratura
(Cattaneo 1976, Brugger 1980) e si verifica quando le fonti sono omogenee
per natura e scadenza agli investimenti che vanno a finanziare. Una misura
dell’adeguatezza orizzontale è quella del margine di struttura e di tesoreria
utilizzati già da molti anni in letteratura. Entrambi hanno però il limite di
calcolare l’adeguatezza servendosi di valori assoluti e quindi di non essere
capace di catturare il margine relativo di copertura e di tesoreria. Per questo
motivo, nel caso del primo, si è soliti servirsi del rapporto di copertura delle
immobilizzazioni, che costituisce l’equivalente in forma di rapporto del
margine di struttura stesso. L’altro margine utilizzato per valutare l’adeguatezza orizzontale è il margine di tesoreria che viene calcolato sottraendo
dalle poste liquide dell’attivo corrente i debiti finanziari e commerciali a
brevissima scadenza. Tale margine, come già il precedente, ha una versione
in forma di rapporto nell’acid ratio, uno degli indicatori di liquidità maggiormente utilizzati in letteratura insieme al current ratio e al quick ratio.
Proprio l’adeguatezza orizzontale nelle poste di bilancio di brevissimo
termine scongiura l’insolvenza e rende possibili il raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’impresa.
L’adeguatezza verticale pone l’accento sulle proporzioni relative delle
fonti di finanziamento ed è capace di segnalare situazioni di squilibrio nella
scelta dei finanziamenti nella forma di eccessivo indebitamento rispetto al
capitale proprio. Per misurare l’adeguatezza verticale possono essere utilizzati i ratio di composizione del capitale aziendale [D/(D+E)] ed E/(D+E)
oppure il conosciuto rapporto di leva finanziaria o D/E).
Quest’ultimo, in particolare, segnala quante volte il debito sottoscritto
dall’impresa sopravanza il capitale netto investito. Si tratta di un indicatore
relativo di adeguatezza in quanto due grandezze che partecipano alla struttura
finanziaria d’impresa vengono messe a confronto le une con le altre. Per questo motivo tale indice è utilizzato confrontandolo con quello di imprese simili
operanti nel medesimo settore e assimilabili alle prime per natura dei flussi
finanziari generati e per rischio a cui sottopongono l’investitore.
L’adeguatezza economica della struttura dei finanziamenti viene sod-
37
disfatta quando la gestione corrente è capace di generare ricchezza sufficiente al “servizio del debito”, ovvero alla copertura degli oneri finanziari
generati dal ricorso all’indebitamento. Il debito, infatti, non genera di per sé
squilibri finanziari. Essi si verificano solo nel caso in cui la redditività operativa dell’impresa, ovvero il reddito operativo ante interessi, non sia capiente rispetto agli interessi passivi originati dal debito stesso. In altre parole, quando EBIT (1 – tc) < Oneri Finanziari. In questo caso, non solo tutta
la redditività operativa è assorbita dal servizio del debito, ma anche una
parte di tali costi costituiscono perdite che vanno a erodere il capitale proprio dell’impresa. Se questa situazione permane nel tempo, l’impresa è destinata a uno squilibrio strutturale e subentra lo stato di sofferenza e crisi.
Proprio per calcolare la capacità dei flussi di cassa di servire il debito
sono state sviluppate in letteratura e prassi una serie di indicatori capaci di
valutare l’effettiva copertura delle politiche di finanziamento da terzi.
Tra i più utilizzati ricordiamo, dal punto di vista prettamente contabile,
il rapporto:
EBITDA
Indice di copertura degli oneri finanziari =
Oneri finanziari
che mette in rapporto il reddito operativo ante ammortamenti, svalutazioni,
oneri finanziari e imposte (EBITDA) con i soli oneri finanziari. Tale indice
non tiene conto della quota capitale oggetto di rimborso che, sommata agli
oneri finanziari, va, invece, a costituire il denominatore (Total Debt Service) dell’indice conosciuto nella prassi e in letteratura come Debt Service
Coverage Ratio (DSCR):
DSCR =
EBIT
Total debt service
oppure una sua variante finanziaria al cui numeratore troviamo il flusso di
cassa disponibile per i finanziatori (FCFF):
DSCR Fin =
FCFF
Total debt service
Qualora gli indicatori sopra descritti assumano valori uguali o inferiori
a uno, si verificherà l’impossibilità oggettiva per l’impresa di fare fronte
alle uscite originate dall’indebitamento con la liquidità generata dall’attività
operativa. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce di per sé un elemento
sufficiente all’emergere dell’insolvenza in quanto il management può, teo-
38
ricamente, reperire nuove risorse nelle altre aree del rendiconto finanziario,
ovvero in quella del debito o in quella del capitale proprio. La copertura del
debito è dunque condizione necessaria alla sopravvivenza dell’impresa nel
lungo termine e a un corretta ripartizione del rischio sui soggetti prenditori,
ma di per sé non è sufficiente a garantirne la solvibilità.
Infatti, l’insolvenza potrebbe manifestarsi a causa degli sfasamenti
temporali del ciclo monetario, responsabili delle tensioni di liquidità e ciò
in presenza anche di flussi di cassa annuali superiori al servizio del debito.
Non è questa la sede per approfondire il tema dell’adeguatezza patrimoniale ed economica, in questa sede ci preme di sottolineare come la funzione tecnica di produzione e adattamento e quella produttiva di finanziamenti siano centrali nelle attività d’impresa e fortemente collegate tra loro.
Proprio il mancato coordinamento, abbiamo visto, genera rischio d’impresa, in questo caso rischio di struttura finanziaria che è inserito tra i rischi
finanziari interni.
7. Il rischio e le fasi del ciclo di vita di un’impresa
Il rischio, che come abbiamo già detto nel par. 1 è originato dalle condizioni di incertezza nelle quali gli investimenti vengono assunti, può
emergere in modo difforme nella varie fasi di crescita dell’impresa. Volendo tracciare un percorso ideale di crescita dalla formazione della business
idea fino all’impresa complessa, possiamo tentare di illustrare il rapporto
tra investimenti e finanziamenti, e il rischio tipico di ogni fase di sviluppo
dell’impresa.
La fase di genesi (start-up) è quella in cui l’imprenditore formalizza la
business idea e definisce gli assetti organizzativi, strategici e proprietari
iniziali. In particolare, in questa fase, l’imprenditore pioniere è tenuto a selezionare gli investimenti iniziali per l’avvio dell’attività e a reperire, prevalentemente dalle proprie disponibilità – attraverso il conferimento – le
fonti finanziarie. Il primo atto di finanziamento dell’impresa è il conferimento del capitale sociale in sede di costituzione al quale normalmente seguono fonti finanziarie di terzi: principalmente nella forma dell’indebitamento bancario di breve e di medio lungo termine. In questa fase primaria
di sviluppo, si avviano le attività di produzione e adattamento di beni e servizi e, proprio a causa della novità, si verificano più spesso che nelle fasi
successive, rischi operativi relativi: ai materiali utilizzati, all’organizzazione del processo produttivo e a quella dei canali distributivi. Per questi
motivi la copertura degli investimenti iniziali è prevalentemente operata at-
39
traverso fondi propri e solo per la parte relativa alle attrezzature e alla
strutture produttive si ricorre al debito. Solo in questo caso, accanto al rischio operativo, si affianca quello derivato di struttura finanziaria (Floreani
2005), rischio che abbiamo visto emergere a causa di un’inadeguata copertura dei fabbisogni finanziari. In questa fase la composizione delle fonti è
inizialmente sbilanciata verso il capitale proprio, mentre il rapporto D/E
aumenta velocemente con l’utilizzo del debito bancario, sia esso a breve o a
medio lungo termine.
La fase successiva, quella di espansione dell’impresa, ha come obiettivo
quello del consolidamento delle attività, della crescita della quota di mercato e
di ampliamento dei canali distributivi, anche oltre i confini nazionali. Gli investimenti tipici di questa fase sono quelli relativi alla crescita della quota di
mercato, all’affermazione di marchi e brevetti distintivi rispetto alla concorrenza e all’espansione del capitale circolante netto a causa della maggior diffusione dei beni e servizi. Si acutizzano i rischi operativi relativi alla logistica
e quelli sulle stime di vendita, che risultano di minor qualità a causa della forte
varianza causata dalla crescita. Sono per la prima volta presenti rischi relativi
alle attività internazionali poste in essere dall’impresa identificabili tanto nel
rischio di cambio che in quello di tasso di interesse, rischi, questi, di natura
finanziaria. Nel caso, poi, l’impresa intraprenda la via della crescita esterna,
gli impieghi saranno prevalentemente di natura finanziaria e relativi all’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di imprese operanti nel
medesimo settore o in altri a esso collegati. Il fabbisogno finanziario tipico di
questa fase è molto elevato e deve essere coperto principalmente ricorrendo a
iniezioni di nuovo capitale proprio capaci di rendere possibile un’ulteriore
espansione del debito. È in questa fase che, in alcuni casi, all’imprenditore
pioniere si affiancano degli operatori specializzati nel capitale di rischio i quali
possono sottoscrivere, in parte o integralmente, l’aumento di capitale necessario alla fase espansiva. A seguito di tale operazione, il rapporto D/E subisce un
ridimensionamento. Ciò permette all’impresa di reperire ulteriori fonti di finanziamento presso gli istituti bancari e comporta, nella seconda parte di questa fase, il ritorno a livelli elevati di D/E. Dal punto di vista della struttura finanziaria, questa fase è caratterizzata da una crescita diffusa di entrambe le
componenti debito e capitale proprio con uno sbilanciamento, nella parte finale, a favore del debito. Con esso infatti si possono finanziare operazioni di
Leverage Buy Out. In questa fase il servizio del debito è in alcuni casi difficoltoso e l’impresa soffre di scarsa flessibilità finanziaria derivante dagli alti
costi collegati al debito. Inoltre, la presenza di operazioni di fusione e acquisizione finisce per aumentare il rischio operativo nella componente dei rischi di
integrazione tra impresa target e bidder. Ciò finisce per far crescere le aspet-
40
tative in termini di rendimento atteso che si dovrà adeguarsi a nuovi e più alti
livelli di rischio, sia finanziario che operativo.
La fase successiva a quella dell’espansione d’impresa è quella del
going-public10. In tale fase il management ha come obiettivo quello di proseguire lo sviluppo delle attività superando i vincoli delle risorse finanziarie
private reperibili sui mercati non regolamentati. Altri possibili obiettivi capaci di orientare questa fase sono (Arosio, Giudici, Paleari 2000):
• il disinvestimento da parte di alcuni soci (pionieri o private bankers)
delle partecipazioni d’impresa. Ciò da spesso origine a operazioni di
management buy out o family buy out;
• il miglioramento dell’immagine aziendale a seguito della maggior trasparenza necessaria per l’accesso alle negoziazioni e conseguenza, anche, della quantità e qualità delle informazioni scambiate sull’impresa;
• la capacità di attrarre risorse umane di maggior qualità.
In questa fase l’impresa continua nel suo percorso di crescita, interna o
esterna che sia, aumentando il volume delle attività fisse e in particolare degli
impieghi in attività durevoli materiali o in quelle finanziarie (in caso di crescita
esterna tramite acquisizioni). Gli ingenti impieghi necessari in questa fase fanno emergere un fabbisogno finanziario di notevoli dimensioni che deve trovare
temporaneo soddisfacimento in fonti di debito quali: il debito secondario (second lien) e il mezzanine financing. Proprio queste fonti permettono all’impresa di non interrompere il proprio percorso di crescita garantendo le risorse per investire in quel processo di riorganizzazione funzionale, strategica e
finanziaria che accompagnerà la società alla quotazione sui mercati regolamentati. In questa fase, il rischio generato dall’impresa è principalmente causato dalle difficoltà di integrazione dei nuovi assets acquisiti dalla medesima e
dal mancato raggiungimento di obiettivi di vendite e redditività. Ciò si manifesta congiuntamente al rischio di struttura finanziaria innescato dal forte ricorso
al capitale di terzi. Proprio questa ultima componente di rischio finanziario è
solo in parte mitigata dall’utilizzo, da parte dell’impresa, di forme di finanziamento a remunerazione variabile, normalmente definiti strumenti di semiequity. Un esempio è la sottoscrizione da parte dell’impresa di prestiti partecipativi o di mezzanine loans destinati alle operazioni di quotazione. Il rapporto
D/E subisce in questa fase un rapido incremento che terminerà solo con
l’immissione di nuovo capitale in fase di Initial Public Offering.
Una volta realizzata la quotazione con l’aiuto degli advisors e del glo10
Il termine “going public” sta a indicare l’operazione di prima quotazione di un’impresa su
un mercato regolamentato. Per un approfondimento sul tema del valore in fase di emissione
cfr. Roggi O. (2003), Valore intrinseco e prezzo di mercato nelle operazioni di finanza
straordinaria. Una analisi sulle public utilities, FrancoAngeli, Milano.
41
bal coordinator (Roggi 2003; Arosio, Giudici, Paleari 2000), l’impresa,
ormai una public company, orienta le proprie attività di impiego e di finanziamento tenendo in dovuta attenzione il rapporto con il mercato nel
quale i titoli sono negoziati. I progetti di investimento vengono scelti non
tanto sulla base del principio di creazione di valore tout-court, ma piuttosto
perseguendo quello specifico di massimizzazione del valore disponibile per
gli azionisti. In questa fase, infatti, la massimizzazione del prezzo azionario
si sostituisce all’obiettivo di creazione del valore e finisce per modificare le
scelte di investimenti e di finanziamento.
Proseguendo nel percorso di crescita, l’impresa raccoglie il capitale
emesso nel corso dell’IPO provvedendo a riequilibrare il rapporto D/E che
era cresciuto nelle fasi precedenti. Visti gli alti costi di emissione, l’impresa
raccoglierà sul mercato il capitale necessario a finanziare il fabbisogno durevole evidenziato nel piano industriale e ciò comporterà, almeno nella prima
fase post-quotazione, una notevole riduzione dell’indice D/E. Successivamente alla quotazione, l’impresa continuerà a crescere espandendo la propria
attività alla produzione di altri beni e servizi, oppure deciderà di affrontare il
mercato internazionale. In entrambi questi casi, l’impresa beneficerà della
riduzione del rischio specifico relativo al core business e sottoporrà i propri
investitori a un rischio mitigato, principalmente pari a quello sistematico. La
letteratura non è concorde sull’utilità delle operazioni di diversificazione intraprese dall’impresa all’indomani della quotazione. Infatti, una corrente di
pensiero (Myers 1968; Shall 1972; Brealey e Myers 1981) afferma che la diversificazione di rischi specifici di impresa è raggiungibile con minori costi e
maggiore facilità dall’investitore (persona fisica), il quale potrà costruirsi un
portafoglio di azioni rappresentative di imprese dalle attività diversificate.
Tali autori concludono che le attività di crescita in settori e attività attigue a
quella svolta sono da disincentivare e non dovrebbero essere oggetto della
crescita post-quotazione. Altri autori, convinti dell’utilità dell’impresa come
intermediario tra i bisogni della collettività non organizzata e lo Stato, pongono l’accento sulla sopravvivenza della stessa e sottolineano come le attività
di diversificazione, successive alla fase di quotazione, portino benefici all’impresa sotto forma di maggiore stabilità dei flussi di risultato, riducendo
così i rischi degli investitori. Ai nostri fini dobbiamo segnalare come la diversificazione riduca il rischio specifico e quindi contribuisca alla riduzione
dei rendimenti attesi dei soggetti finanziatori in assenza di ipotesi di razionalità e perfetta diversificazione del portafoglio delle attività.
Riguardo alla natura delle fonti, e al loro rapporto, possiamo affermare
che dopo la prima fase di maggiore capitalizzazione dovuta all’emissione
azionaria, l’impresa, ormai quotata, potrà e dovrà aumentare il ricorso alla
42
leva finanziaria. Ciò accadrà servendosi di nuovi e più “potenti” strumenti
di debito disponibili prevalentemente per le imprese quotate. Ci riferiamo
in particolare alla possibilità di emettere e quotare sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) i titoli rappresentativi del debito d’impresa e sull’IDEM ogni prodotto da esso derivato. Queste emissioni, che possono essere di natura e importi molto diversi tra loro, contribuiscono a far nuovamente aumentare il rapporto D/E, che tornerà a livelli di attenzione. Soprattutto nelle fasi finali di questo periodo si potrà far ricorso a operazioni a
maggior rischio finanziario attraverso l’emissione di prestiti non garantiti
ad alta rischiosità, quali gli high yield bond.
Continuando il percorso di crescita, l’impresa entra nella fase di maturità. Tale fase è caratterizzata principalmente da rischi di natura non operativa. Obiettivi propri di questa fase sono: la stabilizzazione dei flussi di risultati, la riduzione del costo del capitale, l’individuazione di operazioni di
rejuvenation (Baden Fuller, Stopford 1994) delle attività legate a nuovi
prodotti o mercati, o solo anche a nuovi processi produttivi.
Con la maturità dell’impresa, il rendimento atteso dei progetti da realizzare diminuirà a seguito del venire meno di progetti maggiormente remunerativi, con la conseguenza di una minore redditività differenziale dei
progetti marginali rispetto a quelli inizialmente intrapresi. Questa circostanza, misurata efficacemente dalle riduzione dell’Economic Value Added
di progetto (Stewart 1991), ha come conseguenza quella di disciplinare il
management (Jensen 1986) nell’utilizzo delle fonti finanziarie (Myers
1984) e soprattutto di orientare lo stesso verso operazioni di riduzione del
costo del capitale. Ciò necessariamente spinge a sostituire capitale proprio
con quello di terzi e, indirettamente, ad aumentare il rischio d’insolvenza
dell’impresa. Inoltre il management realizzerà operazioni di copertura dei
rischi, trasferendo a terzi i cosiddetti rischi assicurabili e trattenendo solo
quelli tipici e ineliminabili d’impresa.
Da quanto sopra illustrato emerge come la visione statica dell’impresa
non contribuisca a conoscere il rapporto organico che esiste tra investimenti, finanziamenti, rischio e rendimenti richiesti dai finanziatori.
L’impresa, nel suo divenire, si trasforma negli impieghi e nelle fonti che ne
garantiscono la copertura. Dagli impieghi, diversi fase per fase, emergono
principalmente rischi operativi relativi: ai progetti realizzati, alla logistica,
alla produzione e alla commercializzazione dei beni e servizi.
Dalle fonti, invece, prende origine il rischio finanziario. Quest’ultimo è
caratterizzato principalmente dal rischio d’insolvenza, ma a esso si associano altri rischi finanziari connessi alle caratteristiche dei finanziamenti raccolti, primi fra tutti i rischi di interesse e di cambio.
43
Natura
degli
impieghi
Impieghi
per l’organizzazione
delle funzioni
produttive
e di adattamento
Espansione
commerciale,
impianti e macchinari
M&A
Natura
delle fonti
Conferimento equity
iniziale + debito
bancario
Debito bancario
prevalente sul capitale
proprio. Eventuale e
mezzanino pre IPO
Capitale proprio
raccolto in IPO, debito
strutturato senior
Capitale proprio
(aumenti), Debito
senior, secondario
e subord.
Debito a basso
rendimento
Rischi
aziendali
Rischio operativo
di organizzazione
d’impresa
Rischio operativo
e finanziario
Rischio operativo
e finanziario
e regolamentare
Rischio
finanziario
prevalente
Rischio finanziario
e rischio
di Governance
Altissimo
Alto
Alto
Rapporto
D/E
Alto
Going Public
Basso
Expansion
Basso per
ricapitalizzazione
Fase
di
sviluppo
Basso in crescita
Start-up
Altissimo
Figura 1 – Ciclo di sviluppo dell’impresa, tipologie di rischi aziendali e andamento del rapporto d’indebitamento D/E
Public
Maturità
D/E
t
8. Il rischio e il valore d’impresa
Le discipline aziendali e in particolare la Finanza Aziendale hanno sviluppato e più volte tentato di legare i rischi d’impresa ai rendimenti richiesti dai
suoi finanziatori. I numerosi modelli teorici e strumenti operativi sono stati in-
44
trodotti per comprendere, stimare e poi ridurre i rischi d’impresa (Doherty
1985; Greene e Serbein, 1983; Ferry 1988). Come approfondiremo nel Capitolo 2, tali sforzi sistematori hanno fatto nascere un filone di studi conosciuto
come corporate risk management, nel quale le relazioni tra rischio e valore
dell’impresa sono assunte come principali e le attività si organizzano per affiancare al classico obiettivo di massimizzazione del valore dell’impresa quello
peculiare, e oggi molto ricercato di minimizzazione dei rischi.
Già da alcuni decenni, per la verità, la Finanza Aziendale si è assunta il
compito di indagare sul rapporto che esiste tra rischio e valore. Ciò ha portato agli studi sull’adeguatezza della struttura economico finanziaria dell’impresa nell’esercizio delle proprie attività. In particolare è possibile affermare che, nella prospettiva finanziaria, l’impresa può essere vista come:
la sommatoria degli investimenti in attività necessarie all’impresa e dei corrispondenti finanziamenti necessari alla copertura. Nel suo funzionamento
fisiologico, poi, essa è un organismo capace di produrre flussi finanziari
positivi che eccedono quelli negativi.
In questa seppur sintetica descrizione dell’impresa nella sua prospettiva
finanziaria ritroviamo immediatamente la forte relazione che sussiste tra
attività/impieghi dell’impresa e le fonti finanziarie che ne permettono la
realizzazione e il rischio. Di seguito proponiamo alcuni richiami alla genesi
della relazione sopra descritta.
Nel 1927 a Ca’ Foscari, Gino Zappa introduceva nelle discipline aziendali il concetto di reddito d’impresa e su di esso costruiva una teleologia
d’impresa volta alla sua massimizzazione. Nel medesimo periodo, dall’altro
lato dell’oceano Atlantico, il reddito era oggetto di studi da parte di altrettanto illustri economisti e matematici. Correva l’anno 1930, infatti, quando
Irving Fisher, enunciando la teoria dell’interesse, dette un fondamentale
contributo teorico allo sviluppo delle discipline manageriali e, involontariamente, alla teleologia d’impresa zappiana: introducendo il concetto di
risparmio e di investimento e definendo il valore capitale e il valore d’impresa e di ogni altro investimento in relazione al reddito.
Infatti, sebbene il suo interesse fosse principalmente rivolto a comprendere
le ragioni dell’esistenza di un tasso di interesse sul capitale, indirettamente, egli
fece luce sul rapporto tra il risparmio presente, il suo “utile impiego” (investimento) e il rendimento o reddito futuro che era possibile ritrarre dal risparmio
impiegato. Affermava Fisher (1930, p. 26): “È il risparmio che ci porta a considerare la natura del capitale”. Proprio il capitale, insieme al tasso di interesse
su di esso applicato, è infatti l’elemento di collegamento tra il risparmio presente e il reddito futuro. Nelle parole dell’economista americano: “Il capitale,
nel senso di valore capitale, è semplicemente reddito futuro scontato o, in altri
45
termini, capitalizzato”. Così facendo Fisher lega in modo chiaro il concetto di
risparmio presente a quello di valore capitale futuro, affermando che: “il valore
di qualsiasi proprietà, o diritto di ricchezza, è il suo valore come fonte di reddito e si trova scontando quel reddito atteso”.
Si ponevano in questo modo le basi della teoria del valore più tardi
sviluppata da Modigliani e Miller (1958, 1963, Miller 1977) e da tutti gli
studiosi che hanno contribuito a farne, ai tempi odierni, il paradigma prevalente nelle scienze manageriali (Rappaport 1986, Stewart 1991).
Già nel 1930, Fisher era consapevole del rapporto che esisteva tra il
valore capitale odierno e il reddito futuro incerto. “Il problema fondamentale della valutazione temporale che la natura ci propone è sempre quello
di tradurre il futuro nel presente, e cioè di determinare il valore capitale
del reddito futuro. Il valore del capitale deve essere calcolato sul valore del
suo reddito futuro e non viceversa” (Fisher 1930, p. 31).
Con queste affermazioni egli si mostrava consapevole del fatto che le
decisioni di investimento fossero soggette all’alea del risultato, all’incertezza, portandoci a concludere che già in questo modello il valore
d’impresa dipendesse anche dall’incertezza e dal rischio. È questo sicuramente un altro elemento fondamentale per il quale il contributo di Fisher
rimane fondante nello sviluppo della Finanza Aziendale11: l’introduzione
dell’incertezza e quindi del rischio nella determinazione del valore dell’impresa (Fanni 2000).
Gli studiosi successivi hanno proseguito il lavoro partendo da questo contributo e già con Modigliani e Miller nel 1958 e poi con Myers (1984) e altri, si
è approfondita la genesi del valore. Con Rappaport (1986) e gli anni Ottanta,
poi, il paradigma del valore è divenuto predominante. L’obiettivo d’impresa è
quello di massimizzare il valore in generale e quello per gli azionisti, in particolare. Tale obiettivo è perseguibile e desiderabile tanto quando si opera in
condizione di certezza, tanto quando, invece, le condizioni sono di incertezza.
In questo paragrafo vogliamo mostrare come la massimizzazione del valore
può essere raggiunta in condizioni di incertezza e quindi il rischio influisca
sulla funzione obiettivo (Damodaran 2006) della Finanza Aziendale.
Partiremo nel nostro percorso dalla concezione di impresa basata proprio sul concetto di investimento introdotto da Fisher (1930). In finanza
un’impresa può essere valutata come la sommatoria dei progetti di investimento che un soggetto economico imprenditore realizza al fine di compiere
la propria “impresa”.
11
Sull’argomento e in particolare sul contributo del pensiero di Fisher alla Finanza Aziendale,
cfr. Fanni M. (2000), Manuale di finanza dell’impresa, Giuffrè, Milano, pp. XXIII e ss..
46
In sostanza il valore di un investimento J qualunque, e quindi dell’impresa sommatoria, può essere determinato come valore dei flussi di risultato futuro (CFt) generati dai progetti di investimento e attualizzati a un
tasso di interesse r che tenga conto del grado rischio insito nella stima.
Formalizzando:
Le componenti per la determinazione del valore sono quindi principalmente tre: i flussi di cassa generati dall’investimento CFt, il tempo t e il tasso di attualizzazione r.
In condizioni di certezza tali variabili hanno una determinazione univoca trattandosi di valori certi. Ciò fa si che il valore d’impresa possa essere
definito come la sommatoria dei flussi di cassa nominali attualizzati al tasso
risk free. Nel caso, invece, in cui si operi in condizioni di incertezza le cose
cambiano. Ai valori determinati univocamente saranno sostituite le stime
della variabili e per fare questo dovranno essere costruite, per ciascun elemento di calcolo, le rispettive distribuzioni di frequenza delle variabili
aleatorie.
In dottrina (Guatri Bini 2002), l’alea è inclusa all’interno della formula
del valore in due modi alternativi. Il primo prevede che l’alea sia inclusa
nella stima del tasso di attualizzazione e che invece i flussi di cassa attesi
siano indicati al loro valore nominale. Il secondo metodo prevede che il rischio sia previsto e incluso nella stima attraverso la ponderazione dei flussi
nominali con la probabilità di verificarsi degli stessi. In questo caso la letteratura parla di flusso di cassa equivalente certo. Accanto a questi due primi
metodi esiste anche il “Metodo del Venture Capitalist” (Callow 2005) nel
quale il rendimento atteso risk adjusted viene diviso ulteriormente per la
probabilità di verificarsi.
Recentemente, mutuando gli strumenti dalla gestione dei rischi delle
imprese bancarie, si sta cercando di introdurre la valutazione del rischio
inatteso su operazioni non bancarie servendosi del Cash Flow at Risk. Ne
parleremo nelle pagine che seguono.
8.1. L’inclusione del rischio nel tasso di attualizzazione
Come abbiamo ricordato sopra, utilizzando il primo metodo di inclusione dell’incertezza nel tasso di attualizzazione, i flussi di risultato, detti
47
anche cash flows (CF), sono espressi a valori nominali e non tengono conto
del rischio che essi varino a seguito dell’alea insita negli investimenti realizzati. Il rischio, come conseguenza dell’incertezza nella quale la decisione
è assunta, viene invece a essere incluso nel denominatore della sopra descritta formula, laddove il tasso di interesse al quale si attualizzano e capitalizzano i flussi di cassa contenga un premio per il rischio stesso. Tale tasso sarà sempre stimato tenendo conto del rendimento richiesto dagli investitori per rinunciare al consumo e per investire in un’attività rischiosa. Per
questo motivo al già citato tasso risk free dovrà essere aggiunto un premio
di rendimento capace di indennizzare l’investitore del rischio che sostiene
nel realizzare il progetto stesso. Tale tasso, noto in letteratura come Risk
Adjusted Rate of Return, RAdR (Guatri Bini 2002 et alia), dovrà tenere
conto tanto dei rischi operativi, insiti nell’iniziativa, quanto del financial
risk che emerge dalla struttura finanziaria scelta dall’impresa e dagli altri
rischi finanziari.
Tabella 2 – Modalità di inserimento del rischio nella formula del valore d’impresa
Criteri/CF
e tassi utilizzati
Equivalenti Certi
Flussi attesi rischiosi
Venture Capital
Method
Tipo di flusso
da scontare
Equivalente certo
del risultato atteso
Risultato medio atteso
Risultato
dello scenario
di successo
Tasso di sconto
Risk Free
RAdR
Rendimento richiesto
Calcolato cosi:
Rf
Rf + Premio
per il rischio
RAdR/probabilità
di successo
dello scenario
Fonte: Nostra elaborazione da Guatri e Bini (2002, p. 297)
In sostanza RAdR = E (Rj) = rf + ∆r, dove ∆r è il premio per operare in
condizioni di incertezza nell’investimento j.
Il calcolo del tasso di attualizzazione avviene effettuando la media
ponderata del costo delle fonti finanziarie che partecipano alla copertura
dell’investimento; le principali di esse sono il capitale proprio e quello
di terzi.
La letteratura sul tema del costo del capitale è ampia e variegata. Più
degli altri, Sharpe (1964) e Lintner (1965) e Miles-Ezzel (1980) sviluppando i contributi già noti sotto il nome di “Wacc Textbook” (il cosiddetto costo medio ponderato del capitale) hanno contribuito a completare il quadro
teorico già tracciato da Modigliani e Miller (1958 e 1963).
In generale, per costo del capitale si intende la remunerazione media
48
ponderata corrisposta ai finanziatori. Tale valore può essere stimato in due
modi differenti. Attraverso il tasso-costo viene calcolato l’onere di ciascuna
fonte secondo una logica del costo storico sostenuto, ponderandola con il
peso relativo della fonte nella struttura finanziaria. Ne consegue, la formula
di seguito illustrata:
E
D
WACC = Re
+ Rd
E+D
E+D
dove le due componenti di costo sono calcolate secondo la seguente logica:
• Re viene generalmente stimato facendo ricorso all’onerosità delle fonti
di capitale proprio (ROE storico);
• Rd è invece calcolato come rapporto fra gli oneri finanziari sostenuti e il
debito finanziario contratto.
In alternativa la stima può essere realizzata attraverso il tassoopportunità, più spesso utilizzato nel caso di una misurazione prospettica,
nel qual caso si considerano alla base del calcolo gli impieghi alternativi a
cui hanno rinunciato i finanziatori per investire nell’impresa. Ne consegue,
la formula di seguito illustrata:
WACC = K e
E
D
+ Kd
E+D
E+D
dove le due componenti di costo sono calcolate secondo la seguente logica:
• Ke viene generalmente stimato facendo ricorso al metodo del CAPM
calcolato con un beta levered tenendo conto della specifica struttura finanziaria e del rischio finanziario a essa legato;
• Kd è invece calcolato come somma del tasso privo di rischio e di un
premio per il rischio finanziario legato al rating e alla probability of
default del soggetto finanziato.
Considerato che la somma D + E = V rappresenta il valore dell’impresa
ed è pari al totale delle fonti necessarie per coprire il fabbisogno finanziario, il manager dovrà individuare il mix ottimale di finanziamenti che permetta la massimizzazione del valore dell’impresa secondo la formula del
Discounted Cash Flow (DCF) qui di seguito ricordata
Tale obiettivo, se poniamo costanti i free cash flow to firm (FCFF), sulla
base delle considerazioni fatte in precedenza, coincide con la ricerca della
minimizzazione del costo del capitale aziendale sopra indicato (Wacc).
49
8.2. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa
Un secondo metodo per includere il rischio nella valutazione d’impresa
è quello di utilizzare il metodo degli Equivalenti Certi (Certainty Cash
Equivalent) nel quale l’alea relativa alla realizzazione del progetto viene
incorporata nelle stime dei flussi di cassa. Tale approccio prevede la quantificazione del flusso di cassa certo che un soggetto è disposto a ricevere in
cambio di uno rischioso. Tale importo denominato CEQ è inserito al numeratore della sommatoria al posto del FCFF e attualizzato al tasso risk free.
Un approccio indiretto, ma sempre assimilabile a quello sopra descritto,
è quello presentato da Guatri e Bini (2005). L’equivalente certo è calcolato
in modo indiretto riducendo il valore dei flussi di cassa rischiosi del costo
della copertura. Ciò fatto sarà possibile attualizzare la differenza al tasso
privo di rischio. Limite di questo ulteriore approccio è quello di poter essere applicato solo nel caso in cui la copertura sia perfetta. Ciò facendo si costruisce un’espressione del valore del tipo:
In questo caso, come nel precedente, il tasso di attualizzazione da utilizzare nel processo di valorizzazione dei flussi futuri è quello dell’investimento privo di rischio. Infatti, nessun premio per il rischio sarà dovuto in ragione del fatto che tale rischio è già stato calcolato e ha preso
parte alla determinazione del numeratore.
8.3. L’inclusione del rischio nei flussi di cassa at risk (CFaR)
Recentemente la dottrina ha sviluppato alcuni metodi previsionali per i
flussi di cassa rischiosi. Tra i più noti, anche se poco utilizzato in pratica, è
il metodo di Monte Carlo. Accanto a esso, si sta sviluppando un metodo di
stima che possiamo definire derivato. Esso trae infatti origine dalla stima
del Value at Risk (RiskMetric 1999). Il VaR può essere utilizzato anche nell’analisi del rischio d’impresa e può permetterci di valorizzare quest’ultima
sulla base dei Cash Flow at Risk. In particolare il metodo tenta di includere
50
nel calcolo quelle variabili che permettono di misurare la volatilità dei flussi di cassa operativi di natura commerciale piuttosto che concentrarsi sulla
variabilità introdotta dai rischi di mercato come nel VaR. In letteratura sono
conosciuti tre distinti metodi per il calcolo dei Cash Flow at Risk. Il primo,
tradizionale, è stato sviluppato da Risk Metric (1999) ed è conosciuto come
metodo Bottom-up; esiste poi il metodo illustrato da Stein Ulsher and Laguttata (2001) e definito Top-Down. Recentemente si è sviluppato un terzo
metodo detto Exposure Base CFaR (Andrén, Jankensgard, Oxelheim 2005).
Il metodo bottom-up realizza la stima del CFaR tentando di identificare
e misurare le componenti della volatilità che sono esposti a rischi di mercato. La definizione dei CFaR è dunque diretta a conoscere la volatilità dei
cash flow dato un determinato livello di rischio di mercato. Questo approccio può essere utilizzato quando il top management è ragionevolmente sicuro delle proprie valutazioni riguardo al rischio e soprattutto è consapevole
dei meccanismi che, mutato il rischio di mercato, portano i cash flows a
modificarsi. Questo il principale limite che ha permesso lo svilupparsi di
approcci alternativi. Il metodo top-down, al contrario del precedente, costruisce la distribuzione di probabilità servendosi di dati storici aziendali e
delle proiezioni e stime soggettive dei managers di un numero elevato di
società. Questo approccio ha il vantaggio di offrire una stima media storica
dell’esposizione al rischio. Tale stima deve riflettere l’esperienza di una
pluralità di imprese esposte al rischio di mercato in modo anche dissimile.
L’elemento di forza di questo metodo è, però, anche il suo principale
limite. Infatti le imprese utilizzate per la costruzione della distribuzione di
probabilità possono essere molto diverse tra loro e quindi portare a risultati
non utilizzabili dall’impresa di cui si vogliono stimare i CFaR. Gli autori
(Stein, Ulsher, Laguttata 2001) osservando circa 85000 imprese incluse nel
data base Compustat, e in particolare tentando di spiegare le variazioni
inattese dell’EBITDA di queste imprese, giungono a concludere che tali variazioni sono principalmente attribuibili a quattro diversi gruppi di variabili:
la dimensione, la profittabilità, un indicatore di rischio settoriale dei cash
flow e infine la volatilità del prezzo dell’azione. Sulla base di queste categorie essi hanno diviso le imprese in gruppi omogenei e costruito le distribuzioni di probabilità dei cash flow per classi omogenee.
Per ovviare alla scarsa attenzione che entrambi i precedenti metodi, basati principalmente sulla stima della variabilità dei CF sulla base di quella
delle variabili di mercato, il metodo dell’Exposed Based-CFaR propone un
terzo metodo di calcolo. Esso si sostanzia in sei fasi:
1. identificazione delle variabili macroeconomiche e di mercato attese rilevanti ai fini della performance;
51
2. acquisizione e generazione delle previsioni delle variabili macroeconomiche e di mercato rilevanti per la stima della volatilità;
3. stima dello exposure model che sia tanto plausibile dal punto di vista
economico quanto con buone caratteristiche statistiche;
4. simulazione dei valori relativi alle variabili macroeconomiche servendosi di valori random estratti dalla matrice varianza-covarianza;
5. inserimento dei valori sopra determinati nel modello per generare la distribuzione condizionale dei cash flow che tenga conto dell’impatto
delle sole variabili macroeconomiche di mercato e la distribuzione la
distribuzione di frequenza costruita considerando tutte le variabili non
identificabili come fonti di volatilità non-macroeconomica;
6. combinazione delle due distribuzioni di frequenza in una singola distribuzione per identificare il grado di confidenza con il quale calcolare i CFaR.
Il vantaggio di questo ultimo metodo, che, vista la complessità di utilizzo, si sta sviluppando quasi esclusivamente nelle imprese industriali medio-grandi, è principalmente quello di identificare con chiarezza quale parte
della variabilità dei cash flow è attribuibile ai rischi macroeconomici e di
mercato e quale invece non è a essi attribuibile.
Così facendo, questo metodo, si avvicina alla trattazione del rischio secondo i principi della teoria del portafoglio finanziario (Markowitz 1952,
Modigliani e Miller 1958, Sharpe 1964) e dà una misura indipendente del
rischio sistematico e specifico sopportato dall’impresa.
9. Rischio di credito, insolvenza e costo del debito per l’impresa
Il percorso finora intrapreso ci ha portato a indagare la natura e le manifestazioni del rischio d’impresa, a comprendere il legame tra questo e il
valore d’impresa. La prospettiva scelta è quella dell’impresa e del suo rischio complessivo.
È ora necessario affrancarci temporaneamente dalla prospettiva d’impresa per assumere l’ottica del principale risk taker non azionista, la banca,
e affrontare il tema del rischio di credito. Quest’ultimo, infatti, è normalmente molto discusso dagli studiosi della discipline bancarie, poiché concerne il rischio sostenuto dall’impresa bancaria nell’attività tipica d’impiego delle risorse raccolte presso i risparmiatori. In questo contesto, però,
l’analisi del rischio di credito non è, quindi, esercizio inutile all’economia
del lavoro, giacché tende a chiarire il rapporto genetico che esiste tra rischio di credito, rischio d’insolvenza e pricing del credito. Tale relazione è
importante in quanto il pricing del credito per la banca si trasforma imme-
52
diatamente nel costo del debito per l’impresa. Quest’ultimo, poi, contribuisce alla determinazione del Wacc e di conseguenza alla determinazione del
valore d’impresa.
9.1. La definizione del rischio di insolvenza/credito nella prospettiva
del risk taker bancario: il rischio di credito
“Il rischio di qualunque prestito è espresso dalla probabilità che
l’operazione non dia alcun contributo positivo alla redditività dell’azienda finanziatrice o addirittura incida sfavorevolmente sui suoi risultati di esercizio”.
Dell’Amore (1965) già evidenziava come il rischio di credito fosse legato direttamente alla capacità del debitore di remunerare il finanziamento
ottenuto e di rimborsare il capitale. Più recentemente, il rischio di credito è
stato definito da Sironi (2000a) come: “L’eventualità che si verifichi una
variazione inattesa del merito creditizio; variazione in grado di generare
una modifica imprevista del valore di mercato della posizione creditoria”12.
Entrambe le definizioni citate contengono i due elementi fondanti il rischio di credito:
a. il rischio d’insolvenza, inteso come la probabilità che l’impresa non sia
in grado di adempiere al pagamento degli interessi sul debito e al rimborso del capitale prestato;
b. il rischio di migrazione, relativo al deterioramento del merito creditizio
dell’impresa.
Il primo elemento di genesi del rischio non è, quindi, unico in quanto anche il deterioramento del merito creditizio può generare una riduzione del
valore di mercato di un’esposizione debitoria. Si pensi a un titolo obbligazionario “quotato” nei mercati regolamentati, al quale è stato assegnato un determinato rating, ovvero un giudizio di “affidabilità” creditizia da parte di
un’agenzia esterna. L’eventuale downgrading13, causato dal deterioramento
della qualità creditizia dell’emittente, genererebbe, nel rispetto della logica di
rischio/rendimento, un incremento del premio per il rischio d’insolvenza richiesto dagli investitori. Non essendo possibile la revisione dello spread, tale
12
Cfr. Sironi A. (2000a), “La misurazione e la gestione del rischio di credito: approcci alternativi, obiettivi e applicazioni”, in P. Savona, A. Sironi (a cura di), La gestione del rischio di
credito, esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, Edibank, Roma.
13
Nel linguaggio tecnico dell’agenzie di rating per downgrading viene inteso un declassamento dell’impresa in una classe peggiore rispetto a quella occupata dall’attività, per esempio un rating BBB che diventa BB.
53
declassamento provocherà una riduzione del prezzo di mercato del titolo
quotato. In realtà, il rischio di migrazione, definito anche rischio di spread,
non è connesso solo alla possibilità di migrazione da una classe di rating all’altra, ma può derivare anche dalle generiche condizioni dei mercati. In effetti, è possibile che sia il “mercato”, o meglio gli investitori, a richiedere un
aumento dei differenziali di tasso rispetto ai titoli risk free per le obbligazioni
appartenenti a una medesima classe di rating. Tale fenomeno è generato dalla
relazione esistente tra avversione al rischio degli investitori, premio per il rischio e condizioni congiunturali dei mercati finanziari e non da cause direttamente imputabili al merito creditizio dell’impresa.
Il rischio di migrazione non riguarda solo i titoli obbligazionari, ma anche i rapporti di finanziamento che la banca instaura con i propri affidati14.
La misurazione del rischio di credito richiede, a livello operativo, la
quantificazione di due componenti15: la perdita attesa (expected loss, EL) e
la perdita inattesa (unespected loss, UL)16. L’UL rappresenta la perdita che
l’intermediario si attende a fronte di una posizione di prestito, la seconda è
espressione, in termini di variabilità, del valore sopra citato17.
L’entità della perdita attesa nella concessione di un affidamento, date le
caratteristiche della controparte debitrice, determina il pricing del prestito.
Fino a poco meno di un ventennio fa l’attenzione delle banche era rivolta
quasi esclusivamente alla stima della perdita attesa, senza preoccupazione della
possibilità che la perdita effettiva, a posteriori, potesse risultare maggiore di
14
Uno degli obiettivi di Basilea 2 è quello di valutare il prenditore non solo al momento
della richiesta di affidamento, ma anche durante la fase di vita del prestito. Ciò facendo un
possibile deterioramento o miglioramento della qualità creditizia si rifletterà direttamente
sull’accantonamento a patrimonio di vigilanza e di conseguenza sul tasso di interesse applicato all’operazione in ogetto.
15
Si vedano De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating, FrancoAngeli, Milano, e De
Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi
d’affidamento bancari, Bancaria, Roma.
16
Il NAC è calibrato in modo tale da fornire copertura sia per la componente di perdita attesa sia per quella inattesa: ciò diverge con i modelli finora utilizzati dalle banche che prevedono che la perdita attesa debba trovare copertura in un apposito accantonamento mentre la
perdita inattesa debba trovare copertura nel patrimonio di vigilanza. In sostanza il NAC
estende la copertura patrimoniale anche alla componente di perdita attesa. Ma in realtà la
perdita attesa è tenuta in considerazione nella determinazione del tasso attivo del prestito,
quindi si comprende che il NAC crea una sorta di duplice copertura.
17
Si vedano De Laurentis G. (1994), Il rischio di credito. I fidi bancari nel nuovo contesto
teorico, normativo e di mercato, Egea, Milano; e Id. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma; Sironi A.,
Marsella M. (a cura di) (1998), La misurazione e la gestione del rischio di credito: modelli,
strumenti e politiche, Bancaria, Roma.
54
quella prevista in via preliminare. L’evoluzione degli studi sull’attività bancaria
e sul rischio hanno “spostato”, invece, l’attenzione sulla perdita inattesa.
La distinzione tra EL e UL risulta essere fondamentale anche dal punto
di vista contabile, in quanto, a fronte della prima, la banca dovrà rettificare
il valore dell’attivo o rilevare un accantonamento a fondo rischi nel Conto
Economico, mentre la copertura della seconda avverrà attraverso il patrimonio della banca stessa. Gli azionisti della banca potranno quindi beneficiare di risultati economici superiori alle attese quando le perdite effettive
saranno inferiori a quelle preventivate, mentre dovranno sopportare l’onere
derivante da perdite realizzate maggiori di quelle previste (Sironi 2005).
Nei paragrafi successivi analizzeremo in dettaglio le componenti della perdita attesa e la relazione tra quest’ultima e il costo del debito per l’impresa.
9.2. Le componenti del rischio di credito
La stima della perdita attesa. La perdita attesa di un’esposizione creditizia al momento del default (expected loss, EL) è funzione di due fattori18:
• il valore dell’esposizione creditizia che ci si attende al momento del default (exposure at default, EAD);
• il tasso atteso di perdita attribuibile alla stessa esposizione creditizia
(expected loss rate, ELR).
A sua volta il tasso atteso di perdita è definito come il prodotto di due
ulteriori fattori:
• la probabilità d’insolvenza del debitore (probability of default, PD);
• il valore atteso della quota del credito non recuperabile in caso
d’insolvenza (loss given default, LGD).
Volendo formalizzare, la perdita attesa, espressa in valore assoluto, è
data dal prodotto tra esposizione al momento del default (EAD), probabilità
d’insolvenza (PD) e loss given default (LGD).
EL = EAD × PD × LGD
Nei paragrafi successivi analizzeremo gli aspetti teorici e pratici inerenti
alla misurazione delle componenti del rischio di credito sopra descritte.
18
Si vedano De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating, FrancoAngeli, Milano; e
De Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi
d’affidamento bancari, Bancaria, Roma; Szego G., Varetto F. (1999), Il rischio creditizio,
Utet, Torino; Anolli M., Gualtieri P. (1999), La misurazione del rischio di credito nella gestione delle banche, Il Mulino, Bologna.
55
Il calcolo dell’esposizione al momento del default (EAD). La stima
dell’esposizione al momento del default si basa sui seguenti elementi:
1. l’entità corrente di fido utilizzato (definita Drawn Portion, DP);
2. la quota inutilizzata al momento della valutazione (Undrawn Portion, UP);
3. la percentuale di quota inutilizzata che si prevede sarà utilizzata dal debitore al momento dell’insolvenza (Usage Given Default, UGD)19.
Nella stima dell’EAD, è di fondamentale importanza considerare la parte
di fido inutilizzata e prevedere quale sarà la quota di essa che l’impresa utilizzerà nel momento del default. All’avvicinarsi della situazione d’insolvenza vi è
la tendenza dell’impresa a incrementare l’esposizione entro i limiti del fido accordato dalla banca per far fronte agli squilibri finanziari in atto20. Tale circostanza fa sì che l’entità di fido utilizzata da un’impresa in funzionamento non
patologico e l’exposure at default (EAD) possano divergere notevolmente. Ciò
spiega l’importanza segnaletica degli indicatori sopra citati.
La formula di determinazione dell’esposizione corretta per la quota di
fido non utilizzata è la seguente:
EAD = DP + UP × UGD
A questo punto può essere utile soffermarsi su un aspetto non secondario connesso alla stima dell’esposizione al momento del default. Il fatto di
considerare anche la parte di affidamento non utilizzata, inevitabilmente
determina un incremento della perdita attesa, che, in teoria, per la nota relazione rischio/rendimento, dovrebbe portare a un aumento del pricing del
debito per l’impresa. In altre parole, il maggior rischio avvertito dal finanziatore determina un innalzamento dello spread applicato all’impresa per
remunerare la banca del maggior rischio sostenuto, che in questo caso è
implicito nella quota inutilizzata. Nella maggior parte dei casi, invece, tale
componente di rischio è coperta da una commissione, diffusa nei mercati
anglosassoni con il nome di commitment fee e conosciuta in Italia come
“commissione di massimo scoperto”21.
19
Vedi Sironi A. (2000b), “Un approccio multinomiale semplificato per le banche italiane”,
in P. Savona, A. Sironi (a cura di), La gestione del rischio di credito, esperienze e modelli
nelle grandi banche italiane, Edibank, Roma.
20
Cfr. Ong M. K. (1999), Internal Credit Risk Models: Capital Allocation and Performance
Measurement, Risk Books, London.
21
Con il termine “massimo scoperto” si indica il livello più alto raggiunto dal debito del
cliente nel rapporto tra la banca e il cliente stesso. Viene preso in considerazione per ogni
periodo temporale di determinazione degli interessi addebitati al cliente. Sul massimo scoperto la banca applica, appunto, una commissione percentuale che viene addebitata al cliente. Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006
ha dichiarato nulla la commissione di massimo scoperto.
56
La stima della probabilità d’insolvenza. Il secondo fattore della perdita attesa consiste nella probabilità di default del soggetto, la quale rappresenta la probabilità che si verifichi l’evento “insolvenza”. La determinazione di tale probabilità presuppone la stima di un modello statistico di previsione delle insolvenze. Attraverso tecniche matematico-statistiche (Altman
1968, 1977, 2000; Alberici 1975; Luerti 1992), diffusamente affrontate nei
paragrafi successivi, è possibile attribuire a ciascuna impresa affidata una
stima ex-ante delle probabilità d’insolvenza. Preliminare al calcolo della
PD è l’individuazione della fattispecie da considerare come proxy dell’insolvenza22. Dei vari concetti di default utilizzati nelle ricerche empiriche
sul rischio d’insolvenza e nella prassi operativa delle banche tratteremo nei
paragrafi successivi del presente capitolo.
Un ulteriore aspetto preordinato alla creazione del modello statistico è
quello della scelta dell’ampiezza dell’orizzonte temporale delle valutazioni,
ossia della valenza nel tempo delle previsioni sull’insolvenza. Da essa dipenderà il lag temporale per la raccolta del campione d’apprendimento23
alla base della stima del modello di previsione. Secondo alcuni autori (Masera-Maino 2002; Zazzara 2001), la proiezione temporale di riferimento
non deve essere di breve durata24 e comunque deve essere correlata alla durata della relazione di credito25. È ormai prassi consolidata, sia nei rating
delle agenzie specializzate sia nella pratica bancaria e accademica, determinare le probabilità d’insolvenza a un anno. Tale scadenza è coerente con
le procedure di affidamento bancario che, nella maggior parte dei casi, prevedono una revisione annuale degli affidamenti.
Le probabilità possono essere aggregate per classi di rischio al fine di
determinare un rating26. La banca dovrà innanzitutto definire le due classi
22
Si veda Aa. Vv. (2000a), “Modelli per la gestione del rischio di credito. I ratings interni”,
Tematiche istituzionali, Banca d’Italia, Roma.
23
Il campione d’apprendimento è la base di dati sul quale si procede a stimare il modello di
previsione dell’insolvenza.
24
Le valutazioni del rischio d’insolvenza delle controparti basate su brevi periodi possono
comportare una non idonea valutazione d’importanti condizioni che stanno alla base della
stima del puntuale adempimento delle obbligazioni finanziarie da parete della controparte
affidata.
25
Secondo Banca d’Italia le banche stimeranno la PD su un orizzonte temporale di un anno,
in proposito si veda Aa. Vv. (2000a), “Modelli per la gestione del rischio di credito. I ratings
interni”, Tematiche istituzionali, Banca d’Italia, Roma.
26
Per la costruzione di un modello di rating si veda Banca D’Italia, Tematiche Istituzionali
(2000); De Laurentis G. (1994), Il rischio di credito. I fidi bancari nel nuovo contesto teorico, normativo e di mercato, Egea, Milano; Id. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma.
57
che si collocano negli estremi della scala di valutazione: la classe di rating
“migliore”, nella quale inserire le imprese con il più elevato standing creditizio, e per le quali si stima un rischio di default (PD) molto contenuto, e la
classe di rating “peggiore”, nella quale inserire le imprese per le quali si verifica il default27. La banca dovrà quindi definire il numero delle classi da
istituire nella scala di rating e l’ampiezza di ciascuna di esse28. Tali scelte
non saranno oggetto di ampia trattazione in questo lavoro in quanto costituiscono problematiche di natura tipicamente bancaria, ma è comprensibile
come tali decisioni possano avere un impatto sulla valutazione dell’impresa
e in particolare sul suo costo del debito.
La determinazione dei tassi di perdita attesa in caso di insolvenza.
L’ultimo parametro da stimare per calcolare la perdita attesa è la loss given
default, ossia la perdita attesa in caso d’insolvenza.
Volendo esprimere tale parametro in termini di tasso percentuale, si può
utilizzare la seguente formula:
LGD = 1 − RR
dove:
• LGD = tasso di perdita attesa in caso d’insolvenza;
• RR (Recovery Rate) = il tasso di recupero del credito.
In sostanza, mentre la probabilità di default di un debitore dipende
dallo specifico merito creditizio e, quindi, dalla situazione economicofinanziaria attuale e prospettica dell’impresa, la loss given default riflette le
caratteristiche peculiari dell’operazione di finanziamento.
La componente LGD è funzione dei seguenti fattori29:
a. la tipologia di operazione di finanziamento utilizzata;
b. la presenza di garanzie collaterali alla posizione di affidamento;
c. il valore della base garante, rispetto all’esposizione debitoria del cliente;
d. l’attitudine delle suddette garanzie a trasformarsi in moneta e il profilo
temporale di monetizzazione della base garante;
e. i tempi e i costi del recupero.
Il tasso di recupero30 (recovery rate) dell’esposizione creditizia sarà
27
Qui l’insolvenza non è stimata ma anzi rilevata: si tratta di imprese per le quali in default
si è verificato.
28
A ogni classe di rating corrisponderà un intervallo di probability of default; la “robustezza” di un modello di rating dovrà essere testata ex-post rilevando le frequenze di default riscontrate in ciascuna classe e verificando se esse sono coerenti con l’intervallo delle
probabilità definito ex-ante.
29
Sul punto si veda De Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management:
l’evoluzione dei processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma.
58
determinato come il rapporto tra il valore netto recuperato e l’esposizione al
momento del default; in modo analitico il tasso di recupero può essere
espresso come:
dove:
• ValR = somme recuperate nei periodi da t = 1 a t = n;
• ValS = spese sostenute per il recupero nei periodi da t = 1 a t = n;
• EAD = esposizione al momento del default;
• i = tasso di attualizzazione.
Concretamente si tratterà di stimare il valore delle somme recuperate, il
valore delle spese sostenute per il recupero e la loro distribuzione temporale: tali fattori dipendono dal valore della “base garante” e dall’attitudine di
essa a trasformarsi in moneta.
Essendo tali valori distribuiti nel tempo, questi dovranno essere “attualizzati” a un tasso i31 in quanto la banca sta stimando in data odierna la perdita attesa dall’esposizione.
La LGD dipende dal tasso di recupero e quindi dalla tipologia e dal
valore della “base garante”, dalla tipologia e dalla forma tecnica dell’operazione32.
Alla luce di ciò, una riduzione della loss given default a livello generale
sarebbe ottenibile attraverso la riduzione dei tempi di escussione per il recupero dei crediti in default33, ma questo è argomento a cui si dedicano con
profitto gli studiosi di diritto fallimentare.
A questo punto della trattazione è opportuno concentrare l’attenzione
sulle modalità di stima dei tassi di recupero.
30
Si vedano De Laurentis G. (1994), Il rischio di credito. I fidi bancari nel nuovo contesto
teorico, normativo e di mercato, Egea, Milano; Id. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma; Sironi A., Marsella M. (a cura di) (1998), La misurazione e la gestione del rischio di credito: modelli,
strumenti e politiche, Bancaria, Roma; De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating,
FrancoAngeli, Milano.
31
Il tasso d’attualizzazione dovrà essere espressivo del costo marginale del funding per la
banca e viene di solito stimato tramite il ricorso a un tasso interbancario.
32
Si capisce che ci sono particolari contratti di finanziamento in cui la banca può facilmente
escutere la garanzia e altri in cui il recupero richiede il sostenimento di notevoli spese e
tempi prolungati.
33
In merito ai costi e ai tempi delle azioni di recupero si veda Generale A., Gobbi G. (1996),
“Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche”, Temi di discussione
della Banca d’Italia, marzo.
59
Una via praticabile è quella della stima interna da parte della banca.
Essa viene realizzata sulla base dell’esperienza storica del proprio portafoglio impieghi. In questo caso si procede a segmentare il portafoglioimpieghi per categoria di affidati, per tipologia di esposizione e garanzie
rilasciate, al fine di stimare i tassi medi storici di recupero.
In questo processo di stima la banca deve intendere il tasso di recupero
in senso finanziario e non puramente contabile, stimando, di fatto, il valore
attuale dei flussi di risorse rinvenute dalle diverse fasi del processo di recupero fino al termine del contenzioso. Inoltre si dovrà tener conto di alcune
variabili come:
a. la percentuale di credito che si prevede possa essere recuperata, in
funzione sia della forma del finanziamento sia della garanzia rilasciata (ER);
b. i costi di natura amministrativa che la banca deve sostenere sia esterni,
come quelli legali, sia interni, per il personale addetto al recupero e per
le eventuali strutture dedicate al processo di recupero (AC);
c. il tempo di recupero, che deriva dalla procedura di esecuzione intrapresa (t);
d. il tasso a cui scontare i flussi di recupero attesi, generalmente assimilato al tasso interbancario (i).
9.3. La relazione tra perdita attesa e costo del debito: il pricing del
prestito
La classificazione delle imprese in classi di rating, cui siano associabili
rispettivi valori circa la perdita attesa, permette di calcolare una prima specificazione del risk adjusted pricing34. Tale processo consente di impostare
le politiche di differenziazione di tasso d’interesse dei prestiti in base al rischio di credito35 a essi correlato.
Ponendo uguali il montante di due investimenti di valore unitario, il
primo del tipo risk free, il secondo, con un tasso di interesse pari a ip sol34
In merito alle metodologie di fissazione del tasso d’interesse dei finanziamenti si veda De
Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei processi
d’affidamento bancari, Bancaria, Roma; De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating,
FrancoAngeli, Milano; e, in particolare, Corigliano R. (a cura di) (1998), Rischio di credito e
pricing dei prestiti bancari: nuove metodologie di analisi e conseguenze organizzative per le
banche italiane, Bancaria, Roma.
35
Si tratta d’indicatori che non richiedono le specificazioni di modelli value at risk o la
quantificazione dell’effetto di portafoglio attraverso la stima delle correlazioni tra debitori:
con tale impostazione si giunge a un pricing che è funzione soltanto della perdita attesa.
60
tanto sulla quota di capitale prestato che non genera perdite, si perviene alla
seguente uguaglianza:
(1 – ELR) × (1 + ip) = 1 + irf
dove:
• ELR = tasso di perdita attesa (expected loss rate);
• irf = tasso d’interesse risk free.
Questo semplice modello di pricing è costruito tenendo conto del fatto
che la banca può ottenere il tasso richiesto esclusivamente sulla quota del
prestito che non genera perdite.
Esplicitando la precedente equazione per il tasso d’interesse da applicarsi al prestito avremo:
irf + ELR
ip =
1 − ELR
ip =
irf + PD ⋅ LGD
1 − PD ⋅ LGD
Questa ultima formula stima il prezzo del prestito per livelli superiori
alla somma del tasso risk free e della perdita attesa (il denominatore è minore di 1), in ragione del fatto che tale tasso può essere ottenuto solo sulla
quota del prestito che non genera perdita36, vale a dire (1 – ELR).
Dalla medesima equazione si ricava che il tasso d’interesse a cui le imprese saranno assoggettate per ottenere credito tende a crescere in funzione
delle perdite attese, ossia in funzione della PD e della LGD. Questa relazione tra pricing e perdita attesa può essere evidenziata dall’analisi dello
spread richiesto rispetto a un investimento risk free:
i p − irf =
PD ⋅ LGD ⋅ (1 + irf )
1 − PD ⋅ LGD
La formula sopra illustrata evidenzia come il primo per il rischio pagato dall’impresa dipenda dalla probabilità di default dell’impresa stessa.
Quest’ultima, a sua volta, dipende dalla situazione economico-finanziaria
attuale e prospettica e dalla loss given default. Quindi, tanto minore sarà la
36
Si veda De Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei
processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma; De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating, FrancoAngeli, Milano; Corigliano R. (a cura di) (1998), Rischio di credito e pricing dei prestiti bancari: nuove metodologie di analisi e conseguenze organizzative per le
banche italiane, Bancaria, Roma; Sironi A., Marsella M. (a cura di) (1998), La misurazione
e la gestione del rischio di credito: modelli, strumenti e politiche, Bancaria, Roma.
61
LGD, tanto più limitato sarà il premio per il rischio che l’impresa dovrà pagare alla banca.
Volendo completare la relazione di pricing fin qui trattata, è necessario
rimuovere l’ipotesi d’uguaglianza con il tasso risk free e considerare anche
la componente di premio per il rischio atteso per l’operazione, ossia la remunerazione attesa dagli azionisti37. In questo caso la relazione:
(1 – ELR) × (1 + ip) = 1 + irf
assume la seguente configurazione38:
1 + irf + ik = (1 – PD) × (1 + ip) + PD × (1 – LGD) × (1 + ip).
37
È evidente che l’investitore azionista della banca si assume il rischio d’impresa e deve
quindi essere remunerato con un adeguato premio per il rischio. Ciò impone quindi di considerare, nella procedura di pricing dei prestiti, anche la remunerazione attesa dagli azionisti.
38
Si veda Alberici A., Caselli S. (2003), La valutazione dell’impresa per i fidi bancari,
FrancoAngeli, Milano, pp. 33 e ss.
62
2. IL CORPORATE RISK MANAGEMENT.
ANALISI DEL RISCHIO, IL CAPITALE
DI DOTAZIONE E I SOGGETTI PRENDITORI
di Oliviero Roggi
1. Evoluzione degli studi sul risk management e il trattamento
dei rischi puri
Da alcuni decenni il risk management (RM) è al centro di un numero
crescente di studi e analisi volte a comprendere e ridurre gli effetti del rischio
sull’impresa. L’oggetto della disciplina, al pari degli strumenti, si è evoluto
nel tempo e ha abbracciato sempre nuovi gruppi di rischi. Il risk management
si è arricchito di una prospettiva interdisciplinare alla quale hanno contribuito
esperti di banking, di corporate finance, statistici d’impresa e matematici attuariali. Nella sua accezione generale tuttavia, esso identifica quella branca
delle scienze sociali che studia prevalentemente il manifestarsi dei rischi puri
e/o speculativi che siano. Sebbene il RM li tratti entrambi, è possibile affermare che, nell’evolversi degli studi, i due tipi di rischio sopra definiti abbiano
trovato diversa attenzione da parte degli studiosi.
Inizialmente, gli studiosi hanno dedicato le proprie energie ad approfondire natura e manifestarsi dei rischi puri e, con l’ausilio degli strumenti
delle scienze attuariali, hanno risposto alle esigenze di copertura degli stessi. Rientrano in questo filone di studi i lavori di Dennenberg e Ferrari
(1966); Blinn e Brown (1982); Willet (1951); Williams ed Heins (1964).
Essi sistematizzano le conoscenze relative alla natura e probabilità di accadimento di eventi negativi per l’impresa e si stabiliscono i processi per
l’analisi e copertura dei rischi puri.
Nei medesimi anni e con la specializzazione delle scienze economiche in quelle manageriali, il risk management ha trovato anche una propria collocazione nel filone di studi sulla finanza e in particolare in
quello del financial management, prendendo il nome di corporate risk
management (CRM) o enterprise risk management (ERM1). Le disci1
Nel proseguo della trattazione utilizzero le due definizioni come sinonimi.
63
pline aziendali e in particolare la teoria neoclassica della Finanza
(Fisher 1930; Markowitz 1952; Modigliani e Miller 1958 e 1963; Fama
1970; Fama e French 1984; Jensen 1986; Miller 1977; Myers 1984),
hanno sviluppato numerosi modelli teorici e strumenti operativi per
comprendere, stimare e poi ridurre i rischi d’impresa (Floreani 2005;
Dickinson 2001, p. 360). Dalla seconda metà degli anni Novanta, tali
sforzi sistematizzatori hanno fatto nascere il filone di studi in oggetto
dando rilevanza alla pianificazione dei rischi d’impresa, pratica fino a
quel momento trascurata. In tale consesso le relazioni tra rischio e valore dell’impresa sono assunte come principali e i manager si sono organizzati per affiancare al classico obiettivo di massimizzazione del valore
dell’impresa, quello peculiare, e oggi molto ricercato, di minimizzazione del rischio. Secondo Nocco e Shulz (2006) l’ERM, riconoscendo
l’imperfezione dei mercati, la non perfetta diversificazione del portafoglio degli investimenti e altre imperfezioni che allontanano l’investimento in impresa dal mondo disegnato dalla finanza neoclassica, permette all’impresa di creare valore riducendo i rischi. Il benefico effetto,
affermano gli autori, si manifesta sia a livello macro – il più discusso in
letteratura – sia e soprattutto a livello micro. È infatti a livello micro che
l’ERM deve divenire a tutti i livelli gerarchici un diverso modo di pensare i processi d’impresa. In sostanza un approccio proattivo al rischio
da parte anche di middle manager e impiegati.
Nell’ERM si analizzano i rischi connessi alla natura delle decisioni
economico-finanziarie d’impresa. Tali decisioni infatti sono assunte in condizioni di incertezza. In particolare l’imprenditore è chiamato, nelle decisioni di investimento, a sostenere i rischi a causa dell’asincronia che esiste
tra i flussi di cassa negativi generati dall’acquisizione dei fattori della produzione (Capex e working capital) e quelli positivi relativi alla cessione dei
prodotti sul mercato a individui non organizzati. Per la natura stessa delle
decisioni oggetto del ERM, quindi, è possibile affermare che le attività di
gestione e riduzione del rischio d’impresa risultano essere compatibili con
la teoria d’impresa che vede nella massimizzazione del valore dell’impresa
la funzione obiettivo. Come abbiamo già accennato nel capitolo precedente,
ragionando in termini di decisioni finanziarie rischiose, è possibile misurare
l’impatto sul valore d’impresa generato dalla gestione attiva dei rischi
aziendali e quindi l’incremento di valore susseguente all’applicazione dei
processi di risk assessment. Tale maggior valore è stato definito, da chi
scrive, “beneficio della copertura” e assume valore diverso da zero nel caso
di specie nel quale il mercato è perfetto e il rischio transita dal’impresa verso i propri finanziatori senza modificarsi.
64
2. Il risk management e le aree tipiche di intervento
Il Corporate Risk Management (CRM) può essere definito come un’“attività strategica di supporto al processo di direzione d’impresa volta a creare
valore aziendale a favore dei portatori del capitale di rischio attraverso un
processo integrato d’identificazione, stima, valutazione, trattamento e controllo dei tutti i rischi aziendali” (Floreani 2005:55). Dalla definizione di Floreani emerge come il CRM sia un processo a carattere normativo compatibile
con il principio guida della finanza neoclassica e coerente con le recenti impostazioni di misurazione dei risultati d’impresa. In particolare, oggetto di
tale processo, sono tutti i rischi d’impresa, rischi che abbiamo già visto nel
par. 2 del Capitolo 1. e che si sono concretizzati in business e/o leverage risk.
2.1. Il risk management nell’accezione tradizionale (Traditional Risk
Management)
Il Traditional Risk Management (Forestieri 1996; Cacciamani 2004) è
conosciuto in letteratura come il primo gruppo di tecniche utilizzate nel campo della previsione e trattamento dei rischi. Esso ha l’obiettivo generale di
trattare i rischi puri che possono sorgere durante la vita di un’impresa. Viene
naturale pensare al TRM come a un sottoinsieme del più vasto ERM in
quanto, quest’ultimo, cerca di identificare, misurare e trattare anche rischi
speculativi. Negli studi ricompresi in questo filone si è data enfasi soprattutto
agli strumenti e tecniche di copertura dei rischi puri. Assumono, infatti, rilevanza le tematiche della prevenzione, protezione e copertura da rischi attraverso il trasferimento a soggetti terzi (polizze assicurative e altri strumenti di
risk transferring). In questo approccio si vuole quindi contribuire alla creazione di valore, principio guida della finanza aziendale, attraverso la minimizzazione dei downside risk. In particolare sono rilevanti gli aspetti teorici e
di processo conosciuti come crisis management (Coombs 1999; Seeger e
Sellnow 2007) e il business continuity management. Rispetto al ERM l’approccio alle singole fonti di rischio è non organico e non sono accentuati gli
elementi di programmazione integrata di rischi sostenibili.
2.2. Il Project Risk Management
Le tecniche di valutazione del rischio sono utilizzate frequentemente
nella valutazione di grandi progetti a prescindere dalla forma giuridica
65
con la quale questi sono realizzati. Il project risk management (PRM) è,
dunque, il processo con il quale si identificano, analizzano e trattano i rischi legati a grandi opere pubbliche o private (Pennock e Haimes 2002;
Williams 1995; Bing e Tiong 1999). Date le caratteristiche sopra esposte,
tale filone di studi e applicazioni ha un raggio di azione più limitato rispetto all’ERM e viene utilmente impiegato nell’industria delle costruzioni, grandi opere pubbliche o nell’industria meccanica avanzata (Aeronautica, Spaziale, ma anche Navale). Poiché l’obiettivo del progetto è realizzare e gestire l’opera analizzata, il PRM ha come finalità quella di limitare i downside risk generati nell’esecuzione del progetto. Trattandosi di
grandi opere, spesso molto complesse nella loro realizzazione, le fonti di
rischio sono prevalentemente di business: il rischio di interruzione servizio per eventi atmosferici, il rischio geologico e in generale ogni rischio
operativo nella realizzazione. Il manifestarsi dei rischi sopra ricordati e di
quelli tipici di un progetto complesso hanno come effetto quello di rivedere al ribasso le stime sui flussi di cassa attesi positivi. Non è escluso poi
che il progetto possa soffrire anche di rischi finanziari, dovuti anche all’effetto di alcuni rischi di mercato. In particolare ricordiamo il rischio di
liquidità derivante, per esempio, da un ritardo nei pagamenti dello stato di
avanzamento lavori; o quello di tasso di interesse o di cambio nel caso di
flussi in valuta.
2.3. Il Financial Risk Management
Il Financial Risk Management (FRM) (Floreani 2000; Lusignani 1996)
è orientato ad analizzare in modo specifico i rischi finanziari a cui
l’impresa è sottoposta. Tale approccio al RM ha riscosso sempre maggiori
consensi anche tra le imprese industriali a seguito dell’introduzione in
azienda dei prodotti derivati principalmente su tassi e cambi. A dimostrazione di ciò Conti (2006), nell’adattare il concetto alle imprese non finanziarie, tratta del Corporate Financial Risk Management intendendo: “la disciplina che per oggetto la gestione dei rischi finanziari di prezzo (tasso di
interesse, cambio, prezzo delle commodities ecc.) nelle imprese non finanziarie” (Conti 2006, p. 1). Grazie alla grande varietà di nuovi strumenti introdotti proprio sul mercato dei derivati, il FRM si può avvalere di prodotti
sempre più potenti per mitigare i rischi che dipendono da variabili di mercato legate alle scelte di investimento e di struttura finanziaria. Al pari del
TRM è focalizzato solo su alcuni rischi d’impresa e quindi si presenta come
un sottoinsieme delle tecniche previste nell’ERM.
66
3. Il processo di risk management
Nella definizione dell’AIRMIC2 (2002, p. 2) il risk management è definito come “il processo attraverso il quale gli istituti si occupano dei rischi
associati alle attività svolte con l’obiettivo di ottenere dei benefici riguardanti le singole attività e/o l’insieme delle stesse”.
Le fasi di cui si compone non trovano la dottrina concorde. Il processo
certificato da AIRMIC prevede che l’analisi sia svolta in quattro fasi sequenziali:
• definizioni degli obiettivi di risk management e dell’impresa;
• risk assessment;
• risk treatment;
• risk monitoring.
Alcune delle precedenti fasi si articolano poi in sottofasi. Delle fasi
principali, poi, alcune hanno prevalenza di contenuti normativi manageriali,
mentre altre sono prevalentemente tecniche. In particolare sono manageriali, la scelta degli obiettivi di RM, di quelli strategici dell’impresa e la fase
di risk treatment, che presuppone la definizione di criteri decisionali per il
trattamento del rischio e quindi si configura come attività tipica del governo
dell’impresa. Le altre fasi del processo sono invece prevalentemente tecniche e comprendono il risk assessment, il risk reporting e il monitoring.
Figura 1 – Il processo di Risk Management
Fonte: nostra elaborazione
2
Association of Insurance and Risk Managers. www.airmic.com.
67
In generale il processo di risk management (Shimpi 2001, p. 59) deve
aiutare l’impresa a:
1. definire i rischi sostenibili dall’impresa nel suo complesso;
2. sviluppare un catalogo di rischi potenziali;
3. permettere all’impresa di includere in un modello finanziario dinamico
gli effetti dei principali rischi identificati, trasferiti o ritenuti che essi
siano.
Veniamo adesso a descrivere le principali fasi del processo di risk management partendo dalla prima.
3.1. L’identificazione degli obiettivi di risk management e d’impresa
Questa fase, che come abbiamo ricordato è prevalentemente di carattere
manageriale, prende le mosse dalla scelta dell’atteggiamento che l’impresa
deve tenere di fronte alle varie forme di rischio potenziali. Nella stessa, oltre a scegliere l’atteggiamento e quindi gli obiettivi da perseguire in materia
di rischio, si pianificano le risorse disponibili per il risk management e i
criteri generali per il trattamento dei rischi. Per questo motivo il management è chiamato a definire nell’ordine: gli obiettivi strategici, prima, quelli
operativi, poi, e infine a organizzare la loro realizzazione in piani di azione
coerenti con lo shareholder approach.
In questa fase, che è svolta nel rispetto del principio guida di massimizzazione del valore per gli shareholder, l’impresa si scopre più o meno disponibile al risk taking e definisce la strategia d’impresa più compatibile
con il grado di avversione al rischio che, come ricorda Keynes (Keynes,
1936), è una caratteristica intrinseca, quasi genetica, dei soggetti decisori e
quindi anche dell’impresa nei quali i managers lavorano3.
In questo contesto, quindi, ogni decisione di RM dovrà realizzarsi
avendo prima risposto alla seguente domanda: “quale impatto ha l’azione di
copertura o ritenzione sul valore dell’impresa per i suoi azionisti?”. Solo in
questo modo il RM e in particolare il CRM si pone come leva strategica
utilizzabile dal management nella creazione di valore d’impresa.
3
Afferma infatti Keynes, nel celeberrimo The General Theory of Employment, Interest and
Money: “Even apart from the instability due to speculation, there is the instability due to the
characteristic of human nature that a large proportion of our positive activities depend on
spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether moral or hedonistic or
economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the full consequences of
which will be drawn out over many days to come, can only be taken as the result of animal
spirits – a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted
average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities” (1930, pp. 161-162).
68
3.2. Il risk assessment
La seconda fase di natura prevalentemente tecnica è a sua volta suddivisa in alcune sottofasi:
a. identificazione/descrizione;
b. stima;
c. valutazione dei rischi.
Nell’identificazione dei rischi l’impresa i soggetti delegati al processo
di RM dovranno identificare le fonti dalle quali possono scaturire eventi
negativi capaci di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sopra
prefissati. I sinistri possono impattare sull’impresa nel suo complesso, su
alcuni suoi progetti o esclusivamente su alcune attività intraprese dalla medesima. Per questo motivo al fine di conoscere la variabilità sui risultati
economico-finanziari e la varianza della solidità patrimoniale dell’impresa,
è necessario scomporre l’attività dell’impresa o i suoi progetti in unità elementari all’interno delle quali andremo puoi a identificare le fonti di rischio. Per aiutarsi nell’identificazione, si può procedere classificando le
fonti in esterne/interne e individuando dove rischi puri e speculativi si possono verificare. Chiaramente l’enfasi sarà principalmente riposta sull’identificazione del downside risk, ovvero del solo rischio di perdita; ciò perché,
sebbene si tratti di un rischio come il precedente, l’upside risk ha effetti benefici sulla performance economico-finanziaria e/o sulla patrimonializzazione d’impresa. In ogni caso e per ogni fonte di rischio identificata sarebbe
necessario tentare di stimare, quantitativamente o almeno con tecniche semi-quantitative, il rischio sostenuto.
Nella prassi degli operatori non esiste un processo riconosciuto come il
più adeguato nell’opera di mappatura dei rischi, ma piuttosto si posso brevemente riportare le caratteristiche delle tecniche più note4. Dalle più semplici a quelle sempre più complesse possiamo ricordare:
a. la fault tree analysis (FTA);
b. la failure mode and effect analysis (FMEA) e la sua evoluzione;
c. la failure mode, effect and critical analysis (FMECA).
La prima tecnica prevede di identificare un evento indesiderato detto
“top-event” al quale collegare un albero logico. Questo albero è costruito
andando a collegare al top-event altri eventi detti lower-events servendosi
della logica boeleana. Generalmente il metodo è utilizzato nell’industria aerospaziale o aeronautica per prevedere la probabilità di un hazard, ma può
essere impiegato all’interno dell’impresa per analizzare il venire meno di
4
Per una analisi approfondita dei principali metodi di previsione cfr. Langford J. W. (1995),
Logistics: Principles and Applications, McGraw Hill, New York.
69
una fattore critico della produzione. Dettagliando l’albero e procedendo all’inverso dall’evento più basso al più alto è possibile stimare la probabilità
con la quale si verificherà ogni catena di eventi e ciò preclude alla stima
dell’effetto negativo sull’impresa.
La failure mode and effect analysis, introdotta negli anni Quaranta come tecnica per l’analisi del rischio di produzione dei razzi militari, è una
procedura per l’analisi del manifestarsi di un evento negativo (failure) caratterizzato dalla classificazione in termini di magnitudo (severity) dell’effetto del sinistro.
Figura 2 – Esempio di albero logico
Fonte: nostra elaborazione
Questo metodo è largamente utilizzato nel’impresa manifatturiera all’interno di varie fasi del ciclo di vita del prodotto. In questo caso i sinistri
sono in prevalenza gli errori, i difetti di processo, di progettazione e gli altri
sinistri che possono compromettere la funzionalità del prodotto per il consumatore o metterne addirittura a rischio l’incolumità. L’analisi si concentra
proprio sugli effetti di tali eventi. L’FMEA è stato introdotto per evitare sinistri quali il ritiro di un’autoveicolo per un evidente difetto di progettazione o per ridurre i rischi di produzione.
Una evoluzione del precedente metodo detta: failure mode, effect and
critical analysis (FMECA) è stata sviluppata al fine di integrare nel metodo
precedente anche una analisi di criticità (Critical Analysis) ed è utilizzata
per ottenere risultati paragonabili con il metodo precedente anche su campioni molti piccoli di manufatti.
70
Figura 3 – La descrizione del metodo FMEA
Fonte: Quality Associates International (2007)
Per completare il mapping dei rischi, una volta identificati gli eventi sinistri, è necessario descrivere i rischi a cui l’impresa è sottoposta. In questa secondo task della fase di identificazione saranno redatte le schede di rischio
nelle quali i singoli eventi verranno qualificati secondo le seguenti caratteristiche: nome, descrizione qualitativa del rischio, principali scenari
up/downside legati al rischio corredati della probabilità di verificarsi, una
sommaria valutazione degli effetti economici legati a ciascuno scenario; in
aggiunta, nella scheda, saranno citati i soggetti responsabili della gestione di
quel particolare rischio e l’indicazione delle misure per il suo monitoraggio.
L’analista di RM giunge all’identificazione dei rischi attraverso numerose tecniche di raccolta. Principalmente farà affidamento sulla storia passata dei sinistri e quindi assumerà tutte le informazioni su eventi negativi
occorsi all’interno dell’impresa come conseguenza delle operazioni di gestione. Come ogni analisi storica essa non permette di identificare i nuovi
rischi e neppure quelli che, sebbene presenti anche in passato, non hanno
avuto una manifestazione. L’operatore può anche servirsi di interviste e
brainstorming con soggetti chiave del processo di produzione e contabilizzazione delle attività per ottenere, attraverso un questionario strutturato,
una mappa concreta dei possibili eventi negativi. Normalmente gli operatori si servono di vere e proprie prompt lists nelle quali i rischi sono classificati secondo categorie omogenee. I contenuti di tali liste sono generalmente
sviluppati nel corso dell’analisi di imprese simili precedentemente oggetto
di indagine da parte dell’operatore.
71
3.3. La stima dei rischi (Risk estimation)
Una volta conosciuta la mappa, l’impresa deve dotarsi di un insieme di
misure capaci di quantificare la probabilità dell’evento e quindi anche il suo
impatto sui flussi di cassa, stimando le perdite inattese e/o gli excess of returns. I metodi di stima sono divisi in tre principali gruppo in ragione del
della natura della stima:
a. stime qualitative;
b. stime semi-quantitative;
c. stime puramente quantitative.
Le prime, quelle qualitative, si differenziano dalle altre in quanto il
risultato, in termini di probabilità di un evento, è espresso da una scala
qualitativa capace di illustrare l’intensità della relazione. Le seconde,
quelle semi-quantitative, sono preferite alle prime e soprattutto alle stime quantitative quando vi è necessità di giungere a un indicatore sintetico di tipo numerico (scoring), ma non è necessario quantificare distribuzione di probabilità di un sinistro. Le stime quantitative, quali la simulazione Monte Carlo, pervengono alla stima della distribuzione di
probabilità dei risultati di una variabile aleatoria generatrice di rischio.
Vediamo le differenze nel dettaglio.
La stima qualitativa dei rischi (puri). Come ricordato in precedenza,
le tecniche qualitative si servono di parole o scale descrittive per illustrare
gli effetti economici e le probabilità di realizzazione di un evento aleatorio.
Anche se esistono vari metodi da impiegare nella stima qualitativa dei
rischi puri, la tecnica più diffusa è rappresentata dalla matrice ProbabilitàImpatto, nota anche sotto il nome di “matrice P-I”. Essa richiede per la sua
costruzione, la definizione di:
• una scala qualitativa che indichi la probabilità relativa al verificarsi di
un determinato evento. Generalmente si hanno cinque classi di impatto
(insignificante-basso-moderato-elevato-catastrofico);
• una scala qualitativa rappresentativa degli impatti, ovvero delle possibili conseguenze economiche derivanti dalla realizzazione dell’evento.
Anche in questo caso generalmente si hanno cinque classi di probabilità
(quasi certo-probabile-moderata-improbabile-rara);
• una scala qualitativa che assegna a ogni combinazione di elementi
(probabilità-impatto) un giudizio di valutazione detto risk rating. Questa può assumere quattro diversi valori (estremo-alto-modesto-basso);
• opportuni criteri di valutazione di risk rating.
Graficamente la matrice può essere rappresentata come nella fig. 4.
72
Figura 4 – La struttura della matrice Probabilità-Impatto
Probabilità
Impatto
Insignificante
Basso
Moderato
Elevato
Catastrofico
Quasi certo
(>50%)
Alto
Alto
Estremo
Estremo
Estremo
Probabile
(20%-50%)
Moderato
Alto
Alto
Estremo
Estremo
Moderata
(5%-20%)
Basso
Moderato
Alto
Estremo
Estremo
Improbabile
(1%-5%)
Basso
Basso
Moderato
Alto
Estremo
Rara
(<1%)
Basso
Basso
Moderato
Alto
Alto
Legenda. Basso: gestione dell’evento rischioso mediante procedure di routine. Moderato: richiede di
individuare un soggetto responsabile della sua gestione e del suo monitoraggio. Alto: attenta valutazione
del rischio da parte del responsabile posto al livello gerarchico più elevato. Estremo: richiede un livello
di attenzione massimo, nonché un intervento immediato per il trattamento del rischio.
Vale la pena sottolineare come le scale e i criteri di risk rating dipendano da scelte soggettive, e quindi le scelte siano riconducibili al buon senso
del corporate risk officer. Per realizzare una stima qualitativa, il risk manager può utilizzare sessioni di brainstorming, effettuare interviste, oppure
può decidere di far redigere la matrice P-I direttamente al responsabile che
si occupa della gestione di quel particolare rischio.
Una volta definito lo schema generale, si può procedere all’effettivo
collocamento dei rischi nella matrice P-I. Tale operazione risulta essere
particolarmente delicata, in quanto dalla collocazione del rischio all’interno
della matrice dipende la sua valutazione, e quindi il suo trattamento. Conseguentemente, si dovrà usare particolare cautela nel classificare un rischio,
evitando di definirlo rilevante quando invece non lo è, o non rilevante
quando invece risulta tale. Per quanto riguarda i principali pro e contro
della matrice P-I, è possibile affermare che, se da un lato essa è molto semplice da redigere e da utilizzare, dall’altro essa costituisce solo un primo
screening dei rischi puri, e non può essere impiegata nel caso di rischi speculativi. Inoltre, un ulteriore limite all’utilizzo delle stime qualitative è
quello per il quale accade di attribuire una stessa valutazione a variabili
aleatorie che hanno lo stesso valore atteso, ma rischi differenziati. Ciò dipende dal fatto che la tecnica Probabilità-Impatto tende a sintetizzare una
variabile causale attraverso un unico parametro, peraltro neanche oggettivo,
quale è appunto il risk rating.
73
La stima semi-quantitativa dei rischi (puri). La stima semi-quantitativa5 si configura come quella tecnica nella quale una serie di giudizi
qualitativi vengono trasformati in variabili quantitative attraverso l’utilizzo
di sistemi di punteggio o funzioni e tecniche matematiche di scalatura al
fine di giungere a un giudizio sintetico di rischio. In questo metodo l’operatore si limita a ordinare i rischi attraverso l’attribuzione di punteggi (Scores) che misurano l’intensità del rischio. Ciò è possibile applicando alla
scala qualitativa un punteggio o una funzione matematica. Tale tecnica è
nota sotto il nome di risk score, e viene applicata alla “matrice P-I” dando
luogo a uno schema logico come quello sottostante. Si tratta in sostanza di
costruire un indice di severità di un rischio e poi applicarlo alla rilevazione
esterna al campione che ha contribuito alla determinazione della scala.
Figura 5 – Esemplificazione della tecnica del Risk Score
Probabilità
Score
Quasi certo
100
Probabile
50
Moderata
25
Improbabile
5
Rara
1
×
Impatto
Score
Catastrofico
1.000
Elevato
Alto
Moderato
Basso
> 5.000
5.000____ 500
500_____ 50
< 50
200
Moderato
50
Basso
10
Insignificante
Risk Score
Estremo
1
Fonte: nostra elaborazione
Tutte le tecniche di risk scoring, tra le quali il celeberrimo modello
di Altman (1968), sono basate su questo metodo e possono essere utili
5
Per una analisi approfondita delle tecniche di stima semi-quantitative cfr.: Misani N. (1999),
Il risk management fra assicurazione e finanza. Nuove tecniche di gestione dei rischi puri:
catastrophe bonds, derivati assicurativi, capitale contingente, risk fusion, Egea, Milano; Floreani A. (2004), La valutazione dei rischi e le decisioni di risk management, ISU Università
Cattolica, Milano; Vose D. (2000), Risk Analysis. A Quantitative Guide, Wiley, Chichester;
Corvino G. (1996), “Il processo di identificazione del rischio: descrizione del profilo di rischio
e metodologie di ricerca delle informazioni”, in Forestieri G. (a cura di), Risk management.
Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Egea, Milano.
74
nel caso in cui la valutazione dei rischi debba essere realizzata tenendo
conto di più variabili obiettivo e nel caso di valutazioni comparative di
fonti multiple di aleatorietà (Floreani 2005). Le tecniche semiquantitative tentano di mitigare uno dei principali limiti della tecnica qualitativa, vale a dire, l’impossibilità di effettuare un’analisi di convenienza
economica.
Tra i limiti attribuiti da Floreani (2005, pp. 90 e ss.) a questa famiglia di
metodi, il principale è quello di non permettere la scelta tra investimenti
relativi sulla base dello scoring ottenuto e anche l’ulteriore limite di non
essere adeguate alla valutazione degli upside risks, essendo invece capaci di
stimare appieno i rischi puri. Ulteriore fattore negativo è rappresentato dal
limitare l’analisi del rischio a un unico indice di severità. Ciò comporta una
notevole perdita di informazione in quanto tutte le informazioni disponibili
debbo essere sintetizzate in un solo numero.
La tecnica del Risk Score, applicata alla matrice Probabilità-Impatto,
rappresenta soltanto una delle tecniche, peraltro tra le più elementari, applicabili. Una possibile variante, infatti, potrebbe essere quella di applicare
alla scala qualitativa, che se vogliamo rappresenta il nostro ideale punto di
partenza, una funzione matematica, avente come dominio le categorie della
scala (Carroll 1984). Questo significa che l’esperto dovrà definire innanzitutto la scala su cui sarà effettuata la valutazione, e, successivamente, dovrà, per ciascuna di esse, valutare la frequenza. Ciò può avvenire mediante
la costruzione esemplificata in tab. 1.
Tabella 1 – La scala di giudizio
Giudizio
Punteggio
Inverosimile
1,0-1,5
Improbabile
1,5-2,5
Possibile
2,5-3,5
Probabile
3,5-4,5
Certo
4,5-5
Fonte: Carrol (1984)
Il valore di punteggio viene poi trasformato in valore di probabilità
mediante la seguente funzione.
75
Esistono anche altri approcci semiquantitativi che tendono a comprimere, se non a eliminare del tutto, la fase relativa all’espressione del giudizio
qualitativo, a favore di una formulazione diretta del punteggio. Una valida e
puntuale dimostrazione di quanto appena affermato giunge dalla Metodologia Fink (Fink 1984). Tale tecnica ha come principale obiettivo quello di
stimare le circostanze in cui eventi gravi mettono alla prova i comportamenti consolidati dell’azienda e i suoi rapporti esterni con i vari stakeholder. L’approccio teorizzato da Fink si basa su alcune domande chiave che si
identificano in:
• Qual è la massima intensità che la crisi può raggiungere?
• Qual è il grado di attenzione medio rivolto alla crisi?
• In che misura la crisi può interferire con le normali operazioni?
• In che misura la crisi può danneggiare l’immagine aziendale?
• Fino a che punto può essere messa alla prova la resistenza finanziaria
dell’azienda?
A ogni quesito sarà necessario rispondere con un punteggio compreso tra 0 e 10. Effettuando poi la somma di tali valori ottenuti in ciascuna
riga, si ottiene come risultato un numero compreso tra 0 e 50, che
esprime in maniera sintetica, il livello di gravità delle possibili conseguenze della crisi.
Comunque sia, a prescindere da quale sia la tecnica impiegata, si deve
sottolineare come l’approccio semi-quantitativo rappresenti un miglioramento rispetto alla semplice stima qualitativa. Naturalmente, la valutazione
semi-quantitativa si caratterizza per una serie di limiti piuttosto rilevanti tra
cui vale la pena di ricordare:
• che si tratta di un approccio utile a valutare i rischi puri, ma non lo è
altrettanto nel caso dei rischi speculativi;
• che esso effettua una semplificazione eccessiva per mezzo di un unico
indicatore di gravità dell’evento;
• che il risultato è frutto di una analisi approssimativa, in cui si registra
una notevole perdita di informazioni.
Concludendo, è utile ricordare come negli ultimi anni sia stata identificata una modalità di utilizzazione alternativa/supplementare per le tecniche
qualitative e semiquantitative.
Infatti queste possono essere impiegate come strumento divulgativo,
soprattutto quando ci si rivolge a soggetti che non possiedono competenze
adeguate nell’area di risk management tali da comprendere appieno i risultati di una analisi quantitativa. Inoltre, tale schematizzazione, consente di
non diffondere all’esterno informazioni che potrebbero rivelarsi utili per la
concorrenza.
76
La stima quantitativa dei rischi (puri). Le metodologie quantitative6
si pongono come principale obiettivo quello di stimare la distribuzione
delle variabili casuali aleatorie rappresentative dei rischi aziendali.
Esistono due rappresentazioni simili dell’effetto del rischio sull’impresa:
• la distribuzione dei risultati possibili, che indica l’impatto di un singolo rischio sul risultato economico aziendale, assumendo come assioma la neutralità degli altri rischi aziendali;
• la distribuzione delle perdite possibili, che indica la variazione negativa che il rischio può determinare sulla variabile obiettivo aziendale,
vale a dire sulla massimizzazione del profitto. In questa seconda distribuzione in particolare si prende in esame il downside risk.
Come già abbiamo avuto modo di accennare precedentemente, il processo di stima quantitativa consiste nella determinazione dei possibili risultati di
un evento. Ciò avviene attraverso l’esecuzione di una serie di fasi nelle quali
vengono: dapprima fissati gli obiettivi dell’indagine, poi, scelte le variabili
aleatorie da misurare e infine selezionata la metodologia statistica con la
quale realizzare la stima quantitativa del rischio sostenuto dall’impresa. In
tab. 2 riportiamo una sintesi degli aspetti salienti di ciascuna fase.
Quanto descritto in tab. 2 rappresenta un iter dei passaggi logici da seguire, dal momento che le metodologie quantitative che possono essere impiegate sono numerose e assai eterogenee.
Tabella 2 – Le fasi del processo di stima quantitativa
Formulazione
del modello
Rappresenta un primo di step di fondamentale importanza. In questa
prima fase è necessario riuscire a conciliare esigenze di semplicità e
focalizzazione dell’analisi, e quelle di realisticità e completezza. Per
fare ciò lo specialista può attingere a una serie di modelli esistenti e
collaudati. Inoltre l’analisi risulta essere semplificata dalla natura
monetaria delle variabili coinvolte.
6
Per una analisi approfondita sul tema della stima quantitativa cfr. Misani N. (1995), Introduzione al risk management, Egea, Milano; Floreani A. (2005), Introduzione al risk management: un approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, Etas, Milano; Vose D.
(2000), Risk Analysis. A Quantitative Guide, Wiley, Chichester; Corvino G. (1996), “Il processo di identificazione del rischio: descrizione del profilo di rischio e metodologie di ricerca delle informazioni”, in Forestieri G. (a cura di), Risk management. Strumenti e politiche
per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Egea, Milano; Klugman S., Panjer H., Willmot
G. (1998), Loss Models: From data to Decisions, Wiley, Hoboken; Allen S. (2003), Financial Risk Management: A Practitioner’s Guide to Managing Market and Credit Risk, Wiley,
Hoboken; Green M. R., Serbein O. N (1983), Risk Management: Text and Cases, Reston
Publishing, Reston.
77
Determinazione
delle caratteristiche
delle variabili
aleatorie e dei
principali parametri
del modello
La determinazione delle caratteristiche delle variabili aleatorie avviene mediante l’individuazione di:
• ipotesi o assiomi su cui si fonda il modello. Al fine di ottenere
un’analisi più rigorosa, è necessario basarsi su indicazioni teoriche
che forniscano un’approssimazione della realtà;
• serie storiche e altre informazioni. Attraverso un’accurata analisi
delle informazioni si può arrivare ad avere una migliore conoscenza, e una migliore stima, di quelli che sono i parametri rilevanti
del modello;
• valutazioni soggettive effettuate a opera di soggetti esperti. Si
tratta di una valutazione che può essere impiegata con successo
nelle stime qualitative e semiquantitative durante la fase di identificazione dei principali fattori di rischio; mentre risulta quasi inutilizzabile nel caso di stime quantitative. Ciò perché vi sono difficoltà nella trasformazione di una valutazione qualitativa in una
quantitativa.
Determinazione
della distribuzione
dei possibili
risultati
e degli indicatori
di sintesi
La determinazione del modello può avvenire tramite:
• risoluzione analitica – essa rappresenta la migliore soluzione
quando la distribuzione della variabile aleatoria presa in esame
viene individuata direttamente dal modello, in virtù delle proprietà
che contraddistinguono la v.c. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare
che la soluzione analitica rappresenta una strada praticabile solo
quando si hanno modelli semplificati, il che si verifica quando ci
si trova in presenza di v.c. che hanno una distribuzione normale.
Infatti, in tutti gli altri casi, si preferisce utilizzare altri strumenti;
• simulazione Monte Carlo – è una delle più diffuse modalità di
risoluzione dei problemi che hanno per oggetto la stima di variabili aleatorie. Il metodo Monte Carlo consiste nel cercare la soluzione di un problema, rappresentandolo quale parametro di una
ipotetica popolazione, e, nello stimare tale parametro tramite
l’esame di un campione estratto dalla popolazione mediante una
sequenza di numeri casuali. In altra parole, è possibile stimare la
variabile aleatoria obiettivo generando un numero sufficientemente elevato di scenari (o interazioni) casuali con i quali costruire la distribuzione di frequenza. La simulazione Monte
Carlo prevede la realizzazione dei seguenti passi:
• simulazione di una realizzazione casuale della variabile aleatoria
obiettivo;
• ripetizione per N volte dell’operazione precedente, in maniera tale
da arrivare a ottenere N realizzazioni casuali della variabile aleatoria obiettivo;
• stima della distribuzione della variabile aleatoria obiettivo tramite
le N realizzazioni casuali;
• stima degli indicatori sintetici della v.c.
Validazione e
verifica del modello
Si tratta di una fase volta a verificare la bontà dei risultati derivanti
dall’analisi condotta.
78
In alternativa è possibile avvalersi di una tecnica molto nota anche nell’analisi degli investimenti e conosciuta con il nome di albero delle probabilità. Tale tecnica si fonda sul presupposto per cui l’evento del quale si
sta studiando la frequenza potenziale venga suddiviso in una serie di eventi
sub-sequenziali necessari al suo verificarsi, ognuno dei quali caratterizzato
da una autonoma probabilità di accadimento.
Perché l’evento si verifichi, infatti, è necessario che si realizzino un serie di sub-eventi. Schematizzando quanto detto avremo un relazione del seguente tipo:
P(Ev M) = P(M / L) × P(M) + P(L / I) × P(I) + P(I / A) × P(I) + P(A)
o alternativamente:
P(M) = P(M) ∩ P(L) ∩ P(I) ∩ P(A)
Il metodo dell’albero delle probabilità permette di scomporre un problema naturalmente complesso in una serie di problemi elementari.
Ciò consente un maggior grado di approfondimento, una migliore conoscenza delle dinamiche che possono determinare un evento caratterizzato da
impatti fortemente negativi, e, conseguentemente, permette di identificare agevolmente quei provvedimenti utili a scongiurare il verificarsi del danno. Un
esempio è fornito dai modelli denominati FMECA, descritti precedentemente.
Un’altra tecnica assai nota è la PERT7 (Program Evalutation and Review Tecnique). La principale caratteristica di tale tecnica è quella di fornire
un unico indicatore determinato dall’equazione che segue:
Q=
V optimum+4V probabile + V pessimistico
5
dove:
• Q = quantità da stimare;
• VOptimum = valore che secondo la previsione più ottimistica si ritiene che
la quantità possa assumere;
• VProbabile = valore che dovrebbe assumere la v.c. con maggiore probabilità;
• VPessimistico = valore che si ritiene possa assumere la quantità secondo
una stima pessimistica.
Questa tecnica è basata essenzialmente su una media ponderata con
7
Vedi: Misani N. (1995), Introduzione al risk management, Egea, Milano; Minty G. (1998),
Production Planning and Controlling, Goodheart-Willcox, Tinley Park; Stevenson W. J.
(1996), Production-Operations Management, V ed., McGraw-Hill, New York.
79
{k = 1} per il complesso dei casi estremi e {k = 4} per il caso più probabile, che generalmente coincide con il valore intermedio. Ovviamente è
possibile utilizzare coefficienti diversi, utilizzando una serie di stime
basate, per esempio, su di un’analisi storica.
4. Il valore d’impresa e la valutazione dei rischi. Il modello economico valutativo
L’individuazione di un modello economico-valutativo del rischio permette di realizzare concretamente il collegamento tra valore generato nella
gestione del rischio e quello d’impresa. Si tratta, al pari di altre fasi sopra indicate, di una fase manageriale nella quale il decisore è chiamato a identificare il modello con il quale si intende misurare l’effetto delle politiche di trattamento del rischio. Nel Capitolo 1 avevamo illustrato come il legame tra rischio e valore fosse fortemente dibattuto in letteratura. Qui, partendo dal modello della finanza neoclassica per il quale le operazioni di copertura non generano valore in quanto un investitore razionale e ben diversificato è sottoposto ai soli rischi sistematici, concordiamo con quelli autori (Adam e Chitru
2005; Stulz 1996, Brown, Crabb e Haushalters 2002; Henteschel e Kothari,
Adam 2005), che vedono nelle imperfezioni di mercato e di comportamento
degli operatori, gli elementi generatrici del valore della copertura. In sostanza, l’ERM principalmente opera nella convinzione che trattare i rischi è, come avevamo affermato, un’attività di governo coerente con la funzione
obiettivo di massimizzazione del valore dell’impresa e permette di generare
ricchezza addizionale per gli shareholders. Venendo all’illustrazione delle
modalità con cui si giunge all’incremento di valore attraverso la copertura,
osserviamo come il risk manager per giungere a valutazione complessiva
debba utilizzare con discrezionalità i risultati della stima dei singoli rischi
identificati in precedenza e inserirli in un modello decisionale. In particolare
in questa fase l’operatore decide se e su quali tipi di rischio intervenire e soprattutto, nel caso di presenza di alternative di trattamento del rischio, stabilire e poi seguire un criterio di ordinabilità degli interventi. Prima però di trattare i rischi dovrà riuscire a misurarne l’impatto in termini di valore creato.
4.1. Il modello economico valutativo
Le decisioni inerenti le modalità di trattamento dei rischi possono essere intraprese solo attraverso la preliminare costruzione di un modello eco-
80
nomico-valutativo, nel quale si legano le distribuzioni di probabilità delle
variabili fonte di rischio alle grandezze che invece contribuiscono a determinare il valore dell’impresa.
La scelta del modello economico-valutativo deve essere realizzata tenendo conto di un insieme di dimensioni che trascendono le sole manifestazioni di variabilità delle variabili aleatorie alla base del rischio. Il modello
deve essere coerente con gli obiettivi strategici e gestionali dell’impresa,
debbono essere tenute in adeguata considerazione l’ambiente e i mercati nei
quali l’impresa o istituzione opera. Infine è necessario capire la struttura
delle preferenze dei mercati ai quali l’impresa si rivolge.
Altro sistema di vincoli è il tipo di stime alle quali si può accedere. Se,
infatti, esse sono qualitative o semi-quantitative non sarà possibile ricondurre le decisioni di ritenzione/alienazione/trattamento alle loro conseguenze in termini di flussi di cassa incrementali senza servirci delle capacità di
quantificazione del valutatore. Se invece saranno utilizzate le stime di natura quantitativa allora il modello economico-valutativo costituirà la “catena
di trasmissione” attraverso la quale la decisione riguardo a un determinato
rischio genererà o meno flussi di cassa incrementali.
In letteratura sono previsti molti modelli capaci di realizzare questa
quantificazione di flussi incrementali. Qualora si assuma la rilevanza del modello neoclassico della financial economics e da esso si parta per valutarne le
imperfezioni, l’impatto può essere valutato seguendo il seguente processo.
1. Si stima la distribuzione dei flussi aleatori incrementali8 (FAIt) legati
al rischio che stiamo valutando (per esempio nella copertura assicurativa l’entità del premio pagato a t0) alla quale si aggiungono i flussi di
cassa derivanti dal risarcimento in caso di sinistro. A ognuna delle
possibili manifestazioni del sinistro verrà applicata la probabilità di verificarsi. Sarà così possibile giungere agli E(FAIt).
2. Tali flussi incrementali aleatori verranno attualizzati al tasso risk free
divenendo ognuno VA(FAIt).
3. Sarà tenuto conto del rischio sistematico dell’investimento aggiustando tali flussi alla variabilità da esso introdotta.
8
I flussi di cassa aleatori incrementali si caratterizzano per essere di natura esclusivamente operativa e non debbono tenere conto delle implicazioni sulla struttura finanziaria
ovvero oneri e proventi finanziari dipendenti in qualche modo dalla decisione di copertura
del rischio. Non fanno parte dei FAI nemmeno i costi indiretti legati al manifestarsi di un
evento sfavorevole quale il maggior costo della provvista di liquidità necessaria fronteggiare l’evento negativo che peraltro è già stimato nei flussi incrementali negativi. Per approfondimenti sul calcolo cfr. CoSo (2004), Enterprise Risk Management. Integrated Framework, www.coso.org; anche in Floreani A. (2005), Introduzione al risk management: un
approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, Etas, Milano, pp. 104 e ss.
81
La somma algebrica dei due addendi sopra determinati, VA(FAI) + ∆
rischio sistematico darà il Fair Value9. Se il mercato nel quale il rischio
si manifesta fosse completo e perfetto e i comportamenti degli investitori razionali, il Fair Value misurerebbe il contributo della decisione di
copertura al valore d’impresa. Nel caso in cui invece ci siano delle imperfezioni sarà necessario sommare algebricamente al fair value i flussi
di cassa incrementali generati come effetto delle imperfezioni e del rischio non sistematico ovvero della non perfetta diversificazione del
portafoglio di investimenti in mano allo shareholder. In questo caso il
processo dovrà proseguire con un quarto punto:
4. Aggiustamento per i rischi incrementali negativi (downside risk) e per
effetto delle imperfezioni (IEt).
Proprio per considerare gli aggiustamenti qui sopra descritti, il valore
finale della decisione relativa al rischio sarà quindi la somma algebrica del
fair value con i flussi derivanti dagli aggiustamenti e dagli effetti dell’inclusione del premio per il rischio nel tasso di attualizzazione dei flussi di
cassa. Questi aggiustamenti sono conseguenza dei rischi incrementali ne9
Il fair value è definibile, limitatamente a questo contesto valutativo, come il valore attuale
dei flussi incrementali aleatori determinato con il valore di mercato (prezzo) assunto dagli
stessi se negoziati in un mercato finanziario perfetto. Si tratta del concetto di valore utilizzato dai teorici della finanza neoclassica. In letteratura sono conosciuti almeno due diversi
metodi per la determinazione del fair value. Il primo è conosciuto come metodo del portafoglio replicante utilizzato diffusamente nella valutazione dei prodotti derivati. Si cfr. i principali lavori sulla valutazione delle opzioni e loro più recente applicazioni. Merton R. (1973),
“The Rational Theory of Options Pricing”, Bell Journal of Economics and Management Science, n. 4, pp. 141-183; Black F. (1975), “Fact and Fantasy in the Use of Options”, Financial Analysts Journal, July-August, pp. 36-72; Black F., Sholes M. (1973), “The Pricing of
Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, vol. 81, pp. 637-654, pp.
637-659; Hull J. C. (2006), Opzioni, futures e altri derivati, VI ed., Pearson Prentice Hall,
Milano; Roll R. (1977), “An Analytical Formula for Unprotected American Call Options on
Stocks with Known Dividends”, Journal of Financial Economics, n. 5, pp. 251-258. Il secondo è invece determinato sulla base dei flussi di cassa incrementali aleatori, flussi ai quali
vengono apportate le correzioni necessarie per tenere conto del rischio sistematico sostenuto
da un investiture ben diversificato. Per questa tecnica si veda Floreani A. (2005), Introduzione al risk management: un approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali, Etas,
Milano. Altre accezioni di fair value sono quelle introdotte dall’art. 2426 c.c., numeri 1 e 9
nel quale si prevede il costo quale criterio base per le valutazioni delle poste in bilancio. Tale
criterio di valutazione riguarda le valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento. La
prassi contabile internazionale e, in particolare, i principi contabili internazionali (Ias), sono
infatti orientati all’abbandono del “criterio del costo” in favore del fair value. Lo Ias 32 e lo
Ias 39 definiscono infatti come già detto, “il corrispettivo al quale un’attività può essere
scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra
terzi”. In sostanza, si tratta della valutazione al valore che si può definire “di mercato”, tradotto dalle direttive comunitarie in “valore equo”.
82
gativi e delle caratteristiche d’impresa che possono allontanare l’impresa
dalla condizione prevista nella finanza neoclassica. Le principali imperfezioni dei mercati, capaci di modificare il valore della decisione di copertura, sono: i costi di transazione relativi alle operazioni di copertura, il risk
shifting effect, ovvero il manifestarsi di comportamenti opportunistici che il
management può porre in essere a svantaggio dei propri finanziatori a favore degli shareholders. Tra le imperfezioni capaci di generare valore positivo
per la copertura ricordiamo i costi diretti e indiretti del fallimento. In particolare si tratta dei costi della crisi preordinati alle procedure concorsuali e,
infine, di quelli sostenuti per il fallimento e le asimmetrie fiscali (Miller
1977; Miles ed Ezzel 1980).
4.2. Gli effetti delle imperfezioni e l’allontanamento dalla finanza
neoclassica
Gli effetti delle imperfezioni possono essere misurati attraverso un concetto già introdotto nel Capitolo 1, ovvero la perdita massima potenziale. In
particolare, tale effetto può essere calcolato come prodotto del rischio incrementale di downside (IR) con il premio per le imperfezioni (IP).
Addivenendo alla seguente equazione:
EI j = IR × IP
dove EIj, il valore delle imperfezioni, sarà poi trattato anche con il simbolo ∆VI.
Dal lungo processo fin qui illustrato, scaturisce il valore della decisione
di copertura come la somma algebrica delle componenti sopra descritte
sinteticamente.
dove E(FAIt) sono i flussi aleatori incrementali attesi, rf è il tasso privo di
rischio rj è dato dalla somma del risk free con il premio per il rischio di
mercato quindi con Beta = 1; FRS sono i flussi incrementali negativi o flussi corretti per il rischio sistematico e ∆VI è la somma algebrica degli effetti
delle imperfezioni che favoriscono/sfavoriscono la decisione di copertura e
sono tipiche dell’impresa che l’assume e del periodo nel quale si verifica. I
primi due addendi formano quello che abbiamo detto essere il fair value.
La fase si conclude con la decisione di coprire o meno il rischio.
83
5. Le principali strategie e tecniche di gestione dell’incertezza
(risk treatment)
Ogni rischio che viene identificato e presentato all’attenzione del management è oggetto di una decisione al riguardo. In particolare saranno disponibili, ex ante, tre esiti della decisione di trattamento:
1. il progetto analizzato genera rischi non adeguati rispetto al rendimento che
potrebbe garantire, cosa che rende non conveniente la realizzazione del
progetto e come conseguenza il rischio non viene assunto (risk avoided);
2. il progetto in oggetto essendo economicamente valido genera dei rischi che
possono essere gestiti e minimizzati. il rischio sarà trattato (risk treated);
3. il progetto in studio genera rischi adeguati e non trasferibili o eliminabili attraverso la gestione del rischio e il rischio sarà in questo caso ritenuto (risk retained).
Shimpi (2001) asserisce che i comportamenti di soggetto decisore in
relazione a un rischio, sono classificabili secondo una scala di intensità che
varia dalla non assunzione del rischio (0) fino alla ritenzione del rischio
senza copertura (1).
Figura 6 – Il processo per la valutazione di una decisione rischiosa
Modello economico valutativo
Risk retained
Risk Assessment
Valutazione
dei rischi
Risk avoided
Risk treated
Trattamento del rischio
Ex ante Risk treatment decision
Fonte: Nostro Adattamento da Shimpi (2001)
Rielaborando e modificando in parte quanto detto da Shimpi (2001, pp.
16 e ss.), possiamo ampliare il range delle decisioni alle quattro opzioni
sotto descritte, introducendo l’azione di risk reduction.
1. risk avoidance;
2. risk reduction;
3. risk transfer;
4. risk retention.
84
Pertanto è preferibile riorganizzare il processo secondo il diagramma di
fig. 7.
Figura 7 – Decisioni di copertura del rischio
Modello economico valutativo
Risk avoided
Risk Assessment
Risk retained
Valutazione
dei rischi
Risk accepted
Risk treated
Risk reduction
(Diversification)
Risk transfer
Legenda: in corsivo le decisioni relative al rischio, in normale gli stati relativi a ciascun rischio
d’impresa analizzato.
Fonte: nostra rielaborazione da Shimpi (2001, pp. 16)
La novità è costituita dalla fase di risk reduction, non prevista dal modello precedente. Ciò ci spinge ad ampliare il processo di copertura come
segue: una volta identificati e valutati con un modello economico-finanziario, i rischi sono alternativamente evitati (avoided) o accettati. Nel caso
in cui vengano accettati essi possono essere:
• oggetto di ritenzione. Così facendo essi entrano a far parte del portafoglio rischi sostenuti dall’impresa;
• trattati (risk treated) attraverso le tecniche di diversificazione del rischio o attraverso la cessione a terzi del rischio (risk transfer)
Vediamo nel dettaglio alcune di queste fasi di processo.
5.1. Risk Avoidance
Quando i rischi generati da un progetto sono superiori a quelli sopportabili ed essi non sono coerenti con gli obiettivi guida e le raccomandazioni in
materia di assunzione dei rischi, il decisore sceglierà di non dare seguito al
progetto evitando l’incertezza che ne consegue (Risk Avoidance). In sostanza
si tratta di progetti per i quali il costo della copertura sarebbe superiore al
valore generato con il progetto, il che implicherebbe una distruzione di valore. La soglia di accettabilità, però, dipende anche dalla propensione al rischio
85
del soggetto decisore. Infatti, se essa fosse particolarmente bassa, porterebbe
al rifiuto di molti progetti presentati. L’abilità del management è, in questa
fase, quella di stabilire alcuni criteri per la determinazione del rischio sostenibile e poi, attenendosi a questi, cercare di massimizzare il valore dell’impresa. In sostanza il decisore sceglierà di escludere quei rischi che sono
difficilmente valutabili o quelli che compromettono i risultati del core business. Ricordando la relazione rischio-rendimento sviluppata dai teorici della
teoria di portafoglio, possiamo concludere che un’impresa che è fortemente
avversa al rischio si attende dei rendimenti molto inferiori a quella che accetta progetti rischiosi. La risk avoidance non è particolarmente adatta ad
ambienti dinamici nei quali si devono continuamente ridefinire mercati, prodotti, tecnologia, ciò in quanto porterebbe a rifiutare tutti i progetti.
5.2. Risk Transfer
Continuando nella direzione della ritenzione del rischio, un possibile comportamento è quello tenuto dal management nel caso in cui il progetto sia in
grado di creare valore e quindi il rischio valga la pena di essere sostenuto. Comunque sia, il management vuole limitare parte del rischio trasferendolo ad altri soggetti attraverso l’acquisto di polizze o prodotti finanziari e altri contratti
atipici che possano ridurre la variabilità dei flussi e quindi il rischio sostenuto.
Si tratta del comportamento di risk transfer con il quale il management
“ritiene”, solo temporaneamente, il rischio per poi trovare utile copertura fuori
dall’impresa stessa. Esempio tipico di questo comportamento è quello adottato
nei confronti dei rischi puri come quello di incendio, di insolvenza dei crediti e
di ogni altro evento che sia caratterizzato dalla presenza di solo downside risk.
Nel caso di rischi speculativi, sarà necessario costruire apposite posizioni di
copertura che possano stabilizzare i flussi di cassa futuri. Si pensi alla copertura
sull’oscillazione del prezzo di alcune materie prime come il petrolio. Ultimamente, come afferma Shimpi (2001, p. 19), la copertura si è estesa ai rischi finanziari di mercato quali quello di cambio e di tasso di interesse.
5.3. Risk Retention
L’ultimo grado della scala indicata da Shimpi è quello della risk retention,
ovvero della decisione di assumersi il rischio e mantenerlo all’interno dell’impresa. Alla categoria dei rischi ritenuti partecipano, in verità, due distinti
tipi di rischio: i primi, quelli che sono volontariamente assunti dal manage-
86
ment e che debbono trovare una loro copertura nella dotazione del capitale
proprio posto a garanzia dei terzi; i secondi, ovvero tutti quei rischi che non è
stato possibile identificare, formalizzare, valutare e sui quali non è stato quindi
possibile assumere alcuna decisione. Shimpi ci ricorda infatti che “A risk neglected is a risk retained” (Shimpi 2001, p. 19). Proprio questi rischi non conosciuti, o non conoscibili, fanno sì che sia necessario dotare l’impresa di capitale sufficiente a fronteggiare i possibili effetti negativi da essi generati.
5.4. Risk Reduction, la diversificazione e le altre policies
La classificazione sopra riportata, sebbene illustri i principali comportamenti nei confronti del rischio, non è capace di descrivere compiutamente
l’operato del risk manager di fronte al rischio. Per dare esaurire la trattazione, illustrando tutte le alternative, dobbiamo citare anche il comportamento
di riduzione del rischio attraverso un’adeguata politica di diversificazione
del portafoglio degli investimenti.
L’obiettivo normativo di questa azione è quello ridurre il più possibile
il rischio ritenuto utilizzando l’effetto di abbattimento del rischio specifico
sostenuto da soggetti che investono in attività non correlate tra loro. Questa
tecnica, conosciuta come risk reduction, può essere attuata sia in una logica, ex ante (di prevenzione), che in quella ex post, di minimizzazione delle
perdite subite in occasione dell’evento.
Lo strumento principale per la riduzione del rischio è fornito dalle politiche di diversificazione introdotte da Markowitz (1952) e sviluppate successivamente dai teorici della relazione rischio-rendimento. La diversificazione del rischio è quel fenomeno che interviene quando un soggetto possiede più attività tra loro non correlate o correlate negativamente. Ciò determina un riduzione del rischio del portafoglio. Infatti se il rendimento atteso di un portafoglio continua a essere la media ponderata dei rendimenti
dei singoli titoli in portafoglio, ciò non avviene per quanto riguarda la varianza del rendimento che può essere scelto come indicatore del rischio del
portafoglio. A titolo esemplificativo la varianza di un portafoglio di titoli,
σ p2 , è infatti determinata come segue:
~
σ p2 = ERp − ( R p )
dove, trattandosi di due soli titoli, gli scostamenti dal valore medio sono i
seguenti:
~
~
~
ER p − ( R p ) 2 = E [W1 R1 − ( R1 ) + W 2 R 2 − ( R 2 )] 2
87
Seguendo il ragionamento di Fanni (2000, p. 679) è necessario svolgere
il quadrato della somma nella forma:
( a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab
Applicando alla precedente otteniamo:
Da quest’ultima deriva come:
~
~
~
~
2
E [W1 R1 − ( R1 ) 2 + W 22 R 2 − ( R 2 ) 2 + 2W1W 2 R1 − ( R 1 ) R 2 − ( R 2 )] =
~
~
~
~
= W12 E [ R1 − ( R1 ) 2 ] + W 22 E [ R 2 − ( R 2 ) 2 ] + 2W1W 2 E [ R1 − ( R1 ) R 2 − ( R 2 )]
Ovvero:
σ p2 = W1σ 12 + W2σ 22 + 2W1W2σ 1σ 2
Dove i primi due addendi stimano la varianza dei titoli 1 e 2, ognuna
ponderate con pesi W1 e W2 al quadrato; il terzo è costituito da due volte il
prodotto dei pesi per la covarianza del titolo 1 con il titolo 2. In conclusione
la varianza del portafoglio composto da due titoli è determinato sulla base
delle varianza dei titoli singolarmente presi al quale si somma algebricamente il doppio della covarianza.
Come osserva Fanni (2000, pp. 680 e ss.), la covarianza assume valori
positivi molto elevati ogni volta che i titoli sono fortemente correlati, mentre assume valore zero se i titoli si muovono indipendentemente gli uni dagli altri. Si osservano invece valori molto alti negativi nel caso di movimenti di segno opposto.
Proprio il contributo dato dalle covarianze al rischio del portafoglio,
giustifica l’affermazione secondo la quale, inserendo in un portafoglio delle
attività indipendenti o inversamente correlate le une alle altre, si ottiene una
varianza del portafoglio uguale o inferiore alle somma delle varianze. Ciò
determina, di fatto, l’effetto di diversificazione.
Nel caso poi di una indipendenza tra tutti i titoli presenti nel portafoglio,
la varianza di quest’ultimo sarà determinata come somma delle varianze dei
singoli contenuti ponderate con i loro pesi, costituendo questo un caso particolare della stima.
È da notare che la diversificazione esaurisce il proprio effetto di ridu-
88
zione del rischio dopo che sono state inserite all’interno del portafoglio anche solo 15-20 attività non correlate o inversamente correlate. Ciò in
quanto i rendimenti dei titoli azionari quotati su un medesimo mercato sono
soggetti a fonti di rischio e quindi di variabilità dei rendimenti comuni,
quali: il costo delle materie prime, del denaro, l’inflazione e la crescita del
PIL. Questo permette di richiamare la distinzione nota in letteratura, e già
accennata nel Capitolo 1, tra rischi diversificabili o specifici dell’investimento e, invece, i rischi non diversificabili o sistematici.
In presenza di un soggetto investitore razionale e ben diversificato, esso
sarà disposto a sostenere i soli rischi sistematici in quanto quelli specifici potranno essere abbattuti ricorrendo a un portafoglio di attività non correlate.
Chiudendo questa parentesi sulla diversificazione, cerchiamo di ricondurre il fenomeno all’interno dei comportamenti razionali del soggetto assuntore del rischio. La diversificazione costituisce uno strumento utile alla
risk reduction almeno laddove il decisore abbia la possibilità di frazionare
il proprio capitale destinandolo ad attività diversificate.
In questo senso quanto sopra detto è utile al percorso conoscitivo che
stiamo illustrando.
6. Il monitoraggio dei rischi sostenuti
L’ultima fase del processo integrato di risk management è quello del
monitoraggio. Si tratta di una fase in parte tecnica in parte manageriale vista la diversa natura dei controlli eseguiti.
I principali autori e le agenzie nazionale e internazionali che sin sono
occupate delle progettazione del processo in oggetto, concordano infatti sul
fatto che il monitoraggio sia indispensabile e che l’oggetto sia:
• monitoraggio dei rischi “ritenuti”. Si tratta del controllo concomitante eseguito su quelle variabili aziendali individuate come potenziali
fonti di rischio, rischio che volontariamente il management ha deciso si
assumersi. Ogni scostamento dalle stima di rischio atteso deve infatti
prevedere una sollecitazione degli organi decisionali e il monitoraggio
è proprio l’attività con la quale si esegue la diagnosi di tali eventi;
• monitoraggio sull’obsolescenza dei risultati di un’analisi eseguita
rispetto alla situazione ambientale nel quale il rischio si manifesta;
• monitoraggio della qualità del processo e della sua efficacia. In questo caso gli addetti al monitoring seguono un test sul funzionamento del
processo di risk management segnalando e provvedendo a fornire una
soluzione al top management.
89
7. Il retained risk e la necessità di un fondo di garanzia: cenni
I rischi non evitati (retained) e nemmeno trasferiti (transferred) nell’ambito delle precedenti decisioni di trattamento, vengono ritenuti dall’impresa e vanno a formare quello che comunemente viene definito rischio d’impresa. La presenza di tali rischi è inevitabile e costituisce
proprio elemento fondante dell’attività dell’imprenditore, il quale si
espone all’alea di organizzare processi di produzione di beni e servizi,
anticipando i bisogni di individui non organizzati. In questo senso è
comprensibile come il concetto di rischio è connaturato nell’impresa. Per
fare fronte al rischio e condurre con continuità le proprie attività,
l’imprenditore dovrà svolgere come abbiamo ricordato nel Capitolo 1, la
funzione produttrice di finanziamenti, ovvero, reperire le fonti di finanziamento per gli investimenti. Tali finanziamenti dovranno essere capaci
di preservare l’equilibrio finanziario in ogni istante e quello economico
almeno nel lungo termine.
Per fare questo, a tutela dei terzi, gli ordinamenti civilistici nazionali
hanno previsto, ognuno con forme e istituti giuridici diversi, che l’impresa
si doti di un capitale sociale posto a garanzia delle obbligazioni nei confronti di terzi e impongono che questo capitale sia mantenuto a livelli di sicurezza. Si tratta del capitale legale dell’impresa, quello cioè versato ai soli
fini di rispetto della normativa civilistica (capitale sociale).
In verità l’impresa non può svolgere la propria attività esclusivamente con il capitale sociale minimo di legge, ma spesso, a causa della
struttura dei propri investimenti, è caratterizzata da una intensità di capitale molto maggiore. Per questo motivo accanto al capitale sociale è
necessario associare delle riserve o del nuovo capitale fino a raggiungere un livello adeguato di patrimonializzazione. Il capitale proprio così
raccolto va considerato fondo per lo svolgimento delle attività e, nella
quota eccedente tale fondo, la garanzia per assorbire l’effetto di rischi
generati.
In questo modo il capitale proprio è composto da due addendi: il capitale sociale legale e quello volontario. Quest’ultimo differisce in dimensione al variare dell’attività svolta dall’impresa.
Prima di comprendere quali strategie di finanziamento il management
deve porre in essere al fine di massimizzare il valore dell’impresa attraverso l’ottimizzazione della struttura finanziaria che tenga conto delle opportunità di copertura, è necessario fare un breve excursus sul ruolo del
capitale proprio e di quello di dotazione all’interno della totalità delle
fonti raccolte.
90
8. Il capitale di dotazione, il rischio e la garanzia patrimoniale
Fin dall’età pre-capitalistica medievale, il capitale si identificava con
un fondo di anticipazioni necessarie per una attività di circolazione o produzione delle merci. Per David Ricardo (1817, Capitoli 1 e 5), “il capitale è
elemento attivatore della capacità lavorativa”; per Keynes (1936, pp. 135 e
ss.), esso è il presupposto all’atto di rinuncia al consumo e al sostenimento
del rischio, eventi per i quali il capitalista è giustificato a chiedere una remunerazione o rendimento del capitale.
Anche la Scuola fiorentina di Ceccherelli (1931) e Riparbelli (1950) da
una parte e Corsani (1937) e Fazzi (1940 e 1942) dall’altra, trattano il tema
della struttura delle fonti e dell’importanza del capitale proprio nella gestione dell’impresa. Riparbelli (1950, p. 73 e ss.), trattando del dissesto
aziendale, sottolinea, ai fini della sopravvivenza d’impresa, l’importanza
della struttura finanziaria accanto alla capacità reddituale. L’emergere delle
“disfunzioni finanziarie”, complemento e conseguenza di quelle economiche, genera, a dire dello stesso Riparbelli e di Fazzi (1942, p. 51), le condizioni per il manifestarsi dell’insolvenza e induce l’impresa a dotarsi di un
capitale proprio sufficiente a garantirne la sopravvivenza.
Nella visione più specifica che utilizzeremo nella presente monografia
il capitale di dotazione è definito come l’insieme di fonti finanziarie apportate dall’azionista e nella disponibilità giuridica10 del management, capaci di garantire il funzionamento dell’impresa in condizioni di equilibrio
finanziario. La prospettiva scelta è più ampia di quella giuridicamente conosciuta come capitale sociale in quanto va a ricomprendere accanto alle
10
Nel diritto commerciale italiano (A norma del Titolo V del Libro V c.c. – 1942), la forma
giuridica dell’impresa si definisce sulla base dell’autonomia patrimoniale perfetta, imperfetta o
assente. Nel primo caso siamo in presenza di società di capitali nella forma di Società per
Azioni, e Società a Responsabilità limitata, alle quali si affianca la SAPA società in accomandita per azioni. Tale società unisce la responsabilità limitata dei portatori del capitale alla differenziazione nei compiti riservati ai soci (accomandanti o accomandatari). L’imprenditore può
anche optare per forme giuridiche più semplici e decidere di non separare il proprio patrimonio
personale da quello della società che viene costituita. È questo il caso della più comune della
Società in Nome Collettivo, nella quale i soci rimangono illimitatamente responsabili delle obbligazioni societarie. Una forma di autonomia patrimoniale imperfetta è quella prevista per la
Società in Accomandita Semplice, nella quale i soci accomandanti rispondono limitatamente
alle risorse conferite, mentre quelli accomandatari rispondono al pari di quelli della SNC illimitatamente. Esistono anche altre forme più semplici di organizzazione sociale come la società
semplice, ma in questo caso il patrimonio della società non è individuabile e distinguibile da
quello dei soci. In questo contesto si fa riferimento alle società di capitali ovvero a quelle imprese nelle quali i soci rispondono delle obbligazioni assunte dall’impresa, limitatamente alle
risorse conferite a titolo di capitale proprio. Per un approfondimento di natura giuridica cfr.
Ferrara F., Corsi F. (2006), L’imprenditore e le società, Giuffré, Milano.
91
tradizionali poste che costituiscono il patrimonio netto, ovvero il capitale
sociale versato e le riserve di capitale accumulate nel tempo, anche altre
fonti che possono anche essere fuori-bilancio.
In generale, il capitale, inteso come capitale apportato, è elemento comune a quasi tutte le forme giuridiche che si possono dare a un’impresa. Esiste
una differenza sostanziale nell’identificazione e nel ruolo del capitale nel caso in cui l’imprenditore scelga di operare con la forma della società di persone, piuttosto che con quella di capitali. Nelle prime, infatti, i soggetti imprenditori, laddove amministratori, sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività, configurandosi l’impresa come
un soggetto dotato di autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle società di capitali, quest’ultimo è conferito all’impresa nella forma di capitale sociale e
non si confonde con il patrimonio dei soggetti che costituiscono la società.
Questo fa sì che l’azionista o il titolare di quote sociali, sia responsabile nei
confronti di terzi per il solo ammontare conferito nell’impresa, realizzandosi
così l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitale.
Questa premessa di tipo giuridico, che per la sua brevità non ha pretesa
di essere esaustiva, ci permette però di comprendere il ruolo assunto dal capitale o fondo di dotazione proprio all’interno di un’impresa.
Sia essa di persone o di capitale, il capitale costituisce una garanzia che
l’impresa è obbligata a fornire all’atto della sua costituzione ed è valida per
garantire i terzi che nei confronti dell’impresa possono vantare obbligazioni
contrattuali o interessi legittimi.
In particolare il capitale sociale deve o dovrebbe garantire i terzi nel caso
di insolvenza dell’impresa e rendere possibile la restituzione delle altre fonti
di finanziamento contrattate sui mercati finanziari, dette: capitale di terzi.
In questo ruolo di garanzia il capitale d’impresa deve quindi essere
adeguato a sopportare gli effetti negativi del manifestarsi dei rischi che
l’impresa genera nello svolgimento della propria attività e anche capace di
garantire l’equilibrio finanziario. Prima di illustrare il concetto esteso di capitale d’impresa richiamiamo i concetti noti come modello classico alla
determinazione del capitale sociale.
9. Il capitale investito, di dotazione e quello sociale nella prospettiva classica della finanza aziendale
Tra i principi normativi della finanza aziendale ricordiamo quello di finanziamento. “Scegliere una struttura finanziaria tale che massimizzi il valore
d’impresa e che sia in linea con gli investimenti da finanziare” (Damodaran,
92
2006, p. 12). In questo principio normativo il rapporto tra capitale proprio e di
terzi è solo accennato nella seconda parte e limitato al problema dell’adeguatezza delle fonti rispetto agli investimenti che l’impresa ha intenzione di
realizzare. In questo contesto, in particolare, il rischio è relegato alla determinazione del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa che vanno a determinare
il valore dell’impresa. La determinazione del mix di fonti di finanziamento ottimale, capace di minimizzare il tasso di attualizzazione, è dunque un obiettivo
utile al raggiungimento del fine ultimo dell’impresa, che rimane quello di massimizzazione del valore per i propri azionisti. Una visione così limitata non
mette, a nostro avviso, in adeguata luce l’importanza della sopravvivenza dell’impresa attraverso la verifica degli equilibri economici e finanziari che fanno
da presupposto al funzionamento di lungo termine dell’impresa.
L’adeguata composizione delle fonti rispetto agli impieghi è, difatti,
attività fondamentale per la sopravvivenza dell’impresa. È chiaro quindi
che il dimensionamento del capitale di dotazione e di funzionamento
come il rapporto tra capitale sociale e di terzi siano decisioni strategiche
per coloro che vogliono svolgere una gestione integrata e razionale del
rischio d’impresa.
In letteratura sono state individuate almeno tre esigenze per le quali
l’impresa deve raccogliere del capitale di dotazione:
1. copertura degli investimenti operativi operational capital;
2. copertura dei rischi attesi e inattesi risk capital;
3. segnale ai mercati signalling capital.
Per ognuno di tali fini è necessario che l’impresa si doti di capitale. Il
primo, e più ovvio motivo, è quello di raccogliere le fonti finanziarie necessarie a sostenere le uscite di cassa per gli investimenti operativi, siano essi
durevoli o meno.
La seconda motivazione è riconducibile al rischio di progetto generato
dagli investimenti. A fronte di attività rischiose, infatti, l’impresa dovrà accumulare un’ulteriore quota di capitale volto alla copertura dei rischi di
perdita attesa e inattesa. Questa seconda componente è, come abbiamo già
affermato sopra, detta risk capital.
Inoltre i managers, nella determinazione della quota di equity ottimale,
debbono tenere presente anche le esigenze di “marketing del capitale”; ovvero debbono, soprattutto se quotate su di un mercato regolamentato, raccogliere ulteriori fondi che hanno il solo scopo di costituire una riserva liquida e
disponibile capace di convincere anche il più scettico degli analisti equity,
sulla convenienza di investire nell’impresa. Nella prassi tuttavia queste esigenze sono percepite da un numero limitato di imprese. Non così invece, la
necessità di accumulare equity per scopi assicurativi, interni o esterni.
93
Se l’accumulazione avviene all’interno del capitale dell’impresa, di fatto
si parla di riserve di capitale alle quali debbono corrispondere nell’attivo poste prontamente liquidabili. Se l’accumulazione resterà eventuale ed esterna,
gli imprenditori si prodigheranno per sottoscrivere contratti di copertura delle
perdite in caso si verifichino gli eventi di downside risk. Tale forma di raccolta “on demand” è detta contingent capital ed è prevalentemente utilizzata
dalle imprese evolute per ridurre l’entità dell’equity iscritto in bilancio.
Ritorneremo sul concetto di contingent capital allorché tratteremo del
modello assicurativo di dimensionamento del capitale e non prima di aver
illustrato il modello classico.
9.1. Il modello classico
Per molti anni gli studiosi hanno discusso sulla dimensione ottimale da
dare al capitale di dotazione e a quello sociale. Il dibattito verteva, principalmente, sulle fonti finanziarie capaci di garantire in ogni istante l’equilibrio finanziario. I teorici dell’analisi per indici e margini (Cattaneo 1976),
hanno identificato, e poi calcolato, alcune misure di solidità, stabilità e liquidità capaci di mantenere l’impresa in equilibrio. Altri (Colombi, 1995),
hanno sviluppato modelli complessi quali il baricentro finanziario, proprio
per indagare il rapporto dinamico che esiste tra fonti e impieghi. In tutti
questi approcci, tuttavia, si parte da una considerazione iniziale comune:
quella che tutti i rischi generati dalle attività d’impresa vengano trasferiti ai
soggetti finanziatori e che quindi esista una sostanziale equivalenza tra rischio generato delle attività e quello assunto dai sottoscrittori delle fonti
che le finanziano. Infatti, se il rischio d’impresa non è trattato attivamente
dal management attraverso le tecniche di risk management dell’impresa o
con quelle di diversificazione, si può affermare l’equivalenza tra
Risk generated = Risk retained
Il rischio dovrà ricadere su quello che viene definito capitale totale investiti o paid-up capital: la somma delle fonti finanziarie effettivamente
versate all’interno dell’impresa.
Paid-up capital = F (Risk retained) = F (Risk generated)
Nella prospettica classica le fonti finanziarie sono reperibili in molti
modi. Qui di seguito citiamo le tre forme più comuni ovvero: il capitale
94
proprio, il debito garantito o senior debt e il credito subordinato. Accanto a
tali forme si trovano sempre più frequentemente forme miste di semi-equity
che presentano caratteristiche proprie del debito e in parte dell’equity. Il
capitale proprio (equity), poi, si scompone in capitale sociale propriamente
detto e riserve legali e volontarie. Questi due aggregati formano quello che
è conosciuto come patrimonio netto dell’impresa.
Investimenti = Paid-up capital = Senior debt + Junior debt + Equity
Le fonti sopra esposte sono selezionate in funzione della loro onerosità,
dell’adeguatezza rispetto agli investimenti ai quali offrono copertura e, soprattutto, secondo l’intensità di esposizione al rischio. Ordinando le fonti
sulla base del criterio della rischiosità crescente per il prenditore (seniority),
incontriamo: il prestito senior, che normalmente è provvisto di garanzie
collaterali reali o personali; successivamente vi è il prestito junior, che invece si dice subordinato al precedente, in quanto i diritti di rimborsi sono
subordinati a quelli dei sottoscrittori del prestito senior; infine citiamo il
capitale proprio, per il quale gli azionisti si aspettano un rimborso solo nel
caso in cui si sia provveduto a rimborsare capitale e interessi ai prestatori a
titolo di debito. Gli azionisti sono infatti residual claimers e su di essi insiste, in condizioni di funzionamento ordinario ed equilibrato della gestione
aziendale, l’intero rischio di business e di leverage.
Figura 8 – Il modello standard per la determinazione della struttura finanziaria e
il rapporto tra rischio generato e ritenuto
Bassa
Investimenti
Junior Debt
Esposizione al rischio
Prelazione di liquidazione
Senior Debt
Equity
Alta
Risk generated
=
Fonte: nostra rielaborazione su Shimpi (2001, p. 32)
95
Risk retained
Questo metodo prevede che i portatori di fonti finanziarie si accollino
in modo integrale il rischio generato dalle attività d’impresa. In questo senso proprio l’equity risulta essere l’unica grandezza sulla quale normalmente
dovrebbero andarsi a scaricare le perdite attese e in attese. Pertanto il dimensionamento dell’equity è funzione della perdita massima ottenibile in
presenza di un determinato livello di confidenza e ciò dovrebbe mettere al
riparo l’impresa dagli eventi che è verosimile possono accadere nell’esercizio della stessa. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, quindi,
il rischio d’impresa ricade contemporaneamente su tutti i finanziatori (capitale totale investito o capitale d’impresa), mentre gli effetti di una perdita
sono sopportati dai soli azionisti: capitale di dotazione.
9.2. Il modello assicurativo
Secondo quanto detto nella prima parte di questo capitolo, un approccio
attivo alla gestione del rischio fa si che non tutti i rischi debbono essere sostenuti e sopportati dal paid up capital. Quest’ultimo deve, infatti, essere
capace di fare fronte alla variabilità dei flussi di cassa derivante da rischi
che non possono essere evitati, ridotti e/o trasferiti a terzi.
Figura 9 – Il modello assicurativo. Rischio totale = Rischio ritenuto + Rischio trasferito
Bassa
Derivatives and insurance
Junior Debt
Investimenti
Esposizione al rischio
Prelazione di liquidazione
Senior Debt
Equity
Alta
Risk generated
=
Risk retained
Fonte: nostra rielaborazione su Shimpi (2001, p. 34)
96
+ R. transferred
Shimpi (2001) propone a questo proposito un modello capace di associare ai comportamenti ottimizzanti della finanza tradizionale, azioni più
consone a gestioni assicurative. Ne emerge quello che è conosciuto come
l’insurance model. In esso il rischio generato dall’impresa (business e leverage risk) è in parte ritenuto e in parte trasferito a terzi attraverso la stipula di contratti di copertura.
In questo caso, quindi, al rischio generato dagli investimenti (Risk generated) si contrappongo i rischi ritenuti e quelli trasferiti a terzi.
Risk generated = Risk retained + Risk Transferred
Il rischio che ricadrà sul paid-up capital è in questo caso solo una
parte del rischio generato e ciò porta all’esigenza di raccogliere una
quota minore di capitale come conseguenza della riduzione della perdita
massima potenziale a seguito della copertura. A fronte del rischio trasferito a terzi, si può identificare una seconda forma di capitale, l’off balance-sheet capital, conseguenza dell’attività di trasferimento. Quest’ultimo, insieme al paid-up capital, andrà a costituire il fondo di garanzia per il rischio totale generato dall’impresa.
Paid-up Capital = F (Risk retained)
Off Balance-sheet capital = F (Risk transferred)
Paid-up capital + Off Balance-sheet capital =
= F (Risk Retained; Risk Transferred)
È da notare che in ipotesi di impresa solvibile la riduzione del paid-up
capital riguarderà il solo equity in quanto è a tale grandezza che è affidato il
compito di coprire i rischi d’impresa non trasferibili. Senior Debt e Mezzanine rimarranno invece costanti in importo e per rischi da essi assunti. Questa affermazione segue quanto indicato nella proposta di capitale di dotazione necessario all’impresa nel lavoro di Shimpi (2001). Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa da alcuni autori e tra tutti da Doherty (1995) il
quale contesta a Shimpi la natura di impiego e non di fonte della quota abbattuta tramite trasferimento a terzi.
Finora ci siamo limitati all’utilizzo di strumenti che hanno una rappresentazione in bilancio limitata agli effetti economici della copertura e che hanno
permesso la riduzione del rischio ritenuto. Se, invece volessimo ridurre ulteriormente il rischio, inducendo una riduzione del capitale di dotazione, po-
97
tremmo fare ricorso a quello che viene definito come contingent capital. Tale
fonte finanziaria non si trova nel bilancio d’impresa in quanto viene attivata dal
manifestarsi di un sinistro ed è costituita da linee di credito o di capitale erogabili on demand, capaci di ridurre la quantità di capitale proprio da raccogliere
in assenza di sinistri. Tecnicamente, si tratta di forme di opzioni put di tipo
“knock-in”, ovvero titoli emessi dall’impresa e sottoscritti da assicurazioni e
banche che si attivano a prima richiesta nel caso in cui l’impresa riporti un sinistro oggetto del contratto di opzione. Attenzione, non si tratta di un trasferimento di rischio a titolo definitivo, ma solo temporaneo, infatti, se al manifestarsi del sinistro l’impresa sarà comunque solvibile, le nuove linee di credito
attivate dovranno essere rimborsate al pari delle altre.
Il contingent capital, i contratti assicurativi e i derivati per la copertura
partecipano a quello che in letteratura (Cult 2002; Conti 2005, Doherty
1995, 2005), è conosciuto come risk capital, ovvero quella parte di fonti
dedite alla copertura di rischi inattesi.
Figura 10 – Il modello assicurativo con strumenti off balance-sheet e contingent
capital
Paid-up capital
Off balance-sheet
Bassa
Insurance and derivatives
Contingent capital
Insurance linked securities
Junior Debt
Investimenti
Esposizione al rischio
Prelazione di liquidazione
Senior Debt
Equity
Alta
Risk generated
=
Risk retained
+
Risk transferred
I ragionamenti finora svolti sono stati sviluppati nella prospettiva dell’impresa e quindi sono rivolti alla quantificazione della relazione che esiste
tra rischio sostenuto e capitale di dotazione di una impresa standing alone.
Ciò fa sì che in tali modelli non siano stati introdotti i possibili effetti delle
politiche di diversificazione del rischio che i soggetti prenditori possono por98
re in essere per abbattere il rischio specifico dell’impresa. Assumendo, invece, la prospettiva dell’investitore, e dando a quest’ultimo la possibilità di diversificare il rischio specifico sopportato per investire nell’impresa, possiamo
affermare che una parte del rischio retained da parte del finanziatore può essere abbattuto facendo ricorso alle tecniche di diversificazione del portafoglio
di investimenti che abbiamo già visto nel par. 5.4. Qualora ciò avvenga, vediamo quali sono le conseguenze in termini di rapporto tra il rischio generato
dalle attività e i rischi sostenuti dai soggetti prenditori.
In questo terzo modello, che include anche la diversificazione del rischio in capo al finanziatore dell’impresa, la relazione sarà illustrata dalla
seguente:
Risk generated = Risk assets =
= Risk Retained after diversification + risk transferred
Figura 11 – Il rischio ritenuto nel modello assicurativo con strumenti off balancesheet e Contingent Capital nella prospettiva del risk taker diversificato
Paid-up capital
Off balance-sheet
Bassa
Insurance and derivatives
Contingent capital
Insurance linked securities
Specific risk diversification
Junior Debt
Investimenti
Esposizione al rischio
Prelazione di liquidazione
Senior Debt
Equity
Alta
Risk generated
=
Risk retained
+
Risk transferred
Fonte: nostra elaborazione
In questo caso il rischio ritenuto dopo la diversificazione sarà minore di
quello precedentemente sopportato a causa della seguente relazione:
Risk retained – Risk Diversified = Risk retained after diversification
99
Dalla quale ricaviamo:
Risk Diversified = Risk retained – Risk retained after diversification
In questo caso, il rischio ritenuto dall’impresa dopo la diversificazione
diminuisce proprio in funzione dell’indipendenza dei risultati dell’impresa
rispetto a quelli degli altri investimenti inseriti nei portfolios di attività dei
finanziatori.
Questa situazione è illustrata nella figura della pagina precedente, nella
quale la diversificazione agisce sul rischio specifico sostenuto tanto dagli
azionisti che dai creditori riducendolo. In presenza di un’impresa solvibile,
però, tale riduzione andrà a vantaggio dei soli azionisti.
Tutte queste considerazioni, che permettono di ampliare molto quelle
tradizionali relative alle scelte del mix di capitale proprio e di terzi tale da
massimizzare il valore dell’impresa, ci segnalano l’importanza dell’adeguatezza del capitale di dotazione per l’esistenza dell’impresa. Prima
di procedere all’analisi più dettagliata del rischio d’impresa nella sua
componente principale, il rischio di struttura finanziaria, è necessario
svolgere una riflessione sulla relazione tra rischio e soggetti prenditori del
medesimo. Tale analisi è anticipatrice dei temi trattati nella seconda parte
di questo libro.
10. I prenditori del rischio d’impresa, seniority e insolvenza
Dopo questo breve approfondimento sull’entità del rischio generato, la
sua trasferibilità a soggetti terzi prenditori e dimensione del capitale di dotazione, è necessario riportare il focus dell’analisi sulla struttura finanziaria
per comprendere come business e leverage risk residui si dividano tra i
soggetti prenditori. L’analisi sarà svolta nel caso di imprese con struttura
finanziaria caratterizzata o solo da equity o da debito ed equity.
Prima di farlo vogliamo ripartire dal concetto di seniority e dalla gerarchia individuata dalla legge, dai regolamenti o dalle singole covenants predisposte negli strumenti di finanziamento dell’impresa. Ricordiamo che
ogni strumento finanziario con il quale l’impresa raccoglie risorse può essere ordinato secondo il principio della prelazione sui flussi di risultato. Ciò è
tanto più importante, quanto minori sono i flussi di cassa generati dall’impresa. L’istituto della prelazione, infatti, è trattato, nelle situazioni
aziendali, dalle fattispecie previste dal diritto fallimentare.
Al fine di sopravvivere l’impresa deve generare flussi di cassa disponi-
100
bili per tutti i finanziatori sufficienti a onorare gli impegni assunti in via
prioritaria con i creditori privilegiati, quindi con i creditori chirografari e
infine con gli azionisti. Tra i creditori privilegiati, accanto a dipendenti,
professionisti e artigiani, la legge fallimentare stabilisce ugual grado di seniority ai creditori assistiti da garanzie reali o personali, tra cui si citano gli
obbligazionisti titolari di debito senior. I creditori assistiti da garanzie sono,
infatti, titolari di un privilegio che permette loro l’azione di esecuzione individuale sul bene finanziato e, nella maggioranza degli ordinamenti vigenti, un privilegio in caso di ripartizione dell’attivo della procedura concorsuale. Con grado di seniority inferiore, possono essere citati i creditori
non assistiti da garanzie o diritti disciplinati dalla legge. Tra questi annoveriamo i creditori obbligazionari titolari di debito subordinato e/o mezzanino
e comunque tutti i finanziatori terzi non commerciali e non serviti da garanzia. Tutti questi creditori si soddisfano solo nel caso in cui siano stati
interamenti liquidati gli importi dovuti ai creditori privilegiati e vi siano risorse residue da distribuire.
Riguardo ai rischi assunti dai soggetti prenditori in condizione di
funzionamento dell’impresa (going concern) possono verificarsi tre casi:
1. l’impresa è finanziata interamente da equity;
2. l’impresa è finanziata da equity e debito e il patrimonio netto è capiente
rispetto alla perdita massima potenziale;
3. l’impresa è finanziata da equity e debito e il patrimonio netto è capiente
rispetto alla perdita d’esercizio e inferiore a quella massima potenziale.
Ponendo attenzione esclusivamente all’obiettivo di garantire la sopravvivenza dell’impresa, in altre parole quello di minimizzare il default risk,
possiamo affermare che le imprese che si trovano nella condizione 1 e 2,
garantiscono la sopravvivenza in caso di perdite attese inferiori alla massima potenziale. In questi casi l’azionista rimane unico prenditore del rischio.
In particolare, nel caso dell’impresa unlevered, la natura del rischio è esclusivamente di business.
Nel secondo caso l’azionista si accollerà business e leverage risk,
l’obbligazionista il solo rischio inatteso relativo al debito. Nel terzo caso,
invece, quello caratterizzato da un capitale di dotazione inferiore alla perdita massima potenziale, i rischi sono accollati sugli azionisti fino al concorrere del valore di mercato del capitale di dotazione, se liquido, e quando la perdita assume valori superiori a quest’ultimo, il rischio si trasferisce sui creditori.
Ciò è detto ipotizzando che l’impresa non soffra, nel caso di perdite
anche inferiori alla PMP, di rischi di liquidità, in altre parole di situazioni nelle quali la perdita non può essere coperta con la liquidazione degli
101
assets. Se infatti ciò avvenisse, l’impresa sarebbe in condizioni d’insolvenza a causa dell’inadeguatezza della struttura finanziaria e ciò
porterebbe al fallimento dell’impresa a prescindere dalla sostenibilità di
medio termine della perdita. In altre parole non sarebbe soddisfatto
l’equilibrio finanziario.
Tabella 3 – I prenditori del rischio nell’impresa finanziata da equity e in quella finanziata con equity e debito
HP
Impresa finanziata con solo
equity
Azionista
Creditore
Business risk
—
Impresa finanziata con equity
e debito con Capitale
di dotazione (Paid up capital)
> Perdita massima potenziale*
CD > PMP
Business
e leverage risk
Rischio
d’insolvenza
nullo
Impresa finanziata con Equity
e Debito e con perdita
d’esercizio superiore al CD
e inferiore alla PMP
CD < P < PMP
Business risk
e leverage risk
Parte
del business risk
e leverage risk
* Tale caso fa riferimento a una situazione di Patrimonio netto > Perdita massima potenziale sempre
verificata. Ciò non esclude che si possa verificare una perdita effettiva superiore al patrimonio netto, ma
il caso di specie ipotizza che l’azionista ricapitalizzi l’impresa al fine di coprire in tutto o in parte la
perdita, ricostituendo il capitale sociale. Sulla base di tale ipotesi non vi è la possibilità che si generi una
perdita in c/capitale per gli obbligazionisti e quindi il rischio d’insolvenza risulta nullo.
Figura 12 – La distribuzione dei risultati attesi e la perdita massima potenziale
(PMP)
95%
PMP
5%
Fonte: nostra elaborazione
Al fine di comprendere, quindi, cosa possa accade a un’impresa che abbia
capitale di dotazione capiente o non capiente il valore delle perdite e che voglia, aggiungere all’obiettivo finora perseguito della sopravvivenza, quello
102
della finanza neoclassica di massimizzazione del valore dell’impresa, andiamo
a illustrare il rapporto perdita/capitale di dotazione prendendo come variabile
aleatoria la distribuzione di frequenza dei risultati d’impresa.
Supponiamo di avere costruito la distribuzione di frequenza dei possibili
risultati finanziari d’impresa J. Il risultato atteso, qualora la distribuzione sia
gaussiana, è stimato nel valore medio e sarà pari a R j . Nel caso in cui l’impresa ottenga un rendimento effettivo superiore a quello atteso, i rischi di business e leverage saranno interamente accollati all’azionista. Tali rischi saranno ritenuti dagli shareholders anche nel caso in cui il Rj sia minore di R j
e maggiore di 0; oppure, addirittura, nel caso in cui esso sia negativo, almeno
fino al verificarsi della condizione sotto descritta:
Perdita d’esercizio < Valore di mercato del capitale di dotazione
Nel caso, infatti, in cui la perdita ecceda il capitale di dotazione, avverrà un trasferimento del rischio in capo all’obbligazionista, rischio che avrà
natura prevalentemente finanziaria, ma che potrà anche essere originato da
un evento negativo legato all’attività operativa.
Questa possibilità giustifica la richiesta di un rendimento atteso diverso
da quello risk free per i prestatori di capitale di debito e riporta l’esempio
sopra citato nel quadro teorico previsto dal modello neoclassico.
La presenza di un premio per il rischio d’insolvenza è, infatti, naturale
se si considera che, accanto all’obiettivo di sopravvivenza, il management
deve perseguire anche quello di massimizzazione del valore d’impresa.
Realizzare solo il primo, infatti, porterebbe il livello di capitale di dotazione
a essere uguale o superiore alla PMP, ma ciò non permetterebbe al management di minimizzare il Wacc e conseguentemente massimizzare il valore
d’impresa. In sostanza ci troviamo nuovamente a dover scegliere quel livello d’indebitamento tale per il quale si minimizzano i costi del fallimento
e si massimizza il valore d’impresa. La dimensione del capitale di dotazione sarà, in questo contesto, ottimale quando il costo marginale del fallimento eguaglierà il beneficio marginale del debito.
Tutto ciò è detto in assenza di politiche innovative di gestione del rischio
d’impresa. Infatti, il management potrebbe, servendosi per esempio del contingent capital, realizzare contemporaneamente i due obiettivi sopra citati.
Egli, in sostanza, si troverebbe a determinare il capitale proprio sulla
base del rapporto tra costi e benefici marginali del debito, ma potrà abbattere il rischio atteso non coperto dallo stesso, servendosi proprio del contingent capital da attivarsi in occasione di perdite attese che eccedano il capitale di proprio. Quanto detto finora, tuttavia, non permette all’impresa di
103
mettersi al riparo dagli effetti catastrofici di un rischio inatteso, per la tranquillità del lettore ricordiamo che tali casi sono previsti con una probabilità
vicina allo zero.
La conclusione che traiamo da quanto finora detto è che la gestione
economico finanziaria d’impresa, riletta alla luce dei principi del risk management, permette al management capace di gestire attivamente il rischio
di creare valore e di sottoporre al rischio d’impresa azionisti e obbligazioni
che, per tale rischio, sono adeguatamente remunerati.
104
3. LA VALUTAZIONE DELL’IMPRESA
E DEL SUO CAPITALE ECONOMICO
*
di Oliviero Roggi
1. Premessa
Il tema della valutazione dell’impresa e del suo capitale economico ha
appassionato studiosi e analisti finanziari fin da tempi in cui le imprese erano
prevalentemente valutate per le attività di cui disponevano e per i debiti che
avevano contratto per coprire i loro investimenti. La misurazione del valore
è, infatti, attività strumentale a una variegata gamma di operazioni di finanza
ordinaria e straordinaria realizzate dalle imprese nel corso della loro vita.
Inoltre la valutazione dell’impresa è strumentale alla stima del valore
creato e quindi della stima delle performance aziendali. È in questa sua accezione che la determinazione del valore generato con le decisioni aziendali
è coerente con il percorso di analisi che ci ha portato, nei primi due capitoli,
a conoscere natura e manifestazione del rischio e che deve necessariamente
passare dalla fase di valutazione del valore generato dall’impresa nella gestione attiva del rischio stesso.
L’obiettivo di questo lavoro rimane innanzitutto quello di fornire un quadro teorico delle metodologie utilizzate in dottrina e nella prassi per stimare il
valore intrinseco di un’impresa; per arrivare quanto più vicini possibile all’individuazione del true value che ne esprime in modo astratto il valore certo.
Determinare il valore intrinseco del capitale di un’impresa è un’attività
complessa a causa della pluralità di prospettive dalle quali l’impresa può
essere osservata. Nell’analisi più superficiale emergono immediatamente
gli elementi principali su cui fondare la stima, gli elementi patrimoniali,
quelli reddituali e finanziari legati allo sviluppo. Più difficile è invece cogliere gli aspetti immateriali dell’essere (impresa), o quelli potenziali rela*
L’argomento è stato trattato precedentemente in Roggi O. (2003), Valore intrinseco e prezzo di mercato nelle operazioni di finanza straordinaria. Una analisi sulle public utilities,
FrancoAngeli, Milano; e in Paci I. (2004), Temi di finanza aziendale, FrancoAngeli, Milano.
105
tivi a un migliore impiego delle risorse nello sviluppo o a una valorizzazione in sede di cessione dell’impresa. Ancora più difficile è determinare il
valore imprese in situazione di crisi o usando la terminologia anglosassone
in special situations.
Procederemo come segue: innanzitutto definiremo il concetto di valore
intrinseco, per se, precisando cosa intenderemo per valutazione dell’impresa e del suo capitale economico. In seguito saranno illustrati i principali
strumenti teorici di stima del valore. Infine saranno richiamati alcuni modelli empirici di valorizzazione dell’impresa e doi alcune decisioni tipiche
del Chief Risk Officer, quali quelle di copertura del rischio d’impresa.
2. Il concetto di valore d’impresa. Teoria e prassi professionale
Nell’ultimo decennio molti studiosi si sono dedicati alle ricerche volte
a identificare uno strumento idoneo di misurazione del valore d’impresa
(Copeland, Koller e Murrin 1990 e 2000, Guatri 1990, 1991, 1994, 1997,
1998; Damodaran 1997, 2002 e 2006; Massari 1998; Massari e Zanetti
2008; Guatri e Bini 2001, 2002 e 2005) Tutti, nel perseguire questo fine,
sono partiti dalla definizione stessa di valore d’impresa chiamandolo ora
true-value, ora fair value e talvolta standing alone value. Si tratta di concetti molto simili in quanto basati sulla medesima astrazione concettuale di
valore, ma anche sottilmente diversi gli uni dagli altri nelle caratteristiche
che ognuno di essi vuole esaltare. Guatri (1997) sottolinea come ciascun
metodo sia niente più che un’“opinione” sul valore intrinseco dell’impresa.
In quanto opinabile tale valore è foriero di critiche riguardo alla soggettività
delle determinazioni, ma è comunque un elemento necessario nei processi
obbligatori o volontari in cui la valutazione si realizza.
Si deve alla scuola americana della fine degli anni Ottanta l’identificazione
del true-value quale valore che un investitore sarebbe disposto a pagare nel caso in cui l’impresa si trovasse isolata da forze esogene, capaci in qualche modo
di influenzarne la valorizzazione. Tale definizione vuole sottolineare l’impatto
che l’ambiente rilevante per l’impresa (fornitori, clienti, struttura competitiva
del settore), esercita sulla stessa, in modo da modificarne il valore intrinseco.
Alcuni autori, opportunamente, si soffermano sul termine valore piuttosto che
su quello di prezzo, in quanto il true-value non si forma dall’incontro della
domanda e dell’offerta, nel mercato delle partecipazioni d’impresa. Esso è infatti normalmente riferito al complesso delle attività d’impresa.
Sostanzialmente diverso dal precedente è il valore stand-alone, che
Massari traduce nel concetto zappiano di capitale economico dell’impresa.
106
Si tratta del “valore che potrebbe essere attribuito all’impresa nelle attuali
condizioni di gestione” (Massari 1998, p. 183). Esso, a dire dell’autore, non
prende in considerazione né il valore potenziale in caso di acquisizione, né
tanto meno i benefici privati del controllo dell’impresa. Per questo motivo
il valore stand-alone è anche assimilabile al valore dell’impresa nell’ottica
dell’investitore non di controllo. Le motivazioni che spingono Massari ad
assimilare lo stand-alone value al capitale economico sono da ricercarsi nel
fatto che entrambi si basano sui soli risultati reddituali dell’impresa, in assenza di “perturbazioni” esterne.
Un concetto abbastanza diverso di valore, forse il più pragmatico e vicino al concetto di prezzo, è quello, frequentemente citato dalla dottrina anglosassone, di fair-market value1. Tale configurazione di valore è, per molti
aspetti, simile a quella italiana di prezzo probabile di negoziazione, in occasione di operazioni di finanza straordinaria. Rispetto al true-value, il fairvalue mostra notevoli vantaggi nel suo utilizzo pragmatico. La genesi si deve
agli ambienti della finanza anglosassone, in Paesi nei quali la maggiore efficienza del mercato del controllo delle imprese rende attendibili le stime del
valore intrinseco con questo metodo. Infatti, laddove il controllo delle imprese è contendibile o il volume delle operazioni sul capitale è comunque elevato, il fair-value costituisce un prezioso punto di partenza per l’operatore, o
per l’impresa stessa, nell’avvio delle operazioni di valutazione e poi anche
durante le fasi di negoziazione politica del prezzo di cessione. In questa ottica, il valore dipende dalle transazioni precedentemente avvenute su imprese
simili e non solo dalle caratteristiche uniche della realtà aziendale che si sta
valutando. Per questo motivo parte della prassi anglosassone dà ampio spazio
ai metodi dei multipli relativi di risultato o di mercato per giungere alla stima
del valore futuro di un’impresa. Il concetto di fair-value ha trovato ampia diffusione e legittimazione nel corso degli ultimi anni in quanto applicabile anche a imprese in perdita, come quelle della net economy. Ciò ha portato gli
operatori a servirsi del concetto di fair-value e poi del metodo dei multipli
per il calcolo del valore di partenza nelle negoziazioni (Perrini 2000; Guatri e
Bini 2002 e 2005). Dal multiplo sul fatturato, a quello più noto del P/E, fino
al volatile, quanto inaffidabile, multiplo sul contatto (Perrini 2000), gli studiosi della finanza d’impresa hanno cercato strumenti capaci di catturare il
potenziale di creazione di valore delle imprese e hanno abbandonato sistematicamente le valutazioni patrimoniali, reddituali o miste.
1
In Europa il metodo del fair-value è stato recentemente rivalutato dalla Direttiva Europea
2001/65/CE del 27 settembre 2001 nella quale si è modificato la IV e VII direttiva Europea in materia di bilancio delle società e bilancio consolidato. Cfr. Caratozzolo M. (2002), “L’introduzione del
fair-value nella IV e VII Direttiva Comunitaria: una prima valutazione” Le Società, 11/2002.
107
Proprio gli elementi che avevano decretato il successo del fair value
sono oggi i principali motivi di un ripensamento sull’utilità dello strumento.
Lo scoppio della bolla speculativa legata a internet prima e quello sicuramente devastante della crisi immobiliare che affligge il mondo intero dal
2007 hanno portato a disapplicare il metodo del fair value nella valutazione
degli assets finanziari. Il disallineamento dei prezzi di mercato rispetto alla
più conservative stime di valore intrinseco degli assets ha suggerito agli
analisti la revisione e in parte l’accantonato i metodi legati al valore di mercato e soprattutto quelli nei quali era prevista un’applicazione “creativa”
dei multipli stessi. Ciòha comportato una rivalutazione dei modelli nei quali
il valore alle imprese è stimato sulla base dei più concreti flussi di cassa, se
non addirittura basandosi sul valore dell’attivo. Le crisi, almeno nei modelli
di valutaizone, sono quindi foriere anche di conseguenze positive. Mai come all’indomani della crisi della net economy e nel dibatitto di oggi, infatti,
la disciplina aziendale a cui fa capo la valutazione delle imprese sta riflettendo su nuovi metodi di misurazione del valore intrinseco. Ciò è, di per sé,
un risultato positivo per la determinazione del true-value.
3. Il valore d’impresa e il valore dell’equity. Una premessa
Prima di affrontare in dettaglio l’analisi degli strumenti a disposizione
del valutatore è necessario chiarire cosa intenderemo per valore dell’impresa, cosa per valore dell’equity e cosa si sta valutando.
Per valore d’impresa intenderemo il valore complessivo dell’organismo
economico atto a perdurare e volto alla produzione di beni e servizi (impresa).
È insomma il valore intrinseco dell’impresa nel suo complesso, a prescindere
da chi ne sia il finanziatore. La letteratura utilizza per tale valutazione la dizione assets side valuation per sottolineare la centralità e l’importanza del complesso interrelarsi di risorse, materiali, immateriali, umane, e delle competenze
nelle attività capaci di generare il valore dell’organismo impresa.
Diversa è la valutazione equity side, ovvero quella volta a individuare il
valore dell’impresa per il solo azionista. A tale valore è possibile giungere, stimando direttamente gli elementi che costituiscono le basi del valore
per lo shareholder oppure indirettamente calcolando l’assets side value
prima e sottraendovi poi la posizione finanziaria netta2.
2
Per un approfondimento sul metodo indiretto di determinazione del valore dell’equity basato sul Debt-free approach si confrontino Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle
imprese, Egea, Milano, pp. 58 e ss.; e Visco J. D. (1995), “Debt-free Approach Revisited”,
Business Valuation Approach, March.
108
Guatri (1998), suggerisce poi come tanto il valore dell’impresa quanto
quello per l’azionista possano avere connotazioni molto diverse a seconda
del metodo con il quale si misura. Egli parla di capitale economico quando
il valore dell’impresa per l’azionista è prevalentemente stimato servendosi
dei risultati reddituali netti analitici; definisce invece valore potenziale per
l’azionista quello derivante dall’applicazione dei metodi finanziari prospettici disponibili all’azionista nel lungo termine nelle forme sintetiche (rendite perpetue) o in quelle finanziarie (DCF). Il valore potenziale è anche
quello per l’acquirente e per il venditore in un’operazione di finanza straordinaria. Di ciò parleremo dettagliatamente nel par. 5.5.
Sia il valore flusso che quello potenziale sono misure della capacità di
creazione di valore dell’impresa antagoniste alla visione statica, patrimoniale, della stessa. Proprio il valore stock dell’equity si contrappone ai precedenti ed è assimilabile al patrimonio netto rettificato attraverso l’evidenziazione in bilancio degli assets patrimoniali a valori correnti.
I metodi di valutazione misti di cui parleremo nel par. 5 rispondono,
poi, proprio all’esigenza di valorizzare l’impresa da una pluralità di prospettive capaci di evidenziare ora le componenti di stock del valore, ora
quelle di flusso nel breve e lungo termine, ora quelle miste. Le configurazioni di calcolo al pari delle differenti prospettive sono multiple e permettono la valorizzazione dell’impresa sia nell’ottica della totalità dei finanziatori sia in quella dei soli azionisti. Alcuni metodi però sono specifici
della sola valutazione assets side, altri solo di quella equity based.
4. Le scelte del valutatore e il processo di stima del valore
Il processo di valutazione comprende numerose fasi. Tra le principali
citiamo:
1. l’individuazione degli obiettivi di valutazione (chi valuta, nell’interesse
di chi e cosa si valuta);
2. la definizione del contesto di valutazione (perché si valuta e quali
sono i soggetti che partecipano o interferiscono sulla misurazione
del valore);
a. circostanze della valutazione (obbligatoria, volontaria, ostile);
b. contesto di valutazione (soggetti, interessi e poteri relativi);
3. la raccolta delle informazioni;
4. la scelta del metodo di valutazione;
5. la determinazione del valore (compreso sanity check) e la redazione del
rapporto di valutazione.
109
4.1. Gli obiettivi della valutazione, i valutatori e i soggetti promotori
La prima fase di definizione degli obiettivi si apre individuando la prospettiva interna o esterna dalla quale si valuta l’impresa. La domanda implicita è la seguente: Chi valuta l’impresa? E poi ancora: il valutatore è interno (insider) o esterno alla stessa?
Questo interrogativo, che può sembrare ai non addetti ai lavori niente
più che una curiosità da soddisfare in via preliminare, è, invece, fondamentale per la determinazione del livello di accuratezza della misurazione
del valore, la sua attendibilità. Infatti la valutazione è sovente influenzata
dalla posizione relativa del valutatore rispetto all’impresa. Nel caso si tratti
di dipendente o consulente dell’impresa esso è un “insider” e potrà beneficiare di maggiori informazioni rispetto a quelle ottenibili da un soggetto
terzo (outsider). Il valutatore esterno, infatti, è abbandonato a se stesso in
un esercizio di misurazione nel quale può utilizzare solamente dati pubblicamente disponibili o, al massimo, fraudolentemente ottenuti. Ciò finirà
necessariamente per determinare il grado di attendibilità e accuratezza della
stima del valore intrinseco. Negli ultimi anni, tuttavia, in ragione di un notevole sviluppo dell’informativa finanziaria disponibile sulle società quotate nei listini italiani, anche le valutazioni degli outsiders hanno raggiunto
livelli di analiticità soddisfacenti e permettono agli investitori di formulare
un giudizio abbastanza accurato sulle potenzialità dell’impresa, con un occhio sia ai fondamentali sia all’andamento del corso del titolo.
La prospettiva del valutatore è fortemente influenzata dalle motivazioni
per le quali si arriva alla determinazione quantitativa del valore d’impresa e
in particolare dagli obiettivi dei soggetti nell’interesse dei quali si valuta
l’impresa. Si possono distinguere almeno tre principali gruppi di attori direttamente e indirettamente interessati.
Saranno direttamente interessati al processo valutativo coloro che partecipano da protagonisti alla vita dell’impresa: managers e finanziatori
(azionisti e obbligazionisti).
Saranno invece indirettamente interessati alla determinazione del valore coloro che la dottrina definisce normalmente stakeholders o portatori di
interessi legittimi. Ritroviamo in questa categoria i clienti e i fornitori, interessati a stimare l’andamento dell’impresa e il suo valore, i concorrenti, il
cui valore dipende dalla quota di mercato relativa detenuta dall’impresa
valutanda, le forze sindacali, che cercheranno nella capacità di creare valore dell’impresa le assicurazioni per non vedere minate le basi dell’occupazione dei propri affiliati, e le pubbliche amministrazioni, che puntano a far crescere l’economia e quindi anche la singola impresa.
110
4.2. Le circostanze nelle quali si realizza la valutazione
In merito al contesto nel quale la valutazione del capitale si inserisce, la
dottrina ha elaborato una classificazione che distingue le circostanze di valutazione obbligatoria da quelle facoltative.
Nel primo gruppo rientrano quelle misurazioni del valore d’impresa previste da una disposizione normativa o regolamentare. Per esempio è obbligatorio effettuare la valutazione dell’azienda nel caso di trasformazione in
società di capitale (SpA, o srl) di società di persone (snc o Sas). È ancora necessario giungere a determinare il valore di un’impresa in occasione di operazioni di finanza straordinaria di particolare rilevanza per l’impresa quali:
fusioni, incorporazioni, scissioni, acquisizione/cessione di rami d’azienda.
La procedura di quotazione dell’impresa su di un mercato regolamentato prevede una valutazione approfondita dell’impresa. Talvolta sarà il
Tribunale a chiedere una perizia di valore nell’ambito di procedure concorsuali, contenziosi e arbitrati, o comunque in occasione di procedimenti giudiziari a carico di soggetti coinvolti nell’impresa.
Rientrano invece nella valutazione di natura discrezionale tutte quelle
valutazioni preparatorie alle operazioni di compravendita di aziende, rami
d’azienda, partecipazioni di maggioranza, minoranza qualificata, nel caso
di affidamenti bancari o di operazioni di ristrutturazione finanziaria.
La valutazione è attività utile anche alla pianificazione in quelle imprese che utilizzano piani di incentivazione del personale basati sulla creazione
di valore, e in ogni altra occasione ordinaria o straordinaria nella quale sia
necessario pervenire a una stima del valore dell’intero complesso aziendale
o di quello riservato ai soli azionisti.
È verosimile pensare come gli elementi di contesto sopra citati possano
influire sulle fasi successive di misurazione del valore e principalmente
sulla scelta del metodo di valutazione.
Anche i soggetti che partecipano alla valutazione sono in grado di influenzare la stima del true value. Pensate per esempio al venditore di un’impresa e alla pressione che esso eserciterà sul perito al fine di massimizzare il
valore e poi anche il prezzo di cessione. Nell’ambito della tutela delle garanzie nei confronti di terzi (perizie per il Tribunale), il giudice incaricato esercita di fatto un’influenza sul perito spingendolo ad applicare attentamente il
principio di prudenza nella determinazione del valore del capitale proprio posto dall’impresa a tutela dei terzi creditori. Per non parlare poi dei managers
e delle pressioni che potrebbero esercitare sul valutatore ogni volta che parte
del loro salario è legato alla valorizzazione dell’impresa.
Non è questa la sede per approfondire quanto la valutazione finale sia
111
realmente influenzata dai soggetti che a titolo diverso prendono parte al
processo. È necessario però ricordare che un’attenta analisi del contesto è
necessaria per comprendere il grado di affidabilità della stima.
4.3. La raccolta delle informazioni
Una volta determinato e conosciuto il contesto all’interno del quale
l’operazione di valutazione si svolge è necessario raccogliere le informazioni indispensabili per le fasi tecniche di stima del valore.
Si distinguono innanzitutto i dati primari, quelli direttamente reperiti in
azienda, da quelli secondari, disponibili da fonti pubbliche. Spesso per una
corretta valutazione dell’impresa è necessario integrare gli uni con gli altri
e giungere a una stima quanto più possibile basata su dati non affetti da
bias di rilevazione.
All’interno dell’impresa i periti cercheranno informazioni sulla storia e
sul business nel quale l’impresa opera. Tali informazioni sono normalmente
inserite nelle comunicazioni sociali, nel piano industriale in corso di realizzazione e nei business plan prospettici, documenti di cui le imprese si dotano con maggiore frequenza rispetto al passato. Tuttavia i documenti indispensabili alla redazione di ogni tipo di valutazione sono i documenti contabili sintetici e principalmente: il bilancio d’esercizio relativo agli anni
precedenti a quello della stima, il rendiconto finanziario e tutta la documentazione sintetica e analitica disponibile nella contabilità industriale e
direzionale. Nel caso in cui l’impresa sia valutata sui flussi di risultato saranno indispensabili i documenti finanziari prospettici dai quali sarà possibile ricavare grandezze fondamentali quali: il reddito netto atteso futuro, i
free cash flow to equity o i free cash flow to firm e ancora tutte le variabili
necessarie alla determinazione del valore futuro atteso. Nel caso l’impresa
sia valutata con metodi patrimoniali essa dovrà dotarsi delle informazioni
relative al valore corrente degli assets in suo possesso.
Ai dati interni si associano quelli esterni, pubblici. Questi sono disponibili
gratuitamente o a pagamento da fonti terze. Si tratta prevalentemente di informazioni sulle principali variabili macroeconomiche, sul settore in cui l’impresa
opera, sulle operazioni che si sono realizzate nel settore e sui processi evolutivi
in corso. Ancora, è possibile raccogliere da fonte pubblica le informazioni sulle
imprese simili (comparables) o sulle transazioni comparabili necessarie alla
determinazione del relative-value dell’impresa nei metodi indiretti.
La fase di raccolta delle informazioni è preliminare alla scelta del metodo di valutazione in quanto questa può essere influenzata anche dalla di-
112
sponibilità di dati attendibili e raccolti seguendo il criterio fondamentale
della prudenza nelle rilevazioni. Il valutatore integrerà, poi, il materiale
raccolto proprio alla luce della scelta del metodo di stima del valore.
4.4. La scelta del metodo di valutazione delle imprese
La scelta del metodo di valutazione è sicuramente la fase più importante da
realizzare all’intero del processo valutativo. Non è detto, però, che la scelta di
un metodo sia esclusiva, ovvero che il valutatore ne utilizzi uno solo. È possibile, anzi preferibile, applicare più di un metodo e verificare se i valori indipendentemente determinati convergono intorno a un valore o comunque in un
intervallo di valutazione. In una parola è necessario verificare se e come aspetti
diversi della stessa impresa portino a valutazioni convergenti o divergenti3.
Il progresso delle discipline aziendali che si occupano della valutazione
e quello indotto dalle esigenze degli operatori hanno reso disponibili molte
metodologie di valutazione dell’impresa. La dottrina è solita distinguere però quei metodi che giungono al valore dell’impresa partendo dalle caratteristiche intrinseche, fondamentali, da quelli nei quali il valore è determinato
“per relazione”. Nel primo caso si parla di metodi diretti, in quanto si apprezza l’impresa servendosi di caratteristiche fondamentali: ora degli assets
patrimoniali posseduti, ora del reddito o dei flussi finanziari generati, ora di
una pluralità di caratteristiche dell’essere impresa (metodi misti). Nel caso
invece dei metodi indiretti il valore dell’impresa è determinato per relazione, ovvero prendendo come parametro il valore di imprese simili o di transazioni di mercato che hanno avuto per oggetto imprese comparabili.
Nella fig. 1 sono illustrati i metodi più diffusi per la stima del true value classificati con il criterio diretti/indiretti.
Altro elemento da tenere in considerazione è l’attività svolta dall’impresa e il settore di appartenenza. La scelta del metodo di valutazione
deve essere fatta proprio tenendo in considerazione le specificità dell’impresa che si sta valutando e quindi anche il settore in cui opera. Alcuni
studi hanno messo in evidenza una correlazione tra l’appartenenza di
un’impresa a un settore e il metodo di stima del valore utilizzato. Nella tab.
1 sono riportati i risultati di due studi condotti da Ambrosetti Stern Stewart
Italia nel 1999 e poi ancora nel 2002.
3
Sia la dottrina che la prassi della valutazione prevede nel corso del processo di stima il cosiddetto sanity check. Tale operazione è volta a verificare che la misurazione effettuata con
metodi diretti sia compatibile e convergente con quella realizzata per esempio con metodi di
relative valuation. Per un approfondimento confronta Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano, p. 56.
113
Figura 1 – I metodi di valutazione dell’impresa e del suo capitale economico
Metodi
Metodi diretti
Flussi
di risultato
Finanziari
Misti (equity)
Media +
Avviamento
Criteri empirici
Economic
Value added
Sintetici
Sintetici
Analitici
Reddituali
Multipli di mercato
(imprese e transazioni
comparabili)
Misti
Analitici
Patrimoniali
Semplice
e complesso
Metodi indiretti
Fonte: nostro adattamento da Massari (1998)
Tabella 1 – Metodi di valutazione dell’impresa. Una prospettiva per settori di appartenenza
Metodo Valutazione
Settore Industriale
Holding e
finanziarie
Assicurativo
Bancario
1999
2002
1999*
2002
1999
2002
1999
2002
Patrimoniale
1,9%
0%
50%
74%
28,6%
0%
16,2%
1%
Reddituale
8,4%
5%
—
—
7%
0%
11,2%
16%
Misto (patr + redd)
1,6%
5%
—
6%
23,8%
3%
29,5%
23%
34,7%
32%
—
13%
32%
7%
35%
13%
Discount Cash Flow (DCF)
37,5%
47%
25%
2%
5,6%
16%
7,2%
12%
Economic Value Added
15,9%
8%
25%
5%
2,1%
8%
0,9%
9%
Embedded Value
—
—
—
—
—
65%
—
8%
Altro
—
—
—
—
—
1%
—
18%
Multipli
Si riferisce alle imprese immobiliari e non propriamente alle holding operative e finanziarie i dati risultano pertanto difficilmente comparabili.
Fonte: Ambrosetti Stern Stewart Italia (1999, 2002)
Appare subito evidente come l’attività dell’impresa oggetto di valutazione
influenzi fortemente l’analista nella scelta del metodo di calcolo del valore
economico del capitale o dell’enterprise value. Dal confronto dei due studi
emerge poi come, anche all’interno di settori omogenei, le tecniche di misurazione del true value siano evolute. Per esempio si è assistito a una rivoluzione
degli strumenti impiegati per la determinazione del valore delle banche e delle
114
assicurazioni con il ricorso all’embedded value4 (AIAF 2002; Eccles, Herz,
Keegan, e Phillips 2001). Altra tendenza da evidenziare è quella di un minore
ricorso alla valutazione relativa sia essa realizzata con il metodo dei multipli di
mercato o con quello delle transazioni comparabili. Il DCF model consolida,
nello studio 2002, posizioni di rilevanza già acquisite precedentemente.
Tenendo conto di quanto abbiamo ricordato sopra il perito identificherà
il metodo principale e i metodi di controllo di cui si avvarrà e integrerà, se
necessario, le informazioni necessarie alle fasi tecniche di calcolo.
La descrizione dei principali metodi di valutazione delle imprese sarà
oggetto del par. 5 al quale rinviamo per i dettagli. Proseguiamo invece nella
descrizione del processo di valutazione.
4.5. La determinazione del valore dell’impresa e la redazione della
relazione di valutazione
Per arrivare a determinare il valore dell’impresa nel suo complesso o
per i suoi azionisti è necessario applicare gli algoritmi specifici di ogni
metodo e verificare successivamente il range di valori all’interno del quale
la stima varia. È proprio a questo punto che si rende necessario il sanity
check grazie al quale è possibile stabile se i valori ottenuti con l’applicazione del metodo principale e con quelli di controllo convergono nell’intorno di un valore oppure divergono notevolmente. In questo caso è necessario risalire alle cause del mismatching e verificare se la differenza può
essere imputata in qualche modo ai dati, ad altri fattori di calcolo, oppure
effettivamente alle diversità riscontrate nell’oggetto di valutazione.
Nel caso in cui i valori siano coerenti gli uni agli altri sceglieremo
quale delle valutazioni considerare la definitiva e sulla base di questa scelta
andremo a redigere la relazione di valutazione.
La relazione di valutazione avrà contenuto più o meno dettagliato in
funzione degli scopi per i quali è redatta. Adattando quanto detto da Guatri
(1998, p. 417) possiamo distinguere tre principali scopi:
• interno – stime informali;
• esterno – stime formalizzate per comunicare risultati e notizie a terzi;
• esterno – stime ufficiali.
4
Il metodo dell’embedded value si è diffuso principalmente nei settori assicurativi e bancari.
Per una disamina esaustiva si confrontino tra gli altri: Eccles R. G., Herz H. R., Keegan E. M.,
Phillips D. M (2001), The Value Reporting Revolution. Moving Beyond the Earnings Game,
Wiley, New York; AIAF (2002), “The Communication of Intangibles and Intellectual Capital:
An Empirical Model of Analysis”, Official Report, n. 106, Milano; Di Piazza Jr. S. A., Eccles
R. G. (2002), Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, Wiley, New York.
115
Nel caso di stime informali il reporting non ha una struttura obbligatoria e risponde alle esigenze di controllo interno che hanno originato la valutazione. Chi redige la stima “Ha la massima libertà di comportamento e di
scelta dei criteri e in particolare non è legato a obblighi di dimostrazione a
terzi dei propri assunti e delle conclusioni” (Guatri 199, p. 417).
Le stime formalizzate per scopi di comunicazione di dati a terzi sono il
più delle volte realizzati da soggetti esterni all’impresa e hanno spesso il compito di orientare gli investitori nelle scelte di investimento nel capitale dell’impresa. Sono generalmente realizzate da analisti finanziari di banche
d’affari legate all’impresa o indipendenti e seguono la prassi di comunicazione delle informazioni agli investitori individuali e istituzionali sui mercati finanziari. Un esempio di documento redatto da terzi e volto alla valorizzazione
dell’impresa è quello predisposto dall’advisor della stessa in occasione della
sua cessione. In questo caso l’advisor svolge un’indagine sul valore potenziale
del venditore, indagine che sarà documentata nell’information memorandum
che la banca d’affari (advisor) farà circolare alla ricerca di un potenziale acquirente. In tale documento dovranno essere evidenziati gli elementi strategico-finanziari su cui la valutazione è costruita e soprattutto dovranno essere
ben enunciate le ipotesi con le quali si è giunti al valore del cedente.
L’ultimo gruppo di relazioni è quello delle stime ufficiali. A seconda
della procedura nel corso della quale la stima è richiesta, il valutatore redigerà una relazione dettagliata sulla misurazione da lui effettuata, e se necessario provvederà ad asseverare la perizia presso il tribunale competente per
la procedura stessa.
5. I fondamentali d’impresa. Variabili determinanti nella valutazione diretta dell’impresa e del suo capitale proprio
I metodi di valutazione diretti sono quelle tecniche di calcolo del
valore d’impresa basate su dati fondamentali interni all’impresa. Il più
delle volte si tratta di grandezze stock come gli assets altre volte si tratta
di flussi reddituali o finanziari, ma in entrambe le circostanze il valore
finale dell’impresa è determinato partendo da caratteristiche intrinseche alla stessa.
La dottrina distingue tre gruppi di metodi diretti: quelli patrimoniali,
quelli dei flussi di risultato e i metodi misti.
Il primo metodo, quello patrimoniale si basa sulla visione d’impresa
come contenitore di assets e di debito a valori correnti. In questa accezione
sarà necessario stimare ogni componente patrimoniale dell’impresa e de-
116
terminare il valore del capitale proprio per differenza dei valori correnti del
attivo e del passivo. Si parla di patrimonio netto rettificato.
Figura 2 – I metodi diretti per la determinazione del valore d’impresa. Quadro sinottico
Metodi diretti
Flussi
di risultato
Misti
Finanziari
Misti (equity)
Media +
Avviamento
Economic
Value added
Sintetici
Sintetici
Reddituali
Analitici
Semplice
e complesso
Analitici
Patrimoniali
Fonte: nostra elaborazione
I metodi dei flussi di risultato5 valutano l’impresa relativamente alla
performance che essa è capace di generare. Non importa se l’impresa è
5
Nel Capitolo 1, abbiamo definito il concetto di rischio e analizzato i molteplici criteri per
introdurre l’incertezza nelle decisioni d’impresa nell’ambito della funzione obiettivo della
finanza aziendale, ossia la massimizzazione del valore dell’impresa. A tal fine è stato necessario introdurre il concetto di valore, definendo il valore di un investimento J qualunque, e
quindi dell’impresa sommatoria, come valore dei flussi di risultato futuro (CFt) generati dai
progetti di investimento e attualizzati a un tasso di interesse r.
Inoltre, abbiamo visto che il rischio può essere incluso all’interno della formula del valore
in due modi alternativi. Il primo prevede che il rischio sia incluso nel tasso di attualizzazione,
mentre i flussi di risultato, detti anche cash flows (CF), sono espressi a valori nominali e non
tengono conto del rischio che essi varino a seguito dell’alea insita negli investimenti realizzati.
Il rischio, come conseguenza dell’incertezza nella quale la decisione è assunta, viene quindi a
essere incluso nel denominatore della formula del valore, laddove il tasso di interesse al quale
si attualizzano e capitalizzano i flussi di cassa contenga un premio per il rischio stesso. Il secondo metodo prevede che il rischio sia previsto e incluso nella stima attraverso la ponderazione dei flussi nominali con la probabilità di verificarsi degli stessi.
In questo lavoro tratteremo dei metodi di flusso di risultato che si rifanno al primo dei
metodi sopra descritti.
117
sotto o sovra capitalizzata o di quali assets sia dotata, essa varrà per i risultati che è in grado di ottenere. In questa seconda accezione il valore
d’impresa è assimilato a quello dei flussi di risultato attesi futuri. La dottrina distingue due principali gruppi di flussi di risultato: gli indicatori di
performance reddituale e quelli squisitamente finanziari. I primi hanno trovato nel filone dottrinale italiano iniziato da Zappa (1937) e proseguito da
Guatri (1991, 1994, 1997, 1998) la loro legittimazione e misurano il valore
dell’impresa servendosi di grandezze di bilancio note quali l’utile netto o il
reddito operativo. I secondi hanno i loro natali prevalentemente nel mondo
anglosassone e stimano il valore attraverso l’attualizzazione dei flussi di
cassa disponibili per l’impresa (Free Cash Flow to Firm) o per il solo azionista (Free Cash Flow to Firm o i flussi dividendo).
Il terzo gruppo di strumenti di valutazione è quello che tenta di
“sposare” i due metodi precedenti introducendo elementi di valutazione
reddituale/finanziario in un impianto di stima prevalentemente basato sul
patrimonio netto rettificato. Tra i metodi misti si distingue quello della
media, unico realmente costruito come media dei valori patrimoniali e reddituali dell’impresa; quello del metodo misto con evidenziazione separata
dell’avviamento e il metodo dell’Economic Value Added. Non resta che
approfondire la conoscenza degli strumenti di calcolo.
5.1. Il metodo patrimoniale
Il metodo di valutazione patrimoniale, nella prospettiva più ampia di
stima dell’intero capitale raccolto dall’impresa, si basa sul valore corrente
delle attività di cui l’impresa stessa dispone. In tale prospettiva essa è paragonabile a un contenitore nel quale la proprietà prima, e il management poi,
depositano quelle attività patrimoniali necessarie allo svolgimento dell’attività. La valutazione in questo caso risponde a esigenze di corretta valorizzazione dei singoli cespiti patrimoniali dell’impresa per la determinazione del valore-stock6, ora dell’impresa tutta, ora del solo capitale economico. La valorizzazione delle attività è complessa. In essa si deve tenere
presente che il valore degli assets deve essere stimato in ipotesi di going
concern dell’impresa, ovvero in ipotesi di funzionamento. È per questo
motivo che accanto agli asseta materiali trovano spazio anche gli intangibles, che esprimono le potenzialità dell’impresa nello sfruttamento dell’immagine di marca, del know-how, della tecnologia ecc. La visione del
6
Cfr. Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano, p. 211.
118
contenitore di soli beni materiali non interdipendenti sarebbe parziale e
inadeguata a esprimere correttamente la filosofia di valutazione patrimoniale dell’impresa.
Se l’attivo deve essere valutato tenendo presente quanto appena detto,
la misurazione del passivo aziendale, al contrario, non risulta problematica
in quanto questo deve sempre essere quantificato al valore nominale. L’attivo patrimoniale, invece, deve subire una complessa serie di operazioni di
apprezzamento e stima, necessarie a far emergere il valore di funzionamento di ciascuna attività. I criteri più utilizzati sono, in questa prospettiva,
quello del valore corrente o di riproduzione che sostituiscono il costo storico al quale l’impresa ha acquisito gli assets.
Formalizzando, il valore del complesso delle attività è determinato come sommatoria degli assets (j) materiali e immateriali siano essi cespiti o
disponibilità patrimoniali espresso a valori correnti. Algebricamente:
La valutazione patrimoniale nella prospettiva degli azionisti quali residual claimers, sarà invece determinata come differenza tra il valore degli
assets (Wassets), appena calcolato, e valore corrente delle passività esistenti
(Wliabilities). Tale importo corrisponde al valore nominale, in quanto un’impresa, in regime di funzionamento, è obbligata a iscrivere e rimborsare le
obbligazioni contratte con terzi, al loro valore nominale7.
In tale espressione il patrimonio netto rettificato (K’) è espresso proprio
dalla differenza tra il valore corrente dei singoli cespiti (j) e la sommatoria
delle obbligazioni di pagamento (k) facenti capo all’impresa.
Gli studiosi (Guatri 1992, 1994, 1998; Massari 1998) sono concordi
7
Uno dei pochi casi in cui il valore corrente del debito non corrisponde a quello nominale è
la procedura concorsuale di concordato preventivo o fallimentare; in essa le passività non
privilegiate hanno valore zero fino a quando non sono stati rimborsati i creditori privilegiati,
e poi vengono valutate in moneta fallimentare in sede di riparto dell’attivo fallimentare (Cfr.
Legge Fallimentare RD 16 marzo 1942). Un altro caso di sottovalutazione del passivo riguarda l’impresa che, dopo aver emesso obbligazioni sul mercato finanziario, si trova nella
condizione di poter legalmente e finanziariamente rimborsare il prestito (richiamando i titoli) a un valore di mercato inferiore a quello nominale.
119
nell’attribuire al metodo del patrimonio semplice una serie di limiti oggettivi tali da farlo derubricare a strumento di controllo del valore, piuttosto
che essere un autonomo metodo di valutazione8.
Il limite principale è quello di trascurare gli elementi immateriali non
iscritti in bilancio a seguito di acquisizione a titolo oneroso. Il secondo, non
meno importante, è quello di considerare l’impresa come un contenitore di
assets anziché come un’organizzazione complessa, nella quale il valore si
crea non solo attraverso il possesso di beni, ma, soprattutto, tramite le capacità di chi li utilizza.
In relazione a tale limite osserviamo che le imprese sono indotte dalla concorrenza ad attuare strategie di differenziazione (Porter 1982) che le costringono a investire in assets immateriali capaci di garantire la riconoscibilità ai loro
prodotti. Che si tratti di marchi registrati, brevetti a tutela di opere dell’ingegno
o di altri intangibles9 legati prevalentemente alle aree del marketing e delle tecnologie produttive, poco importa: è vitale per l’impresa distinguersi dalle proprie concorrenti per esprimere pienamente il proprio valore.
Proprio per dare il giusto peso a questa rilevante componente del valore aziendale e per rimuovere il limite sopra enunciato, la dottrina e la prassi hanno sviluppato, e gradualmente introdotto, il metodo patrimoniale
complesso. Il valore intrinseco è calcolato, nella prospettiva dell’azionista,
come la somma tra il Patrimonio Netto Rettificato (K’), determinato con il
metodo semplice, e i Beni Immateriali (BI), gli intangibles posseduti dall’impresa.
Wequity = K ' + BI
Tali beni constano di attività immateriali, generalmente non iscritte in
bilancio (fatta eccezione per quelle acquisite a titolo oneroso, come l’avviamento commerciale evidenziato in occasione di acquisizioni d’impresa),
e contribuiscono in modo determinante al successo dell’impresa10.
8
Non a caso Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milanopreferisce
la dizione “informazione patrimoniale” a quella di metodo patrimoniale, da contrapporre a
quelli finanziario e reddituale. Il valore-stock determinato nel corso dell’indagine svolta con
criteri patrimoniali “non è mai, in se stesso, un modo accettabile per valutare un’azienda. Ciò
non toglie che l’informazione patrimoniale sia sempre utile” (p. 211). L’indagine patrimoniale,
prosegue l’autore, “rimane per sempre un momento utile o necessario delle stime di valore,
anche quando queste ultime si orientano sui valori-flussi o sui prezzi probabili” (p. 212).
9
Per una prospettiva storica esaustiva della relazione tra valore e intangibles si cfr. Guatri L.
(1997), Valore e intangibles nella misura della performance aziendale: un percorso storico,
Egea, Milano.
10
Senza la pretesa di essere esaurienti riprendiamo da Guatri i principali beni immateriali
dell’area marketing e tecnologia oggetto di valutazione patrimoniale complessa: nome e lo-
120
In verità l’introduzione del valore di detti beni apprezza la capacità dell’impresa che ne dispone, di produrre risultati superiori a quelli mediamente
ottenuti nel proprio settore. Tale condizione appare necessaria affinché si
manifesti l’extra-profitto che sta alla base del calcolo dell’avviamento nei
metodi misti patrimoniali-reddituali.
Se la prospettiva di valutazione è quella dell’azionista di maggioranza
al valore come sopra determinato dovrà essere aggiunto il maggior valore
corrispondente ai benefici ottenuti dal controllo (BC) della società (Fringe
benefits, redditi indiretti ecc.).
Wequity = K ' + BI + BC
È generalmente condiviso che la valutazione con il metodo patrimoniale
sia efficace per quelle imprese in cui le attività tangibili iscritte nel bilancio
rappresentano la maggior parte del valore intrinseco e su cui c’è minore incertezza di misurazione. Perciò il metodo trova principale applicazione nel
campo delle imprese finanziarie e di quelle immobiliari, come appare evidente nelle percentuali di utilizzo dei metodi di stima riportate in tab. 1.
L’informazione patrimoniale è di sicura utilità anche per lo svolgimento
di operazioni di finanza straordinaria quali la quotazione sul mercato regolamentato o la negoziazione in caso di acquisizione e/o fusione d’impresa.
Gli operatori delle principali banche d’affari preferiscono peraltro attribuire
al valore patrimoniale d’impresa il significato di valore intrinseco minimo
da cui partire per la valutazione: un floor-value solido e spesso non contrattabile. L’utilizzo dell’informazione patrimoniale è, nella frequenza, inversamente proporzionale alla rilevanza del peso degli elementi intangibili
sul successo d’impresa. Come già evidenziato nell’indagine condotta da
AIAF in collaborazione con ASSI (Ambrosetti Stern Stewart Italia 1999)
solo l’1,9% delle imprese industriali del campione analizzato utilizza l’informazione patrimoniale per determinare il proprio valore. Il metodo basato
sul valore degli assets patrimoniali risulta invece maggiormente diffuso in
settori come quello bancario, con il 16,2% delle preferenze, o quello assicurativo con il 28,6%.
go società, denominazione marchi, insegne, marche secondarie, idee pubblicitarie, strategie
di marketing, garanzia prodotti, grafica, idee promozionali, sforzo di pubbliche relazioni,
design delle etichette, design dell’imballo, registrazione marchi, tecnologia, know-how produttivo, R&S, brevetti, segreti industriali, software, databases; cfr. Guatri L. (1998), Trattato
sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano, pp. 245 e ss. Riguardo al modo in cui i beni
immateriali partecipano alla produzione di ricchezza aziendale si confronti Massari M.
(1998), Finanza aziendale. Valutazione, Mc-Graw Hill, Milano, in cui si contrappongono i
criteri di valorizzazione del costo sostenuto e delle maggiori prospettive di reddito.
121
5.2. Il metodo reddituale
L’approccio valutativo conosciuto come reddituale si fonda sul seguente assunto: un’impresa vale in quanto è capace di produrre ricchezza nell’esercizio della propria attività. In questa prospettiva, il valore-stock
illustrato nelle pagine precedenti lascia il posto al valore-flusso quale migliore strumento di misurazione del valore intrinseco dell’impresa. I sostenitori dell’approccio dei flussi di risultato, di cui il metodo reddituale fa
parte, sono convinti che il principale value driver sia proprio il reddito
d’impresa nella sua duplice configurazione di reddito operativo o utile netto, a seconda che l’oggetto di valutazione sia l’intera impresa o il solo capitale economico.
L’impresa è nella prospettiva reddituale non più un contenitore di assets
con i quali produrre beni e servizi, ma quel particolare mix di risorse materiali, immateriali e umane capace di garantire nel lungo termine una consistente e duratura eccedenza dei ricavi sui costi di gestione: il reddito
d’esercizio. L’impresa vale in quanto produce risultati positivi i quali, apprezzati con strumenti adeguati, ne determinano il valore stand alone.
I flussi di risultato economico da misurare sono quelli prospettici
dell’impresa. I flussi passati costituiscono, invece, le basi su cui impostare la stima.
Sul piano operativo, determinare il valore dell’impresa con il metodo
reddituale, significa valutare i flussi di reddito atteso futuro tenendo conto
dell’orizzonte temporale in cui si verificheranno. Si tratta quindi di attualizzare o capitalizzare11 i flussi a un tasso che tenga conto del rischio operativo
e finanziario a cui l’impresa sottopone l’investitore12. Nella prassi il tasso di
attualizzazione/capitalizzazione è stimato servendosi del massimo rendimento ottenibile dagli investitori sul mercato finanziario con titoli azionari
simili, in termini di rischio operativo e finanziario (si tratta in sostanza del
costo-opportunità. Cattaneo 1999).
11
Il valore dell’impresa con il metodo reddituale è frequentemente ricavato con la sola operazione di attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Nel caso in cui si debba stimare il valore
atteso futuro dell’impresa i flussi reddituali situati tra il giorno 0 e il giorno t, nel quale la
stima deve essere effettuata, saranno capitalizzati, mentre i flussi di risultato successivi al
giorno t saranno attualizzati.
Il tasso utilizzato nelle operazioni finanziarie per spostare i capitali nel tempo è il medesimo, in quanto riflette il rischio operativo e finanziario a cui l’impresa sottopone i propri
investitori. Per un approfondimento sul tasso di attualizzazione si confrontino Renoldi A.
(1997), Valore dell’impresa, creazione di valore e struttura finanziaria, Egea, Milano, e Poli
A. (1997), Costo del capitale, Etas, Torino.
12
Per la scelta del corretto tasso di attualizzazione cfr. Capitolo 1 par. 8.1.
122
In letteratura (Massari 1998) si conoscono almeno due gruppi omogenei di metodi valutativi reddituali: quelli analitici e quelli sintetici. I
primi mirano a determinare il valore dell’impresa stimando in modo
dettagliato i costi e ricavi che questa avrà in futuro, in modo da quantificare il reddito operativo o l’utile netto prospettico di periodo. I secondi, invece, si servono del reddito medio normalizzato per determinare il valore d’impresa, dopo avere ipotizzato uno scenario di crescita
dell’impresa.
Talvolta la prassi ha preferito utilizzarli congiuntamente stimando in
modo analitico i primi esercizi futuri e lasciando ai metodi sintetici il compito di determinare il valore finale dell’impresa.
Un’ulteriore dimensione nell’illustrazione dei vari metodi reddituali è
quella dell’orizzonte temporale di valutazione.
Qualora si consideri l’impresa come “un organismo economico atto
a perdurare”(Zappa 1937, 1957) e quindi di fatto se ne ipotizzi la durata
illimitata, si potranno utilizzare algoritmi che tengano conto di questa
caratteristica.
In tali formule semplificate di stima il valore intrinseco dell’impresa è
determinato come il risultato di una serie matematica di redditi normalizzati
futuri lucrati dall’impresa (metodo sintetico).
La formula della rendita perpetua senza fattore di crescita sarà pertanto:
•
•
nella prospettiva assets side;
nella prospettiva equity side.
Se invece, come più spesso si orienta la prassi dei consulenti e soprattutto degli organi di giustizia, l’impresa è considerata capace di produrre
redditi solo in un orizzonte temporale limitato agli otto anni successivi alla
valutazione, allora il valore sarà determinato analiticamente solo dai flussi
reddituali stimati analiticamente.
Come si è accennato, spesso è necessario utilizzare entrambi gli algoritmi con l’accortezza di stimare analiticamente i flussi di reddito più vicini
e sinteticamente quelli prodotti dal giorno T, nel quale si interrompe la valutazione analitica, fino all’infinito. In questo caso si dovrà procedere a
un’operazione di normalizzazione del reddito.
Nella tab. 2 abbiamo tentato di incrociare la prospettiva di valutazione
e il grado di analiticità della stima del reddito per giungere alla determinazione dell’algoritmo di calcolo più appropriato rispetto alle esigenze del
valutatore e alle caratteristiche dell’impresa.
123
Fonte: nostra elaborazione
Orizzonte definito
Assets Side
Tabella 2 – La valutazione reddituale
Analiticità della stima
Analitico
Sintetico
Composto
124
n.d.
Orizzonte indefinito
Orizzonte definito
Prospettiva di Valutazione
Equity side
n.d.
Orizzonte indefinito
Elementi comuni alla valutazione delle imprese con il metodo reddituale
a prescindere dalla prospettiva assunta o dal grado di analiticità sono:
• una o più configurazioni di reddito: Reddito operativo (Ro) per la valutazione dell’impresa nel suo complesso e utile netto (UN) per quella
equity;
• un tasso di attualizzazione necessario per tenere conto della struttura
temporale dei flussi di reddito.
Il tasso di attualizzazione è calcolato in modo diverso a seconda si tratti
di valutare l’intera impresa o il solo capitale economico. Nel primo caso, si
misurerà il rendimento medio ponderato delle fonti di capitale raccolte a titolo di debito o di capitale proprio dall’impresa e necessarie a finanziarie il
progetto d’investimento arrivando a determinare il costo medio ponderato del
capitale (Wacc)13. Nel caso della valutazione del solo capitale economico, esso sarà invece pari al rendimento richiesto dagli shareholders per progetti di
investimento con profilo di rischio simile a quello considerato (re).
Una terza caratteristica comune è la necessità di normalizzare le
configurazioni di reddito sopra illustrate nel caso si valuti l’impresa in
un orizzonte temporale illimitato. Tale processo di normalizzazione si
rende necessario per non includere nella valutazione elementi gestionali
transitori che potrebbero in qualche modo rendere difficoltosa la stima
dell’effettiva capacità dell’impresa di produrre reddito. Un esempio
classico, in questo senso, è l’esclusione di poste straordinarie quali
plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e/o insussistenze14 dal calcolo del reddito normalizzato.
Una volta eseguite le operazioni di normalizzazione sarà possibile arrivare alla valorizzazione dell’impresa.
Con il metodo analitico, il valore dell’impresa nel suo complesso sarà
determinato, in un orizzonte limitato 0-T, operando la sommatoria dei flussi
13
Il costo medio ponderato del capitale è quello sostenuto dall’impresa per remunerare
i portatori di capitale: azionisti, creditori finanziari. Il rendimento è ottenuto ponderando i tassi delle singole fonti finanziarie sulla base della loro incidenza percentuale sulla
struttura finanziaria.
Wacc = re
E
D
+ rdr
D+E
D+E
dove re è il rendimento richiesto dagli azionisti, rdr è il rendimento richiesto dai portatori di
capitale di debito e i due rapporti esprimono i pesi, ovvero le percentuali di incidenza dei
mezzi propri [E / (D + E)], e delle fonti di debito [D / (D + E)] sulla struttura finanziaria.
14
Per una approfondita disamina sull’argomento della normalizzazione dei risultati reddituali si confronti Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano; e
Guatri L., Bini M. (2005), Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano.
125
di reddito operativo/utile netto stimati per i successivi T anni e opportunamente attualizzati al costo medio ponderato del capitale (Wacc).
In questo caso non è necessario procedere alla normalizzazione dei
flussi in quanto si ipotizza di essere in grado di misurare, anno per anno,
tanto le componenti ordinarie quanto quelle straordinarie di reddito. In tale
valutazione è trascurata la capacità dell’impresa di realizzare redditi oltre
l’anno T. Ciò costituisce un notevole limite del metodo che può essere rimosso introducendo quello che abbiamo chiamato metodo composto.
In tale metodo il valore del capitale economico di un’impresa è composto da due addendi. Il primo, è già noto al lettore essendo l’omologo di
quello precedentemente trattato, ed esprime il valore analitico dell’impresa
o del solo capitale economico nel periodo 0 – T, mentre il secondo costituisce il valore finale, o residuo, al termine del periodo di valutazione analitica. Quest’ultimo è ottenuto grazie all’utilizzo del metodo sintetico:
Il secondo addendo è determinato ricorrendo a una serie di ipotesi restrittive sull’evoluzione dell’impresa. Innanzitutto è ipotizzata la permanenza dell’impresa per un tempo indeterminato; viene inoltre postulato un
flusso reddituale normalizzato costante per gli anni che vanno da T all’infinito; si considera pure costante il grado di rischio a cui l’impresa sottoporrà l’investitore per il tempo avvenire, e quindi è utilizzato un tasso di
attualizzazione esso pure invariato.
Nonostante le vigorose semplificazioni necessarie per giungere a una
valutazione sintetica, tale metodo permette, al contrario di quello patrimoniale, di inserire elementi dinamici, quali le potenzialità future di risultato,
nella valutazione dell’impresa.
Sebbene il metodo reddituale costituisca un primo passo verso la determinazione del valore potenziale dell’impresa, esso soffre, per sua natura, di notevoli limiti di applicazione. Tanto il reddito operativo quanto l’utile netto, sono
126
configurazioni di risultato stimate nella logica di redazione del bilancio civilistico. L’utile netto è pertanto influenzato dalle politiche di bilancio relative agli
ammortamenti, alla svalutazione dei crediti, e ad altri costi non monetari. Inoltre utilizzando indicatori di performance di tipo contabile non è immediatamente apprezzabile la capacità dell’impresa di generare valore attraverso
l’attività operativa. Potrebbe infatti accadere che, sebbene i ricavi della gestione siano sistematicamente superiori ai costi d’esercizio, la natura finanziaria
degli stessi generi situazioni di squilibrio nelle manifestazioni finanziarie delle
operazioni di gestione. Solo analizzando i cash flows della gestione operativa e
complessiva, sarà possibile rimuovere questo importante limite, che rende il
metodo reddituale incerto nella determinazione del valore intrinseco.
Nel prossimo paragrafo saranno passati in rassegna i metodi finanziari che risultano più efficaci nella valutazione della ricchezza creata
dall’impresa.
A causa delle ipotesi restrittive e dei limiti oggettivi evidenziati qui
sopra, il metodo reddituale di stima del valore d’impresa non trova frequente applicazione nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.
Ciò prevalentemente perché il management che si appresta a effettuare
una fusione, una acquisizione o un altro atto di gestione straordinaria, ha
necessità di conoscere l’entità e la distribuzione temporale della liquidità su cui potrà contare. Ciò al fine di gestire i processi di integrazione
tra le imprese acquisite e, eventualmente, sostenere correttamente gli
obiettivi dell’impresa bidder e target.
Lo studio realizzato da AIAF/ASSI conferma la scarsa affezione dimostrata a questo metodo dai periti incaricati della misurazione del valore intrinseco per l’ammissione alle contrattazioni. Ciò può derivare dal fatto che dovendosi omologare ai metodi di valutazione utilizzati sui mercati finanziari,
dove il valore di una impresa viene stimato in una prospettiva outsider e nell’interesse dei potenziali investitori, l’impresa si vedrà costretta a utilizzare i
flussi monetari quale principale strumento di stima del proprio valore. Per gli
investitori, infatti, una azione vale in quanto capace di produrre flussi di dividendo e di capital gain, e non per l’utile d’esercizio che evidenzia in bilancio.
5.3. Il metodo misto. “Stock e flussi di valore”
Prima di passare alla stima del valore intrinseco basata sui flussi finanziari è necessario introdurre i metodi misti nei quali il valore patrimoniale,
semplice o composto che sia, si somma all’avviamento dell’impresa. I metodi misti sono, di fatto, metodi di stima del valore intrinseco relativi. In-
127
fatti il valore dell’avviamento viene calcolato come sommatoria dei flussi
di extra-profitto lucrati dall’impresa rispetto ai concorrenti a parità di stock
di patrimonio netto rettificato.
In letteratura si distinguono due gruppi di metodi misti15: quelli cosiddetti puri (tra cui la media algebrica) e quelli che utilizzano l’Excess Earning Method, o relativi.
Il più immediato e semplice modo di determinare il valore intrinseco
dell’impresa tenendo presente sia stock di assets disponibili, sia potenzialità di reddito, è il metodo della media algebrica. Con questo metodo l’assets side value di un’impresa è determinato come media del valore patrimoniale e di quello reddituale sintetico.
In esso il capitale investito netto (CIN’) è sommato al valore della rendita perpetua derivante da un reddito operativo (Rot) sottoposto all’ipotesi
di assenza di crescita (steady state)16, e poi il tutto diviso per due. Volendo
esprimere il valore dell’impresa così determinato in funzione del capitale
investito netto (CIN’) e dell’avviamento (A) ricaveremo:
dalla quale è possibile determinare il valore dell’avviamento o goodwill che
sarà:
Al metodo della media aritmetica si è affiancato, con il trascorrere degli
anni un altro gruppo di tecniche basate sul concetto di Excess of Return
(Viel, Bredt e Renard 1986; Fishman, Pratt, Griffith e Wilson 1992). In esse
l’avviamento è stimato come sommatoria degli extra-rendimenti lucrati
dall’impresa e non dai suoi concorrenti di settore, o dalle imprese comunque ritenute simili. Si tratta di una valutazione relativa che, insieme a
15
Il metodo misto è apparso per la prima volta negli Stati Uniti, al contrario di quanto generalmente sostenuto negli ambienti della finanza aziendale. Il metodo si deve precisamente a
Viel J., Bredt O., Renard M. (1986), La valutazione delle aziende, Etas, Milano.
16
Si tratta di una serie matematica che per t che va da 1 all’infinito converge al valore
Ro1/wacc; nel caso in cui i redditi futuri siano stimati ricorrendo al reddito operativo normalizzato la serie convergerà, invece, al valore Ronorm/wacc.
128
quella dell’Economic Value Added, prepara e favorisce la diffusione delle
tecniche di relative valuation.
I drivers di valore per la stima del capitale economico dell’impresa sono costituiti da: stock di risorse (assets) a disposizione dell’impresa e da
capacità differenziali, ovvero competenze nella gestione operativa che rendono l’impresa più redditizia per l’azionista e quindi giustificano una maggiorazione di valore rispetto al solo valore patrimoniale. Formalmente la
valutazione mista, con evidenziazione separata dell’avviamento, si esegue
applicando il seguente algoritmo:
dove:
• K’j = patrimonio netto rettificato dell’impresa j al tempo 0;
• Rjn = utile netto dell’impresa j per ogni anno n che va da 0 a N;
• isett = rendimento normalizzato di imprese del medesimo settore dell’impresa j o rendimento di imprese simili.
rappresenta, invece, l’extra rendimento netto cumulato, lucrato per N anni
dall’impresa j e attualizzato al tempo 0 servendosi di un tasso di attualizzazione pari rj.
L’avviamento, valore attuale degli extra-rendimenti futuri, è calcolato
in ottica equity side e permette di determinare la ricchezza differenziale
creata per i soli azionisti della società.
Se volessimo invece determinare l’extra-rendimento garantito a tutti i
portatori di capitale sarebbe necessario calcolare il più noto Economic Value Added (EVA)17 o metodo misto in “versione finanziaria”18 (Guatri 1998,
17
Sul tema dell’Economic Value Added la dottrina si è soffermata fin dal 1991 anno nel
quale G. Bennett Stewart III illustrò il metodo nel famoso volume: Stewart G. B. III (1991),
The Quest for Value: The EVATM Management Guide, Harper Collins, New York. Si ricordino tra i primi contributi in lingua italiana sul tema Massari M. (1995), “Il metodo misto di
valutazione delle imprese. Una riformulazione aderente alla moderna finanza aziendale”,
Finanza marketing produzione, n. 3.
18
L’appellativo “versione finanziaria” è dovuto al fatto che nel calcolo dell’EVA alcune imputazioni sostanziali quali gli accantonamenti ai fondi imposte, svalutazione crediti, obsolescenza magazzino, garanzia e i ratei e risconti in genere sono determinati secondo il criterio della cassa e
non con quello della competenza economica dell’esercizio. Cfr. Guatri L. (1998), Trattato sulla
valutazione delle imprese, Egea, Milano, pp. 455 e ss.
129
p. 291), con il quale si stima il valore economico aggiunto dell’impresa nel
suo complesso. L’EVA è uno strumento di valutazione molto impiegato
nella stima del valore intrinseco di grandi imprese poiché permette la determinazione del valore aggiunto annuale sulla base del quale sono realizzati i piani di incentivo rivolti ai managers delle società. In questo caso il
valore dell’impresa sarà determinato come segue:
e quindi:
in cui:
• CIRj = Capitale investito nell’impresa j da tutti gli investitori;
• EVAjn = Economic Value Added dell’impresa j nel periodo n;
• Nopatjn = Net Operating Profit after Tax ovvero reddito operativo al
netto delle tasse dell’impresa j nel periodo n;
• Wacc = costo medio ponderato del capitale normalizzato per imprese
simili o dello stesso settore;
• Waccj = costo medio ponderato del capitale per l’impresa j;
• MVA = sommatoria per n che va da 0 al N degli EVA dei singoli anni.
Sebbene i metodi misti siano i primi a inserire una pluralità di aspetti
nella valutazione dell’impresa, essi hanno visto la loro applicazione ridursi
nel tempo principalmente a causa di alcune difficoltà di calcolo del saggio
di rendimento normalizzato di settore o di imprese simili, ma soprattutto
per la sempre minore rilevanza dell’entità degli assets per la riuscita dei
progetti imprenditoriali.
Lo studio di AIAF/ASSI testimonia la scarsa affezione degli operatori
al metodo per l’applicazione a imprese industriali (1,6% nel 1999 e 5% nel
2002). I dati mostrano anche una forte riduzione nel suo utilizzo per il settore bancario e assicurativo, campo nel quale invece il 23% degli intervistati dichiarava di usarlo nel 1999. Per la verità la riduzione è da attribuire
alla cresciuta importanza attribuita al metodo dell’embedded value, o valore
incorporato, utilizzato dalle imprese assicurative e bancarie per stimare il
valore reale delle attività (polizze) in portafoglio.
Ulteriori approfondimenti sui metodi misti non aggiungerebbero molto
alla nostra panoramica. Unica considerazione aggiuntiva degna di nota è
forse il fatto che questi metodi non si adattano alla valutazione delle imprese industriali. La valutazione patrimoniale-reddituale, inoltre, si presta poco
all’impiego nelle operazioni di finanza straordinaria e ciò in quanto in essa
130
vengono trascurati i drivers di valore cari all’investitore finanziario: flussi
monetari ritraibili dall’investimento (dividendo e capital gain). Per la valorizzazione di questi ultimi sembra che il metodo di stima del valore intrinseco di maggior impiego sia quello finanziario, che illustreremo nel prossimo paragrafo.
5.4. Il metodo finanziario. Il valore del tempo e dei flussi finanziari
Le tecniche di misurazione del valore basate sulla stima dei flussi finanziari generati e poi distribuiti dalle imprese sono molto articolate e vanno generalmente sotto il nome di Discount Cash Flow methods (DCF). Come già per i
metodi patrimoniali e reddituali, anche nel caso dei metodi finanziari, insieme
agli strumenti di stima del valore del complesso delle attività d’impresa, coesistono quelli volti ad apprezzare il valore del solo capitale netto.
L’indagine condotta da AIAF mette in risalto l’importanza del metodo
dei flussi nel panorama dei metodi di valutazione delle imprese rilevando
che nel 1999 il 37,5% delle imprese industriali inserite nel campione dichiara di servirsene per il calcolo del valore. È necessario quindi conoscerne gli aspetti principali.
Similmente ai metodi reddituali, i metodi finanziari si propongono di
valutare il potenziale di creazione di valore dell’impresa e non tanto la dotazione di risorse e competenze necessarie all’accrescimento dello stesso.
La differenza principale rispetto ai metodi illustrati nei paragrafi precedenti
risiede nella prospettiva di valutazione finanziaria, volta a stimare
l’entità dei flussi di cassa positivi e negativi (entrate e uscite finanziarie),
generati e generabili dalla gestione aziendale. I dati da raccogliere sono
qualitativamente diversi da quelli utilizzati nella valutazione reddituale e
per questo muta anche l’origine degli stessi. Il documento principale da cui
si ricavano le informazioni sulla “vita finanziaria” dell’impresa è il rendiconto finanziario, in tutte le sue diverse configurazioni. Il conto economico,
compilato seguendo il principio della competenza, non sarà più idoneo a
illustrare la dinamica finanziaria dell’impresa e a fornire i dati per la valutazione. Da esso, però, si parte per ricavare le configurazioni di flussi di
cassa che ci serviranno per la stima del valore dell’impresa. Lo stato patrimoniale continuerà a essere documento importante per la comprensione
della dinamica dei flussi finanziari. In particolare saranno necessari due
prospetti patrimoniali per determinare le variazioni subite dalle vari gruppi
di investimenti e finanziamento all’interno del periodo di osservazione che
dovranno essere inserite nel rendiconto.
131
Una volta illustrate le fonti dei dati da raccogliere è importante stabilire
che cosa sia necessario per il calcolo del valore d’impresa con il metodo
finanziario.
A questo proposito sono rilevanti:
• la tipologia dei flussi di cassa (quali),
• l’entità dei flussi finanziari di risultato dell’impresa (quanti);
• la distribuzione temporale degli stessi (quando);
• il valore finanziario del tempo;
• il rischio di errore nella determinazione dei flussi stessi.
Valore finanziario del tempo e rischio di errore nella stima dei flussi
sono fattori rilevanti nella determinazione del tasso di attualizzazione con il
quale i capitali saranno spostati nel tempo19.
Il metodo finanziario ha una articolazione di configurazioni di calcolo del valore dell’impresa complessa, al pari di quella vista per i metodi reddituali.
Anche in questo caso la scelta dell’algoritmo di calcolo dipenderà dall’oggetto di analisi (impresa/capitale netto) e dal grado di analiticità scelto
nella valutazione. In ragione di quest’ultima dimensione potranno esser
eseguite valutazioni sintetiche, analitiche o composte dei flussi di cassa ritraibili dalla gestione aziendale.
Partendo dal modello composto, il valore generale di una impresa con il
19
In letteratura il tasso di attualizzazione è normalmente scisso in due componenti che sono
legate rispettivamente al valore finanziario del tempo e al rischio dell’investimento. R = rf +
Premio per il rischio. La prima componente è il tasso rf che è il corrispettivo riconosciuto all’investitore per la rinuncia al consumo. Ciò a causa del valore finanziario del tempo per il
quale due capitali nominalmente identici, ma disponibili in istanti diversi, hanno valore attuale diverso. Infatti colui che ha la disponibilità del capitale al tempo 0 può impiegarlo senza alcun rischio e ottenere, alla fine del periodo, la restituzione del capitale insieme al rendimento rf come compenso per la rinuncia al consumo immediato. In finanza aziendale si
usa stimare il tasso di interesse per la rinuncia al consumo con il tasso privo di rischio (rf)
lucrato dagli investitori in titoli di stato a breve termine. La seconda componente del rendimento richiesto da un investitore per cedere il capitale all’impresa è il premio per il rischio
al quale il soggetto viene sottoposto. Ora, il rischio è determinato dallo scostamento del valore effettivo di una variabile casuale da quello atteso. In questo caso quindi l’investitore
subisce il rischio di vedere dei flussi di cassa futuri diversi, per entità e manifestazione temporale, da quelli previsti (attesi) e sui quali egli basava le proprie decisioni di investimento.
Il premio per il rischio è proprio il rendimento differenziale concesso all’investitore per indennizzarlo dell’incertezza che si assume con l’investimento. Per la stima di questa seconda
importante componente del rendimento azionario gli studiosi hanno sviluppato alcuni modelli teorici tra i quali il più famoso, e tuttora utilizzato, è il Capital Assets Pricing Model;
Sharpe W. F. (1964), “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk”, Journal of Finance, n. 19, pp. 425-442; e Lintner J. (1965), “The Valuation of
Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, 47 (1), pp. 13-37.
132
metodo dei flussi finanziari può essere determinato genericamente con
l’ausilio dell’equazione che segue:
dove:
• FCt = Flussi di cassa di periodo t;
• r = tasso di attualizzazione che tengono conto del rischio dell’investimento;
• VT0 = valore attuale del valore terminale o finale;
• VTt = valore terminale del titolo al tempo T.
In questa espressione il primo addendo è costituito dalla sommatoria
dei flussi di cassa stimabili analiticamente attraverso il ricorso a documenti
finanziari prospettici, mentre il secondo addendo stima il valore residuo
dell’impresa per i flussi che genererà dall’anno T all’infinito, o almeno
nella sua vita utile. Quest’operazione permette di stabilire quanta parte del
valore d’impresa sia attribuibile ai flussi finanziari più vicini nel tempo, e
quindi analiticamente prevedibili, e quanta parte sia, invece, imputabile al
valore terminale (terminal value), frutto, quest’ultimo, di una stima sintetica dei flussi più lontani.
Il valore finale, o terminale (VTt), sarà determinato con algoritmi sintetici basati sulle rendite perpetue con o senza fattore di crescita. In questo
modo esso sarà:
in caso di flussi costanti perpetui;
•
FCT +1
in caso di flussi distribuiti con fattore g.
r−g
dove g = fattore annuale di crescita dei flussi di cassa distribuiti.
Per arrivare a determinare il valore attuale di VTT, VTo, sarà poi necesFCT +1
sario attualizzare VTT per T anni. VT0 =
oppure con flussi crer (1 + r ) T
FCT +1
scenti costanti VT0 =
.
( r − g )(1 + r )T
Una volta enunciate brevemente le modalità di calcolo comuni a tutti i
metodi finanziari, nei paragrafi che seguono si illustreranno, le variabili
dalla cui combinazione scaturirà ora il valore dell’impresa, ora quello del
solo capitale netto.
•
VTT =
Le configurazioni di flussi finanziari utilizzabili nella stima del va133
lore intrinseco. Il valore d’impresa è, come abbiamo detto, determinato
dalla sommatoria dei flussi di cassa attesi futuri, attualizzati. Una prima necessità è quella di individuare la natura di tali flussi finanziari.
Una premessa è fondamentale: i flussi sono stimati al loro valore nominale o reale e non contengono in alcun caso correzioni necessarie per tenere
in considerazione il rischio di errore nella stima. Il rischio, infatti, sarà inserito nella formula del valore allorquando si andrà a determinare il tasso con
cui attualizzare i flussi nominali o reali ora identificati.
Natura ed entità dei flussi finanziari generati dall’impresa. A seconda della prospettiva dalla quale si affronta con metodi finanziari la valutazione dell’impresa è necessario introdurre e poi definire concetti sostanzialmente diversi di flussi finanziari.
Se l’ottica dalla quale si osserva il valore è quello dell’impresa nel suo
complesso, i flussi che saranno oggetto di analisi sono tutti quelli generati
per dalla stessa con le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria e disponibili per i finanziatori. Poco importa la destinazione che essi prenderanno, se saranno appannaggio dei portatori di capitale di rischio o dei creditori. L’impresa vale per la sua capacità di generare flussi finanziari netti
considerati nel loro valore assoluto.
Se l’obiettivo è quello di valutare il valore del capitale economico
d’impresa nella prospettiva degli azionisti, i flussi considerati saranno
quelli disponibili per tale categoria di soggetti.
Quali sono le possibili misurazioni di tali flussi?
Il Free Cash Flow to Firm nella valutazione assets-side. La dottrina
(Damodaran 1994, 2001 e 2006; Massari 1998) individua nel Free Cash
Flow to Firm (Flusso di cassa disponibile per l’impresa o FCFF), il principale strumento tecnico di stima dei flussi generati complessivamente dall’impresa e lo definisce come: “il flusso di cassa disponibile per la remunerazione di tutti i soggetti portatori di risorse monetarie al netto delle sole
spese in conto capitale, delle variazioni del Capitale Circolante Netto e
delle poste non monetarie” (Damodaran 2001, p. 600).
Il FCFF è determinabile tanto direttamente che indirettamente, ovvero
partendo dal Free Cash Flow to Equity (FCFE). Non abbiamo ancora parlato del flusso di cassa disponibile per l’azionista quindi definiremo il
FCFF solo nella prospettiva diretta come:
FCFF = Earning before interests & tax (1 – t) + Cosi non monetari +
– Spese in conto capitale – Variazioni del capitale circolante non cash
134
Si tratta di una configurazione particolare di un flusso finanziario generato della gestione operativa. La base è costituita dall’EBIT (Earning Before interest and Taxes) un reddito operativo al lordo degli oneri finanziari
generati dal debito contratto dalla società e delle imposte. Da esso viene
sottratta indirettamente la parte relativa all’imposizione fiscale e ciò è fatto
moltiplicando il tutto per (1 – tc). Dove tc rappresenta l’aliquota fiscale a cui
l’impresa è soggetta. EBIT (1 – tc) è quindi il reddito operativo al lordo
delle imposte e al netto delle imposte.
Tale configurazione di reddito operativo è particolarmente adatta alle
esigenze di calcolo, in quanto comprende i flussi di cassa destinati ai creditori e allo Stato. Essendo, però, l’EBIT calcolato con il criterio della
competenza si rende necessario aggiungervi i costi non monetari.20 Otterremo così un EBIT che potremmo chiamare finanziario e che risulta essere
il reddito operativo distribuibile ai finanziatori in assenza di uscite finanziarie per investimenti, previste nel piano industriale. Al contrario qualora il
piano industriale preveda degli investimenti in attività fisse o circolanti che
abbiano manifestazione finanziaria nell’esercizio, per arrivare al FCFF, sarà
necessario sommare algebricamente il saldo dell’area degli investimenti e
del capitale circolante. In questo modo è possibile avere ragionevole certezza dei flussi di cassa disponibili per remunerare i fornitori di capitale
presenti in impresa a qualunque titolo, dopo che si sono garantiti gli investimenti inseriti nel piano industriale.
L’attualizzazione dei FCFFt annuali porterà alla stima dell’intero valore dell’impresa, e non del solo patrimonio netto, secondo la formula che,
nella sua semplificazione estrema, potrebbe essere la seguente:
Il potenziale di creazione di valore di un’impresa è stimato analiticamente per i T anni successivi a quello della valutazione e i flussi sono
opportunamente attualizzati a un tasso pari al rendimento richiesto da
tutti i finanziatori dell’impresa e cioè al costo medio ponderato del capitale (Wacc).
Ai FCFF analitici stimati per T anni deve essere aggiunto il Valore
20
Si tratta di tutti quei costi che non hanno avuto manifestazione finanziaria nel momento di
valutazione dell’impresa. Damodaran A. (2006), Finanza aziendale, II ed., Apogeo, Milano,
aggiunge all’EBIT i soli ammortamenti che, sicuramente, costituiscono i principali costi non
monetari inseriti in bilancio, ma certo non sono i soli. È per questo che ci sembra più opportuno estendere il calcolo a tutta la categoria dei costi non monetari.
135
Terminale (VTo) determinato come valore attuale dei FCFF generati dall’anno T fino all’infinito. Tale valore, così come il valore finale utilizzato
nel metodo reddituale, è generalmente calcolato con l’ausilio delle rendite
perpetue.
Il flusso di cassa che dovrà essere inserito al numeratore della rendita
perpetua è il “FCFF steady state” (Perrini 2000) detto anche “no growth”
(Fanni Duemila), ovvero il flusso di cassa disponibile per l’impresa al netto
delle componenti straordinarie e di crescita che possono modificarne temporaneamente il valore.
in caso di flussi costanti perpetui;
•
FCFFT +1
in caso di flussi distribuiti che crescono con un fattore g.
Wacc − g
In conclusione, il valore totale dell’impresa con il metodo finanziario
basato sui free cash flow to firm è rappresentato da:
•
VTT =
La valutazione equity-side e i flussi finanziari per gli azionisti. Il
metodo finanziario può essere applicato anche nella stima del valore dell’impresa per azionisti e quindi nella valutazione dell’impresa detta equityside (Massari 1998; Perrini 2000).
La prassi e la teoria hanno sviluppato moltissime configurazioni di
flussi di cassa disponibili per gli azionisti. I più noti e utilizzati sono: il free
cash flow to equity (FCFE) e il flusso di dividendo (DIV) o, nella sua versione unitaria, il Dividend per Share (DPS).
Il free cash flow to equity è il flusso di cassa “che un’impresa può permettersi di distribuire agli azionisti sotto forma di dividendi” (Damodaran
2006). Esso è in sostanza il flusso disponibile per gli azionisti dopo che sono stati garantiti gli investimenti inseriti nel piano industriale (Area A), il
pagamento della quota capitale sul debito contratto dall’impresa, al netto di
nuove emissioni, nonché gli interessi maturati su tale debito (Area B). Anche la gestione del circolante va a incidere sul FCFE, diminuendolo, ogni
volta che la variazione del “CCN non-cash” è positiva (Area C) aumentandolo in caso contrario. Sempre positivo, invece, il contributo dell’ammortamento (Area D), in quanto recupero di un costo non monetario. Al pari
del FCFF in quest’ultima area si possono inserire anche gli altri costi non
monetari dell’impresa quali, per esempio, gli accantonamenti, le svalutazioni di crediti ecc.
136
Sinteticamente quindi il free cash flow to equity può essere determinato
come la somma algebrica fra l’utile netto e il saldo delle 4 aree sopra menzionate.
FCFE = Utile netto ± A ± B ± C + D
dove:
• A = spese in conto capitale per gli investimenti inseriti nel piano industriale;
• B = saldo delle operazioni di accensione/rimborso di finanziamenti di
terzi;
• C = variazione del Capitale circolante netto non cash;
• D = ammortamenti.
Utilizzando il FCFE il valore del capitale netto dell’impresa sarà dato, al
pari del FCFF, dalla somma dei flussi analitici attualizzati e del valore finale
o terminale al tempo T, anch’esso attualizzato alla data della valutazione:
dove FCFEt sono i free cash flow to equity stimati analiticamente nel primo
periodo; re è il tasso di attualizzazione per progetti di investimento dal profilo di rischio simile a quelli dell’impresa valutata; FCFE steady è il flusso
di free cash flow utilizzato nel calcolo del valore terminale (VT0) che si
ipotizza disponibile perpetuamente dall’anno T fino all’infinito.
Un’altra configurazione di flussi di cassa disponibili all’azionista, per
la verità più restrittiva rispetto a quella del FCFE, è quella presentata nel
Dividend Discount Model. Ai FCFE si sostituiscono i flussi di dividendo,
mentre il tasso di attualizzazione che deve incorporare il rischio sopportato
dall’azionista resterà re, ovvero il costo del capitale azionario.
Il tasso di attualizzazione dei flussi finanziari e il rischio. Nell’ambito della valutazione con il DCF, l’operazione di attualizzazione è necessaria per rendere omogenei i flussi di cassa naturalmente distribuiti sull’asse temporale del periodo di osservazione. Il tempo non è un variabile
neutra nei confronti del valore dell’impresa in quanto colui che ha disponibilità di un capitale al tempo 0 può impiegarlo e ottenere, alla fine del periodo, il capitale stesso aumentato almeno degli interessi per la rinuncia al
consumo se non anche un indennizzo per il rischio dell’investimento. È
quindi necessario comprendere come spostare i flussi di cassa nel tempo e
soprattutto quale tasso di attualizzazione utilizzare.
In generale colui che dispone del capitale e lo investe temporaneamente
137
sarà disposto a farlo solo se adeguatamente compensato. Quantomeno, il
soggetto richiederà una remunerazione per la rinuncia alla disponibilità del
proprio denaro, e quindi al potenziale consumo, oltre chiaramente alla restituzione del capitale iniziale.
La dottrina ha utilizzato per stimare il tasso di attualizzazione il concetto di costo-opportunità andando a indagare quali impieghi alternativi
possa avere il capitale prestato all’impresa.
Nel caso in cui si operi in condizioni di certezza il costo opportunità nel
cedere del capitale è costituito dal rendimento di investimenti il cui risultato
sia certo. La prassi è solita stimare questo tasso con il risk free rate (rf), ovvero il saggio di remunerazione di titoli di Stato a breve termine.
Se invece l’investimento presenta aspetti di incertezza sia nella restituzione
del capitale, sia dei flussi di rendimento ottenuti come compenso, il costo opportunità, e quindi il tasso di attualizzazione, dovrà tenere conto di questa nuova variabile: l’incertezza appunto. Quest’ultima nasce dall’incapacità di prevedere correttamente quello che succederà in futuro. È una condizione naturale di
ogni soggetto economico, anche razionale, che si trovi a operare con grandezze
che hanno una loro manifestazione futura. L’impossibilità di prevedere che cosa accadrà in futuro genera il rischio (Damodaran 2001, p. 49; Brealey, Myers
e Sandri 2003)21. Questo non ha, per sua natura un’accezione solo negativa, ma
è conseguenza dello scostamento tra l’accaduto e il previsto.
21
Il rischio si manifesta per cause esterne e interne all’investimento stesso. In finanza aziendale si distinguono due categorie di rischio:
•
sistematico;
•
specifico.
Il primo è dovuto a variabili non controllabili dal singolo investitore ma che influenzano
in modo determinate il risultato atteso. Nel caso specifico dell’impresa il rischio sistematico
può essere la variazione delle condizioni di mercato vigenti, l’incremento generalizzato dei
prezzi delle materie prime, la variazione del tasso di interesse vigente sul mercato dei capitali.
Esiste poi un rischio specifico dell’impresa principalmente imputabile a circostanze operative o
finanziare tipiche dell’impresa e che impediscono all’investitore di raggiunge il risultato sperato. Nell’ottica dell’investitore finanziario però il rischio specifico può essere abbattuto e
quindi eliminato avvalendosi delle tecniche di diversificazione del rischio. Per questo motivo
gli studiosi di finanza non sono propensi a riconoscere alcun premio per il rischio specifico
sostenuto in un certo investimento, nel caso in cui l’investitore possa diversificare le fonti di
rischio specifico, abbattendolo. Nell’ambito della valutazione delle imprese e nei panni di un
qualunque investitore interessato all’investimento nel capitale, la differenza tra risultato atteso
ed effettivo può essere imputata a diversi fattori o fonti di rischio. Per esempio un risultato può
essere disatteso a causa di improvvise modificazioni del mercato, della situazione politica,
della congiuntura economica ecc. Inoltre vi possono essere cause interne all’impresa di cui si
sta valutando il capitale che in qualche modo possono allontanare il risultato atteso da quello
effettivo. Normalmente la dottrina le raccoglie in due classi: operativo, finanziario. Per un approfondimento sulle fonti di rischio si veda Cattaneo M. (1999), Manuale di finanza aziendale,
Il Mulino, Bologna.
138
Il costo opportunità, da utilizzare come tasso per l’attualizzazione dei
flussi di cassa provenienti da investimenti rischiosi, dipende dalla natura
della valutazione:
• nel caso in cui si stia valutando quel particolare investimento che è l’intera impresa, il costo-opportunità sarà costituito dal massimo tra i rendimenti medi ponderati richiesti dai soggetti che apportano le fonti di finanziamento. In finanza tale rendimento è stimato prevalentemente dal costo
medio ponderato del capitale di cui parleremo diffusamente più sotto;
• nel caso si stia determinando, invece, il valore del solo capitale economico, il costo-opportunità è stimabile dal massimo tra i rendimenti ottenibili dal prestatore del capitale per investimenti che hanno profilo di
rischio simile a quello dell’impresa valutata.
Proprio per tenere conto di queste diversità, la dottrina ha sviluppato
due configurazioni di tasso di attualizzazione, che si utilizzano nella prospettiva assets o equity side della valutazione: il costo del capitale aziendale
e il costo del capitale netto.
Il costo medio ponderato del capitale nella valutazione assets-side.
Se i flussi che si debbono scontare sono relativi all’impresa nel suo complesso, in altre parole se stiamo stimando i FCFF, sarà necessario attualizzarli con il tasso di rendimento richiesto da tutti i soggetti portatori di risorse all’impresa. Tecnicamente si tratterà di calcolare il rendimento delle singole fonti di finanziamento dell’impresa e ponderarlo con l’importanza che
tali fonti hanno all’interno della sua struttura finanziaria.
Ciò porterà come abbiamo già visto in precedenza alla determinazione del costo medio ponderato del capitale, Weighted Average Cost of
Capital (Wacc).
In termini formalizzati e nell’ipotesi semplificata di una struttura finanziaria composta da azioni ordinarie e debiti:
Wacc = re
E
D
+ rdr
D+E
D+E
dove re è il rendimento richiesto dagli azionisti di cui parleremo in seguito,
rdr è il rendimento richiesto dai portatori di capitale di debito, al netto del
beneficio fiscale22 e i due rapporti esprimono i pesi, ovvero le percentuali di
22
Il costo reale del debito per l’impresa è inferiore a quello pagato nominalmente alla banca
o agli obbligazionisti in quanto gli interessi passivi costituiscono oneri deducibili almeno ai
fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche. In verità l’impresa si troverà a pagare
un costo del debito reale pari a Rdn (1 – Tc) = Rdr. Per approfondimenti sull’impatto della
139
incidenza dei mezzi propri, E / (D + E), e delle fonti di debito D / (D + E)
sulla struttura finanziaria.
Per le ragioni illustrate sopra il costo del capitale è tendenzialmente inferiore al costo del capitale netto. Ciò è dovuto al minore rischio a cui sono
sottoposti i creditori dell’impresa in quanto essi hanno un privilegio sui
flussi di cassa rispetto agli azionisti e allo Stato. Il minor rischio giustifica
un minor rendimento richiesto, ciò porta rdr a essere sistematicamente inferiore a re e quindi Wacc a essere minore o uguale a re.
Implicitamente abbiamo enunciato una relazione di tipo crescente che
lega il rischio al rendimento di un titolo. Secondo questa relazione per sopportare rischi maggiori l’investitore razionale richiederà rendimenti più alti
e viceversa.
Il costo del capitale azionario nella valutazione equity-side. La seconda configurazione di tasso di attualizzazione impiegata nella determinazione
del valore del capitale proprio di un’impresa è quella del costo del capitale
azionario (ke o re). Tale costo è stimato servendosi di alcuni modelli creati
dagli studiosi fin dagli anni Sessanta. Questi studiano la relazione rischiorendimento e sono conosciuti con gli acronimi di CAPM (Capital Asset Pricing Model, Sharpe 1964, Lintner 1965) e APM (Arbitrage Pricing Model).
Secondo Sharpe (1964) e Lintner (1965), nel CAPM, il costo del capitale azionario è legato al rischio sostenuto da una relazione lineare crescente che risponde alla seguente equazione:
re = k e = rf + β ( rm − rf )
dove rf è il rendimento per i titoli privi di rischio (risk-free), il beta23 (β) è
normativa fiscale sul valore del capitale si confrontino Modigliani F., Miller M. H. (1963),
“Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, American Economic Review, 53, 3; Miller M. H. (1977), “Debt and Taxes”, Journal of Finance, n. 32; Damodaran
A. (2001), Finanza aziendale, Apogeo, Milano.
23
Nella sua misurazione più comune il Beta di un titolo può essere definito come il rapporto
tra la covarianza del rendimento del titolo con il rendimento del mercato e la varianza dei
rendimenti del mercato stesso. Formalizzando:
Covim σ iσ m
β=
=
Varm
σ m2
Abbiamo già incontrato il Beta in occasione della presentazione degli strumetni comuni
alla misurazione del rischio nel Capitolo 1. Adesso però la sua utilità risulta evidente nella
stima della componente di costo del capitale proprio dell’impresa. La letteratura identifica
tre metodi principali per la determinazione del Beta: il regression beta (quello presentato più
sopra), il bottom-up beta (basato sulle grandezze fondamentali d’impresa e sulla leva finan-
140
l’indice di sensibilità del rendimento del singolo titolo alle variazioni del rendimento del mercato azionario nel suo complesso e (rm – rf) è il premio richiesto dall’investitore per l’impiego in azioni invece che in titoli non rischiosi.
In altre parole il rendimento del capitale azionario sarà legato alla remunerazione del titolo privo di rischio, al premio per il maggior rischio
connesso all’investimento nel portafoglio azionario (rischio sistematico) e
anche al rischio specifico, operativo e finanziario, dell’impresa valutata.
Conclusa anche la stima del tasso di attualizzazione, abbiamo adesso tutti
gli elementi per individuare il valore dell’impresa e/o del suo capitale proprio.
Sono stati scelti, infatti, i flussi da analizzare (FCFF vs. FCFE), sono stati stimati i flussi prospettici (quanto), ne è stata determinata la struttura temporale
(quando). Abbiamo inoltre individuato il metodo per spostare i flussi nel tempo
servendosi, ora del costo del capitale azionario ora di quello totale.
Per quanto riguarda l’applicabilità del metodo, a prescindere dai limiti
che abbiamo evidenziato nel corso di questo lungo paragrafo, il metodo finanziario resta quello a nostro avviso più adeguato per unire il rigore logico
e metodologico delle applicazioni al pragmatismo delle informazioni che se
ne traggono per la stima del valore intrinseco.
5.5. La valutazione delle operazioni di M&A. L’impatto delle sinergie sul valore intrinseco delle imprese coinvolte
Il metodo finanziario costituisce, a oggi, il principale strumento di valutazione delle imprese sottoposte a operazioni di finanza straordinaria per
le caratteristiche di modularità di applicazione che lo contraddistinguono.
Grazie alla legge di conservazione del valore è possibile esprimere il
valore del complesso originato dall’operazione in funzione: del valore intrinseco delle imprese coinvolte in una operazione di M&A e di quello
creato dall’operazione.
Wbidder + target = Wbidder + Wtarget + Wacq
dove:
• Wbidder + target = è il valore del complesso post-operazione di M&A;
• Wbidder = è il valore stand-alone dell’impresa acquirente (bidder);
ziaria e operativa della stessa); l’accounting beta (nel quale gli utili d’impresa sono inseriti
in una regressione insieme a quelli ottenuti dalle imprese quotate o a realtà appartenenti allo
stesso settore). Per una disamina esaustiva sul tema della determinazione del beta confronta
fra tutti Caparrelli F. (1995), Il mercato azionario, McGraw-Hill, Milano; e Damodaran A.
(2001), Finanza aziendale, Apogeo, Milano, pp. 49-158.
141
•
•
Wtarget = è il valore stand alone delle imprese acquisita (target);
Wacq = è il valore generato con l’operazione di acquisizione.
In dottrina (Massari 1998; Zanetti 2000) la stima del valore dell’operazione è effettuata servendosi degli strumenti per la valorizzazione degli
investimenti. In quest’ottica l’operazione straordinaria è vista come un progetto di investimento indipendente capace di generare risultati in termini di
flussi di cassa incrementali.
Per questo si è soliti riferirsi al valore di acquisizione come alla sommatoria dei flussi di cassa incrementali generati a seguito dell’operazione di
M&A sia dalla bidder che dalla target. Ricavando dalla precedente:
Wacq = Wbidder + target – Wbidder – Wtarget
Massari (1998, p. 164) cita tra i flussi incrementali originati con l’operazione:
• flussi derivanti da fenomeni di collusione tra bidder e target postM&A;
• flussi incrementali riferibili alla gestione più efficace di talune funzioni
aziendali (principalmente basati su economie di scale e di scopo);
• flussi incrementali riferibili allo sfruttamento di elementi di carattere
incrementale.
Si tratta di flussi incrementali originati dallo sfruttamento di economie
di integrazione, di scala, o semplicemente attraverso la razionalizzazione
del complesso organizzativo post-M&A.
Nell’economia di questo scritto però l’acquisizione è vista come una
operazione che incide profondamente sulle imprese che ne sono interessate
andando a modificarne il valore intrinseco. Per questo motivo richiameremo la dottrina solo in quelle parti che riteniamo funzionali alla stima del
valore intrinseco delle imprese coinvolte nella M&A e rinviamo invece a
Massari e Zanetti (Zanetti 2000) per la trattazione teorica completa del valore delle acquisizioni e del prezzo di acquisizione.
Il nuovo valore generato è alla base del calcolo del prezzo massimo sostenibile nell’acquisizione della target. Il prezzo massimo che il compratore
sarà disposto a pagare per l’impresa target (Pmax_target) sarà quindi determinato da due componenti: il valore stand-alone dell’impresa (Wtarget) acquisita e quello generato dall’acquisizione (Wacq).
Pmax target = Wtarget + Wacq
Nella pratica il prezzo di acquisizione sarà determinato dalla forza re-
142
lativa di acquirente e venditore ed eventualmente dall’influenza esercitata
dagli operatori professionale che prendono parte a titolo di consulenti all’operazione.
L’operazione di stima del valore intrinseco delle imprese partecipanti
alle operazioni di M&A è più complessa di quella di determinazione del
prezzo di acquisizione a causa dell’incertezza nell’attribuzione del maggior
valore creato dall’operazione alla bidder o alla target. Il problema non si
pone nel caso in cui a seguito dell’operazione di acquisizione le due imprese si fondano dando luogo a un unico organismo che si apprezzerà dell’intero valore differenziale generato dall’operazione. Nel caso, però, le due
imprese non decidano la fusione e comunque nel corso dell’operazione di
acquisizione, gli analisti dovranno stimare il valore intrinseco della bidder e
della target cercando di comprendere ad appannaggio di quale delle due
imprese andrà il maggior valore creato.
Numerosi studi empirici dimostrano che anche precedentemente all’annuncio formale dell’operazione il prezzo dell’impresa target aumenta. Ciò farebbe intendere che il maggior valore creato dalla M&A
venga di fatto attribuito alla target tanto da far scindere gli elementi di
valutazione in due parti:
Wtarget post = Wtarget + x × Wacq
dove:
• Wtarget_post = è il valore intrinseco della target durante o dopo
l’operazione di M&A;
• Wtarget = è il valore iniziale della target;
• x = è la quota di valore generato dall’acquisizione di cui usufruirà la
target;
• Wacq = è il valore generato con l’operazione.
È tuttavia logico presupporre che alcuni vantaggi indiretti ricadano anche sulla bidder e che quindi il valore intrinseco di quest’ultima muti a seguito dell’operazione divenendo:
Wbidder post = Wbidder + (1 – x) × Wacq
dove:
• Wtarget post = è il valore intriseco della bidder durante/dopo l’operazione
di M&A;
• Wbidder = è il valore iniziale della bidder;
• (1 – x) = è la quota di valore generato dall’acquisizione di cui usufruirà
la bidder;
• Wacq = è il valore generato con l’operazione.
143
6. I metodi indiretti di valutazione del capitale economico delle
imprese
Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate alcune tecniche di stima
del valore intrinseco dell’impresa basate sul valore di imprese terze, simili
a quella oggetto di quotazione. Si tratta dei metodi di relative valuation
(Damodaran 2002; Guatri e Bini 2001, 2002; Guatri 1998), impiegati intensamente alla fine degli anni Novanta per la valutazione di un numero crescente di imprese. In essi il valore dell’impresa è stimato attraverso un
processo di comparazione con imprese simili quotate o con negoziazioni che hanno avuto per oggetto aziende simili.
Figura 3 – I metodi di relative-valuation
Metodi indiretti
Criteri empirici
Multipli di mercato
Approccio
delle società
comparabili
Approccio
delle transazioni
comparabili
Fonte: nostra elaborazione
Alcuni fattori esterni tra cui il boom di nuove tecnologie e l’istituzione di
mercati regolamentati24, creati ad hoc per realtà imprenditoriali con alte potenzialità di sviluppo, hanno favorito la diffusione di questi metodi, che uniscono
la praticità di calcolo al fatto che non necessitano di dati storici di mercato e
fondamentali sull’impresa valutanda. Come già accennato nel corso del capitolo, questi metodi hanno trovato principale applicazione nell’ambito delle
operazioni di finanza straordinaria, nei casi in cui i metodi tradizionali hanno
mostrato limiti evidenti di determinazione del valore e, infine, come metodi di
controllo di metodi diretti quali per esempio il DCF con il quale condividono i
drivers di valore25. Infine molti operatori della finanza applicata (Livian 2000),
24
Borsa Italiana SpA, Regolamento dei mercati organizzati da Borsa Italiana SpA del 16
dicembre 2002 approvato dalla Consob con delibera n. 14032 del 15 aprile 2003; inoltre
confronta l’art. 67 del D.lgs. 58/1998.
25
È possibile infatti ricavare da ogni singolo multiplo di mercato o degli utili la relazione
con le grandezze fondamentali che sono alla base del calcolo del DCF. In particolare è possibile esprimere i multipli in funzione dei flussi di cassa, del saggio di crescita degli stessi e
144
prevalentemente investment bankers americani o londinesi, ne hanno abusato
per risolvere il problema di indeterminabilità del valore per le imprese sprovviste di dati storici, e/o dalla formula di business non tradizionale.
La principale ragione del successo resta, però, la facilità di utilizzo
unita al fatto di essersi dimostrata utile strumento nelle fasi di valutazione
legate a operazioni di Leverage Buy Out (LBO) o Management Buy Out
(MBO)26 (Kaplan e Ruback 1995, 1996) e nel sanity check27 (Guatri e Bini
2002) operato da sponsor e global coordinator prima della definizione del
prezzo di collocamento. Grazie alla relative valuation infatti è possibile
stimare il prezzo massimo sostenibile da un investitore per sottoscrivere, in
primo collocamento, le azioni di un’impresa.
6.1. I multipli di mercato e delle transazioni comparabili. Una definizione
Per multiplo o moltiplicatore si intende il rapporto tra due grandezze
di natura diversa: il prezzo di mercato del capitale o dell’impresa (Enterprise Value) al numeratore, e una grandezza fondamentale al denominatore.
del tempo nel quale tali flussi si manifestano (tasso di attualizzazione Re o Wacc). Per la
relazione tra multipli e fondamentali d’impresa si confronti: Damodaran A. (2002), Valutazione delle aziende, Apogeo, Milano.
26
Per Leverage Buy Out si intende una operazione di acquisizione di un’impresa target resa
possibile da un ricorso accentuato alla leva finanziaria del soggetto acquirente. Per Management Buy Out si intende invece l’operazione di finanza straordinaria nella quale il management, assistito da finanziatori esterni o solo confidando sulla leva finanziaria di una newco appositamente costituita per l’operazione, assume il controllo dell’impresa target. Il management
buy out può essere realizzato sia con risorse finanziarie proprie sia con mezzi di terzi. In questo
ultimo caso si parla di MLBO. Per una disamina completa sull’argomento nella prospettiva
manageriale si confrontino Wright M. (1994), Management buy-outs: Issues and Evidence,
Dartmouth, Aldershot; e Wright M., Thompson S., Robbie K. (1992), “Venture Capital and
Management Led-leverage Buy-out: A European Perspective”, Journal of Business Venturing,
n. 7, pp. 47-71. Per la letteratura squisitamente finanziaria si vedano Kaplan S. N., Ruback R.
S. (1995), “The Evaluation of Cash Flow Forecasts: An Empirical Analysis”, Journal of Finance, n. 50, pp. 1059-1093; e Kaplan S. N. (1989) “The Effects of Management Buyouts on
Operating Performance and Value”, Journal of Financial Economics, n. 24, pp. 217-254.
27
Si tratta di una procedura applicata prevalentemente nell’ambito dei processi di valutazione per
la quale si utilizzano un metodo principale, generalmente il DCF e uno o più metodi di controllo.
In particolar modo nella quotazione di nuove azioni e nelle acquisizioni, strumento di controllo
del metodo principale è spesso quello dei multipli, poiché esso permette di associare a una valutazione totalmente interna, come quella del DCF, una mista con valori di mercato e fondamentali.
Nella quotazione il sanity check viene eseguito immediatamente prima della fissazione definitiva
del prezzo di emissione al fine di stimare qual è il prezzo massimo sostenibile dal mercato, in funzione delle caratteristiche di congiunturali, per l’impresa che viene proposta.
145
L’applicabilità del metodo dei multipli si fonda sull’ipotesi che i rapporti calcolati su imprese selezionate in un determinato campione omogeneo siano adeguati anche all’impresa oggetto di valutazione.
In letteratura (Guatri e Bini 2002) si distinguono due principali metodi di
determinazione dei prezzi probabili secondo la teoria della relative valuation:
• il metodo dei multipli di mercato;
• il metodo dei “criteri empirici”.
In questo paragrafo ci occuperemo solamente del primo e lo faremo distinguendo i seguenti metodi di calcolo:
• l’approccio delle società comparabili;
• l’approccio delle transazioni comparabili.
Una scelta così restrittiva nell’esposizione è giustificata dall’obiettivo
di illustrare sommariamente quelle tecniche di valutazione che permettono
la stima del valore intrinseco delle imprese, rinviamo pertanto a Guatri e
Bini (2002) e Massari (1998) per l’esame dettagliato di ciò che non tratteremo di seguito.
Al pari degli altri metodi di valutazione anche quello basato sui multipli può essere applicato in una prospettiva assets side o in una equity-side.
Come vedremo nel par. 6.4, le valutazioni dell’impresa nel suo complesso
utilizzeranno prevalentemente l’enterprise value rapportandolo alle grandezze fondamentali dell’impresa, mentre nel caso di valutazione del capitale proprio la variabile utilizzata sarà il prezzo dell’azione che sarà rapportato ora all’utile netto per azione, ora al cash flow per azione ecc.
6.2. Il Processo di calcolo di un multiplo generico
Prima di procedere è necessario comprendere quale sia la logica implicita nell’uso dei multipli. Il processo con cui si arriva alla determinazione
del relative value, attraverso l’applicazione a una grandezza d’impresa di
un multiplo calcolato su imprese comparabili, è rappresentabile come segue
(Damodaran 2002 e 2006; Massari 1998; Guatri e Bini 2002 e 2005):
1. si selezionano le società quotate, confrontabili con quella che stiamo
valutando, di cui siano noti i prezzi di mercato (Pc);
2. si sceglie una variabile Xc (di solito una misura di performance: Utile
Netto, Reddito Operativo, EBIT, EBITDA), che si ritiene probabile variabile esplicativa dei prezzi di mercato;
3. si calcola per ogni impresa del gruppo il rapporto tra il prezzo Pc e la
grandezza Xc;
4. si determina il valore medio dei singoli rapporti all’interno del gruppo;
146
5. si rileva la grandezza (Xj) prescelta per il confronto tra valutanda e
comparables;
6. si determina, supponendo che la relazione Pc / Xc valga anche per la
società oggetto di stima, il valore dell’impresa moltiplicando il multiplo
ottenuto dai comparables per la grandezza desunta dai dati dell’azienda
oggetto di valutazione.
È sufficiente, infatti, risolvere la seguente proporzione matematica
per ottenere l’enterprise value o l’equity value dell’impresa oggetto di
valutazione:
Pc : Xc = Pj : Xj
Il prezzo/enterprise value dell’impresa j si ottiene ricavando Pj dalla
proporzione sopra citata, ovvero:
Pj = Xj × Pc / Xc
In questo modo è possibile calcolare ogni tipo di multiplo, provenga esso da società comparabili o da negoziazioni omogenee a quella per la quale
si realizza la valutazione.
6.3. Come si scelgono le imprese comparabili
Rifacendosi ai lavori pubblicato da Guatri e Bini (2002 e 2005), a cui
peraltro rinviamo per maggiori dettagli, il grado di comparabilità viene determinato secondo i criteri illustrati di seguito28:
• l’appartenenza allo stesso settore;
• la dimensione;
• il rischio finanziario (grado di indebitamento);
• l’omogeneità effettiva, e non solo apparente, delle grandezze assunte a
base dei multipli;
• la governance;
• la trasparenza;
• lo stadio di vita dell’impresa;
• i modelli di business ecc.
È possibile notare come il settore sia considerato ancora il primo dei criteri
con cui selezionare le imprese simili. Un’altra grandezza tradizionale, la dimensione, si affianca al settore per ridurre il numero delle imprese considerate
28
Per un’analisi approfondita dei criteri di confrontabilità si veda Guatri L., Bini M. (2002), I
moltiplicatori nella valutazione delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano, pp. 27 e ss.
147
comparabili. Altri criteri selezionano ulteriormente le imprese in base al profilo
di rischio, alla struttura di governance e alla trasparenza nei confronti dei mercati finanziari. Queste ultime due caratteristiche sono complementari in quanto
permettono di valutare imprese che hanno una reputazione simile tra gli operatori dei mercati. Non meno importanti risultano poi essere l’omogeneità nel
ciclo di vita dell’impresa o la condivisione del modello di business.
A proposito della rilevanza degli uni o degli altri elementi, è possibile
notare come negli ultimi anni si sia accentuata l’attenzione agli aspetti legati ai mercati finanziari ovvero il profilo di rischio, la trasparenza e la governance, mentre siano divenuti meno rilevanti l’appartenenza allo stesso
settore e la dimensione. Ciò è in parte dovuto alla rivoluzione informatica
di fine millennio che ha reso possibile fornire beni e servizi fungibili con
strutture aziendali e modelli di business molto diversi.
6.4. “Il valore dei propri simili”. La scelta del multiplo di mercato
più adatto per il confronto con imprese simili
I multipli o moltiplicatori necessari alla determinazione del valore sono
scelti tra i molti disponibili innanzitutto in funzione dell’oggetto di valutazione. Essi possono essere infatti moltiplicatori adatti per la valutazione
dell’impresa in un’ottica equity-side, oppure possono permettere la valutazione in una prospettiva assets-side.
Nel primo caso al numeratore dei rapporti figurerà il prezzo di borsa o
la capitalizzazione, In altre parole il valore corrente del capitale (Guatri e
Bini 2002). Nel secondo caso al numeratore del rapporto troveremo l’investimento nell’attivo lordo (somma della capitalizzazione di borsa e del debito finanziario netto) ovvero quello che nel linguaggio finanziario è definito enterprise value29.
La scelta del multiplo è influenzata anche dalla rilevanza nell’attività
dell’impresa di alcune variabili fondamentali piuttosto che di altre. Gli studiosi (Guatri e Bini 2002 e 2005; Damodaran 2002 e 2006) distinguono generalmente tre o quattro gruppi di rapporti proprio in funzione degli aspetti
fondamentali che ogni gruppo di multipli mette in rilievo:
• multipli degli utili;
• multipli del valore di libro o di rimpiazzo;
29
Come ricordano Guatri L., Bini M. (2002), I moltiplicatori nella valutazione delle aziende,
Università Bocconi Editore, Milano, pp. 84 e ss., non esiste uniformità di vedute circa la definizione di enterprise value ed equity value (prezzo). Per il primo si contano quattro diverse configurazioni di calcolo, il secondo è stimato oltre che dal prezzo di mercato, da altre due variabili.
148
•
•
multipli dei ricavi;
multipli specifici di settore.
Ognuno di questi gruppi permette la valutazione di imprese dalle caratteristiche fondamentali implicite diverse. Per esempio si utilizzerà un
multiplo degli utili come il P/E quando l’impresa di cui si vuole stimare il
valore ha nel pay out, nel saggio di crescita (g) nel rendimento per
l’azionista (Re) i principali drivers per il confronto con le comparables. La
scelta delle imprese comparables è fortemente influenzata dalle variabili
fondamentali che restano latenti in ognuno dei moltiplicatori. Ecco perché
quando gli aspetti caratterizzanti dell’impresa da valutare sono i ricavi delle
vendite sarà possibile misurare il valore della stessa misurando l’EV/sales,
e ciò sulla base di variabili latenti quali: il ROS, la tassazione societaria tc, il
costo medio ponderato del capitale (Wacc) e le variazioni del circolante.
Analogamente è possibile scomporre qualsiasi multiplo per verificarne
il rapporto con le grandezze fondamentali rilevanti per la valorizzazione
dell’impresa.
Un’avvertenza è opportuna: essendo basata prevalentemente sui prezzi
di mercato di aziende comparabili, l’efficacia dei metodi in oggetto è fortemente influenzata dal grado di efficienza del mercato finanziario all’interno del quale i prezzi si formano. In occasione dell’elencazione dei
limiti del metodo torneremo sull’argomento.
Di seguito presentiamo succintamente i multipli più utilizzati e conosciuti in dottrina e nella pratica.
Il multiplo price/earning. Al gruppo dei multipli degli utili appartiene il
multiplo Price/Earning, o P/E, sicuramente il rapporto più “usato e abusato” nella valutazione relativa. Esso permette di stimare il valore di
un’impresa tenendo in considerazione gli aspetti di crescita, delle politiche
di dividendo e del rischio d’impresa.
Esso è determinato dal rapporto tra il prezzo di mercato di un titolo e l’utile
per azione. Indirettamente il P/E esprime il cut-off period di un investimento
azionario, in quanto il risultato può essere interpretato come il numero di anni
necessari a recuperare l’importo impiegato nell’attività valutata.
Premesso che il prezzo teorico di mercato di una attività finanziaria è
determinabile attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa ritraibili dal titolo come azionista della società, ovvero algebricamente e nella forma più
sintetica del modello di Gordon:
149
dove: Po è il prezzo di mercato dell’azione al tempo zero; DPSt è il dividendo per azione distribuito nel periodo t; re è il tasso di attualizzazione
che, come abbiamo visto nella valutazione con il metodo finanziario, deve
essere pari al costo del capitale netto. In ipotesi di assenza di arbitraggio,
tale prezzo teorico corrisponde a quello applicato nelle negoziazioni, il
prezzo effettivo di mercato.
Premesso ancora che il denominatore (E) è costituito dalla grandezza
denominata Earning per Share (EPS), l’utile netto per azione, possiamo rilevare che il valore del P/E dipende dal modello di crescita dei dividendi e
in particolare:
• in caso di assenza di crescita, il multiplo P/E corrisponde al reciproco
del costo del capitale di rischio per l’impresa;
• in presenza di opportunità di crescita, la formula sarà invece:
P Payout(1 + g )
=
E
re − g
Osservando questa uguaglianza e cercando di giustificare un valore
anomalo di un’impresa rispetto alle altre, esso può dipendere dal fattore g,
cioè dalla crescita attesa di utili e dividendi, dal pay-out, ossia dal tasso di
distribuzione degli utili, oppure dal costo del capitale azionario re.
Se, nell’ambito di un’operazione di quotazione o di negoziazione si ritengono importanti le politiche di pay-out, il saggio di crescita del dividendo e il rischio, misurato da re, sarà adeguato valutare l’impresa servendosi
di questo multipli degli utili.
Nel confronto con l’indice medio dei comparables, il P/E di un’impresa permette la valutazione delle capacità del manager finanziario della
stessa. La valutazione sarà positiva quando le azioni della sua azienda sono
vendute a un rapporto prezzo/utili maggiore di quello dei comparables. In
questo caso infatti gli investitori riterranno che la società presenti opportunità di crescita maggiori della media o che distribuisca maggiori quote di
ricchezza creata. Tuttavia il P/E può essere alto anche a causa di utili molto
bassi; al limite, una società che in un determinato periodo non ha utili (EPS
= 0), presenterà un rapporto P/E infinito. La duplice, e per alcuni versi
contrapposta, interpretazione del perché il P/E di un’impresa è superiore a
quello medio dei comparables, permette di evidenziare un chiaro limite nel
suo utilizzo, quello di una interpretazione non univoca delle ragioni di tale
diversità e, nel caso limite, addirittura dell’impossibilità di applicazione a
imprese in fase di start-up e/o di imprese in perdita.
150
•
•
•
Altri limiti importanti30 nella stima del P/E sono relativi:
all’omogenea individuazione del numero delle azioni emesse (esistenza
di piani stock options o altri derivati che possano far variare il numero
totale delle azioni emesse);
al fatto che gli utili per azione dipendono dal metodo di contabilizzazione
delle acquisizioni (pooling/purchase). Per cui imprese che hanno realizzato
acquisizioni e le hanno contabilizzate in modo non omogeneo introducono
elementi di errore nella determinazione del multiplo medio;
al non omogeneo trattamento dei costi capitalizzati (fra tutti la R&D)
che modificano sostanzialmente i risultati netti soprattutto di imprese in
fase di crescita e/o ad alta intensità di intangibles.
Il multiplo EV/EBIT e la valutazione asset-side. L’omologo del P/E
nella valutazione dell’impresa nel suo complesso è il mutiplo EV/EBIT
(per la verità talvolta il P/E si contrappone al più ampio EV/EBITDA). Il
moltiplicatore esprime il rapporto tra il valore del capitale operativo dell’impresa (Enterprise Value, EV) e il reddito operativo prima degli interessi
passivi e delle tasse (Earning Before Interest and Tax, EBIT). Implicitamente esso indica il moltiplicatore da applicare al reddito industriale puro
per ottenere il valore corrente dell’azienda. L’utilizzo del multiplo può generare risultati non attendibili nel caso in cui l’impresa da valutare sia significativamente diversa dai comparables nei rapporti di composizione
della struttura finanziaria o goda di un trattamento fiscale speciale e diverso
dalle imprese prescelte per il calcolo dell’indice medio.
In ipotesi di crescita zero, l’EBIT misura il flusso di cassa della gestione operativa. Infatti, si può assumere che gli ammortamenti tendano a
uguagliare gli investimenti di rinnovo e che non si verifichino variazioni
del capitale circolante commerciale.
Con queste ipotesi possiamo scrivere la seguente espressione:
EV =
EBIT (1 − tc )
Wacc
dove tc è l’aliquota fiscale mentre le altre variabili sono già note. Per ottenere il multiplo analizzato sarà sufficiente dividere entrambi i membri per
EBIT, ottenendo:
1 − tc
EV
=
EBIT Wacc
30
Per un approfondimento si confronti: Damodaran A. (2002), Valutazione delle aziende,
Apogeo, Milano, pp. 233 e ss.
151
Dall’espressione sopra riportata si evince che, a parità di aliquota fiscale, le differenze dei valori assunti dal multiplo EV/EBIT dipendono dal
costo medio ponderato del capitale inserito al denominatore del rapporto.
Nel caso si assuma che il rischio operativo sia uniforme, le differenze tra i
valori del multiplo dovrebbero riflettere esclusivamente i livelli di rischio
finanziario, ossia i diversi gradi di indebitamento dell’impresa. In presenza
di crescita la formula si complica molto per accogliere g e altre variabili legate alla crescita di alcune grandezze aziendali.
L’utilizzo di questo indice nella valutazione pre-quotazione o in sede di
acquisizione è consigliabile quando la struttura finanziaria, il trattamento
fiscale dell’impresa, il saggio di crescita dei dividendi e le variazioni del
capitale circolante sono variabili importanti nella determinazione del valore
dell’impresa.
Una variante all’EV/EBIT è quella costituita dal EV/EBITDA. Quest’ultimo, forse più utilizzato del precedente, è determinato dal rapporto tra i
valori di mercato di capitale proprio e debito al netto della liquidità (EV) e
l’Earning Before Interests Tax Depreciation and Amortization (EBITDA). Le
liquidità vengono sottratte dal numeratore poiché nel calcolo dell’EBITDA al
denominatore non figurano gli interessi attivi da esse generate.
Il multiplo Price/Book Value (P/BV). Al gruppo dei multipli del valore di libro o di rimpiazzo appartiene un moltiplicatore conosciuto come
Market to Book Value (patrimonio netto) o Price to book value. Tale multiplo è il rapporto tra capitalizzazione di borsa dell’impresa (Prezzo × Numero delle azioni emesse) e il valore di libro del patrimonio netto. Esso viene
utilizzato nella valutazione delle imprese nelle quali il contributo degli intangibles al valore totale dell’impresa è alto.
Infatti l’identificazione del multiplo medio per i comparables e poi il
confronto con l’indice della società valutata permette di interpretare eventuali diversità in funzione di una maggiore redditività netta dell’impresa,
oppure di una minore onerosità del capitale azionario o di comprendere la
temporanea sopra-sottovaluzione degli assets d’impresa. Infatti se il rapporto è inferiore a 1, il multiplo indica lo sconto che l’investitore ottiene
nell’investire sul titolo; se è maggiore di 1 indica invece il premio che
l’investitore paga per acquistare un titolo della società.
Il multiplo EV/Sales. Se volessimo valutare l’impresa servendosi di un
moltiplicatore dei ricavi potremmo utilizzare il moltiplicatore EV/sales. Esso vuole stimare il valore d’impresa partendo dalla quota di mercato della
società oggetto di valutazione.
152
In assenza di crescita l’indice sarà:
ROS × (1 − tc )
EV
=
Sales
Wacc
In questo modo il risultato dipenderà direttamente dalla redditività sulle
vendite (ROS), dalla tassazione societaria (tc) e dal costo medio ponderato
del capitale (Wacc). In presenza di crescita sarà invece rappresentato dall’uguaglianza che segue.
1
ΔCC
ROS × (1 − tc )
EV
=
− Sales − Sales
Sales
Wacc − g
Wacc − g Wacc − g
Il rapporto EV/Sales è di uso frequente tra gli operatori poiché è difficilmente negativo, in quanto calcolato sulla più ampia grandezza del conto
economico. Questa caratteristica ne permette l’utilizzazione anche per la
valutazione di imprese in crisi o in ristrutturazione, o che al contrario si
trovano nelle fasi di start-up. Inoltre il rapporto non risente, al contrario
degli indici presentati finora, di eventuali manipolazioni contabili sugli
ammortamenti e sulle rimanenze.
6.5. I multipli delle transazioni di imprese simili. Il valore d’impresa
e i multipli impliciti
Il secondo approccio utilizzabile nella stima del valore intrinseco di
un’impresa con il metodo dei multipli è quello delle transazioni comparabili o deal multiples.
In questo caso il valore dell’impresa viene stimato attraverso quello negoziato, in occasione di operazioni di finanza straordinaria, tra compratori e
venditori di imprese simili a quella oggetto di valutazione.
Operativamente il metodo non si discosta molto dal precedente. Infatti
è necessario prima individuare le caratteristiche dell’impresa e le grandezze
fondamentali che meglio ne descrivono il valore (drivers di valore). Una
volta stabilito quale multiplo esprime al meglio queste caratteristiche è necessario ricavare il multiplo implicito negoziato in ognuna delle transazioni
di imprese comparabili. Per esempio nella valutazione di un’impresa del
settore energia ricaviamo il EV/Megawatt. Se l’entrerprise value dell’impresa venduta era 1,2 Mil €€ e il numero dei megawatt di produzione
153
dell’impresa era 120.000 megawatt di fatto la transazione era avvenuta con
un multiplo EV/Megawatt pari a 10, ovvero a 10 €€ di valore per Megawatt
di potenza disponibile. Calcolando il multiplo implicito e facendone la media è possibile ottenere il multiplo medio delle transazioni che hanno avuto
per oggetto imprese simili. Moltiplicando quest’ultimo per il potenziale di
megawatt prodotti dall’impresa oggetto di valutazione otterremo il suo enterprise value.
L’utilizzo di alcuni dei multipli, principalmente quelli degli utili impliciti nelle transazioni di imprese, è fortemente osteggiato dalla dottrina in
considerazione del fatto che essi risentono, come affermano Guatri e Bini
(2002), di alcuni fattori esogeni all’impresa quali: la contingenza di mercato finanziario al momento della transazione, la modalità di negoziazione
in borsa o fuori borsa, con titoli o in contanti. Anche premi di maggioranza
e sinergie bidder-target possono influire sul prezzo finale e quindi rendere
quest’ultimo molto lontano dal valore intrinseco stimabile dai fondamentali. Quanto detto fa in modo che, il più delle volte, i prezzi delle transazioni
siano statisticamente indipendenti dai risultati (utili e FC ecc.) conseguiti
dalle imprese oggetto di valutazione e anche di quelle inserite nel campione
delle imprese comparabili, con grave danno all’attendibilità della stima.
Questa circostanza non si verifica, però, se i multipli delle negoziazioni
comparabili sono costruiti con indicatori che esprimono la “rarità” di alcuni
assets disponibili alle imprese; per esempio citiamo: la raccolta di una banca, le camere di una struttura alberghiera, il portafoglio clienti di un’impresa di servizi. Guatri e Bini (2002) definiscono queste attività strategiche
core assets e affermano che: “I multipli fondati su prezzi desunti da transazioni comparabili non dovrebbero assumere a denominatore misure di performance reddituali, ma misure di struttura: quali misure di capacità (per
esempio megawatt per un’impresa elettrica) o di top line di conto economico (fatturato ecc.) o patrimoniale (portafoglio premi per un’assicurazione)”
(Guatri e Bini 2002b, p. 373).
Alla luce di quanto detto l’applicazione dei multipli costruiti seguendo
l’approccio delle transazioni comparabili introduce elementi fortemente
problematici nella valutazione e, spesso, finisce per renderne impossibile
l’applicazione anche come metodo di controllo.
6.6. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del metodo dei multipli
Volendo tracciare un bilancio fra elementi a favore e contrari all’applicazione del metodo dei multipli, possiamo affermare quanto segue.
154
Tra gli elementi che ne consigliano l’applicazione rileviamo il fatto che
questi:
• forniscono grandezze di riferimento di immediato utilizzo e di rilievo
pratico, soprattutto nel caso vi sia una serie consistente di dati disponibili per il confronto e quindi la possibilità di effettuare paragoni immediati anche tra aziende appartenenti a diversi settori;
• permettono di ovviare a situazioni di scarsa informativa societaria o di
alta variabilità dei flussi futuri;
• sono applicabili anche ad aziende sprovviste di concorrenti diretti nel
settore, a condizione che vi siano dei comparables;
Tra gli elementi che ne limitano l’applicazione possiamo citare:
• l’inefficienza temporanea (anomalia) o permanente di un mercato che
può rendere il prezzo misura inaffidabile del valore intrinseco di
un’impresa;
• il fatto che il denominatore del multiplo è calcolato su grandezze spesso desunte dal bilancio d’esercizio o infrannuale, mentre il numeratore
è un prezzo rilevato con cadenza giornaliera. Ne consegue una mancanza di omogeneità fra numeratore e denominatore. Tale circostanza costituisce elemento di potenziale errore nel calcolo;
• la difficoltà e la discrezionalità nella selezione delle imprese comparabili. Esiste infatti un trade-off tra numerosità del campione e omogeneità che costituisce elemento di possibile deviazione dei valori del
multiplo.
Concludendo vogliamo sottolineare come da quanto detto nel corso di
questo lavoro emerge chiaramente la varietà e variabilità degli strumenti per
la stima del valore d’impresa. Ciò sottolinea la natura ineliminabilmente soggettiva dell’attività del valutatore, un’attività comunque discrezionale a prescindere dal rispetto dei principi di razionalità, dimostrabilità, neutralità e
stabilità della valutazione. Per superare le difficoltà l’incaricato della stima
dovrà applicare le proprie conoscenze e professionalità in modo da restituire
un valore il più coerente possibile con le caratteristiche intrinseche dell’impresa. Così facendo egli si adoperà per raggiungere quel true-value che
costituisce l’unico, astratto, valore certo dell’organismo chiamato impresa.
155
4. LA LEVA FISCALE NELLA VALUTAZIONE
DELLA STRUTTURA FINANZIARIA
E DEL RISCHIO DI DEFAULT
di Valentina Cioli
1. Premessa
La capacità di un’impresa di creare valore economico dipende non solo
dall’allocazione efficiente degli investimenti e dall’identificazione dei segmenti di mercato strategicamente più rilevanti, ma anche da un attento governo della propria struttura finanziaria. In effetti, come è già stato ampiamente discusso nei capitoli precedenti, le decisioni finanziarie sono generalmente tese alla ricerca di una combinazione ottimale tra investimenti e
finanziamenti in grado di aumentare il valore dell’impresa sul mercato. In
particolare, mentre sul fronte degli investimenti si cercherà di individuare le
scelte strategiche più idonee a conseguire quote di mercato e vantaggi competitivi durevoli, sul fronte dei finanziamenti l’obiettivo principale sarà
quello di creare un mix di mezzi propri e mezzi di terzi in grado di coprire
gli investimenti effettuati e contemporaneamente di assicurare uno sviluppo
sostenibile dell’impresa, nel rispetto dell’obiettivo di minimizzare il costo
del capitale aziendale (Wacc).
Se da un lato, quindi, il problema principale del management è quello
di individuare gli investimenti più “redditizi” e più “capaci” di creare valore, dall’altro è importante, ai fini della sopravvivenza dell’impresa stessa,
che sia predisposta una struttura finanziaria capace di non deprimere eccessivamente i risultati aziendali a causa degli oneri finanziari e consona a
trarre massimo vantaggio dalle possibilità di crescita attraverso il ricorso al
solo finanziamento con mezzi propri.
Ne consegue che uno dei problemi principali affrontati negli studi di
Finanza Aziendale è quello dell’individuazione della struttura finanziaria
ottimale di ciascuna realtà di impresa, struttura che risulta strettamente correlata a numerosi fattori, sia endogeni che esogeni, con particolare riferimento al contesto istituzionale all’interno del quale ciascuna impresa opera.
Con il termine contesto istituzionale, vogliamo riferirci principalmente
157
al panorama normativo esistente, e in particolare alla regolamentazione, soprattutto di carattere tributario, che può influire sulle decisioni di copertura
dei fabbisogni finanziari.
Il presente capitolo affronta il tema della progettazione della struttura finanziaria ottimale alla luce dell’impatto della variabile fiscale sul
valore dell’impresa. In effetti, come dimostrato da numerosi studiosi a
partire da Modigliani e Miller, la deducibilità degli oneri finanziari diventa, per l’impresa che li sostiene, una leva di valore in termini dello
scudo fiscale a essi collegato. Tuttavia, la presenza del beneficio fiscale
non dovrebbe indurre l’imprenditore a indebitarsi oltre livelli ritenuti
economicamente vantaggiosi e capaci di garantire una sufficiente elasticità finanziaria. Infatti, come dimostrato anche dai teorici del trade off1,
esiste un limite all’indebitamento rappresentato dai costi del dissesto e
dalla probabilità di fallimento che aumentano al crescere del rapporto di
leva finanziaria per la maggiore percezione del rischio di insolvenza
dell’impresa finanziata.
Di conseguenza questo scritto si lega ai precedenti in quanto analizza
l’impatto della variabile fiscale sulle scelte di struttura finanziaria e sulla
determinazione del livello ottimale di indebitamento dell’impresa, ma se ne
differenzia in quanto non tratta il tema della rischiosità dell’impresa o della
sua gestione, ma esamina piuttosto le implicazioni del rischio finanziario
sulle scelte di finanziamento, anche alla luce della specifica politica fiscale
del Paese in cui l’impresa opera.
In particolare verranno esaminati gli effetti che le innovazioni fiscali dell’ultimo decennio producono sulle politiche finanziarie delle imprese, prevedendo che esista una probabilità di fallimento positiva e che sia possibile quantificare i costi del dissesto sia in termini di maggiore costo del capitale di terzi
(costi diretti), sia in termini di perdita di valore aziendale (costi indiretti).
Prima di approfondire nello specifico l’analisi dell’attuale disciplina fiscale esamineremo brevemente le differenti posizioni della dottrina sul rapporto ottimale che dovrebbe legare debito e capitale proprio, tenuto conto
sia del rischio finanziario legato a un eccessivo indebitamento, sia dei vantaggi del debito visto come la fonte di finanziamento meno onerosa.
In effetti, fin dai primi studi di finanza aziendale, l’individuazione di un
rapporto ottimale tra mezzi propri e mezzi di terzi ha interessato numerosi
autori, che hanno formulato tesi differenti anche alla luce di specifici modelli di struttura tributaria.
1
Myers S. C. (1974), “Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions. Implications for Capital Budgeting”, Journal of Finance, vol. 29, e scritti successivi.
158
Modigliani e Miller nel saggio del 19582 ipotizzano un mondo senza
imposte e un mercato perfettamente efficiente con assenza di asimmetrie
informative e di costi di transazione. In questo scenario la struttura finanziaria adottata, fatta propria l’assunzione di costanza degli investimenti,
non ha impatto sul valore dell’impresa e il rischio finanziario dell’impresa,
nella sua componente di rischio di default, viene annullato dall’impossibilità di fallimento e dalla certezza dell’informazione.
In un saggio successivo del 19633, gli autori, pur mantenendo l’ipotesi di assenza di default risk, modificano la loro impostazione iniziale
sull’irrilevanza della struttura finanziaria anche in presenza di imposte
sul reddito prodotto e di oneri finanziari deducibili, arrivando a determinare il valore dello scudo fiscale, con inevitabili e considerevoli ripercussioni sulla scelta tra capitale proprio e capitale di debito. Infatti il ricorso all’indebitamento diviene tanto più conveniente quanto maggiore è
la quota deducibile degli oneri finanziari e quanto più elevata è l’aliquota
fiscale, mentre il vantaggio fiscale del debito si annulla in presenza di
oneri fiscalmente non deducibili. In tal caso, la permanenza dell’ipotesi
di non fallibilità e di certezza informativa annulla il rischio finanziario,
fissando il costo del debito al tasso privo di rischio. Ciò porta all’affermazione, valida solo a livello teorico, che la struttura finanziaria
ottimale è rappresentata da investimenti finanziati solo con debito.
Nella realtà, invece, in presenza di rischio di default, il ricorso al capitale di terzi comporta, per l’impresa, un costo crescente all’aumentare
del rapporto di leva finanziaria rappresentato dal confronto tra l’ammontare di debito e l’ammontare del patrimonio netto (D/E). Tale onere
deve essere coperto dal risultato della gestione operativa, per cui il beneficio fiscale della deducibilità degli oneri finanziari cessa nel momento in
cui non esiste più un imponibile fiscale. Ne consegue che il meccanismo
della leva finanziaria, nonché i vantaggi dello “scudo fiscale” del debito
vengono meno in presenza di una perdita di esercizio correlata a situazioni di squilibrio finanziario4.
2
Modigliani F., Miller M. H. (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the
Theory of Investment”, American Economic Review, 48, 3, pp. 261-297.
3
Modigliani F., Miller M. H. (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A
Correction”, American Economic Review, 53, 3, pp. 433-443.
4
L’operatività della leva finanziaria deve essere valutata tenendo conto anche dell’aumento
del rischio che comporta una politica finanziaria aggressiva, favorevole a un elevato livello
di indebitamento. Lo sfruttamento dell’effetto leva comporta un aumento del rischio finanziario degli investitori che può innalzare l’onerosità del capitale di debito e ridurre il valore
globale del beneficio fiscale. Insieme al rischio finanziario il manager deve valutare anche il
rischio economico legato alla variabilità dei risultati, per cui di fronte a mercati instabili o a
159
In generale, dall’analisi del comportamento delle imprese alla luce della
specifica politica fiscale nazionale è emerso che, nella maggior parte dei casi,
specie in passato, il livello di indebitamento ritenuto ottimale per la massimizzazione del valore dell’impresa è risultato piuttosto elevato e quasi sempre superiore all’ammontare dei mezzi propri. Ciò era imputabile a un corpus
normativo che prevedeva da un lato la tassazione del patrimonio dell’impresa
e, dall’altro, la piena deducibilità degli oneri finanziari, rendendo più conveniente il ricorso al credito rispetto ai mezzi propri. Si favoriva, cioè, un sistema finanziario di tipo banco-centrico fondato più sugli intermediari finanziari che sull’approvvigionamento diretto sui mercati mobiliari.
Di conseguenza le imprese italiane sono attualmente fortemente sottocapitalizzate e proprio per la bassa capitalizzazione spesso sono state limitate la
crescita e la competitività, specie sul piano dell’internazionalizzazione e
dello sviluppo tecnologico. Questa situazione ha fatto emergere in modo rilevante il problema della relazione tra scudo fiscale e rischio finanziario, legame già ampiamente sottolineato da tutti i teorici del trade-off.
Nel presente lavoro esamineremo come in Italia dopo il 1997 sia stata
portata avanti una politica di profondi cambiamenti sul piano fiscale che
hanno avuto un impatto rilevante sulle scelte e sulle strategie aziendali,
nonché sui calcoli di convenienza economica legati all’uso di numerosi
strumenti e tecniche di ottimizzazione finanziaria e fiscale.
In particolare verranno esaminate le novità tributarie che hanno influito
più direttamente, anche se per vie diverse, sulle scelte di struttura finanziaria, accennando allo strumento della dual income tax (Dit), già in vigore dal
1997 e adesso abolita, per soffermarsi sull’operatività dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), ancora in vigore, e concludere con le
recenti disposizioni che limitano la deducibilità degli oneri finanziari in
presenza di indici di copertura inferiori a dei benchmark prestabiliti, ritenuti
capaci di garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa.
2. La posizione della dottrina sul rapporto debito/capitale proprio
Sin dal 1952 con i primi scritti di Durand e dei tradizionalisti e poi con
i lavori di Modigliani e Miller del 1958 e del 1963, gli studiosi si sono occupati del tema della creazione di valore nelle scelte di finanziamento e
della ricerca della struttura finanziaria ottimale.
Anche i contributi di Myers (1974) e di Miller (1977) hanno fatto luce
imprese con strutture di costi più rigide sarebbe preferibile ricorrere a una struttura finanziaria caratterizzata da una maggiore presenza di mezzi propri.
160
sul rapporto tra fonti di finanziamento e valore introducendo i concetti di
beneficio fiscale del debito e di costi del dissesto.
In tali studi viene così evidenziato il legame tra finanziamenti di impresa, valore e ambiente all’interno del quale la stessa opera.
In ciascuno dei lavori esaminati si parte dalla consapevolezza che le
decisioni di finanziamento possono essere analizzate con riferimento a tre
specifici contesti:
• l’impresa, estrapolata dall’ambiente in cui opera, senza considerare
quindi alcun tipo di sinergie interne ed esterne;
• l’impresa nei mercati, intesi come luogo di scambio, di beni materiali e
di beni capitali, facendo particolare riferimento al luogo in cui quest’ultima reperisce mezzi finanziari, ovvero al mercato finanziario;
• l’impresa come parte di un ambiente economico e sociale complesso e
mutevole, considerando tutti gli stakeholders che gravitano intorno a essa e
anche l’insieme di norme più o meno codificate che regolano i rapporti tra
detti soggetti e che vanno sotto il nome di corporate governance.
Indipendentemente dal contesto di analisi la domanda di ricerca rimane
comunque identica e sintetizzabile nei seguenti aspetti:
• verificare l’esistenza di una particolare combinazione di fonti di finanziamento che, a parità di condizioni, risulti preferibile;
• individuare i fattori che contribuiscono a determinare questa particolare
combinazione di fonti di finanziamento.
A oggi, grazie anche ai numerosi studi condotti sull’argomento, si può
affermare che:
• per ogni impresa esiste una struttura finanziaria ottimale specifica;
• l’individuazione di questa struttura richiede la considerazione congiunta di numerosi fattori: risparmio fiscale, rischio finanziario, asimmetrie informative, esigenze di controllo, ruolo dei mercati finanziari, i
cui effetti sulla scelta del rapporto di indebitamento sono articolati e
spesso contrapposti.
L’alternativa debt versus equity, ovvero la scelta tra la capitalizzazione
di un’impresa contrapposta al finanziamento in senso proprio con l’obiettivo della massimizzazione del valore dell’impresa, rappresenta pertanto
una fase importante della pianificazione finanziaria, direttamente collegata
alla più complessa pianificazione strategica.
Sin dalla metà degli anni Cinquanta, gli studiosi si sono chiesti se esistesse un nesso causale fra struttura finanziaria, percezione di rischio rilevata dai
finanziatori e valore di mercato delle azioni di un’impresa indebitata.
Tra i principali autori ricordiamo Modigliani e Miller (M&M) che, nel
citato saggio del 1958, ipotizzano un mercato perfetto in un mondo privo di
161
imposte, rischio di default e in assenza di crescita degli investimenti e sulla
base di queste ipotesi arrivano a formulare la ben nota proposizione che il
valore di un’impresa è determinato solo dalle sue attività, ovvero dalle
sue scelte di investimento (reali o finanziarie), mentre è irrilevante la
forma di copertura finanziaria scelta per quegli investimenti. In effetti,
date le ipotesi enunciate, un investitore che si trovasse di fronte due imprese con le medesime caratteristiche in termini di attivo patrimoniale, ma con
struttura finanziaria differente, una delle quali totalmente finanziata con
mezzi propri (unlevered) e l’altra, in parte finanziata con mezzi di terzi (levered), conseguirebbe lo stesso valore attuale complessivo sia investendo
direttamente nell’impresa non indebitata, sia comprando, per lo stesso ammontare, titoli di capitale e titoli di credito (debito) dell’impresa levered.
Ciò a dimostrazione del fatto che il valore è rappresentato dai flussi operativi generati dall’impresa e che in questa prospettiva non esiste una struttura
finanziaria ottimale.
Le conclusioni di M&M, invece, mutano nel 19635 quando gli studiosi
esaminano gli effetti dell’introduzione della variabile fiscale e dei correlati
scudi fiscali sugli oneri finanziari, che originano un valore incrementale
rappresentato dal valore attuale dei risparmi di imposta. Tale premio di
valore è infatti diretta conseguenza della possibilità di detrarre gli oneri finanziari dal reddito imponibile, riducendo conseguentemente il loro costo
reale a vantaggio di una maggiore redditività netta dell’esercizio e di un
minor costo del capitale aziendale.
Limite a un indebitamento pari al 100% del valore delle fonti è tuttavia
rappresentato dall’emergere della stima del rischio di default dell’impresa
finanziata. La contrazione di nuovo debito avviene infatti a tassi crescenti,
come conseguenza di un deterioramento progressivo del rating. Ciò comporta
un decremento del valore dell’impresa poiché esso è stimato attualizzando gli
FCFF operativi a un costo del capitale maggiore (conseguenza di tassi di interesse più elevati) e sottraendo dal valore unlevered il valore attuale dei costi del
dissesto (funzione crescente della probabilità di default).
Di conseguenza, la questione della struttura finanziaria ottimale deve
essere affrontata considerando che le imprese, in presenza di oneri finanziari deducibili, possono godere di uno scudo fiscale legato al debito. Un eccessivo indebitamento tuttavia incrementa il rischio di default che è una
componente del rischio finanziario.
Nel par. 3, sebbene consapevoli della molteplicità dei fattori che incidono
5
Modigliani F., Miller M. H. (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A
Correction”, American Economic Review, 53, 3, pp. 433-443.
162
sulle scelte di struttura finanziaria, approfondiremo l’impatto combinato
della variabile fiscale e dell’indebitamento sulla redditività del capitale
proprio per verificare se esiste sempre un incentivo all’indebitamento.
L’analisi sarà effettuata ipotizzando di operare in un mondo reale dove
esiste rischio di fallimento e dove è possibile un comportamento opportunistico degli operatori.
3. La criticità della variabile fiscale nella determinazione della
leva finanziaria
In generale come si evince dalla tab. 1 il sistema tributario può esercitare molteplici interferenze nelle scelte aziendali, attraverso numerose direttrici che impattano su aree aziendali specifiche.
Nell’esaminare la relazione esistente tra la variabile impositiva e la
struttura finanziaria dell’impresa è necessario premettere che i costi e i benefici determinati da tale variabile devono essere considerati congiuntamente ai
costi e benefici determinati da un insieme più ampio e articolato di elementi.
Talune variabili, infatti, possono avere un effetto disincentivante nei confronti del ricorso all’indebitamento, come i costi del dissesto finanziario;
mentre altre variabili, al contrario, possono aumentarne la convenienza.
Limitando l’oggetto del nostro studio alle sole aliquote societarie6 si
rileva che in presenza di imposte sul reddito di impresa, il valore di un’impresa levered cioè indebitata, equivale alla somma tra il valore di un’impresa unlevered e il valore attuale dei benefici fiscali derivanti dalla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile. Conseguentemente una
modifica nella forma della struttura finanziaria incide sul valore dell’impresa, come vi incide anche una modifica del grado di deducibilità fiscale
degli oneri finanziari.
In particolare il peso della variabile fiscale emerge analizzando la formula
del costo medio ponderato del capitale, dalla quale è possibile estrapolare
l’equazione della leva finanziaria sia in presenza sia in assenza di imposte.
6
In effetti se analizziamo anche le aliquote personali, a parità di aliquota societaria sugli
utili realizzati dalla società, si determina:
•
un aumento del valore dello scudo fiscale del debito qualora l’aliquota di tassazione a
livello personale dei dividendi sia superiore all’aliquota di tassazione personale degli
interessi corrisposti dall’impresa;
•
una diminuzione del valore dello scudo fiscale, e quindi del vantaggio fiscale collegato
al ricorso all’indebitamento qualora il livello di tassazione dei dividendi sia inferiore rispetto all’aliquota di tassazione degli interessi; cfr., Miller M. H. (1977), “Debt and
Taxes”, Journal of Finance, n. 32.
163
Tabella 1 – L’influenza della normativa fiscale sulle scelte gestionali
Contenuti
della normativa fiscale
Aree aziendali
interessate
Decisioni aziendali
connesse
Oneri fiscali su fattori
produttivi e su output
Logistica
Produzione
Produzione
Localizzazione
Incentivi alla produzione
Agevolazioni all’occupazione
Organizzazione
Personale
Livello di occupazione
Finanza
Politica dei dividendi
o della distribuzione di utili
Finanza
Decisioni di finanziamento
Finanza
Decisioni di capital
budgeting
Riduzione del costo del
lavoro
Forme di lavoro alternative
Imposizione sul capital gain
Tassazione dividendi
o utili distribuiti
Tassazione riserve
Agevolazioni
per autofinanziamento
Deducibilità oneri finanziari
Finanziamenti agevolati
Contributi in c/esercizio
o in c/capitale
Agevolazione investimenti
Riduzione del costo
del capitale
Fonte: nostra elaborazione
Secondo la nota formula del Wacc textbook il costo del capitale aziendale è pari a:
E
D
Wacc = k e
+ k d (1 − T )
E+D
E+D
dove
• ke = indica il rendimento atteso dai detentori del capitale di rischio;
• ka = indica il rendimento delle attività in cui l’impresa ha investito;
• kd = indica il costo dei mezzi di terzi che si esprime mediante il tasso di
interesse passivo;
• D = indica l’ammontare del debito contratto;
• E = indica l’ammontare del capitale netto aziendale;
• T = indica l’aliquota media di imposta sul reddito d’impresa.
164
In assenza di crescita, quando l’impresa non crea nuovo valore, il VAN
dei progetti è 0 con la conseguenza che il TIR e il costo del capitale coincidono. In tal caso la formula precedente coincide con la formula del rendimento delle attività.
E
D
Wacc = ra = re
+ rd (1 − T )
E+D
E+D
•
•
•
re = indica il rendimento atteso dai detentori del capitale di rischio;
ra = indica il rendimento delle attività in cui l’impresa ha investito;
rd = indica il costo dei mezzi di terzi che si esprime mediante il tasso di
interesse passivo Da questa ultima si ricava la formula della leva finanziaria7:
Questa equazione può anche essere espressa mediante gli indici utilizzati per l’analisi finanziaria e in questo caso abbiamo:
In cui se T > 0 abbiamo un risparmio di imposta sull’ammontare degli
oneri finanziari sostenuti che hanno un costo percentuale al netto dei benefici fiscali pari a i × (1 – T). Tuttavia l’incremento del livello di debito deve
essere pianificato alla luce della percezione di rischiosità finanziaria del finanziatore marginale. Infatti il nuovo debito potrebbe essere giudicato più
rischioso e avere un costo i1 > i0.
La formula della leva, sopra riportata può però subire alcune modificazioni in relazione allo specifico modello di prelievo tributario adottato e
7
Il termine leva finanziaria indica l’aumento della redditività del capitale proprio, rappresentata dal ROE al crescere del livello di indebitamenti (D) in presenza di un reddito
operativo in grado di coprire gli oneri finanziari. Tale fenomeno deriva dalla natura dei
finanziatori a titolo di capitale proprio che si configurano come residual clamers sui
flussi dell’impresa e che sopportano quindi completamente sia i rischi operativi, sia i
rischi finanziari di un eccessivo indebitamento. Secondo la relazione diretta tra rischio
e rendimento consegue che tali soggetti richiederanno una remunerazione superiore per
investire in un’impresa levered e questa tenderà a crescere all’aumentare del livello di
debito, sempre che esista una copertura degli oneri finanziari. Infatti, in caso di mancata copertura anche gli stessi obbligazionisti non troveranno più un reddito operativo
in grado di soddisfarli e l’impresa, se priva di nuove fonti finanziarie, si troverà in stato
di default.
165
alle relative previsioni di deducibilità degli oneri finanziari. In particolare
possiamo avere due casi limite:
1. Ipotesi di imposizione sul reddito di impresa e oneri finanziari indeducibili dall’imponibile:
ROE =ROI (1 − T ) + [ ROI (1 − T ) − i ]
D
E
In questo caso, l’imposta non riduce l’importo degli oneri finanziari sostenuti, ma soltanto la redditività netta, di conseguenza non esiste alcuno scudo fiscale e un aumento del tasso di indebitamento ha solo
l’effetto di peggiorare il rischio finanziario dell’impresa.
2. Ipotesi di assenza di imposizione sul reddito di impresa, ovvero T = 0:
ROE =ROI +
D
( ROI − i )
E
La redditività aziendale non è gravata dalla presenza del prelievo tributario, ma l’impresa sostiene completamente il peso degli oneri finanziari. Non si realizza alcuno “scudo fiscale”. Si tratta di una situazione migliore della precedente in termine di flussi di cassa residuali e
di rischio finanziario, ma viene totalmente annullato l’incentivo fiscale all’indebitamento.
Le stesse considerazioni espresse in termini analitici possono essere riassunte anche nella figura sottostante dalla quale emerge che la presenza
delle imposte tende sempre ad abbattere il reddito degli azionisti rispetto a
un sistema privo di imposte. Tuttavia la situazione individuata nell’ipotesi
di indeducibilità degli oneri finanziari rende il ricorso all’indebitamento
con il conseguente sostenimento degli oneri stessi molto più costoso che nel
caso in cui siano completamente deducibili.
Possiamo dire che in presenza di imposte e oneri finanziari deducibili il
debito “costa meno” di quanto non avvenga in assenza di imposte o con
oneri finanziari indeducibili; in termini più tecnici abbiamo un risparmio
fiscale. Il costo degli oneri stessi, pari all’interesse sul capitale di debito, in
realtà viene pagato solo per l’ammontare i × D (1 – T), per cui nel caso,
semplificato, di applicazione della formula di rendita perpetua per la stima
dei benefici fiscali derivanti dalla deducibilità degli interessi passivi avremo un valore attuale del risparmio fiscale sul costo del debito pari a T × D8.
8
Il valore T × D si ottiene applicando la formula di rendita perpetua al flusso di risparmio
fiscale sugli oneri (T × i × D) che una volta diviso per i viene pari a T × D, ne consegue che
il costo netto del debito in ipotesi di rendita perpetua sarà pari a [i × D (1 – T)] diviso per i,
ovvero D (1 – T).
166
Figura 1 – Il rapporto tra ROE e grado di indebitamento in diversi scenari di deducibilità fiscale degli oneri finanziari
ROE
In assenza di imposte
ROENoTax
ROETax-Dedux
ROE = ROI
ROETax-Indedux
ROE = ROI + (1 – t)
Con imposte e oneri
finanziari deducibili
(ROI – i)
Con imposte, ma oneri
finanziari indeducibili
(ROI – i) × (1 – T)
(ROI × (1 – T) – i)
D*/E*
Rapporto di leva D/E
Fonte: nostra elaborazione
Questa situazione favorisce il ricorso ai capitali esterni piuttosto che ai
mezzi propri fino al punto in cui gli oneri finanziari rimangono inferiori al
reddito operativo.
L’ipotesi in cui si prevede la presenza di oneri totalmente indeducibili
annulla completamente il risparmio fiscale conseguente al sostenimento
degli oneri finanziari, riducendo sensibilmente l’utilità del ricorso alla tecnica del leverage. In tal caso scomparirebbe del tutto il valore attuale del
beneficio fiscale e anche l’operatività della leva finanziaria sarebbe ridotta,
in quanto si avrebbe leva solo quando il reddito operativo al netto delle imposte ROI × (1 – T) fosse superiore al costo complessivo del debito. Il tutto
con la conseguenza di accrescere la percezione di rischio finanziario per i
nuovi finanziatori di un’impresa già sufficientemente indebitata, ricadendo
nell’ambito delle obiezioni sollevate sia dai tradizionalisti sia dai sostenitori
delle teorie del trade off o dell’ordine di scelta9.
Di conseguenza, prima di esaminare l’impatto sulle decisioni finanzia9
Myers S. C. (1984), “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, 39, 3, pp. 572592; Baskin J. (1989), “An Empirical Investigation of the Pecking Order Hypothesis”, Financial Management, primavera, pp. 26-35.
167
rie delle imprese della normativa vigente, premesso che gli operatori razionali, destinatari delle nostre analisi, sono soggetti avversi al rischio, è necessario soffermarsi brevemente anche sul concetto di rischio e sulle sue
determinanti in relazione alla stima del costo del debito.
4. Il rischio di default nella stima del costo del capitale di debito
Riprendendo i concetti dei primi capitoli ricordiamo come i rischi finanziari siano originati dagli “scostamenti dei risultati effettivi dai risultati
attesi a causa di cambiamenti nelle variabili finanziarie”. Il rischio di insolvenza o di default, legato a un eccessivo indebitamento, rappresenta una
tipologia di rischio finanziario per l’impresa che si somma alla rischiosità
del business e ne aumenta il costo del capitale.
In effetti gli oneri finanziari sono un elemento di rigidità all’interno del
conto economico perché devono trovare adeguata copertura nella redditività
operativa. Ne consegue che spesso un alto livello di indebitamento, nonostante i vantaggi fiscali relativi, finisce per elevare la probabilità di insolvenza, cosa che interviene se l’impresa non riesce a fronteggiare nel lungo periodo le proprie obbligazioni, anche in presenza di business redditizi.
Da ciò deriva anche l’impatto dell’indebitamento sulla liquidità aziendale; in quanto viene progressivamente ridotta la capacità di debito dell’impresa
cui è collegata la stessa flessibilità finanziaria. Infatti il management generalmente accantona una riserva di liquidità sia per fronteggiare squilibri imprevisti tra flussi monetari in entrata e in uscita, sia per finanziare nuove opportunità di investimento, non programmate. Le imprese che sfruttano tutta la
capacità di debito sostenibile, spesso spinte solo dai benefici fiscali, sono invece fortemente esposte alle fluttuazioni finanziarie e troveranno notevoli
difficoltà a ottenere ulteriori finanziamenti in caso di necessità.
Tutto ciò contribuisce ad aumentare la probabilità di insolvenza nota
come probability of default che impatta direttamente sul costo del debito
per il finanziato o sul rendimento richiesto sui capitali concessi a titolo di
finanziamento.
Di conseguenza, la mitigazione del rischio è diventata sempre più una
variabile fondamentale nella gestione finanziaria; tanto che in ogni istituzione finanziaria gli analisti ritengono indispensabile un apposito ufficio di
corporate risk management, deputato alla determinazione, al controllo e
alla gestione delle esposizioni rischiose.
Nell’economia del presente lavoro faremo essenzialmente riferimento
al rischio di default dal lato del debitore in rapporto ai benefici fiscali go-
168
duti. Tale situazione come già sviluppato nel Capitolo 3 si riflette sul pricing del debito, specialmente dopo l’adozione delle disposizioni del Nuovo
Accordo sul Capitale delle Banche (NAC) noto come Basilea 2 sulla base
del quale dal 2007 le istituzioni finanziarie devono determinare il proprio
requisito patrimoniale anche in funzione dell’esposizione al rischio di insolvenza del finanziato.
Tale variabile viene, misurata sulla base di un rating10 che stima appunto la probabilità di fallimento del soggetto (PD) e la perdita attesa al
momento del verificarsi dell’evento, nota come loss given default (LGD) e
della quale abbiamo trattato nei capitoli precedenti.
A ogni classe di rating corrisponde una diversa probabilità di fallimento
e una più elevata PD si traduce in uno spread più elevato da aggiungere al
tasso base, rappresentato dalla remunerazione di investimenti privi di rischio di insolvenza.
La valutazione comporta la realizzazione di una scala di giudizi di rating, non sempre uguali tra le banche, che attribuiscono al debito contratto11
una specifica classe di merito creditizio. Un rating peggiore indica una minore probabilità che l’azienda emittente rimborsi il debito e quindi un rischio di insolvenza più elevato, con la conseguenza che gli investitori richiederanno un rendimento più alto.
Per quanto riguarda le modalità di stima del merito creditizio tramite il
rating, l’accordo di Basilea 2 prevede che le banche non devono fare ricorso esclusivamente ad analisi di rating esterno, operato dalle agenzie12, ma
possono predisporre anche sistemi di rating interno13, con i quali le grandi
esposizioni vengono valutate facendo attenzione anche alla variabile quali10
Il rating è un giudizio sintetico espresso con caratteri alfanumerici o numerici, che esprime la probabilità di insolvenza.
11
Il rating può essere riferito e quindi attribuito a un’impresa debitrice in generale, in questo
caso parliamo di borrower rating, oppure può riferirsi a una specifica operazione di emissione di debito e in questo caso parliamo di facility rating.
12
Le due principali agenzie di rating sono Standard&Poor e Moody e i loro giudizi sono
sintetizzati da sigle (per esempio da AAA a D); gli investimenti vengono così suddivisi in:
investment grade (quelli più sicuri), fino a BBB e speculative grade (junk bond). La differenza tra le due agenzie risiede nella diversità di valutazione:
•
S&P stima la probability of default di un’emittente;
•
Moody stima la loss given default (perdita attesa sul titolo).
13
Esistono due approcci per valutare il rating internamente:
•
at-the-point-in-time-approach, che adotta un orizzonte temporale a breve (massimo un
anno). Il limite è la grande volatilità, infatti, guardando solo il breve periodo, durante le
recessioni dà punteggi bassi e viceversa;
•
trough-the-cycle-approach, che ha invece un orizzonte temporale maggiore considerando quindi l’impatto dei cicli economici.
169
tativa (internal rating), mentre per le esposizioni più modeste si ricorre a
sistemi più semplici (scoring model).
L’obiettivo finale rimane comunque quello di determinare lo spread da
aggiungere al rendimento privo di rischio, senza considerare in alcun modo
lo scudo fiscale, che assume soltanto un valore marginale, e che viene considerato positivamente solo in presenza di giudizi di merito up investment
grade. In effetti in tali fattispecie la posizione finanziaria dell’impresa è ritenuta sufficientemente solida e tale da poter godere pienamente dei vantaggi di una minore fiscalità sull’imponibile finale.
Una volta stimata la probability of default del finanziato, come ricordato nel Capitolo 1 è possibile “prezzare” il debito contratto, uguagliando il
montante di un investimento risk free al montante di un investimento rischioso moltiplicato per un valore inferiore all’unità, che sconta il tasso di
perdita attesa.
1 + iRF = (1 + iρ ) × (1 − ELR )
Dove il tasso di perdita attesa ELR (Expected Lost Rate) è pari a:
ELR = PD × LGD
con:
• iρ che indica costo del debito lordo;
• PD (Probability of Default) che indica la probabilità di insolvenza; legata al rating;
• LGD (Loss Given Default) che indica il tasso di perdita attesa in caso
di insolvenza; influenzato dalla presenza di garanzie (legato al facility
rating);
Di conseguenza la probability of default e la loss given default sono
strettamente legate alla valutazione del merito creditizio e alla stima del costo del debito, indipendentemente dalla variabile fiscale, che continua a
mantenere il suo effetto di scudo in presenza di un imponibile positivo.
Tuttavia, specialmente con riferimento alla recente normativa tributaria,
l’attenzione dei legislatore si sta spostando a premiare solo quelle imprese che si indebitano principalmente per sostenere lo sviluppo aziendale e non tanto per sfruttare l’effetto scudo o per favorire i propri
azionisti grazie a differenziali fiscali positivi.
A tale proposito una variabile molto importante, considerata di recente
anche dal Legislatore nazionale, è rappresentata dal rapporto di copertura
degli oneri finanziari, nelle varie forme conosciute. Tale rapporto infatti
mostra la capacità dell’impresa di sostenere il costo del debito con le risorse prodotte dalla gestione operativa. L’indice può assumere differenti con-
170
figurazioni sia nelle voci al denominatore, sia in quelle al numeratore; in
particolare se si considera un tipico indicatore economico nel numeratore
verranno utilizzati l’EBIT o l’EBITDA, mentre nel denominatore gli Oneri
Finanziari (OF), se invece l’analisi è di carattere più finanziario e vuole individuare la reale capacità dell’impresa di fronteggiare l’indebitamento finanziario, allora al numeratore saranno indicati i flussi prodotti e al denominatore la somma tra quota capitale annua e quota interessi riconducibile
all’indebitamento oneroso contratto.
Indicatori poco superiori all’unità o addirittura inferiori mostrano
un’impresa fortemente esposta al rischio finanziario che quindi dovrebbe ridurre il suo tasso di indebitamento, anche se ciò può comportare la rinuncia a una quota di valore creato con lo scudo fiscale. L’impresa infatti
deve scongiurare situazioni di effetto leva negativo, nelle quali non esiste
alcun beneficio fiscale legato all’indebitamento.
Nei paragrafi successivi analizzeremo le scelte di struttura finanziaria
seguite dalle imprese italiane, differenziando il loro comportamento in relazione alla specifiche norme tributarie che si sono susseguite fino a oggi, focalizzandoci in particolare sui cambiamenti avvenuti dopo il 1997.
5. La situazione prima della riforma fiscale 1997 e le opportunità
offerte dalla normativa fiscale vigente
Dall’esame dei risultati di un’indagine statistica del Comit14 sulle scelte
di struttura finanziaria di un campione di imprese industriali, di piccola e
media dimensione, si rileva che prima del 1997:
• le imprese di maggiori dimensioni generalmente finanziavano i loro
progetti o con l’autofinanziamento o con risorse di terzi, evitando qualsiasi operazione sul capitale. Così facendo esse rinunciavano a intraprendere progetti con valore attuale netto positivo provocando un rallentamento della crescita economica del Paese;
• le imprese preferivano spesso finanziarsi con mezzi di terzi anche per
poter usufruire del vantaggio fiscale della deducibilità degli interessi passivi. In tal caso il problema era quello di riuscire a individuare il livello
di leverage tale da evitare i costi legati al dissesto, consentendo anche il
mantenimento di un certo grado di capacità di debito inutilizzata;
• l’aggiustamento della leva finanziaria al livello ottimale di lungo perio14
Cfr. Bonato L., Hamaui R., Ratti M. (1991), Come spiegare la struttura finanziaria delle
imprese italiane?, Roma, Comit – Ufficio Studi e Programmazione, Quaderno R91-18.
171
do risultava lento e complesso per cui era necessario concentrare l’attenzione sulla dinamica dell’indebitamento, oltre che sul suo livello,
cercando di evitare che si creassero tensioni finanziarie.
Questa situazione era la diretta conseguenza della politica tributaria
attuata fino a quel momento la quale prevedeva una doppia tassazione sul
reddito di impresa, esplicata mediante un’imposta proporzionale sul reddito
delle persone giuridiche (Irpeg) con aliquota al 37% e un’imposta locale sul
reddito (Ilor) anche essa proporzionale e con aliquota del 16,2%; portando
la tassazione globale intorno al 53,2%.
Gli oneri finanziari risultavano completamente deducibili, tranne in
presenza di proventi esenti dall’imposizione (nel qual caso doveva essere
calcolato un pro rata di indeducibilità), per cui il ricorso all’indebitamento
provocava un risparmio di imposta pari al 53,2% sul costo del debito.
Questa forma di imposizione, unitamente a un’imposta patrimoniale
calcolata sul valore complessivo del patrimonio netto di una società (ovvero la somma rettificata del capitale sociale e delle riserve di utili accantonate), era espressiva di un sistema fiscale che penalizzava e disincentivava la capitalizzazione a favore dell’indebitamento.
Per rispondere sia alla complessità dell’intero sistema, sia alla preoccupante e diffusa sottocapitalizzazione delle imprese, era necessario procedere a un’incisiva riforma del richiamato sistema impositivo.
Potevano essere contemplate le seguenti alternative:
• disporre la totale indeducibilità degli oneri finanziari, con l’immediata conseguenza di aggravare le condizioni delle imprese fortemente
indebitate, che si sarebbero trovate a dover pagare elevate imposte,
senza disporre degli utili necessari;
• detassare gli utili reinvestiti, avvantaggiando le imprese esistenti sul
mercato rispetto a quelle nuove o a quelle che avevano scelto di finanziare i propri investimenti con nuovi apporti di capitale, piuttosto che
con utili trattenuti e reimpiegati nella gestione.
La scelta seguita dal Legislatore del 1997 fu quella di realizzare il duplice obiettivo di disincentivare l’indebitamento favorendo al contempo la
ricapitalizzazione, verso un maggiore riequilibrio della struttura finanziaria
attraverso gli aumenti di capitale e l’autofinanziamento.15
15
La prima regolamentazione secondo questo orientamento era contenuta nella legge delega
sulla “semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti” e sul “riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese”,
nel presupposto di provvedere, attraverso questo nuovo sistema, a un generale “rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo”. Il tutto finalizzato alla ricerca di un
meccanismo per riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese a favore di un maggiore
172
Furono istituite con D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, successivamente
corretto dal D.lgs. 137 del 10.04.1998 e con D.lgs. 466 del 18.12.1997
rispettivamente:
• l’IRAP o imposta regionale sulle attività produttive;
• la DIT o dual income tax16, che prevedeva un’aliquota calmierata per
i redditi derivanti da autofinanziamento da reddito o da ricapitalizzazione.
Nonostante il successo della normativa, la DIT venne abolita con la riforma fiscale del 2004, che ridusse ulteriormente il carico fiscale introducendo nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi.
Dopo queste norme si sono susseguite varie regolamentazioni che
hanno in parte modificato in parte ampliato le disposizioni del 1998, ma
che essenzialmente sono state tutte strutturate in modo da orientare le
imprese verso nuove scelte sia sul piano finanziario sia su quello organizzativo.
Analizzando con maggiore dettaglio la normativa vigente al momento
della scrittura del presente lavoro17, una volta premesso che la stessa è costantemente soggetta a cambiamenti e revisioni, specie in occasione delle
Manovre Finanziarie di fine anno, emerge che le disposizioni che possono
influenzare le scelte finanziarie delle imprese sono quelle collegate all’Irap
ricorso a forme di autofinanziamento o di capitalizzazione vera e propria, riducendo i casi di
insolvenza e i conseguenti fallimenti a vantaggio di un livello più stabile dell’occupazione e
di una progressiva crescita economica del Paese. (Cfr. art. 3, comma 143 e 144 della legge
662/1996 collegata alla Manovra Finanziaria 1997 concernente le “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica”).
16
Per quanto relativo alla DIT (operativa dal 1997 al 2003) è difficile collocarla nell’ambito
di una specifica definizione di tributo, in quanto si tratta piuttosto di un procedimento di determinazione della base imponibile sia ai fini Irpeg che ai fini Irpef. La sua finalità era
quella di agevolare qualunque forma di investimento di risorse proprie, apportate esternamente o prodotte nel corso della gestione aziendale, all’interno di una struttura produttiva,
indipendentemente dalla sua forma giuridica. Il meccanismo, infatti, prevedeva, che il reddito complessivo venisse suddiviso in due tranches, la prima, stimata sulla base del reinvestimento degli utili, soggetta ad aliquota agevolata del 19% e la seconda soggetta ad aliquota
ordinaria. È importante evidenziare inoltre l’effetto cumulativo della Dit, in quanto l’incremento di capitale preso a base per l’applicazione del coefficiente di remunerazione ordinaria, salvo eventuali riduzioni di carattere straordinario, doveva subire un progressivo aumento in quanto veniva mantenuto costante il termine di riferimento iniziale (il 30 settembre
1996), mentre veniva fatto variare quello finale (la fine dell’esercizio di riferimento). Ne
consegue che ogni anno potevano essere sfruttati, oltre che gli aumenti verificatisi nell’anno
stesso, anche quelli realizzati in passato secondo una logica di cumulatività fino a raggiungere l’obiettivo limite dell’aliquota di imposta media minima del 27%.
17
Come data di riferimento prendiamo il giugno 2009, nel quale sono operative le disposizioni fiscali della Finanziaria 2007 e 2008.
173
e alle nuove regole sulla detraibilità degli interessi e degli oneri finanziari assimilati.
In particolare, in termini di Irap18, le imprese devono determinare
l’imponibile rappresentato dal valore aggiunto della produzione derivante
dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione (art
2425 c.c., voci A.1 A.5) e la somma delle voci del costo della produzione
(art. 2425 c.c., voci B.6, B.8, B.10a, B.10b, 11, 14.).
Vengono pertanto escluse dalla deducibilità tutti i costi di carattere finanziario, comprese anche le perdite su crediti e tutti i costi relativi al personale impiegato con alcune esclusioni e alle altre forme assimilabili al lavoro dipendente, come per esempio le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo occasionale.
Conseguentemente nella quantificazione dell’imponibile e nella scelta
della strategia di allocazione dei fattori produttivi capitale e lavoro, assumono
maggiore rilevanza i componenti negativi di reddito divenuti indeducibili,
con particolare riferimento agli oneri finanziari e ai costi del personale.
Tralasciando di esaminare questi ultimi in quanto irrilevanti nella composizione della struttura finanziaria di un’impresa, è evidente che l’attuale
indeducibilità degli oneri finanziari ai fini Irap impatta in modo rilevante sulle scelte finanziarie aziendali, poiché rende più conveniente lo
spostamento dell’indice di leva finanziaria a favore di un maggiore utilizzo
dei mezzi propri, anche se l’aliquota di riferimento è relativamente modesta
e attualmente si attesta al 3,9%.
Molto più importanti sono tuttavia le previsioni della finanziaria per
il 2008, nelle quali si rileva una completa riscrittura dell’art. 96 del
TUIR, in cui dopo aver abrogato le disposizioni che regolavano la deducibilità degli interessi passivi sulla base della thin capitalization19 (art.
18
L’IRAP è un’imposta dovuta, su base territoriale e a livello delle singole Regioni, su un presupposto applicativo costituito dall’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o
allo scambio di beni o di prestazioni di servizi. Dalla definizione risulta evidente che l’ambito
applicativo della nuova imposta risulta notevolmente ampliato rispetto ad alcune delle imposte
che è andata a sostituire. In effetti, i soggetti passivi colpiti costituiscono una categoria molto
più ampia ed eterogenea che in passato, comprendendo anche le categorie professionali di lavoratori autonomi, precedentemente non assoggettati a Ilor. È un’imposta a carattere reale, non
deducibile ai fini delle imposte sui redditi, il cui ammontare prescinde dall’esistenza di un utile
di esercizio, in modo che a tale carico tributario può essere assoggettata anche una società in
perdita, nonché una società che disponga di perdite fiscali pregresse riportabili a nuovo ai fini
Irpeg. L’introduzione dell’Irap ha comportato la contemporanea abolizione dei contributi per il
Servizio Sanitario Nazionale, dell’Ilor, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della
tassa di concessione governativa sulla Partita Iva, dell’Iciap e delle tasse di concessione comunale, consentendo una notevole semplificazione del sistema.
19
Si trattava di una norma che impediva la deduzione degli interessi passivi sui finanzia-
174
98) e del pro rata patrimoniale20 (art. 97), vengono modificate integralmente le regole di deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES,
a partire dal 1º gennaio 2008.
menti fruttiferi effettuati da parte di soci qualificati o garantiti dagli stessi, se ricorrevano
determinate condizioni che comportassero un rilevante differenziale di imposta a favore del
finanziatore a titolo di debito invece che di capitale proprio. Del resto, se non si ipotizzano
intenti elusivi della tassazione, non si capisce come mai, se il finanziatore è proprio lo stesso
socio, quest’ultimo non dovrebbe apportare immediatamente mezzi finanziari a titolo di capitale proprio. In un certo senso con questa disposizione si passava da una normativa a favore degli apporti di capitali propri (la Dit) a una norma che puniva gli apporti a titolo di capitali di prestito in luogo dei mezzi propri. La disciplina colpiva in particolare le situazioni in
cui gli interessi pagati dalla società e deducibili per la stessa non concorrevano a formare il
reddito imponibile dei soci in quanto soggetti a ritenuta separata di imposta del 12,5% (caso
di interessi su prestiti di durata superiore ai 18 mesi).
La norma prevedeva per la sua applicazione che ricorressero le seguenti condizioni:
•
la società avesse superato una specifica soglia di ricavi;
•
la remunerazione dei “prestiti” non confluisse nel reddito imponibile dei soci;
•
il rapporto tra finanziamento fruttifero erogato dal socio qualificato e netto di pertinenza del socio stesso fosse fortemente sbilanciato indicando una soglia di sottocapitalizzazione (finanziamento del socio superiore a 4 volte la quota del netto imputata al socio).
Prevedendo il limite dimensionale dei ricavi minimi, venivano escluse le società di modeste dimensioni dove il ricorso al finanziamento da parte dei soci potrebbe risultare una
delle poche soluzioni per superare il vincolo finanziario allo sviluppo.
20
Si tratta delle norme relative alla partecipation exemption non più operative che si applicano quando un’impresa acquista una quota rilevante (qualificata) del patrimonio netto
di un’altra e successivamente la cede realizzando una plusvalenza in esenzione di imposta. Infatti, se il valore di libro di tale partecipazione eccede il valore del netto contabile,
si presume che la stessa possa essere stata acquistata anche con finanziamenti esterni onerosi per cui gli interessi passivi pagati dall’impresa, al netto degli interessi attivi, collegati
alla quota attribuibile al finanziamento della partecipazione, sono indeducibili. In pratica
se, tramite un finanziamento esterno, una società acquista delle partecipazioni da cui derivano redditi esenti, sia a livello di dividendi che di profitti da plusvalenze, il contribuente
non ha diritto al beneficio fiscale della deducibilità degli interessi passivi sul finanziamento stesso, in quanto ha coperto un investimento che ha permesso nel tempo di realizzare redditi esenti da imposta. Va infatti confrontato il valore di libro delle partecipazioni
con quello del patrimonio netto per cui si ottiene un pro rata di indeducibilità dato dal
rapporto tra il valore contabile della partecipazione meno il patrimonio netto al numeratore (che coincide con il finanziamento preso per acquisire la partecipazione) e il totale dell’attivo ridotto di alcune voci. In particolare vengono sottratti lo stesso patrimonio netto, i
debiti commerciali in modo da evidenziare il complesso delle passività consolidate. In tal
modo il numeratore indica la parte del valore di acquisto non finanziata dai mezzi propri
della partecipante, mentre il denominatore è un indicatore dell’indebitamento finanziario.
Ne consegue che se l’intero acquisto della partecipazione è finanziato con mezzi propri in
quanto di valore inferiore al netto della partecipante, non si profila la fattispecie dell’indeducibilità. In caso contrario, si ritiene invece che parte dell’acquisto sia stato effettuato proprio ricorrendo a finanziamenti esterni della stessa partecipata e quindi gli oneri
finanziari sostenuti sono deducibili solo per la parte eccedente tale pro rata.
175
In particolare viene stabilito un collegamento tra oneri finanziari deducibili e risultato operativo lordo (ROL), fatta eccezione per alcune
esclusioni di particolari investimenti per i quali viene sempre prevista la
deducibilità del costo del debito contratto a copertura21. Sono inoltre sempre
deducibili gli interessi passivi e gli oneri assimilati (commissioni max scoperto, disaggio su prestiti obbligazionari ecc.) risultanti dal conto economico fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi a essi assimilabili
iscritti nel conto economico stesso.
Tale collegamento comporta la deducibilità degli interessi passivi eccedenti il valore degli interessi attivi solo per un importo non superiore al
30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica,
aumentato per il 2008 di 10.000 euro e per il 2009 di 5.000 euro. Si tratta
pertanto della previsione di deducibilità solo in presenza di un rapporto di
copertura ROL / OF superiore a 3,33 che dista notevolmente dal rapporto
EBIT / OF = 1 necessario per il funzionamento della leva finanziaria in presenza di oneri deducibili.
Risulta evidente pertanto la finalità del legislatore di favorire le imprese
con un ROL elevato, permettendo loro di detrarre una maggior quantità di
interessi passivi dal reddito d’esercizio, in quanto si ritiene che il ricorso all’indebitamento sia motivato più da esigenze di sviluppo che dalla volontà
di sfruttare l’effetto leva finanziaria e fiscale.
La stessa volontà di favorire la crescita aziendale limitando intenti meramente elusivi è dimostrata anche dalle previsioni in ordine al riporto negli
esercizi successivi degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati,
che non è stato possibile dedurre in un esercizio per incapienza rispetto al
30% del ROL. Analogamente la quota del 30% di ROL prodotto a partire
dal 2010 e non utilizzata per dedurre gli interessi passivi del periodo di
competenza, può essere portata a incremento del 30% del ROL dei successivi periodi d’imposta.
Ai fini dell’applicazione della norma si considerano oneri finanziari
quelli derivanti da contratti di mutuo, dall’emissione di obbligazioni e titoli
similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (voce C.17 del conto
economico, OIC 11/2005), con esclusione degli interessi “impliciti” di na21
Tra le esclusioni oggettive dal limite di deducibilità rientrano gli interessi che, secondo le
disposizioni del TUIR, sono capitalizzabili (ovvero non concorrono alla formazione dei costi
d’esercizio); si tratta di quegli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la fabbricazione o acquisizione di beni che, in deroga alla regola generale e come stabilito dall’art. 110,
comma 1, lett. b, del TUIR, possono essere iscritti in bilancio ad aumento del costo, ma dei
soli beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento
della loro entrata in funzione.
176
tura commerciale e di quelli già elencati nelle esclusioni oggettive di cui al
primo punto e con l’aggiunta di quelli derivanti da contratti di leasing
(compresi nella voce B.8).
Si tratta pertanto di tutti gli oneri direttamente connessi all’indebitamento diretto sia di natura bancaria, che finanziaria (obbligazioni), e alle
forme indirette mediante accensione di un leasing, proprio quei valori sui
quali viene calcolato lo scudo fiscale. Tali valori mostrano la dipendenza
dell’impresa da fonti di terzi e devono essere adeguatamente coperti con la
redditività prodotta dal core business, che viene appunto rappresentata dall’aggregato del ROL assimilabile al più noto EBITDA (ebit before interest
tax, depreciation and amortizations) che rappresenta la figura reddituale più
vicina al flusso di cassa operativo.
A questo punto, appare lecito domandarsi se anche la disciplina contenuta nell’art. 96, così come modificato dalla legge Finanziaria 2008,
risulti uno strumento di incentivo alla capitalizzazione delle imprese, Infatti legare la deducibilità degli interessi passivi a un’elevata redditività
lorda non necessariamente sta a significare che l’impresa presenta una
struttura finanziaria adeguatamente capitalizzata. La deducibilità degli
interessi passivi sarebbe anche possibile qualora, per motivi di asimmetrie informative, fosse possibile ottenere credito a basso costo pur non
essendo in presenza di un’elevata redditività, e trovandosi anzi in una
situazione di dissesto finanziario. Naturalmente tale situazione non potrebbe continuare nel lungo periodo, per cui in orizzonti medio lunghi è
plausibile ritenere un effetto positivo della norma in termini di riequilibrio della struttura finanziaria.
La mancanza di limiti dimensionali che ne escludano l’applicazione per
alcune tipologie di imprese differenzia tale normativa dalle precedenti e fa
sì che coinvolga tutte le realtà aziendali operanti nel Paese.
Non deve essere tuttavia trascurato il ruolo svolto dagli interessi di mora di carattere commerciale che in questa ottica potrebbero diventare particolarmente appetibili in quanto ancora assoggettati allo scudo fiscale con la
conseguenza, a seconda del potere contrattuale verso clienti e fornitori, dell’allungamento dei tempi di pagamento ai propri fornitori, ma anche di incasso dai clienti. Ciò, specie nelle PMI, comporterebbe un deterioramento
del portafoglio portato allo sconto a seguito del peggioramento degli indici
andamentali rilevati dalle banche affidatarie.
In conclusione, con queste disposizioni il Legislatore vuole spingere le
imprese ad adottare livelli di indebitamento più equilibrati, adeguati alla
redditività operativa media conseguibile, ma anche alla sua volatilità, in
modo da ridurre sul fronte dei finanziamenti il rischio di tensioni finanzia-
177
rie, costruendo al contempo una struttura di investimenti operativi basata su
logiche di esternalizzazione anche parziale di alcune fasi produttive.
Entrambe queste politiche dovrebbero rendere l’impresa più flessibile e
meno esposta alle congiunture economiche negative22.
6. L’equazione della leva finanziaria sotto specifici scenari tributari
Fatte queste considerazioni, analizzeremo gli effetti di specifiche politiche fiscali sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’utilizzo dello strumento della leva finanziaria.
La nostra analisi si focalizzerà sugli effetti dell’Irap rispetto alla normativa
passata e sul ridimensionamento dell’operatività della leva finanziaria e del
vantaggio fiscale in presenza di oneri finanziari parzialmente deducibili. Ipotizzeremo che i rapporti di copertura degli oneri finanziari siano soddisfatti e
che pertanto questi ultimi siano interamente deducibili ai fini Ires.
Per comprendere meglio i benefici, può essere utile fare un confronto
tra le diverse equazioni della leva finanziaria prima della riforma e successivamente utilizzando l’attuale aliquota societaria Ires del 27,5%:
1. situazione precedente, in presenza di oneri finanziari deducibili dal
reddito e imposta patrimoniale sul totale del patrimonio netto calcolato ai fini della Legge, che in questa formula per semplicità coincide con lo stesso valore contabile E:
ROE = ROI (1 − 53,2%) +
D
[( ROI − i ) × (1 − 53,2%)] − 0,75% ;
E
2. situazione attuale in presenza dell’imposta Irap (non si considera la Dit
in quanto già abolita), con oneri finanziari parzialmente deducibili dal
reddito (rispetto del rapporto OF/ROL < 30%), assenza di un’imposta
patrimoniale sul totale del patrimonio netto:
ROE = ROI (1 − 27,5%) +
D
3,90% VAP
[( ROI − i ) × (1 − 27,5%)] −
.
E
E
dove:
• ROE = utile netto/capitale netto;
• ROI = reddito operativo/totale investimenti;
• i = costo del capitale;
22
Per tutti vedasi Lorenzoni G. (1980), “Le strategie di impresa fondate su sinergie esterne”,
L’impresa, n. 1; e Grandinetti R. (1993), Reti di Marketing, Etas, Milano.
178
•
VAP = valore aggiunto della produzione corretto per le deduzioni forfettarie e quelle relative al personale.
Per chiarire meglio il differente impatto del nuovo modello tributario,
possiamo fare riferimento a un esempio numerico e a tale proposito si segnala al lettore che per semplicità non verranno considerate le detrazioni
forfettarie previste per il calcolo dell’Irap.
Supponiamo che un manager finanziario si trovi di fronte all’esigenza
di coprire un fabbisogno di 2 milioni di euro e che possa ricorrere ai mezzi
propri o a un finanziamento esterno con un costo pari al 5%. Viene fatta
salva l’ipotesi di assenza di rischio finanziario al variare del tasso di indebitamento e viene ipotizzato un rendimento della gestione operativa pari al
20% e quindi superiore al costo degli oneri finanziari.
Si possono allora presentare tre tipologie di alternative:
• la copertura del fabbisogno ricorrendo totalmente e unicamente ai mezzi propri;
• la copertura del fabbisogno ricorrendo totalmente e unicamente a mezzi
di terzi;
• la copertura del fabbisogno con un’uguale combinazione di mezzi propri e mezzi esterni.
Tabella 2 – Copertura totalmente con mezzi propri
Passivo (dati in migliaia di euro)
Debiti
Capitale netto
Apporto
0
3.000
2.000
Totale passivo
5.000
Costi (dati in migliaia di euro)
Costi per materie prime, servizi
e altri costi
Ricavi (dati in migliaia di euro)
Ricavi di vendita
10.000
Spese del personale
EBITDA
Ammortamenti
EBIT
4.000
6.000
5.000
1.000
Utile ante imposte EBIT
1.000
•
Imposizione con la passata disciplina:
– Irpeg + Ilor = 53,2% × 1000 = 532;
– Patrimoniale = 0,0075 × 5.000 = 37,5;
– Utile netto = 1000 – (532 + 37,5) = 430,5.
179
20.000
•
Imposizione con l’attuale disciplina:
– Ires = 27,5% × (1.000) = 275;
– Irap = 3,90% × (20.000 – 15.000) = 195;
– Utile netto = 1.000 – (275 + 195) = 530.
Tabella 3 – Copertura totalmente con mezzi di terzi
Passivo (dati in migliaia di euro)
Debiti
2.000
Capitale netto
3.000
Apporto
0
Totale passivo
5.000
Costi (dati in migliaia di euro)
Ricavi (dati in migliaia di euro)
Costi per materie prime, servizi
e altri costi
Ricavi di vendita
Spese del personale
4.000
EBITDA
6.000
Ammortamenti
5.000
EBIT
1.000
Oneri finanziari
100
Utile ante imposte EBIT
900
•
•
20.000
10.000
Imposizione con la passata disciplina:
– Irpeg + Ilor = 53,2% × 900 = 478,8;
– Patrimoniale = 0,0075 × 3.000 = 22,5;
– Utile netto = 900 – (478,8 + 22,5) = 398,7.
Imposizione con l’attuale disciplina:
– Ires = 27,5% × 900 = 247,5;
– Irap = 3,9% × (20.000 – 15.000) = 195;
– Utile netto = 900 – (247,5 + 195) = 457,5.
Tabella 4 – Forma di copertura mista
Passivo (dati in migliaia di euro)
Debiti
1.000
Capitale netto
3.000
Apporto
1.000
Totale passivo
5.000
180
Costi (dati in migliaia di euro)
Costi per materie prime, servizi
e altri costi
Ricavi (dati in migliaia di euro)
Ricavi di vendita
Spese del personale
4.000
EBITDA
6.000
Ammortamenti
5.000
EBIT
1.000
Oneri finanziari
20.000
10.000
50
Utile ante imposte EBIT
950
•
Imposizione con la passata disciplina
– Irpeg + Ilor = 53,2% × 950 = 505,4;
– Patrimoniale = 0,0075 × 4.000 = 30;
– Utile netto = 950 – (505,4 + 30) = 414,6.
• Imposizione con l’attuale disciplina:
– Irpeg = 27,5% × 950 = 261,25;
– Irap = 4,25% × (20.000 – 15.000) = 195;
– Utile netto = 950 – (261,25 + 195) = 493,75.
Per cui riassumendo possiamo evidenziare uno schema delle variazioni
del ROE in presenza delle differenti discipline fiscali.
Tabella 5 – Schema delle variazioni del ROE e del relativo effetto leva
Ipotesi
Strutture finanziarie
Copertura
Non levered Con copertura
con debiti
mista
D/E = 2/3
D/E = 1/4
(1.000 / 4.000) (2.000 / 3.000)
Vecchia norma
Ires ridotta + Irap
Effetto leva
con copertura
mista
D/E = 1/4
Effetto leva
con copertura
con debiti
D/E = 2/3
8,61%
10,37%
13,29%
1,76%
4,68%
10,60%
12,34%
15,25%
1,74%
4,65%
Fonte: nostra elaborazione
Mantenendo costante il ROI% e il costo del capitale di credito i% si nota
come al variare della deducibilità degli oneri finanziari e della tassazione dei
mezzi propri conferiti conseguente l’applicazione della nuova normativa,
l’effetto leva subisca un sensibile ridimensionamento. Nella fig. 2 sono riprodotte le rette che indicano l’andamento del ROE% al variare del rapporto
di indebitamento e sono state prese in considerazioni due differenti situazioni: una retta indica l’andamento considerando che venga applicata la precedente normativa, l’altra indica l’andamento con la nuova normativa e VAP =
5.000, in presenza di oneri finanziari interamente deducibili ai soli fini Ires.
181
Figura 2 – Il rapporto di leva: un confronto tra la nuova e la vecchia normativa
ROE
Nuova normativa
15,25%
Vecchia normativa
13,29%
12,34%
10,60%
10,37%
8,61%
D/E = 1/4
D/E = 2/3
D*/E*
Rapporto di leva D/E
Fonte: nostra elaborazione
Il punto D*/E* indica un particolare valore del rapporto di indebitamento
in presenza del quale c’è coincidenza tra il ROE% delle due normative, in
quanto l’effetto agevolativo introdotto dall’abolizione dell’ILOR al 16,2% e
della patrimoniale e dalla minore imposizione conseguente all’abbassamento
dell’aliquota Ires viene esattamente controbilanciato dalla contestuale indeducibilità degli oneri finanziari e dei costi del personale ai fini Irap.
Passato questo punto si nota come, al crescere del rapporto di indebitamento, l’effetto leva subisca un sensibile ridimensionamento rispetto al
passato.
Naturalmente in presenza di rapporti di copertura che non soddisfano i
limiti per la deducibilità, viene a ridursi l’operatività della leva fiscale anche ai fini Ires con conseguente aumento del costo del debito per l’impresa
e peggioramento del correlato effetto di leva finanziaria.
6. Conclusioni
Da quanto esposto si possono trarre alcune considerazioni riassuntive,
riepilogate nel quadro sottostante, che per lo più confermano che di fronte a
182
un sistema tributario con oneri finanziari deducibili si verifica un elevato ricorso ai finanziamenti esterni che tende a ridursi (in modo meno
che proporzionale) se tale deducibilità viene limitata e se si cerca al contempo di agevolare le forme di finanziamento con mezzi interni. La leva
della tassazione del reddito di impresa e quella della tassazione dei proventi
finanziari conseguiti dagli apportatori di capitale di debito determinano il
valore dello scudo fiscale secondo le modalità già esaminate da Modigliani
e Miller nel 1963 e da Miller nel 1977.
In presenza di oneri finanziari indeducibili, invece, la riduzione dello
scudo fiscale si rivela un importante deterrente a un eccessivo indebitamento, ma al contempo può privare l’impresa dei mezzi finanziari necessari
per sostenerne lo sviluppo o anche solo la sopravvivenza sui mercati.
Nella tab. 6 viene riassunto il legame tra politiche fiscali, struttura del
capitale e variazione dei rischi finanziari.
Tabella 6 – Un quadro riassuntivo del legame tra scelte di politica fiscale e decisioni di finanziamento
Scelte di politica fiscale
Scelte di finanziamento
Rischio finanziario
Deducibilità totale degli one- Ricorso a elevati capitali di Crescita del debito e possiri finanziari
credito
bile peggioramento del rating
Deducibilità limitata
Aumento del costo dell’inde- Aumento del rischio finanziabitamento
rio a causa dei minori flussi
residuali
Capitali di credito ridotti
Ricorso a forme di copertura Ricorso a forme di copertura
alternative che riducano l’o- alternative o limitazione degli investimenti
nere dell’investimento
Agevolazione per gli apporti Struttura più capitalizzata
Riduzione del rischio finandi mezzi propri
Nuovi capitali + autofinan- ziario
ziamento
Incremento autonomia e flessibilità finanziaria
Fonte: nostra elaborazione
Lo scenario che prevede una piena deducibilità degli oneri finanziari
ovvvero il pieno sfruttamento della leva fiscale è compatibile con il principio di massimizzazione del valore generalmente utilizzato in dottrina. La
recente normativa tributaria italiana si è spostata progressivamente verso un
sistema che prevede la parziale deducibilità degli oneri finanziari; con aliquote d’imposta minori che hanno ulteriormente ridotto la convenienza
dello scudo fiscale del debito. Ciò al fine di ridurre la preoccupante sottocapitalizzazione delle imprese, specie di piccola dimensione, generata dal
183
sistema fiscale anteriore al 1997 che favoriva l’indebitamento rispetto all’autofinanziamento e all’apporto di nuovo capitale di rischio.
Nonostante la diversità delle disposizioni e delle logiche utilizzate, le
varie previsioni di intervento risultano tra loro complementari e i rispettivi
punti di contatto sono sintetizzabili nei seguenti termini:
• l’Ires comporta per tutte le imprese un abbassamento dell’aliquota societaria fino all’attuale 27,5% con un’evidente riduzione del vantaggio
fiscale del debito rispetto alle aliquote precedenti;
• le imprese che utilizzano il debito per ridurre l’onere impositivo sono maggiormente penalizzate dall’introduzione dell’Irap e dalle previsioni sulla deducibilità degli interessi legata al rapporto di copertura del ROL.
Considerando che l’eccessivo indebitamento è stato visto generalmente
come fonte di svantaggio competitivo, in tutte le riforme l’obiettivo comune è stato quello di incentivare il ricorso al capitale proprio istituendo agevolazioni (vedi l’abrogata Dual Income Tax) e penalizzando le imprese eccessivamente indebitate per mezzo dell’IRAP. Certamente la minore deducibilità degli oneri finanziari che è passata dal 53,2% al 27,5%, ha spostato
il livello di indebitamento ottimale verso tassi inferiori rispetto al passato
attenuando i benefici correlati ai risparmi di imposta; e a livello generale è
possibile affermare che sia la Riforma Visco che le Finanziarie successive
hanno raggiunto almeno a livello teorico i propri obiettivi.
Questo fatto ci ha spinto a riconsiderare il valore dello scudo fiscale
alla luce della normativa vigente e al contempo ha spostato sempre più
l’attenzione degli operatori e dei manager sull’analisi delle reali performance operative delle imprese finanziate. A ciò si aggiunga anche una maggiore attenzione ai flussi di cassa che devono essere in grado di coprire sia il
servizio del debito sia l’imposizione fiscale.
Si prevede infatti che la mutata politica fiscale possa produrre effetti
positivi anche in termini di riduzione del rischio finanziario e di miglioramento del merito creditizio degli affidati, nella misura in cui stimolerà i
manager a sviluppare un’adeguata programmazione finanziaria volta a sviluppare progetti a VAN positivo con strutture di finanziamento sostenibili.
Tuttavia se è vero che l’indice di autonomia finanziaria legato ai mezzi
propri definisce il sentiero auto sostenibile della crescita è vero anche che
la necessità di una misura maggiore di mezzi propri talvolta può risultare
un forte limite allo sviluppo.
I risultati raggiunti in questo studio inducono a ritenere però che la riforma potrà raggiungere solo in parte gli obiettivi dichiarati. Infatti dalle
analisi di convenienza svolte emerge ancora che l’indebitamento (specie
184
tramite l’accensione di un prestito sottoscritto dagli stessi soci) risulta più
conveniente del finanziamento tramite capitale proprio, anche se questa
convenienza si è andata sensibilmente riducendo in conseguenza delle previsioni legate al limite del rapporto di copertura.
In ogni caso si rileva che, sebbene non sia possibile portare il sistema verso un piano di assoluta neutralità fiscale rispetto alle scelte di finanziamento, l’attuale riforma è riuscita ad attenuare le distorsioni della
disciplina precedente al 1997, con risultati positivi in termini reali oltre
che finanziari. In effetti, il riequilibrio delle diverse fonti di finanziamento alternative dovrebbe non solo rafforzare la struttura finanziaria
delle imprese, limitando i casi di incaglio finanziario o le ancor più gravi situazioni di dissesto, ma anche favorire l’attività di investimento e il
conseguente sviluppo economico.
185
5. CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
E CRISI DEI MERCATI FINANZIARI
di Francesco Ferragina
Negli ultimi anni il panorama finanziario del nostro Paese si è evoluto
con notevole rapidità. Il manifestarsi di alcuni importanti fenomeni, infatti,
ha reso sempre più pressante l’esigenza di adeguare la disciplina del mercato finanziario alle mutate necessità dell’economia contemporanea: da una
parte, il mercato europeo, unificato anche grazie all’introduzione dell’euro,
è diventato sempre più un luogo di scambio delle merci e di circolazione
dei capitali il cui funzionamento travalica ormai i confini nazionali. Dall’altra parte, l’evoluzione della tecnologia informatica e di Internet hanno
favorito l’avvicinamento di un gran numero di investitori, non soltanto professionali, al mercato finanziario con la conseguente necessità, da parte
delle imprese e degli operatori specializzati, di consentire un più ampio e
agevole accesso all’informazione.
Il complesso scenario che si è delineato ha favorito l’introduzione e la
diffusione di nuovi strumenti per il finanziamento dell’impresa: in questo
contesto si è inserita la cartolarizzazione.
La cartolarizzazione, omologo italiano del termine anglosassone securitization1, è uno strumento finanziario, ampiamente utilizzato in Italia e all’estero.
Le opportunità offerte dalla securitization sono molteplici: questa,
infatti, consente all’impresa di diversificare le fonti di finanziamento, di
conseguire benefici effetti sulla struttura finanziaria e di ridurre il costo
dei finanziamenti. Tali vantaggi, si ribadisce, potrebbero essere particolarmente apprezzati dalle imprese italiane, poiché offrirebbero una possibile soluzione ad alcune delle tipiche problematiche di natura finanziaria: l’accesso a fonti di finanziamento non sempre coerenti con le caratteristiche dell’impresa e le relazioni con un numero di interlocutori fi1
Il termine securitization è utilizzato prevalentemente nella prassi americana. Gli operatori
inglesi utilizzano il termine securitisation.
187
nanziari limitato e talvolta non attento alle reali esigenze di finanziamento dell’attività produttiva2.
L’utilizzazione di una tecnica così evoluta ha portato notevoli benefici
anche non esclusivamente finanziari. Questa, infatti, induce nelle imprese
che desiderano porla in essere, un’evoluzione culturale che origina dalla
necessità di confrontarsi continuamente con operatori specializzati. Tale
cambiamento si potrebbe tradurre nell’adozione e nell’implementazione di
strumenti di rilevazione e di valutazione oggettiva delle proprie performances che siano utili per fornire informazioni esaurienti, chiare e attendibili,
sia in chiave storica sia prospettica, al mercato finanziario.
In generale, indipendentemente dalla tipologia di asset oggetto di cessione, il processo di securitization può essere applicato a qualsiasi attivo
che presenti un valore ragionevolmente individuabile o che produca un
flusso di cassa futuro prevedibile.
Tuttavia, dopo un decennio di applicazione della legge istitutiva in Italia e dopo la pesante crisi che ha investito tutti i mercati finanziari, è possibile tracciare un quadro di quanto avvenuto individuando l’eventuale legame intercorrente tra essa e il fenomeno della securitization.
La recente crisi finanziaria è una delle più serie e impegnative della storia contemporanea. Tale crisi, interessando drammaticamente l’economia
mondiale nella sua interezza, ha suscitato molte considerazioni sulle cause
della sua origine.
Se, infatti, le cause principali della situazione patologica si rilegano al malfunzionamento del libero mercato e alle carenze dei sistemi di regolamentazione è universalmente riconosciuto che l’origine della crisi sia legata all’introduzione su larga scala dei derivati del credito quali i CDO nell’ambito della
cartolarizzazione. Tale pratica ha dato origine alla prassi di accorpare, “impacchettare” e rivendere agli investitori rischi finanziari di vario tipo.
In verità già con l’accordo di Basilea3, nella sua prima stesura del 1988,
si introdussero norme rigide per garantire maggiore stabilità al sistema bancario e in particolare si mise in evidenza l’esigenza per le le banche di istituire un capitale di sicurezza qualora esse avessero investito in attività rischiose quali gli stessi mutui attivi o i titoli da essi derivati. Le banche, tuttavia, al fine di alleggerire la portata e gli effetti della disciplina iniziarono
a utilizzare le operazioni di cartolarizzazione per eliminare parte del rischio
2
Nelle imprese di piccole e medie dimensioni i principali “fornitori” di capitale sono le banche, spesso quelle locali, che mettono a disposizione delle imprese strumenti di finanziamento tradizionali.
3
Per approfondimenti cfr. Il Rapporto di Moody’s inerente l’analisi dell’origine del mercato
della securitization.
188
di credito dai propri bilanci. Successivamente, le nuove norme hanno incentivato le banche ad aumentare notevolmente le operazioni di cartolarizzazione non solo per ridurre il rischio connesso al proprio attivo ma anche
per aumentare la disponibilità finanziaria necessaria a effettuare nuovi investimenti trasferendo il “peso” delle proprie scelte precedenti sul mercato
finanziario. Questo meccanismo, che successivamente analizzeremo nel
dettaglio, immette una notevole quantità di risorse nel sistema finanziario
favorendo, nel tempo, l’effettuazione di operazioni collegate ad asset di
scarsa qualità. L’insolvenza dei creditori sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione, connessa a sua volta ad altre motivazioni, è stata una delle
cause della crisi finanziaria. Nonostante ciò non si ritiene che la cartolarizzazione debba essere accantonata poiché è uno strumento finanziario valido
e utile se utilizzato in modo corretto e appropriato.
La securitization ha assunto nel corso dell’ultimo trentennio un’importanza sempre crescente tra le innovazioni che hanno interessato i mercati finanziari e le modalità di diffusione degli strumenti negoziabili.
La nascita di questo tipo di operazioni è relativamente recente: i primi
casi di securitization si possono rilevare negli USA all’inizio degli anni
Settanta4. Questi sono nati dall’esigenza di attivare e rendere liquido il mercato secondario dei mutui ipotecari assicurati dagli enti governativi o paragovernativi. In quegli anni erano state create dal governo degli USA alcune
agenzie che avevano lo scopo di agevolare l’erogazione di mutui a famiglie
disagiate per favorire lo sviluppo del mercato secondario dei mutui ipotecari. Per potersi finanziare, queste agenzie iniziarono a emettere titoli a fronte
dei mutui ipotecari detenuti in portafoglio dando corso al processo di securitization. I titoli emessi furono definiti mortgage backed securities (MBS)
e riscossero un notevole successo tra gli investitori tanto che gli operatori
finanziari iniziarono a pensare di applicare la stessa tecnica anche su altre
classi di attivo. I motivi del successo erano dovuti al fatto che, vista la garanzia fornita dalle agenzie federali, i crediti risultavano facilmente esigibili, e inoltre, visto che i mutui erano erogati a condizioni fortemente standardizzate, era agevole aggregare i crediti in “pacchetti” omogenei con
conseguenti maggiori possibilità di collocazione sul mercato.
Verso la metà degli anni Ottanta si sono sviluppate le “asset backed securities (ABS)”, collegate ad altre categorie di attività quali i crediti derivanti da contratti di leasing, carte di credito ecc.
Il mercato europeo delle securitization è ancora più recente.
4
Cfr. Ferri G. (1998), “La cartolarizzazione dei crediti. Vantaggi per le banche e accesso ai
mercati finanziari per le imprese italiane”, Studi e note di economia, n. 3.
189
L’introduzione di questo tipo di operazioni risale, infatti, alla metà degli
anni Ottanta.
La Gran Bretagna è stata il primo Paese a utilizzare tale tecnica e le
prime operazioni si sono concluse già nel 1987. L’inserimento della securitization nel mercato finanziario anglosassone è stata agevolata dal sistema
legislativo fondato sulla Common law5, che ha semplificato l’adattamento
del modello americano dell’operazione al quadro normativo britannico, e
dalla forte dinamicità del sistema finanziario e degli operatori del mercato.
Il primo tra gli Stati europei che hanno favorito lo sviluppo della securitization attraverso l’approvazione di una legge specifica che ne disciplinasse le modalità operative, è stata la Francia6 che nel 1988 ha promulgato la prima legge sulla “titrisation”. Tale disposizione è stata modificata
in modo sostanziale nel 1993 al fine di renderla più adeguata alle esigenze
del mercato finanziario. Tuttavia, la securitization è stata introdotta nell’ordinamento francese con modalità differenti rispetto al modello anglosassone: in Francia, infatti, la “titrisation” è caratterizzata dalla presenza
dei “fondi comuni di crediti”, in luogo degli intermediari specializzati costituiti ad hoc. L’operazione si realizza attraverso l’emissione, da parte di
una società di gestione, di certificati di partecipazione del fondo abilitato
a investire in crediti7.
1. La crisi dei mercati finanziari e la cartolarizzazione
La recente evoluzione dei mercati finanziari e la situazione di profonda
crisi che li attraversa in questo momento sembra abbiano messo in dubbio
la capacità della finanza contemporanea di riuscire a rispondere alle esigen5
Questo sistema legislativo, come noto, fissa soltanto i principi generali e lascia alla prassi
il compito di introdurre delle regole specifiche che, in ossequio ai principi, adattino la disciplina ai casi di specie.
6
Il sistema legislativo francese, fondato sul codice napoleonico, presuppone che esista una
disciplina specifica per ciascuna fattispecie. La mancanza di un corpus legis in talune materie può pertanto, essere un limite alla diffusione di alcuni strumenti o un incentivo a superare
gli ostacoli che si pongono attraverso la realizzazione di operazioni off shore.
7
L’art. 8 del decreto istitutivo della titrisation (décret n. 89-158 del 9 marzo 1989 e successive modifiche) individua le principali modalità operative dei FCC: “i FCC non possono acquistare che crediti della stessa natura sia non immobilizzati, sia di dubbia esigibilità
o in contenzioso. Il pagamento del capitale e degli interessi di questi crediti deve essere
effettuato in una soluzione, o in più volte, attraverso versamenti, periodici o a date prefissate, in cui è prestabilito un montante minimo”. Per un approfondimento sulla titrisation
si veda Aa. Vv. (1997), “Dossier titrisation”, Banque, n. 581, maggio.
190
ze di ottimizzazione delle risorse finalizzate al supporto delle iniziative industriali: le cartolarizzazioni che pure hanno avuto un ruolo molto importante negli ultimi anni nel migliorare la circolazione delle risorse finanziarie e nell’aumentare la liquidità disponibile, devono essere “ripensate” alla
luce della possibile evoluzione della crisi del mercato finanziario.
Esaminiamo con maggiore grado di approfondimento la recentissima
situazione di crisi, quella registrata nel corso del 2008 tentando, per quanto
possibile, di fornire un quadro più ampio dello scenario internazionale.
Il quarto trimestre del 2008, in conformità alla tendenza registrata nell’anno, è stato caratterizzato dallo sforzo volto alla riduzione a livello sistematico dell’indebitamento, dalla carenza di liquidità, dalla stretta del
mercato del credito e dalla riduzione alla propensione al rischio.
Secondo Eurostat, il quarto trimestre 2008 segna l’entrata ufficiale dell’Eurozona in una fase di recessione, già preannunciata, per altro, dai due
trimestri precedenti caratterizzati da una crescita del PIL (Prodotto Interno
Lordo) tendenzialmente negativa.
Per quanto concerne l’andamento dei tassi d’interesse, le Banche Centrali continuano le loro politiche di abbattimento. Sia la Banca Centrale Europea (BCE) che la Banca of England (BOE) hanno, nel rispetto della tendenza accennata, ridotto i tassi nei primi mesi del 2009 arrivando, rispettivamente, al 2 e all’1%.
Per quanto concerne l’occupazione, secondo i dati Eurostat, il tasso di disoccupazione nell’Unione Europea, nel mese di dicembre, è stata pari al 7,4%.
I “picchi” negativi si sono registrati in Spagna (14,4%)8 e in Lettonia (10,4%).
Il prezzo degli immobili è in continua riduzione. Tendenza caratterizzante l’Eurozona nel suo complesso e che in particolare nel Regno Unito
trova un esempio paradigmatico: nel quarto trimestre del 2008 tale prezzo è
sceso del 4,4% facendo registrare una riduzione annua pari al 14,7%.
La qualità del credito, nell’Eurozona, continua a peggiorare, sospinta
dall’incertezza derivante dalla fase economica congiunturale. La fase di recessione della quale non si comprende l’entità e la durata provoca oscillazioni nella fiducia delle parti, aggravata dalla tendenza perseverata dalle
agenzie di rating di continuare a declassare i tiloli europei.
Le Collateralised Debt Obligations (CDO) rimangono la classe di attività più deboli seguita da Residential Mortgage-Backed Security (RMBS),
sia performing che non performing.
Secondo la BCE, i prestiti al settore privato sono diminuiti bruscamente
8
Il dato è in controtendenza rispetto a quanto registrato negli scorsi anni che sono stati caratterizzati da una fase di espansione e crescita del Paese.
191
nel quarto trimestre dell’anno: la riduzione registrata tra i mesi di dicembre
e novembre è pari a 47 miliardi di euro. Le cause di questa tendenza sono
da ricercarsi nel maggior rigore nello standard creditizio e nell’aumento del
tasso di disoccupazione. Le nuove emissioni di titoli cartolarizzati sono
soggette alla diminuzione dei volumi negoziati. La tendenza Europea al
maggior rigore dello standard creditizio, alla riduzione di prestiti e alla diminuzione della domanda consumer trova riscontro anche negli Stati Uniti
come risulta dall’indagine sul mercato primario del prestito condotta della
Federal Reserve relativa al quarto trimestre 2008.
Le negoziazioni degli Asset-Backed Commercial Paper (ABCP) sono diminuite significativamente in Europa, nel 2008, anche a causa del minore numero di investitori disposti a porre in essere questa tipologia di transazione9.
Alla luce della sommaria rappresentazione proposta si evince che è
proprio la finanza creativa a essere stata additata come “tossica” dal mercato fin dal momento in cui è iniziata la crisi, nell’estate del 2007, con i default dei titoli legati ai mutui subprime americani e anche successivamente
con il collasso di storiche banche d’investimento10. I timori hanno interessato in modo crescente sia le banche d’affari11 sia le banche commerciali12.
Il mercato ha compreso che non sono più le sole banche d’investimento, a preoccupare ma anche i grandi gruppi creditizi a essere in difficoltà sia per la qualità di alcuni assets originati dalle operazioni finanziarie
sopra accennate sia dalla qualità del credito che con l’economia reale in
frenata e la disoccupazione in aumento prospettano l’aumento dei crediti in
sofferenza nei bilanci delle banche.
L’intervento pubblico a salvaguardia e rilancio del sistema rischia di
non essere sufficiente: le banche irlandesi, per esempio, hanno un passivo
che ammonta a 9 volte il PIL del Paese; analogamente in Francia, Olanda e
Belgio in cui i passivi ammontano a 4 volte i rispettivi PIL nazionali. Italia
e Austria hanno un rapporto rispettivamente pari al 2,5 e 3,5 volte.
L’Ufficio Ricerca Macroeconomica di Intesa Sanpaolo denuncia che il
rischio in oggetto (relativo alle banche) sta diventando rischio sovrano. Il
mercato sembra avvalorare questa tesi, infatti, i credit default swap (CDS),
9
Secondo la società di ricerca Dealogic, le negoziazioni degli ABCP che alla fine del 2008
ammontano a 14,3 milioni di euro, hanno subito una drastica riduzione quantificabile in un
terzo nel periodo compeso tra il 2007 e l’ultimo trimestre del 2008.
10
Si fa riferimento al caso Lehman Brother.
11
Nei primi mesi del 2009 MorganStanley ha guadagnato il 22% e Goldman Sashs l’8%.
12
Nei primi mesi del 2009 le grandi banche d’affari hanno registrato perdite importanti pari
al: 72% per Bank of America; 78% per Citigroup; 59% per Wells Fargo; 37% per Ubs e
25% per Deutsche Bank.
192
le polizze che servono per assicurarsi contro l’insolvenza di qualunque
emittente obbligazionario, sono saliti vertiginosamente13.
A questo punto è necessario un chiarimento terminologico. Spesso si
associano i termini tossicità, nelle sue innumerevoli espressioni “toxic paper” o “toxic asset”, ai bond strutturati.
Tuttavia è necessario, ai fini di contestualizzare la crisi e circoscrivere
le reazioni spesso ingiustificate, quale sia il reale peso dei titoli non performing e, dove effettivamente, questi siano iscritti.
Le cartolarizzazioni e le obbligazioni strutturate in circolazione hanno un
valore nominale che supera gli 8.500 miliardi di euro, mentre il volume nozionale dei CDS14 è pari a 45.000 miliardi di euro. Se tutti i prodotti della finanza
strutturata, swap, CDS fossero considerati tossici, sarebbe necessario un progetto di “bonifica”15 di ampia portata quantificabile in oltre 53.000 miliardi di
euro. Tali dimensioni sono del tutto teoriche, in quanto per poter avere una visione analitica occorre definire la tossicità che non può e non deve essere confusa con la totalità dei titoli cartolarizzati, i CDS e i bond illiquidi.
Tabella 1 – Fonte Esf, Securitisation data Report, Banca dei regolamenti internazionali
Cartolarizzazioni in
Europa
USA
Asset Backed securities*
176
1.984
CDO (Collateralized Debt Obligation)
284
n.d.
RMBS**
848
4.573
CMBS***
139
401
Al 30 settembre 2008 in miliardi di euro.
Legenda: * Cartolarizzazioni di credito al consumo, carte di credito; ** Cartolarizzazioni di mutui
residenziali; *** Cartolarizzazioni di mutui commerciali.
Il mercato, intanto, ha elaborato una sua definizione di “tossico”. In
prima battuta, sono etichettati come “tossici”, ovvero danneggiano il bilan13
Il mercato stima che la probabilità di default per l’Inghilterra nei prossimi 5 anni sia pari
all’11%; per l’Italia al 13%; per gli USA, Francia e Germania al 6%. C’è da precisare che le
previsioni finanziarie devono essere considerate per l’informativa di massima che forniscono in merito all’umore dei mercati e non anche come indicazione di carattere assoluto in
quanto sottoposte all’influenza di diversi fattori (anche aleatori).
14
Come precedentemente introdotto, inerentemente al rischio sovrano, l’acronimo sta per
Credit Default Swap, si tratta di derivati sul credito che funzionano come un’assicurazione
contro il default dei debitori.
15
Tale progetto trova riscontro nella realtà nella pionieristica volontà di istituire la Bad Bank
che consiste in un’istituzione finanziaria realizzata per ospitare, previo trasferimento dalle
banche titolari, i titoli a elevato rischio.
193
cio della banca, tutti gli strumenti finanziari difficili da valutare a causa
della struttura troppo complessa o delle caratteristiche di estrema rischiosità
dell’operazione sottostante che li ha generati. In tale categoria rientrano le
cartolarizzazioni dei mutui subprime americani nonché i CDO collegati agli
stessi, si tratta in quest’ultimo caso di cartolarizzazioni. La tossicità deriva
dall’errata valutazione del rischio subprime e dal fatto che il tasso di default
potenziale dei subprime è stato ridotto da prodotti strutturati molto complessi come i CDO alle quali le agenzie di rating attribuivano un rating
molto elevato (spesso AAA). La potenziale tossicità di questa particolare
tipologia di operazioni contestualizzate alla realtà statunitense, ha contagiato tutte le cartolarizzazioni anche quelle europee costruite sui mutui residenziali caratterizzati da tassi di insolvenza molto bassi (2%). la medesima situazione ha caratterizzato anche le cartolarizzazioni effettuate su crediti al consumo. Analogamente per i CDO, soprattutto quelli sintetici costruiti con credit default swap.
L’illiquidità intrinseca di questi bond ha contribuito a far precipitare le
quotazioni. Pertanto, con il termine bond tossico si intende, in definitiva, il
più generico bond illiquido che ha un prezzo di mercato secondario sotto la
pari che non è necessariamente il suo vero valore. Così rientrano nella definizione molte obbligazioni di società che potrebbero subire gli effetti della
crisi economica in atto.
Quella che si è prospettata è una crisi che riguarda oltre che la finanza
anche l’economia reale, pertanto, le associazioni di categoria, gli organismi
nazionali pubblici competenti stanno lavorando con le autorità di vigilanza
al fine di individuare le modalità più opportune di soluzione dei problemi
che si sono manifestati.
Relativamente al mercato della cartolarizzazione, fortemente stressato
dagli eventi, si segnala l’iniziativa intrapresa dall’Australian Securitisation
Forum (AusSF), dall’American Securitisation Forum (ASF), dallo European Securitisation Forum (FSE) e dalla SIFMA che hanno organizzato una
serie di incontri con l’obiettivo di ristabilire la fiducia degli operatori su
questi strumenti finanziari.
Il risultato degli incontri è sintetizzato in una relazione contenente una
serie di best practices e raccomandazioni volte a ripristinare la fiducia sulle
operazioni di cartolarizzazioni a livello mondiale in cui si individuano
quattro azioni prioritarie d’intervento:
• migliorare la diffusione di informazioni inerente i titoli da cartolarizzazione;
• aumentare la trasparenza con la predisposizione di best practices operative;
194
•
•
ripristinare la credibilità del rating;
rafforzare la fiducia nelle valutazioni, le metodologie e le ipotesi.
Sia in Europa che negli Stati Uniti, particolare attenzione è rivolta all’aumento della trasparenza delle operazioni finanziarie e di quelle rivenienti da cartolarizzazione in particolare.
In Europa, sono state elaborate dieci iniziative16.
1. La prima, giunta a completamento, consiste nell’incrementare la trasparenza nei rapporti riguardanti le cartolarizzazioni al fine di promuovere
la corretta attuazione delle stesse.
2. La seconda, giunta a completamento, è la realizzazione di uno strumento che permetta di ottenere dati globali, aggiornati e comprensibili.
A tal fine è stata introdotta la relazione trimestrale che fornisce informazioni in merito all’emissione dei titoli, a eventuali sospensioni, ai
prezzi e tipo di investitori e luogo. L’obiettivo è quello di garantire la
trasparenza alle autorità di vigilanza che saranno supportate da un valido strumento nella loro attività di monitoraggio sul mercato.
3. La terza, giunta a completamento, consiste nello sviluppare e monitorare l’implementazione di Asset Backed Commercial Paper divulgandone
gli elementi caratteristici. La finalità è quella di promuovere una reportistica periodica che fornisca un’informativa coerente e completa agli
investitori che operano sul mercato ABCP.
4. La quarta, giunta a completamento solo parzialmente17, consiste nello sviluppare e monitorare l’implementazione delle emissioni di cartolarizzazioni e la loro trasparenza. L’obiettivo è incoraggiare la trasparenza così da
poter ottenere un flusso di informazioni riguardanti Residential Mortgage
Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateral
Debt Obligation, Asset Backed Securities e altre classi di attività.
5. La quinta, giunta a completamento, consiste nel garantire il libero accesso alle informazioni riguardati le transazioni passate e in corso al fine di facilitare, mettendo a disposizione informazioni da fonti illimitate
e l’accesso agli strumenti informativi.
6. La sesta, in corso di esecuzione, consiste nello sviluppo di portali internet al fine di consentire l’accesso on-line degli investitori e dei soggetti
a diverso titolo interessati in modo da poter avere informazioni senza
alcun costo (o a costo irrilevante).
7. La settima, giunta a completamento, consiste nel centralizzare l’accesso
ai RMBS, CDO attraverso il sito dell’ESF al fine di permettere l’accesso on-line agli emittenti e ai gestori di prodotti cartolarizzati.
16
17
Per maggiore dettaglio si rimanda a: www.europeansecuritisation.com.
L’iniziativa è giunta a completamento per i soli MBS.
195
8. L’ottava, giunta a completamento solo parzialmente18, consiste nel migliorare la standardizzazione e la digitalizzazione dei modelli di Reporting. L’obiettivo è da ricercarsi nello sviluppo di standard che riguardino
le varie fasi del processo, dall’emissione alla sorveglianza, che passa per
la realizzazione di formati documentali e informativi condivisi.
9. La nona, in corso di realizzazione, consiste nello standardizzare le definizioni al fine di sviluppare una terminologia non equivocabile all’interno dell’Unione Europea.
10. La decima consiste nello sviluppare la valutazione del merito di credito per
gli investitori e di valutazione il cui scopo è garantire agli investitori una
modalità per valutare autonomamente il credito di una transazione.
Negli Stati Uniti, tra le altre, è stato avviato dall’ASF un'iniziativa riguardante un progetto restart per lo sviluppo dettagliato di standard di mercato per i
titoli cartolarizzati. L’iniziativa riguarda i RMBS sotto una pluralità di punti di
vista: dalla standardizzazione e l’ampliamento dell’informativa relativa all’emissione e la successiva negoziazione dei titoli, all’offrire agli investitori
una maggiore accessibilità alle informazioni relative alle transazioni19.
Lo scenario attuale si caratterizza per la visione pessimistica dei portatori di interesse delle cartolarizzazioni. Il grafico riportato indaga in merito
al ripristino della fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni nel breve periodo che deve essere intesa come una priorità. L’ipotesi di partenza è la divisione dei fattori che possono riportare tale fiducia in quattro classi che
consistono nella: capacità di divulgazione dell’informativa, capacità di poter valutare scientemente il Collateral e attibuirvi un prezzo, capacità di
elaborare un sistema incentivante, capacità di rappresentare l’operazione. A
tali fattori viene attribuito un rating che ne decreta l’importanza relativa.
Tale importanza viene quasi parimenti attribuita alla divulgazione di informazioni riguardanti gli assets sottostanti e alla fiducia nei dati e nelle assunzioni derivanti dall’applicazione dei metodi di valutazione.
In un contesto caratterizzato da forte sfiducia nel sistema si assiste alla
ricerca di misure volte a contrastare la crisi che spesso si sostanziano in imponenti interventi pubblici.
Ecco che la soluzione al problema prospettato sembra la realizzazione
di un’istituzione finanziaria (probabilmente a matrice pubblica) che sia in
grado di poter dividere i titoli in base al loro reale valore e permettendo, così all’investitore di ritrovare la capacità di scegliere consciamente e la consequenziale fiducia nel sistema.
18
La fase è giunta a completamento per i soli RMBS e CMBS.
Per maggiore dettaglio in merito all’iniziativa si rimanda al sito www.americansecuriti
zation.com.
19
196
Figura 1 – Fonte SIFGA/ASF/ESF/AusSF Report: Restoring Confidence in the Securitisation Markets
2. Gli elementi caratteristici di un’operazione di asset securitization20
La securitization è: “The process whereby loans, receivables and
other financial assets are pooled together, with their cash flows or eco20
Per approfondimenti si vedano: Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing,
Egea, Milano; Aa. Vv. (1997), “Dossier titrisation”, Banque, n. 581, maggio; Gambaro M.
(1995), “La titolarizzazione dei crediti: come realizzare un’operazione in Italia”, in Lo sviluppo
della securitization in Italia, Bancaria, Roma; Colagrande F., Fiore L. F., Grimaldi M., Grandina D. (1999), Le operazioni di securitization. Caratteristiche, vantaggi e opportunità. Aspetti
operativi, giuridici e contabili, Il Sole 24 Ore, Milano; Pini G. (1995), “La securitisation: rischi
e ruolo del rating”, in Lo sviluppo della securitisation in Italia, Bancaria, Roma; Ferri G.
(1998), “La cartolarizzazione dei crediti. Vantaggi per le banche e accesso ai mercati finanziari
per le imprese italiane”, Studi e note di economia, n. 3; Stupazzini G. (1997), “I titoli garantiti
da crediti”, Amministrazione e Finanza, 12; Girino E. (1998), “Securitization, i crediti diventano titoli”, Amministrazione e Finanza, n. 5; Girino E. (1999), “Securitization, le nuove regole”,
Amministrazione e finanza, n. 11; Artina V. (1998), “Cessione dei crediti: le norme e le opportunità”, Amministrazione e Finanza, n. 19; Rocca E. (1999), “Securitization e rappresentazione
in bilancio”, Amministrazione e finanza, n. 11. Si veda inoltre il sito internet dell’European
Securitization Forum: www.Europeansecuritization.com e il sito www.securitization.it.
197
nomic values redirect to support payments on related securities. These securities […], are issued and sold to investors in the public and private
markets by or on behalf of issuers, who utilize securitization to finance
their business activities”21.
Questa definizione mette in luce, in sintesi, uno dei principali elementi
della cartolarizzazione la cui struttura è tale che il valore delle attività cedute non è legato alle caratteristiche dell’impresa, bensì alla capacità del
portafoglio stesso (collateral) di generare cash flow stabili e certi che siano
in grado di offrire una remunerazione adeguata all’investitore22.
In secondo luogo, la gestione dell’operazione è affidata a un soggetto
creato appositamente allo scopo, giuridicamente distinto dall’impresa cedente. Attraverso una securitization si realizza, pertanto, l’obiettivo di
rendere autonomamente negoziabili determinate classi di attività e ciò avviene utilizzando un soggetto finanziario “più efficiente” rispetto all’impresa titolare delle attività in esame23.
Gli assets che possono essere oggetto di una cartolarizzazione sono
molteplici, ma devono possedere requisiti comuni: devono essere idonei a
generare cash flow significativi e stabili, tali da essere coerenti con posizioni rischio-rendimento correnti sul mercato per attività finanziarie similari e, nell’ambito di una singola operazione, devono essere caratterizzati da
omogeneizzazione e standardizzazione in ordine alla durata, al rimborso e
al grado di rischio. A seconda del tipo di attività cartolarizzate sono solitamente individuate due tipologie di titoli: le mortgage backed securities
21
“La securitization può essere definita come il processo con cui i prestiti, i crediti e altri
assets finanziari sono aggregati, e i flussi di cassa o i valori economici da essi generati sono
reindirizzati a sostenere i pagamenti dei titoli emessi a seguito del processo. Tali titoli […],
sono emessi e venduti agli investitori sia sul mercato finanziario sia attraverso collocamenti
privati, direttamente o indirettamente dall’emittente, che utilizza la securitization per finanziare la propria attività” (cfr. European Securitization Forum, forum permanente costituito
appositamente per favorire la conoscenza e lo sviluppo della securitization in Europa. Per
quanto riportato cfr. European Securitisation Forum (1999), “European Securitization: A
Resource Guide”, www.europeansecuritization.net).
22
L’elemento suddetto potrebbe essere particolarmente apprezzato sul mercato italiano in
cui le imprese sono fortemente indebitate e hanno dimensioni tali da non essere “interessanti” per il mercato dei capitali. Allo stato attuale non è possibile tuttavia stimare quale
potrà essere l’impatto della cartolarizzazione sulle imprese di piccole e medie dimensioni
poiché la complessità dell’operazione e i costi da essa generati sono molto elevati.
23
Si veda in proposito anche, Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing,
Egea, Milano. L’autore propone un’ulteriore definizione dell’operazione di cartolarizzazione: “le banche d’affari in genere definiscono la securitization come una transazione nella
quale il cash flow futuro che deriva da un portafoglio di assets è riconfezionato nella forma
di titoli classati presso gli investitori”.
198
(MBS) per le operazioni che hanno per oggetto dei mutui e le asset backed
securities (ABS) per quelle che sono riferite ad altre classi di attività. La
prassi del mondo finanziario ha poi favorito il sorgere di moltissime altre
denominazioni e acronimi che spesso indicano delle varianti alle operazioni
principali o servono per individuare immediatamente il tipo di asset che è
stato cartolarizzato o il tipo di struttura di cartolarizzazione che si pone in
essere (si veda per esempio WBS, whole business securitization, ABCP, asset backed comercial paper, CDO-CBO ecc.).
2.1. La struttura dell’operazione
La cartolarizzazione è un’operazione molto complessa che coinvolge
una pluralità di soggetti ciascuno dei quali ha una funzione ben definita.
Nonostante tale complessità, dovuta alla possibilità infinita di varianti,
le securitization, sia sotto il profilo della struttura delle operazioni sia per
ciò che concerne la tipologia e il ruolo dei soggetti coinvolti, sono sostanzialmente omogenee24.
La prassi internazionale riconduce le operazioni di securitization
“tradizionali” in due strutture principali:
• pay-through: è il modello adottato in Italia con la legge 130/1999 e
consiste nell’emissione di titoli da parte di un soggetto giuridicamente
autonomo dall’originator (normalmente definito Special purpose vehicle) il cui cash flow è destinato ad acquisire gli assets cartolarizzati;
• pass-through: questo modello è caratterizzato dall’emissione di titoli
che attribuiscono all’investitore la proprietà di una parte del portafoglio
di assets cartolarizzati. I titoli emessi sono denominati pass-through
certificates.
Da quanto brevemente descritto in precedenza, si desume che il legislatore
nazionale ha inteso disciplinare la securitization con struttura pay-through.
A titolo meramente esemplificativo, è possibile individuare le fasi di
un’operazione tipo (si veda fig. 2)25:
24
Per tale motivo, la struttura dell’operazione descritta nel presente lavoro, pur se riferiti in
maniera specifica alla cartolarizzazione dei crediti commerciali, sono agevolmente utilizzabili anche per securitization riferite ad altre classi di attivo.
25
Si veda in proposito anche, Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing,
Egea, Milano. Alle fasi citate che presuppongono che l’originator imposti e realizzi autonomamente un’operazione di cartolarizzazione, nella prassi nel sono aggiunte altre due: la prima
consiste nella scelta dell’advisor indipendente nazionale e internazionale (a seconda delle caratteristiche dell’emissione) che assisterà l’originator in ogni fase dell’operazione. La seconda
consiste nella scelta dell’arranger che, solitamente, è una banca d’affari o una primaria banca
199
selezione, da parte dell’originator, degli assets da cartolarizzare26;
costituzione dello special purpose vehicle, società di scopo costituita
sotto forma di società di capitali, autonoma rispetto all’originator, che
deve acquisire da quest’ultimo gli assets finanziando l’operazione attraverso l’emissione di titoli sul mercato27;
• cessione allo special purpose vehicle degli assets individuati dall’originator;
• definizione delle caratteristiche dei titoli che saranno emessi e individuazione delle modalità ottimali di collocamento sul mercato in funzione delle caratteristiche del portafoglio di assets e in considerazione
della domanda corrente sul mercato finanziario;
• individuazione dell’eventuale credit enhancer28;
• individuazione della società di rating che deve valutare l’emissione29;
• emissione e collocamento dei titoli presso gli investitori. in questa fase
può essere necessario avvalersi di un operatore specializzato;
• gestione e amministrazione degli assets e dei pagamenti effettuati dalla
clientela (attraverso il servicer30).
• rimborso dei titoli ABS31.
La fig. 2 rappresenta schematicamente lo svolgimento dell’operazione
ed evidenzia, ove esistenti, i flussi finanziari connessi alle singole fasi32.
•
•
internazionale, che si occupa della strutturazione dell’operazione finanziaria sul mercato e del
collocamento dei titoli. Talvolta l’arranger svolge anche il ruolo di advisor. Per il collocamento
dei titoli ABS sul mercato, come avremo modo di ribadire nel proseguio, ci si può avvalere
anche di un soggetto ad hoc.
26
In questa operazione l’impresa deve tener conto non del valore nominale dei crediti bensì
del loro valore di realizzo cui è commisurato il valore dei titoli che saranno emessi sul mercato. Il credit rating degli strumenti mobiliari oggetto di emissione, infatti, dipende dalla
qualità del collateral dell’emissione stessa.
27
Si veda in proposito anche il par. 2.3.
28
Il credit enhancement è la garanzia fornita da soggetti terzi specializzati sulla possibilità di
rimborso dei titoli.
29
Sulla funzione della società di rating si veda il par. 2.6.
30
Il servicer è il soggetto che si occupa della gestione del patrimonio cartolarizzato.
31
Il rimborso delle ABS avviene sulla base di un piano finanziario definito in funzione dei
cash flow generato dal collateral.
Questo piano può avere una duplice struttura: può prevedere un rapporto diretto tra le
scadenze dei titoli ABS e gli attivi che maturano e generano cash flow. Oppure si può dare
luogo a operazioni rotative (revolving) in cui gli assets oggetto di cartolarizzazione vengono
ceduti e portati a scadenza periodicamente via via che si formano nel bilancio dell’originator per un certo periodo di tempo.
32
Le linee tratteggiate indicano che l’operazione può essere strutturata anche non individuando in modo specifico i soggetti indicati.
200
201
Altri
partecipanti
Originator n
(asset seller)
Originator 1
(asset seller)
Rating
Agency
Cash flow
Credit enhancement
Special Purpose
Vehicle
(SPV o SCC)
Servicer
• Rapporti con
debitori
• Centralizza gli
incassi
Emissione del rating
Prezzo di vendita
Flussi di cassa correntil port.
Vendita del portafoglio
Cessione degli assets allo SPV
Figura 2 – Struttura dell’operazione di cartolarizzazione
debitori
debitori
investitori
Titoli emessi:
• senior (AA)
• mezzanine (A)
• subordinated (BB)
• equity (unrated)
Pagamento interessi
Prezzo di vendita
collocamento
Pagamento degli interessi
Consorzio
di
collocamen
to
Gestore fiduciario
(trustee –
eventuale)
Prezzo di
vendita
collocamento
Emissione titoli ABS
I principali soggetti coinvolti in un’operazione di cartolarizzazione sono quindi i seguenti: l’originator (impresa cedente) o gli originators in caso
di operazione multiseller, lo special purpose vehicle (cessionario ed emittente titoli33), la società di rating, il credit enhancer, il servicer. Ciascuno di
questi svolge, come accennato in precedenza, un ruolo ben definito nell’operazione e persegue finalità differenti. Assieme a questi protagonisti,
esistono altre figure che svolgono ruoli di rilievo, ma che sono meramente
strumentali al buon esito dell’operazione.
2.2. I rischi connessi a un’operazione di securitization
Alle operazioni di securitization sono connessi dei rischi, insiti nella
tecnica stessa dell’operazione, che si riflettono sul funding e sul costo complessivo delle stesse. Le tipologie di rischio più diffuse sono le seguenti34.
Rischio di credito. Il rischio di credito (default ratio) può essere definito come la probabilità che si verifichi un ritardato pagamento da parte del
debitore. Generalmente il credito ceduto si considera insolvente a fronte di
ritardi di pagamento che superano una determinata soglia critica desunta
sulla base di rilevazioni statistiche.
Uno dei vincoli più stringenti all’emissione di ABS è la capacità dell’attivo sottostante di rispettare determinati indici di perfomance (esempio
default ratio inferiore al 3%).
A sua volta la qualità del collaterale unitamente alle diverse forme di
credit enhancement determina il rating del titolo ABS, che poi identifica la
probabilità di inadempimento attribuitogli dalle agenzie di rating.
Rischio di liquidità. Il rischio di liquidità consiste nella probabilità
che divenga impossibile vendere sul mercato un particolare ABS (in
qualsiasi momento) a un prezzo che si avvicina ragionevolmente al suo
valore intrinseco.
Il livello di liquidità per ogni singolo ABS dipende da molti fattori,
33
Lo Special purpose vehicle potrebbe anche non essere il soggetto che emette i titoli sul
mercato.
34
Si veda in proposito Lanteri L., Scura E. (2001), “La cartolarizzazione dei crediti e le
politiche di bilancio nelle imprese corporate”, in La cartolarizzazione nelle imprese non finanziarie: aspetti teorici, strategici ed operativi, Progetto Fin.Te.Ma., Quaderno n. 3, dicembre, Egea, Milano.; De Angeli S., Oriani M. (a cura di) (2000), La securitization dei
crediti bancari, FrancoAngeli, Milano.
202
incluse le caratteristiche percepite della domanda e dell’offerta, la dimensione del mercato, le performance dell’attivo sottostante, l’andamento dei tassi d’interesse. Una delle più importanti unità di misura
della liquidità è la differenza tra il prezzo di domanda e il prezzo
d’offerta quotati da un dealer per gli ABS: all’aumentare dello spread,
si accresce il rischio di liquidità percepito.
Rischio di pagamento anticipato. Il rischio di pagamento anticipato
consiste nella probabilità di ricevere tutto o parte del capitale dell’attivo
sottostante prima del termine dovuto (attivi ammortizzabili) o previsto (attivi non ammortizzabili). La raccolta dei pagamenti prima del previsto cash
out a servizio del collaterale comporta un rischio di re-investimento.
Dalla valutazione di tale tipologia di rischio discende la determinazione
della durata degli ABS e in ultima analisi del relativo rendimento. Per determinate tipologie di attivi (per esempio mutui fondiari), l’aumento dei pagamenti anticipati è direttamente correlato all’andamento dei tassi d’interesse sul mercato.
Rischio di tasso d’interesse. Il rischio di tasso di interesse è legato alla
trasformazione delle scadenze e dei tassi che normalmente caratterizzano le
emissioni ABS. In particolare le modalità di produrre interessi degli attivi
sottostanti difficilmente possono coincidere in maniera puntuale con i pagamenti a servizio dei titoli obbligazionari. Inoltre, qualora i titoli ABS siano emessi a reddito fisso, i relativi prezzi fluttuano in relazione alle variazioni dei tassi di interesse e della situazione economica generale. Viceversa
i prezzi di ABS a tasso variabile, ovviamente sono molto meno reattivi rispetto al mercato, dal momento che l’indice a fronte del quale si ridefinisce
periodicamente il tasso corrente riflette le variazioni di mercato.
Rischio di ammortamento anticipato. La maggior parte delle emissioni revolving sono soggette meccanismi di ammortamento anticipato denominati anche “payout events” o “early calls”. Esistono dunque tipologie
di eventi prefissati tassativamente (per esempio pagamenti insufficienti da
parte dei debitori ceduti; aumento del defaul ratio sull’attivo ceduto al di
sopra di una determinata soglia; contrazione del livello di overcollateralisation al di sotto di un dato valore) che innescano anticipatamente il piano
di ammortamento, il quale una volta innescato non può essere revocato, né
interrotto. Con l’ammortamento anticipato, il periodo revolving si chiude
così come il periodo di ammortamento controllato, oppure, se del caso,
quello di accumulazione. Il rimborso accelerato dunque funge da ulteriore
203
protezione per gli investitori e, proprio per questo, è richiesto espressamente dalle agenzie di rating.
2.3. L’originator
L’originator è il soggetto che avvia l’operazione di cartolarizzazione.
Gli obiettivi più rilevanti che l’originator si propone di conseguire attraverso la cartolarizzazione possono essere raggruppati nel modo seguente:
operazioni di “sistemazione” del bilancio, ricorso a nuove fonti di finanziamento e riequilibrio della struttura finanziaria, riduzione dei costi di finanziamento e riduzione del profilo di rischio a essa connesso.
Per ciò che concerne l’utilizzo della cartolarizzazione per “sistemazioni” di bilancio, è necessario distinguere due aspetti: da un lato, infatti,
l’operazione di securitization configura una cessione dei crediti iscritti in
bilancio con la conseguente eliminazione di tali crediti dai prospetti contabili. Dall’altro lato, consente di migliorare i quozienti di solvibilità e il rapporto di indebitamento con benefici effetti sulla possibilità di utilizzo della
leva finanziaria e sulla redditività complessiva della gestione35.
Questo aspetto è, però, soltanto il risultato esteriore dell’operazione di
cartolarizzazione. I maggiori vantaggi sono, infatti, conseguiti in termini di:
• riequilibrio della struttura finanziaria. Attraverso la cessione degli assets l’originator realizza risorse liquide che può utilizzare per estinguere fonti troppo onerose o finanziamenti contratti a condizioni non convenienti;
• diversificazione delle fonti di finanziamento. Le risorse liberate attraverso la cartolarizzazione possono essere utilizzate per effettuare nuovi
investimenti produttivi36;
• riduzione dei costi di finanziamento. Il costo delle operazioni di securitization è connesso, infatti, alla qualità degli assets ceduti e alla tipologia dell’operazione che si intende realizzare e non ai comuni parametri di determinazione dell’affidabilità di un’impresa. Il costo complessivo di un’operazione potrebbe, pertanto, essere inferiore per
un’impresa a quello di un’altra fonte di finanziamento tradizionale;
35
Il miglioramento degli indicatori finanziari, e in particolare di quello di indebitamento, è
connesso più che all’operazione di cartolarizzazione in sé, all’utilizzo delle risorse finanziarie che sono acquisite con la sua realizzazione.
36
Nel caso di imprese con elevato profilo di rischio o con scarse possibilità di accesso ulteriore al credito o, ancora, con crediti non performing in portafoglio, la cartolarizzazione costituisce una fonte di finanziamento alternativa svincolata dalle caratteristiche dell’impresa.
204
•
miglioramento del profilo rischio connesso. La realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione riduce infatti:
– il rischio di liquidità, dovuto alla necessità di finanziare gli assets
in oggetto per tutta la loro vita utile;
– il rischio legato all’andamento dei tassi di interesse, poiché tale rischio viene trasferito ai titolari delle securities37;
– il rischio di portafoglio, attraverso la “dismissione selettiva” degli
assets che contribuisce a un miglioramento del merito creditizio38.
L’attività più importante che l’originator pone in essere è quella di individuazione degli assets che saranno oggetto di securitization. Nel progettare l’operazione è necessario tenere in adeguata considerazione sia le
caratteristiche del mercato finanziario su cui si procederà a negoziare i titoli, sia le caratteristiche della domanda sul medesimo mercato39. In questa
attività l’originator deve valutare, quindi, una pluralità di elementi tra cui:
le caratteristiche degli assets, particolarmente in ordine alla natura, diversificazione e liquidabilità, i vincoli di natura legislativa e fiscale40 alla cessione e, più in generale, la fattibilità e la convenienza complessiva dell’operazione nonché i tempi di effettuazione della stessa.
I requisiti principali che un portafoglio di assets deve possedere al
fine di essere oggetto di una securitization possono essere sintetizzati
come segue41:
• stabilità dei flussi di cassa associati;
• elevata trasparenza al fine di ridurre al minimo il rischio di asimmetrie
informative;
• livello di diversificazione coerente con il rischio-rendimento atteso dai
possibili investitori;
• elevata affidabilità dei terzi coinvolti: credit enhancers, società di rating, servicers;
• scadenze di pagamento frequenti e flessibilità nella loro gestione42.
37
Salvo particolari forme di garanzia che devono essere prestate su specifiche tranches di
cartolarizzazioni.
38
Si veda in proposito Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing, Egea, Milano.
39
Spesso, per progettare e seguire la cartolarizzazione, l’originator conferisce l’incarico a
un soggetto specializzato denominato Arranger. Questo opera secondo un mandato contenente gli elementi generali dell’operazione e gli obiettivi minimi che l’originator intende
conseguire.
40
Si veda in proposito il par. 5.
41
Si veda in proposito Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing, Egea, Milano.
42
Questo requisito è molto utile, per esempio, nei casi di elevata stagionalità del settore di
riferimento dell’originator.
205
Viste le sue caratteristiche, la cartolarizzazione sembrerebbe offrire una
rilevante opportunità di accesso al mercato dei capitali anche per imprese di
medie dimensioni e in particolare per quelle in fase di start-up e con notevoli
tassi di crescita43. A queste ultime, infatti, è spesso associato un elevato livello di rischio che limita notevolmente la possibilità e la capacità di accedere a fonti di finanziamento di tipo tradizionale. L’attuazione di un’operazione
di cartolarizzazione potrebbe, invece, consentire alle imprese di reperire risorse finanziarie indipendentemente dal profilo di rischio connesso all’impresa e quindi in modo più agevole e più conveniente. Purtroppo, queste
imprese non sono sempre in grado di selezionare nel proprio attivo degli assets tali da rendere conveniente un’operazione di securitization. Gli operatori
specializzati hanno superato il problema costituendo delle società ad hoc con
l’obiettivo di costituire portafogli omogenei rispetto ai requisiti individuati,
ma con assets provenienti da differenti originator44. Un’importante opportunità di finanziamento è offerta alle imprese appartenenti a un medesimo settore/comparto industriale o a uno stesso distretto: in questi casi, infatti, nonostante la ridotta dimensione dei singoli originators, l’insieme delle imprese
risponde a quelle caratteristiche di stabilità dei flussi di cassa e di massa critica che consentono la realizzazione dell’operazione.
Con particolare riguardo alla legge 130/1999, il nostro legislatore ha
stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano “alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili anche in blocco”, a una società
specializzata nel compimento di tali operazioni (art. 1 lett. a) alla quale si
impone il vincolo di destinazione delle somme corrisposte dal debitore o
dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi
nonché al pagamento dei costi dell’operazione (art. 1 lett. b).
In ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti, la norma lascia ampio
spazio agli operatori: non si esclude, infatti, la possibilità di cartolarizzare
crediti di difficile esigibilità (non performing).
43
Tra le imprese con elevati tassi di crescita vi sono per esempio, quelle operanti nei settori
ad alta tecnologia, come telecomunicazioni, informatica, Internet.
44
Questo tipo di cartolarizzazione, applicabile attraverso una particolare struttura alla
realtà italiana, è in corso di studio da parte dello scrivente che la ha provvisoriamente definita “cartolarizzazione cooperativa” o “cartolarizzazione distrettuale”. Si tratta di una
cartolarizzazione multiseller fondata su una struttura ABCP in cui è previsto l’intervento
di particolari operatori strettamente connesso con l’economia locale. Attualmente se ne
sta testando la fattibilità su un settore dell’economia Toscana in collaborazione con
l’Associazione degli industriali della Provincia di Firenze e di alcune banche internazionali specializzate. Questo tipo di operazione e i risultati della ricerca sul campo saranno
oggetto di una prossima pubblicazione.
206
La legge 130/1999 ha previsto che la cartolarizzazione riguardi la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti. Con questa ultima
espressione il legislatore ha voluto fare un esplicito rinvio all’art. 58 TUB e
alle istruzioni di vigilanza (aggiornamento n. 132 del 5 dicembre 1996)
nelle quali si definiscono le cessioni in blocco come un’operazione unitaria
di trasferimento che comporti il trapasso in un unico contesto temporale, di
una pluralità di crediti che presentano un comune elemento distintivo. È
evidente che, per esigenze di tutela dei terzi, i crediti ceduti in blocco devono essere chiaramente individuati anche nell’avviso da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale45. Tuttavia, in ordine alle modalità di individuazione dei
crediti ceduti in blocco, la legge 130/1999 non è chiara e quindi i criteri con
cui procedere sono rimessi alla prassi. Tale incertezza legislativa potrebbe
avere effetti di rilievo nel caso di cessione di crediti futuri o di operazioni
revolving in cui l’individuazione dei crediti è ancora meno agevole.
Relativamente alle modalità di cessione, la ratio della norma, nonostante
che il testo di legge (art. 4 L. 130/1999) non preveda un’esplicita disciplina
circa il trasferimento dei crediti allo special purpose vehicle (pro soluto oppure pro solvendo), sembra voler favorire quei contratti di cessione che configurano la definitiva uscita dei crediti dal patrimonio del cedente in considerazione del fatto che i crediti stessi sono legati all’emissione dei titoli che devono finanziare l’intera operazione. Un’eventuale cessione pro solvendo, oltre a essere non conforme allo spirito della norma, sarebbe penalizzata dal
punto di vista fiscale: l’amministrazione finanziaria potrebbe, infatti, contestare la deducibilità delle eventuali perdite realizzate su crediti poiché mancherebbero i requisiti previsti dall’art. 66 TUIR46.
2.4. Special purpose vehicle
Lo special purpose vehicle (società per la cartolarizzazione dei crediti –
SCC – secondo la normativa italiana) è il soggetto che è costituito appositamente per l’acquisto dei crediti dell’originator. Questo soggetto ha, quin45
Si veda in proposito Pardolesi R. (1999), “La cartolarizzazione dei crediti in Italia: commentario alla legge 130/99”, Quaderni di giurisprudenza commerciale.
46
L’art. 66 del TUIR dispone che le perdite su crediti, affinché siano deducibili, devono risultare da elementi certi e precisi. In generale, la deduzione della perdita realizzata su crediti, è consentita solo quando assume caratteri di inevitabilità e risponde a una scelta di convenienza oggettiva dell’imprenditore (Ris. Min. 9 aprile 1980 n. 9/557). Nel caso specifico di
cessione del credito a prezzo inferiore a quello nominale, la differenza è ammessa in deduzione solo nel caso di cessione pro soluto (Ris. Min. 13 marzo 1983 n. 9/634).
207
di, la funzione di separare gli assets ceduti dai valori di bilancio della cedente. Per questo motivo, lo special purpose vehicle non deve avere alcun
legame di natura giuridica con l’originator e deve limitare la sua attività al
solo acquisto di uno o più portafogli di crediti47.
L’attività e le caratteristiche della società per la cartolarizzazione sono
specificate nell’art. 3 della legge 130/1999.
Questa disposizione individua l’oggetto sociale esclusivo dello Special
purpose vehicle nella “realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti” e ne circoscrive la funzione istituzionale. Il veicolo è caratterizzato inoltre, da durata limitata, costi di gestione ridotti, e operatività
ridotta al ruolo di parte attiva nella cessione dei crediti e solo eventualmente all’emissione dei titoli48. L’analisi del contenuto della norma ci consente di esprimere due considerazioni: con opportuni accorgimenti organizzativi che garantiscano la separazione patrimoniale, è possibile realizzare
con un medesimo special purpose vehicle, molteplici operazioni di cartolarizzazione. Inoltre, non è necessario che vi sia identità tra lo special purpose vehicle e l’emittente titoli: nel caso in cui si verifichi una situazione del
genere solo lo special purpose vehicle dovrà avere i requisiti previsti dalla
normativa in esame e in particolare quelli previsti per l’oggetto sociale.
Per ciò che concerne la forma societaria e la dotazione patrimoniale, la
L. 130/1999 rinvia espressamente al TUB – Titolo V e cioè alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario. Le società per la cartolarizzazione dovranno pertanto essere iscritte nell’elenco speciale tenuto presso
l’UIC e i suoi esponenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge 147/1998.
Lo special purpose vehicle è generalmente thin capitalized49. La ragione della thin capitalisation risiede nella funzione stessa del soggetto, costituito unicamente per realizzare l’operazione, nel fatto che la garanzia offerta ai terzi sottoscrittori dei titoli emessi dallo special purpose vehicle non
è il patrimonio dell’impresa bensì gli assets a essi sottostanti, eccetto
eventuali meccanismi di credit enhancement.
47
Cfr. Gambaro M. (1995), “La titolarizzazione dei crediti: come realizzare un’operazione
in Italia”, in Lo sviluppo della securitization in Italia, Bancaria, Roma. Si veda inoltre nel
proseguio del lavoro quanto si dirà sulle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla
legge 130/1999.
48
Si veda in proposito Napolitano G. (1999), “Commento alla l. 30 aprile 1999, n. 130, recante ‘disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti’”, Impresa comm. ind., p. 1297; e Pardolesi R. (1999), “La cartolarizzazione dei crediti in Italia: commentario alla legge 130/99”,
Quaderni di giurisprudenza commerciale.
49
Cioè con basso livello di capitalizzazione. È da valutare l’eventuale impatto della recente
riforma fiscale sulla struttura e sull’operatività delle cartolarizzazioni.
208
Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività dello Special purpose vehicle avviene mediante emissione di titoli.
La società per la cartolarizzazione, cessionaria dei crediti, può anche non
coincidere con il soggetto emittente i titoli ABS50.
Al fine di comprendere quali siano le modalità con cui le Special purpose vehicle possono svolgere la propria attività nel rispetto delle norme
vigenti sul mercato domestico, è necessario analizzare il provvedimento
della Banca d’Italia del 23 agosto 2000: in tale disposizione vengono individuati dei criteri-guida sia per ciò che concerne l’operatività delle Special
purpose vehicle sia per quanto riguarda gli adempimenti di carattere informativo-contabile cui le stesse devono attenersi.
Le Special purpose vehicle, oltre alle caratteristiche già evidenziate,
hanno l’obbligo di porre in essere soltanto attività compatibili con l’interesse dei portatori dei titoli. A tale fine devono porre particolare attenzione
alla “separatezza patrimoniale”, alla trasparenza delle operazioni effettuate
e alla realizzazione di operazioni finalizzate solo al raggiungimento degli
obiettivi della cartolarizzazione in essere.
In particolare, l’elemento che caratterizza la cartolarizzazione è il principio della segregazione patrimoniale evidenziato nel combinato disposto
dell’art. 1 lett. b) e dell’art. 3 comma 2: secondo tale principio, ciascuna
emissione di titoli è funzionale al gruppo di crediti acquistati dalla società
veicolo e il titolo emesso dalla società cessionaria o dalla società emittente
non è garantito dal patrimonio della società, ma dai soli crediti relativi all’operazione. Una analisi approfondita della disposizione citata ci consente
di ribadire che solo i titolari dei diritti sui titoli emessi possono compiere
azioni sul patrimonio “segregato”, mentre, i creditori particolari della società possono rivalersi, per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte
dalla società per la cartolarizzazione, solo sul patrimonio di quest’ultima.
Ai titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione si applicano le disposizioni del TU dell’intermediazione finanziaria (D.lgs. 58 del 1998). L’art.
5 della L. 130/1999 dispone che i titoli emessi per finanziare l’acquisto dei
crediti sono soggetti al controllo della Banca d’Italia con applicazione delle
relative sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni della stessa.
All’emissione di titoli non si applicano:
• il divieto di raccolta diretta di risparmio tra il pubblico previsto dall’art.
11 del TUB;
• i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa in vigore;
50
La Special purpose company se diversa dalla Special purpose vehicle si occupa soltanto di
emettere i titoli ABS sul mercato al momento del closing dell’operazione.
209
•
gli artt. dal 2410 al 2420 c.c., aventi a oggetto i limiti all’emissione di
obbligazioni, il deposito e l’iscrizione della deliberazione, la riduzione
del capitale sociale, il contenuto delle obbligazioni, la costituzione
delle garanzie, l’assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune degli obbligazionisti, l’azione individuale degli obbligazionisti e
il sorteggio delle obbligazioni.
In tale modo, il legislatore ha voluto eliminare molte delle limitazioni
che fino a ora hanno impedito lo sviluppo della securitization in Italia.
L’inapplicabilità dei limiti suddetti e l’esclusione dall’art. 11 del TUB
trovano fondamento logico nella stessa struttura dell’operazione di cartolarizzazione e in particolare nel principio di segregazione patrimoniale;
poiché, infatti, lo special purpose vehicle non è responsabile patrimonialmente per il rimborso dei titoli emessi, che sono garantiti unicamente
dai crediti ceduti o dal credit enhancer51, non è necessario imporre le
cautele proprie degli emittenti responsabili di cui all’art 2740 CC ai quali,
in carenza di adeguata patrimonializzazione, è inibito il ricorso al prestito
obbligazionario52.
2.5. Tecniche di Credit enhancement
La presenza di garanzie ovvero di terzi soggetti che garantiscano il
buon esito dell’operazione, il cosiddetto credit enhancement, non è obbligatoria per la realizzazione della stessa, ma è importante per il suo classamento. Nel corso del tempo infatti, le operazioni di securitization, sono diventate sempre più complesse e caratterizzate da assets sempre più eterogenei; ogni qualvolta la struttura dell’operazione presenta profili di rischio
troppo elevati, è necessario ricorrere a meccanismi di garanzia, per favorirne un buon accoglimento dei titoli da parte del mercato.
A fini meramente classificatori, gli strumenti di credit enhancement più
diffusi possono essere distinti in interni ed esterni in base alle proprie caratteristiche53:
51
Il credit enhancement è la garanzia fornita da soggetti terzi specializzati sulla possibilità di
rimborso dei titoli. Per maggiori dettagli si veda quanto già esposto in precedenza.
52
Cfr. Napolitano G. (1999), “Commento alla l. 30 aprile 1999, n. 130, recante ‘disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti’”, Impresa comm. ind., p. 1297.
53
Si veda in proposito Colagrande F., Fiore L. F., Grimaldi M., Grandina D. (1999), Le operazioni di securitization. Caratteristiche, vantaggi e opportunità. Aspetti operativi, giuridici
e contabili, Il Sole 24 Ore, Milano; Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing,
Egea, Milano. Si veda inoltre European Securitization Forum (2002), “European Securitization: A Resource Guide”, www.europeansecuritization.net.
210
Tecniche di credit enhancement interno. La maggior parte delle
emissioni di titoli ABS sono assistite da forme di credit enhancement interno. Le più diffuse sul mercato internazionale sono le seguenti.
• Subordinazione. Una tipologia estremamente diffusa di credit enhancement è la struttura senior/subordinated (o A/B). Tecnicamente la
stessa richiama la figura dell’overcollateralization. È caratterizzata da
una tranche di rischio di titoli senior (o A) e da una o più fasce di rischio subordinate (B, C ecc.) che forniscono protezione alla tranche A.
Eventuali perdite di asset inclusi nel collateral vengono in primo luogo
assorbite dai titoli subordinati. Gli ABS della tranche senior (A) non
vengono intaccati fintanto che le perdite gravanti sul veicolo emittente
non eccedano l’ammontare delle tranche subordinate. La tranche senior grazie al meccanismo di subordinazione rappresenta la quota dell’emissione ABS valutata con il rating più elevato (esempio AAA),
mentre le fasce di rischio subordinate presentano qualità inferiore (ma
presumibilmente a rendimento maggiore) ricevendo un rating minore
ovvero risultando unrated. Queste tranche sono spesso sottoscritte dallo
stesso originator.
• Overcollateralization. In questo caso l’ammontare nominale del financial asset pool oggetto di cessione è maggiore di quello del titolo che
sostiene. In definitiva l’outstanding dell’emissione risulta superiore al
controvalore nominale della stessa.
• Yield Spread (Excess Spread). La “gestione per eccesso”, costituisce la
prima difesa contro le perdite. È l’ammontare netto del pagamento
(corresponsione) degli interessi dagli attivi dopo che sono stati pagati i
detentori delle obbligazioni e le spese. Lo spread mensile per eccesso è
impiegato per coprire le perdite del periodo corrente e può essere versato in un fondo di riserva per aumentare il credit enhancement.
• Reserve Fund è un fondo separato, creato dall’emittente per rimborsare
eventuali perdite, sino all’ammontare della riserva.
Tecniche di credit enhancement esterno. In alternativa alle tecniche
di credit enhancement interno o, sempre più spesso, in modo complementare a queste, il mercato ha sviluppato un elevato numero di tecniche definite
“esterne”. Queste forme di garanzia hanno il pregio di fornire, al contrario
di quelle interne, un sostegno “indipendente” rispetto ai soggetti che pongono in essere le operazioni di cartolarizzazione. Tale caratteristica genera
solitamente un maggior apprezzamento del mercato che si traduce in una
riduzione del costo complessivo dell’operazione.
Le principali tecniche di credit enhancement esterno sono le seguenti.
211
•
Cauzioni (garanzie/fideiussioni). Una cauzione è una polizza assicurativa
fornita da una compagnia assicurativa quotata a protezione di una più
tranche di una particolare emissione ABS. La protezione garantisce la
copertura di qualsiasi perdita nella quale il veicolo possa incorrere (sia
capitale sia interesse). Nel caso in cui i titoli ABS in oggetto presentino
requisiti minimi per gli investitori (cioè rating BBB/Baa o equivalenti), la
garanzia può essere fornita da parte dello stesso originator (se dotato di
rating elevato). Normalmente ciò comporta uno o più livelli di credit enhancement, che copriranno le perdite prima della polizza assicurativa. A
evidenza un ABS assicurato ha la stessa valutazione dei rating claimspaying delle compagnie di assicurazione, generalmente tripla-A, in
quanto la compagnia di assicurazione garantisce il pagamento.
• Garanzie di terzi o società del gruppo. Un terzo – per esempio una
compagnia assicurativa quotata o una società del gruppo – si impegna a
rimborsare il trust delle perdite sino a un ammontare prestabilito massimo. Può anche concordare di anticipare il capitale e l’interesse, ove
necessario, e riacquistare i prestiti non onorati.
• Lettere di credito. Sono emesse da istituti finanziari, solitamente banche, cui è corrisposta una commissione; consentono di avere la liquidità
necessaria a rimborsare il trust di qualsiasi perdita realmente subita, sino all’ammontare del credit enhancement richiesto.
• Conto corrente collaterale (aggiuntivo). In questo caso l’emittente si
fa prestare la quantità di credit enhancement necessaria da una banca
commerciale e successivamente investe quella somma in titoli a breve
termine (un mese) a tassi maggiori. Poiché si tratta di un vero e proprio deposito in contanti – a differenza della lettera di credito che
rappresenta una promessa di pagamento – un eventuale downgrading
del fornitore di conto corrente collaterale non comporta un downgrading dell’emissione.
• Collateral Invested Amount. È simile a una tranche subordinata e può
essere acquistato su base negoziale da un terzo garante o cartolarizzato
con un collocamento privato.
Il ruolo di credit enhancer esterno è svolto principalmente da istituti di
credito, da compagnie di assicurazione e da agenzie specializzate.
2.6. Società di rating
Il rating è uno strumento che negli attuali mercati finanziari assume un
rilievo sempre maggiore. In genere, mediante il rating il potenziale investito-
212
re acquisisce una valutazione della rischiosità dell’investimento e può agevolmente confrontare le diverse opportunità che gli sono offerte dal mercato
finanziario. Proprio questa funzione rappresenta il motivo principale per cui
anche il legislatore ha previsto l’obbligo di sottoporre a rating le operazioni
di cartolarizzazione. Infatti, “la complessità di un’operazione di cartolarizzazione e della struttura di garanzie che a questa si collegano, può rendere difficile a un investitore la valutazione diretta della validità del titolo”54. È, pertanto, necessario, per gli investitori, poter disporre di un giudizio sintetico
con cui valutare la coerenza tra il rischio e il rendimento connessi all’operazione; tale giudizio è espresso dalle società di rating55.
La legge 130/1999, tuttavia, prevede l’obbligo di rating solo per le operazioni per le quali è previsto un collocamento presso il pubblico56. Proprio
il particolare ruolo di garanzia degli investitori non professionali che la legge assegna alle società di rating, ha spinto la Consob a emanare uno specifico provvedimento in cui si precisano i requisiti di professionalità e di indipendenza che devono essere posseduti dai soggetti in argomento57.
I punti principali della delibera Consob possono essere sintetizzati come segue.
• Requisiti di professionalità: gli operatori di rating devono essere costituiti
in forma societaria e devono assicurare, nella formulazione del giudizio,
esperienza58, riservatezza, adeguatezza della struttura di valutazione. Tali
requisiti si considerano posseduti da operatori attivi sul mercato europeo
da almeno tre anni nel campo delle valutazioni del merito del credito.
• Requisiti di indipendenza: la delibera Consob pone particolare attenzione all’argomento. L’organismo di vigilanza dei mercati dispone infatti che la valutazione del merito del credito non può essere effettuata
da società che si trovino a essere controllati o controllanti o collegate,
direttamente o indirettamente, a soggetti che partecipano all’operazione59. Al fine di individuare le ipotesi di controllo e collegamento si
54
Cfr. Gambaro M. (1995), “La titolarizzazione dei crediti: come realizzare un’operazione
in Italia”, in Lo sviluppo della securitization in Italia, Bancaria, Roma.
55
L’attendibilità del rating dipende dalla professionalità e dall’affidabilità delle società che
lo effettuano. A tale proposito la Consob ha emanato un proprio regolamento con cui dovrebbe individuare i requisiti di professionalità e di indipendenza delle società di rating.
56
Si veda art. 2, comma 4, della legge 130/1999.
57
Cfr. delibera Consob 12175 del 2 novembre 1999.
58
L’esperienza professionale è assicurata quando il giudizio è formulato con il concorso di
soggetti che per almeno tre anni abbiano esercitato una attività di valutazione dei crediti.
59
Per soggetti che partecipano all’operazione si intendono il soggetto cedente, lo special
purpose vehicle, i servicers, i credit enhancers.
213
deve fare riferimento alle disposizioni del TUF art. 93, e del Codice
Civile art. 2359. Qualsiasi rapporto di partecipazione tra la società di
rating e altri soggetti che partecipano all’operazione di cartolarizzazione deve essere indicato nel prospetto informativo.
Il provvedimento della Consob non pare sufficiente ad assicurare una
soddisfacente risoluzione dei problemi in essere. Innanzitutto, pare che si sia
voluto restringere il campo dei soggetti coinvolti nell’operazione: non sembrerebbero pertanto applicabili le disposizioni viste in precedenza, per esempio, alle operazioni in cui il cessionario sia diverso dallo Special purpose
company (emittente titoli). Inoltre, la mancanza di una qualsiasi forma di vigilanza sull’operato delle società di rating60 riduce, nella pratica, la portata
giuridica della disposizione Consob. Tale considerazione potrebbe, per esempio, trovare conforto nel fatto che la Borsa Italiana ha ristretto il numero delle
società di rating ammesse alla valutazione del merito del credito ai fini della
quotazione delle ABS all’Euromot alle tre società internazionali più note
(Moody’s Investors Service LTD, Standard & Poor’s rating group e Fitch
IBCA Inc.) e nel fatto che lo stesso regolamento fissa dei requisiti minimi di
valutazione del merito del credito per l’ammissione alle quotazioni61.
L’oggetto principale di analisi della società di rating è costituito dalla
verifica della “qualità” del portafoglio con lo scopo di valutare la congruità
dei rendimenti promessi con le aspettative di incasso dei crediti costituenti
la massa ceduta. Il portafoglio crediti viene quindi frazionato in “pacchetti”
omogenei in relazione alla durata e alla rischiosità dei crediti. Le modalità
con cui ciascuna società procede all’attribuzione del rating sono differenti.
Nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, però, tutte le società valutano almeno tre aspetti essenziali: i flussi di cassa rinvenienti dall’operazione, la loro distribuzione tra le varie classi di investitori, la struttura legale dell’operazione62.
I rischi analizzati dalle società di rating in una operazione di cartolarizzazione sono principalmente i seguenti63:
• il basis risk che è strettamente connesso alla natura stessa dei crediti
60
Non ci sono infatti obblighi di iscrizione ad albi o registri di alcun tipo.
Si veda in proposito il par. 3.
62
Si veda in proposito Pini G. (1995), “La securitisation: rischi e ruolo del rating”, in Lo
sviluppo della securitisation in Italia, Bancaria, Roma.
63
Si veda in proposito Rumi G. (2000), “Securitisation in Italia. La legge n. 130/99 sulla
cartolarizzazione dei crediti”, Giurisprudenza Commerciale, n. 3; Colagrande F., Fiore L. F.,
Grimaldi M., Grandina D. (1999), Le operazioni di securitization. Caratteristiche, vantaggi
e opportunità. Aspetti operativi, giuridici e contabili, Il Sole 24 Ore, Milano; Dossena G.
(1995), Asset securitization e project financing, Egea, Milano; Bontempi P., Scagliarini G.
(1999), La securitization, Giuffrè, Milano.
61
214
oggetto di cessione e alle loro caratteristiche di base (scadenze, debitori ecc.);
• il credito collateral risk legato alla possibilità che parte degli assets
cartolarizzati originino delle perdite per mancato incasso;
• i rischi legati a ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’operazione e la loro eventuale incapacità a fare fronte agli impegni
assunti.
Generalmente solo una parte del portafoglio riceve un rating di tipo investment grade che viene ulteriormente suddiviso in classi di rischio (minimo, intermedio, massimo) cui è assegnato un rendimento connesso (rispettivamente basso, medio, alto). Gli altri titoli cartolarizzabili sono caratterizzati da un rating non investment grade, con elevato profilo di rischio
connesso poiché emessi a fronte di crediti non performing.
Successivamente all’assegnazione del rating, la società incaricata ha
il compito di monitorare le performances degli assets ceduti che devono
essere coerenti con le aspettative individuate in fase di prima istruttoria.
Il rating può, quindi, essere aumentato (upgrade) o diminuito (downgrade) durante la vita dell’emissione, a discrezione della società di rating,
qualora si vengano a modificare le condizioni che hanno consentito di
esprimere la valutazione originaria. Tale attività ha evidenti ripercussioni sui titoli emessi sul mercato secondario poiché influenza la formazione dei prezzi.
2.7. Servicer
Il servicer è il soggetto che si occupa della gestione del portafoglio
ceduto dall’originator. Nelle operazioni con struttura anglosassone il
ruolo del servicer è svolto spesso dallo stesso originator in virtù della
maggiore conoscenza dei debitori ceduti. Tuttavia, l’ordinamento italiano pone notevoli limiti alla figura del servicer: la legge, infatti, prevede
che ci sia l’obbligo di indicare nel prospetto, informazioni circa le generalità dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, ma prevede anche che tali attività siano
svolte da soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
TUB. Non pare possibile, pertanto, che l’originator ricopra anche l’incarico di servicer nel caso in cui non sia iscritto nel suddetto elenco.
Questa previsione di legge, in palese contrasto con la pratica dell’operazione realizzata “fuori confine” potrebbe porre un notevole ostacolo allo sviluppo della cartolarizzazione in Italia, soprattutto per origi-
215
nators non “finanziari”. Nella pratica, infatti, la coincidenza tra l’originator e il servicer nasce da una duplice esigenza:
• da un lato l’originator può mantenere “riservata” l’operazione finanziaria continuando a tenere un rapporto diretto con i propri clienti;
• dall’altro, la conoscenza del cliente da parte dell’originator e l’eventuale continuità dei rapporti commerciali esistenti tra i due soggetti, dovrebbero essere elementi a favore del buon esito dell’operazione.
Non si riesce pertanto a comprendere il motivo per cui il legislatore non
abbia voluto estendere anche a operatori non iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del TUB la possibilità di assumere la qualifica di servicers.
La Banca d’Italia, infine, ha emanato un provvedimento64 in cui si precisano le regole cui devono attenersi i soggetti in esame.
I servicer hanno il compito di verificare che:
• le somme che provengono dalla riscossione dei crediti affluiscano alla
special purpose vehicle nel pieno rispetto del principio di separazione
patrimoniale;
• siano sempre tutelati e curati da parte della special purpose vehicle e
di altri soggetti coinvolti nell’operazione, gli interessi dei portatori
dei titoli;
• gli incassi avvengano nel rispetto delle scadenze programmate.
Per assolvere ai propri compiti in modo continuo ed efficace sono previsti taluni obblighi per i servicers65. Questi, infatti, devono:
• dotarsi di strutture tecniche e organizzative adeguate al corretto e continuo esame delle operazioni di cartolarizzazione. In tale ambito devono predisporre sistemi di gestione dei flussi finanziari di incasso dei
crediti, di monitoraggio continuo delle operazioni di incasso e di recupero dei crediti in sofferenza;
• disporre di una dotazione patrimoniale idonea ad assicurare la continuità
nello svolgimento delle proprie funzioni66. Il capitale sociale versato non
deve comunque essere inferiore a un miliardo di lire in base all’originario
dettato normativo (è stato oggetto di conversione in euro);
64
Cfr. Provvedimento del Governatore del 23 agosto 2000 recante “Disposizioni per le società di cartolarizzazione”.
65
I servicers possono delegare talune proprie funzioni ad alcuni soggetti specializzati solo
se rimane inalterata la possibilità di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di
cartolarizzazione per le quali il servicer è comunque responsabile.
66
Il provvedimento del 23 agosto 2000 del Governatore della Banca d’Italia, stabilisce anche delle regole di vigilanza prudenziale e fissa alcuni limiti minimi di patrimonio utile ai
fini di vigilanza in connessione con le attività svolte dal servicer.
216
•
•
informare la Banca d’Italia ogni qualvolta si verifichino delle anomalie
nello svolgimento delle operazioni;
predisporre un sistema informativo e contabile che consenta in qualsiasi momento di ricostruire con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione. A tale fine i servicers devono realizzare e inviare periodicamente alle società emittenti dei rendiconti da cui risultino informazioni circa i dati contabili, le posizioni dei debitori e ogni altra
circostanza rilevante al fine del recupero dei crediti e dell’escussione delle garanzie67.
3. Alcuni esempi di strutture di cartolarizzazione
Prendendo spunto da quanto precede, si è tentato di esaminare in maniera critica le varie strutture di cartolarizzazione finora utilizzate nella
prassi finanziaria tentando di approfondire l’analisi di quelle forme, che
potrebbero contribuire allo sviluppo del sistema industriale senza provocare
stravolgimenti nella normale operatività delle imprese e senza causare un
aggravio dei costi informativi e di ottenimento del credito da parte del sistema medesimo.
L’esame della prassi internazionale, è emerso che la struttura paythrough è quella più utilizzata. Il motivo di questa scelta probabilmente risiede nel fatto che tale tipo di struttura offre molteplici varianti che le consentono di adattare lo schema di base a ogni esigenza di finanziamento.
L’ingegneria finanziaria applicata alle operazioni di securitization, pur
senza considerare la struttura della Synthetic securitization, ha prodotto una
estrema sofisticazione delle strutture di base consentendone l’utilizzo per il
finanziamento di singole imprese e di interi settori industriali.
Nonostante ciò, o forse proprio per questo motivo, l’impossibilità di
standardizzare la securitization può rappresentare una opportunità per individuare e costruire nuove strutture che siano utili a tale scopo.
Nel seguito della trattazione verranno, quindi, analizzate alcune delle
opzioni strutturali maggiormente utilizzabili per il finanziamento delle imprese anche di piccola e media dimensione e, in particolare, sarà approfondito l’esame delle Collaterized obligations (CO) e delle Asset backed commercial paper program (ABCP).
67
Si veda in proposito Rumi G. (2000), “Securitisation in Italia. La legge n. 130/99 sulla
cartolarizzazione dei crediti”, Giurisprudenza Commerciale, n. 3 e la bibliografia ivi citata.
217
3.1. Le Collateralised Obligations (CO)
Nella loro pluriennale presenza sui mercati finanziari, le ABS si sono
evolute allo scopo di migliorare il rapporto rischio/rendimento sia per gli
emittenti che per i prenditori di titoli.
Un primo filone di sviluppo di questa tecnica finanziaria ha tentato di
rispondere a questa esigenza cercando di svincolare il rendimento e la
struttura delle scadenze delle ABS emesse dalle caratteristiche delle attività
sottostanti attraverso la trasformazione del rischio di portafoglio sottostante
e si è concretizzato con l’emissione di titoli complessi denominati Collateralised Obligations (CO). In base alle caratteristiche del collaterale possono
essere suddivisi in Collateralised Mortgage Obligations (CMO), e Collateralised Debt Obligations (CDO) a loro volta ulteriormente in suddivisibili
in Collateralised Bond Obligations (CBO) e Collateralised Loan Obligations (CLO). In particolare, vista l’esperienza nazionale e internazionale in
tema di finanziamento delle imprese di piccole e medie dimensioni, si ritiene opportuno concentrare l’analisi sulle CDO.
Le Collateralised Debt Obligations (CDO). Negli ultimi anni i mercati sono stati caratterizzati da un elevato numero di operazioni di securitization strutturate nella forma di Collateralised Debt Obligations (CDO).
È chiamata CDO qualsiasi cartolarizzazione di tipo ABS nella quale il
portafoglio sottostante è composto da titoli obbligazionari (Collateralised
Bond Obligation, CBO) o da prestiti (Collateralised Loan Obligation, CLO)
o eventualmente un mix di titoli e prestiti.
Assieme alle Collaterized Mortgage Obligations (CMO) i CDO sono le
categorie di ABS che si stanno sviluppando maggiormente in Europa.
Mentre però le prime sono operazioni molto standardizzate e facili da confrontare, di contro è più difficile l’analisi dei CDO in quanto vi sono moltitudini di strutture, tipologie di collaterali e strumenti di gestione. La maggior parte degli assets dei CDO provengono dal sistema bancario: portafogli di obbligazioni o di finanziamenti i cui debitori sono le imprese68 clienti
degli istituti di credito stessi.
68
Data la tipologia di attività a garanzia, la società originator è comunemente una istituzione finanziaria. Gli obiettivi che una banca può realizzare attraverso questo strumento di finanziamento
sono molteplici: riduzione del patrimonio di vigilanza con conseguente aumento del rendimento
del capitale (ROE), riduzione dei costi finanziari, miglioramento nella gestione e nel profilo di
rischio dell’attivo di bilancio. Nel caso dei CLO ciò che rende ancora più appetibile è la possibilità per la banca di mantenere la relazione con il cliente attraverso il ruolo di “amministratrice”
che svolge nella transazione. Inoltre quest’ultimo ruolo permette alla banca una maggiore e più
efficace disciplina nello svolgimento della propria funzione di gestione del credito.
218
219
Altri
partecipanti
Originator n
(istituzione
finanziaria
“aggregante”)
Rating
Agency
Cash flow
L’ultima tranche E è
sottoscritta da originator e
garantita e garantita
Per le senior notes (class
A, B, C, D) gli investitori
sono istituzionali
Titoli emessi:
• senior (A)
• mezzanine (B)
• mezzanine (C)
• mezzanine (D)
• junior o equity
(unrated E)
Pagamento interessi
Prezzo di vendita
collocamento
Pagamento degli interessi
Consorzio
di
collocamen
to
Emissione titoli CLO
Gestore fiduciario
(trustee –
eventuale)
Prezzo di
vendita
collocamento
Credit enhancement
Special Purpose
Vehicle
Servicer
• Rapporti con
debitori
• Centralizza gli
incassi
Emissione del rating
Prezzo di vendita
Flussi di cassa correntil port.
Vendita del portafoglio
Cessione degli asset allo SPV
Figura 3 – Struttura dell’operazione di cartolarizzazione distrettuale tramite CDO
debitori
debitori
Come già illustrato nei paragrafi precedenti, anche nel caso di CDO,
l’originator cede un portafoglio omogeneo di assets a una società veicolo
costituita appositamente per la realizzazione dell’operazione.
La struttura dell’operazione è quindi quella rappresentata nella fig. 3.
L’originator spesso mantiene la relazione commerciale con il cliente
debitore (acquisendo la qualifica di servicer se ne ha i requisiti) e gestisce il
portafoglio ceduto e i relativi incassi per conto della società veicolo.
Questa ultima procede all’emissione e al collocamento dei titoli, spesso
in tranche con differente grado di privilegio, per raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad assicurare all’acquisto del portafoglio.
La tranche senior (AAA) è quella di maggiore dimensione e quindi
quella che garantisce la percentuale più alta di finanziamento e che contribuisce a ridurre il costo medio ponderato dell’operazione. Il classamento
dell’operazione prosegue fino all’emissione di tranche junior: queste sono
quelle con il livello di subordinazione più basso, e conseguentemente sono
le prime a sopportare eventuali perdite di portafoglio. Tra queste, la tranche
denominata equity è spesso sottoscritta dallo stesso originator.
Molto spesso l’operazione prevede anche un periodo di reinvestimento
durante il quale l’originator può aggiungere nuovi assets al portafoglio esistente avendo cura però che tali incrementi siano coerenti con le caratteristiche complessive dell’intero portafoglio.
A seconda dell’obiettivo che si intende realizzare, un CDO può definirsi come operazione di arbitraggio, nel caso in cui la società cedente voglia
sfruttare opportunità di mercato al fine di ridurre il costo di finanziamento
(Arbitrage CDO), oppure come operazione patrimoniale nel caso in cui
quest’ultima intenda rendere più efficiente la gestione del proprio capitale
(Balance Sheet CDO).
Con i Balance Sheet CDO (o CDO di bilancio), l’impresa originator persegue l’obiettivo di ottimizzare il bilancio: generalmente si tratta di una istituzione finanziaria che cerca di “deconsolidare” un portafoglio di crediti.
Questo tipo di transazione è in forte sviluppo, principalmente grazie
alle banche che cercano di ridurre il loro capitale regolamentare per soddisfare le esigenze crescenti in termini di ROE69.
L’interesse di un Arbitrage CDO si analizza, indipendentemente da
qualsiasi considerazione sul cedente, l’obiettivo dell’originator che è quello
di effettuare un arbitrato di mercato comprando un portafoglio che verrà diviso in diversi livelli di rischio, più adatto ai profili ricercati dagli investito-
69
Nella maggior parte dei casi, i portafogli ceduti sono dei prestiti, così il termine CLO è
spesso assimilato ai Balance Sheet CDO.
220
ri in modo che il costo all-in di rifinanziamento del CDO (cioè il prezzo di
vendita di tutte le tranche compresa la più subordinata) sia più vantaggioso
del prezzo di acquisto dell’attivo sottostante70.
In genere gli Arbitrage CDO sono dotati di un gestore, il quale ha il
compito di gestire il portafoglio per conto dello Spv secondo criteri definiti
nell’Investment Management Agreement. All’interno del quale, tra l’altro,
viene stabilita la frequenza e la forma dei reportings che il gestore deve
fornire allo Spv e alle agenzie di rating.
I Balance Sheet CDO sono solitamente operazioni di ammontare rilevante in quanto il portafoglio smobilizzato deve essere sufficientemente
ampio per avere un impatto significativo sul ROE dell’impresa cedente.
Al contrario, gli Arbitrage CDO sono spesso delle transazioni private
che vertono su portafogli di limitate dimensioni. Così, benché vi siano numerose transazioni, gli Arbitrage CDO rappresentano, per volume delle
operazioni, un segmento di mercato molto inferiore rispetto a quello relativo ai Balance Sheet CDO71.
3.2. Le Asset Backed Commercial Paper (ABCP)
Un programma di Asset backed commercial paper (ABCP) è composto
da un conduit che emette titoli normalmente a breve termine (commercial
paper o CP) e utilizza le risorse finanziarie ottenute per acquistare varie tipologie di asset da uno o più originators. L’operazione è in grado di fornire
una valida e flessibile alternativa di finanziamento a quelle imprese o aggregati di esse che cercano di finanziare la propria attività a breve termine.
Un programma ABCP coinvolge molteplici soggetti che intervengono a
vario titolo nell’operazione; molti di questi coincidono con le figure già viste
nei capitoli precedenti, altri sono completamente nuovi (per esempio fornitori
di liquidity facilities per assistere i rimborsi degli effetti commerciali).
Gli asset che vengono cartolarizzati possono essere a lunga, media o
breve scadenza; tuttavia, in funzione della natura a breve termine dei titoli
emessi, le asset-backed commercial paper (ABCP) hanno prevalentemente
a oggetto crediti commerciali a breve termine.
70
Per natura il sottostante di un CDO di arbitrato è un attivo che è stato comprato, e si tratta
dunque di un attivo negoziabile. Spesso si tratta di titoli così il termine CBO viene spesso
assimilato agli arbitrage CDO.
71
Questo scarto è amplificato in Europa, dove molti operatori emettono dei Balance sheet
CDO, mentre la maggior parte degli Arbitrage CDO è costituita da attivi americani (HighYield per esempio).
221
I titoli vengono emessi dal veicolo nella forma di commercial paper72:
si tratta di asset-backed securities, cioè titoli garantiti esclusivamente dal
pool di crediti acquisiti dal veicolo.
Generalmente le asset-backed commercial paper (ABCP) hanno
scadenza compresa tra i 3 e i 12 mesi e vengono emesse su base revolving73.
A ogni scadenza dei titoli, il veicolo ne rimborsa il valore nominale ed
emette nuove commercial papers (roll-over) per un importo nominale pari
all’ammontare dei crediti outstanding. Ciò permette di collegare il piano di
ammortamento dei crediti in portafoglio (per esempio a medio termine) a
quello di rimborso delle ABCP (a breve termine).
Al closing dell’operazione, il veicolo ha quindi finanziato l’acquisizione dell’interesse economico nel portafoglio crediti dell’originator attraverso l’emissione e il collocamento presso gli investitori delle commercial
paper notes.
Il collocamento, in genere avviene tramite dealers o placement agents,
normalmente investment o commercial bank.
I dealers, previa deduzione delle loro spettanze sotto forma di commissioni, trasferiranno i fondi raccolti presso un account in nome del veicolo,
tenuto dall’issuing and paying agent (generalmente funzione svolta da una
banca commerciale).
Il veicolo preleverà poi i fondi e li trasferirà, attraverso il servicer, all’originator come prezzo per l’acquisizione del pool di asset.
Il veicolo provvede inoltre al rimborso delle ABCP che giungono a
scadenza attraverso l’emissione di nuove ABCP74.
72
Le commercial papers non sono titoli di credito, ma “semplici dichiarazioni ricognitive
del debito rilasciate dall’impresa finanziata”. Cfr. Treccani (2008), Enciclopedia Giuridica.
Le polizze sono liberamente trasferibili e spesso beneficiano di una garanzia di elevato standing. Le polizze non sono titoli cambiari, ma documenti privi dei requisiti di astrattezza,
letteralità ed esecutività e circolanti secondo le norme di diritto comune. Il debitore oltre a
riconoscere l’esistenza del debito, dichiara di rinunciare a opporre al portatore qualsiasi eccezione non risultante dalla polizza. Le polizze di credito commerciale non scontano
l’imposta di bollo cambiaria. Possono anche essere emesse da società a responsabilità limitata. Per approfondimenti si rinvia a Troiano V. (1994), Le polizze di credito commerciale,
Cacucci, Bari; e Capriglione F. (1992), “Le polizze di credito commerciale”, in Il Contratto,
Cedam, Padova.
73
In genere la durata delle commercial paper non supera i tre mesi, ma nulla vieta che al
fine di una loro più efficace utilizzo in una securitization possano presentare scadenza più
lontane. In Italia, peraltro la scelta di emettere dei titoli a più lunga scadenza – oltre i 18 mesi – è originata da esigenze fiscali.
74
Durante la transazione il valore outstanding dei titoli asset-backed eguaglia sempre il credito residuo del pool di crediti.
222
223
Rating
Agency
Emissione del rating
Prezzo di vendita
Flussi di cassa correnti port.
Vendita del portafoglio
Special Purpose
Vehicle
Prezzo di
vendita
Emissione
Servicer
• Rapporti con
debitori
• Centralizza gli
incassi
Cash flow
Titoli emessi:
• senior (A)
• mezzanine (B)
• mezzanine (C)
• mezzanine (D)
• equity (unrated E)
Pagamento interessi
Prezzo di vendita
Collocamento
Pagamento degli interessi
Consorzio
di
collocamen
to
x Insurance
company
x Gestore fiduciario
(trustee –
eventuale)
x Issuing & payng
agent
Credit enhancement – Liquidity support
Cessione degli asset allo SPV
Emissione
Mercato
Italia/ estero
Italia
Estero
Legenda: nella figura sono indicati tutti i soggetti coivolti nell’operazione: quelli tipici della securitization sono indicati con colore blu, gli altri soggetti con
colore bianco. Le aree in grigio servono a evidenziare le differenti fasi dell’operazione. Le relazioni tra i soggetti coinvolti e il tipo di attività svolta da ciascuno
di essi nelle singole fasi è rappresentata dalle linee di collegamento. le linee tratteggiate in colore verde servono per delineare i luoghi fisici in cui si svolgono le
attività.
Altri
partecipanti
Originator n
Originator 2
Originator 1
Conduit
Emissione titoli
ABCP
Figura 4 – Struttura dell’operazione di cartolarizzazione distrettuale tramite ABCP
debitori
debitori
I fondi occorrenti per l’emissione delle nuove ABCP derivano dal pool
cartolarizzato: in particolare, i flussi di cassa per capitale e interessi, generati periodicamente dai titolari dei crediti inclusi nel portafoglio cartolarizzato, sono raccolti dall’originator e trasferiti al servicing agent, dove andranno ad alimentare un collection account, intestato al veicolo.
Dal collection account tutti i flussi vengono poi trasferiti in un segregated account tenuto presso l’issuing and paying agent il quale li userà per
pagare gli investitori al momento della presentazione delle commercial paper in scadenza.
In seguito si procederà similmente; l’issuing and paying agent, utilizzerà i fondi derivanti dalle nuove emissioni di commercial paper, per ripagare
quelle giunte a scadenza.
A tutela degli interessi degli investitori, la struttura deve prevedere
adeguate forme di garanzia. Gli originator coinvolti nell’operazione devono rispettare certi livelli minimi di credit quality e operatori specializzati
(banche o compagnie di assicurazione) devono provvedere a fornire le necessarie garanzie all’operazione. Inoltre, a maggiore garanzia, i credit enhancers o gli stessi originators coinvolti possono intervenire tramite la
formula del prestito subordinato.
Nelle asset-backed commercial paper il costo del funding con cui il veicolo finanzia i propri investimenti nel pool è legato alle commercial paper.
Se il costo del debito varia, il veicolo dovrà assicurarsi che l’investimento nel pool cartolarizzato supporti sempre le proprie obbligazioni di
pagamento.
In caso di crediti commerciali o di altri crediti che non producono interessi
ciò è relativamente semplice: il veicolo tratta tutti i flussi rivenienti dalle collections e stanzia quanto necessario a pagare il costo delle passività emesse.
Se non si ottengono flussi di cassa sufficienti ad assicurare il servizio
del debito e ripagare l’investimento effettuato dal veicolo, normalmente ha
inizio la fase di liquidazione dell’operazione.
Generalmente, al closing dell’operazione, viene costituita una riserva di
liquidità (liquidity reserve) con il finanziamento subordinato concesso dall’originator (o dalla Banca). Il veicolo ha la possibilità, durante l’operazione, di utilizzare la riserva, nel caso la somma tra l’ammontare dei ricavi
generati dal portafoglio e depositati su un apposito conto (collection account), e i ricavi di sottoscrizione delle ABCP non siano sufficienti a coprire le spese senior dell’Spv e il rimborso dei titoli asset-backed giunte a scadenza. Scopo principale della liquidity reserve è quello di garantire agli investitori il servizio del debito anche nella situazione in cui la performance
del portafoglio risulti peggiore di quella attesa.
224
Inoltre, il receivable purchase agreement può contenere la previsione di trigger commencing liquidation dell’investimento del veicolo se il
tasso delle commercial paper, insieme alle spese di servicing e simili,
ecceda quello degli interessi legato al pool di crediti contenuto nel portafoglio ceduto.
Nel momento in cui inizia la liquidazione dell’interesse del veicolo75, i flussi di pagamenti seguono la stessa sequenza, con l’unica differenza che l’originator trasferirà i flussi ottenuti dalle receivable al servicing agent, e questi all’issuing and paying agent per consentire il pagamento delle commercial paper in scadenza senza attendere i proventi
derivanti da nuove emissioni.
Nel caso in cui non si sia in fase di liquidazione dell’investimento e il
veicolo non sia in grado di emettere nuove commercial paper, l’issuing and
paying agent deve ottenere la liquidità necessaria ricorrendo alle credit enhancement facilities precedentemente stipulate.
Infine, il veicolo può impegnare presso un collateral agent tutti i suoi
diritti nel pool di receivables nel quale ha investito in modo da assicurare il
rimborso di tutte le proprie obbligazioni verso i creditori, inclusi il credit
and liquidity enhancers e i titolari delle commercial paper.
Negli ultimi anni è cresciuto il numero delle commercial bank, che sono intervenute, in qualità di sponsor, per la costituzione di conduit da utilizzare nell’ambito di strutture multiseller.
La presenza del conduit, riduce sostanzialmente i costi dell’operazione,
eliminando la necessità, a livello di singola operazione, della valutazione da
parte delle agenzie di rating, e delle richieste relative alle forme di garanzia
da attuare a supporto dell’operazione. Il rating viene quindi emesso sull’intero ammontare dei titoli collocati. Il giudizio viene proposto direttamente sul conduit e concerne l’intera struttura.
Nel caso di multiseller conduit, in cui vengono cartolarizzati gli asset
generati da più società distinte, la struttura dell’operazione può prevedere la
presenza di più special purpose vehicle, ognuna attinente uno specifico originator, che trasferiscono pool di asset al conduit per la successiva cartolarizzazione.
Normalmente, i conduit, emettono commercial paper ad alto rating (A1
secondo la scala Standard & Poor’s), grazie all’ottenimento di credit enhancement da terze controparti garanti, di stand by lines of credit per bisogni di liquidità a breve e diversificando gli asset acquistati.
75
In caso di operazione multiseller, ovviamente, la liquidazione può riguardare anche solo
un pool di receivable facenti capo a un originator. In tal caso l’operazione resta in essere,
relativamente agli altri seller intervenuti nel programma.
225
I programmi ABCP hanno molti aspetti in comune con quelli di securitization, di cui costituiscono una particolare articolazione, tuttavia differiscono nei seguenti aspetti:
• gli investimenti in asset del conduit possono aumentare di dimensione
con il passare del tempo. La struttura del portafoglio del conduit è infatti sostanzialmente aperta e quindi è sempre pronta ad accogliere un
ampliamento dei portafogli esistenti o nuovi portafogli derivanti da ulteriori operazioni.
• i conduit possono effettuare investimenti in varie tipologie di asset al
fine di ottenere una diversificazione del portafoglio. Ciò è strumentale
all’assegnazione del rating alle emissioni di ABCP.
4. Conclusioni
Dopo quasi un decennio dall’emanazione della legge 130/1999, la cartolarizzazione dei crediti è divenuta una operazione finanziaria diffusa anche sul mercato italiano. Il numero crescente delle operazioni concluse in
questi anni e la riduzione progressiva del taglio medio delle stesse evidenzia una maturazione del mercato della cartolarizzazione e una maggiore attenzione degli operatori rispetto alla natura e ai reali obiettivi che con la securitization si possono perseguire. Nelle ultime operazioni infatti, le imprese hanno utilizzato la cartolarizzazione come strumento di finanziamento
dell’attività e non come mezzo per attuare politiche di “pulizia” dei bilanci.
Nonostante ciò, è necessario che il mercato domestico si sviluppi ulteriormente accogliendo tutte quelle operazioni, comuni nella prassi dei Paesi
di stampo anglosassone, che al momento non sono realizzate in Italia: a tale
fine potrebbe essere opportuno, pur senza imbrigliare la materia, apportare
dei correttivi alla legge 130/1999 con l’obiettivo di ridurre le incertezze in
ordine ad alcuni aspetti e favorire ulteriormente l’utilizzo di questo strumento da parte delle imprese non finanziarie che possono trovare nella
cartolarizzazione uno strumento di finanziamento stabile e conveniente.
Alla luce della recente stretta del credito (credit crunch) che ha interessato l’economia a livello globale, modifiche all’apparato regolamentare vigente risultano ancor più necessarie per ripristinare, iniettando la fiducia
necessaria, un virtuoso funzionamento del sistema finanziario e degli operatori del mercato creditizio.
226
BIBLIOGRAFIA
Aa. Vv. (1997), “Dossier titrisation”, Banque, n. 581, maggio.
Aa. Vv. (1999), Atti del convegno “Le novità legislative in materia di cartolarizzazione dei crediti”, Il Sole 24 Ore, Milano
Aa. Vv. (1999), La cartolarizzazione dei crediti in Italia. Caratteristiche tecniche,
aspetti legali e fiscali e vantaggi per le banche e per le imprese, Bancaria,
Roma.
Aa. Vv. (2000a), “Modelli per la gestione del rischio di credito. I ratings interni”,
Tematiche istituzionali, Banca d’Italia, Roma.
Aa. Vv. (2000b), Atti del convegno Business International: II incontro sulla securitisation in Italia, Roma
Aa. Vv. (2000c), I rating e i nuovi strumenti di controllo del rischio di credito, atti
del convegno 28 settembre 1999 Excelsior Hotel, Il Sole 24 Ore, Milano.
Aa. Vv. (2003),”Forum su Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo
del credito?”, Economia & management, n. 4, pp. 15-29.
Adam T. R. (2002), “Risk Management and the Credit Risk Premium”, Journal of
Banking & Finance, vol. 26, n. 2-3, pp. 243-269.
Adren N., Jankensgard H., Oxelheim L. (2005), “Exposure-based Cash-flow-atrisk: An Alternative to VAR for Industrial Companies”, Journal of Applied
Corporate Finance, vol. 17, pp. 76-86.
AIAF (2002), “The Communication of Intangibles and Intellectual Capital: An
Empirical Model of Analysis”, Official Report, n. 106, Milano.
Airmic, Alarm, Irm (2002), A Risk Management Standard, Institute of Risk Management, Association of Insurance and Risk Managers.
Alberici A. (1975), Analisi dei bilanci e previsione delle insolvenze, Milano, Isedi.
Alberici A., Caselli S. (2003), La valutazione dell’impresa per i fidi bancari, FrancoAngeli, Milano.
Alberici A., Forestieri G. (1986), La previsione delle insolvenze bancarie: profili
teorici e analisi empiriche, Giuffrè, Milano.
Alici Y. (1996), “Neural Networks in Corporate Failure Prediction: The UK Experience”, Neural Networks in the Capital Market 1995 Proceeding, World scientific, Singapore.
227
Allen S. (2003), Financial Risk Management: A Practitioner’s Guide to Managing
Market and Credit Risk, Wiley, Hoboken.
Altman E. I. (1968), “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of
Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, vol. 23. n. 4, pp. 589-609.
Altman E. I. (1984), “A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost
Question”, Journal of Finance, vol. 39, n. 4, pp. 1067-1089.
Altman E. I. (1989), “Measuring Corporate Bond Mortality and Performances”,
Journal of Finance, vol. 44, pp. 909-922.
Altman E. I. (2000), “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the
Z-score and the Zeta Models”, Journal of Finance, July.
Altman E. I., Haldeman R., Narayanan P. (1977), “Zeta Analysis: A New
Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations”, Journal of Banking
& Finance, n. 1.
Altman E. I., Marco G., Varetto F. (1994), “Corporate Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear Discriminant Analysis and the Neural Networks (The
Italian Experience)”, Journal of Banking & Finance, vol. 18, pp. 505-529.
Altman E. I., Suggit H. J. (2000), “Default Rates in the Syndicated Bank Loan
Market: A Mortality Analysis”, Journal of Banking & Finance, vol. 24, pp.
229-253.
Ambrosetti Stern Stewart Italia (1999), “Best practices nei metodi di valutazione
d’impresa e di stima del costo del capitale”, Rivista AIAF, n. 23, ottobre; Collana Quaderni AIAF, n. 97.
Ambrosetti Stern Stewart Italia (2002), “Best practices nei metodi di valutazione
d’impresa e di stima del costo del capitale”, supplemento alla Rivista AIAF n.
41, dicembre; Collana Quaderni AIAF, n. 107.
Andreani G. (1998), “Dual Income Tax (DIT). Analisi della disciplina”, Il Fisco n.
4, pp. 1242-1250.
Anmer J., Packer F. (2000), How Consistent are Credit Ratings? A Geographic and
Sectoral Analysis of Default Risk, International finance discussion papers,
board of governors of the Federal Reserve System.
Anolli M., Gualtieri P. (1999), La misurazione del rischio di credito nella gestione
delle banche, Il Mulino, Bologna.
Appetiti S. (1984), L’utilizzo dell’analisi discriminatoria, Banca d’Italia, Roma.
Arnaboldi F. (2000), “Dalla misurazione del rischio dei fidi al credit risk management”, in Aa. Vv., I rating e i nuovi strumenti di controllo del rischio di credito: atti convegno 28 settembre 1999 Excelsior Hotel, Il Sole 24 Ore, Milano.
Arosio R., Giudici G., Paleari S. (2000), “What Drives the Initial Market Performance of Italian IPO’s? An Empirical Investigation on Underpricing and
Price Support”, working paper.
Artale G., Pampana A., Rajola C. (2000), Guida alla securitization. I vantaggi, gli
strumenti e gli adempimenti della nuova legge, Bancaria, Roma.
Artina V. (1998), “Cessione dei crediti: le norme e le opportunità”, Amministrazione e Finanza, n. 19.
228
Artzner P., Delbaen F., Eber J., Heat D. (1999); “Coherent Measures of “risk”,
Mathematical Finance, vol. 9, n. 3, pp. 203-228.
AS/NZS 436O (1999), Risk Management, Standards Australia and Standards New
Zealand.
Asquith D., Jones J. D., Kieschnick R. (1998), “Evidence on Price Stabilization,
and Underpricing in Early ILO Returns”, Journal of Finance, vol. 53, pp.
1759-1773.
Associazione Bancaria Italiana (2001), Rischio di credito, rating interni e cartolarizzazione. Atti convegno ABI 23-24 novembre 2000, Edibank, Roma.
Associazione Bancaria Italiana (2002), Loss given default: aspetti metodologici e
proposta di una struttura dati per la stima, Bancaria, Roma.
Associazione Bancaria Italiana, Commissione tecnica per gli studi (1995), Metodi
avanzati per la gestione del rischio di credito, Bancaria, Roma.
Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, Relazione sull’attività svolta
nel 2002, p. 149.
Avesani R. (2000), “L’esperienza di Banca Intesa”, in Aa. Vv., “Modelli per la gestione del rischio di credito. I ratings interni”, Tematiche istituzionali, Banca
d’italia, Roma.
Baden Fuller C., Stopford J. (1994), Rejuvenating the Mature Business. The Competitive Challenge, Harvard Business School, Oxford.
Bagella M., Becchetti L., Caggese A. (1996), “Finanza d’impresa: vincoli ed opportunità
per le piccole e medie imprese”, Quaderni di Politica Industriale, n. 9, p. 11-42.
Banks E. (2003), The Simple Rules Of Risk – Revisiting The Art Of Financial Risk
Management, Wiley, Cambridge.
Banks E. (2004), Alternative Risk Transfer Integrated Risk Management through
Insurance, Reinsurance, and the Capital Market, Wiley, Cambridge.
Baron D. P. (1974), “Default Risk, Homemade Leverage, and the ModiglianiMiller Theorem”, American Economic Review, vol. 66, pp. 176-182.
Bartram S. (2000), “Corporate Risk Management as a lEver for Shareholder
Value Creation”, Financial Markets, Institutions and Instruments, vol. 9-5,
pp. 279-325.
Basel Committee on Banking Supervision (2003), The Internal Ratings-based Approach, Consultative Document, Bank for International Settlements, Basel.
Basel Committee on Banking Supervision (2004), International Convergence of
Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for
International Settlements, Basel.
Basile I., De Sury P. (1997), La determinazione del prezzo delle azioni destinate
alla quotazione, Cariplo, Laterza, Milano.
Baskin J. (1989), “An Empirical Investigation of the Pecking Order Hypothesis”,
Financial Management, primavera, pp. 26-35.
Beaver W. (1967), “Financial Ratios as a Predictors of Failures”, Empirical Research in Accounting, n. 4, pp. 71-111.
Berens J. L., Cuny C. L. (1993), Inflaction, Growth and Capital Structure, Working
Paper, University of Califormia at Irvine.
229
Beretta S. (2004), Valutazione dei rischi e controllo interno, Università Bocconi
Editore, Egea, Milano.
Berger A. L., Udell G. F. (1995), “Relationship Lending and Lines of Credit in
Small Firm Finance”, Journal of Business, n. 3, pp. 351-381.
Bertolini F., Carniol F., Corvino G., Forestieri G., Paci S., Peccati L., Pichler F., Pisani R. (2004), Risk management, strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Etas, Milano
Bertoni A. (1996), Il rischio di credito: metodologie avanzate di previsione delle
insolvenze, Giappichelli, Torino.
Betti S. (2001), Value at risk: la gestione dei rischi finanziari e la creazione del
valore, Il Sole 24 Ore, Milano.
Bianchi T. (1977), I fidi bancari: tecnica e valutazione dei rischi, Utet, Torino.
Bibbia, Genesi, 3, 23-24.
Bing L., Tiong R. (1999), “Risk Management Model for International Construction
Joint Ventures”, Journal of Construction Engineering and Management, September/October, pp. 377-384.
Black F. (1975), “Fact and Fantasy in the Use of Options”, Financial Analysts
Journal, July-August.
Black F., Cox J. C. (1976), “Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond
Indenture Provisions”, Journal of Finance, pp. 351-367.
Black F., Sholes M. (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”,
Journal of Political Economy, vol. 81, pp. 637-654.
Bodo G. (1999), “La securitisation su immobili e crediti commerciali: il caso Fiat”,
in Aa. Vv., Atti del convegno “Le novità legislative in materia di cartolarizzazione dei crediti”, Il Sole 24 Ore, Milano.
Boffelli G. (2000), “L’assegnazione del rating interno bancario”, Rivista bancaria
europea, n. 15.
Boleat M. (1992), “Securitization dei mutui: l’esperienza britannica”, in Aa. Vv.,
“La creazione di un mercato secondario dei mutui in Italia”, Quaderni del
Cordusio, n. 2.
Bonato L., Hamaui R., Ratti M. (1991), Come spiegare la struttura finanziaria
delle imprese italiane?, Roma, Comit – Ufficio Studi e Programmazione,
Quaderno R91-18.
Bontempi M. E., Ferrari S., Giannini S., Golinelli R. (1998), La riforma della tassazione del reddito di impresa: effetti sul costo dei fattori, sui bilanci e sulle
scelte finanziarie, Università di Bologna, Bologna.
Bontempi M. E., Golinelli R. (1996), “Le determinanti del leverage delle imprese:
un’applicazione empirica ai settori industriali dell’economia italiana”, Studi e
Note di Economia, n. 2, pp. 35-66.
Bontempi P., Scagliarini G. (1999), La securitization, Giuffrè, Milano.
Borghesi A. (1985); La gestione dei rischi di azienda; Cedam, Padova.
Borsa Italiana (2000), “EuroMot”, www.borsaitaliana.it.
Borsa Italiana (2003), “Regolamento dei mercati organizzati da Borsa Italiana SpA del
16 dicembre 2002” approvato dalla Consob con delibera n. 14032 del 15 aprile.
230
Bothers D. A. (1979), “Use of a Business Failure Prediction Model for Evaluating
Potential and Existing Credit Risk”, Unpublished MBA Research Project,
Simon Fraser University, March.
Bozzi M. (2000), “Le variabili economiche finanziarie nel processo d’analisi del
merito creditizio”, in Aa. Vv., I rating e i nuovi strumenti di controllo del rischio di credito: atti convegno 28 settembre Excelsior Hotel, Il Sole 24 Ore,
Milano.
Brealey R. A., Myers S. C., Sandri S. (2003), Principi di finanza aziendale,
McGraw Hill, Milano.
Brealy R. A., Myers S. C., Allen F., Sander S. (2007), Principi di finanza aziendale,
McGraw-Hill, Milano.
Brennan M. J., Franks J. (1997), “Underpricing, Ownership and Control in Initial
Public Offerings of Equity Securities in the UK”, Journal of Financial Economics, 45, pp. 391-413.
Brugger G. (1980), L’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa, Giuffré,
Milano.
Brunetti G. (1989), “La finanza d’impresa: decisioni e comportamenti nell’attuale
contesto economico”, L’eccellenza nella gestione delle risorse finanziarie, Padova, Cedam.
Buerger V. (1991), “The Risks of Asset-backed Securities: Lessons from History”,
in Z. Shaw, International Securitisation: The Scope, Development and Future
Outlook for Asset-backed Finance, Stockton, New York.
Cacciamani C. (2004), “Risk management e valore d’impresa”; working paper n.
32, Università Bocconi, Cerap, Milano.
Callow D. (2005), Understanding Valuation. A Venture Investors Perspect, Foley &
Lardner, San Francisco.
Cannata F., Laviola S. (2001), “Il nuovo accordo sul capitale delle banche, i commenti dell’industria bancaria”, intervento al convegno CERMEF “Rischio di
credito, nuovo accordo di Basilea e implicazioni per le banche italiane”, Banca
di Roma, Roma.
Cantino V. (2002), Valore d’impresa e merito creditizio: il rating, Giuffrè, Milano.
Cantor R. (2001), “Moody’s Investors Service Response to the Consultative Paper
Issued by the Basel Committee on Bank Supervision. A New Capital Adequacy Framework”, Journal of Banking& Finance, n. 25, pp. 171-185.
Cantor R., Packer F. (1995), “The Credit Rating Industry”, Journal of Fixed Income, December.
Caparrelli F. (1995), Il mercato azionario, McGraw-Hill, Milano.
Capriglione F. (1992), “Le polizze di credito commerciale”, in Il Contratto, Cedam, Padova.
Caprio L. (1999), “Il capital assets pricing model”, in Cattaneo M., Manuale di finanza Aziendale, Il Mulino, Bologna, pp. 275-276.
Caputo Nassetti F. (1992), “The Prospect for Securitisation in Italy: Recent Developments”, Journal of International banking law, n. 6.
231
Caratozzolo M. (2002), “L’introduzione del fair value nella IV e VII Direttiva Comunitaria: una prima valutazione”m Le Società, n. 11.
Caretta A., Basile I., Munari L. (1987), L’innovazione finanziaria, aspetti, origini e
diffusione, Giuffrè, Milano.
Carey M., Hrycay M. (2001), “Parameterizing Credit Risk Models with Rating
Data”, Journal of Banking & Finance, n. 25, pp. 197-270.
Carlotti M. (1993), “Struttura Finanziaria e Variabili Fiscali nel contesto italiano
attuale”, Finanza, Imprese e Mercati, n. 1.
Carretti F., Dallocchio M. (1997), “La quotazione delle imprese italiane: Milano o
New York?”, Economia & Management, n. 1, pp. 12-27.
Carroll J. M. (1984), Managing Risk, Butterworths, Boston.
Carty L. (2000), “Misurazione del rischio d’inadempienza delle aziende private”,
in Aa. Vv., I rating e i nuovi strumenti di controllo del rischio: atti convegno
28 settembre 1999, Il Sole 24 Ore, Milano.
Cattaneo M. (1976), Analisi finanziaria e di bilancio, Etas, Milano.
Cattaneo M. (1999), Manuale di finanza aziendale, Il Mulino, Bologna.
Cattaneo M., Caprio L. (1999), “Incertezza, rischio, comportamento dell’investitore”, in Cattaneo M., Manuale di finanza aziendale, Il Mulino, Bologna,
pp. 213-256.
Ceccherelli A. (1931), Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende
commerciali, Barbera, Firenze.
Ceccherelli A. (1948), Economia aziendale e amministrazione delle imprese,
Barbera, Firenze.
Centrale Dei Bilanci (a cura di) (1998), “Alberi decisionali e algoritmi genetici nell’analisi del rischio d’insolvenza”, Bancaria, n. 1.
Chamberlain G. (1983), “Funds, Factors, and Diversification in Arbitrage Pricing
Models”, Econometrica, vol. 51, pp. 1301-1324.
Chamberlain G., Rothshild M. (1983), “Arbitrage, Factor Structure, and Mean-variance
Analysis on Large Asset Markets”, Econometrica, vol. 51, pp. 1281-1304.
Chapman R. (1998), “The Effectiveness of Working Group Risk Identification and
Assessment”, International Journal of Project Management, vol. 16, n. 6, pp.
333-343.
Cherubini U., Ratti M. (1991), “Quanto valgono le matricole? L’underpricing nelle
prime quotazioni: teorie economiche e analisi empirica”, in Penati A. (a cura
di), Il rischio azionario e la borsa, Egea, Milano.
Chiabrera C. (1993), “L’andamento dei prezzi delle azioni di nuova emissione”,
Analisi Finanziaria, n. 10, pp. 54-70.
Ciampaglia G. M. (2000), “La cartolarizzazione delle poste attive ed i suoi scopi: la
struttura della securitisation”, Finanza, Marketing e Produzione, n. 4.
Circ. Cons. Naz. Ragionieri Commercialisti n. 41/99 (1999), “Cartolarizzazione dei
crediti. Aspetti civilistici e fiscali”, Società, Bilancio e Contabilità, n. 11.
Colagrande F., Fiore L. F., Grimaldi M., Grandina D. (1999), Le operazioni di securitization. Caratteristiche, vantaggi e opportunità. Aspetti operativi, giuridici e contabili, Il Sole 24 Ore, Milano.
232
Colombi F. (1995), Baricentro finanziario, Strategie & finanza, Roma.
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (2003), Presentazione del nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, Banca dei regolamenti internazionali, Basilea.
Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti (1999), “La cartolarizzazione
dei crediti”, Guida Normativa, n. 186.
Conti C. (2006), Introduzione al Corporate Financial Risk Management, Pearson,
Milano.
Coombs T. (1998), “An Analytic Framework for Crisis Situation: Better Responses
from a Better Understanding of the Situation”, Journal of Public Relation Research.
Cooper D. F., Geoffry R. (2007), Project Risk Management Guidelines, Wiley,
Cambridge.
Copeland T. E., Koller T., Murrin J. (1990), “Valuation: Measuring and Managing
the Value of Companies”, Wiley, New York.
Copeland T., Koller T., Murrin J. (1993), Il valore dell’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano.
Copeland T., Koller T., Murrin J. (2000), Il valore dell’impresa, III ed., Il Sole 24
Ore, Milano.
Corigliano R. (a cura di) (1998), Rischio di credito e pricing dei prestiti bancari:
nuove metodologie di analisi e conseguenze organizzative per le banche italiane, Bancaria, Roma.
Cornelli F. (1997), “Scelte finanziarie d’impresa e innovazioni fiscali”, Il Fisco, n. 44.
Corsani G. (1937), La gestione delle imprese mercantili e industriali, Cedam, Padova.
Corvino G. (1996), “Il processo di identificazione del rischio: descrizione del profilo di rischio e metodologie di ricerca delle informazioni”, in Forestieri G. (a
cura di), Risk management. Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri
dell’impresa, Egea, Milano.
CoSo (2004), Enterprise Risk Management. Integrated Framework, www.coso.org.
Credit Suisse Financial Products (1997), CreditRisk, www.credit-suisse.com.
Criscione A. (2003a), “Ires, la riforma presenta il conto”, Il Sole 24 Ore, 24 settembre.
Criscione A. (2003b), “Imprese in allarme su dividendi e debito”, Il Sole 24 Ore,
15 ottobre.
Crivellari D. (1999a), “Il recupero crediti: fra outsorcing e cartolarizzazione”, Amministrazione & Finanza, n. 19.
Crivellari D. (1999b), “Recupero crediti: dal contratto di servicing alla businessline bancaria”, Amministrazione & Finanza, n. 20.
Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), “Prototype Risk Rating System”, Journal of
Banking & Finance, vol. 25, pp. 47-95.
Crowe R., Horn R. (1967), “The Meaning of Risk”, Journal of Risk and Insurance,
vol. 34, pp. 459-474.
Culp C. (2004), Risk Transfer: Derivatives in Theory and Practice, Wiley, Hoboken.
Cumming C. (1987), “The Economics of Securitization”, FRBNY Quarterly Review, autumn.
233
Cummins D., Phillips R., Butsic R., Derring R. (2000), The Risk Premium Project (RPP).
Phase I and II Report, Casualty actuarial Society, Committee on Theory of Risk.
D’Ambrosio C. A., Archer S. H. (1967), Business Finance: Theory & Management, MacMillan, New York.
Damodaran A. (1994), Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment
and Corporate Finance, Study Guide, Wiley, New York.
Damodaran A. (2001), Finanza aziendale, Apogeo, Milano.
Damodaran A. (2002), Valutazione delle aziende, Apogeo, Milano.
Damodaran A. (2006), Finanza aziendale, II ed., Apogeo, Milano.
Danielis D. (2000), “L’esperienza di Unicredito Italiano”, in Aa. Vv., “Modelli per
la gestione del rischio di credito. I ratings interni”, Tematiche istituzionali,
Banca d’Italia, Roma.
De Angeli S., Oriani M. (a cura di) (2000), La securitization dei crediti bancari,
FrancoAngeli, Milano.
De Angelo H., Mansulis R. (1980), “Optimal Capital Structure under Corporate
Taxation”, Journal of Financial Economics, n. 8, pp. 5-29.
De Laurentis G. (1994), Il rischio di credito. I fidi bancari nel nuovo contesto teorico, normativo e di mercato, Egea, Milano.
De Laurentis G. (2001), Rating interni e credit risk management: l’evoluzione dei
processi d’affidamento bancari, Bancaria, Roma.
De Lisa R. (2002), I sistemi interni di credit rating, FrancoAngeli, Milano.
Deakin B. E. (1972), “A Discriminate Analysis of Predictors of Business Failure”,
Journal of Accounting Research.
Dell’Amore G. (1965), Economia delle aziende di credito. I prestiti bancari, Giuffrè, Milano.
Dessy A. (1994), Imposte, politiche finanziarie e valore azionario, Egea, Milano.
Di Majo A., Pazienza M. G., Triberti B. (2005), “Le scelte di finanziamento delle
imprese minori: teorie e analisi del caso italiano”, WP DISEFIN, n. 7.
Di Piazza Jr. S. A., Eccles R. G. (2002), Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, Wiley, New York.
Diebold F. X., Bangia A., Kronimus A., Schagen C., Schuermann T. (2002), “Ratings
Migration and the Business Cycle, with Application to Credit Portfolio Stress
Testing”, Journal of Banking & Finance, vol. 26, n. 2-3, pp. 445-474.
Dimson E., Marsh P., Staunton M. (2003), “Global Evidence on the Equity Risk
Premium”, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 15-4, pp. 27-38.
Doherty N. A. (1985), Corporate Risk Management, McGraw-Hill, New York.
Donzi R. (1999), “La cartolarizzazione dei crediti: strumento di rivitalizzazione del
sistema economico”, Mondo Bancario, n. 4, luglio-agosto.
Dossena G. (1995), Asset securitization e project financing, Egea, Milano.
Duff & Phelps CreditRating (2000), Società di cartolarizzazione dei crediti INPS:
SCCI SpA, European Structured Finance Report.
Duffee G. R. (1996), “On Measuring Credit Risk of Derivatives Instruments”,
Journal of Banking and Finance, n. 20, pp. 805-883.
234
Durand D. (1952), “Cost of debt and EquityFunds for Business: trends and problems in measurement”, Conference on Research in Business Finance, National Bureau of Economic Research, pp. 215-247.
Ecchia S. (1996), Il rischio di credito. Metodologie avanzate di previsione delle
insolvenze, Giappichelli, Torino.
Eccles R. G., Herz H. R., Keegan E. M., Phillips D. M (2001), The Value Reporting
Revolution. Moving Beyond the Earnings Game, Wiley, New York.
Edmister R. O. (1972), “An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small
Business Failure Prediction”, Journal of Financial and Quantitative Analysis.
European Securitisation Forum (1999), “European Securitization: A Resource Guide”, www.europeansecuritization.net.
European Securitization Forum (2002), “European Securitization: A Resource
Guide”, www.europeansecuritization.net.
Fabbri A. (2001), “Le synthetic securitization: struttura, caratteristiche economiche
e logiche di valutazione”, Bancaria, n. 1.
Fabozzi F. J. (1998), Handbook of Structural Financial Products, Frank J. Fabozzi
Associated, New Hope.
Fama E. F. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical
Work”, Journal of Finance, vol. 35, pp. 383-417.
Fama E. F. (1981), “Stock Return, Real Activity, Inflation and Money”, American
Economic Reviow, n. 71, pp. 545-565.
Fanni M. (2000), Manuale di finanza dell’impresa, Giuffrè, Milano.
Fazzi R. (1940), Saggio sui fondamenti della teoria economico-tecnica del
commercio, Coppini, Firenze.
Fazzi R. (1942), Il trasferimento dei rischi aziendali e la gestione delle imprese di
assicurazione, Gonini, Firenze.
Fazzi R. (1982), Il governo dell’impresa, voll. I e II, Giuffrè, Milano.
Feeney W. P. (1995), Securitization. Redefining the Bank, St. Martin’s Press, New
York.
Ferranti G (2003), “La thin capitalization trova un’indeducibilità ‘corretta’”, Il Sole
24 Ore, 8 ottobre.
Ferrara F., Corsi F. (2006), L’imprenditore e le società, Giuffré, Milano.
Ferri G. (1998), “La cartolarizzazione dei crediti. Vantaggi per le banche e accesso
ai mercati finanziari per le imprese italiane”, Studi e note di economia, n. 3.
Ferry T. (1988), Modern Accident Investigation and Analysis, Wiley, New York.
Fink S. (1984), Crisis Management: Planning for the Inevitable, Amacom, New
York.
Fiore J. (1999), “La cartolarizzazione dei crediti del Banco di Sardegna, in Aa. Vv.,
Atti del convegno “Le novità legislative in materia di cartolarizzazione dei
crediti”, Il Sole 24 Ore, Milano.
Fisher A. R (1936), “The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems”,
Annals of Eugenics, n. 7.
Fisher I. (1928), The Money Illusion, Adelphi, New York.
235
Fisher I. (1930), “The Opportunity Theory of Interest”, in Economia politica contemporanea, Saggi di economia e finanza, Padova, Cedam.
Fisher I. (1930), The Theory of Interest. As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it, Macmillan, New York.
Fitch IBCA (1997), “Bank Collateralised Loan Obligation: An Overview”, Structured Finance, asset-backed, special report, 18 dicembre.
Fitch IBCA (2002), “Metodologie per l’assegnazione di rating alle imprese non finanziarie”, www.borsaitaliana.it.
Floreani A. (1999), “Altri modelli di formazione del prezzo delle attività finanziarie”, in Cattaneo M., Manuale di finanza aziendale, Il Mulino, Bologna, pp.
276-305.
Floreani A. (2004), Enterprise risk management. I rischi aziendali e il processo di
risk management, ISU Università Cattolica, Milano.
Floreani A. (2004), La valutazione dei rischi e le decisioni di risk management,
ISU Università Cattolica, Milano.
Floreani A. (2005), Introduzione al risk management: un approccio integrato alla
gestione dei rischi aziendali, Etas, Milano.
Forestieri G. (a cura di) (1986), La previsione delle insolvenze aziendali. Profili
teorici e analisi empiriche, Giuffrè, Milano.
Forestieri G. (1992), “Rischio di credito e finanza d’impresa”, Economia & management, n. 2, pp. 36-42.
Forestieri G. (a cura di) (1996), Risk management. Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Egea, Milano.
Forestieri G. (1996), “Lo sviluppo del risk management. Condizioni, limiti, opportunità per le imprese e per il mondo assicurativo”, in Forestieri G. (a cura di),
Risk management. Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Egea, Milano.
Forestieri G., Onado M. (a cura di) (1995), La gestione del credito nelle banche europee: innovazioni organizzative e strumenti per il controllo del rischio, Egea,
Milano.
Froot K., Stein J. (1998), “Risk Management, Capital Budgeting, and Capital
Structure Policy for Financial Institutions: An Integrated Approach”, Journal
of Financial Economics, vol. 47-I, pp. 55-82.
Frova S., Nova A., Ordanini A., Zanetti L. (1998), Fiscalità e strategie di impresa.
L’impatto del nuovo regime fiscale sulle scelte di organizzazione produttiva e
sulle politiche finanziarie, Milano, Egea.
Gai L., Rossi F. (2003), “Basilea2: possibili implicazioni per banche e imprese dall’analisi di un campione di piccole e medie imprese toscane”, Rivista Bancaria, n. 2, pp. 23-59.
Gaitskell B. (1991), “The Securitisation Issuer’s Perspective”, in Shaw Z., International Securitisation: The Scope, Development and Future Outlook for Assetbacked Finance, Stockton, New York.
Galletti D., Guerrieri G. (2002), La cartolarizzazione dei crediti, Il Mulino, Bologna.
236
Gambaro M. (1995), “La titolarizzazione dei crediti: come realizzare un’operazione in Italia”, in Lo sviluppo della securitization in Italia, Bancaria, Roma.
Gannon S. (1999), “The Use of Securitisation to Mobilize Liquidity and in Particolar the Use of Specialized Mortgage Corporations”, in M. Giovanoli, G.
Heinrich, International Bank Insolvencies: A Central Bank Perspectives, Kluwer, The Hague.
Gardener E. P. M. (1986), “Securitisation and the Banking Firm”, Research
Papers in Banking and Finance, RP 86/15, University College of North
Wales, Bangor.
Gardener E. P. M. (1987), “Le banche e lo sviluppo delle operazioni di finanziamento in titoli”, Banca, Impresa e Società, n. 1.
Gardener E. P. M. (1989), “The Future of Securitization in Western Europe”, Research Papers in Banking and Finance, RP 86/23, Institute of European finance, University of North Wales, Bangor.
Generale A., Gobbi G. (1996), “Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche”, Temi di discussione della Banca d’Italia, marzo.
Ghini A., Andriolo M. (1997), “L’analisi delle caratteristiche e delle implicazioni
nella gestione d’impresa della nuova imposta sulle attività produttive”, Bollettino Tributario, n. 12.
Giannini S. (1996), “L’imposizione del reddito d’impresa: un’ipotesi di riforma per
la ricapitalizzazione delle imprese”, in A. Fossati, S. Giannini (a cura di), I
nuovi sistemi tributari, FrancoAngeli, Milano.
Girino E. (1998), “Securitization, i crediti diventano titoli”, Amministrazione e Finanza, n. 5.
Girino E. (1999), “Securitization, le nuove regole”, Amministrazione e finanza,
n. 11.
Giunta F. (a cura di) (2002), Analisi di bilancio. Teoria e tecnica, copisteria Il Prato, Firenze.
Giunta F., Bonacchi M. (1998), “Redditività e fabbisogni finanziari per “aree di
gestione”, Analisi Finanziaria, n. 24.
Glennie D. G., De Bouter E. C., Luke R. D. (1998), Securitization, Kluwer, The
Hague.
Godano G. (1987), “La securitization del capitale internazionale”, Parabancaria, n. 3.
Gordon M. (1998), Production Planning and Controlling, Goodheart-Willcox,
Tinley Park.
Gordon M. J., Kwan C. C. Y. (1979), “Debt Maturity, Default Risk and the Capital
Structure”, Journal of Banking & Finance, n. 3, pp. 313-329.
Gordon R. H., Malkiel B. G. (1981), “How Taxes Affect Economic Behaviour”, in
H. J. Aaron, J. A. Pechman (a cura di), Corporation Finance, The Brookings
Institution, Washington.
Grablowski B., Talley W. (1981), “Probit and Discriminant Functions for Classifying Credit Applicants: A Comparison”, Journal of Economic and Business,
n. 33, pp. 254-261.
237
Graham W. J. (1959), “Income Tax Allocation”, The Accounting Review, January,
pp. 14-27.
Grandinetti R. (1993), Reti di Marketing, Etas, Milano.
Grando A., Verona G., Vicari S. (2006), Tecnologia, innovazione e operations,
Egea, Milano.
Granieri M. (2000), “La disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Appunti di
analisi economica e comparata”, Rivista di diritto dell’impresa, n. 1.
Granieri M., Renda A. (1999), “La securitization tra diritto ed economia, tra normativa nazionale e modelli stranieri”, in Pardolesi R. (a cura di), “La cartolarizzazione dei crediti in Italia”, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale.
Green M. R., Serbein O. N (1983), Risk Management: Text and Cases, Reston
Publishing, Reston.
Greenbaum S. I., Thakor A. V. (1993), “Modalità alternative di raccolta bancaria:
‘securitization’ o depositi”, in G. Marotta, G. B. Pittaluga, La teoria degli intermediari bancari, Il Mulino, Bologna.
Griep C., De Stefano M. (2001), “Standard & Poor’s Official Response to the Basel
Committee’s Proposal”, Journal of Banking & Finance, vol. 25, pp. 149-169.
Griffin H., Dugan M. (2003), “Systematic Risk and Revenue Volatility”, Journal of
Financial Research, vol. 26-2, pp. 179-189.
Gualtieri P. (2000), “Taluni aspetti problematici attinenti la realizzazione di programmi di securitization in Italia”, Banche & Banchieri, n. 2.
Guatri L. (1990), La valutazione delle azienda: teoria e pratica dei Paesi avanzati
a confronto, Egea, Milano.
Guatri L. (1991), La teoria di creazione del valore: una via europea, Egea, Milano.
Guatri L. (1997), Valore e intangibles nella misura della performance aziendale:
un percorso storico, Egea, Milano.
Guatri L. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano.
Guatri L., Bini M. (1998), Trattato sulla valutazione delle imprese, Egea, Milano.
Guatri L., Bini M. (2001) “Veri e falsi multipli di valore: una rilettura concettuale”,
La valutazione delle aziende, n. 22, pp. 3-25.
Guatri L., Bini M. (2002), I moltiplicatori nella valutazione delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano.
Guatri L., Bini M. (2005), Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano.
Guelfi S. (1996a), “Scelte finanziarie “di valore” per gli azionisti”, Amministrazione & Finanza, n. 8.
Guelfi S. (1996b), “La ‘leva’ del prestito obbligazionario crea valore per i soci”,
Amministrazione & Finanza, n. 18.
Guelfi S. (1996c), “Fiscalità nelle strategie finanziarie e valore economico per gli
investitori. Relazioni”, AF – Analisi Finanziaria, n. 24.
Guelfi S. (1998), “Innovazioni fiscali e struttura del capitale”, Analisi Finanziaria,
n. 29.
Hayre L. (1999), An “update on European MBS and ABS market, Salomon Smith
Barney Publications”, www.europeansecuritisation.com.
238
Helman C. (1991), “Developments in Financing Techniques”, in Shaw Z., International Securitisation: The Scope, Development and Future Outlook for Assetbacked Finance, Stockton, New York.
Hempel G. H., Simonson D. G., Coleman A. B. (1994), Bank Management, Text
and cases, Wiley, New York.
Henderson J. (1997), Asset Securitization, Current Techniques and Emerging Market Applications, Euromoney, London.
Henderson J., Scott J. P. (1988), Securitization, Woodhead-Faulkner, Cambridge.
Hull J. C. (2003), Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 Ore, Milano.
Hull J. C. (2006), Opzioni, futures e altri derivati, VI ed., Pearson Prentice Hall,
Milano.
Iavagnilio M., Trutalli F. (1998), “Irap e Dual Income Tax: un approccio indiretto
alla thin capitalization”, Il Fisco, n. 16.
Iben T., Litterman R. (1989), “Corporate Bond Valuation and the Term Structure of
Credit Spreads”, Journal of Portfolio Management, pp. 52-64.
Ingersoll J. (1984), “Some Results in the Theory of Arbitrage Pricing”, Journal of
Finance, vol. 39, pp. 1021-1039.
J. P. Morgan (1997), CreditMetrics, technical document, www.riskmetrics.com.
Jacobson T., Roszbach K. (2003), “Bank Lending Policy, Credit Scoring, and
Value-at-risk”, Journal of Banking & Finance, vol. 27, n. 4, pp. 615-633.
Jensen M. C. (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and
Takeovers”, American Economic Review, n. 76, pp. 323-329.
Jonkhart M. (1979), “On the Term Structure of Interest Rates and the Risk of Default”, Journal of Banking and Finance, pp. 253-262.
Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge.
Kaplan S. N. (1989) “The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value”, Journal of Financial Economics, n. 24.
Kaplan S. N., Ruback R. S. (1995), “The Evaluation of Cash Flow Forecasts: An
Empirical Analysis”, Journal of Finance, n. 50, pp. 1059-1093.
Kendall L. T. (1996), “Securitization. A New Era in American Finance”, in Kendall
L. T., Fishman M. J., A Primer on Securitization, MIT Press, Cambridge.
Kendall L. T., Fishman M. J. (1996), A primer on Securitization, MIT Press, Cambridge.
Keynes J. (1930), The General Theory of Employmen, Interest and Money, MacMillan, London.
Klugman S., Panjer H., Willmot G. (1998), Loss Models: From data to Decisions,
Wiley, Hoboken.
Kmv Corporation (1994), Credit monitoring, San Francisco, www.moodyskmv.com.
Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, VII, p. 48 e ss.
Koller G. (1999), Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry:
A Practical Guide, CRC Press LLC, Boca Raton.
Koppf G., Lent J. (1989), “Securitization: The Future for C & I Loans”, Journal of
Commercial Bank Lending, n. 10.
239
Krahnen J. P., Weber M. (2001), “Generally Accepted Rating Principles: A
Primer”, Journal of Banking & Finance, vol. 25, pp. 3-23.
Kraus F., Litzenberg A. (1973), “A State Preference Model of Optimal Financial
Leverage”, Journal of Finance, vol. 28, pp. 911-922.
Laitinen E., Laitinen T. (2000), “Bankruptcy Prediction. Application of the Taylor’s Expansion in Logistic Regression”, International Review of Financial
Analysis, n. 9, pp. 239-269.
Lando D., Skodeberg T. M. (2002), “Analyzing Rating Transitions and Rating Drift
with Continuos Observations”, Journal of Banking & Finance, vol. 26, n. 2-3,
pp. 423-444.
Langford J. W. (1995), Logistics: Principles and Applications, McGraw Hill, New
York, pp. 488 e ss.
Lanteri A. (1995), “La securitization in Italia: il punto di vista di un operatore”, in
Aa. Vv., Lo sviluppo della securitisation in Italia, Bancaria, Roma.
Lanteri L., Scura E. (2001), “La cartolarizzazione dei crediti e le politiche di bilancio nelle imprese corporate”, in La cartolarizzazione nelle imprese non finanziarie: aspetti teorici, strategici ed operativi, Progetto Fin.Te.Ma., Quaderno
n. 3, dicembre, Egea, Milano.
La Torre M. (1995), Securitisation e banche. La titolarizzazione degli attivi bancari, Il Mulino, Bologna
La Torre M. (1998), “Le politiche finanziarie e il processo di securitisation”, in A.
Carretta, G. De Laurentis, Il manuale del leasing, Egea, Milano.
La Torre M. (1999), “La securitisation degli attivi: gli effetti propulsivi dell’euro”,
Bancaria, n. 2.
Lenoci F., Peola S. (2004), Negoziare con le banche alla luce di Basilea 2, i cambiamenti per le imprese e le banche, Ipsoa, Milano
Liebenberg A., Hoyt R. (2003), “The Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence From the Appointment of Chief Risk Officer”, Risk Management and Insurance Review, vol. 6, n. 1, pp. 37-52.
Lintner J. (1965), “Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification”, Journal of Finance, vol. 20, pp. 587-615.
Lintner J. (1965), “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, Review of Economics and
Statistics, 47 (1), pp. 13-37.
Livian M. (2000), Valutazioni.com, Egea, Milano.
Lorenzoni G. (1980), “Le strategie di impresa fondate su sinergie esterne”,
L’impresa, n. 1.
Lucarelli C. (1996), “Il processo di rating e la creditanalysis per le aziende di credito”, Il Risparmio, n. 3.
Luerti A. (1992), La previsione dello stato d’insolvenza delle imprese. Il modello
AL/93, Etas, Milano.
Lugano R. (2003), “Partecipazioni a vendita agevolata”, Il Sole 24 Ore, 30 giugno.
Lunelli R. (1998), “L’attuazione di una delega per l’applicazione di un’aliquota ridotta sul
reddito d’impresa DIT – Dual Income Tax (rate)”, Il Fisco, n. 15, pp. 4575-4580.
240
Lupi R. (2000), “Profili fiscali delle operazioni di cartolarizzazione”, in Atti del convegno “Business International: II incontro sulla securitisation in Italia”, Roma.
Macminn R. D. (2002), “Value-at-risk: A Comment”, Journal of Banking & Finance, vol. 26, n. 2-3, pp. 297-301.
Maddox J. (1990), “Securitization is Killing Branch Banking”, Journal of Retail
Banking, n. 2.
Maimeri F. (1999), “Prime osservazioni sul disegno di legge in tema di cartolarizzazione dei crediti”, Banca, borsa e Titoli di credito, n. 2, marzo-aprile.
Mandelker G., Rhee S. (1984), “The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on systematic risk of Common Stock”, Journal of Financial
and Quantitative Analysis, vol. 19, pp. 45-57.
Manfredini M. (1998), “Impatto economico e finanziario dell’Irap per una Società
di Capitali”, La Tribuna dei Dottori Commercialisti, n. 3, pp. 14-20.
Mansini R., Speranza M. G. (1996), “Selezione del portafoglio crediti in un processo di ABS”, in AMASES, Atti del Convegno, Università Urbino, Urbino.
Marsland-Shaw L., Selzer D. (1990), “How Rating Agencies View Asset-backed
Debt”, in Bonsall D., Securitisation, Butterworths, London.
Martin D. (1977), “Early Warning of Bank Failures: A Logit Regression Approach”, Journal of Banking & Finance, n. 1, pp. 249-276.
Martin J., Sayrak A. (2003), “Corporate Diversification and Shareholder Value: A
Survey of Recent Literature”, Journal of Corporate Finance, vol. 9, pp. 37-57.
Masera R., Maino R. (2002), Il nuovo accordo di Basilea sul capitale. La recente
evoluzione, le indicazioni del Comitato, i potenziali impatti sui rapporti banca/impresa, Bologna, AITI
Massari M. (1992), Le imprese che possono accedere alla Borsa Valori in Italia, Il
Sole 24 Ore, Milano.
Massari M. (1995), “Il metodo misto di valutazione delle imprese. Una riformulazione
aderente alla moderna finanza aziendale”, Finanza marketing produzione, n. 3.
Massari M. (1998), Finanza aziendale. Valutazione, Mc-Graw Hill, Milano.
Massari M., Perrini F. (1997), “L’effetto Irap-Dit: decisioni finanziarie, valutazione
degli investimenti e delle imprese”, Rivista Milanese di Economia, n. 3.
Massari M., Zanetti L. (2008), Valutazione fondamenti teorici e best practice nel
settore industriale e finanziario, McGraw-Hill, Milano.
Meneghetti P. (2003), “Il credito dei soci diventa sottile”, Il Sole 24 Ore, 15 settembre.
Merton R. (1973), “The Rational Theory of Options Pricing”, Bell Journal of Economics and Management Science, n. 4.
Merton R. (1973), “Theory of Rational Option Pricing”, Bell Journal of Economics
and Management Science, n. 4, pp. 141-183.
Merton R. C. (1974), “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rate, Journal of Finance, May, pp. 6-22.
Metelli F. (1995), Il rischio finanziario, Il Sole 24 Ore, Milano.
Meulbroek L. (2002), “Integrated Risk Management for the firm: A Senior’s Managers Guide”, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 14, pp. 56-70.
241
Miccolis J., Shah S. (2000), “Enterprise Risk Management: An Analytic Approach”, Towers Perrin, Tillighast.
Miglietta A. (1992), “La finanza d’impresa di fronte al vincolo fiscale: una via
per la massimizzazione del valore azionario”, Finanza, Marketing e Produzione, n. 3.
Mignarri E. (1997), “Gli effetti dell’Irap sulle scelte di finanziamento”, Amministrazione & Finanza, n. 16.
Miles J. A., Ezzel J. R. (1980), “The Weighted Average Cost of Capital, Perfect
Capital Markets and Project Life: A Clarification”, Journal of Financial and
Quantitative Analysis, vol. 15.
Mill J. S. (1848), Principles of Political Economy, with Some of Their Applications
to Social Philosophiy, Parker, London.
Miller M. H. (1977), “Debt and Taxes”, Journal of Finance, n. 32, pp. 261-276.
Minty G. (1998), Production Planning and Controlling, Goodheart-Willcox, Tinley Park.
Misani N. (1995), Introduzione al risk management, Egea, Milano.
Misani N. (1999), Il risk management fra assicurazione e finanza. Nuove tecniche
di gestione dei rischi puri: catastrophe bonds, derivati assicurativi, capitale
contingente, risk fusion, Egea, Milano.
Modigliani F., Cohn R. A. (1979), “Rational Valuation in the Market”, Financial
Analysts Journal, March-April, pp. 24-94.
Modigliani F., Miller M. H. (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and
the Theory of Investment”, American Economic Review, 48, 3, pp. 261-297.
Modigliani F., Miller M. H. (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, American Economic Review, 53, 3, pp. 433-443.
Mondaini D., Stupazzini F. (1997), “I titoli garantiti da crediti”, Amministrazione &
Finanza, n. 12.
Monti E., Messina C. (1991), “La tecnica della securitisation”, Bancaria, n. 3.
Moody’s (anni vari), “Rating italiani”, www.borsaitaliana.it.
Moody’s Investor Service (1991), Global Credit Analysis, IFR Publishing, New York.
Moretti G., Ancarani A. (1997), “Scelte di finanziamento: il peso delle nuove imposte”, Amministrazione & Finanza, n. 22.
Morolli M. (1999), “Le prospettive del mercato italiano e l’esempio di un’esperienza estera”, in Aa. Vv., La cartolarizzazione dei crediti in Italia. Caratteristiche tecniche, aspetti legali e fiscali e vantaggi per le banche e per le imprese, Bancaria, Roma.
Morton K. (2000), “Securitising Europe”, Risk, june.
Muratori D. (1993), “Trasformare i crediti in titoli”, Amministrazione e Finanza, n. 3.
Myerberg M. (1996), “The Use of Securitization by Investors and Issuers in International Markets”, in Kendall L. T., Fishman M. J., A Primer on Securitization, MIT Press, Cambridge.
Myers S. C. (1974), “Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions.
Implications for Capital Budgeting”, Journal of Finance, vol. 29, pp. 1-25.
Myers S. C. (1968), “Procedures for Capital Budgeting Under Uncertainty”, Industrial Management Review, pp. 1-20.
242
Myers S. C. (1984), “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, 39, 3, pp.
572-592.
Napolitano G. (1999), “Commento alla l. 30 aprile 1999, n. 130, recante ‘disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti’”, Impresa comm. ind., p. 1297.
Nocco B. W., Stulz R. M. (2006), “Enterprise Risk Management: Theory and
Practice”, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 18
Ocampo J. M. (1989), “The ABCs of Asset Securitization”, The Banker Magazine,
may-june.
ODCEC Roma (2008), Il nuovo regime tributario degli oneri finanziari, Roma,
novembre.
Ohlson J. (1980), “Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy”,
Journal of Accounting Research, n. 28, pp. 109-131.
Ong M. K. (1999), Internal Credit Risk Models: Capital Allocation and Performance Measurement, Risk Books, London.
Paci I. (2004), Temi di finanza aziendale, FrancoAngeli, Milano.
Pardolesi R. (1999), “La cartolarizzazione dei crediti in Italia: commentario alla
legge 130/99”, Quaderni di giurisprudenza commerciale.
Parisi M., Gentili M. (2001), “Asset-backed securities: aspetti operativi e tecniche
di pricing”, Mondo Bancario, n. 5.
Pavel C. (1986), “Securitization”, Economic Perspectives, Federal Riserve Bank of
Chicago, july-august.
Pavel C., Phillips D. (1987), “A Profite of Bank That Sell Loans”, Journal of
Commercial Bank Lending, n. 12.
Pellicanò P. (1998), “La securitisation: aspetti tecnici e legali”, Mondo Bancario, n.
4, luglio-agosto.
Pennock M., Haimes Y. (2002), “Principles and Guidelines for Project Risk Management”, System Engineering, vol. 5, n. 2, pp. 89-108.
Perold A. (2001), “Capital Allocation in Financial Firms, Competition and Strategy” Working Paper Series, Harvard Business School, n. 98, p. 72.
Perrini F. (2000), E-valuation: valutare le imprese Internet, McGraw Hill, Milano.
Perrini F., Vesin G. (1998), “La quotazione in borsa di un’azienda familiare”, Economia & Management, n. 3, pp. 51-65.
Petkovic D. (2000), “New Structure: Whole Business Securitisation of Project
Cash Flow”, Journal of International Banking Law, n. 8.
Piazza M. (2003), “Sette ‘lacci’ contro l’indebitamento”, Il Sole 24 Ore, 19 ottobre.
Piazza M., Bono M. (2003), “Per i debiti il ‘peso’ dei soci”, Il Sole 24 Ore, 8 novembre.
Piccolo D. (2000), Statistica, Il Mulino, Bologna.
Pini G. (1995), “La securitisation: rischi e ruolo del rating”, in Lo sviluppo della
securitisation in Italia, Bancaria, Roma.
Piras L. (2002), “Creazione e misurazione del valore: un confronto tra DCF ed
EVA”, Analisi Finanziaria, n. 45, pp. 4-29.
Pivato S. (1983), Trattato di Finanza Aziendale, FrancoAngeli, Milano.
243
Pivato S. (1992), “La protezione delle risorse aziendali”, in Guatri L., Economia
delle aziende industriali e commerciali, Egea, Milano.
Pivato S. (1995), Il mercato telematico per piccole e medie imprese. Realtà locali e
contesto internazionale, Giuffrè, Milano.
Poli A. (1997), Costo del capitale, Etas, Torino.
Porter M. E. (1982), La strategia competitive. Analisi per le decisioni, Editrice
Compositori, Bologna.
Porter M. E. (1987), “From Competitive Advantage to Corporate Strategy”, Harvard Business Review, May-June, pp. 43-59.
Porter M. E. (1987), Il vantaggio competitivo, Edizioni di comunità, Milano.
Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, Londra.
Preda S. (1986), L’innovazione finanziaria in Italia, Unicopli, Milano.
Preda S. (1996), La finanza mobiliare in banca, Egea, Milano.
PricewaterhouseCoopers (1996), “Enhancing Shareholder Wealth by Better Managing Business Risk”, International Federation of Accountants.
Pyle D. H., Leland H. E. (1977), “Informational Asymmetries, Financial Structure,
and Financial Intermediation”, Journal of Finance, n. 32, pp. 371-387.
Quadri A. (1999), “Potenzialità della cartolarizzazione”, Credito Cooperativo, n. 6/7.
Quagliata B. (1991), “La tecnica della securitisation”, Tributi, n. 12.
Querè M. (1990), “Securitisation in France”, in Bonsall D., Securitisation, Butterworths, London.
Rajan R., Servaes H. (1997), “Analyst Following of Initial Public Offerings”,
Journal of Finance, n. 52, pp. 507-529.
Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value: The New Standard for Business
Performance, Free Press, New York.
Rappaport A., Mauboussin M. J. (2001), Expectations Investing: Reading Stock
Prices for Better Returns, Harvard Business School Publishing, Harvard.
Reilly A. H. (1987), “Are Organizations Ready for Crises? A Managerial Scorecard”, Columbia Journal of World Business.
Reis R. C. (1998), “Securitisation Structures”, J. of International Banking Law, n. 1.
Renn J. (1998), “Three Decades of Risk Research: Accomplishment and New
Challenger”, Journal of Risk Research.
Renoldi A. (1997), Valore dell’impresa, creazione di valore e struttura finanziaria,
Egea, Milano.
Repetto D. (2000), “Il business dei titoli securitizzati”, Il giornale della banca e
della finanza, n. 1.
Resti A. (2002), “La riforma dei requisiti patrimoniali obbligatori: effetti sulla
qualità dell’offerta di credito”, in Settimo rapporto sul sistema finanziario italiano. La banca, le regole e l’etica. Stabilità, integrità, sostenibilità, Fondazione Rosselli, Edibank.
Reuvid J. (2005), Managing Business risk – A Practical Guide to Protecting Your
Business, II ed., Kogan Page, London.
Ricardo D. (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, Murray,
London.
244
Ricci R., Messina C. (1992), L’innovazione finanziaria, Utet, Torino.
Ricci S. (1999), “L’utilizzo della leva finanziaria: aspetti fiscali”, Tribuna dei Dottori Commercialisti, n. 1.
Riparbelli A. (1950), Il contributo della ragioneria all’analisi dei dissesti, Vallechi, Firenze, pp. 73 e ss.
Rizzi J., Maza M., Mansfield D. (1998), “Liberating the Balance Sheet”, Corporate
Finance, Guide to Securitisation, supplemento, gennaio.
Rizzino Bisinelli S., Anello P. (2000), “Spogliarsi del rischio di catastrofe con
emissione di bond”, Amministrazione & Finanza, n. 13.
Rocca E. (1999), “Securitization e rappresentazione in bilancio”, Amministrazione
e finanza, n. 11.
Roggi O. (2003), Valore intrinseco e prezzo di mercato nelle operazioni di finanza
straordinaria. Una analisi sulle public utilities, FrancoAngeli, Milano.
Roggi O. (2007), “Basel II e default risk estimation”, atti della conferenza “Small
Business Banking and Financing: A Global Perspective”, Cagliari 2007.
Roll R. (1977), “An Analytical Formula for Unprotected American Call Options on
Stocks with Known Dividends”, Journal of Financial Economics, n. 5.
Rosenthal J. A., Ocampo J. M. (1988), “The Future of Credit Securitization”, The
McKinsey Quarterly, autumn.
Rosenthal J. A., Ocampo J. M. (1988), Securitization of Credit. Inside the New
Technology of Finance, McKinsey, Wiley, New York.
Ross S. (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of
Economic Theory, n. 13, pp. 341-360.
Rumi G. (2000), “Securitisation in Italia. La legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione
dei crediti”, Giurisprudenza Commerciale, n. 3.
Rumi G. (2001), Securitisation. La cartolarizzazione dei crediti in Italia, regolamentazione dell’istituto, Il Sole 24 ore, Milano.
Runde J. (1998), “Clarifying Frank Knight’s Discussion of the Meaning of Risk
and Uncertainty”, Cambridge Journal of Economics, vol. 22, pp. 539-546.
Saunders A. (1997), Financial Institutions Management, Boston, Irwin.
Saunders A., Altman E. I. (2001), “An Analysis and Critique of the BIS Proposal on
Capital Adequacy and Ratings”, Journal of Banking & Finance, vol. 25, pp. 25-46.
Scarelandi P. (2000), “L’esperienza di San Paolo IMI”, in Aa. Vv., Modelli per la
gestione del rischio di credito. I ratings interni. Tematiche istituzionali, Banca,
d’Italia, Roma.
Schall L. D., Sundem G. L. (1980), “Capital Budgeting Methods and Risk”, Financial Management, vol. 9, pp. 161-179.
Schroeck G. (2002), Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, Wiley, New York.
Schumpeter J. A. (1948), “Irving Fisher’s Econometrics”, Econometrica, n. 3, July,
pp. 219-31.
Shall L. (1972), “Asset Valuation, Firm Investment and Firm Diversification”,
Journal of Business, pp. 11-28.
245
Sharpe W. F. (1964), “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under
Condition of Risk”, Journal of Finance, n. 19, pp. 425-442.
Shaw Z. (1991), International Securitisation: The Scope, Development and Future
Outlook for Asset-backed Finance, Stockton, New York.
Sierra J., Becchetti L. (2003), “Bankruptcy Risk and Productive Efficiency in
Manufacturing Firms”, Journal of Banking & Finance, vol. 27, n. 11, pp.
2099-2120.
Simon H. A. (1957), Administrative Behavior, II ed., McMillan, New York.
Sironi A. (2000a), “La misurazione e la gestione del rischio di credito: approcci
alternativi, obiettivi e applicazioni”, in P. Savona, A. Sironi (a cura di), La gestione del rischio di credito, esperienze e modelli nelle grandi banche italiane,
Edibank, Roma.
Sironi A. (2000b), “Un approccio multinomiale semplificato per le banche italiane”, in P. Savona, A. Sironi (a cura di), La gestione del rischio di credito,
esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, Edibank, Roma.
Sironi A. (2005), Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano.
Sironi A., Marsella M. (a cura di) (1998), La misurazione e la gestione del rischio
di credito: modelli, strumenti e politiche, Bancaria, Roma.
Sironi A., Savona P. (a cura di) (2000), La gestione del rischio di credito: esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, Edibank, Roma
Smallman J., Selby M. (1990), “Asset-backed Securitisation”, in Bonsall D., Securitisation, Butterworths, London.
Smith C. W. (1980), “On the Theory of Financial Contracting: The Personal Loan
Market”, Journal of Monetary Economics, vol. 6, pp. 333-357.
Smith C. W., Smithson C. W., Wilford D. S. (1990), Managing Financial Risk,
Harper & Row, New York.
Smith D. (a cura di) (2002), Business Continuity Management: Good Practice
Guidelines, Business Continuity Institute, London.
Smith J. (2003), “The Shareholder vs. Stakeholder Debate”, MIT Sloan Management Review, Summer, pp. 85-90.
Spiess D. K., Pettway R. H. (1997), “The IPO and First Seasoned Equity Sale: Issue Proceeds, Owner/Managers’ Wealth and the Underpricing Signal”, Journal
of Banking & Finance, n. 21, pp. 967-988.
Springate G. L. V. (1978), “Predicting the Possibility of Failure in a Canadian
Firm”, Unpublished MBA Research Project, Simon Fraser University, January.
Standard & Poor’s (1996), Corporate Rating Criteria, New York.
Standard & Poor’s (1998), Ratings performance 1997: Stability and Transition,
New York.
Standard & Poor’s (2002), Credit Risk Tracker Italy, New York.
Stein J., Usher S., LaGatutta D., Youngen J. (2001), “A Comparables Approach to
Measuring Cash flow-at-Risk for Non-Financial Firms”, Journal of Applied
Corporate Finance, vol. 13, n. 4, pp. 100-109.
Stevenson W. J. (1996), Production-Operations Management, V ed., McGraw-Hill,
New York.
246
Stewart G. B. III (1991), The Quest for Value: The EVATM Management Guide,
Harper Collins, New York.
Stone C., Zissu A., Lederman J. (1991), Asset Securitisation: Theory and Practice
in Europe, Euromoney, London.
Stupazzini G. (1997), “I titoli garantiti da crediti”, Amministrazione e Finanza, 12.
Stoughton N. M., Zechner J. (1998), “IPO – Mechanisms, Monitoring and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, n. 49, pp. 45-77.
Szego G., Varetto F. (1999), Il rischio creditizio, Utet, Torino.
Tagliavini A., Sebton T. (1995), “L’esperienza italiana ed europea a confronto”, in
Aa. Vv., Lo sviluppo della securitization in Italia, Bancaria, Roma.
Tagliavini G. (1998), “Il ROI ‘dopo’ l’Irap”, Analisi Finanziaria, n. 10.
Tardivo G. (1990), Innovazione finanziaria e mercati internazionali dei capitali,
Giappichelli, Torino.
Tasca R. (1987), “Il contributo delle unità in disavanzo alla titolarizzazione nei
mercati finanziari internazionali”, Banche e Banchieri, n. 9.
Taulli T. (1999), Investire negli IPO, Egea, Milano.
Terriero G., ABI, Atti del convegno “Nuovi approcci nella valutazione del rischio di credito delle imprese: sistemi di internal rating”, Brescia 21 gennaio 2003.
Thieffry G., Walsh J. (1997), “Securitisation: The New Opportunities Offered by
Economic and Monetary Union”, Journal of International Banking Law, n. 12.
Thompson J. K. (1995), Securitisation: An International Perspective, OECD, Paris.
Tobin J. (1985); “Neoclassical Theory in America: J. B. Clark and Fisher”; American Economic Review, pp. 28-38.
Treccani (2008), Enciclopedia Giuridica.
Treynor J. (1961), “Market Value, Time and Risk”, unpublished document.
Trippi R. R., Turban W. (1993), Neural Networks in Finance and Investing, Irwin,
Chicago.
Troiano V. (1994), Le polizze di credito commerciale, Cacucci, Bari.
Valacca R. (1999a), “La cartolarizzazione dei crediti nella disciplina del reddito
d’impresa”, Corriere Tributario, n. 19.
Valacca R. (1999b), “Cartolarizzazione dei crediti pecuniari ceduti a titolo oneroso”, Corriere Tributario, n. 29.
Valliapan K. (1990), “The Impact of Securitisation on UK Bank Corporate Lending”, in Institute of European Finance, Research Papers in Banking and Finance, University College of North Wales, Bangor.
Van Deventer J. (1990), Towards Securitisation. Trends in the International Financial Markets, Butterworths, London.
Vantellini P. (1988), “Ruolo delle Holding Estere e Gestione Finanziaria dei Gruppi”, Economia e Management, luglio.
Varetto F. (1990), Il sistema di diagnosi dei rischi di insolvenza delle Centrale Bilanci, Bancaria, Roma.
Varetto F., Marco G. (1994), Diagnosi dell’insolvenza aziendale con reti neurali,
Bancaria, Roma.
247
Vella C. (2001), “Effetti della cartolarizzazione nei bilanci delle società cessionarie”, Bancaria, n. 9.
Verna A. (1999), “Sintesi del rapporto IRS sul mercato azionario 1999”, Banche e
Banchieri, n. 3, pp. 290-297.
Viel J., Bredt O., Renard M. (1986), La valutazione delle aziende, Etas, Milano.
Visco J. D. (1995), “Debt-free Approach Revisited”, Business Valuation Approach,
March.
Vitale S. (1999), Il regime giuridico delle operazioni internazionali di securitization. La cartolarizzazione, Cedam, Padova.
Vitucci M. (2001), “La cartolarizzazione degli attivi: profili di legislazione e vigilanza”, Mondo Bancario, n. 6.
Vose D. (2000), Risk Analysis. A Quantitative Guide, Wiley, Chichester.
Walras L. (1874) Elements d’economie politique pure, Economia, Paris.
Wenman L. (1991), “Credit Enhancement: Introduction and Overview”, in Shaw
Z., International Securitisation: The Scope, Development and Future Outlook
for Asset-backed Finance, Stockton, New York.
Wiginton J. (1980), “A Note on the Comparison of Logit and Discriminant Models
of Consumer Credit Behaviour”, Journal of Financial and Quantitative
Analyis, n. 15, pp. 757-770.
Willet A. (1901). The Economic Theory of Risk and Insurance, University Press of
Pacific, Hawaii.
Wilson R. L., Sharda R. (1993), “Bankruptcy Prediction Using Neural Networks”,
in Trippi R. R., Turban E., Neural Networks in Finance and Investing, Irwin,
Chicago.
Wright M. (1994), Management buy-outs: Issues and Evidence, Dartmouth, Aldershot.
Wright M., Thompson S., Robbie K. (1992), “Venture Capital and Management
Led-leverage Buy-out: A European Perspective”, Journal of Business Venturing, n. 7.
Yang Z. R., James H., Packer A. (1997), The Failure Prediction of UK Private
Construction Companies, Mimeo.
Zanelli M. (1995), La securitisation: aspetti tecnici e regolamentazione, Futura2000, Roma.
Zanetti L. (2000), La valutazione delle acquisizioni: sinergie, rischio e prezzi,
Egea, Milano.
Zappa G. (1927), Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Istituto Editoriale
Scientifico, Milano.
Zazzara C. (2001), “I modelli per il rischio di credito nel nuovo accordo di Basilea”, relazione presentata al convegno Cermef “Rischio di credito, nuovo accordo di Basilea e implicazioni per le banche italiane”, Banca di Roma, Roma.
Ziliotti B., Benedetti A. (2007), Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul
leverage finanziario: una analisi teorica del caso italiano, Parma, WP 02.
Zmiewski M., Foster B. (1996), “Credit Scoring Speeds Small Business Loan
Processing”, Journal of Lending & Credit Risk Management, novembre.
248