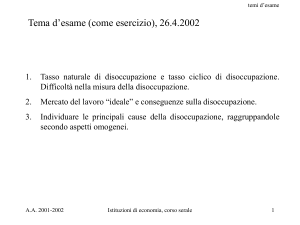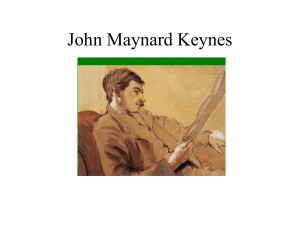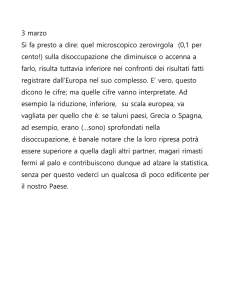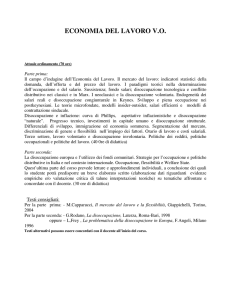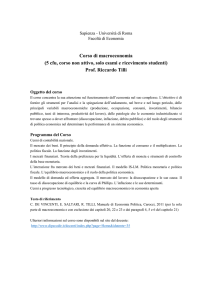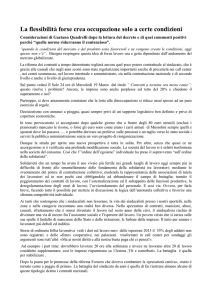Emilio Reyneri
OCCUPAZIONE, LAVORO E DISEGUAGLIANZE SOCIALI NELLA
SOCIETÀ DEI SERVIZI
in corso di pubblicazione (non citare)
1. Apogeo e caduta della classe operaia della grande industria
A metà anni Settanta in Europa e negli altri paesi dell’Occidente sviluppato si concluse
un trentennio di crescita economica senza precedenti (la golden age) e di grandi
miglioramenti delle condizioni di lavoro e di vita (les trente glorieuses). Nonostante il
forte esodo agricolo, vi fu una costante crescita dell’occupazione e il tasso di
disoccupazione dei paesi europei scese fino all’1,5% a metà anni Sessanta. Nei paesi
first comers dello sviluppo capitalistico, come Gran Bretagna e Olanda, si completò la
transizione industriale e cominciò a decollare quella terziaria; in altri, come Francia e
Germania, esplose il processo di industrializzazione; in altri ancora, i late comers, come
l’Italia, i tempi furono un po’ ritardati, ma la rapidità del mutamento fu ancor maggiore.
La forte mobilità settoriale si realizzò in poco più di una generazione grazie a un
profondo ricambio della forza lavoro. Imponenti immigrazioni interne e internazionali
sostituirono le donne, che si dedicarono in maggior misura al lavoro familiare, i più
giovani, che proseguirono negli studi, e gli anziani, che cominciarono a godere di un
migliore sistema pensionistico (Reyneri 2000).
Il sistema economico e sociale si trovava in un circolo virtuoso. Grazie a un boom
degli investimenti industriali la produttività del lavoro cresceva a un ritmo inusitato;
anche il volume della produzione cresceva rapidamente e trovava facile sbocco nella
sempre maggiore capacità di consumo di beni durevoli da parte delle famiglie; i salari
dei lavoratori aumentavano in misura cospicua senza causare inflazione né contrazione
dei profitti delle imprese, poiché la loro dinamica restava entro quella della produttività
del lavoro; infine si affermava il welfare state o état providence, che, pur con notevoli
differenze nazionali, ridusse le insicurezze nel mercato del lavoro con le indennità di
disoccupazione e le pensioni e contribuì ad accrescere il benessere delle famiglie dei
lavoratori fornendo gratuitamente un crescente volume di servizi sanitari, educativi e
sociali.
Nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale la metà degli anni Settanta
segna il massimo assoluto dell’occupazione industriale con percentuali tra il 37% e il
44%, mentre nei paesi, come Gran Bretagna, Olanda e Svezia, in cui l’esodo agricolo
era avvenuto prima della guerra, il terziario diventa il settore dominante già a metà anni
Settanta con percentuali tra il 55% e il 65%. La Germania seguì una dinamica simile,
anche se il declino dell’industria fu più lento, così come l’avvio della terziarizzazione.
L’occupazione è caratterizzata anche da un forte processo di salarizzazione. La
percentuale di piccoli imprenditori e lavoratori in proprio (artigiani e commercianti) in
qualche paese raggiunge livelli così bassi (neppure il 7% in Gran Bretagna e ancor
meno in Svezia) da far pensare a un’imminente scomparsa del lavoro indipendente. Solo
1
i liberi professionisti aumentano, ma il loro numero resta ancora esiguo. Parallelamente
cresce la dimensione media delle imprese, in particolare nell’industria manifatturiera.
Gli anni Sessanta e i primi anni Settanta segnano l’irrepetibile stagione del gigantismo
industriale. In alcuni paesi europei questo processo fu incentivato dall’intervento dello
stato, che nazionalizzò settori in crisi o ne promosse altri ove l’iniziativa privata era
carente. L’occupazione in grandi organizzazioni aumentò anche per la diffusione dei
servizi pubblici (soprattutto sanità e scuola): a fine anni Settanta, nei paesi europei i
dipendenti pubblici avevano quasi raddoppiato il loro peso in meno di trent’anni.
Tra la fine degli anni Sessanta (in Gran Bretagna, Olanda, Belgio) e i primi anni
Settanta (in Germania, Italia, Francia, Spagna) si raggiunse la massima diffusione del
sistema di produzione taylorista e fordista, che prevede la standardizzazione del lavoro
operaio in compiti ripetitivi da affidare a lavoratori cui si richiedono solo disciplina e
resistenza psicofisica. Ciò consentì l’inserimento di manodopera senza esperienza né
socializzazione al lavoro industriale. Nelle grandi imprese si afferma la logica del job o
«posto» che promette di garantire l’occupazione sino alla pensione, almeno ai lavoratori
nazionali. La burocratizzazione delle imprese industriali e dei servizi pubblici e la
diffusione delle macchine per ufficio e dei centri di elaborazione dati provocarono la
parcellizzazione anche di molte mansioni non manuali e una forte crescita di impiegati
esecutivi addetti a lavori altrettanto monotoni e ripetitivi di quelli svolti dagli addetti
alla catena di montaggio. Si parlò di proletarizzazione del lavoro non manuale e si mise
in discussione il tradizionale confine tra lavoro operaio e impiegatizio.
Ancora più che per la sua diffusione (che in nessun paese europeo occidentale può aver
superato un quinto dell’occupazione) la figura dell’operaio comune (semiskilled o
ouvrier spécialisé) della grande impresa manifatturiera acquisì un ruolo dominante nel
sistema di relazioni industriali e sulla scena sociale grazie alla sua concentrazione e alla
capacità di mobilitazione. Alla nuova classe operaia, di origine rurale e senza tradizioni
sindacali, si era attribuito un comportamento deferente verso l’autorità e la disciplina
imposta dalla grande impresa, che li ricambiava con salari relativamente elevati e con la
sicurezza del posto di lavoro. Questa era la prima generazione di lavoratori manuali che
riusciva ad accedere ai consumi di massa e a un sicuro benessere economico, avendo
ancora fresco il ricordo di una condizione misera e incerta e di attività lavorative ben
più faticose e penose. Negli anni Sessanta i sociologi parlarono di «operaio affluente»
per descrivere i giovani operai che adottavano stili di vita simili a quelli dei giovani del
ceto medio e si mostravano poco propensi alla conflittualità e alla militanza sindacale.
La mobilitazione individualistica parve sostituire quella collettiva.
Ma la profezia della fine del conflitto industriale fu clamorosamente smentita dal più
acceso ciclo di lotte operaie del dopoguerra. Mentre negli Stati Uniti la disaffezione dei
giovani operai verso il lavoro dequalificato e ripetitivo provocò una forte crescita
dell’assenteismo, in Europa dal 1969 scoppiò un movimento di scioperi che sorprese le
organizzazioni sindacali. La sicurezza del lavoro, assicurata da una situazione di pieno
impiego, aveva avuto senza dubbio un ruolo importante nel ridurre la remora al conflitto
dovuta al timore del licenziamento, profondamente diffuso tra lavoratori privi di risorse
professionali e quindi con scarso potere di contrattazione individuale. E la rigida
organizzazione del lavoro della grande impresa taylorista si rivelò fragile di fronte alle
asprezze conflittuali di una forza lavoro non socializzata alla «cultura del produttore»
della vecchia classe operaia. Anche se la conflittualità rimase elevata sino a metà anni
Settanta solo in Italia, ove gli operai delle catene di montaggio erano tutti nazionali, il
modello della golden age si era ormai incrinato.
2
Le conquiste sindacali e politiche furono importanti in tutti i paesi europei. Si
consolidò il modello di occupazione caratterizzato da un contratto a tempo pieno e
indeterminato e dall’integrazione organizzativa nell’impresa. Sia il diritto del lavoro sia
la contrattazione collettiva mirarono a porre forti vincoli alla libertà delle imprese di
fare licenziamenti, non soltanto individuali, ma anche collettivi. E in caso di perdita del
lavoro l’intervento pubblico offriva ampie tutele, inserendo i disoccupati in generosi
programmi di sostegno del reddito. La percentuale di sussidi e di trasferimenti alle
famiglie sul prodotto interno lordo raddoppiò da metà anni Cinquanta a metà anni
Settanta. Infine, il forte aumento delle retribuzioni del lavoro dipendente e in particolare
della fascia meno qualificata fece sì che nei primi anni Settanta la distribuzione del
reddito divenne la più favorevole ai lavoratori e le differenze retributive le più ridotte
dell’epoca moderna (Oecd 2007).
Il sistema economico dell’Europa occidentale non fu più in grado di far fronte alla
crescente rigidità e al maggior costo del lavoro anche per i due choc petroliferi del 1974
e del 1979, che causarono un forte aumento dei costi dell’energia. La recessione
provocò un aumento della disoccupazione e si avviò un circolo vizioso: caduta dei
profitti e degli investimenti, rallentamento della dinamica della produttività del lavoro e
dei salari reali, riduzione dell’occupazione, alta inflazione nonostante la stagnazione
produttiva. Inoltre, la crescente concorrenza dei paesi in via di sviluppo e i nuovi
comportamenti dei consumatori, più orientati alla qualità, avevano reso saturi e/o incerti
i mercati dei beni di consumo, mostrando i limiti del sistema di produzione fordista. La
fine delle trente glorieuses fu segnata dalla caduta del suo protagonista: la classe
operaia della grande industria.
2. Deindustrializzazione e terziarizzazione
Il passaggio dall’agricoltura all’industria fu vissuto favorevolmente perché consentì un
netto miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, nonostante i costi psicologici
dell’inurbamento o dell’immigrazione. Inoltre, la disoccupazione diminuì perché le
donne ridussero la loro partecipazione al mercato del lavoro e il pieno impiego dei
maschi breadwinner fu facilmente raggiunto. Decisamente traumatico fu invece il
processo di deindustrializzazione e terziarizzazione, non solo perché la chiusura delle
grandi fabbriche precedette il decollo dell’occupazione nei servizi, ma anche perché le
nuove occasioni di lavoro nei servizi non erano adatte alle caratteristiche personali e alle
qualificazioni professionali degli ex-operai industriali. Pertanto, mentre tornava a
crescere l’offerta di lavoro femminile, la disoccupazione tornò a dominare la scena
dell’Europa occidentale: il tasso di disoccupazione crebbe sino superare il 10% negli
anni Novanta e non è sceso sotto il 7% neppure nella congiuntura favorevole dei primi
anni Duemila. E nell’Europa orientale la transizione all’economia di mercato provocò
una drammatica esplosione della disoccupazione, con tassi oltre il 15% per parecchi
anni.
Poiché le imprese destinate alla chiusura erano la roccaforte dei sindacati, prima
in Gran Bretagna e poi negli altri paesi dell’Europa occidentale la deindustrializzazione
provocò la ripresa di un’accesa conflittualità, inevitabilmente destinata a «gloriose
sconfitte». Cospicui pre-pensionamenti in Germania, Italia, Belgio e Francia e costose
politiche attive di reinserimento al lavoro nei paesi scandinavi riuscirono ad attenuare le
tensioni sociali, mentre in Gran Bretagna il trionfante tatcherismo riuscì a vincere le
resistenze dei lavoratori licenziati. Ancor più drammatica fu la de-industrializzazione
3
nei paesi dell’Europa orientale, ove l’occupazione industriale negli anni Ottanta aveva
raggiunto un livello altissimo, poiché concise con il crollo del sistema comunista. Nella
ex-Germania Est dal 1989 al 1992 sparì un terzo dei posti di lavoro. Al di là delle
diverse connotazioni ideologiche, un evidente parallelismo tra grande industria, classe
operaia e organizzazione accentrata dell’attività economica e della vita sociale aveva
caratterizzato un trentennio di storia europea, sia all’Est, sia all’Ovest, e ora si esaurisce
con l’avvento della società dei servizi (Therborn 1995).
La percentuale di occupati nelle imprese manifatturiere nei paesi dell’Europa
occidentale, che a metà anni Settanta oscillava tra il 25% e il 35%, trenta anni dopo va
dal 13% al 22%. Il paese più industrializzato rimane la Germania, seguita dall’Italia, su
livelli prossimi a quelli di quasi tutta l’Europa orientale dopo il crollo dell’economia
pianificata. Ma la contrazione della classe operaia delle grandi fabbriche è ancor più
rilevante. Per ridurre i costi del lavoro e/o aumentare la flessibilità, le grandi imprese
cominciarono ad affidare parte del proprio ciclo produttivo a piccole unità, che operano
spesso al di fuori del sistema delle garanzie consolidatosi nell’«età dell’oro». Inoltre,
nelle poche grandi imprese manifatturiere sfuggite al processo di downsizing le funzioni
di produzione diretta si riducono a favore di quelle indirette di gestione, innovazione e
distribuzione sia per il ricorso a tecnologie labour saving, sia per il decentramento in
paesi meno sviluppati. Nelle imprese industriali dell’Europea occidentale i lavoratori
manuali si riducono a poco più della metà degli occupati e superano il 65% solo in
Spagna, Italia e nell’Europa orientale, ove prevalgono imprese piccole con tecnologie
arretrate. Ormai in Francia, Gran Bretagna e Olanda la maggioranza del lavoro manuale
non sta più nei tradizionali settori dell’agricoltura, dell’industria e nelle costruzioni, ma
nei servizi e negli altri paesi dell’Europa occidentale siamo comunque oltre il 40%. Solo
nell’Europa orientale il lavoro manuale è ancora prevalentemente industriale.
Ridotta a un ruolo marginale l’occupazione agricola (meno del 4% nell’Europa
occidentale, ma ancora oltre il 10% in quella orientale), all’inizio del nuovo millennio la
domanda di lavoro si concentra sempre più nel terziario: oltre il 77% in Gran Bretagna,
Olanda e paesi scandinavi, poco meno in Francia, mentre la soglia del 70% non è stata
raggiunta soltanto in Germania, Italia e Spagna e quella del 60% nell’Europa orientale.
In buona parte dell’Europa il divario rispetto agli Stati Uniti, ove l’occupazione terziaria
sfiora l’80%, appare ormai quasi colmato. Se la tendenza è comune, tuttavia, i processi
di terziarizzazione sono diversi da un paese all’altro, pur essendo condizionati da un
cambiamento tecnologico e una crescita economica simili. Infatti, solo la minor parte
dei lavoratori del terziario fornisce servizi alle imprese (da quelli finanziari a quelli
informatici, dalla consulenza alla commercializzazione), perché la componente di gran
lunga maggioritaria è quella dei servizi alle persone: dalla sanità all’istruzione, dalla
sicurezza al divertimento, dalla distribuzione commerciale alla ristorazione. E volume e
composizione dell’occupazione in questi servizi dipendono dai modelli di welfare state
e di famiglia di un paese.
Nei paesi scandinavi, caratterizzati da una forte pressione fiscale e da famiglie
che tendono a esternalizzare le funzioni di cura, si è consolidato un cospicuo settore
pubblico nella sanità, nell’istruzione e nei servizi sociali, mentre nei paesi anglosassoni,
ove le famiglie tendono egualmente a esternalizzare le funzioni di cura, ma la pressione
fiscale è bassa, l’occupazione nei servizi alla persona è altrettanto alta, ma più privata.
Invece, nei paesi dell’Europa continentale e meridionale, ove a una pressione fiscale
medio-alta si accompagna la tendenza delle famiglie a internalizzare le funzioni di cura,
l’occupazione nei servizi alla persona è più ridotta (Esping-Andersen 1991). Poiché ora
4
il volume complessivo dell’occupazione nei paesi occidentali dipende in larghissima
misura proprio dall’occupazione nei servizi per la persona, si comprende perché in paesi
come la Danimarca e la Gran Bretagna il tasso di occupazione della popolazione da 15 a
64 anni sfiora il 75% grazie a percentuali di occupazione nei servizi alla persona
superiori al 30%, mentre Francia e Germania, ove le persone occupate in questi servizi
sono intorno al 25%, il tasso di occupazione non arriva al 70% e Italia e Spagna, ove
appena il 20% delle persone lavora nei servizi alla persona, non arriva neppure al 60%.
Gran parte dei servizi alla persona sono forniti da dipendenti pubblici, che nell’Europa
occidentale sono in forte crescita da fine anni Settanta perché l’accresciuto peso politico
della classe operaia aveva provocato uno sviluppo della cittadinanza sociale e l’aumento
della spesa pubblica (Crouch 2001). La percentuale di occupati nel settore pubblico, che
a fine anni Settanta aveva raggiunto il 15%, all’inizio del nuovo secolo sfiorava il 25%,
sia pur con forti differenze nazionali secondo il livello di reddito e il modello di welfare
state (dal 16% della Spagna e dal 22% della Gran Bretagna al 24-26% di Germania e
Italia e al 37% della Danimarca). E, poiché sia in famiglia sia in strutture pubbliche o
private i servizi alla persona sono per lo più prestati da donne, nella società dei servizi
quel che fa la differenza nel livello dell’occupazione è proprio la posizione delle donne.
3. La femminilizzazione del mercato del lavoro
Quando la classe operaia dell’Europa occidentale raggiunse il suo maggior peso sociale
e politico le donne erano al minimo della partecipazione al mercato del lavoro. Sia pure
con un’anticipazione nei paesi scandinavi e in Gran Bretagna, nell’Europa occidentale
la crescita dei tassi di attività femminili decolla solo negli anni Settanta e prosegue più
lentamente negli anni Ottanta e Novanta, per poi accelerare nuovamente all’inizio del
nuovo secolo. Fanno eccezione Spagna e Olanda, ove la partecipazione al lavoro delle
donne, che partiva da un livello molto basso, è cresciuta sempre a ritmi elevati. Al
contrario, la transizione dall’economia pianificata a quella di mercato ha provocato un
crollo dell’alta occupazione femminile, che solo in parte si è poi ripresa, sicché buona
parte dei paesi dell’Europa orientale attualmente appartiene, insieme a Grecia, Italia e
Spagna, al gruppo dei paesi a bassa partecipazione delle donne al lavoro (con tassi di
occupazione inferiori al 55%), mentre i paesi scandinavi, l’Olanda e la Gran Bretagna
sono quelli a più alta partecipazione (con tassi di occupazione oltre il 65%). Perciò, la
percentuale delle donne tra gli occupati oscilla dal 40% dell’Italia al 47% della Svezia,
per i paesi dell’Europa occidentale ben 10-12 punti percentuali più che nei primi anni
Settanta.
Le attuali differenze nel tasso di occupazione delle donne in paesi con tenori di
vita e strutture tecnologiche simili dipendono principalmente dalla possibilità di fruire
di servizi di cura, pubblici o privati, perché sono concentrate nella fascia di età adulta
sulla quale le norme sociali prevalenti fanno gravare il compito di svolgere lavori di
cura nella famiglia. D’altro canto, questi servizi occupano per lo più donne, sicché
l’elevata occupazione femminile è frutto di un «circolo virtuoso» tra domanda e offerta
di lavoro, innescato dalla spesa pubblica nei paesi scandinavi e da quella privata in Gran
Bretagna. Altrettanto importante è stato il ruolo del part time: nei paesi dell’Europa
occidentale (con l’eccezione dell’Italia sino ai primi anni Novanta) l’occupazione delle
donne è cresciuta per lo più grazie all’aumento della componente a tempo parziale e il
tasso di occupazione femminile è più alto nei paesi in cui il part time è più diffuso.
Tuttavia, in alcuni paesi dell’Europa settentrionale l’altissima percentuale di donne
5
occupate a tempo parziale da qualche anno si sta riducendo. Si può pensare che, ormai
consolidata la propria posizione nel mercato del lavoro, le donne sono riuscite a imporre
situazioni in famiglia, sul lavoro e nella società che sempre più consentono loro di
conciliare i (più ridotti) impegni familiari con un’attività a tempo pieno. La maggiore
partecipazione al lavoro delle donne si deve anche al crescente livello di istruzione delle
nuove generazioni, poiché in ogni paese europeo le donne più istruite sono più inserite
nel mercato del lavoro, vuoi perché vogliono far rendere il loro più alto capitale umano,
vuoi perché sono più emancipate dai valori familisti, vuoi perché sono più coinvolte in
lavori più gratificanti. Solo nei paesi europei a più alta occupazione femminile non vi
sono quasi differenze secondo i livelli di istruzione, mentre negli altri la minore
partecipazione al lavoro si deve alle donne meno istruite, che restano ancora largamente
escluse dal lavoro extra-familiare.
Perciò, l’offerta di lavoro femminile è più istruita di quella maschile, soprattutto
nei paesi europei in cui la partecipazione al lavoro delle donne è minore. In questi paesi
le donne sopportano rischi di disoccupazione molto più alti dei maschi, mentre ove la
presenza femminile nel mercato del lavoro si è consolidata e un’esplicita penalizzazione
non sarebbe socialmente tollerata, i tassi di disoccupazione delle donne sono di poco
superiori o addirittura inferiori a quelli dei maschi. Tuttavia, nei paesi all’avanguardia
per l’occupazione femminile (Svezia, Danimarca, Finlandia) le donne soffrono una
maggiore segregazione occupazionale rispetto a quelli più bassa occupazione femminile
(Grecia e Italia). Nella società dei servizi la presenza delle donne nel mercato del lavoro
sembra caratterizzata da un contrappasso tra occupazione e segregazione orizzontale,
che, peraltro, è in aumento ovunque. Infatti, l’espansione dell’occupazione femminile
avviene per lo più grazie a una crescente domanda per attività considerate tipicamente
femminili: insegnanti, infermiere, cameriere, commesse, impiegate. Ne consegue una
crescente concentrazione delle donne in occupazioni ove sono dominanti, senza che sia
seriamente intaccata la loro quasi esclusione da quelle «maschili».
Quanto alla segregazione verticale, le donne sono molto sovra-rappresentate tra
gli impiegati esecutivi, gli addetti ai servizi e alla vendita, e anche tra le occupazioni
elementari (ma molto meno di quanto accada nel modello americano); per contro sono
molto sottorappresentate in tutte le attività manuali legate alla produzione industriale e,
sia pure in misura minore, nel livello più alto del lavoro intellettuale, quello direttivo. Ai
livelli medio-alti delle attività intellettuali (quelli del lavoro professionale e tecnico) la
presenza delle donne è di poco superiore alla media nazionale. Tuttavia, considerando il
loro maggior livello di istruzione, le donne risultano fortemente penalizzate: laureate e
diplomate raggiungono le posizioni più qualificate nell’area del lavoro non manuale
molto meno frequentemente dei maschi con lo stesso titolo di studio. Inoltre, le donne
con un ruolo di supervisione, pur in aumento, non raggiungono il 25%. Il soffitto di
cristallo» caratterizza tutti i paesi dell’Europa occidentale senza serie differenze e senza
recenti mutamenti: ciò significa che anche una maggiore presenza femminile non riesce
a infrangerlo. Solo nei paesi dell’Europa orientale le donne istruite sembrano un poco
meno penalizzate per l’accesso alle posizione lavorative più elevate. Invece, in tutti i
paesi europei le donne sono molto meno penalizzate quanto alla stabilità occupazionale,
perché, se sono più spesso occupate a tempo determinato, sono anche più inserite nel
settore pubblico, ove le garanzie di stabilità sono molto maggiori che in quello privato,
sia pur con qualche eccezione (Gran Bretagna e Danimarca).
6
4. Flessibilità produttiva, fine del lavoro standard ed esplosione della precarietà?
Contrariamente all’enfasi italiana sulle piccole imprese, in Europa il processo di
deindustrializzazione e l’avvento della società dei servizi hanno segnato non tanto il
declino delle grandi organizzazioni, che si sono diffuse nel terziario pubblico e privato
(sino a raggiungere anche dimensioni multinazionali), quanto l’esaurimento del modello
su cui si era a lungo fondata l’industria manifatturiera, cioè la divisione del lavoro in
mansioni ripetitive e la produzione in serie di beni standard destinati a soddisfare un
consumo stabile e orientato al prezzo. La crescente concorrenza internazionale da parte
dei paesi emergenti a basso costo del lavoro, ma soprattutto il maggior potere di
acquisto e la crescente sofisticazione del gusto dei consumatori hanno imposto non solo
di puntare sulla qualità dei prodotti, ma anche di accelerarne il ritmo di innovazione e di
ampliarne la differenziazione per cogliere le diverse nicchie di mercato con strategie che
mirano a personalizzare il bene o il servizio. Al posto delle economie di scala si sono
affermati i principi dell’economia dell’appropriatezza, secondo i quali, più che ridurre i
costi di produzione, è importante produrre i beni e i servizi «appropriati» nel tempo e
nel luogo in cui sono richiesti dal mercato (Butera 1987). L’enorme sviluppo delle
tecnologie informatiche e la disponibilità di una forza lavoro più istruita hanno molto
contribuito ad affrontare mercati sempre più sofisticati e instabili, ma l’imperativo dei
nuovi assetti produttivi è diventato la flessibilità, intesa come capacità di un’impresa di
rispondere prontamente agli impulsi dei mercati, quando non addirittura di anticiparli.
Ciò comporta un uso flessibile delle risorse umane da parte delle imprese private
e delle organizzazioni pubbliche, ma la flessibilità del lavoro può essere perseguita in
modi diversi. A parte la possibilità di variare le retribuzioni e gli orari di lavoro, si può
far fronte all’incertezza ricorrendo alla flessibilità numerica oppure a quella funzionale.
La flessibilità numerica, che riguarda i gradi di libertà con cui un’impresa può adeguare
volume e caratteristiche professionali dell’occupazione all’andamento della produzione,
interessa tre aspetti: le norme che regolano licenziamenti e assunzioni, la possibilità di
ricorrere a rapporti di lavoro non a tempo indeterminato e quella di affidare fasi o
funzioni del ciclo produttivo in subappalto ad altre imprese o con contratti d’opera a
collaboratori. La flessibilità funzionale, che concerne invece la possibilità di spostare i
lavoratori da un posto all’altro all’interno dell’impresa o di variarne il contenuto della
prestazione, non richiede soltanto assenza di vincoli, ma anche un’elevata polivalenza
professionale e la disponibilità dei lavoratori ad accettare processi di riqualificazione,
condizioni che presuppongono un saldo attaccamento e un elevato coinvolgimento nei
fini produttivi dell’organizzazione; ma per avere dei dipendenti fedeli e motivati occorre
garantire loro un’occupazione stabile. Quindi i due tipi di flessibilità tendono ad avere
conseguenze opposte sulla struttura dell’occupazione.
La prima conseguenza dei processi di esternalizzazione e destrutturazione delle
attività produttive dovrebbe essere la forte crescita delle piccole imprese e del lavoro in
proprio. Tuttavia, la «fuga dal diritto del lavoro», inteso ovviamente come dipendente, è
stata molto meno irresistibile di quanto si creda. Infatti, interrottosi a metà anni Settanta
il lungo processo di salarizzazione, negli anni Ottanta la percentuale di occupazione
indipendente risale nettamente nell’Europa occidentale, soprattutto nei paesi in cui era
scesa sotto il 10%, ma poi ovunque si stabilizza o addirittura si riduce, sicché all’inizio
del XXI secolo è di poco superiore al 16%, tre punti percentuali meno di venti anni
prima. Le differenze nazionali tendono a ridursi, ma restano forti (da poco più del 7% di
Francia e Danimarca a oltre il 26% di Italia e Grecia) e si spiegano principalmente con i
7
diversi livelli di capitale sociale familiare che la piccola borghesia trasmette da una
generazione all’altra (Arum, Müller 2004). Se tralasciamo l’Europa orientale, ove una
percentuale di lavoro indipendente oltre il 20% è frutto della traumatica transizione
all’economia di mercato, non siamo di fronte a una crisi della società salariale per
l’esplosione di micro-imprenditori e lavoratori in proprio.
Tuttavia l’occupazione indipendente, se non è cresciuta, è profondamente mutata
nella sua composizione. Al declino dell’artigianato e soprattutto del piccolo commercio,
largamente sostituito dalla grande distribuzione, si è contrapposta la crescita delle
attività professionali. Nella società dei servizi è aumentata la domanda di prestazioni
richieste alle libere professioni (tradizionali o nuove, in forma individuale o associata)
da parte sia delle imprese sia delle famiglie, come rivela anche il forte aumento tra gli
indipendenti dei laureati. Tra quelli giuridicamente e statisticamente classificati come
indipendenti sono aumentati anche lavoratori che non hanno una vasta clientela, ma un
rapporto di collaborazione con uno o pochissimi committenti. La figura del lavoratore
parasubordinato o dependent self-employed è stata codificata solo in pochi paesi europei
(Italia, Austria, Grecia e Portogallo), ma la sua diffusione di fatto è stata rilevata anche
in parecchi altri, sicché si è stimato che possano costituire l’1% dell’occupazione totale
(Pedersini 2005). Per l’Italia si giunge al 5% includendo i falsi lavoratori indipendenti
in quanto pienamente inseriti nell’organizzazione del committente. Le più interessate
sono le attività tradizionalmente coinvolte nel sub-appalto, ma anche quelle colpite dai
processi di esternalizzazione e quelle, in forte crescita, ove è diffuso il lavoro freelance.
Prevalgono le mansioni intellettuali e tecniche, anche se non mancano quelle manuali
qualificate.
Pur numericamente esigua, la figura del lavoratore parasubordinato, comparsa
anche negli Stati Uniti a metà anni Novanta, rappresenta un caso estremo di instabilità e
flessibilità del lavoro. Anche nell’occupazione indipendente sono cresciute le situazioni
lavorative di breve durata (Arum, Müller 2004), perché, mentre per i veri indipendenti il
lavoro si interrompe raramente (perché alle riduzioni di attività si fa fronte riducendo i
guadagni), per i dependent self-employed i contratti hanno una scadenza e i periodi di
disoccupazione sono frequenti. Stipulando un mero contratto d’opera, l’impresa scarica
tutti i rischi economici sul lavoratore, mentre si difende dal rischio di comportamenti
opportunistici contando sulle reti di relazioni che i collaboratori usano per cercare nuove
commesse: infatti, chi non adempiesse con zelo alle proprie prestazioni, quasi sempre
qualificate, perderebbe reputazione e sarebbe escluso da queste reti. Le organizzazioni
riescono così a godere dei vantaggi dell’esternalizzazione senza rischiare di sopportarne
i costi.
Il lavoro dipendente, se non si riduce, ma anzi esporta alcune sue caratteristiche
al lavoro giuridicamente indipendente (gran parte dei collaboratori rispettano istruzioni,
luoghi e orari di lavoro dettati dal committente), tuttavia vede affievolirsi la sua maggior
conquista nell’«età dell’oro»: la protezione normativa del contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Infatti, dalla fine degli anni Ottanta in tutti i paesi europei la legislazione
per la protezione dell’occupazione diventa meno rigida, poiché vengono ridotti i vincoli
e i costi che le imprese devono sostenere per liberarsi dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato e sono ampliate le possibilità di far ricorso a rapporti di lavoro a termine,
anche attraverso le agenzie di somministrazione di lavoratori interinali, che negli anni
Novanta sono riconosciute ovunque (Oecd 2004). Nei paesi europei ove la protezione
dei lavoratori aveva raggiunto livelli più alti questa tendenza è più accentuata e interessa
la riduzione dei vincoli più per il lavoro a termine che per quello a tempo indeterminato.
8
Questa «deregolazione al margine» ha contribuito a segmentare il mercato del lavoro tra
insider, adulti occupati a tempo indeterminato che conservano le tradizionali protezioni,
e outsider, giovani che alternano disoccupazione e lavori temporanei.
La riduzione dei vincoli ha indubbiamente contribuito all’aumento del lavoro a
termine, anche se la sua diffusione era cominciata a fine anni Sessanta ed era proseguita
sino a metà anni Ottanta, suscitando grande preoccupazione nonostante il livello ancora
basso. Poi, dopo qualche anno di stabilità e in qualche paese di riduzione, la diffusione
dei lavoratori temporanei ha ripreso a crescere, sia pur con un leggero calo all’inizio del
XXI secolo. Considerando i 12 paesi dell’Europa occidentale per cui sono disponibili i
dati, il 30% dell’occupazione creata negli ultimi venti anni è a termine e la percentuale
di lavoratori temporanei sull’occupazione alle dipendenze è cresciuta dal 9% a quasi il
15%, ma con notevoli differenze nazionali. Da un lato, nei paesi in cui l’occupazione a
tempo indeterminato è poco o nulla protetta contro il licenziamento (Danimarca, Gran
Bretagna e Irlanda) il lavoro a termine resta poco diffuso (non oltre il 5-6%); dall’altro,
in Spagna, dopo il boom della seconda metà degli anni Ottanta a eseguito del processo
di liberalizzazione del mercato del lavoro, la percentuale di lavoro a termine è rimasta
stabile intorno al 33%. Quindi, sono i paesi dell’Europa continentale e l’Italia ad aver
segnato la crescita dei lavoratori a tempo determinato, che peraltro costituiscono una
categoria eterogenea e interessano essenzialmente i giovani.
Tra i lavoratori a termine vi sono quelli assunti a scopo formativo, che in paesi
come la Germania raggiungono percentuali molto elevate, e gli stagionali, numerosi
soprattutto in paesi come l’Italia ove sono importanti le attività agricole e turistiche. In
entrambi i casi sono posizioni lavorative che hanno poco a che fare con le esigenze di
flessibilità delle imprese. D’altro canto, sono comprese anche situazioni che per la loro
anomalia hanno attirato l’attenzione al di là della loro diffusione: il lavoro a chiamata, il
lavoro interinale, lo staff leasing. Il «contratto a zero-ore» o job on call prevede che il
lavoratore sia disponibile a svolgere una prestazione saltuaria solo quando sia richiesta
dal datore di lavoro. Lo staff leasing o appalto di manodopera prevede che gruppi di
lavoratori siano assunti da agenzie e inviati a svolgere funzioni pienamente integrate
nell’organizzazione dell’impresa committente anche senza alcuna scadenza, mentre i
lavoratori interinali sono assunti a termine dalle agenzie e sono poi inviati in missione
per qualche giorno o qualche mese presso imprese che li utilizzano come fossero propri
dipendenti. Staff leasing e lavoro interinale costituiscono il caso più flessibile di lavoro
atipico, poiché comportano una dissociazione tra datore di lavoro e organizzazione che
utilizza il lavoratore. Il lavoro tramite agenzia, introdotto in Gran Bretagna, Olanda e
Francia già negli anni Ottanta, si è diffuso negli altri paesi dell’Europa occidentale solo
negli anni Novanta e in quelli dell’Europa orientale nel nuovo secolo. Nonostante la
forte crescita, il suo peso rimane marginale: 1,5% dell’occupazione totale e 14% del
tradizionale lavoro a tempo determinato, a spese del quale è per lo più avvenuta la sua
diffusione. Il fatto che il lavoro interinale sia più diffuso nei paesi europei in cui esiste
da più tempo potrebbe far pensare che sia destinato a crescere ancora, ma un recente
arresto non soltanto ove è più diffuso fa piuttosto supporre una sua saturazione, come,
sia pur su livelli superiori, è accaduto negli Stati Uniti.
La crescita dei lavori instabili non significa che in Europa stia scomparendo
l’occupazione di lungo periodo, come è stato profetizzato da molti studiosi ricorrendo
ad aneddoti e impressioni personali. Se consideriamo il numero di persone con la stessa
occupazione da almeno 10 anni come un indicatore pur imperfetto della diffusione del
lavoro stabile, risulta che per i 12 paesi dell’Europa occidentale per cui sono disponibili
9
i dati dal 1992 al 2002 la loro percentuale sull’occupazione totale addirittura aumenta da
poco meno del 38% a oltre il 40% (Doogan 2005). Nel 2007 la percentuale di occupati
di lungo periodo scende al 39%, ma, benché la forte crescita dell’occupazione totale
avrebbe dovuto accrescere la quota dei lavoratori occupati da poco tempo, rimane oltre
il livello di 15 anni prima, soprattutto perché la partecipazione delle donne al lavoro non
solo aumenta, ma diventa molto più permanente grazie anche alla diffusione del part
time che consente a molte donne poco istruite di restare al lavoro in età adulta e matura.
Persino nei paesi dell’Europa orientale la percentuale di occupati di lunga durata negli
anni Duemila si aggira sul 40%. L’occupazione di lunga durata concerne soprattutto i
lavoratori professionalmente più qualificati, ma anche parecchi settori in espansione
della nuova economia, come i servizi alle imprese, mentre declina in quelli colpiti dalle
politiche pubbliche di privatizzazione e deregolazione.
Poiché la percentuale di occupati di lunga durata in Europa è oltre una volta e
mezza quella degli Stati Uniti, l’esplosione dei contingent workers risulta propria del
modello americano, mentre quello europeo pare più orientato a «tesaurizzare» le risorse
professionali dei lavoratori, anche perché soggetto a regole normative e contrattuali più
rigorose, come dimostrano Gran Bretagna e Irlanda ove la percentuale di occupati di
lunga durata è simile a quella degli Stati Uniti. Se nei paesi anglosassoni si è largamente
affermata la flessibilità numerica, anche al di là dello status giuridico dei lavoratori,
negli altri paesi europei sembra prevalere quella funzionale,che mira al coinvolgimento
dei lavoratori, benché la fase di ingresso al lavoro sia diventata molto più precaria.
Infatti, le imprese e le organizzazioni pubbliche tendono sempre più a usare rapporti di
lavoro instabili, a fini formativi o no, per le assunzioni non solo di giovani, ma anche di
lavoratori adulti, riservandosi di stabilizzarli dopo un periodo molto più lungo di quello
di prova previsto per il lavoro a tempo indeterminato. Un aumento dei lavori di breve
durata per i giovani e i maschi è stato in parte compensato da un aumento dei lavori di
lunga durata per gli adulti e le donne, cosicché si è assestato un nuovo equilibrio tra
lavori instabili e stabili a spese di questi ultimi (Auer 2005) e il problema più serio
diventa quello del rischio di intrappolamento nelle attività precarie, in particolare per i
giovani.
La diffusione del sentimento di insicurezza dell’occupazione va ben oltre quanto
questo scenario farebbe supporre, almeno secondo gli studiosi che hanno enfatizzato la
società del rischio (Beck 2000). Ovviamente la sensazione di insicurezza del lavoro può
dipendere dal generale sentimento di insicurezza che pervade la società contemporanea
molto più di quella del recente passato (ma se il confronto fosse con quella pre-moderna
il giudizio dovrebbe essere ben diverso). Tuttavia, dai tentativi di stimare la percezione
dell’insicurezza del lavoro emerge un quadro più articolato. Innanzi tutto, il sentimento
di insicurezza del lavoro dal 1985 al 1997 cresce in tutti i paesi europei e in particolare
in Italia e Francia (Oecd 1997, 2003), ma dal 1995 al 2005 diminuisce o rimane stabile
in tutti i paesi europei, compresi quelli orientali, con l’eccezione dell’Italia ove aumenta
ancora (Maurin, Postel-Vinay 2005; Paugam, Zhou 2007). Esiste una evidente relazione
con il livello della disoccupazione che nell’Europa a 15 è cresciuto da metà anni Ottanta
sino al 1994-1996 e poi è diminuito sino al 2007, mentre non ve ne è alcuna con la
diffusione del lavoro temporaneo (Fevre 2007). D’altronde, il sentimento di insicurezza
è più diffuso non nei paesi ove la regolazione della protezione del lavoro dipendente è
meno rigida o l’occupazione più instabile, ma in quelli ove la disoccupazione è minore e
la spesa per le politiche del lavoro maggiore (Erlinghagen 2008). La Danimarca è il
paese della flexicurity, perché diffuso sentimento di sicurezza dell’occupazione e bassa
10
disoccupazione si accompagnano a una regolazione dell’occupazione molto flessibile e
a una grande mobilità del lavoro, grazie a politiche del lavoro molto costose. A livello
individuale l’insicurezza del lavoro è maggiore, oltre che ovviamente per gli occupati
temporanei, per chi ha vissuto periodi di disoccupazione, per le donne e per i lavoratori
poco istruiti e poco qualificati. La relazione tra bassa sicurezza e scarsa qualità del
lavoro, forte soprattutto nell’Europa continentale e meridionale, rischia di polarizzare
l’occupazione tra un cuore protetto e una periferia gravemente penalizzata.
5. Crescita o polarizzazione della qualità del lavoro?
Alla terziarizzazione settoriale se ne accompagna una professionale, nel senso che si
riduce il lavoro manuale, perché in gran parte dei servizi prevalgono mansioni non
manuali e anche nell’industria gli operai diminuiscono a favore di impiegati e tecnici.
Nell’Europa occidentale i lavoratori manuali, che a fine anni Settanta superavano ancora
la metà dell’occupazione, nel 2007 ne costituiscono appena un terzo e si concentrano
nelle costruzioni, nelle piccole fabbriche e soprattutto nei servizi alle persone (dalla
custodia alla sicurezza, dai trasporti alla manutenzione domestica, dalla cura della
persona all’assistenza, dalla preparazione e offerta di cibi alla pulizia). Una figura nuova
compare nel mercato del lavoro: quella dell’operaio dei servizi. Rispetto alla condizione
dell’operaio industriale poco qualificato numerose sono le consonanze, ma anche le
differenze. In entrambi i casi la prestazione richiesta è semplice e non richiede abilità
nel leggere, scrivere e far di conto, né sapere tecnico specifico. Invece alla manualità
non si accompagna per gli operai dei servizi uno sforzo fisico altrettanto intenso, ma
piuttosto la capacità di resistere ad orari e condizioni di lavoro disagiati: turni asociali,
ambienti isolati o esposti a intemperie, rapporti servili, ecc. Tuttavia, anche se il loro
status è all’ultimo posto nella valutazione sociale delle occupazioni, i bad jobs dei
servizi richiedono una delle competenze trasversali richieste ai professionisti: la piena e
intelligente dedizione alle funzioni svolte, per pesanti, noiose e sporche che siano.
Ma il più rilevante mutamento nella struttura dell’occupazione è frutto della
diffusione della «società della conoscenza»: secondo le stime di Aoyama e Castells
(2002), nei paesi europei i lavoratori che trattano informazioni, che negli anni Settanta
costituivano solo da un quarto a un terzo dell’occupazione, all’inizio del nuovo secolo
sfiorano la metà, un livello non inferiore a quello degli Stati Uniti. Poiché le nuove
tecnologie informatiche hanno un impatto molto positivo sulla qualificazione del lavoro,
sono in forte crescita dirigenti e lavoratori professionali e tecnici, che nell’EU12 già
all’inizio degli anni Novanta superavano un terzo dell’occupazione e nel 2007 sfiorano
il 40%, mentre, oltre agli operai specializzati e semi-qualificati, diminuiscono gli
impiegati addetti a mansioni semplici. I paesi dell’Europa orientale seguono un percorso
simile, benché su livelli più arretrati. Sembra, dunque, che in Europa vi sia una tendenza
all’innalzamento professionale della struttura dell’occupazione, contrariamente agli
Stati Uniti, ove la grande crescita dei lavoratori più qualificati è stata in parte bilanciata
da una minore espansione di quelli meno qualificati, alimentata dall’ampia disponibilità
di forza lavoro immigrata, sicché si è avuta una polarizzazione asimmetrica (Wright,
Dwyer 2003). Tuttavia, negli anni Duemila anche nell’Europa occidentale è aumentata
la percentuale dei lavoratori addetti a occupazioni elementari, grazie anche alle nuove
immigrazioni, e la distanza dal modello americano si è ridotta. Poiché una tendenza alla
polarizzazione caratterizzava la Gran Bretagna anche prima, si conferma che questa
tendenza è propria delle economie di mercato liberali, mentre in quelle in cui lo stato
11
esercita un maggiore ruolo nel mercato del lavoro l’espansione del lavoro dequalificato
nei servizi è minore, almeno finché tale ruolo non entra in crisi e si afferma un regime di
occupazione dualistico (Gallie 2007b).
Le differenze nazionali sono, però, notevoli. In Gran Bretagna, Svezia e Olanda
è altissima la proporzione delle professioni intellettuali ed è elevata anche quella delle
attività non manuali non qualificate, mentre è molto bassa la presenza delle occupazioni
manuali, persino di quelle specializzate. Al contrario, in Spagna, Portogallo e nei paesi
dell’Europa orientale all’elevata percentuale delle occupazioni manuali, soprattutto non
qualificate, si contrappongono basse percentuali di quelle non manuali. Tra questi
estremi stanno Italia e Germania, che presentano percentuali delle categorie di lavoro
manuale simili, mentre è diversa la ripartizione dell’occupazione non manuale: in
Germania prevalgono le professioni intellettuali, in Italia quelle poco qualificate. In
posizione intermedia vi sono anche Francia e Irlanda, mentre Finlandia e Danimarca
sono più vicine all’Europa centro-settentrionale per l’elevata presenza di professioni
intellettuali, e la Grecia è più vicina agli altri paesi dell’Europa meridionale per l’alta
percentuale di occupazioni manuali specializzate. Queste differenze nella struttura
dell’occupazione riflettono quelle nell’organizzazione del lavoro (Gallie 2007b). Infatti,
nei paesi scandinavi, in Gran Bretagna, Olanda e Francia prevalgono forme avanzate di
organizzazione, fondate sull’apprendimento, la soluzione dei problemi, elevati livelli di
autonomia e di lavoro di gruppo, mentre le forme tradizionali sono ancora le più diffuse
nei paesi mediterranei e nella maggior parte di quelli orientali (ma sempre meno) e
conservano un ruolo importante in Germania a causa delle regioni orientali (Valeyre et
al. 2008).
Le più importanti innovazioni nei processi organizzativi sono avvenute tra metà
anni Ottanta e metà anni Novanta, poi, secondo le indagini sulle condizioni di lavoro,
sono proseguite solo nell’Europa orientale, mentre in quella occidentale si sono arrestate
e il grado di complessità del lavoro è diminuito dal 1995 al 2000, mentre è aumentato
quello di intensità, perché il ritmo di lavoro è sempre più dipendente dalle richieste di
clienti e committenti (European Commission 2007). Poiché, invece, è proseguita la
tendenza all’aumento delle professioni qualificate, va crescendo lo sfasamento tra i
requisiti, per cui competenze più elevate sono richieste per affrontare compiti anche
meno complessi, ma da svolgere «sotto pressione». A un maggior livello di autonomia e
responsabilità si accompagna un più penetrante controllo sui risultati e sul rispetto delle
scadenze, che implica un aumento dello stress e del senso di mancanza di controllo sulla
propria vita lavorativa (Edwards 2005) e un maggior impegno di tempo, anche fuori
dell’orario di lavoro formale, per cui sono sempre più i lavoratori della conoscenza che
non «staccano» mai dalle reti sociali e virtuali in cui sono inseriti (Barbieri et al. 2007).
Tuttavia, le imprese possono aumentare il livello di qualificazione oltre le competenze
richieste nel tentativo di procurarsi i lavoratori migliori o semplicemente perché è
aumentata l’offerta di forza lavoro istruita. La sovra-qualificazione, cioè lo sfasamento,
oggettivo o percepito, tra livello di istruzione o conoscenze possedute e categoria di
inquadramento o competenze richieste, è diffusa in tutti i paesi europei, sia pur in
diversa misura (Brynin 2002). I più colpiti sono i giovani, soprattutto quelli con lavori
temporanei, e il fenomeno si sta accentuando in quasi tutti i paesi europei (Quintini,
Martin 2006).
Come per i mutamenti nella struttura dell’occupazione per livelli professionali,
anche per quelli nella distribuzione dei redditi quasi tutti i paesi europei presentano una
minore tendenza all’aumento delle diseguaglianze rispetto agli Stati Uniti. Dopo che a
12
metà anni Settanta la quota dei salari sul reddito aveva raggiunto il suo massimo e le
differenze retributive il loro minimo, entrambe le tendenze si invertono nettamente
(Oecd 2007): le diseguaglianze nei redditi, infatti, aumentano in quanto la quota dei
salari si riduce maggiormente nei settori ove prevalgono i lavoratori poco qualificati. La
causa principale è la globalizzazione, perché sia l’aumento degli investimenti nei paesi
meno sviluppati e delle importazioni da questi paesi, sia la crescente immigrazione
accelerano la deindustrializzazione, riducono la domanda di lavoratori non qualificati,
rendono la forza lavoro più eterogenea, ne indeboliscono la posizione contrattuale e
modificano la distribuzione del reddito a sfavore del lavoro. La riduzione della quota dei
salari e l’aumento delle loro diseguaglianze si spiega inoltre con fattori istituzionali
quali l’indebolimento dei sindacati, anch’esso dovuto in larga misura all’immigrazione
e alla delocalizzazione degli investimenti (Lee 2005), e la crisi dello stato sociale, che
genera più occasioni di lavoro poco remunerate nei servizi e costringe disoccupati
sempre meno protetti ad accettarle. Ma, poiché l’aumento delle differenze retributive si
deve principalmente all’enorme crescita dei guadagni percepiti dalle superstar del jet set
e della finanza, si deve anche pensare, più che alla necessità di gestire tecnologie e
organizzazioni sempre più sofisticate, a profondi mutamenti nelle norme sociali che
regolano le ricompense (Atkinson 2007).
Nella maggior parte dei paesi europei le differenze retributive sono cresciute
solo moderatamente e sono addirittura diminuite in Francia, nonostante la gravissima
debolezza dei sindacati. Ciò non vuol dire, però, che le diseguaglianze nel mercato del
lavoro non siano aumentate. Infatti, in questi paesi è aumentata la dispersione nel grado
di stabilità dell’occupazione con la diffusione dei rapporti di lavoro a termine e atipici.
Di fronte alle pressioni della globalizzazione volte ad aumentare le diseguaglianze, Stati
Uniti e Gran Bretagna hanno differenziato le retribuzioni, mentre i paesi dell’Europa
continentale hanno invece differenziato lo status dei rapporti di lavoro (Maurin, PostelVinay 2005). Retribuzioni e stabilità del lavoro hanno costituito due sostituti funzionali
per rispondere alle esigenze di flessibilità imposte dai mutamenti economici. Peculiare è
il caso dell’Italia, ove sono cresciute sia le differenze nei redditi, sino a sfiorare l’alto
livello degli Stati Uniti, sia quelle nello status dei rapporti di lavoro, soprattutto per la
gran diffusione dei lavori parasubordinati.
6. Mobilità occupazionale e fluidità sociale
Come nel processo di industrializzazione, anche in quello di terziarizzazione i grandi e
rapidi mutamenti nella struttura dell’occupazione hanno provocato un’elevata mobilità
inter-generazionale. In entrambi i casi da una generazione all’altra diminuì nettamente
la percentuale di coloro che svolgevano lo stesso lavoro del padre. Nel processo di
industrializzazione moltissimi figli di contadini o braccianti diventarono operai e molti
figli di operai ebbero accesso a lavori non manuali. Ciò venne vissuto come promozione
sociale, per dequalificate che fossero le nuove mansioni, poiché il lavoro operaio nella
grande fabbrica assicurava livelli e garanzie di reddito inimmaginabili nelle campagne e
le occupazioni impiegatizie consentivano di soddisfare quelle aspettative di stile di vita
che le maggiori retribuzioni avevano già sollecitato nelle famiglie della nuova classe
operaia. Nel processo di terziarizzazione la promozione sociale fu ancora più evidente,
poiché la grande maggioranza delle nuove occasioni di lavoro nei servizi erano di alto o
buon livello di qualificazione professionale, sicché nuove generazioni sempre più
13
istruite vi trovarono ampie soddisfazioni, sia pure dopo un ingresso nel mercato del
lavoro spesso più difficile.
Secondo una ricerca su 9 paesi dell’Europa occidentale e orientale (Breen 2004),
grazie al forte aumento delle posizioni lavorative più elevate (dirigenti, professionisti,
tecnici), la mobilità ascendente ha interessato più di un quarto delle persone negli anni
Settanta, circa un terzo negli anni Ottanta e poco più negli anni Novanta. Tuttavia, il
netto rallentamento della crescita delle occupazioni più qualificate professionalmente e
socialmente negli anni Duemila fa supporre che la mobilità assoluta ascendente tra le
generazioni si stia riducendo, con il rischio di frustrare le aspettative crescenti dei ceti
medi e popolari per la prima volta dopo mezzo secolo. D’altro canto, le disuguaglianze
di classe si sono solo un poco attenuate, poiché l’associazione tra la professione dei
padri e il destino occupazionale dei figli si è ridotta negli anni Ottanta in parecchi paesi
europei, ma è rimasta stabile negli anni Novanta. Infatti, secondo la stessa ricerca, la
fluidità sociale, che misura le differenti possibilità di accedere a un certo status da parte
di individui di origine sociale diversa, se dagli anni Settanta agli anni Ottanta è cresciuta
in Francia, Svezia, Olanda, Polonia e Ungheria, ma non in Gran Bretagna e Germania,
dagli anni Ottanta agli anni Novanta non presenta segni di mutamento in nessun paese
europeo. Inoltre, non risulta alcuna tendenza alla convergenza, sicché restano forti le
differenze tra i paesi ad alta (Svezia, Polonia, Ungheria) e quelli a bassa (Germania,
Francia, Italia) fluidità sociale.
Solo i paesi social-democratici e quelli del socialismo di stato sono riusciti per
qualche tempo a incrinare le diseguaglianze nella trasmissione delle posizioni sociali da
una generazione all’altra persino in un periodo di forte aumento della mobilità assoluta.
Negli altri paesi, nonostante la forte crescita dell’istruzione superiore, le probabilità di
raggiungere i livelli più alti sono restate strettamente legate all’istruzione dei genitori
(Shavit, Blossfeld 1993; Gabriele, Raitano 2008). Le differenze tra i paesi a regime
social-democratico e quelli liberali o conservatori sono evidenti anche considerando la
trasmissione intergenerazionale dei redditi da lavoro: infatti, in Italia e Gran Bretagna il
50% della differenza relativa nei guadagni dei genitori è trasmesso ai loro figli contro il
15% Danimarca e meno del 20% in Austria, Norvegia e Finlandia (Oecd 2008).
Se la mobilità intergenerazionale ha indubbiamente attenuato i confini di classe e
in particolare quelli che definivano la classe operaia, l’avvento della società dei servizi
ha segnato una grande espansione della classe impiegatizia, tecnica e professionale e la
nascita di due nuovi gruppi sociali. Manager di società multinazionali, funzionari di
agenzie pubbliche, artisti e intellettuali costituiscono un gruppo ormai vasto di persone
che si muovono da un paese all’altro restando all’interno degli stessi modi di vita e
relazioni sociali: sono le superstar della società globale. Ben diverse sono le condizione
di lavoro e di vita dei lavoratori dei servizi, per i quali si è pensato alla nascita di una
underclass. Le loro possibilità di carriera professionale, infatti, sono quasi inesistenti,
poiché vi è una cesura con le posizioni qualificate dei servizi, cui si accede solo grazie
ad un’elevata istruzione formale e non con la permanenza in attività che non consentono
di accumulare esperienze. Tuttavia, le caratteristiche di chi svolge questi lavori (giovani,
donne di mezza età, immigrati) impedirebbero che si formi un ghetto di proletari dei
servizi (Esping-Andersen 1993). Giovani e donne adulte vivono tale condizione come
transitoria per la propria esperienza di vita e chi vi resta intrappolato se ne accorge
troppo tardi, quando ormai si è assuefatto e la capacità di reagire si è affievolita. Quanto
agli immigrati, la condizione di temporaneità e di estraneità è connaturata alla loro
situazione, almeno per la prima generazione. Questa ipotesi, però, contrasta con quanto
14
accade nell’Europa meridionale ove da queste occupazioni in grande espansione non si
esce facilmente (Bernardi, Garrido 2008).
Benché le diseguaglianze sociali non siano scomparse e anzi si riproducano di
generazione in generazione, nella società dei servizi si parla poco di classi e si è diffusa
l’ipotesi che i rischi si distribuiscano su base individuale (Beck 2000). È vero che nei
welfare states più incisivi (ma non in quelli residuali e conservatori) i correlati di classe
si sono attenuati, perché l’intervento pubblico si è assunto il compito di far fronte a gran
parte dei tradizionali rischi dei lavoratori e gli stili di vita sono diventati meno diseguali.
Ma in quasi tutti i paesi europei le differenze retributive sono tornate ad ampliarsi, gli
stati sociali vanno riducendo la loro azione, le appartenenze ascritte restano molto
importanti, come rivela la riscoperta delle relazioni personali e familiari come «capitale
sociale» che si può far fruttare per trovare un buon posto di lavoro (Barbieri 1998), e la
disoccupazione in età adulta continua a essere un’esperienza riservata ai lavoratori
manuali, bloccandone le possibilità di accesso a posizioni più qualificate. Cospicue sono
le evidenze empiriche sulla persistenza dell’importanza delle classi sociali nel modellare
opportunità e vincoli degli individui nel mercato del lavoro anche nell’epoca della
globalizzazione (Mills, Blossfeld, Bernardi 2006), benché siano emerse anche altre linee
di frattura.
7. Le nuove fratture generazionali ed etniche
Alla crescente partecipazione al lavoro delle donne, che sono diventate un soggetto
autonomo con interessi e comportamenti spesso in contrasto con quelli dei maschi, si
sono aggiunte le diseguaglianze fondate sull’età e sulla nazionalità o sulla connotazione
etnica. Giovani e immigrati, di prima o seconda generazione, sono sempre più diventati
i soggetti deboli, sui quali si «scaricano» le criticità e le tensioni del mercato del lavoro
praticamente in tutti i paesi europei, sia pure in modi differenti.
A metà anni Settanta comparve per la prima volta in Europa il fenomeno della
disoccupazione giovanile, che colpì in modo particolarmente acuto Francia e Italia, ma
anche Gran Bretagna e Germania, dove però fu riassorbita molto presto. Contrariamente
alle generazioni nate prima degli anni Sessanta, da allora i giovani incontrano grandi
difficoltà quando entrano nel mercato del lavoro e risultano molto penalizzati rispetto
agli adulti. Dai primi anni Ottanta nell’Unione europea il tasso di disoccupazione dei
giovani (15-24 anni) è sempre poco più del doppio di quello degli adulti (25-49 anni),
benché le nuove generazioni siano sempre meno numerose per il continuo calo della
natalità in quasi tutti i paesi europei. Le differenze nazionali non sono rilevanti, anche se
alla Germania, ove il tasso di disoccupazione dei giovani è di pochissimo superiore a
quello degli adulti, si contrappongono Italia, Grecia e recentemente Gran Bretagna, ove
il tasso di disoccupazione dei giovani è almeno triplo di quello degli adulti. Cercando di
identificare i fattori che spiegano queste differenze si è tentato di spiegare il motivo del
fenomeno. Da sola l’ipotesi che contrappone i giovani outsider agli adulti insider, superprotetti da una legislazione del lavoro eccessivamente rigida, si è rivelata inconsistente,
perché non vi è alcuna relazione tra grado di protezione dell’occupazione e rapporto tra
il tasso di disoccupazione dei giovani e quello degli adulti, come ben illustrano il caso
della Germania (elevata protezione degli occupati e nessuna penalizzazione dei giovani)
e quello della Gran Bretagna (minima protezione e severa penalizzazione dei giovani).
Invece, il ruolo svolto dal grado di protezione dell’occupazione risulta significativo se è
accompagnato da quello svolto dal sistema formativo, per cui i giovani corrono minori
15
rischi di disoccupazione nei paesi, come la Germania, in cui prevale un orientamento
professionale, che fornisce alle imprese precisi segnali sulle abilità e le competenze dei
giovani (Wolbers 2008).
Tuttavia, poiché le differenze nella disoccupazione dei giovani riguardano quasi
soltanto quelli più istruiti e in alcuni paesi, come l’Italia, sono stati soprattutto i giovani
istruiti a veder peggiorata la propria situazione nel corso del tempo, la disoccupazione
giovanile si può spiegare anche con la diversa composizione della domanda di lavoro,
più o meno orientata alle occupazioni più qualificate, e con il crescente sfasamento tra
aspirazioni professionali dei giovani e capacità del sistema economico di soddisfarle.
Inoltre, occorre considerare le differenze nei sistemi di protezione del reddito, poiché i
giovani sono più penalizzati soprattutto nei paesi in cui la protezione del reddito dei
disoccupati da parte dello stato è poco generosa e chi è senza lavoro può contare solo
sull’aiuto della famiglia. In Europa si contrappongono due modelli di disoccupazione.
Quello familista, proprio dei paesi mediterranei, si fonda sulla solidarietà familiare, per
cui i disoccupati sono per lo più giovani che vivono con i genitori anche oltre i 30 anni;
mentre quello assistenziale, rappresentato dai paesi scandinavi, si fonda su un cospicuo
sostegno pubblico, che consente agli adulti di reggere lunghi periodi di disoccupazione
e ai giovani di uscire dalla famiglia di origine anche prima di aver trovato un lavoro. Il
primo modello attribuisce eccessivi compiti alla famiglia, limitando l’autonomia dei
giovani e provocando la caduta della natalità, mentre il secondo comporta un importante
aggravio della spesa pubblica. Ma per i disoccupati e in particolare per quelli giovani la
situazione peggiore è quella dei paesi, come la Gran Bretagna e la Francia, in cui la
solidarietà familiare si è ormai molto indebolita e la spesa pubblica per le politiche del
lavoro è modesta (Gallie, Paugam 2000).
Da metà anni Novanta la disoccupazione giovanile, come quella complessiva, si
riduce, ma nella maggior parte dei paesi europei, quelli in cui si diffondono i rapporti di
lavoro instabili, i giovani sono colpiti da un’altra penalizzazione rispetto agli adulti. In
Germania, Francia, Olanda, Svezia, Finlandia, Portogallo e Italia tra il 1995 e il 2005 la
percentuale di occupati a tempo determinato tra i giovani sino a 25 anni è da 4 a 6 volte
quella degli adulti e in Spagna e Polonia è soltanto doppia perché è altissima anche tra
gli adulti. Sembra quasi una regola in Europa che il primo lavoro dei giovani finiti gli
studi sia instabile. Poiché la percentuale di lavori temporanei diminuisce con il crescere
dell’età, secondo i paesi da un terzo a due terzi dei giovani con un’attività temporanea
riescono a trovare un’occupazione permanente nell’arco di due anni (Oecd 2002), ma
non pochi restano intrappolati in una successione di lavori precari e di disoccupazione:
nel 2005 nella maggior parte dei paesi europei a 27 anni ancora più di un lavoratore su
cinque aveva un’occupazione temporanea e la transizione verso il lavoro permanente se
in alcuni paesi è in via di miglioramento, in altri va peggiorando (Quintini, Martin
2006). In Italia, ove entrano sempre più tardi nel mercato del lavoro, la condizione dei
giovani è ancora peggiore ed è degradata più gravemente da una generazione all’altra: si
è stimato che a 35 anni erano ancora in una situazione instabile poco più del 28% dei
nati negli anni Cinquanta e quasi il 39% dei nati negli anni Sessanta (Barbieri, Scherer
2005). Disoccupazione e precarietà non colpiscono nella stessa misura tutti i giovani. In
quasi tutti i paesi europei i giovani meno istruiti e le giovani donne corrono rischi molto
più elevati sia di essere disoccupati, sia di entrare in una posizione di lavoro instabile e
di non riuscire a uscirne. Più complessa è la situazione dell’Italia, poiché i giovani più
istruiti corrono quasi gli stessi rischi dei meno istruiti sia di restare senza lavoro, sia di
trovare lavori instabili, dalle quali però riescono a uscire più facilmente.
16
Oltre all’incertezza, che rende più difficile compiere scelte cruciali come quella
di avere dei figli, e al maggior rischio di disoccupazione, i lavori instabili penalizzano i
giovani perché, a parità di altre condizioni, sono meno remunerati (in media del 15%) e
in molti paesi consentono un minore accesso a prestazioni accessorie e/o previdenziali
(Oecd 2006). Considerando anche le più rigide regole introdotte dalle riforme avviate
fin dagli anni Novanta, gran parte dei giovani contemporanei sono perciò destinati a
ritirarsi dal lavoro non soltanto in età più avanzata di quanto è accaduto o accadrà ad
almeno due generazioni precedenti, ma anche con pensioni molto meno generose. Alla
segmentazione tra adulti stabilmente occupati e giovani disoccupati o precari, quindi, si
accompagnano forti diseguaglianze intergenerazionali nell’accesso alle pensioni. Se le
generazioni entrate nel mercato del lavoro da metà anni Sessanta a metà anni Ottanta
hanno avuto la fortuna di trovare subito un lavoro stabile e di accedere a una buona
pensione anche prima di 60 anni, quelle entrate successivamente non potranno usufruire
di facili prepensionamenti e rischieranno una vecchiaia povera se il declino demografico
continuerà a depauperare la popolazione in età attiva, quella su cui grava il compito di
mantenere i bambini, ma soprattutto i sempre più numerosi anziani.
Alla frattura generazionale, che non genera conflitti come negli anni Sessanta
probabilmente perché i giovani sono sempre meno numerosi, si aggiunge quella etnica,
che invece rischia di essere foriera di crescenti tensioni e conflitti, perché le persone con
una origine nazionale diversa da quella del paese in cui vivono sono un gruppo sociale
che è ovunque più o meno gravemente penalizzato ed è destinato a crescere ben oltre
l’attuale 8% della forza lavoro nella vecchia Europa a 15. Nei paesi dell’Europa centrosettentrionale la vecchia immigrazione dal dopoguerra sino a metà anni Settanta segnò
una mobilità sociale ascendente per milioni di lavoratori provenienti dalle campagne dei
paesi delle rive del Mediterraneo, anche se furono addetti ai compiti più dequalificati.
Infatti, grazie anche alle procedure di reclutamento messe in atto da alcuni paesi, questi
immigrati erano pochissimo istruiti e avevano avuto ben peggiori esperienze di lavoro e
di disoccupazione. Erano immigrati «a tempo e scopo definiti», cioè con la prospettiva
di guadagnare il più possibile nell’arco di qualche anno per ritornare poi al paese di
origine, ma molti si stabilirono con la famiglia. Da qualche tempo costoro si sono ritirati
dal lavoro, spesso grazie ai programmi di prepensionamento che hanno accompagnato i
processi di deindustrializzazione, e nel mercato del lavoro sono entrati i loro figli e le
loro figlie, nati o comunque cresciuti nel paese di arrivo e quindi con aspirazioni in tutto
simili a quelle dei loro coetanei figli di famiglie nazionali.
I cosiddetti «immigrati di seconda generazione» vivono in una condizione di
esclusione e inferiorità sociale, perché nel mercato del lavoro di tutti i paesi europei di
vecchia immigrazione vi è una chiara stratificazione su base etnica o nazionale (Heath
2007). La situazione migliore è quella di chi è originario di un paese dell’Europa nordoccidentale, poi vengono gli originari di un paese dell’Europa meridionale od orientale,
mentre al livello più basso vi sono gli originari di un paese non europeo. La gerarchia è
simile in tutti i paesi per quanto riguarda sia il rischio di disoccupazione, sia l’accesso
alle occupazioni più qualificate, nonostante qualche peculiarità: ad esempio, quelli con
un’origine italiana in Germania hanno un tasso di disoccupazione doppio di quello dei
tedeschi, mentre quelli con un’origine indiana o cinese hanno tassi di disoccupazione
relativamente bassi. Le disuguaglianze di classe si riproducono attraverso due processi.
Soprattutto i figli degli immigrati reclutati come guestworkers per lavorare come operai
comuni nell’Europa centrale raggiungono livelli di istruzione poco superiori a quelli
molto bassi dei loro genitori. Ma anche coloro che raggiungono livelli elevati riescono
17
ad accedere a posti di lavoro qualificati molto meno dei compagni di scuola di origine
locale. Alla penalizzazione nel sistema educativo si aggiunge una penalizzazione, ancor
più iniqua, nel mercato del lavoro, che si può attribuire alla carenza di quelle relazioni
sociali esterne alla propria comunità che consentono di conoscere le occasioni di lavoro
qualificate, ma anche a orientamenti discriminatori mai scomparsi in Europa neppure
verso i «diversi» più inseriti.
Inoltre, dalla fine degli anni Ottanta nuovi flussi immigratori hanno interessato
tutta l’Europa occidentale e in particolare i paesi, un tempo di emigrazione, dell’Europa
meridionale, che hanno ricevuto ben oltre la metà dei nuovi arrivi, pur costituendo solo
un terzo della popolazione dell’Europa a 15. Nei paesi di vecchia immigrazione i nuovi
arrivati provengono quasi tutti da paesi diversi da quelli dei vecchi, così nel mercato del
lavoro e nella società può nascere una nuova gerarchia secondo il modello americano
delle successive ondate immigratorie; mentre quelli di nuova immigrazione si trovano
ad affrontare un fenomeno sconosciuto senza trovare alcun aiuto nella memoria, ormai
affievolita, dell’esperienza di emigrazione. Oltre a una cospicua presenza di donne che
emigrano da sole per motivi di lavoro, una caratteristica accomuna questi nuovi flussi.
Contrariamente al passato, la presenza di persone con livelli di istruzione medio-alti è
cospicua per tre motivi: l’istruzione superiore è diffusa nell’Europa Orientale, da cui
molti provengono, ed è notevolmente cresciuta in parecchi paesi del Terzo Mondo,
inoltre un’emigrazione spontanea in un contesto in cui le frontiere dei paesi di arrivo
sono formalmente quasi del tutto chiuse comporta una forte selezione positiva, poiché
occorrono buone risorse umane, cognitive ed economiche per riuscire ad aggirare tutti
gli ostacoli.
Tuttavia, il più alto livello di istruzione e la maggiore intraprendenza dei nuovi
immigrati non assicura loro un migliore inserimento nel mercato del lavoro rispetto ai
vecchi, sia pure con significative differenze. Nell’Europa centro-settentrionale i nuovi
immigrati sono molto penalizzati per il tasso di disoccupazione, che è oltre il doppio di
quello dei nativi, mentre sono relativamente poco penalizzati rispetto ai nativi con le
stesse caratteristiche personali per l’accesso alle occupazioni qualificate. Al contrario, in
Italia e Spagna gli immigrati hanno tassi di disoccupazione poco superiori a quelli dei
nativi, mentre la loro penalizzazione quanto all’accesso ai lavori qualificati è enorme:
pochi laureati e pochissimi diplomati svolgono mansioni non manuali anche dopo alcuni
anni di presenza (Reyneri, Fullin 2008). Se nel primo caso si può parlare di brain drain,
in questo caso dobbiamo parlare di brain waste, benché occorra tener presenti tutti gli
ostacoli oggettivi che rendono molti difficile la trasferibilità delle competenze da un
paese all’altro (dalla conoscenza delle lingua alla certificazione dei titoli di studio, alla
natura stessa delle competenze). Questo esito contrapposto può essere spiegato con la
diversa combinazione tra status degli immigrati e caratteristiche del welfare state. Nei
paesi dell’Europa centro-settentrionale una larga percentuale di immigrati è costituita da
richiedenti asilo, che ricevono adeguati sostegni di reddito e possono vivere anche senza
lavorare in attesa di un lavoro adeguato alle proprie competenze; per contro nei paesi
dell’Europa meridionale la stragrande maggioranza degli immigrati è entrata senza un
appropriato permesso di soggiorno, ottenuto poi grazie alle numerose regolarizzazioni, e
non ha altra alternativa che lavorare anche nelle mansioni meno qualificate, perché non
può usufruire del sostegno familiare come per i disoccupati nativi. Ma occorre tener
conto anche della diversa composizione della domanda di lavoro. Nei paesi dell’Europa
centro-settentrionale prevale una domanda orientata verso occupazioni molto qualificate
cui gli immigrati istruiti possono accedere solo dopo un periodo di apprendimento della
18
lingua e di altri aspetti specifici, mentre nei paesi dell’Europea meridionale prevale una
domanda orientata verso mansioni elementari o poco qualificate, cui tutti gli immigrati
possono accedere immediatamente.
Anche se diverse sono le modalità, importanti linee di frattura su base etnica si
aggiungono alle diseguaglianze di condizione di lavoro, di genere e di generazione che
hanno origine nel mercato del lavoro. Secondo un tradizionale approccio pluralista si
potrebbe dire che proprio il non sovrapporsi, ma l’incrociarsi di queste fratture fanno sì
che i conflitti sociali restino a bassa intensità e non si sommino. Ma ci si può chiedere
quale ruolo abbia avuto anche la lunga crescita economica, interrottasi soltanto per brevi
periodi, e cosa potrà accadere se la crisi economica iniziata con quella finanziaria nel
2008 sarà lunga e grave.
19
Aoyama Y., Castells M. (2002), An empirical assessment of the informational society:
Employment and occupational structures of G-7 countries, 1920-2000, in
«International Labour Review», n. 1-2.
Arum R., Müller W. (2004), The Re-emergence of Self-employment: Comparative
Findings and Empirical Propositions, in W. Müller, R. Arum (a cura di), Selfemployment Dynamics and Social Inequality: a Cross-national Study of Selfemployment in Advanced Economies, Princeton University Press, Princeton.
Atkinson A. B. (2007), The distribution of earnings in Oecd countries, in «International
Labour Review», n. 1-2.
Auer P. (2005), Protected mobility for employment and decent work: Labour market
security in a globalised world, Employment Strategy Papers, International Labour
Office, n. 1
Barbieri P. (1998), Regolazione istituzionale e redistribuzione dello stigma. Stato,
mercato e reti sociali nei sociali nei processi di avviamento al lavoro come fattore di
esclusione sociale, in «Rassegna italiana di sociologia», n. 2.
Barbieri P., Scherer S. (2005), Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del
mercato del lavoro in Italia, in «Stato e mercato», n. 74, agosto.
Barbieri P. et al. (2007), I confini del tempo di lavoro, in Istat, I tempi della vita
quotidiana, Argomenti, n. 32, Roma.
Beck U. (2000), La società del rischio, Carocci, Roma.
Bernardi F., Garrido L. (2008), Is There a New Service Proletariat? Post-industrial
Employment Growth and Social Inequality in Spain, in «European Sociological
Review», n. 3.
Breen R. (2004) (a cura di), Social Mobility in Europe, Oxford University Press,
Oxford.
Brynin M. (2002), Overqualification in employment, in «Work, Employment and
Society», n. 4.
Butera F. (1987), Dalle occupazioni industriali alle nuove professioni, Angeli, Milano.
Crouch C. (2001), Sociologia dell’Europa occidentale, Il Mulino, Bologna.
Doogan K. (2005), Long term Employment and the Restructuring of the Labour Market
in Europe, in «Time and Society», n. 1.
Edwards P. (2005), The puzzle of work: insecurity and stress and autonomy and
commitment, in A. Heath, J. Ermisch, D. Gallie (a cura di), Understanding social
change, Oxford University Press, Oxford.
Erlinghagen M. (2008), Self-Perceived Job Insecurity and Social Context: A Multi-Level
Analysis of 17 European Countries, in «European Sociological Review», n. 2,
Esping-Andersen G. (1991), Strutture di classe post-industriali: un confronto tra
Germania, Svezia e Stati Uniti, in «Stato e mercato», 32, agosto.
Esping-Andersen G. (1993), Occupazioni o classi sociali: esiste un proletariato
postindustriale?, in «Polis», n. 3,
Esping-Andersen G. (2000),
European Commission (2007), Employment in Europe 2007, Brussels.
Fevre R. (2007), Employment insecurity and social theory: the power of nightmares, in
«Work, Employment and Society», n. 3.
Gabriele S., Raitano M. (2008), La trasmissione intergenerazionale dei titoli di studio
nell’Unione Europea, in «La rivista delle politiche sociali», n.2.
Gallie D. (2007a) (a cura di), Employment Regimes and the Quality of Jobs, Oxford
University Press, Oxford.
20
Gallie D. (2007b), Production Regimes, Employment Regimes, and the Quality of Work,
in Gallie (2007a).
Gallie D., Paugam S. (2000) (a cura di), Welfare Regimes and the Experience of
Unemployment in Europe, Oxford University Press, Oxford.
Heath A. (2007) Cross-national patterns and processes of ethnic disadvantage, in A.
Heath, S.-Y. Cheung (a cura di), Unequal Chances. Ethnic Minorities in Western
Labour Markets, Oxford University Press, Oxford.
Lee C.-S. (2005), International Migration, Deindustrialization and Union Decline in 16
Affluent Oecd countries, 1962-1997, in «Social Forces», September.
Maurin E., Postel-Vinay F. (2005), The European Job Security Gap, in «Work and
Occupations», n. 2, May.
Mills M., Blossfeld H.P., Bernardi F. (2006) (a cura di), Globalization, Uncertainty and
Men’s Careers. An International Comparison, Edward Elgar, Cheltenham.
Oecd (1997-2008), Employment outlook, Paris.
Paugam, S., Zhou Y. (2007), Job Insecurity, in Gallie (2007a).
Pedersini R. (2005), Economically dependent workers', employment law and industrial
relations, in European industrial relations observatory [http://www.eurofound.
europa.eu/eiro/index.htm].
Quintini G., Martin S. (2006), Starting well or losing their way? The position of youth
in the labour market in Oecd countries, Employment and Migration Working Papers,
Oecd, Paris.
Reyneri E. (2000), Il mercato del lavoro e la struttura dell’occupazione, in V.
Castronuovo (a cura di), Storia dell’economia mondiale, vol. V: La modernizzazione
e i problemi del sottosviluppo (1945-1980), Laterza, Roma-Bari.
Reyneri E., Fullin G. (2008), New Immigration and labour markets in western Europe:
a trade-off between unemployment and job quality?, in «Transfer», n. 4.
Shavit Y., Blossfeld H.P. (1993) (a cura di), Persistent Inequality: Changing
Educational Stratification in Thirteen Countries, Westview Press, Boulder, CO.
Therborn G. (1995), European modernity and beyond. The trajectory of the European
societies, Sage, London.
Valeyre et al. (2008), Work Organization in Europe, European Foundation of the
Improvement of Living and Work, Dublin.
Wolbers M. H. J. (2007), Patterns of Labour Market Entry: A Comparative Perspective
on School-to-Work Transitions in 11 European Countries, in «Acta Sociologica»,
settembre.
Wright E. O., Dwyer R. E. (2003), The patterns of job expansion in the USA: a
comparison of the 1960s and 1990s, in «Socio-Economic Review», n. 1.
21