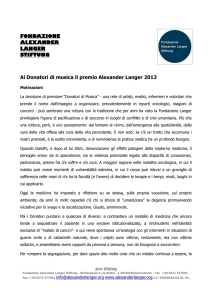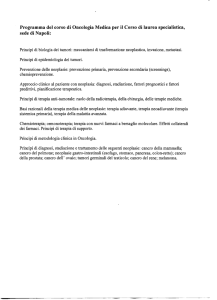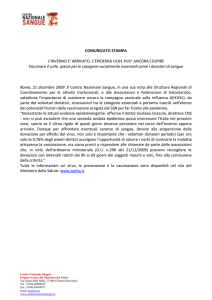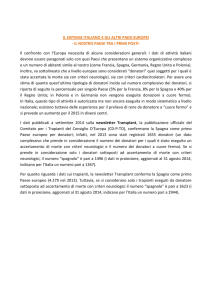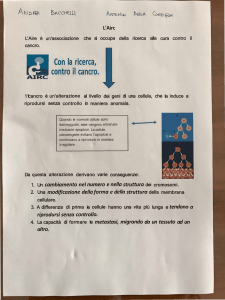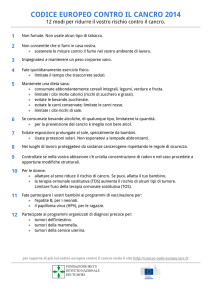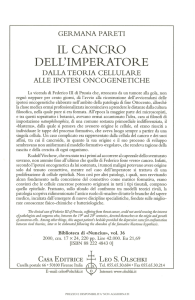L’arte del prendersi cura
...perché la Grande Musica divenga sempre più uno Strumento
di importante aiuto alle cure mediche in ogni reparto di oncologia…
Gian Andrea Lodovici
Quaderno della Fondazione Alexander Langer Stiftung
nr. 2 - dicembre 2013
Il premio di questo 2013 ai Donatori di
Musica ci è parso inizialmente di un segno
diverso rispetto alle problematiche più
Perché le note fanno bene alla vita
politiche, di prevenzione dei conflitti, di
(di Marina Sereni)
2
dialogo e convivenza tra popoli dei premi
La buona politica di Alexander Langer
precedenti. Un premio che sembrava par(di Laura Boldrini)
3
lare più alla nostra interiorità, alla necesL’arte del prendersi cura
sità di trasformare il nostro quotidiano e
(di E. Nicolodi, F. Levi e A. Bravo)
4
i nostri stili di vita. L’abbiamo chiamata
Tutti i giorni dopo “l’arte del prendesi cura”, la ricerca che
(di Maurizio Cantore)
5
abbiamo avviato nelle giornate di “EuroIn sala d’attesa
mediterranea” a Bolzano, all’inizio di luIntervista a Claudio Graiff glio.
(a cura di B. Bertoncin e E. Rabini)
6
E ci è venuto naturale ripensare agli inseLa cultura della cura gnamenti di Gandhi e poi di Ivan Illich e
(di Claudio Graiff)
8
della sua allieva Barbara Duden, così cari
Un pubblico speciale
ad Alexander Langer. Nei loro interventi
Intervista a Roberto Prosseda
denunciavano gli effetti potenzialmente
(a cura di B. Bertoncin e E. Rabini)
10
patogeni della medicina moderna, di una
vita medicalizzata, nonché di relazioni
Per una storia dei Donatori di Musica
distorte dalle disparità di conoscenze e di
(di Giorgio De Martino)
12
potere tra chi soffre e chi cura.
La musica Creatrice
Indice
(di Antonio Osnato)
13
Era il segno che avevo reagito
Intervista a Roberto Dall’Olio (a cura di Barbara Bertoncin)
14
Per questo sono rinato
Poesie di Roberto Dall’Olio
16
Parlare fa bene
Intervista ad Andrea Martoni (a cura di Barbara Bertoncin)
18
La difesa della normalità
Intervista ad Anna Segre (a cura di Gianni Saporetti)
20
Anna e la malattia (di Anna Bravo)
20
La malattia e la persona
Intervista a Gemma Martino
(a cura di Paola Sabbatani) 22
I limiti del medico
Intervista a Marco Bobbio
(a cura di Enzo Ferrara)
24
Salute? No, grazie! (di Barbara Duden)
26
Infermiere e pianeta, elogio della gratuità
(di Alexander Langer) 30
La malattia ha cambiato la mia vita
(di Martin Berkofky) 32
Con il premio ai Donatori di Musica, il
Comitato scientifico della Fondazione ha
voluto segnalare e incoraggiare la diffusione di questa esperienza adottata sistematicamente in alcuni ospedali italiani.
La grande musica entra nei reparti e favorisce la creazione di un spazio liberato
dalla rigidità dei ruoli e dall’isolamento
del malato -insieme a medici e infermieriin una enclave istituzionalizzata.
Il bel libro che la Presidenza della Camera ci ha voluto donare a conclusione della
scorsa legislatura sui Premi Langer dal
1997 al 2012, racconta come anche altri
premi, pur con sfaccettature diverse, ci
avevano obbligati a pensare al tema della
salute. Così è stato nel 2003 con l’Associa-
zione Gabriele Bortolozzo per il suo impegno contro le emissioni nocive di Porto Marghera; o il premio del 2005 alla
psichiatra bosniaca Irfanka Pasagic, che
cura le vittime del genocidio di Srebrenica dai traumi ancora evidenti. Infine
quello del 2006 all’ostetrica dai piedi
scalzi di Bali, Ibu Robin Lim, e il premio
del 2007 al sudafricano Zackie Achmat,
che nel suo paese conduce una difficile
battaglia per garantire ai malati di Aids
la somministrazione dei farmaci attraverso il servizio pubblico. Senza dimenticare il premio 2010 alla Fondazione Stava1985, che ha vissuto una tragedia così
simile a quella del Vajont, di cui ricorre
quest’anno il 50° anniversario.
Ora ci rendiamo conto che l’“Arte del
prendersi cura” li attraversa tutti e che
anche gli altri premi chiedono sostanzialmente la stessa qualità di relazioni
alla quale i Donatori di musica aspirano
e ci propongono.
Li sentiamo così in sintonia con le conclusioni di una relazione di Alexander
Langer del novembre 1990 al Congresso
nazionale dell’Associazione infermieri di
area critica: “Sviluppare la gratuità vorrebbe dire difendere e valorizzare tutti
i luoghi in cui ci si può ritrovare, si può
sostare, ci si può parlare, senza dover
fare parte di una struttura, senza dover
pagare il biglietto di ingresso, senza essere abbonato a un circuito, senza avere
poi un contratto di assistenza tecnica
che dopo cura la manutenzione”.
Un bel programma per tutti noi.
Perché le note fanno bene alla vita
Bettina Foa,
Enzo Nicolodi
di Marina Sereni*
Bellissimo questo nome di “Donatori di Musica” che regalano alle ammalate e agli ammalati di alcuni reparti oncologici -e non solo- la bellezza della musica. Lo spirito con
cui offrono il loro dono è riassunto molto bene nelle motivazioni forniteci dal Comitato
scientifico della Fondazione Alexander Langer, che ci consente ogni anno -dal 1997- di
conoscere le esperienze e le pratiche più coraggiose e innovative sul piano della tutela
e della promozione dei diritti umani messe in atto a livello globale.
Il libro curato da Grazia Barbiero: “Il Premio Alexander Langer alla Camera dei deputati / 1997-2012”, pubblicato nel 2012, raccoglie e documenta questi percorsi coraggiosi
di solidarietà ai quali sono appese le nostre speranze migliori.
Aver cura del prossimo non è cosa facile in un’epoca di passioni tristi e frammentazione sociale, di solitudini ed egoismi. Quest’anno il Premio valorizza una buona pratica
italiana nel nome di Alexander Langer, l’uomo che più di tanti altri, ha illuminato
“l’importanza dei mediatori, dei costruttori di ponti, dei saltatori di muri, di esploratrici di frontiera” per affermare un mondo di pace.
*Marina Sereni è vicepresidente della Camera dei Deputati
2
Laura Boldrini
La buona politica
di Alexander Langer
Il Premio Internazionale Alexander Langer giunge quest’anno alla diciassettesima edizione. è un evento ormai tradizionale che la Camera dei Deputati ospita
con grande piacere.
Tra le particolarità del Premio c’è il fatto
che fin dalla sua prima edizione, nel 1997,
a promuoverlo e organizzarlo sono sempre
state le deputate dell’Ufficio di Presidenza della Camera.
Altrettanto significativo è che la maggioranza dei premiati nei precedenti sedici
appuntamenti siano state donne.
Mi piace ricordare a questo proposito che
nella prima edizione, nel 1997, il Premio
andò a Khalida Toumi Messaudi, una
donna che con estremo coraggio si è battuta da protagonista per i diritti delle donne
e per le libertà civili nel suo Paese, l’Algeria. Per me, lo comprendete bene, si tratta
di fatti molto importanti e ricchi di valore.
L’istituzione di questo Premio Internazionale, per le sue finalità, è un modo certamente efficace di ricordare Alexander
Langer e di rinnovare gli ideali che hanno
ispirato la sua vita e la sua azione politica. Di lui è stato detto e scritto molto:
del suo impegno a difesa dell’ambiente,
per la pace nella ex-Yugoslavia, per la
convivenza in Alto Adige; del suo ruolo di
promotore del movimento politico dei Verdi in Italia e in Europa e di membro del
Parlamento Europeo. In ciascuno di questi ambiti ha lasciato un segno del tutto
particolare.
Io vorrei oggi parlare dei suoi modi corretti e rispettosi. Un tratto del carattere,
certo, ma anche una visione della politica
e delle relazioni con le persone. Una politica intesa, e praticata, come dialogo, convincimento, ascolto delle verità altrui.
Il contrario dell’idea che sembra prevalere oggi della politica come puro esercizio
del potere, come sopraffazione, come delegittimazione dell’avversario.
Nella cultura di persone come Alexander
Langer la nonviolenza non è assenza di
conflitto: è ripudio di ogni intolleranza e
di ogni pregiudizio, è costruzione di ponti
tra le culture, le identità, le appartenenze.
Rispettare gli altri, allora, non significa
rinuncia, rassegnazione, arrendevolezza:
le sue battaglie, quasi sempre controcorrente, Alexander Langer le ha condotte
con coraggio e a viso aperto.
Oggi il confronto politico è troppo spesso
gridato, sopra le righe, si eccede nei toni e
giudizi sulle persone, si appare sordi alle
ragioni dell’interlocutore.
Proprio oggi, in un tempo come questo,
abbiamo un grande bisogno di non dimenticare quella lezione di buona politica che
Alexander Langer ci ha lasciato con il suo
esempio e con la sua esperienza nei movimenti e nelle istituzioni.
Li ritroviamo pienamente, questi valori,
nelle motivazioni che accompagnano il
conferimento dei Premi. Ricorrono, nelle
motivazioni, alcune parole: libertà, uguaglianza, convivenza, tolleranza religiosa,
parità tra i sessi, tutela della natura, diritti umani. Sono le tessere di un mosaico
che ben rappresenta una moderna cultura
democratica e una sensibilità nuova verso
il destino del nostro pianeta. Al centro di
tutto questo ci sono la dignità della persona e l’inviolabilità dei suoi diritti.
Della dignità umana, parla anche l’esperienza dei “Donatori di Musica” ai quali
va il Premio Langer di quest’anno.
Si tratta di un gruppo di medici, artisti,
infermieri, volontari che organizzano
eventi musicali soprattutto nei reparti
oncologici.
Nella motivazione del conferimento del
Premio si spiega bene che donare concerti a persone che vivono una condizione di
dolore e di estremo disagio, non è un atto
di semplice carità o un puro tentativo di
svago. L’obiettivo dei “Donatori di musica” è quello, si dice nella motivazione, di
“contrastare un modello di medicina che
ancora tende a sequestrare il paziente in
una enclave istituzionalizzata, a rinchiuderlo nell’identità esclusiva di malato di
cancro… Rompere la segregazione per
dare spazio alle molte cose che un malato
continua a essere… costruire legami fra i
degenti, i loro familiari e amici, gli artisti,
gli operatori sanitari”.
Rompere la segregazione, costruire legami. In queste parole ci sono le ragioni che
spiegano perché va ai “Donatori di Musica” un Premio che fino ad oggi è andato
a personalità e ad associazioni impegnate
per la pace, per la tutela dei diritti umani,
per le libertà civili e politiche in ogni parte del mondo.
Perché si tratta comunque, lo dicevo
poc’anzi, dell’impegno per la dignità della persona e l’inviolabilità dei suoi diritti.
Valori ai quali tutti noi teniamo molto.
Per questo ai “Donatori di musica” e alla
“Fondazione Alexander Langer Stiftung”
va il ringraziamento e la sincera stima
della Camera dei Deputati.
Grazie ancora di essere qui e buon lavoro
a tutte e a tutti voi.
Mercoledì, 9 ottobre 2013,
Sala del Cavaliere
3
Motivazioni del Premio Alexander Langer ai Donatori di Musica
L’arte del prendersi cura
La decisione di premiare i “Donatori di Musica” -una rete di artisti, medici, infermieri e
volontari che prende il nome dall’impegno a
organizzare, prevalentemente in reparti oncologici, stagioni di concerti- può sembrare
una rottura con la tradizione che per anni
ha visto la Fondazione Langer privilegiare
l’opera di pacificazione e di soccorso in luoghi di conflitto e di crisi umanitaria. Più che
una rottura, però, è uno spostamento: dal
lontano al vicino, dall’emergenza alla quotidianità, dalla cura della vita offesa alla cura
della vita pericolante. E non solo: se c’è un
tratto che accomuna i nostri premiati è la
scelta nonviolenta, e di nonviolenza la pratica medica ha un profondo bisogno.
Quando Gandhi, e dopo di lui Illich, denunciavano gli effetti patogeni della moderna
medicina, il bersaglio erano sia lo specialismo, sia la violenza potenziale legata alla
disparità di conoscenze, padronanza, potere
fra chi soffre e chi cura. A maggior ragione
nella malattia oncologica, in cui il malato
può vivere momenti di vulnerabilità estrema, in cui il corpo può ridursi a un groviglio
di sofferenza nelle mani di chi ha la facoltà
(e l’onere) di decidere le terapie, i tempi, i
modi e i luoghi in cui applicarle.
Oggi la medicina ha imparato a riflettere su
se stessa, sulla propria vocazione, sul proprio ambiente; da anni in molti ospedali c’è
chi si sforza di “umanizzare” la degenza promuovendo iniziative per lo svago e la socializzazione. Giusto, ammirevole.
Ma i Donatori puntano a qualcosa di diverso: a contrastare un modello di medicina
che ancora tende a sequestrare il paziente
in una enclave istituzionalizzata, a rinchiuderlo nell’identità esclusiva di “malato di
cancro” – e qui viene spontanea un’analogia
con gli interventi in situazioni di guerra civile o di catastrofe naturale, dove i colpiti
sono vittime, certamente, ma non vittime
soltanto, e amerebbero avere rapporti da
persona a persona, non da bisognosi a soccorritori.
Per rompere la segregazione, per dare spazio alle molte cose che un malato continua a
essere, la via maestra è costruire legami fra
i degenti, i loro familiari e amici, gli artisti,
gli operatori sanitari. Un lavoro che non può
accontentarsi della performance isolata perché vuole tempi lunghi, continuità, sapienza
sedimentata, un contorno coerente.
è in questa prospettiva che il concerto prende senso come strumento e simbolo di condivisione: si discute, lo si prepara insieme,
insieme si vive la beatitudine che la musica
sa dare, si gusta il cibo che accompagna l’incontro. E insieme si cambia.
La presenza nel reparto dei musicisti, un
pezzo di mondo dal quale i pazienti sono
stati esclusi o si sono lasciati escludere, ha
consentito -dicono i Donatori- una “rivoluzione imbarazzante” per la sua semplicità:
iniziata dalla consapevolezza che ognuno è
nello stesso tempo sano e malato, spesso in
4
transito da una condizione all’altra, la rivoluzione è approdata alla scoperta che non
necessariamente il paziente è la figura che
chiede e riceve, può altrettanto bene essere quella che offre e dà. In questa logica di
scambio, l’artista porta la sua musica, gli
operatori le proprie conoscenze, i malati il
proprio sapere: esperienza del dolore, ma
non soltanto, anche storia della vita che si è
vissuta e si spera di tornare a vivere.
è un insieme che protegge dal rischio di
diventare, proprio malgrado, “malati professionali”. Ed è una critica pratica alla
nostra cultura, in cui il cancro è avvolto da
un’aura perturbante che rende difficile persino nominarlo e che può falsare i rapporti
e le parole. L’esperienza dice che ci si può
opporre. è proprio dall’esperienza nascono
i Donatori.
Nel 2007 un musicologo e direttore artistico, degente all’ospedale di Carrara, propone
al suo primario di organizzare un concerto
-quel che faceva prima e vuol continuare a
fare nel modo in cui gli è possibile. L’esperimento ha una ricaduta bella e fattiva oltre
le previsioni, tanto che l’evento si trasforma
in sistema, e invoglia altre persone, altre
istituzioni -gli ospedali di Bolzano, Brescia,
Saronno, Sondrio, Vicenza, il San Camillo
Forlanini di Roma.
Un progetto così semplice e così ambizioso
esige regole e patti. Agli artisti chiede, insieme all’eccellenza professionale, sensibilità e
riserbo: nessun turismo umanitario, nessuna autopromozione o ritorno di immagine.
Agli operatori chiede un lavoro costante di
informazione calibrato sul livello diffuso di
conoscenza della malattia e delle opzioni terapeutiche. A tutti si chiede empatia, rispetto reciproco, messa in discussione dei ruoli:
nel setting del concerto, nessuno ha un abbigliamento “di funzione”, a significare che
si tratta di una performance diversa da ogni
altra.
Ma nella cura il medico non abdica al suo
ruolo. Lo svolge con più consapevolezza del
punto di vista del malato, ma anche dei propri disagi, difficoltà, debolezze, da affrontare insieme. A differenza che nella direttiva
“il malato è al centro”, che lascia spesso la
decisione nelle mani del medico, qui al centro è il rapporto. E quel rapporto è la condizione per una buona alleanza e una modalità di cura non accanita e non bellicosa
-come avviene invece nella diffusa tendenza
a concepire la terapia come guerra, duello,
prova di forza.
La priorità delle relazioni è l’altra faccia
della “rivoluzione imbarazzante”: mentre
ancora oggi l’“umanità” del curante è considerata dagli stessi pazienti un (pregevolissimo) di più, per i Donatori è parte integrante
dell’eccellenza professionale. Senza la quale
non c’è buona medicina né buona terapia.
Questo impegno complessivo non è materia
per un progetto di riforma sanitaria; è materia per un lavoro di riforma interiore, la
stessa strada che porta a scegliere la nonviolenza e a decidere consapevolmente della
propria vita.
Enzo Nicolodi (presidente Fondazione),
Fabio Levi (presidente Comitato scientifico)
Anna Bravo (relatrice)
La scultrice sudtirolese Sieglinde Taz Borgogno
ha inserito nel suo “Giardino delle statue” a Pochi
di Salorno (BZ) un bronzo dedicato ai Donatori
di Musica, accanto ad altre opere che ricordano
Alexander Langer e tutti i premi a lui dedicati.
Maurizio Cantore
Tutti i giorni dopo
Sono onorato di essere qui con voi e felice
di raccontarvi una bella storia che nasce in
Italia, in quell’Italia che in queste settimane di tragedie umane ha dimostrato che concetti come solidarietà e amore appartengono
alla maggior parte dei suoi figli. è la storia
di “Donatori di Musica”. La storia di persone che rimangono tali o addirittura scoprono di essere persone migliori nel momento
più difficile della loro vita, quello della diagnosi di cancro. La storia di 8.000 pigiami
lasciati negli armadi dei reparti di oncologia
negli oltre 200 concerti che si sono svolti in
questi cinque anni perché al concerto si va
ben vestiti anche se è in ospedale. La storia
di volontari che con gioia cambiano volto e
attraverso nuove azioni trovano sempre più
forti motivazioni. La storia di musicisti che
si tolgono il frac e suonano nell’abbraccio
di persone che ascoltano con il cuore prima
che con l’orecchio. La storia di medici che si
tolgono il camice, vivono nelle stanze della
quotidianità oncologica, prima ascoltano e
poi parlano per una condivisione più vera.
La storia di luoghi dove il dialogo è orizzontale e non dall’alto verso il basso, dove anche
le paure più nascoste hanno modo e forza
di essere dette, dove i desideri cancellati da
qualche etto di tumore possono riaffacciarsi,
dove insomma la speranza viene ripescata e
rianimata. La storia di luoghi dove il malato
con tumore non ha soltanto diritti, ma anche doveri, principalmente verso se stesso, il
primo dei quali non diventare malato di professione, persona cioè che parla solo al passato, cancella il futuro dal suo immaginario
e si trasforma nella sua malattia. La storia
di un nuovo tipo di relazione tra medico e
malato in cui l’obiettivo di cura diventa un
obiettivo comune e la strada per raggiungerlo diventa una strada mai percorsa da soli.
La musica è un fertilizzante magico di questo nuovo terreno d’incontro.
E proprio dall’occasione di un incontro nel
giugno 2007 nell’Oncologia di Carrara, nasceva l’idea di Donatori di Musica. Gian
Andrea Lodovici, uomo della musica, critico
musicale famoso e importante produttore di
musica classica, entrava nel mio studio di
Carrara per fare l’ultimo piacere alla moglie Caterina e al piccolissimo figlio Giorgio. Sentire un’ulteriore opinione sul trattamento del proprio cancro allo stomaco.
Erano 12 mesi che eseguiva chemioterapie,
perdeva capelli, faceva esami, stava sempre
peggio e la musica era stata cancellata nei
suoi pensieri. Quella musica che per lui era
stata sempre motivo e ispirazione di vita.
In quel primo incontro, che poteva essere anche l’ultimo, non ho parlato di nuove
chemioterapie, di armi più potenti o mirate
per combattere il suo cancro, ho chiesto il
suo aiuto per fare dei concerti nel mio reparto. I suoi occhi subito hanno cambiato
orizzonte, prima mi passavano attraverso
con indifferenza, ora si posavano sui miei,
accesi però da un dubbio: “Perché lui, mio
possibile salvatore chiede a me aiuto, a me
che ho il cancro?”. Proprio in quel momento,
la luce si è riaccesa in lui e gli ultimi mesi
della sua vita sono stati percorsi con gioia a
creare concerti e poi stagioni musicali nella
nostra Oncologia. Gian Andrea con serenità
e profonda stima ha quindi ceduto il testimone a chi, lui ne era certo, avrebbe proseguito il suo cammino, Roberto Prosseda, uno
Attualmente sei oncologie italiane sono attive; a gennaio prossimo entreranno l’Oncologia pediatrica di Parma e il Servizio di
Igiene Mentale di Castelfranco Veneto.
Nella filiera del dono dei Donatori di Musica
ci sono oltre 200 musicisti di altissima qualità sia musicale (debbono essere professionisti con esperienza documentata nazionale
e internazionale) che empatica.
dei più noti pianisti italiani che da subito lo
ha raccolto con entusiasmo e fortissime motivazioni. Nasceva così l’idea di creare una
rete di musicisti, medici, volontari, malati,
familiari, infermieri, psicologi per portare
la grande musica non episodicamente ma
continuativamente nelle oncologie italiane.
E dopo Carrara ecco che Claudio Graiff, primario oncologo di Bolzano, costruiva il secondo punto della rete delineando una retta
e quindi la direzione da seguire. E poi ecco
le Oncologie di Brescia, Vicenza, Roma, Sondrio e Saronno con oltre 200 concerti suonati
in questi anni. E arriviamo ai giorni d’oggi.
L’incontro con la Fondazione Alexander
Langer e le motivazioni che hanno premiato
DdM, sono state per noi rivelatrici di obiettivi da raggiungere e non di mete già colte:
il concetto di non violenza di una medicina
che attualmente tende ancora a istituzionalizzare il malato e di fatto a spegnere il suo
essere persona. Porlo al centro della nostra
attenzione significa che lui può solo chiedere e ricevere, non dare e offrire. Donatori di
Musica è una semplice, imbarazzante rivoluzione che quotidianamente pone al centro
non il malato, ma la costruzione di una relazione con lui come persona che può anche
dare e offrire.
è nel momento del concerto che il musicista
è chiamato a dare una musica diversa da
quella che suona di fronte a platee anche di
migliaia di persone, protetto dal palco e dalla irraggiungibilità del “grande maestro”.
Qui suona in mezzo a persone che sentono il
suo respiro e vedono le vene delle sue mani.
Non può nascondersi e deve donare la sua
musica più intima perché chi lo ascolta lo
fa con il cuore e con la pelle. E quindi deve
scoprire la sua musica più innamorata che,
a volte è capitato, lui stesso non aveva mai
sentito prima.
Ma di tutte le fasi dei concerti di Donatori
di Musica quelle più importanti sono tutti
i giorni dopo: non servirebbe a niente avere assistito al più grande ed emozionante
concerto del secolo se tutti i giorni successivi non venisse mantenuta quella magica
relazione che si è creata durante il concerto.
Ecco perché la bellezza e la grandezza della rivoluzione di Donatori di Musica si vede
ancora di più in tutti i giorni dopo: proprio nella quotidianità ospedaliera fatta di vittorie e di sconfitte, fatta di lacrime e abbracci.
Fatta di carne, di scienza e di cuore.
(Intervento del dott. Maurizio Cantore
alla Camera dei Deputati, 9 ottobre 2013)
5
In sala d’attesa
Stagioni di concerti nei reparti di oncologia, in cui sono coinvolti tutti e alla fine anche il musicista ringrazia; la diffusione della medicina “difensiva” che scarica tutte le responsabilità sul malato; l’eccellenza dell’accoglienza e quel sogno di comprare
il pianoforte. Intervista al dott. Claudio Graiff.
Claudio Graiff, oncologo presso l’ospedale
di Bolzano, è tra i fondatori di “Donatori di
Musica” (www.donatoridimusica.it).
Da alcuni anni, assieme ad altri, ha
dato vita a “Donatori di Musica”, una
rete di musicisti, medici e volontari
che organizza stagioni di concerti negli
ospedali. Può raccontare?
La storia dei Donatori di Musica è cominciata nel 2007 dall’incontro di due persone:
Gian Andrea Lodovici, un musicologo, direttore artistico di un’importante casa discografica, che si trova a frequentare, come
degente, il reparto di Oncologia dell’ospedale di Carrara, con una malattia purtroppo
molto avanzata e ben consapevole della sua
aspettativa di vita; l’altra persona è Maurizio Cantore, il primario di quel reparto, un
medico da sempre capace di instaurare delle
relazioni forti e credibili con le altre persone.
Gian Andrea Lodovici a un certo punto butta là una proposta: “Perché non proviamo
a organizzare un concerto? In fin dei conti
questo è il mio mestiere, mi piacerebbe molto...”. Il medico accetta volentieri. Non è la
prima volta che si fanno delle attività diverse da quelle strettamente cliniche in quel reparto, però questa si dimostra subito molto
coinvolgente e quindi si decide di ripeterla.
Così, finché Lodovici ha le energie, ogni tanto organizza una serata, un concerto, invitando alcuni musicisti che sono anche amici
suoi. Nel frattempo capita che Maurizio e io
ci incontriamo a un convegno. Ci conoscevamo già, eravamo amici, essendo uniti anche
da una condivisione sul senso del nostro mestiere. Lui mi racconta questa cosa e vede
-me l’ha detto dopo- un luccichio nei miei
occhi, che lui imputa al mio interesse per la
musica... in realtà io mi ero commosso per il
senso che intravedevo in questa possibilità.
non ci deve essere distanza
tra il musicista e gli altri, quindi
lo strumento è in mezzo alla sala
Nel frattempo, Lodovici, a soli 48 anni, purtroppo se ne va, ma prima di morire esprime
l’auspicio che la “Grande Musica divenga
sempre più strumento di importante aiuto
alle cure mediche in ogni reparto di oncologia”. Teniamo presente che sono le parole
di un ammalato che ha sperimentato su di
sé cosa poteva significare organizzare e seguire questi concerti. Ecco, Lodovici lascia
queste parole e passa il testimone a Roberto
Prosseda, uno dei più importanti pianisti
italiani, che lo raccoglie con entusiasmo,
coinvolgendo anche sua moglie, pure lei pianista, che è poi l’ideatrice del nome dell’Associazione.
Nasce così l’idea di costruire una rete di musicisti, medici, volontari, infermieri, psicologi, ammalati, familiari, insomma di tutte
6
le persone coinvolte, con l’obiettivo di darci
una maggiore sistematicità.
Diceva che i concerti in reparto non
sono un’iniziativa benefica o ricreativa. C’è dell’altro e ci sono anche delle
regole...
A marzo 2009 nasce la rete. Raccolte le adesioni dei primi musicisti, si comincia a predisporre una serie di regole di base. Vengono stabiliti alcuni piccoli paletti: intanto le
iniziative non devono essere episodiche ma
continuative, altrimenti si perde il senso.
Non ci deve essere distanza tra il musicista
e gli altri, quindi lo strumento è in mezzo
alla sala. Sia da noi che a Carrara il concerto si svolge nella sala d’attesa del reparto. Il
musicista poi è pregato di non indossare un
abbigliamento “di funzione” e così tutti gli
operatori sanitari e gli ammalati. La totale indistinguibilità è uno degli elementi del
progetto: significa che in quel momento nessuno ricopre un ruolo istituzionale.
Questo non è un concerto per gli ammalati,
non è un’iniziativa benefica, è qualcosa che
si fa tutti assieme e da cui trae beneficio lo
stesso musicista. La particolare sensibilità
e l’esperienza di vita degli ammalati e dei
familiari, ma anche degli operatori sanitari,
sono infatti uno stimolo poderoso alla maturazione del musicista che quindi dona e riceve, tant’è vero che spesso ci dicono di avere
più ricevuto che dato.
Questo ritorno molto forte ha fatto sì che la
rete raccogliesse molto velocemente adesioni di un gran numero di musicisti. E qui interviene un altro criterio, nel senso che non
tutti quelli che si propongono vengono invitati. Ci sono dei requisiti necessari: si deve
trattare di musicisti professionisti con una
carriera internazionale di un certo livello.
Insomma, non accettiamo tutti, o meglio,
visto che sarebbe sciocco non accettare una
persona che, pur essendo un dilettante, desidera dare il suo contributo, facciamo delle
manifestazioni a latere, che però non rientrano nel progetto.
Infine c’è la gratuità, che è fondamentale,
ma non va intesa in senso esclusivamente
economico (in realtà grazie a qualche sponsor riusciamo almeno a rimborsare le spese
vive). Gratuità significa che il musicista non
deve attendersi alcun compenso e nemmeno
un ritorno in notorietà. Questo serve anche
a noi per essere certi dello spirito con cui il
musicista si propone. Molti ci chiedono: “Se
ne sa così poco... Perché quando fate concerti non lo annunciate nei giornali?”. Perché è
una cosa tra di noi.
Nel 2009, con questo minimo di teorizzazione alle spalle, attraverso la rete del Collegio
italiano primari e oncologi medici ospedalieri (Cipomo) abbiamo scritto una breve lettera presentandoci agli ospedale interessati.
Nella primavera dello stesso anno siamo
partiti, inizialmente in due, Bolzano e Car-
rara. Si sono poi uniti l’ospedale di Sondrio e
quello di San Bonifacio di Verona, dove l’iniziativa, successivamente interrotta, aveva
coinvolto un reparto chirurgico. D’altra parte, organizzare non uno, ma venti concerti
all’anno non è così semplice, bisogna crederci. In seguito si sono aggiunti il San Camillo
Forlanini di Roma e, più recentemente, Brescia e Vicenza. L’ultimo in ordine di arrivo
è Saronno.
Voi pretendete anche che sia garantita
l’eccellenza medica dei reparti coinvolti.
Quello che per noi è davvero un requisito
fondamentale è l’eccellenza nell’accoglienza.
D’altra parte non esiste eccellenza clinica
senza relazione.
se è vero che il compito della terapia
compete ai tecnici, il compito della
“cura” compete a tutti
Uno studio pubblicato recentemente ha dimostrato che gli ammalati seguiti da medici
“empatici” presentano meno complicanze
acute e una migliore aspettativa quantitativa di vita. Un risultato clinico positivo può
venire in pari misura dal migliorare la tua
capacità empatica o dall’utilizzare l’ultimo
nuovissimo farmaco, si figuri cosa possiamo
ottenere se mettiamo insieme le due cose!
Io, poi, quando parlo di eccellenza intendo
una cosa precisa, cioè far bene il proprio mestiere. L’eccellenza per me è il piastrellista
che alla fine del lavoro passa la mano ed è
contento del risultato; l’eccellenza non è la
cosa straordinaria, è la cosa normale fatta
come meglio si può.
Perché questi concerti sono un momento importante nella vita degli ammalati, dei medici e degli infermieri?
Per gli ammalati e gli operatori questo progetto significa il coinvolgimento della società nelle attività di cura degli ammalati. È
importante che questa società, che ha deciso di costruire gli ospedali fuori dalle città,
si riappropri della cura dei suoi ammalati,
perché se è vero che il compito della terapia
compete ai tecnici, il compito della “cura”
compete a tutti. A volte pretestuosamente si
tirano fuori motivazioni di carattere tecnico, di accessibilità, ma sappiamo benissimo
che esistono strutture molto frequentate che
sono ubicate nel cuore delle città. Basti pensare all’Hôtel Dieu di Parigi che è sotto la
chiesa di Notre Dame. La realtà è che oggi
la malattia in qualche modo “stona”.
Lei dice che l’attuale organizzazione
sanitaria rischia di far sì che l’essere ammalati diventi un mestiere. Può
spiegare?
Oggi molte persone vivono la loro malattia
come un continuo dentro e fuori, perché certe cose si possono fare solo in ospedale, se
poi ci aggiungiamo la dislocazione geografica, di cui dicevamo, e una sorta di apar-
Bolzano, 5 luglio: Concerto di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti
theid che si viene a creare tra i malati e i
sani si arriva a quella che ho chiamato la
“condizione professionale” dell’ammalato.
Un signore, che dopo aver fatto il giro delle
sette chiese era venuto anche da me in cerca
di un’improbabile risposta, alla domanda su
quale fosse il suo mestiere mi ha risposto:
“Io facevo...”. Al che ho iniziato a chiedere:
“Perché facevo? Non ce la fa più? Le manca
la forza?”. “No, no, ce la farei”. “Ah, è perché
ora le sue priorità sono altre, non le interessa più...”. “Scherza? Il mio lavoro me lo sogno di notte!”. “E allora?”. “Ma dottore, per
forza non lo faccio...”. Ecco, “per forza” non
lavorava più, doveva fare l’ammalato!
Perché ormai si è creata questa spaccatura tra il sano e il malato che ci impedisce
di vivere come prima, anche se potremmo.
Questo concetto della malattia, che è prettamente culturale, ci cambia la vita, ci cambia il concetto dello spazio, del tempo, ci fa
coniugare i verbi al passato. Ecco, l’irruzione dei musicisti nella vita di ammalati che
dal mondo sono stati buttati fuori (o si sono
autoesclusi) è qualcosa di fondamentale per
rompere questo isolamento. Per questo noi
la definiamo una rivoluzione, imbarazzante
nella sua semplicità, perché vuole riportare
al concetto che ognuno di noi è a un tempo
sano e ammalato. Molti malati di oggi saranno i sani di domani e sicuramente quasi
tutti i sani di oggi saranno i malati di domani. Insomma, siamo tutti sani e malati. La
condizione della malattia, nel momento in
cui diventa dominante e totalizzante al punto da obbligarti a rinunciare a tutto quello
che eri, fa sì che tu non sia più il signor pinco pallino che oggi ha un problema, bensì tu
diventi il tuo problema.
Allora, per gli ammalati, al di là dell’intensità emotiva con cui ognuno di loro può vivere
il momento del concerto, credo che questo
sia un aspetto che conta. Non è la solidarie-
tà o la beneficenza. È il musicista che arriva e alla fine ringrazia di aver condiviso
dei momenti con persone che attraverso la
loro esperienza hanno comunque acquisito
un sapere che lui può giusto intravedere.
Ma soprattutto è una cosa che si fa assieme,
in cui anche l’ammalato e i familiari svolgono una parte attiva. Il progetto prevede che
alla fine ci sia un buffet in cui il malato fa
qualcosa di pratico, ma soprattutto di simbolico perché il malato non è al centro.
Nell’idea di porre il malato al centro, a
suo avviso, si sono commessi anche degli errori...
Sicuramente la medicina per troppo tempo
ha perso di vista il malato. Nei primi anni
Ottanta sembrava che gli ospedali avrebbero potuto funzionare molto bene operando
solo su organi isolati, senza il corollario delle cose che fanno “perdere tempo”.
Quante volte le persone mi dicono: “Mi scusi dottore se le faccio perdere tempo, vorrei
sapere quali sono le condizioni di salute di
mio papà”. Ecco, nel momento in cui io medico non ho in mano uno strumento, ma sto
interagendo con una persona, nell’immaginario sto perdendo del tempo, perché io sono
un tecnico. Tutto questo non è vero. Negli
ultimi anni molto si è fatto per rivedere questa impostazione. I sistemi sanitari hanno
recuperato una visione olistica (anche se
adesso si abusa di questa parola) mettendo
al centro l’ammalato... e quella è stata la
frittata! Perché si è riacquistato interesse e
attenzione ai bisogni del malato, ma sempre
nella posizione in cui io corrispondo ai tuoi
bisogni, punto.
Se l’obiettivo è la bidirezionalità, beh, questa non è rispettata dalla posizione centrale
del malato. In più così si mette l’ammalato
in una condizione di passività che lo professionalizza ancora di più: lo metti fuori dalla città, lo consegni nelle mani dei medici e
delle infermiere e intanto tu, società, aspetti
che torni. Ma magari non c’era bisogno che
smettesse di lavorare... L’ammalato al centro non solo viene quindi temporaneamente
espulso dalla società, ma anche rispetto agli
operatori sanitari si trova in una posizione
del tipo: “Io chiedo, se qualcuno ha qualcosa
da darmi, grazie”. Non io chiedo e do. Ecco,
da noi l’ammalato sta attorno al tavolo, si dà
da fare come gli altri; il simbolo del buffet è
questo.
Diceva che alcuni malati riscontrano
anche dei benefici fisici, misurabili...
Sì, con il tempo abbiamo scoperto che questa
esperienza induce dei cambiamenti anche in
alcuni aspetti di qualità della loro vita. Abbiamo raccolto dei dati sia a Carrara che a
Bolzano.
per me è sempre molto commovente
quando qualcuno ci viene
a trovare pur non avendo più bisogno
Per ora quello che emerge è che grazie a
queste iniziative diminuisce il livello di
stress legato all’ospedalizzazione, vengono
facilitate le relazioni tra operatori e pazienti, per alcuni addirittura migliora la qualità
e la durata del sonno, diminuiscono gli episodi di nausea e vomito.
E per gli operatori cosa significa?
Parlo per me. Vedere una persona che torna
in ospedale, dove magari è stata la mattina
o una settimana prima, e si siede magari
sulla stessa sedia dov’era rimasta in attesa
di una terapia sgradevole o di una notizia
a volte non buona; ecco, vedere una persona che senza averne alcun bisogno torna in
questo luogo e si siede su quella stessa sedia
per fare qualcosa di diverso, di bello, mi fa
pensare che forse abbiamo instaurato una
relazione buona, credibile; che abbiamo crea-
Fare musica significa dare senso alle cose. Rendere ricco un momento dell’esistenza, forse
un’intera esistenza. Condividere delle emozioni, forse le più intime, quelle che non si possono
dire. Da queste premesse nasce l’esigenza dei Donatori di Musica. Non diversamente dai
donatori di sangue, i musicisti possono dare qualcosa che hanno, sapendo che quella cosa
sarà altrettanto essenziale per chi l’ascolta. Ma ci sono due peculiarità in questo modo di
donare: l’idea che volontariamente essi scelgono di condividere la musica al di fuori della
situazione “protetta” della sala da concerto, dove sono normalmente su un palcoscenico e
in una posizione privilegiata; e, in secondo luogo, il fatto che ad ascoltarli saranno persone
dall’esistenza speciale, con un diverso sguardo sulla vita, sulla sofferenza, sull’affettività.
Per questo ogni musicista sa che non può restare “sul palcoscenico”, non può risparmiarsi.
Deve mettersi in gioco, a disposizione, mettere in campo la sua generosità. Ecco le condizioni
grazie alle quali la donazione si realizza appieno: un darsi che è anche un ricevere, scoperta
di sé e ritorno all’essenza della musica, dare senso alla cose attraverso le emozioni di chi
suona e di chi ascolta.
Luigi Attademo
7
to un luogo dove si può venire anche quando
non si ha bisogno. Per me è sempre molto
commovente quando qualcuno ci viene trovare pur non avendo più bisogno, oltre alla
strumentalità del rapporto; è un’attestazione importante e una grande gioia.
I medici oncologi, così come gli specialisti che hanno a che fare con malattie importanti, sono quotidianamente
a contatto con storie di sofferenza e
talvolta con esiti infausti. Diceva che
queste iniziative aumentano il senso
di condivisione. Sappiamo della sofferenza del malato, ma la sofferenza del
medico?
Il contatto con la sofferenza, con la malattia, fa parte della scelta di fare il medico.
Chi sceglie questa strada deve sapere che la
sua vita sarà coinvolta in maniera totalizzante da questa esperienza. Chi fa il medico
ospedaliero in determinati reparti è meglio
sappia da prima che non avrà una vita sociale normale né una vita familiare normale. Dovrà essere disposto a queste rinunce.
Se lavora in un’unità di terapia intensiva,
coronarica, o in un’ematologia con bambini
con la leucemia, non potrà pensare che tutto
questo non abbia un impatto fondamentale
sulla sua vita extra professionale, saremmo
degli schizofrenici, dei dissociati. A volte a
noi medici sembra che il mondo sia tutto un
grande ospedale, c’è anche un’alterazione
della percezione.
In questo però non c’è sofferenza perché
prevale il senso di dedizione, di missione se
vuole. Se in tutto questo provi anche una
profonda gioia, allora funziona. Anche perché il ritorno è clamoroso. L’importante è
che tutto questo non diventi una condivisione che ti mette alla pari con l’ammalato.
quante volte si vede
l’ammalato arreso e il medico
combattivo. Non va bene
Tu devi sempre rimanere altro. A un corso
per infermiere ho usato questa espressione:
“Non permettete all’ammalato di entrare
nel vostro letto, perché altrimenti si impadronirà di voi e non sarete più credibili.
Siate voi a entrare nel letto dell’ammalato”.
È fondamentale mantenere la propria alterità, non identificarsi, anche proprio per il
malato.
Il momento dell’identificazione, che può
sembrare il più alto nella nostra professio-
La cultura della cura
I Musicisti “colti”, interpreti della “grande
Musica” di Gian Andrea Lodovici, con questa
iniziativa sono entrati a pieno titolo nell’universo della malattia e della medicina, il pensiero nobile e alto di Alex Langer e dei suoi
epigoni oggi trova nuove corrispondenze culturali con DdM e con la medicina moderna.
Le parole nel segno delle quali si è sviluppata
la profonda intesa tra Musicisti e Medici sono
infatti proprio “cultura” e “armonia”.
Armonia non è solo un concetto musicale, basti pensare all’uso che se ne fa nella parlata
comune e alla sua derivazione etimologica.
Armonia può significare “riconciliazione degli
opposti, concerto di elementi diversi o anche
discordanti, in ogni ambito, anche quello del
corpo umano”. Per questo, oltre a “cultura”,
anche “armonia” può forse essere uno degli
elementi di collegamento non solo tra la medicina e DdM, ma anche tra queste e il pensiero
al quale si ispira la Fondazione Langer.
Anche attraverso esperienze come DdM, la
medicina del futuro, vorrei dire del presente,
persegue infatti l’armonizzazione tra Uomo e
ambiente, tra curato e curante in una dinamica di continui scambi di ruolo oltre la cristallizzazione dell’iconografia consueta di camici
e pigiami, ma soprattutto l'armonizzazione
tra l’Uomo e la malattia, in questo senso configurandosi come una pratica che si preoccupa
e occupa delle persone, sul confine indefinito
tra malattia e salute nel senso più ampio e
integrale di questi termini. L’esercizio della
medicina, in questa nuova relazione di cura,
si compie nel recupero di quella dimensione
umana e culturale che negli ultimi decenni
sembrava talvolta aver smarrito o relegato in
secondo piano. Il ritrovato concetto di cura,
richiamando il significato originario della parola (mi riferisco al mito), comprende in sé le
pratiche terapeutiche ma non si esaurisce in
esse. La cura così intesa, la cura globale della
persona, è un concetto trasversale, coinvolge
l’intera società umana, ed è evidente che la
8
medicina non può averne il monopolio, ma è
altrettanto chiaro che la pratica medica non
può più limitarsi all’esercizio della terapia.
La nuova medicina, quella che apre le porte
della cura, pur mantenendo la prerogativa
esclusiva dell’esercizio della terapia medica,
si propone quale protagonista nel gestire il
passaggio dalla tecnica della cura alla cultura della cura, per dirla con Dietrich von Engelhardt. Infatti l’acquisizione della dimensione culturale della sofferenza e della cura
è indispensabile per riuscire a intercettare i
bisogni emergenti degli ammalati, in particolare quelli oncologici, tenendo conto del fatto
che solo una parte di loro può oggi guarire, che
la persona guarita dal cancro esprime ancora
bisogni importanti per tutto il resto della propria vita e che coloro che non guariscono possono oggi vivere a lungo, presentando certamente importanti problematiche cliniche, ma
anche bisogni diversi, i quali devono pur’essi
trovare modo di esprimersi e di essere oggetto
di cura. Non si può ignorare tutto questo nel
contesto attuale, nel quale la transizione epidemiologica dalla prevalenza delle malattie
acute a favore di quelle croniche, degenerative, invalidanti, persistenti, è ormai compiuta. Una medicina che sappia rinnovarsi deve
interrogarsi sui modi possibili di intercettare
questo cambiamento, non depotenziando il
suo arsenale scientifico-tecnologico, ma divenendo una pratica più critica e consapevole,
partecipativa e aperta, inserita nel dibattito
culturale e non chiusa nella torre d’avorio
della scienza. Percorso difficile, ma forse indispensabile per riuscire a ricollegare un senso
a quella sofferenza che non può essere eliminata, ma anche a riconoscere al dolore le sue
dimensioni non biologiche.
Questo è il significato del passaggio dalla tecnica alla cultura della cura.
Claudio Graiff (Bolzano, 5 luglio 2013,
cerimonia di consegna del Premio)
ne, è quello in cui annulli il tuo ruolo perché
a quel punto il malato ha bisogno di qualcun
altro in grado di reggere il timone. Al di là
di tutti i discorsi che facciamo, l’ammalato
infatti spera anche di avere un buon timoniere, di andare nella giusta direzione.
Ovviamente, quando qualcosa va male c’è
dolore.
Quando un paziente mi dice di aver avuto
degli episodi di vomito, io per prima cosa
dico: “Mi dispiace”, e mi dispiace sinceramente. Però l’episodio negativo non deve
assumere il sapore della sconfitta. Non mi
piace l’immaginario bellico che ruota attorno al tumore, la “lotta”, la “vittoria”. Questa visione militaresca a volte diventa una
maniera di non condividere. Quante volte si
vede l’ammalato arreso e il medico combattivo. Non va bene. Noi non lottiamo contro le
malattie, noi lottiamo per noi. Il cancro non
è qualcosa di alieno, è una parte di noi.
Una volta, in caso di prognosi infausta,
i medici tendevano a parlarne con i familiari anziché con il malato. Oggi le
cose sono cambiate, ma molti medici,
nell’incapacità di gestire una comunicazione così delicata, finiscono per essere brutali o si rifugiano in formule
asettiche e poco chiare.
Diceva nel 1982 lo scrittore Norman Cousins: “Essere capaci di diagnosticare con
esattezza è una buona dimostrazione di
competenza medica. Essere capaci di dire al
malato ciò che egli deve sapere è una buona prova di arte medica”. La medicina resta
sempre una pratica dove l’arte individuale
si sovrappone alle conoscenze della scienza.
La medicina, pertanto, non è una scienza,
ma una pratica che coniuga appunto arte e
scienza.
Io non credo si possa insegnare la comunicazione, anche se la si può perfezionare, affinare. Dopodiché contano anche le qualità
individuali, perché le insidie sono forti. Da
un lato c’è l’inadeguatezza umana di ognuno di noi, che quando si trova a comunicare
cose così grandi come quelle che attengono
alla vita e alla morte dovrebbe aver risolto
i suoi problemi con la vita e con la morte.
Dall’altro c’è l’aspetto più deteriore che è la
tendenza alla deresponsabilizzazione, all’esercizio della medicina cosiddetta difensiva,
in cui l’informazione diventa lo strumento
per tutelarsi: “Tu sai quello che hai, io te
l’ho detto”.
Con l’aumentare della conflittualità che c’è
un po’ in tutti i settori, sta diventando un
approccio diffuso: ti dico come stanno le cose
e buonanotte. In quel momento non c’è più
alleanza, c’è contrapposizione. È un po’ come
quando si fa scegliere il malato mettendogli
davanti due foglietti: “Può fare l’intervento
chirurgico o una radioterapia, qui ci sono
tutti gli elementi per scegliere. Quando ha
deciso me lo dica”.
Questo succede sempre di più. E l’ammalato rimane lì: “Ma come, devo scegliere io?
Da solo?”. Li lasciamo sempre più soli questi ammalati. Però un po’ se la sono voluta
perché si parla sempre di etica e deontologia
medica ma... e l’etica del paziente? I pazienti sono sempre leali con i loro curanti? Ci
sono pazienti che sono anche sleali. Io vedo
sempre l’aspetto reciproco: è vero, i medici
devono fare questo, gli infermieri devono
fare quello, e i pazienti? Devono fare anche
loro la propria parte. Calma, ce n’è per tutti!
Ma torniamo alla sua domanda: come si dà
una cattiva notizia? Quando capita che una
persona arriva e mi dice: “Sto bene, però
mi sono accorto che da qualche giorno mi
è cresciuta una cosa...”, lui sa già cosa sta
succedendo, perché è stato operato, ne abbiamo parlato, spera di sentirsi dire che non
è niente, ma ha capito che non va bene e l’ho
capito anch’io. In quel momento cosa devo
fare? La pratica medica prevede che io dica:
“Adesso facciamo qualche accertamento e se
dovesse esserci qualcosa ci rivediamo”. Io
credo invece di poter tranquillamente manifestare il mio sgomento e la mia amarezza, far capire cioè che ci sono rimasto male
anch’io perché così è. Possiamo essere tristi
assieme. Dopodiché dirò: “Adesso le possibili strade gliele indico io”. Io ho il dovere di
intervenire con qualcosa di propositivo perché questo è il mio mestiere.
riuscire a instaurare un dialogo franco,
improntato sulla fiducia, può riuscire
a evitare i rischi di accanimento
I Donatori di Musica ci aiutano anche in
questo, perché avere una relazione forte,
consolidata anche dalla condivisione di quel
momento conviviale, permette di dar vita a
un’alleanza vera e di prendere delle decisioni più condivise nei momenti difficili. A quel
punto il “facciamo ancora qualcosa”, oppure
il “non facciamo più niente” diventano più
credibili. Il paziente non è così stupido da
pensare che qualunque esperto ne sappia
più di lui, in fondo non si parla solo del suo
cancro, si tratta di decidere anche della sua
vita. Riuscire a instaurare un dialogo franco, improntato sulla fiducia, può riuscire a
evitare i rischi di accanimento.
L’accanimento è qualcosa che nasce con un
fine positivo, quello di non chiudere una porta, ma che poi degenera a causa di una valutazione errata. Qui non si parla ovviamente
della macchina, dei tubi, dell’accanimento
del rianimatore.
Io definisco l’accanimento in oncologia come
il perseguimento di un bene parziale dell’individuo a scapito del suo bene complessivo.
Tu valuti gli aspetti che ti sembrano importanti, ma non necessariamente lo sono
anche per il paziente, così, perseguendo un
bene parziale, alla fine rischi di essere di
danno alla persona.
Faccio un esempio banale. Mettiamo che mi
portino una persona immobilizzata sul letto
per dolori intensi legati a metastasi ossee;
una persona che ha solo il dolore come sintomo. Ora, io so che non si può modificare
l’aspettativa di vita e che, però, esistono
diverse terapie che possono dargli sollievo. Gli prescrivo una chemioterapia o una
radioterapia che sortisce un ottimo effetto.
Dopo un mese la persona si muove. Il medico è soddisfatto: “Ma questo è un risultato
splendido!”. Ebbene, l’ammalato potrebbe
rispondere: “Si sono molto contento” e allora
avremmo centrato l’obiettivo.
Ma l’ammalato potrebbe anche dire: “Dottore, se lei mi chiede se ho dolore, le devo
dire di no, ma va peggio tutto il resto: ho
perso tutti i capelli, non riesco a farmi vedere da nessuno, non mi guardo neanche allo
specchio. Poi sono così debole, ho sempre la
nausea, episodi di vomito, le gambe gonfie.
Insomma, se mi chiede se la mia vita è migliorata non so cosa rispondere, non vorrei
che fosse addirittura peggiorata”.
Ecco, io con questa persona ho fatto un atto
di accanimento perché avevo un’alternativa. Sarebbe stata più opportuna una terapia antidolorifica. L’accanimento moderno è
quello di scegliere lo strumento che non è
il più idoneo. Ma la scelta dello strumento
più idoneo viene anche dal conoscersi, dal
parlarsi.
Grazie alle nuove cure, il cancro è diventato sempre più una malattia cronica.
Non c’è dubbio che i trattamenti oggi disponibili consentono di controllare la malattia.
Il cancro è come il diabete, l’ipertensione,
le cardiopatie. È una malattia cronica. Tra
l’altro ha una forte probabilità di guarigione, mediamente circa il 60%, quindi paradossalmente è una delle più guaribili tra le
malattie croniche. Perché (almeno per ora)
non si guarisce dalla bronchite cronica, dal
diabete o da una malattia neurologica, mentre di tumore si guarisce.
Certo, se non si guarisce, è una malattia
cronica caratterizzata, da un lato, da una
particolare durezza degli atti terapeutici
e, dall’altro, da quest’aura quasi metafisica che ha assunto per cui sembra sia la più
brutta malattia del mondo.
Ora, proprio perché il percorso è lungo, per
me l’importante è saper gestire questa situazione ricordando sempre che noi non
dobbiamo curare la malattia, ma l’ammalato. Quindi anche gli strumenti e le terapie
che via via adotteremo saranno scelti assieme all’ammalato.
Avete avuto anche manifestazioni di solidarietà inattese...
Poco dopo l’inizio della stagione ricevo
una telefonata: “Buongiorno, sono Roberto
Furcht”. Conoscevo quel nome, Furcht è un
importante grossista di pianoforti e una persona con una grandissima competenza musicale spesso coinvolta in giurie di concorsi.
Mi dice: “Siete sicuri di avere uno strumento
idoneo per i vostri concerti?”. Effettivamente c’era un pianoforte verticale lasciato all’ospedale, non uno strumento da concerto.
il cancro, paradossalmente,
è una delle più guaribili tra
le malattie croniche
Rispondo: “Facciamo quello che possiamo”.
“Mi dica un po’, si offenderebbe se mandassi
un pianoforte?”. Insomma, per farla breve,
ci fornisce un pianoforte in comodato d’uso
che tuttora è lì e che io spero piano piano di
riuscire a comperare.
Perché vuole comprare il pianoforte?
Perché prima della mia pensione vorrei riuscire a lasciare questo strumento con il numero di inventario.
Furcht ha fatto capire che per lui è donato,
però non è la stessa cosa: fino a quando non
sarà di proprietà dell’azienda sanitaria, rimarrà una cosa che non è censita da nessuna parte, che oggi c’è e domani non c’è più...
Se invece diventa di proprietà dell’ospedale,
chi verrà dopo di me, se non lo vuole dovrà
farlo scaricare dall’inventario, insomma dovrà marcare una discontinuità. Ecco perché
ci vogliamo mettere la targhetta. La targhetta significa che è inventariato, che è
una delle “apparecchiature” del reparto.
(a cura di Barbara Bertoncin e Edi Rabini,
Una città n° 200, febbraio 2013)
9
Un pubblico speciale
Una passione per la musica nata da bambino, l’incontro con Gian Andrea Lodovici, la sua intuizione su Mendelssohn e
quell’invito ad andare in ospedale, ma non a trovarlo, bensì a fare un concerto... Intervista a Roberto Prosseda.
Roberto Prosseda, pianista, è noto soprattutto
per le incisioni dedicate a musiche inedite
di Felix Mendelssohn. È presidente del Comitato artistico dei Donatori di Musica.
Da dove viene la tua passione per la
musica?
Mio padre, che è mancato nel 2010, era un
insegnante di inglese, molto appassionato
di musica, quindi a casa c’erano molti strumenti, che io fin da piccolo avevo considerato un po’ dei giocattoli. Il più grande era il
pianoforte, quindi quello che mi attraeva di
più. Ecco, il mio rapporto con il pianoforte
è cominciato cercando di piallargli un angolo con una pialla giocattolo che mi avevano
regalato. Non sono neanche stato rimproverato; anzi, l’idea che questo pianoforte
avesse attratto la mia attenzione -anche se
non esattamente come i miei genitori speravano- è stata presa positivamente. Ma non
sono mai stato forzato a suonarlo. Da solo
ho scoperto le note; come tanti bambini che
hanno un buon orecchio riuscivo a riprodurre delle melodie, delle canzoncine. Ho imparato a scrivere la musica prima di imparare
a scrivere le lettere. Sono stato fortunato
da questo punto di vista, perché non è stata
una difficoltà. Molto spontaneamente e gradualmente ho capito che poteva diventare
la mia attività principale -non voglio dire
professione, perché sarebbe riduttivo. Noi
musicisti abbiamo questa fortuna di unire
la passione con ciò che dobbiamo fare per
vivere.
A posteriori dico che per me è stato importante fare concorsi senza vincerli. Non ho
mai vinto un primo premio in un concorso molto importante; questo mi ha spinto
a cercare il motivo vero del perché faccio
musica e a scoprire che il senso per me sta
nello spirito della condivisione. La condivisione è centrale nella mia ricerca; condivisione per me vuol dire comunicare le cose
belle che scopriamo grazie alla musica. La
musica esiste quando viene vissuta insieme, quando diventa occasione di scambio, il
che, per accadere, necessita evidentemente
di almeno due persone; questa dimensione
dello scambio può avvenire in un concerto,
quando si parla di musica, in una lezione tra
insegnante e allievo; per me avviene soprattutto nei concerti dei Donatori di Musica.
All’origine del tuo rapporto con i Donatori di Musica c’è l’incontro con Gian
Andrea Lodovici.
Proprio nel momento in cui avevo deciso di
non fare più concorsi, avendo capito che non
era quella la mia strada, ho incontrato Lodovici. Parliamo del 2002-2003: l’occasione
fu un disco di musiche di Muzio Clementi
prodotto per la Arts, l’incisione completa degli studi per pianoforte “Gradus ad Parnassum”. Io ero uno dei dieci pianisti coinvolti
e così, grazie a questa operazione, lo conobbi e poi rimanemmo in contatto per lo più
10
telefonicamente. Ogni tanto lo chiamavo:
avevo capito che a lui piaceva condividere
le sue riflessioni con giovani artisti; per me
era un privilegio, visto che da lui c’era molto da imparare. In una di queste telefonate,
mi disse: “Secondo me, potresti dedicarti a
Mendelssohn”. Io, all’epoca, lo consideravo
un autore abbastanza noioso, scomodo da
suonare. Gli risposi: “Ma Mendelssohn non
lo suona nessuno, è difficile, accademico...”.
Lui aveva insistito: “Ma no, guarda che ci
sono delle cose interessanti, degli inediti...”.
Alla parola “inedito” mi si è accesa una scintilla. Ho sempre avuto la passione di fare
qualcosa che avesse un minimo di utilità,
diciamo così. Spesso noi musicisti classici
siamo molto autoreferenziali e tendiamo a
fare ciò che già si fa: non solo a riprodurre
musica preesistente, che è ovvio, ma anche
interpretazioni preesistenti. Avevo proprio
voglia di fare qualcosa di non preesistente
e, avendo saputo che c’erano degli inediti,
mi sono messo alla caccia. Lodovici non mi
aveva detto molto di più, ma mi aveva dato
qualche dritta, quasi come in una caccia al
tesoro. Da lì sono riuscito, grazie all’aiuto
suo e di altri musicisti e musicologi, a trovare dei manoscritti e quindi anche gli stimoli
per seguirli, studiarli. Una cosa che spero
ci sia sempre nel mio percorso è proprio
questa gioia della scoperta. La musica va
riscoperta continuamente. Pensiamo a cosa
dev’essere stata la prima esecuzione di una
sonata di Beethoven! Sarebbe bello anche
oggi riproporre quell’atmosfera di sorpresa,
entusiasmo, o anche delusione: insomma,
che il pubblico non sappia già cosa ascolterà
e come verrà suonato.
Comunque è stato così che ho conosciuto Lodovici.
Poi lui si ammalò. Quando capì la gravità
del tumore, mandò una lettera a tutti gli
amici, una lettera di addio. Era la primavera del 2007 e lo scritto suonava più o meno
così: cari amici, vi saluto, adesso io sparisco,
mi mancano pochi mesi, non ho speranze di
guarigione... Insomma, un congedo, anche
piuttosto triste. Dopo due mesi venne ricoverato in Oncologia a Carrara.
Lì successe qualcosa. Il primario, Maurizio
Cantore, gli chiese: “Cosa fai nella vita?”, e
lui: “Facevo il produttore discografico, organizzavo concerti...”. “No, non facevi, fai,
mica sei morto”. “Eh, ma ormai sono qui,
cosa posso fare?”. “Puoi organizzare una stagione di concerti in reparto!”.
La cosa è nata così. Dopodiché Gian Andrea
chiamò me e mia moglie chiedendo se avevamo voglia di andare in ospedale e noi: “Certo, veniamo a trovarti”. “No, no, intendevo
a suonare, a fare un concerto”. E così andammo e suonammo, proprio della musica
di Mendelssohn, tra l’altro. Suonai anche un
inedito di Mendelssohn in prima esecuzione
mondiale. Per dieci pazienti!
Noi capimmo molte cose in quel concerto,
così come nei successivi: cioè che lì veramente vai al cuore della musica e del senso che
ha per noi dedicare la vita alla musica, che
è appunto di suonare per gli altri. Quando
suoni per dei pazienti, alcuni dei quali probabilmente non ascolteranno altri concerti,
evidentemente cambia anche l’approccio. Lì
la musica diventa davvero un dono reciproco.
Donatori di Musica è nato così, quando alcuni di noi, che erano andati ai primi concerti, ma anche i pazienti e gli stessi dottori,
si resero conto che attorno a quel concerto
succedeva qualcosa di magico: non era un
concerto come un altro, non era neanche
un’attività ricreativa per distrarli. Un concerto, infatti, facilmente ti porta a riflettere
su questioni esistenziali, anche sulla morte.
Non è vietato suonare una marcia funebre.
In generale i pazienti non dicono molto. Sicuramente si avverte della gratitudine. Una
riconoscenza che è reciproca. Ovviamente
che il concerto si tenga in un ospedale resta
una cosa abbastanza spiazzante e insolita.
suonai anche un inedito
di Mendelssohn in prima esecuzione
mondiale. Per dieci pazienti!
Quanto a quel pubblico così speciale, da un
lato verrebbe da dire che è veramente un
pubblico ideale, ma, per certi versi, non lo
è affatto, perché non ti mette a tuo agio,
nel senso che ti carica di grandi responsabilità suscitando un senso di impotenza, di
frustrazione: cosa posso fare per loro? Però
ti aiuta anche a dare le giuste priorità alle
cose. Avere l’occasione di parlare con queste
persone che magari proprio nella sofferenza
hanno trovato una felicità... è un grande stimolo, un privilegio.
State discutendo su come allargare
questa esperienza ad altri luoghi di
cura...
Ci stiamo interrogando su come far sì che
le stagioni di Donatori di Musica possano
essere presenti anche in altri ospedali, preservando però le caratteristiche peculiari di
questa esperienza. Il rischio è che rimanga
l’involucro, il contenitore, e vengano meno
i principi, la sostanza. Oggi sono coinvolti
sette ospedali e vorremmo che diventasse
qualcosa di più stabile, strutturato.
Intanto abbiamo creato un piccolo comitato
artistico per selezionare i musicisti dal punto di vista musicale ma anche umano. Esiste
anche un protocollo medico che indica le varie fasi necessarie affinché un ospedale possa chiedere di far parte di Donatori di Musica. Ci vuole intanto una richiesta da parte
dell’ospedale. Non è giusto andare a bussare
alla porta, chiedere a un ospedale di poter
ospitare una stagione. È qualcosa che deve
nascere da un bisogno sentito. La richiesta
deve essere sottoscritta anche dal direttore
sanitario: abbiamo sperimentato che non
basta la buona volontà del singolo per far
funzionare il tutto. Senza l’appoggio anche
formale e ufficiale della struttura si rischia
di creare conflitti, anziché armonizzare.
È importante far capire che i concerti di Donatori di Musica non sono solo concerti negli
ospedali, ma qualcosa di più. Il concerto è
una leva, un’occasione per provare a cambiare i rapporti tra le persone.
I concerti di Donatori di Musica hanno luogo dove c’è già un’eccellenza nell’attenzione
alle persone, nel rapporto tra medici e infermieri con i pazienti. Se tutto questo non
c’è, evidentemente si può lavorare per predisporlo; in questo senso, conoscere Donatori
di Musica può essere forse uno sprone, un
pretesto per iniziare a cambiare le cose. È
importante che chi viene a conoscere l’esperienza di Donatori di Musica capisca esattamente di cosa si tratta: è un progetto che
porta i medici e gli operatori sanitari a mettersi in discussione. Alcuni, quando capiscono questo, tornano indietro.
A volte ci sono pure dei problemi pratici: in
alcuni ospedali l’esperimento si è concluso
perché gli infermieri non volevano fare gli
straordinari, o perché il primario non voleva che l’accesso al reparto ai familiari fosse
prolungato oltre l’orario, cosa che invece il
concerto presuppone.
È chiaro che Donatori di Musica va un po’ a
invadere degli spazi, a creare “scompiglio”.
Per questo è fondamentale che ci sia un’unità di intenti. Quando i concerti di Donatori di Musica entrano in un ospedale, succede qualcosa... Dovreste vedere il reparto
di Maurizio Cantore a Carrara. Non è più
un reparto, è un centro culturale! Ci sono
mostre fotografiche, corsi di pittura, di recitazione, letture di poesie. È un reparto
aperto a tutti, anche visivamente è un luogo
ospitale, è tutto colorato, non c’è una parete
bianca, non c’è puzza di medicinali, non c’è
l’odore dell’ospedale. C’è anche un giardino,
perché una volta c’è stato un giardiniere a
curarsi e Maurizio Cantore, come al solito,
gli ha chiesto: “Cosa fai?”, e alla risposta canonica: “Facevo il giardiniere...”, non se l’è
fatto ripetere: “No, lo fai ancora!”, “E dove?”.
“Qui!”. È un reparto impresso dalla presenza delle persone che ci sono passate perché
ognuno ha lasciato qualcosa.
Gli altri musicisti che coinvolgete come
reagiscono?
Quasi tutti dopo la prima volta ringraziano.
Ovviamente quando metti piede in un ospedale vedi barelle, persone tristi e pensi che
può accadere anche a te, quindi l’impatto è
sempre un po’ difficile. Quando però arrivi in reparto, nel luogo del concerto... beh,
già vedere un pianoforte in un day hospital
è qualcosa che apre il cuore. Noi poi siamo
sempre accolti molto bene.
Sarebbe bello che tutti fossero accolti come
veniamo accolti noi. Per me è sempre una
festa. Cosa che spesso non succede quando
vai a suonare in qualche teatro, dove magari se chiedi di entrare mezz’ora prima per
studiare storcono il naso... Dipende sempre
dallo spirito con cui fai le cose. Ai concerti dei Donatori di Musica, ci sono anche gli
“imbucati”.
nei grandi ospedali ci sono maggiori
problemi di gestione. Le stagioni attive
adesso sono in ospedali piccoli
A Carrara succede spesso che musicisti che
abitano in zona, che magari hanno già suonato, abbiano piacere a tornare. Io sono tra
questi. Ma quel che è più importante è che
tornano anche gli ex malati o i familiari del
paziente che non c’è più; alcuni tornano per
tenere in vita il ricordo, altri forse per essere parte attiva di una cosa bella. Spesso a
Carrara le torte che vengono servite dopo il
concerto le fanno le signore che magari han-
no avuto l’intervento al seno qualche anno
prima. C’è anche l’ex paziente che viene per
dire agli altri malati: “Guardate, io sto bene,
potete tornare a star bene anche voi”.
I musicisti comunque rimangono contenti e
colpiti e subito dicono: “Io sono disponibile
a farne altri”. Sono situazioni in cui tutti
ringraziano tutti. È curioso, fa anche sorridere. All’inizio, quando non c’era un gruppo
consolidato, alcuni li invitavo io, ma ho visto
che l’invito forzato non funziona. I musicisti che davvero si affezionano all’esperienza
sono quelli che si sono fatti avanti spontaneamente.
Adesso c’è una lista d’attesa di oltre quattrocento richieste! E siamo già in oltre cento ad
aver tenuto almeno un concerto. Calcolando
che ci sono sette stagioni attive, siamo già
quasi troppi. Sarebbe bello che aumentassero le stagioni, quindi gli ospedali, così da
coinvolgere anche altri musicisti. Stiamo
tentando di sondare anche al Sud. Abbiamo organizzato un concerto all’ospedale
Garibaldi di Catania per far conoscere alla
cittadinanza questa esperienza. È venuto
proprio Martin Berkofsky. Negli ospedali
grandi ci sono maggiori problemi di gestione. Non a caso le stagioni attive adesso sono
in ospedali piccoli, di provincia, dove forse è
più facile superare certi intoppi burocratici,
c’è più autonomia e spesso c’è anche l’eccellenza.
È chiaro che in un ospedale dove bisogna
aspettare un anno per fare un esame e i
medici sono pochi, sottopagati, con contratti
precari, è difficile che un progetto del genere
possa attecchire. Ma nulla è impossibile. A
Brescia, a curare la stagione, è Mauro Tagliani, uno psico-oncologo con un contratto
a termine, che a volte paga di tasca propria
per proseguire Donatori di Musica!
(a cura di Barbara Bertoncin e Edi Rabini)
11
Giorgio De Martino
Per una storia dei Donatori di Musica
Uno: questa storia vuole poche parole.
Due: le parole sono medicine, dunque, potenzialmente, veleno.
Tre: la documentazione abbonda, le testimonianze pure, tante morti, tante vite... Farne
un reportage equivarrebbe a fallire.
Quattro: qui la prosa è perdente, gli aggettivi appestano, solo la poesia, senza vergogna,
avrebbe la forza di dire ciò che col resto suonerebbe maldestro: in rima persino, senza
vergogna, anche se per certo è strada non
percorribile, per ovvi motivi.
Cinque: la retorica in questa storia è più
d’un rischio, è una disastrosa eventualità,
una criminale deriva (ecco: “criminale deriva”, il puzzo di retorica già fa capolino),
ed è un attimo svoltarcisi dentro bel bello;
un barocchismo può far vomitare più della
“chemio”.
Sei: sono attratto dall’opzione di scorta e la
tengo idealmente davanti al foglio elettronico bianco: quella che nessuno è indispensabile, che improrogabili impegni, che magari il
prossimo anno, che perdio lasciatemi in pace.
Suona il telefono rispondo sdraiato, ignaro
della tegola che mentre squilla s’è già staccata ed è in volo, e io sotto. È l’amico editore,
e col vivavoce c’è pure il fratello più grande,
parimenti editore e amico. Fanno un nome
che ho letto più volte, sulla rivista che fanno, la stessa alla quale collaboro da una dozzina di anni.
Il nome è quello di Gian Andrea Lodovici,
morto di cancro nel 2009. E riassumono in
qualche minuto l’avventura d’un uomo che
è vissuto di musica fino all’ultimo istante.
E l’avventura inizia, nella sua parte che ci
riguarda, quando sembra finita. Perché sfinito -svuotato, sfibrato- sulla poltroncina
dello studio del primario di Oncologia, al
quarto piano dell’ospedale civico di Carrara,
quest’uomo s’innamora della strana allegra,
euforica, eccentrica poesia per la vita che
scorre in reparto e di ciò che chiede avidamente e giustamente questo reparto, musica di qualità, arte.
Un luogo dove ogni paziente è un compagno
d’avventura, dove in ogni manciata di letti
c’era il desiderio di un pianoforte (e oggi ce ne
sono ben tre), dove le pareti trasudano musica e ovunque si posino gli occhi ci sono porte
aperte e colori e fotografie in bianco e nero,
dove i pigiami son bestie rare e all’inverso è
una staffetta continua di sorrisi e di indaffaratissimi amici. Dove le barriere le vedi
perché cadono, e nuove emozioni, relazioni,
rivoluzioni, quotidianamente fioriscono.
Un posto d’altronde, dove si pretende di curare cosachessia, o è “casa” o è l’inferno: e
oncologia, persino nel nome, già puzza di
zolfo. Non a Carrara, però. Non a Bolzano,
non a Brescia, Saronno, Sondrio, Vicenza.
Ma è da Carrara, dove l’idea era semenza
e Lodovici la terra che l’ha germogliata, a
Carrara, “casa” casa seppure amara, languida, casa amata di chi l’ha percorsa, casa di
vetro con le macchinette per il caffè e la vista sul mare lontano, sotto le cime innevate
12
dal marmo... È a Carrara che avrei dovuto
andare, per conoscere, intervistare, annotare, sbobinare.
C’è un primario mi dicono, c’è Cantore (Maurizio) e il suo vice Mambrini (Andrea), che
sono la corrente a due e venti che illumina
quel quarto piano con vista mare. Il tutto,
da avvicinare, per farne una storia.
Grazie alla rivoluzione relazionale di Cantore e Mambrini e degli altri colleghi, rivoluzione che comprende la musica e l’opera
dei Donatori di Musica (perché la musica è
il grimaldello che spacca i chiavistelli della
Bastiglia, in questa rivoluzione), in oncologia da qualche parte è stato certo nascosto
un “acceleratore di emotività”, un intensificatore di passioni, meraviglioso e parimenti faticoso, perché non prevede distrazioni.
Qui la penna che disegna la vita, del paziente ma anche dei medici, degli operatori, dei
familiari e dei volontari, preme sul foglio
lasciando una traccia forte, netta, inequivocabile d’inchiostro e la vita acquista una
nuova coscienza di sé: non sfugge, anzi si
sente il suo misterioso, miracoloso procedere, istante dopo istante.
Al quarto piano dell’ospedale di Carrara,
capita di ascoltare una volontaria-paziente
dire: “Quando morirò mio marito è già d’accordo con Maurizio, andranno insieme a festeggiare, col vestito elegante, usciranno a
mangiare una pizza”. E per com’era detta,
era una frase onesta e gioiosa, senza retrogusti, senza aggressività, senza la mascherata volontà d’esorcizzare alcunché.
Qui che il tempo si accorcia, e la tentazione
è guardare indietro e difendersi dalla fine
più o meno imminente negando il futuro,
qui sembra misteriosamente che sia -per
ciascuno- una startup rampante per una
nuova percezione dell’esistenza.
A volte, l’energia che si respira in oncologia,
tra le macchinette del caffè e le foto appese,
i pianoforti e la vista mare e la finta neve di
marmo, si fa irrespirabile. Perché, a raccontarla con una banalità a effetto (ma vera),
in quella corsia ci si ammala perdutamente
della vita: un amore travolgente, letterario,
di quelli d’una volta, dove è l’intensità che
conta e non l’inutile privilegio di molti calendari da trascorrere insieme, distrattamente.
Qui una stretta di mano è una promessa, un
bacio sulla guancia significa che si mette in
atto uno scambio chimico, di quelli che fan
saltare le provette.
Ecco perché, dopo il primo bacio sulla guancia, non ho più potuto, e mi son dovuto astenere, dall’offrire questo casto saluto alla
volontaria psicologa che in camice bianco
sorride e ascolta gli ospiti ricoverati in reparto.
Giorgio De Martino, giornalista e critico musicale,
sta lavorando alla pubblicazione di un libro divulgativo che racconti l’esperienza dei Donatori di Musica,
frutto di un’idea e di una sfida lanciata dai fratelli
Zecchini, editori di “Musica”, Per questo quaderno ci
ha gentilmente messo a disposizione un breve estratto, tratto dal primo capitolo del volume.
La musica innamorata
Alcuni mesi fa, una zia di mio padre,
novantenne e ammalata gravemente
di tumore, espresse il desiderio di
vedermi e di sentirmi suonare. Amava
tanto la musica, il pianoforte, e lei era
poco più che moribonda e trafitta da
dolori indicibili. Eppure voleva ascoltare
musica, ma non una musica qualsiasi,
la musica suonata da me. Non ho
compreso il messaggio d’amore che mi
stava porgendo. Mi sono recato nella sua
villetta e ho suonato il suo pianoforte.
Uno, due, tre brani. Ma invece di stare
in quella relazione d’amore, sapete dove
scappavano i miei pensieri? Mi ritrovavo
a pensare che quello strumento era un
orrore. Tutto scordato, con i tasti che
spesso non tornavano più neanche al
loro posto, insomma, una schifezza di
strumento, immaginate l’esecuzione. E
quasi mi vergognavo di suonare. E non
ho pensato che lei, in quel momento
supremo della sua vita, in quegli ultimi
suoi giorni, voleva ascoltare una musica
innamorata, non una musica perfetta.
che forse io, con le mie paure inutili
da musicista perbenista non ho saputo
donarle. In quel momento il mio cuore
non era certamente pervaso da quello
sguardo innamorato che il mio amico
Cantore mi aveva trasmesso. Insomma,
in me il sentimento dell’istituzione e del
palcoscenico, le smanie di perfezione
avevano inquinato quel “qualcosa di
bello” al quale ero stato chiamato. Ora
ho capito che non ho amato abbastanza
quell’attimo di vita.
(Stefano)
Solo un lampo
Caro Maurizio, l’esperienza di ieri è stata
davvero emozionante. Concordiamo sul
fatto che è superfluo ringraziare, da ambo
le parti, ma credo sia invece importante
trasmetterci con forza l’entusiasmo di
condividere un così grande progetto.
L’obiettivo ci era chiaro -portare la
gioia della musica- ma la sorpresa è
stata comunque grande. Sorpresa di
scoprire come un ospedale, sempre
pensato come luogo della sofferenza,
possa farsi anche luogo dell’accoglienza.
Sorpresa di scoprire che i medici non
sono necessariamente dall’altra parte,
ma possono essere da questa parte.
Sorpresa di scoprire che le persone
sofferenti riescono non soltanto ad
ascoltare la musica, ma attraverso questa
anche a ricompattare il proprio corpo
con il proprio animo. Sorpresa, per noi
esecutori, di scoprire noi stessi non tanto
come semplici vettori di comunicazione,
ma come possibili disvelatori di trame
interiori, e da ultimo come amici.
L’ultima sorpresa è proprio questa: come
si possa creare, sulla base di un incontro,
un’immediata atmosfera di amicizia. Per
voi che “restate sul campo” le relazioni si
prolungano e si arricchiscono; ma anche
noi, che rappresentiamo solo un “lampo”,
abbiamo l’occasione di partecipare a
questo grande scambio di umanità.
(Mara)
Antonio Osnato
La musica Creatrice
Ovunque e sempre l’uomo si è espresso con
la musica, ha creato musica. La musica è
una vibrazione che penetra direttamente
nelle cellule, le stimola, le invita a rispondere con la matrice sonora dell’armonia della
vita.
Esistono numerosi livelli, valori e qualità di
musica che corrispondono alle dimensioni
interiori individuali vissute, percepite e poi
portate in atto dai compositori.
A ogni musica corrisponde una valenza qualitativa di chi l’ha composta. Potremmo definire questa nostra società monocorde. La
società omologata, la voce monocorde dell’umanità, fa comodo e gioco a chi manovra la
stanza dei bottoni da cui partono le direttive
sui destini del genere umano. L’omologazione, l’appiattimento degli individui, la globalizzazione dei consumi e del pensiero, rappresentano un insulto al suono della vita.
Omologare un individuo significa far tacere
una nota umana preziosa, significa produrre non più un suono, ma un rumore superficiale.
Daniel Levy osservò: “Esistono miliardi di
suoni in un unico Suono, che ci sfiorano soltanto, perché non trovano che gabbie dentro
le quali sta chi si è quasi volontariamente
creato un destino”. Da sempre l’essere umano ha nutrito la sua anima con la musica. Attraverso la musica da sempre viaggiano sentimenti e stati d’animo. Occorre distinguere
la musica udita dalla musica ascoltata.
La prima è quella che andrebbe definita
baccano, che imperversa nei supermercati,
nei locali pubblici o nelle case dove il rumore
televisivo travalica ogni parete. La musica
ascoltata è quella dei concerti, quella che si
sceglie e si ascolta nel silenzio della propria
casa. L’ascolto della musica vera fa parte
del risultato di un’educazione a vivere, a
percepire, a coltivare la propria interiorità,
a non perdere il contatto tra noi e il nostro
suono di provenienza.
La musica ha avuto da sempre una proprietà
terapeutica. L’ascolto dei suoni adatti serve
a riequilibrare le diverse dimensioni energetiche della persona che ascolta. La musica diviene una vera e propria cura, perché
permette il ripristino di uno stato di salute
dell’anima che si riflette anche sul corpo.
è parecchio interessante osservare le proprietà vibratorie ed energetiche del suono: il
suono è vibrazione che provoca una risposta
della materia che viene colpita e che può addirittura modificare la sua forma.
A uno scultore fu chiesto in che modo si predisponesse prima di iniziare un’opera ed egli
così rispose: “Prima di metter mano ai ferri
guardo e riguardo la materia, le do una bottarella, cerco di afferrare il canto che esce da
quel sasso!”. Solo la sensibilità di un artista
poteva esprimersi così: “Il canto che esce dal
sasso!”. Ogni espressione della natura ha in
sé un canto, un suono individuale. Qualunque oggetto, qualunque sostanza materiale,
se sollecitata, rimanda una voce: la sua voce.
Gli strumenti musicali sono nati nel tempo
dall’osservazione della risposta sonora che
era possibile ottenere cambiando forme e
qualità di materia degli oggetti. Ogni oggetto ha una voce, una tonalità sua propria che
varia con la qualità della sostanza di cui è
composta, con la sua densità e forma.
Ogni oggetto è vivo e non inerte come a noi
sembra. Non esiste nulla di inerte. Esistono
oggetti fermi, privi di moto proprio, ma non
di voce, quindi di vita. Noi non ci accorgiamo che la realtà è ondulatoria, ogni cosa si
definisce dalla sua vibrazione specifica, cioè
dal suo ritmo animatore; l’essenza delle cose
è la loro musica. Il musicista la coglie e la riproduce, dunque tutto nasce, ha origine dal
l’elemento primordiale comune a tutti i fenomeni cosmici. Soltanto la quantità e l’intensità del suono primordiale varia di caso
in caso. Secondo i riferimenti delle antiche
cosmologie, il mondo avrebbe avuto origine
da una parola creatrice, sarebbe cioè stato
creato per mezzo di un ritmo sonoro che scaturì dal centro dell’universo. Questo suono
fu il primo sacrificio, il primo atto evocativo.
Suono, rito e ritmo sono identiche espressioni della fonte della vita e non a caso spesso
viaggiano insieme. La vita si esprime con il
movimento e la legge del moto è il ritmo. Il
ritmo consente alla vita di scandire il suo
esprimersi armonioso, di darle un tempo e
una sonorità.
suono ed è in ultima analisi timbro e ritmo.
Gli archetipi, cioè le forme essenziali della
realtà sono i timbri-ritmi fondamentali. La
fusione dell’udito e della vista dagli antichi
cinesi veniva definita luce degli orecchi. Per
le culture superiori orientali e per la mistica medievale europea questa fusione era
conosciuta; ma l’uomo moderno ha una percezione minima e superficiale della grande
imperscrutabilità del mondo acustico, la
policromia, la poliritmia e la forza lineare
del suono, da cui le antiche leggende cosmogoniche facevano procedere il mondo visibile
e tangibile.
Della musica nascosta nella natura parla
la mistica spagnola. Secondo Giovanni della Croce, non soltanto i fiumi risonanti e il
sibilare del vento, ma anche la musica non
udita sono una manifestazione della voce di
Dio che giunge nella profondità dell’anima.
Secondo l’antica concezione indiana, anche
nella pura materia il vero e proprio substrato è, e rimane, acustico. Il suono costituisce
Ogni stagione ha il suo suono. C’è il suono
pacato e dolcissimo dell’autunno, uno caldo
e avvolgente dell’estate, uno sommesso e discreto dell’inverno. Vivaldi si è sforzato di
riportare tutto ciò alle orecchie umane con le
sue famose “Quattro stagioni”. Nella natura
esistono suoni udibili dalle orecchie umane
e suoni percepibili nel silenzio dell’anima.
Ma la più semplice e nello stesso tempo la
più grande scoperta che possiamo fare nel
tempo è quella di avere la consapevolezza
che noi siamo strumento, musicista, accordatore e musica stessa. Noi siamo gli interpreti, i direttori d’orchestra, il coro e la voce
solista. Noi possiamo ri-suonare il suono
della vita in modo meraviglioso o violentare
questo stesso suono creando rumore e confusione che offendono l’armonia della vita.
(Per gentile concessione del poeta e magistrato
siciliano Antonio Osnato.
Tratto dal libro Silenzio, rumore, suono,
Carlo Saladino editore, 2010)
13
Era il segno che avevo reagito
La scoperta per caso, dopo una caduta e un’ecografia, di avere un cancro forse fatale; le operazioni, la chemio forte, la voglia
di vivere, l’angoscia che rimane... Intervista a Roberto Dall’Olio.
Roberto Dall’Olio, insegnante, vive a Bentivoglio, Bologna. Sull’esperienza della malattia ha pubblicato una raccolta di poesie
Per questo sono rinato, Pendragon, 2005.
Mi sono ammalato di tumore nel marzo del
1995, avevo 30 anni. All’epoca lavoravo in
Trentino, facevo supplenze piuttosto lunghe
come insegnante e quindi risiedevo là. Un
pomeriggio, con colleghi e tecnici, avevamo
pensato di andare a sciare. Era una giornata piuttosto grigia ed era nevicato di fresco,
la pista era vuota e così abbiamo deciso di
fare una gara. Loro ovviamente erano più
bravi di me e io, non so, devo aver spinto un
po’ troppo e lì ho sentito un dolore che, secondo me, era all’inguine. Ho pensato fosse
uno strappo, uno stiramento. Qualche giorno dopo, all’indomani di un’altra nevicata,
siamo andati a Madonna di Campiglio. La
sera a cena ero nel parcheggio della baita,
c’erano due signori di Genova che non riuscivano a muovere la macchina, allora con
un collega ci siamo messi a spingere. Insomma, spingi spingi, la macchina è riuscita a partire, ma io sono scivolato di netto e
sono caduto a 180 gradi, piatto, sul ghiaccio,
sbattendo dappertutto. La notte ho fatto fatica a dormire dal mal di schiena e anche il
giorno dopo è stato segnato dal dolore, tra
l’altro mi sono accorto che mi si era gonfiato
un testicolo. Ho pensato fosse stata la botta,
però il dolore alla schiena mi preoccupava.
A quel punto ho pregato il padrone di casa
da cui ero in affitto di farmi visitare dal suo
medico, anche se non ero un suo mutuato.
Dai primi esami non risultava nulla, ma
io ho insistito per fare anche un’ecografia.
L’ecografo mi ha diagnosticato il tumore,
l’ha visto subito. Ero all’ospedale di Tione,
in provincia di Trento, mi ha detto: “Guardi, questa è una cosa abbastanza grave,
secondo me, però io non le so dire di più”.
Così sono tornato a Bologna per fare una
visita specialistica e lì il responso si è ulteriormente precisato: “Questo è sicuramente
un carcinoma”. In pochi giorni, intanto, ero
già molto peggiorato. Il medico lì per lì l’ha
messa sulle battute: “Lei non ha le pantofole, quindi aspettiamo il fine settimana, però
entra lunedì”. E poi quella frase: “Si ricordi
che di queste cose si può anche guarire”.
mi hanno tolto tutti i linfonodi di
destra e una parte di quelli di sinistra.
Un’operazione difficilissima
Sono stato operato quasi subito e mi sono anche rimesso in sesto abbastanza velocemente. Fino a trent’anni fa non si sapeva come
intervenire; in pratica non c’era scampo, perché dai linfonodi genitali il cancro risale fino
al polmone, quindi intervenendo sul testicolo direttamente si spargeva tutto e non c’era
più niente da fare. Invece adesso l’intervento
viene fatto in tutt’altra maniera.
14
Il fatto è che all’epoca la Tac non era in
grado di fare una completa perlustrazione
dell’area retroperitoneale. Ricordo che il
professor Armando Maver, l’allora primario, mi chiamò nel suo ufficio e mi disse che
secondo lui c’erano metastasi. La Tac non le
rilevava però -mi disse- considerata la gravità del carcinoma, la mia giovane età e l’accelerazione che in genere ha questa malattia… Insomma, lui aveva questo sospetto.
Aggiunse che avrebbe potuto mandarmi anche a Milano, che non c’erano problemi. Ma
io gli dissi che mi fidavo di quello che pensava e che ero disponibile a questo secondo intervento piuttosto pesante. Così, appena mi
sono ristabilito dalla prima operazione, nel
giro di un mese, a fine aprile, inizio maggio,
è stata programmata la seconda.
Il secondo intervento è durato sette ore. Mi
hanno fatto un taglio che va grosso modo
dalla bocca dello stomaco fino all’inguine. In
più mi si è rotto un vaso linfatico, quindi ho
dovuto prendere antibiotici e albumina. È
incredibile come un boccettino che costava
all’epoca 600.000 lire, in flebo, resusciti letteralmente un morto.
Tecnicamente hanno dovuto spostare l’intestino perché i linfonodi genitali sono dietro
il peritoneo e dovevano vederli per valutare
se eventualmente toglierli -c’era il rischio di
sterilità, ma quello era il meno. Devo dire
che il professor Maver ci aveva azzeccato, ci
aveva proprio visto giusto, quindi mi hanno
tolto tutti i linfonodi di destra e una parte di
quelli di sinistra. Un’operazione difficilissima, un po’ come disfare una maglia.
Poi è arrivato il dolore. Dopo l’intervento è
stato tremendo, perché anche solo a toccarlo l’intestino si irrita, poi deve rimettersi a
posto… Per non parlare della sete… è stato
terrificante. Io ero intubato, alimentato con
flebo, costantemente sedato e tuttavia mi ricordo che sognavo sempre di essere in un deserto. Avevo una sete terribile. Poi pensavo
di dormire per ore invece mi svegliavo circa
ogni 20 secondi. Alla fine non ce la facevo
più, allora finalmente mi è stata iniettata
la morfina; lì ho smesso di sognare queste
situazioni così angoscianti e sono cominciati
i panorami verdi... tutto era verde, e mi sono
addormentato.
Ho fatto la chemioterapia. Ho preferito il
bombardamento. Mi sono sottoposto a tre
cicli intensivi di cinque ore l’uno, ogni giorno, per cinque giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 14, con
la flebo attaccata. I primi due sono andati
discretamente. Come antiemetici prendevo
dei farmaci che all’epoca costavano 250.000
lire alla scatola e che erano in commercio
solo a San Marino, a Città del Vaticano e
in Svizzera. Adesso vengono utilizzati normalmente.
Credo che nella nausea ci sia anche un elemento psicologico, di rifiuto.
Io, a un certo punto, mi ricordo che bevevo
solo delle bibite gasatissime, la cedrata, per
esempio, perché il gas inibisce la percezione della lingua, che è quella da cui parte la
nausea... E io sono uno che ha tenuto, avevo
un’ottima fibra, anche a livello del midollo
osseo, che è quello che poi conta...
Comunque non mangiavo quasi più niente,
tranne la carne di vitello, che doveva essere
tenerissima, non so perché il vitello, certo
è che si faceva fatica a mangiare... In quel
periodo ho avuto anche un abbassamento
notevole dei globuli bianchi. È stata dura.
Dopo la chemio i miei mi portavano a casa,
e ricordo che il pomeriggio cercavo di riposare, sdraiato nel letto al buio per cercare
di tener ferma la nausea. Lì i miei amici mi
hanno molto aiutato.
a volte le relazioni si rafforzano,
una relazione sentimentale invece
si è interrotta
Quando non c’erano i miei, di solito venivo
accompagnato dal taxi della Ant, l’Associazione Nazionale dei Tumori Solidi, fondata
dal professor Pannuti, uno dei primari del
Malpighi. È un’associazione che fa un servizio domiciliare importante, tra l’altro solleva i pazienti dai disagi degli spostamenti. I
malati che escono dalle cure chemioterapiche mal sopportano il freddo in inverno e il
caldo dell’estate. Tu esci, con questo sole che
ti spacca la testa, e magari non hai nessuno
che può venirti a prendere. Ecco, al posto
dell’autobus, loro ti offrono la possibilità di
fare il viaggio in taxi, col condizionatore...
L’ultima seduta di chemioterapia è stata la
più dura. Gli intervalli erano di circa una
ventina di giorni, io però ho dovuto aspettare un mese prima che l’organismo si riequilibrasse un po’, sennò, con un bombardamento troppo forte, va a finire che c’è una
depressione immunologica.
Arrivato a casa, l’ultimo giorno, sono riuscito a malapena a correre in bagno e ho vomitato tutto.
Questa condizione scatena una reazione forte nelle persone che hai attorno. Le cose non
sono più come prima. A volte le relazioni si
rafforzano, come mi è accaduto per molte
amicizie, una relazione sentimentale invece
si è interrotta. Per incapacità di entrambi, è
inutile stare qui a fare il dosaggio delle responsabilità. Devo anche dire che dopo gli
interventi sentivo molto il bisogno di stare
da solo.
Nel corso delle cure la mia reazione è stata un po’ una via di mezzo tra l’abbandono
agli specialisti e il bisogno di dialogare, di
capire. Internet era ancora agli esordi, comunque no, non sono andato a vedere. Mi
sono documentato sul vocabolario e poi sulle
Scienze, tramite un mio amico, un collega
che era stato anche lui malato e aveva un
po’ di documentazione, anche in inglese.
Della malattia io ho sempre voluto sapere
tutto e ho fatto della mia reazione razionale
uno dei punti di forza. Pur essendo la situazione gravissima, ho avuto l’enorme fortuna
di accorgermene in tempo. Perché se non ci
fosse stata quella caduta, beh, anche dieci
giorni dopo non sarebbe stata la stessa cosa.
Della malattia poi ho sempre parlato e continuo a parlarne. è un po’ come coi reduci
che hanno sempre voglia di parlare della
guerra. Forse perché sono momenti estremi
in cui vedi la morte, e però c’è anche molto
la vita. Vita e morte si intrecciano in una
maniera forse irripetibile, quindi c’è sempre
un ritorno a questa esperienza, cosa che per
gli altri è poco comprensibile.
Alla fine dell’estate mi sentivo di ricominciare a lavorare. La chemioterapia, se incassata
bene, ti permette di riprenderti abbastanza
velocemente, tanto più se sei giovane. Io poi
morivo dalla voglia di fare qualcosa, di uscire… Insomma, ho pensato: “Piglio, ci vado,
poi vedrò...”. Tanto era visibile a tutti la mia
condizione, a parte il fatto che ogni forma di
peluria era scomparsa (e pure questo è pericoloso, perché vengono meno alcune protezioni), anche il colorito era giallognolo, per
cui se non fossi entrato subito a regime la
gente avrebbe capito. Comunque piano piano mi sono rimesso in pista.
Purtroppo la malattia mi ha lasciato dei
segni. Mi si è molto accentuata l’attenzione
verso me stesso, non nel senso narcisistico, però, come dire, non vivo molto bene le
malattie. Purtroppo questo è un paradosso
incredibile...
c’è quest’angoscia
da cui non riesco a liberarmi. Faccio
una vita “normale”, però...
C’è quest’angoscia da cui non riesco a liberarmi. Faccio una vita “normale”, però, c’è
questa cosa che sto molto attento a me stesso... In che senso? Mah, per esempio, io sono
un po’ allergico, ecco, basta un mal di gola
o qualsiasi cosa provochi un po’ di difficoltà
respiratorie per farmi scattare una reazione
emotiva di grande preoccupazione.
Non è una cosa proprio patologica, a livello
di ipocondria, è specifico di alcuni disturbi,
soprattutto respiratori. E ovviamente coinvolge anche le persone che mi sono care, in
primis i miei figli. Io provo a controllarmi,
però faccio in fretta a preoccuparmi. D’altra
parte, considera anche che rischiavo la sterilità. Oggi ho due figli. Il primo, puoi immaginare, è stata un’esperienza straordinaria
una cosa fortissima, anche perché è stato il
segno che in qualche modo avevo reagito,
che potevo addirittura dare la vita.
Certo, è bizzarro. Io pensavo sarebbe accaduto il contrario, cioè che, passata quella,
nulla più mi avrebbe toccato e invece... Per
certi versi è vero, perché l’energia che sento,
e anche la capacità di sdrammatizzare, sono
notevoli, ma non su di me o sui miei cari...
Mia moglie fa quello che può. Fortunatamente lei ha un altro carattere.
Comunque mi è stato spiegato che questa
mia reazione ha una sua razionalità.
Me lo spiegò pure il dottor Vitali, che è anche
psicanalista, disse: “Beh, quest’ansia super-
ficiale è un modo per distogliere l’attenzione
da un’ansia profonda”. È un meccanismo
psichico di difesa, che può essere fastidioso,
ma in realtà mi difende dal rivivere l’evento
in modo ben più angosciante.
Era da tempo che coltivavo l’idea di scrivere
qualcosa su quanto mi era capitato, perché
rimanesse, per me. Ci avevo anche provato,
in prosa, in forma di diario, ricordi, frammenti, però mi sembrava sempre o di esagerare o di sminuire e non mi andava mai
bene quello che veniva fuori. Poi, sempre a
proposito di malattie, mi capita di prendere
un virus allo stomaco, di quelli tremendi che
non riesci a mandar giù niente.
Così sono stato costretto al digiuno. Come
si sa un digiuno prolungato crea uno stato
di grande lucidità. Insomma, era da qualche
giorno che non mangiavo e fatto sta che una
mattina, ero a casa da lavorare, mi metto
al computer e comincio a scrivere, e scrivo
scrivo… i ricordi uscivano uno dopo l’altro.
In due o tre giorni ho scritto novanta poesie, in forma di diario, che partono dal primo momento in cui mi è stata annunciata
la malattia. Erano tutte cose che avevo ben
presenti, ma era riemerso tutto secondo una
concatenazione ben precisa, un percorso.
Ho così vagheggiato l’idea di farne qualche
copia per gli amici e anche per ringraziare
i medici. Le ho fatte leggere anche al dottor Martoni, il primario, che dopo qualche
giorno mi ha chiamato: “Ascolta, ti va di venir da me, in ospedale?”. Mi ha detto che a
sua moglie erano piaciute e questo gli aveva
fatto balenare l’idea: “Noi abbiamo un bisogno assoluto di entrare in questa questione
della comunicazione medico-paziente. E anche di uscire all’esterno…”. Insomma, mi ha
proposto di farne un libro, che inaspettatamente ha messo in moto tutta una serie di
iniziative. Intanto si è creato, nell’ospedale,
un luogo di incontro tra pazienti e anche familiari che è diventato una piccola associa-
zione. Grazie all’azienda sanitaria, che si è
dimostrata molto sensibile, ha visto la luce
qualche numero di una rivista “Se ne parli”,
che è anche il titolo di una delle mie poesie.
Di questo invito a parlare abbiamo fatto un
po’ un manifesto dell’iniziativa.
Il gruppo è venuto fuori spontaneamente,
evidentemente c’era un bisogno diffuso, soprattutto di uno scambio tra persone nelle
stesse condizioni, con l’agio di essere tra
pari, perché con le altre figure, per quanto
uno possa essere vicino, è sempre il medico,
è lo psicologo, lo specialista, il prete, il pastore evangelico, quello che è…
Oggi le persone si incontrano regolarmente.
Come dicevo, ci sono pazienti e familiari, si
è creata una piccola rete. La reazione del
paziente è decisiva per la sua salvezza. Nessuno sa cosa avviene a livello intracellulare,
però, da un raffreddore a un tumore, tutti
dicono che conta molto come reagisci e come
reagisci dipende molto da chi hai accanto:
le amicizie, la famiglia, ecc. Se si è soli si
fa poca strada, temo. Anche per questo i
gruppi sono importanti. Purtroppo, infatti,
per quanto le cose stiano cambiando, questa malattia resta ancora il “brutto male”
(in dialetto bolognese si dice “al brot mel”)
perché è immediatamente legata alla morte.
Questo, per certi versi, resta vero, ma non
con le percentuali di un tempo. Allora la dimensione del gruppo aiuta un po’ anche a
sfatarne il mito.
Anche questa idea eccessivamente agonistica, per cui si “vince” contro la malattia.
Non so, a me non ha mai convinto molto.
Tanto più che, grazie alla medicina, si sta
ingrandendo la categoria di chi convive con
questa malattia. Conosco persone malate da
trent’anni. La malattia va e viene e non guarisci, e non muori…
(a cura di Barbara Bertoncin.
La versione integrale è uscita su
Una città n° 157, giu./lug. 2008)
15
Poesie di Roberto Dall’Olio
Per questo sono rinato
Di queste cose si può anche guarire
erano le diciassette di venerdì
diciassette marzo
millenovecentonovantacinque
non era primavera
Si può guarire da certi mali
e tutta la vita si spandeva
liquida nella mente
mi ero fatto piccolo
infinitamente
Gli amici mi hanno portato di peso
sul letto operatorio
il resto è stato un volto
vedrà -mi disseandrà tutto bene
Lo sai cosa mi pesa?
Questa testa a ciuffi di calvizie
e questi venti chili
di pancia tesa
che non vanno giù
sono guarita e offesa
mi guardo
non mi riconosco più
e non l’accetto
mi diceva la signora
dal bel viso accanto
al mio solito letto
La Simona quando venivano
portavano le robe di sempre
da ospedale…
ciccioli secchi crescenta e vino
mentre io andavo a flebo
era il loro modo
di reagire al male
Vinc e la Wilma
venivano tutti i giorni
sono stati assidui e cari
quasi fuori tempo
un cofanetto
di Sperlari
Ma la debbo fare
la chemioterapia?
Chiedevo al dottore
con la confidenza delle ore spese
tra visite chiacchiere
e diagnosi a ventre aperto
Se non vuoi andare a Lourdes
fu la sua risposta
Non opporti al male
lascialo entrare nel canyon
della tua mente
solo lì
se va bene
puoi pazientemente
tramutarlo in vita
A 10 anni dalla diagnosi di un cancro e dall’esito positivo delle terapie, Roberto Dall’Olio, ha raccontato la sua esperienza in forma poetica,
nel libro Per questo sono rinato, edizioni Pendragon, dal quale sono tratte queste poesie.
L’Associazione “Se ne parli”, ispirata nel nome a una delle poesie di Dall’Olio, è nata per approfondire i bisogni dei pazienti oncologici, per
ampliare confronto e comunicazione tra i malati, i loro familiari, i medici e il personale paramedico.
Onlus senza fini di lucro, l’Associazione è diretta dal dottor Andrea Angelo Martoni, già primario dell’Unità operativa di Oncologia medica
del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.
16
Eubiosia?
Eutanasia?
La buona vita?
La buona morte?
Sono possibili entrambe
io credo che chi
non ce la fa più
lentamente di franare
abbia il diritto
di precipitare
Perché?
Me lo sono chiesto
tante volte perché
proprio a me
Sto provando
dopo il tumore
a vivere
con amore
Era caldo
sul letto di casa
dopo la chemio
arriva una telefonata
fuori orario
infatti è una sassata
Matteo di là dalla cornetta
mi dice alterato
È morto Langer
si è impiccato
Mancava il pianista
ho suonato io
pelato come un bimbo
appena nato
ricordavamo Nagasaki
cinquant’anni dopo
quel buco nero
che risucchiò milioni di vite
segnò per sempre
un solco col passato
Dopo anni
riesco a dire
a nitrire in versi
il mio desiderio
perfino di impazzire
stanando tutta la vita
di questo mondo
nei luoghi persi
in dubbi e affanni
di quel tritolo
che mi portavo giù
sigillato in fondo
al molo
Almeno questo mi sento di poter dire
che il cancro
come ogni malattia grave
non è una colpa
un crudo castigo
o il segno di un peccato
È un terremoto
che sconvolge tutto
ma proprio tutto
il tuo privato
e si fa emergenza
di una civiltà
che ha bisogno di sapere
Se ne parli
perché di ciò di cui
si può parlare
non si abbia a tacere
Caro Claudio
medico di famiglia
amico e terapeuta
non me lo cavo dalla testa
che la cosa più dura
se ne esci
è fare i conti con ciò che resta
La paura
Il sonno è fatto
per chi sta bene
quando ti crivellano la mente
i colpi del dolore
non vorresti altro che sparire
volere insieme
vivere e morire
17
Parlare fa bene
La massima trasparenza, la capacità di comunicare, condizione del rapporto di fiducia fra medico e paziente. Un ospedale
che, inevitabilmente, è sempre più organizzato come una fabbrica e un’esigenza, in gran parte insoddisfatta, di “personalizzazione”. Intervista ad Andrea Martoni.
Andrea Martoni è stato Direttore dell’unità
operativa di Oncologia Medica presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi a Bologna.
Quello della comunicazione fra paziente e medico, in particolare in ospedale,
resta un problema o le cose sono cambiate?
Quando ci sono di mezzo malattie gravi,
all’inizio almeno, il medico si trova in difficoltà perché le conseguenze sullo stato
psichico, emotivo, di una malattia grave,
sono enormi, fino al punto da condizionare
le stesse decisioni che il medico prende. Non
solo, un paziente può anche rifiutare di fare
quello che il medico dice. Di fronte a una
malattia grave, che mina profondamente la
persona, che mette a repentaglio la vita, o
anche solo alla paura di una tale malattia,
il medico non può non tener conto dei sentimenti perché la sua relazione col paziente
dipenderà da questo e così le decisioni che
verranno prese.
Allo stato attuale succede che se uno ha già
una sua propensione a stabilire delle relazioni, una sua sensibilità, che casomai è
quello che l’ha spinto a scegliere medicina
(e che appunto non gli viene dagli studi di
medicina), bene, perché questo aiuta. Però
la maggioranza di chi si iscrive a medicina
non parte con questo background e l’insegnamento non ne tiene molto conto. Quindi,
alla fine, chi ce l’ha già di suo riesce a sopperire, chi non ce l’ha...
Ovviamente non esiste un medico che non
abbia avuto un paziente con cui non ha legato. Questo fa parte della vita. Però è indubbio che tutti vorremmo avere a che fare
con un medico che ha più facilità a comunicare, che ha meno problemi relazionali, che
è capace di prendere in carico anche aspetti
della vita del paziente che non siano strettamente professionali.
La necessità di efficienza dell’ospedale
va contro questo aspetto di “personalizzazione”, se così si può dire....
Queste malattie gravi, in particolare il tumore, vengono curate in ospedale. Le terapie diventano sempre più forti, sempre più
efficaci, e anche più complesse. Farle bene
tecnicamente, farle in maniera corretta, significa inevitabilmente accentuare sempre
di più l’aspetto organizzativo, per cui, ad
esempio, un day hospital di oncologia, dove
si fanno le chemioterapie, assomiglia sempre di più a una catena di montaggio, perché
non è un atto solo, è un processo dove intervengono molti operatori e le fasi da concatenare sono diverse.
Non lo dico in maniera negativa: è giusto
fare così. Solo che sarebbe altrettanto giusto
avere degli spazi, dei momenti in cui ci si
ferma, ci si confronta, si dice qualche parola,
si ha uno scambio tra le persone, anche a
partire da ruoli diversi, uno è un professio-
18
nista, l’altro è “il cliente”, se vogliamo usare questa parola. Purtroppo, questo tempo,
queste possibilità stanno sempre più diminuendo, pur nella consapevolezza, ormai
abbastanza acquisita, dell’importanza del
rapporto umano. Anche il medico sensibile
si accorge di avere sempre meno tempo da
dedicare a questo aspetto.
Dall’altra parte il cliente, il paziente, ha un
crescente bisogno di avere più tempo perché conosce sempre di più quello che gli sta
succedendo, quindi, giustamente, è pieno di
dubbi e interrogativi.
A questo punto non c’è il rischio che le
risposte se le vada a cercare da solo?
Infatti si arrangia un po’ da solo e cerca delle
strade di informazione che sono pericolosissime: internet, i giornali, la televisione, che
solitamente lanciano messaggi non realistici. Colpa del giornalista che intervista, ma
anche di chi si fa intervistare, perché ormai
esiste la promozione anche della ricerca, la
promozione dello scienziato, la promozione
del libero professionista.
più sei trasparente, nei dubbi,
nelle certezze, più sei capito e vieni
considerato meritevole di fiducia
Le informazioni raramente sono corrette,
quasi sempre vengono distorte. Se pensiamo
poi che chi ha la malattia è portato lui stesso a distorcere le notizie, se l’informazione è
minimamente ambigua, nel senso di creare
delle attese, ecco che il danno è fatto.
Qual è il modo per instaurare un rapporto di fiducia con il malato?
La trasparenza. La mia esperienza è questa:
più sei trasparente, nei dubbi, nelle certezze, più sei capito e vieni compreso, più vieni
considerato meritevole di fiducia. Questo è
fondamentale, perché il rapporto medicopaziente è un rapporto di fiducia. La fiducia
la si conquista in tanti modi, ma certamente
bisogna essere chiari, trasparenti, non ambigui, e veramente interessati alla persona
che hai di fronte. Certo, se sei oberato dall’orario, dai turni, ecco, rischi di perdere tutto
questo, che è anche un’opportunità.
Del resto a essere pagate sono le prestazioni, non certo questi tempi “vuoti”...
Le parole chiave sono “efficienza”, “efficacia”. Se poi parli con i direttori generali, almeno quelli che io ho conosciuto, che sono
dei buoni dirigenti, ti diranno sicuramente:
“Ma no, non è vero, non c’è solo questo...”.
Casomai loro apprezzano l’impegno anche
sul versante comunicativo, però, alla fine,
se gli vai a dire che hai bisogno di più persone per dedicare più tempo al paziente, ti
risponderanno immancabilmente di no. Per
un problema di bilancio. Quindi a parole il
problema viene compreso, ma nei fatti...
D’altra parte è chiaro che l’amministratore
deve occuparsi degli aspetti economici, quin-
di l’aziendalizzazione deriva dalla necessità
di essere più efficienti, che è una necessità
ineludibile. Abbiamo uno Stato che investe
nella Sanità una quota del proprio Pil più
bassa delle altre nazioni, seppur di poco, ma
in presenza di uno spreco enorme. Se poi aggiungiamo a questo che il sistema sanitario
da Firenze in su funziona abbastanza bene,
e da Firenze in giù funziona abbastanza
male…
Capita ancora che l’interessato non
venga informato della gravità della
cosa e venga informata la famiglia.
Questo non è legale. Punto. Se capita qualcosa, se c’è un procedimento penale per
qualche motivo, la prima cosa che il giudice va a cercare è il consenso del paziente di
fronte a un atto sanitario, se c’è o non c’è. E
se anche c’è, ma il paziente dice: “Io non avevo capito che lì fosse scritto così”, il giudice
può dar torto al medico.
Allora, rispetto al consenso, c’è un aspetto
legale che a me interessa, naturalmente,
ma un po’ meno dell’altro, che sta nella sostanza delle cose, cioè nella relazione e nella comunicazione fra medico e paziente, in
particolare nel nostro campo dell’oncologia.
Qui, a fronte di una diagnosi molto seria, io
ormai sono sicuro che il 90% delle persone
che si presentano e che hanno avuto o hanno
un tumore, hanno una buona informazione
sulla loro diagnosi, anche sul grado di gravità. Sulla diagnosi, direi che non c’è più alcun
problema. Il consenso informato ormai è un
atto dovuto, che vale per tutte le indagini
diagnostiche e per le varie terapie.
Oggi tutte le cartelle contengono almeno
una pagina dove c’è scritto che il paziente è informato. Non è solo un atto formale, perché più che il foglio di carta conta il
colloquio, che viene gestito dal medico, secondo quella sensibilità e quelle capacità
comunicative che ha o che dovrebbe avere
e di cui dicevo prima. E qui è chiaro che le
parole sono molto importanti. Una sfumatura nell’uso delle parole, pur dicendo la stessa cosa, può cambiare molto. Ci sono delle
persone con cui si può parlare chiaramente
di tumore, con altre si possono usare delle
parole magari più tecniche, che possono risultare meno traumatiche. Si possono adottare delle perifrasi: si può dire che le cellule
crescono, che vanno in giro (che è poi una
descrizione esatta di ciò che accade), prendono le vie linfatiche, senza dire casomai la
parola “metastasi”. Al che spesso è il paziente che alla fine dice: “Ma sono metastasi?”,
“Eh, sì, sono metastasi...”.
Capita ancora una situazione tipica, che per
un verso fa sorridere. Qui da noi vengono
molte persone anche dal Sud e nel Sud vige
ancora quello che era il comportamento dei
parenti venti o trent’anni fa da noi: “Mi raccomando, eh, lui non sa niente, poi vengo io
a parlare con lei...”. Al che, più di una vol-
ta, mi è successo di chiedere al malato, in
genere anziano, proprio per rompere questa
situazione: “Lei, cos’ha?”. E spesso la risposta è stata: “Ho un tumore”. Allora vedi i parenti quasi svenire. La cosa ha poi un effetto
di sollievo enorme per il paziente e alla fine
anche per i parenti, perché tenere nascosta
una cosa è un dramma per tutti.
Insomma, è inutile prendersi in giro, se uno
fa una Tac, un’endoscopia, un esame complicato, capisce che c’è qualcosa e se gli si dice:
“Non è niente” , lui sente che non gli si dice
la verità. Ma anche per i parenti è un gran
sollievo, perché gli si toglie il peso di dover
tener nascosta la verità. Devo dire che è un
sollievo anche per il medico. Avere a che
fare con persone informate, con cui si parla
in maniera trasparente, chiara, con le parole giuste e ispirate dalla giusta sensibilità,
dà molte più soddisfazioni. È la soddisfazione di un rapporto di reciproca sincerità e di
pienezza del ruolo di entrambi, io medico e
tu paziente.
Ma sulla prognosi si può essere altrettanto chiari?
Sulla prognosi, cioè su come andrà a finire,
è un po’ diverso. C’è un aspetto di delicatezza, anche di umanità, che fa sì che questo
aspetto dell’informazione vada valutato con
attenzione. Dopo aver parlato chiaramente
della diagnosi, la domanda che viene sempre
più posta (e anche questo una volta non succedeva) è: “Ce la farò?”, che è la domanda più
vera, più sincera, e alla quale è difficile dare
una risposta. A volte instillare delle speranze eccessive è un errore, ispirare speranza
in maniera sfumata forse è la cosa giusta da
fare. Quindi dare dei messaggi di complicità, di serietà, però anche di speranza.
la paura di non farcela a guarire,
il tragitto della cura come la maratona:
uno solo vince, ma nessuno perde
Credo che la risposta più veritiera e anche
corretta in fondo sia: “Speriamo di sì”, perché anche il medico deve sperare. Perché il
medico ha delle certezze, però, qualche volta, soprattutto se le cose sono complicate...
Ecco, la prima persona plurale “speriamo”,
ha proprio questo senso e, nello stesso tempo, è un messaggio utile a far sentire che
“siamo sulla stessa barca”.
Il discorso di “stare sulla stessa barca” pone
però un altro problema comunicativo. Sulla
stessa barca i pazienti ci stanno se, durante
il percorso, che può essere anche lungo, le
cose vanno abbastanza bene. Perché il sistema qualche volta può avere una falla, quindi la barca può anche essere abbandonata.
Oppure può essere abbandonata perché anche se tu, medico, ce l’hai messa tutta, le richieste, le esigenze, le aspettative che il paziente si è creato dentro di sé sono maggiori
delle possibilità che tu gli offri, per cui se ne
va, quasi sempre cercando delle altre soluzioni cosiddette alternative... Infine, può anche succedere, seppur raramente, che ci siano delle possibilità che tu non sei in grado di
dare e che altrove esistono. Questo bisogna
riconoscerlo. È raro, perché parliamo di una
realtà, Bologna, in grado di fare quasi tutto,
però qualcosa ci può essere, e allora non bisogna avere la presunzione di dare risposte
a tutto. Qualche volta il medico deve anche
attenuare il proprio orgoglio, l’ambizione di
essere in grado di risolvere tutto.
Anche rispetto a tutto questo la trasparenza
è la scelta migliore.
Capitano persone che dicono di non voler sapere niente?
Ci sono anche quelle, sono rare, ma ci sono,
non solo gli anziani. Ci sono persone che dicono: “Faccia lei, io non voglio saper niente”.
Gli anziani spesso sono quelli che rimangono un po’ nella posizione di incertezza, che
sanno, quasi sempre e però... L’anziano, poi,
in genere sta bene a casa sua, bisognerebbe
tenerlo lontano dall’ospedale, lasciarlo il più
possibile nel suo ambiente. Purtroppo oggi
sempre di più sono da soli, spesso con i figli lontani... Con gli anziani comunque non
bisogna “strologare” tanto su come comportarsi, bisogna essere disponibili, perché per
l’anziano il massimo è vedere che c’è una
persona più giovane di lui, che è un medico,
cioè uno con il camice bianco, che gli presta
attenzione, che è gentile nei modi, che si sta
preoccupando...
Può raccontare un po’ di questi gruppi
di discussione...
Questi incontri sono nati due anni fa. Devo
dire che l’esca di questa iniziativa è stato
un ex paziente, Roberto Dall’Olio. Io sentivo il bisogno di creare delle occasioni in
cui si potesse dedicare un po’ di tempo alla
comunicazione. Lui aveva fatto questo libro di poesie sulla sua esperienza della
malattia e una di queste si intitolava “Se
ne parli”, che toccava il tema dell’informazione, dell’importanza di tirare su il velo, di
non aver paura di parlarne. L’esperimento
è nato da lì, sostanzialmente. è un gruppo
che non è sempre lo stesso. C’è un nucleo
storico, di tre o quattro persone, poi ci sono
altre quindici-venti persone che girano. Le
tematiche prevalenti all’inizio erano quelle
dell’informazione, delle nuove terapie, poi
pian piano sono diventate quelle di carattere più personale, del vissuto della malattia,
di quello che succede dentro le persone. La
malattia come colpa, come punizione, il sentirsi un perdente, la paura di non farcela a
guarire, il tragitto della cura come la maratona: uno solo vince, ma nessuno perde,
l’alterazione dell’immagine corporea, come
ci vedono gli altri, l’assenza di chi non viene
più all’incontro... Poi ovviamente si discute
delle relazioni con i medici e gli infermieri
dell’ospedale, delle strategie per affrontare
la malattia, delle relazioni con gli altri, i parenti innanzitutto.
Abbiamo una persona che viene quasi tutte
le volte e parla di sua figlia. L’ammalata è
la figlia, non la mamma, e la mamma parla
come se fosse lei. Lì c’è un problema di rapporti, per cui la ragazza non è mai venuta,
invece viene questa madre che parla pensando di riferire il pensiero della figlia, ma
in realtà è il suo pensiero, è il suo vissuto.
Ecco, c’è anche il vissuto dei parenti.
La comunicazione può evitare che si
crei diffidenza e, nel caso, a prevenire
azioni di rivalsa contro l’ospedale?
Oggi si parla molto della sanità e uno dei
temi più vivi, in questi ultimi mesi, è come
gestire il rischio di creare dei danni in corso
di assistenza sanitaria.
Ovviamente si tratta di un rischio che non
potrà mai essere azzerato, questo deve essere chiaro. Gli episodi di malasanità di cui
ormai si parla tutti i giorni, con un’enfasi
devo dire eccessiva, ci saranno sempre. Si
tratta di prevenire al massimo l’incidente e
anche di preparare il personale alla gestione del rischio. Oggi si investe moltissimo in
quest’ambito. Ci si sta muovendo per farlo
diventare patrimonio della cultura di tutti
gli operatori sanitari, medici e non medici. In
effetti questi incontri possono essere utili anche a prevenire il cosiddetto rischio clinico.
per prevenire il rischio clinico,
una “cura” della comunicazione
è importantissima
Se uno va a chiedere ai periti che fanno perizie per i tribunali, per le cause civili con
richiesta di risarcimento danni a un’azienda ospedaliera, se uno va a vedere bene,
nell’80-90% dei casi alla base c’è anche una
cattiva comunicazione. Se questa fosse stata
migliore non si sarebbe arrivati alla causa.
Allora, per prevenire il rischio clinico, una
“cura” della comunicazione è importantissima. In tal senso queste iniziative si muovono nella giusta direzione, anche se non è
quella la loro ragion d’essere. Però mi rendo conto che molti frequentatori hanno dei
“problemi”, interiori, certo, di rapporto con
la stessa malattia, ma anche esteriori, di
rapporto con l’ospedale. Avere uno spazio
dove uno può dire quello che vuole può essere importante. Proprio stasera io ho spinto in questo senso, ad affrontare di più nei
prossimi incontri, quello che non va.
Da chi è formato il gruppo?
Roberto sin dall’inizio ha usato questa parola “reduci”, che non è sbagliata perché in
fondo si torna sul luogo della battaglia.
Negli Stati Uniti, dove sono sempre di più
quelli che si sono messi alle spalle la malattia, si chiamano “survivals”, sopravviventi,
che in italiano non è molto bello. Comunque,
seguendo i loro siti, ho visto che anche a loro
il termine “survivals” comincia a non piacere tanto, perché l’idea del reduce, pensiamo
alle tantissime associazioni, si porta dietro
sempre un po’ di magone...
Il nostro è un gruppo misto, che vuol dire
che ci sono dei malati attuali, degli ex pazienti, dei reduci, dei parenti. Ovviamente
l’eterogeneità rende la situazione particolarmente delicata, perché si tratta di condizioni psico-emotive molto diverse. Io ero un
pochino preoccupato all’inizio e invece poi
ho visto che le cose funzionano.
Ho notato che ci sono perlopiù donne...
è vero. Il problema è che l’uomo è più chiuso
e la donna comunica più facilmente. Questo
è poco ma è sicuro. Poi c’è da dire che in prevalenza sono tumori della mammella, una
problematica che si trascina dietro problemi
di identità. Se uno non ha più un rene, a causa di un tumore, non ha un problema di identità, ha solo paura che gli torni la malattia,
invece una donna che ha avuto un tumore al
seno soffre per entrambi i problemi...
(a cura di Barbara Bertoncin.
La versione integrale è uscita su
Una città n° 152, dic./gen. 2008)
19
La difesa della normalità
Il cancro da “male incurabile” sta trasformandosi, grazie all’avanzamento delle cure e alla loro personalizzazione, in un
male cronico, che si può tenere a bada, impedendogli di impossessarsi della propria vita. Intervista ad Anna Segre.
Anna Segre ha insegnato Geografia all’Università di Torino. è morta il 20 giugno 2004.
Sì, a un dato momento ho pensato che fosse giusto, utile, parlare di questa cosa; credo siano passati i tempi in cui i malati di
cancro si celavano dietro malattie varie, di
solito dietro l’espressione “male incurabile”, e non ne parlavano, né con gli amici né
tantomeno in pubblico. Di fatto si apprendeva sempre che qualcuno era stato malato
di cancro dopo la sua morte, dal necrologio,
che diceva: “Stroncato da male incurabile, il
tal dei tali eccetera, eccetera”…
Ecco, io credo che i malati di cancro che
hanno la “fortuna” di sopravvivere a lungo
abbiano il dovere di parlarne. E non per fornire facili illusioni, come quei saggi che si
trovano in libreria o nelle erboristerie, intitolati “Come sono guarita dal cancro”, ma
perché altri possano trovare magari nelle
parole di una persona un aiuto, un modo di
affrontare la malattia che a loro non è venuto in mente, non è venuto spontaneo.
Teniamo presente che la stessa dizione
“male incurabile” non è più appropriata,
perché di fatto il cancro non è più un male
Anna e la malattia
incurabile. Questo va detto. Ci sono cure e
modi di affrontarlo che stanno trasformando il cancro in un “male cronico”. Non vorrei essere troppo ottimista, ma sono anche i
miei medici che me ne parlano. Cure sempre
più personalizzate, adattate ai diversi tipi
di cancro, se non riescono ancora a far guarire, riescono però ad allungare la vita del
malato, cronicizzando quindi la malattia,
facendola durare.
E siccome è aumentata molto anche la possibilità di salvaguardare la qualità della
vita di chi ha questa malattia, la tendenza
a cronicizzare il male è da vedere come un
fatto positivo.
tu vivi a casa tua, fai le tue cose,
però le scadenze vere sono quelle
della visita, degli esami, della cura
Per questo penso che sia meglio parlarne,
per raccontare come alcune persone riescono, nonostante la malattia, a vivere in modo
discreto.
Questo penso sia anche il mio caso. Il che
non vuol dire, però, che non abbia subìto
una rivoluzione totale della mia vita, del
Sono parole di cui sento un’eco nei modi in cui Anna ha vissuto la
malattia. Con smarrimento, paura, collera, tristezza infinita. Che le
sono rimaste. Ma gradatamente le è sbocciata anche tanta voglia di
vivere, e al meglio possibile nella situazione data. Aveva conquistato
più fiducia in se stessa, più fermezza nelle decisioni, un’elasticità
mentale che è di pochi -mi raccontava con che nuova facilità riusciva a intervenire nei dibattiti, di come il suo pensiero prendeva forma
e fluiva spontaneamente mentre parlava, anche quando si trattava
di temi nuovi. Continuava a fare lezione, a partecipare a convegni,
metteva insieme persone, coordinava ricerche. Si concedeva più
cose, oggetti per la casa, vestiti, viaggi, una scintillante auto blu, che
aveva guidato in una sola tirata fino a Bolzano in occasione di una
cerimonia per il Premio Langer; si era fatta costruire un caminetto
nel soggiorno della bella casa ai piedi della collina. Spero che non vi
sembrino divagazioni: in quei tocchi di leggerezza e “frivolezza”, in
quel desiderio di agio, si esprimeva una Anna in parte nuova, meno
doverista rispetto ai tempi in cui la nostra priorità era la politica,
più dolce con se stessa, più ragazzina, mi verrebbe da dire. E più
creativa: sono certa che tutti riconoscono l’originalità dell’“Atlante”,
a cominciare dall’immagine di copertina, quasi un simbolo della
sua sensibilità. Sono stati anni pieni. Anna si crogiolava nel calore
della nuova famiglia in cui l’aveva introdotta Claudio, si godeva
Leah, e Ada in versione materna.
Sperimentava cose nuove, la discesa di un fiume in canoa con tanto
di caschetto protettivo, nuove terapie per l’emicrania, l’incontro in
Canada con le balene, lo shiatsu, la scrittura narrativa -ricordo un
suo breve racconto in cui fotografava i vari tipi di borse che i pazienti in attesa della chemioterapia portavano con sé a Candiolo,
scegliendo la strada difficile di far parlare gli oggetti e i gesti invece di descrivere i sentimenti. Faceva progetti: una vacanza, una
speciale sorpresa per Claudio, un giro in Provenza alla ricerca delle terracotte locali, un soggiorno in una beauty farm dove tutti i
trattamenti erano a base di uva, un libro da scrivere insieme sulla
storia di Nella, Renzo e Carlo Angela, un altro che avrebbe dovuto
intitolarsi “Intanto vivo” e raccontare come la malattia (certe malat-
20
mio modo di pensare al tempo, al futuro.
Ecco, una delle cose più fastidiose quando
non si ha molto male, come nel mio caso, è
questa continua ospedalizzazione, nel senso
che tu vivi a casa tua, fai le tue cose, però le
scadenze vere sono quelle della visita, degli
esami, della cura, quindi sulla tua agenda
prima segni queste e poi, eventualmente, aggiungi gli impegni di lavoro, se l’hai
mantenuto. Tutto dipende da quello e non
si può assolutamente fare diversamente…
Bisogna però anche dire che in questi posti
i medici, e ancor più gli infermieri, in genere sono meglio che negli ospedali comuni,
nel senso che veramente svolgono un lavoro difficilissimo, di responsabilità e -non è
una frase banale- sempre col sorriso sulle
labbra, con la parola giusta, per otto ore di
seguito. Io non ho mai capito come facciano.
Ammiro tantissimo queste persone. Vedono
passare i malati a migliaia e però si ricordano sempre il tuo nome, o, meglio, il tuo
cognome, perché non è più il tempo in cui il
paziente viene chiamato nonna, nonno, oppure per nome. Si ricordano il tuo cognome,
come è giusto.
Io, il primo mese di malattia, credevo di non
tie con l’“aura”, il cancro, l’infarto) ridefiniscono le relazioni, certe
amiche/i che si dileguano, persone meno intime che corrono a starti
vicino, alcuni che neppure chiedono: “come stai?”, perché è faticoso
cercare parole adatte, altri, che pur rischiando la goffaggine, provano e riprovano a comunicare. Progettava il matrimonio, che è avvenuto, e subito dopo un viaggio con Claudio ad Agrigento. Ma fino ad
Agrigento non è potuta arrivare.
Difficile non accorgersi di quanto Anna somigli a sua madre in questa determinazione a non disperdere il tempo che rimane, a capitalizzare le esperienze belle: “Amore per la vita”, lo ha definito Fabio
Levi. Ricordo l’ammirazione che tutte e due avevamo per queste parole di un ex deportato: “Ero lì, e pensavo, Hitler può farmi di tutto,
ma il fatto di aver vissuto bene, facendo quel che mi piaceva, divertendomi, quello non poteva togliermelo”. Credo che la forza di Anna
venisse anche dalla sua capacità di fare propri messaggi fuggevoli.
Non vorrei aver disegnato un’immagine eroicistica. Disperazione e
ripiegamento su se stessa a volte prevalevano. Come avrebbe potuto
essere diversamente? Anna non coltivava illusioni, solo speranze,
non aveva un atteggiamento guerresco verso la malattia, nessuna
sfida prometeica, nessuna scorciatoia psicologista; sulle orme di Susan Sontag, rifiutava l’ideologia che riconduce il male alla depressione e le guarigioni al pensiero positivo. Anna sapeva; ma voleva
avere ancora bei giorni, passare tempo con le persone care, fare un’escursione in montagna, una nuotata al mare, un saggio, un corso.
Questo e molto altro aveva raccontato in un’intervista a “Una città”,
uno dei testi più coraggiosi e generosi fra i tanti usciti finora. Forse
questo discorso sembra un’apologia, e non me ne dispiace. Anna la
merita per molte ragioni, non ultimo un tratto cui mi affido per concludere, come mi sono affidata tante volte in passato per altre cose:
la virtù quotidiana della cura. Essere intelligenti è facile, un po’ più,
un po’ meno lo siamo tutti. La differenza sta nel cuore. Ricordo come
Anna si era prodigata per un’amica argentina, il suo dolore per il
dramma familiare di un’altra amica, la condivisione dei momenti
difficili dei suoi cari; ricordo una sua visita notturna mentre ero in
ospedale, e al mattino la aspettava la chemio.
Anna Bravo
Ebbene, per me, allora sedicenne, fu un
anno terribile, che mi ha segnato per tutta
la vita. Da allora ho vissuto proprio con la
paura di queste malattie, di star male, di
soffrire quanto ha sofferto lei. Ecco, la paura
del dolore è ancora una cosa molto rilevante
in queste malattie. Il fatto che il dolore oggi
possa essere neutralizzato grazie a farmaci,
a terapie apposite, mi sembra una conquista
straordinaria.
riuscire più a far niente, nemmeno a leggere
il giornale o un libro. Avevo subìto un’operazione lunga e complicata, quindi può darsi
che fosse anche la conseguenza di questo.
Avevo il cervello completamente svuotato,
mi sembrava di non ricordare più nulla, di
dovermi focalizzare solo su quello, sul male
che sentivo, sulla ferita fisica da guarire.
è una malattia in cui tu devi essere
seguita quotidianamente da chi ti vuol
capire. E allora selezioni gli amici
Poi, invece, piano piano, seppur con l’inizio
della chemioterapia, tutto è un po’ cambiato, ma c’è voluto molto tempo; ed è cambiato
con un lavoro su me stessa veramente lungo, confrontandomi anche con altre persone.
Lì ho visto che l’unica soluzione era quella
di continuare a svolgere il proprio lavoro,
pur nelle difficoltà di programmazione che
subentrano. Tu non sai mai se starai bene il
tal giorno, se la terapia te la fissano di giovedì o di venerdì o chissà quando…
Sì, penso che vada difesa la normalità. E la
normalità è innanzitutto riuscire a fare il
proprio lavoro.
Io sono stata fortunata perché ho un lavoro, quello di docente universitario, in cui gli
orari sono abbastanza gestibili. Però, ecco,
già in questo il ruolo degli amici diventa indispensabile.
Ad esempio, nella settimana successiva
alla chemioterapia io non sono in grado di
fare lezione, ma per fortuna ho un pool di
amici-colleghi disposti a sostituirmi in qualunque momento; dico pool perché sono tanti e si dividono i ruoli, non tutti hanno le
stesse competenze, per cui a seconda delle
necessità va uno o va l’altro. E questa è una
grande fortuna, che però si costruisce, anche raccontando via via agli amici le difficoltà. E selezionando, perché non tutti sono
disponibili a fare questo percorso con te. Un
po’ mi dispiace, ma io ho fatto una grande
scelta all’inizio: ho visto subito gli amici che
erano disposti, disponibili, capaci -perché
anche di questo si tratta- di accompagnarmi in questo cammino, e quelli che invece
non lo erano, per difficoltà proprie, magari
di comprensione, perché è vero che il cancro
non è più la malattia killer di una volta, ma
resta pur sempre una malattia difficile da
sopportare, da descrivere. è una malattia in
cui tu devi essere seguita quotidianamente
da chi ti vuol capire. E allora per forza selezioni gli amici. Gli amici che restano hanno
però un ruolo fondamentale. Le persone che
invece facevano finta di niente sono uscite
dalla mia vita.
Per i familiari vale lo stesso discorso degli
amici: bisogna scegliere. Nel mio caso non
ho dovuto neanche scegliere: avendo una famiglia minuscola ho visto subito chi c’era e
chi non c’era. E chi c’era era un familiare
nemmeno familiare perché era il mio compagno di vita, Claudio, che è stato in questi
anni l’unica persona che mi ha accompagnato sempre a fare la terapia, dai medici, a
ricevere i risultati. E io credo che abbiamo
sofferto esattamente dello stesso stress, io
malata e lui no.
Deve essere terribile vedere una persona
di famiglia stare male, sopportare cure e
non poter fare assolutamente niente, per
cui c’è questa dedizione, che nel mio caso è
stata assoluta. Se riesco ad affrontare così
la malattia, certamente per metà è merito
suo. Ma questa dedizione assoluta il familiare o l’intera famiglia, quando c’è, quanto
la paga? Certamente il prezzo è altissimo.
Io lo so perché in altri tempi, quand’ero giovanissima, ho avuto una mamma malata
di una malattia simile, che a quei tempi si
curava poco, infatti resistette solo un anno.
Già, la qualità della vita, come suol dirsi. Ecco, tutte queste persone, i medici, gli
infermieri, gli psicologi, i familiari e poi le
terapie, che sono fondamentali, insieme riescono a farti godere di una qualità accettabile della vita. Che tu sai che ha un termine.
Ma ciascuno di noi lo sa. Il giorno in cui mi
hanno comunicato al cellulare che una mia
carissima amica aveva avuto un infarto, io
stavo entrando in ospedale per una cura.
Dove stava la differenza? Non c’era. Quella che gli statistici chiamerebbero speranza
di vita, da un momento all’altro è diventata
molto più breve per l’amica che fino all’altro
giorno non aveva avuto niente e più lunga
per te che da anni ti curi e soffri, portandoti
dietro tutto il bagaglio di una malattia gravissima.
Questa presa d’atto della non differenza,
della non diversità, è per me molto recente
e, in questo, lo psicologo mi ha aiutato molto. Voglio dire, anche tenendo conto della
teoria delle probabilità, non so quanto sia
maggiore quella di morire in un incidente
automobilistico o per un male improvviso.
Una mia collega di università qualche anno
fa è andata a letto normalmente la sera e al
mattino non si è risvegliata.
Qual è la differenza tra me e lei? La mia scadenza non è più vicina di quella degli altri.
Certo, io vivo più di altri con l’idea delle scadenza, ho più difficoltà a far programmi, non
posso dire: “L’anno prossimo farò un viaggio
in Australia…”. Sì, questo non lo dico più,
però due settimane prima, se sto bene, mi
organizzo il mio viaggio in Australia.
vorrei che anche nel nostro paese ci
fosse la possibilità di fare il testamento
biologico, lo ritengo fondamentale
Insomma, impari a vedere in modo diverso
il male che può arrivare improvvisamente.
Io ho avuto tante lezioni di vita in questo
periodo. Ho avuto anche una collega che, col
mio stesso male, è vissuta molto meno. A un
certo punto ha saputo che le terapie non sarebbero state più utili e ha deciso di non farle più. Anche quella è una scelta. Una scelta
in cui sai come va a finire. Sono comunque
scelte che, finché stai bene di testa, puoi fare
anche tu.
Ecco, la mia vera preoccupazione è quella
di arrivare a un momento in cui non sarò
più capace, lucida, per fare le mie scelte. Per
questo vorrei che anche nel nostro paese ci
fosse la possibilità di fare il testamento biologico, perché la ritengo una cosa fondamentale, un indice di civiltà.
(a cura di Gianni Saporetti.
La versione integrale è uscita su
Una città n° 117, nov./dic. 2003)
21
La malattia e la persona
Le facili illusioni della prevenzione di massa nel caso del tumore al seno. Un tasso di guarigione pressoché invariato da
decenni. Un approccio sempre più segmentato e standardizzato che non tiene conto della complessità della persona e dei
contesti. Intervista a Gemma Martino.
Gemma Martino è Direttore Scientifico di
Metis, il Centro Studi in Oncologia Formazione e Terapia di Milano. Ha lavorato all’Istituto dei Tumori, ricoprendo il ruolo di direttore di Divisione. Si occupa della qualità
di vita delle persone con tumore e della formazione degli operatori sanitari “per il loro
ben-fare e il loro ben-essere”.
Può darci un quadro dell’informazione
sanitaria e della vostra attività?
Potremmo definire la nostra attività sanitaria una militanza, che si organizza per aiutare le persone in crisi e rimane con i pori
aperti della sensibilità e dell’intelletto per
modificare i comportamenti della salute e
della malattia e la cultura intorno a essa.
Nel campo dei tumori, infatti, non sempre si
è proceduto con grazia.
L’immagine che diamo del cancro è che -se
preso in tempo- lo possiamo curare. Come
terapeuti siamo pronti all’azione e nel linguaggio usiamo ancora metafore di guerra
che danno corpo alle nostre paure di avere
nemici che attentano all’invulnerabilità:
battaglie che si combattono, tumori che si
bombardano, esplosioni che si prevengono,
arruolamenti per lo screening. Una persona
che ha ricevuto una diagnosi di tumore difficilmente fa sue queste metafore guerriere,
piuttosto si prefigura immagini più naturali, più geologiche -all’atto della diagnosi
è stato come un “terremoto” all’interno, un
“sovvertimento”, una “tempesta inattesa”che arrivano dal profondo dell’anima. Un
bisogno di ripararsi e capire prima di agire.
L’uso dei simboli e del linguaggio espressi nella varie fasi di prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori la dice lunga sui diversi
tempi e modi di pensare, agire, comunicare
tra terapeuti e utenti/pazienti.
già 50 anni fa, senza diagnosi precoce,
almeno la metà delle donne
con tumore al seno viveva a lungo
Un esempio alla portata di tutti è quanto s’è
mosso ed è stato promosso nel campo dei tumori al seno. Qui, un uomo carismatico con
grandi capacità organizzative e relazionali,
Umberto Veronesi, seguito da un gruppo di
medici attivi e fedeli, ha impostato ricerche
cliniche, creato movimenti di opinione, mobilitato il Parlamento. Del cancro al seno
ne parlano quotidiani, settimanali, mensili, le radio e le televisioni, politici e politiche. Per attivare le donne a sottoporsi a
indagini strumentali come mammografia ed
ecografia e cercare tumori in fase iniziale
che permettono di usufruire di trattamenti
chirurgici più conservativi del seno e di ottenere dalle terapie complementari (radio e
chemioterapie), oltre che maggiori successi
di guarigione, molto materiale informativo
gira negli ambulatori, nei negozi, nei mezzi
22
di trasporto. Grazie a questa eccessiva informazione di massa che illumina sui progressi della tecnologia medica, oggi si parla in
maniera diversa di “noduli” mammari. Così,
tuttavia, le donne mobilitate a partecipare
agli screening sono portate a pensare che il
tumore al seno sia la loro malattia preponderante, dalla quale guariscono se si sottopongono alle indagini richieste. In questa fase
sanitaria pochi si preoccupano di quanto
denaro si spende per mobilitare tante donne
per diagnosticare precocemente il cancro in
alcune di esse, di quali siano i loro disagi,
le loro aspettative nell’accogliere l’invito a
presentarsi nei centri di screening. Tra diecimila donne sottoposte a mammografia -se
tutto va bene, se il sistema funziona bene, se
le mammografie sono fatte bene, se i tecnici
le sanno leggere correttamente- scopriremo
cento donne con tumore, che nessuno aveva
diagnosticato prima, e altre 400 a cui chiederemo di sottoporsi a un iter diagnostico
più approfondito (ecografie, biopsie) per avere la sicurezza che il sospetto di cancro sia
fasullo. Le cento donne con cancro accertato
potranno usufruire di interventi conservativi, settanta di loro guariranno. Il messaggio
occulto che diamo è che se arriviamo tardivamente alla diagnosi moriamo… Ma già 50
anni fa, senza diagnosi precoce, almeno la
metà delle donne con tumore al seno viveva
a lungo, anche se con esiti devastanti da chirurgia, radio e chemioterapia. Oggi queste
terapie non comportano più mutilazioni ed
effetti collaterali insopportabili, quindi parliamo di esiti e disagi diversi, ma l’efficacia
è la stessa di 50 anni fa. E le donne di oggi
non sono da meno delle loro madri e delle
loro nonne nel mettere in campo le loro risorse di guarigione…
Lei quindi mette in discussione lo
screening?
Io dico che continuare a proporre lo screening nelle modalità messe finora in atto non
è più corretto: si può sfruttare meglio la mobilizzazione delle donne per interagire con
loro, valutare altre proposte sia informative
che organizzative. Sarebbe giusto setacciare
solo le donne a rischio e non mobilitare quelle che mai nella vita (e sono tante) svilupperanno un cancro al seno, mentre, casomai,
sono sotto tiro di altre malattie ed avrebbero
bisogno di altre prevenzioni. Oggi, poi, molte donne che si trovano di fronte alla diagnosi di cancro e devono affrontare il percorso
terapeutico, continuano a sentirsi dubbiose
e sole, malgrado il flusso informativo e operativo che le campagne di screening mettono in atto.
La malattia tumorale è comunque diversa
in ciascuna persona, non solo perché è diversa in termini isto-patologici e biologici, ma
anche perché essa si inserisce e si innesca
in una struttura psichica, corporea e relazionale unica e non codificabile: c’è chi soffre
del fatto che è stata intaccata la sua immagine (“Come? Sono stata sempre bene!”) e
si arrabbia con se stessa e col mondo. C’è
chi dice: “Mi è venuta, avrà un significato di
cambiamento”.
C’è chi si colpevolizza: “So perché mi è venuta e non posso cambiare”. C’è chi rimette
il suo corpo affidandolo alla scienza e non si
mette in discussione. Basterebbe già questo
a indirizzarci sulla diversità di senso di una
malattia nominata genericamente uguale
per tutti: la malattia fa parte sia del sistema
sanitario che del sistema personale, relazionale, culturale.
Quindi lei concentrerebbe le energie
anche su una “personalizzazione” della
cura...
Il sistema sanitario ha grosse possibilità di
ricerca mirata, ma sbaglia se non dà senso
ai suoi progressi comprendendone l’efficacia
nella considerazione del sistema biodinamico della persona con le sue relazioni e i suoi
valori. Partendo dagli stessi presupposti
biologici e sottoponendo le persone alle stesse terapie sappiamo che alcune guariscono,
altre si cronicizzano, altre vanno in progressione.
a domande del tipo: “Ho questo
tumore. Guarirò, vivrò?”, molti sanitari
cambiano il livello logico di risposta
Certamente molto dobbiamo ancora lavorare per trovare ulteriori specificazioni biologiche e arrivare a diversificare sottogruppi
e terapie sempre più specifiche, ma saremo
sempre carenti se non immettiamo il dato
di valore: il senso che la persona dà alla
sua vita e l’efficacia delle altre mille fonti
terapeutiche, comprese quelle spirituali a
cui essa ha attinto. Ad esempio, l’uso contemporaneo di altre terapie non convenzionali, come la realizzazione di sogni, la fuga
dagli impegni e dalle relazioni pesanti; e,
ancora, il ri-annodamento di nodi scorsoi,
l’attivazione dei processi di individuazione
o la decisione di lasciarsi andare e ritornare all’origine del tempo. Domande e risposte
che devono rientrare nei dati statistici e riempirli di senso e di relatività.
Pochi terapeuti condividono con i pazienti i
loro sistemi di valore e di relazione, pochi
individualizzano una terapia centrata sia
sulla tipizzazione delle loro cellule neoplastiche sia sulla dinamica della loro vita. Pochi terapeuti, inoltre, accettano di dialogare
con i loro pazienti sull’incertezza dell’andamento della loro malattia e della relativa
risposta terapeutica. A domande del tipo:
“Ho questo tumore. Guarirò, vivrò?”, molti
sanitari cambiano il livello logico di risposta: “Un 60-70% di persone che hanno avuto il suo problema è sopravvissuto a cinque
anni”. Risposta accettabile per chi usa la
razionalità come modalità di restare den-
tro i binari; non per chi usa l’intuito come
base dell’esperienza umana. In questi casi
l’insistenza della proposizione terapeutica
in virtù di una possibile maggior risposta
comporta danni e intrusività.
E che dire del termine “sopravvivere” da
noi usato in tutte le casistiche! è vero che
stiamo sopravvivendo allo tsunami, alle
guerre, ai genocidi, agli stupri in un’epoca
che permette ad alcuni di godere con altrettanta facilità, intensità e brevità delle bellezze del creato e dei prodotti di consumo
e di prestigio… Ma è questo malessere che
vogliamo ripercorrere nel proporre le nostre
terapie? La crisi per la malattia può essere
l’occasione per riprenderci la vita, ritrovare
l’essenzialità e il gusto dell’anima e non solo
continuare a sopravvivere.
le strutture di accoglienza sono
necessarie in un mondo che non ci
lascia il tempo di assistere i nostri cari
Quando ci ammaliamo è un momento doloroso e ricco di riflessioni e riproposizioni,
paure e speranze, semplicità e bisogni. Poco
viene restituito alla scienza e al mondo rispetto alla passione che ciascun individuo
esprime nei percorsi di diagnosi, cura, risposte e progressioni. Del resto, le persone a cui
capita una malattia che comporta una crisi
profonda, e quindi una rivisitazione del senso della vita, rappresentano una distonia
dei sistemi valoriali attuali e non innescano
processi di rinnovamento culturale.
L’uso del linguaggio mediatico non ha sortito un’attiva partecipazione della popolazione nel processo di salute in oncologia:
l’uso di alcune parole che svelano le nostre
credenze profonde rispetto al cancro e l’indicazione a comportamenti rigidi e sottomessi, ci porta a una in-cultura sanitaria in un
campo che pure è pieno di buone intenzioni
e buone terapie.
Mi sembra di capire che voi privilegiate una complessità del vivere la malattia e della cura...
Quando viene diagnosticata la presenza del
cancro, presi dal capire cosa succede in termini biologici, a noi terapeuti risulta difficile “ascoltare il corpo” dell’altro in termini
biografici, relazionali, emozionali. Questa
mancanza di ascolto del disagio crea uno
iato nella scienza e nell’organizzazione. La
scienza risulta parziale e artefatta se -una
volta agita la scorporazione degli organi
per focalizzarne il problema specifico- non
lavora sulla riconnessione individuale e sistemica. Parlare di medicina d’organo (come
appunto: tumori al seno) facilita la conversazione e l’indirizzo scientifico, ma allontana dalla complessità della cura e dalla
possibilità di catturare la realtà da parte
della scienza. Nella mia pratica medica poche volte ho assistito alla scorporazione del
seno, del polmone, della laringe, del colon
da parte dei pazienti, mentre assisto a un
proliferare di pubblicazioni e di studi segmentari sia in ambito medico che psicologico. La focalizzazione d’organo è necessaria
quanto l’incorporazione della dinamica sistemica. L’attenzione all’organo va messa
a fuoco e poi allontanata per uno sguardo
d’insieme che comprenda lo sfondo. Per ca-
pire la complessità della realtà-malattia, di
cui facciamo parte anche noi che prescriviamo, dobbiamo allertare tutti i sensi ed
entrare nel vuoto prescrittivo per arrivare
liberi alla decisione terapeutica condivisa e
trascendentale. Nella scienza le zoommate
tra l’obiettivo macro per la lettura del vetrino e l’obiettivo a distanza per la visione
del contesto e della dinamica relazionale ed
emozionale sono assolutamente necessarie.
La scienza, quindi, sarebbe troppo dedita al segmento?
Le definizioni specialistiche facilitano l’indirizzo del percorso, ma separano e disintegrano l’esperienza. L’esperienza di chi si
ammala, d’altra parte, resta isolata e non
riesce a diventare cambiamento e rinnovamento culturale. Faccio un esempio di
indirizzo specialistico. Nel ’75, all’Istituto
Tumori di Milano, mettemmo in piedi una
divisione di Terapia del Dolore. Anche se
sottolineava un problema trascurato nella
cura oncologica, la definizione di terapia del
dolore mi pareva già una stonatura. L’apertura di una Divisione di questo genere -facilitata dalla convinzione (spesso errata) che
la malattia oncologica comporta dolore- ci
permise di mettere a fuoco strategie anestesiologiche e farmacologiche, ma separò nel
malato l’esperienza del dolore cronico e incoercibile dal resto delle cure e noi analgesisti
dai sistemi sanitari oncologici.
Nel tempo, più carica di esperienza clinica,
libera da vincoli di ruoli e pastoie identitarie, mi adoperai per riorganizzare la scienza
medica oncologica in maniera meno settoriale. Nei protocolli di cura d’eccellenza -come il
protocollo della Forza Operativa Nazionale
per il Carcinoma Mammario- abbiamo fatto
scomparire il termine “terapia del dolore e
riabilitazione” reimmettendo le procedure
specialistiche in ogni atto curativo, con una
visione anticipatoria del dolore cronico e del
disagio fisico e psicologico, all’atto stesso
dell’osservazione clinica oncologica.
Oggi restano in piedi e sorgono nuovi centri di Terapia del Dolore che vengono sempre più associati a un’altra segmentazione
dell’esperienza umana: a quella fase evolutiva che non risponde più alle terapie e
che è stata definita terminale e della cura
palliativa. Le strutture di accoglienza sono
necessarie in un mondo che non ci lascia il
tempo di assistere i nostri cari, pena l’esclusione sociale, tuttavia separa l’individuo dal
contesto di cura esplicata in precedenza. La
separazione e l’accoglienza riparatoria sono
ormai insite nel nostro sistema sanitario.
Il fiorire di tante associazioni di persone
operate e la produzione di tanti libri che
raccontano dell’esperienza individuale dopo
la malattia fa dedurre che l’organo è curato e delegato agli ospedali e il corpo -con la
sua emozione e le sue relazioni- rimasto in
solitudine, richiede sostegno in luoghi di
possibile dialogo tra simili, a dimostrazione
che anche l’integrazione nei sistemi sociali e
familiari a volte risulta difficile quando non
impossibile.
Per sollevare le persone nella fase di disagio per l’evolutività della malattia sono nate
associazioni di “assistenza al malato terminale di cancro”. è un messaggio di preoccupazione da parte del mondo del volontariato
per le persone che vengono poco assistite
nelle strutture pubbliche e che restano spesso sole.
Tuttavia, ancora una volta la strutturazione
di luoghi e di azioni di accoglienza separata, perpetua le nostre credenze limitanti sul
cancro. Solo i malati di cancro vanno in fase
terminale? Che differenza c’è tra un terminale di cancro e un terminale di un’altra
malattia? La struttura separata e ultraspecialistica conferma e non stempera il tabù
(cancro uguale malattia dolorosa e portatrice di morte), oltre a inficiare le belle proposizioni da noi usate nella fase di prevenzione
oncologica.
Quindi, l’eliminazione del dolore è sacrosanta, sacrosante sono le crociate per togliere i
vincoli alla somministrazione dei narcotici
e a quant’altro sia utile alla buona morte.
L’errore è quello di introdurre “unità/divisioni” ospedaliere specifiche separando il
dolore dagli atti di cura oncologici e artificiosamente defininendo “terminale” il processo
di avvicinamento alla morte. Ci dovrebbero
essere al loro posto laboratori di ricerca, di
verifica e di insegnamento del buon modo
di procedere per la prevenzione e il sollievo del dolore, là dove questo si presenti con
intensità prima che arrivi a essere cronico
e intrattabile. Eviteremmo alcune induzioni
del tipo: “Se vado in terapia del dolore vuol
dire che sto morendo”, e agevoleremmo l’armonia del lasciarsi andare...
Quindi, per concludere, come potrebbe
descrivere il vostro modo di lavorare?
Se le specificazioni possono diventare sovrastrutture e possono contravvenire alla regola della buona cura, l’astensione dalle definizioni può essere confusiva e disperdente.
l’attenzione all’organo va messa a fuoco
e poi allontanata per uno sguardo
d’insieme che comprenda lo sfondo
Quando sono uscita dall’Istituto dei Tumori
e ho creato Metis con il gruppo di professionisti che mi ha seguito con entusiasmo, abbiamo fatto scomparire parole che definivano alcune nostre competenze in virtù di una
modalità di attenzione alla persona e ai suoi
sistemi di appartenenza: via dunque oncologia, senologia, riabilitazione, terapia del
dolore, psicologia… Semplicemente Metis,
una figura mitologica con i suoi significati
profondi e nascosti. Cos’è successo? Al di
là dei collegamenti di ricerca con strutture
specialistiche (lo storico Int e il neonato Ieo
di Milano) e al di là del passaparola e dei
percorsi carsici di internet, non è facile individuarci. Restiamo la nicchia per pochi. Né è
facile trovare fondi per la ricerca integrata.
Ogni tanto ci offriamo l’opportunità di incontrare le persone che ci hanno comunque
scovato, stimolandoci a incontri d’arte e d’amicizia. In queste occasioni le persone riconoscenti per questo modo di lavorare libero
e complesso danno il loro contributo, anche
con minime donazioni, a far sì che la nostra
esperienza possa continuare a procedere
fuori dalle luci della ribalta, ma dentro il
cuore e lo spirito inquieto di ciascuno.
(a cura di Paola Sabbatani,
Una città n° 129, maggio 2005)
23
I limiti del medico
Tornare a vedere il malato come persona usando la tecnologia e le conoscenze di oggi, evitare di affidarsi esclusivamente
alle misurazioni e agli standard prestabiliti, porsi, insieme ai pazienti e ai parenti, il problema dei limiti della cura, in tanti
casi chiedersi che tipo di speranza si dà. Intervista a Marco Bobbio.
Marco Bobbio è primario della Cardiologia
dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.
Il libro di cui si parla nell’intervista è Il malato immaginato. I rischi di una medicina
senza limiti, Einaudi, 2010.
Cosa intende con l’espressione “il malato immaginato”?
Il vero problema del sapere medico contemporaneo, nascosto, latente, sono i limiti della medicina. Al giorno d’oggi si parla sempre
dei traguardi futuri, si dice che si vivrà fino
a 130 anni, che si curerà questa e quella malattia. Ma non si riflette abbastanza su che
cosa tutto questo significhi. Quando a una
riunione ho sentito affermare che si potrà
arrivare fino a 130 anni non mi sono trattenuto dal commentare: “Non auguro a nessuno di vivere fino a cento anni per doversi
occupare della madre di 130”. Purtroppo, un
altro grande problema attuale è che tutta
l’evoluzione tecnologica -che è indispensabile, fondamentale- viene però spesso utilizzata in modo non appropriato. C’è un ricorso
alla tecnologia anche quando non è sufficientemente conosciuta e magari dopo anni
ci si rende conto che i vantaggi prospettati
non sono confermati. Nel frattempo i trattamenti sono entrati nella routine e non è più
nemmeno facile tornare a farne a meno.
Il termine “immaginato” si riferisce al malato per come viene rappresentato dai medici per dare forza e lustro alla medicina e al
proprio lavoro. Allo stesso modo, si riferisce
a come anche i malati arrivano a immaginare se stessi, ma al di là del malato immaginato c’è il malato reale.
quello delle emozioni è un argomento
che non viene quasi mai trattato
nei libri di testo né nelle conferenze
Nel libro introduco anche il concetto della
medicina sostenibile, un termine che di solito viene utilizzato in ambito economico e
riferito alla sostenibilità economica della
medicina. In realtà, affermo che la medicina
è sostenibile se è sostenibile da quel paziente, dal suo contesto affettivo, dalla sua vita,
dal suo assetto emotivo. Certe volte alcuni
pazienti non accettano un determinato trattamento in un momento in cui sono fragili,
deboli, ma lo richiedono sei mesi dopo, ed è
del tutto legittimo.
Oppure accade il contrario, che i pazienti si
pentano per aver accettato un trattamento,
perché emotivamente erano stati trascinati.
Quello delle emozioni è un argomento che
non viene quasi mai trattato nei libri di testo né nelle conferenze mediche. Ma è un errore, perché questo è un po’ anche il nucleo
della innegabile conflittualità che c’è fra medici e pazienti dovuta in gran parte al fatto
che il paziente è spaventato, preoccupato,
così come il medico è angosciato che il pa-
24
ziente non guarisca, che la procedura vada
male. E certe volte fra queste due angosce si
creano delle scintille, dei conflitti che diventano difficilmente gestibili.
Com’è possibile superare questi limiti
nella medicina contemporanea?
Ci sono due punti secondo me importanti:
il primo impone di tenere conto dell’importanza della ricerca scientifica, dell’evoluzione tecnologica, ma il secondo ci ricorda che
non ne dobbiamo diventare schiavi. Non
dobbiamo neppure ricadere nella situazione
precedente, quella in cui ogni medico faceva
quello che riteneva più importante, senza
dover rispondere delle sue scelte.
Il mio messaggio non è quello di ritornare ai
“bei” tempi andati. Piuttosto, partendo dalle
conoscenze che abbiamo adesso e da quelle
che avremo in futuro, è necessario muoversi
verso una personalizzazione, una individualizzazione della medicina in cui la tecnologia
e le conoscenze derivanti dalle ricerche svolgono comunque un ruolo determinante. Se
invece usiamo le misure solo come strumenti indiscutibili, perché le riteniamo oggettive, allora possiamo arrivare a commettere
grossi errori.
Quello che affronto tutti i giorni è, da un
lato, un tentativo di smitizzazione della presunta oggettività della scienza, dall’altro,
uno sforzo di re-indirizzamento delle ricerche verso le necessità particolari e personali
di ogni malato.
Vorrei specificare che in alcune situazioni,
per esempio nel caso dei bambini, dei quali
ho poca esperienza, alcuni dei ragionamenti
che io faccio non si possono applicare. Per
esempio, bisogna capire quando la medicina
non può dare più molto o può dare qualcosa
che è però irrilevante nella vita di un paziente. Ma un conto è il caso di un paziente
di 85 anni che ha già avuto numerosi ricoveri e interventi chirurgici, per cui ci si può
fermare a riflettere. Un conto è aver a che
fare con un bambino con la leucemia, per il
quale vale la pena di dedicare tutte le energie, compreso il farmaco sperimentale, per
provare veramente di tutto. In questo caso
si può salvare una vita che poi avrà un’estensione ulteriore di altri venti o trenta
anni almeno.
Il problema di cui parlo si pone per la gran
parte dei pazienti, invece, che frequentano i
nostri ospedali, ai quali diamo delle speranze di vita aggiuntiva di qualche settimana o
al massimo di qualche mese.
Allora ci dobbiamo porre il problema: che
tipo di speranza di vita gli do? Questo mese
che gli daremo in più, come lo passerà? Ne
vale la pena, sì o no? Dobbiamo imparare a
confrontarci tra medici e con pazienti e parenti. Bisogna sempre porsi il problema dei
limiti.
Questo per quanto riguarda la cura.
Ma cosa pensa della possibilità di agire
in difesa della salute anche con la prevenzione?
Quando parlo di prevenzione, la intendo
sempre in ambito strettamente medico, perché non conosco gli altri contesti, come la
prevenzione ambientale, per esempio. Ma
certamente questa visione ristretta della
prevenzione è un limite della medicina in generale e mio in particolare. Perché limitando
gli aspetti della prevenzione al solo ambito
medico, va a finire che si pone l’accento solo
sull’aspetto individuale, colpevolizzante, che
non tiene conto degli aspetti sociali.
la medicina non ha un grosso
interesse per la prevenzione anche
perché il risultato non è tangibile
Io posso colpevolizzare una persona che
non fa abbastanza moto o che compra cibi
preconfezionati nei supermercati, ma se
tutto il mondo gira così, se tutta la pubblicità gira così, l’unico risultato è che questa
persona si sente in difetto tutte le volte che
va al supermercato. La medicina non ha un
grosso interesse per la prevenzione anche
perché il risultato non è tangibile. Se opero
un paziente moribondo ottengo un risultato
immediato. Quando avvio un programma di
prevenzione contro l’infarto, non si vede il
risultato. La prevenzione è un investimento
che non ha un ritorno quantificabile e quindi dà meno soddisfazione.
Lei è perplesso su un certo uso delle linee guida.
Io sono nato professionalmente come metodologo della ricerca e questo è stato il mio
principale campo di lavoro. Anche negli Stati Uniti ho lavorato in questo settore. E sono
stato un grande fautore sia della “medicina
basata sulla prova di efficacia” sia delle linee guida, e mi rendo conto -non dico che
sono pentito, né di averle abbandonate- che
questi strumenti sono molto importanti, ma
vanno utilizzati in un modo adeguato.
Invece, proprio mentre si tende a farne un
uso dogmatico, ci si accorge che la ricerca
scientifica fornisce sì delle informazioni, ma
non fornisce dei dati assoluti e quindi va interpretata e utilizzata in modo appropriato.
Posso dire che c’è una sopravvalutazione
della statistica soprattutto da parte di chi
non conosce bene i problemi quotidiani della medicina. Non si possono stabilire delle
regole assolute per decidere quali pazienti
debbano essere trattati e quali no.
Ho qui davanti le linee guida italiane per
la diagnosi e il trattamento del diabete. Ci
sono documenti analoghi della Scozia, di
varie società americane ed europee che ripetono le stesse cose. Sono 150 pagine, doppia colonna, corpo otto, di definizioni, precisazioni, classificazioni, come se i pazienti
potessero essere tagliati col coltello: questo
ha bisogno di quel trattamento e quello no.
C’è una tendenza scientista a pensare che
la biologia possa essere confinata in numeri, cut off, categorie, per cui tutto quello che
entra nello schema va trattato, tutto quello che non entra non va trattato. In realtà
il mondo della biologia, e della medicina in
particolare, è molto più sfumato. Dopo aver
letto queste 150 pagine mi sono reso conto
che gran parte dei pazienti che ho davanti
sono diversi da quelli lì. È vero che potrei
fare degli studi sempre più particolareggiati, ma non potrò mai avere dei dati che
intercettino tutte le caratteristiche di ogni
singolo paziente.
Allora dovrei fare magari uno studio differenziando gli effetti che il farmaco ha sui
giovani o sugli anziani, sugli uomini o sulle
donne; dovrei poi fare uno studio di verifica sulle donne anziane diabetiche. Ma cosa
potrei dire degli effetti sulle donne anziane
diabetiche con più di 80 anni e su quelle con
meno di 80 anni? Se porto questo discorso
all’infinito non troverò mai alcuna soluzione. Allora tanto vale fermarsi prima, dire
quali sono le indicazioni generali ottenute
dallo studio e poi cercare di capire, caso per
caso, se il trattamento può essere o meno
favorevole al paziente. Inoltre, va detto che
per introdurre un nuovo farmaco nel mio
armamentario terapeutico devo disporre di
vantaggi rilevanti, non solo dello zero virgola qualcosa, perché, anche se dal punto di
vista statistico il dato sperimentale rispecchia i criteri della significatività statistica,
magari dal punto di vista della rilevanza clinica è invece del tutto marginale e non giustifica la spesa per un nuovo trattamento.
Lei denuncia una certa informazione
scientifica e medica superficiale, ecla-
tante oppure addirittura condizionata…
C’è una ricerca indipendente, onesta, svolta
da ricercatori che vogliono capire cosa succede. In altri casi, invece, la ricerca è condizionata e molto spesso per l’intervento delle industrie che producono farmaci e dispositivi,
pur nell’ambito di procedure standard che
vengono chiamate Good clinical practice. Ci
sono, infatti, all’interno di queste Good clinical practice dei margini per fare in modo
che le conclusioni della propria ricerca siano
il più positive possibile. Su questa si sovrappone un’informazione a sua volta parziale:
da una parte il ricercatore, comunicando i
propri risultati, cercherà di sottolineare più
gli aspetti positivi che quelli negativi, perché vuole dare la maggiore enfasi possibile
al proprio lavoro, dall’altra parte anche l’industria, che ha dei grandi interessi economici, tenderà a far risaltare solo gli aspetti
positivi e non quelli negativi dell’applicazione di un nuovo ritrovato. Attraverso tutta
questa filiera del messaggio quello che arriva al lettore è un messaggio distorto. è difficile individuare chi sia disonesto; ognuno
aggiunge un pezzetto di distorsione e quello
che arriva al fondo non corrisponde al messaggio iniziale. Per ultimo, bisogna tenere
conto di quello che capisce il lettore.
Quanto contano gli interessi extra-lavorativi nelle decisioni sanitarie?
Il conflitto di interessi dal mio punto di vista
non consiste soltanto nella monetizzazione,
nella corruzione, quella volgare di quando
ti danno diecimila euro se prescrivi determinati farmaci. Il conflitto di interessi è il
condizionamento del proprio lavoro dovuto
a interessi che esulano dal rapporto fra il
singolo medico e il singolo paziente.
Immagini un centro specialistico dove si
fanno determinate procedure diagnostiche;
per mantenere la competenza bisogna farne
un certo numero all’anno, ma se il numero
diminuisce per condizioni epidemiologiche
o anche solo perché hanno aperto un altro
centro nell’ospedale vicino, cosa succede?
Che nessuno dei due centri ha più le competenze sufficienti per rimanere al passo con
l’evoluzione tecnologica, con la manualità,
con l’esperienza. E tuttavia è difficile che
uno dei due centri chiuda, è più facile che
vengano fatte fare procedure anche a pazienti che non ne hanno così tanto bisogno.
Su questo punto devo dire che la programmazione sanitaria è molto carente. Dovrebbe essere la Regione a stabilire quanti centri sono necessari per eseguire determinate
procedure. E invece c’è una corsa ad acquisire tutte le competenze possibili. Il direttore generale dell’assessorato alla sanità in
alcune conferenze ha dichiarato che con il
numero dei laboratori di emodinamica attivi
in Piemonte, tenendo conto del numero di
operatori che ci devono essere in ogni centro
e del numero di analisi che ogni operatore
dove eseguire per mantenere un’adeguata
competenza tecnica, mancano duemila infarti all’anno in Piemonte. Considerazione
lodevolissima, ma all’obiezione “siete voi che
le avete approvate”, la risposta è stata che
è il sistema sociale che spinge per la moltiplicazione dei centri; l’ospedale, il sindaco,
il direttore generale, gli stessi cardiologi di
quella zona vogliono il loro centro e “noi non
siamo in grado di opporci”. Però se non è in
grado la Regione di regolare l’attività, francamente, non si sa chi possa farlo.
Tornando ai medici, molti già oggi si rendono conto di un’eccessiva invadenza del proprio lavoro nelle vite private delle persone,
imponendo trattamenti mediamente più efficaci e “per il bene del paziente”.
dopo aver letto queste 150 pagine mi
sono reso conto che gran parte dei
pazienti che ho davanti sono diversi
Costoro percepiscono il disagio di una medicina parcellizzata, riduzionista, che ha
stabilito in modo dogmatico, cosa è meglio.
La medicina si sta appiattendo ad applicare
protocolli standard a chiunque.
Giorgio Israel, storico della scienza e matematico, ha scritto Per una medicina umanistica (Lindau, 2010), con sottotitolo Apologia di una medicina che curi i malati come
persone. Israel, proprio osservando che la
medicina sta perdendo una delle sue caratteristiche peculiari rispetto a tutte le altre
scienze, che è quella del rapporto umano,
afferma che vi è una forte incongruenza:
perché mai i medici si mettono a misurare
tutto quando hanno accesso a una potenzialità così importante che è il rapporto umano,
la conoscenza del singolo paziente, che va al
di là di tutte le possibili misurazioni?
è giusto utilizzare le misure per capire i fenomeni, ma poi il rapporto di cura bisogna
giocarselo con il paziente.
(a cura di Enzo Ferrara.
La versione integrale è uscita su
Una città n° 177, settembre 2010)
25
Barbara Duden
Salute? No, grazie!
Le coraggiose posizioni di Ivan Illich sulla medicalizzazione della vita.
Mi propongo oggi di riflettere con voi sul motivo del risoluto “Danke nein!”, “No, grazie!”,
che è stato anche l’elemento centrale delle
aspre critiche di Ivan Illich alla medicalizzazione della vita. Nelle sue riflessioni sulla
medicina, la malattia, il dolore e la ricerca
di salute organizzata, si possono distinguere tre periodi: il saggio Nemesi medica negli
anni Settanta; il “No, grazie!” alla sanità
come sistema intorno agli anni Novanta; infine la critica a una medicina che si strutturava come una “roulette probabilistica” per
la gestione dei rischi, in un discorso tenuto
a Bologna nel 1998.
Ciò che aveva scritto sulla medicina come
simbolo istituzionale della modernità non
gli bastava più poco dopo la pubblicazione
del libro. Non perché avesse cambiato atteggiamento, ma perché sentiva che alla fine
del ventesimo secolo la sua critica doveva
essere argomentata in modo diverso.
Nemesi medica
In Nemesi medica, pubblicato nel 1976
-in un momento culminante della fede nel
progresso e nello sviluppo- Ivan analizza
l’impresa medica, come esempio specifico
dell’inadeguatezza e contro-produttività dei
servizi pubblici in un contesto industriale.
Analizza la medicalizzazione della salute
come un fenomeno presente in tutte le società industriali, in un mondo materiale
pieno zeppo di beni, dove la persona diventa
incapace di produrre da sé cose utili e utilizzabili. Questo valeva nello stesso modo per
l’impresa educativa, con la scolarizzazione
forzata di tutti i bambini, che blocca l’autonomo autoapprendimento, e per la congestione delle strade che rende il camminare
senza senso e pericoloso.
Ivan Illich riconosceva l’urgenza di strappare dalle mani degli esperti la valutazione
del sistema medico-farmaceutico. Lo vedeva
come un compito politico preminente, che
rendeva necessari studi e sforzi personali propri di una ricerca che andava al di là
della tutela professionale. Per trovare un’alternativa concreta al sistema che ci opprime, l’immaginazione doveva essere liberata
dalle strettoie, in modo da rendere visibile
l’enorme ricchezza dei modi di esserci l’uno
per l’altro e per se stessi. I professionisti non
sono in grado di vederla. Già di per sé questo
ampliamento della visuale ci permetterebbe
di comprendere come la colonizzazione della vita quotidiana attraverso la medicalizzazione della malattia, dell’invecchiamento
e della morte ci allontani dalla capacità di
prenderci cura con mezzi nostri, di metterci
in gioco, che ci viene ostacolata dal monopolio degli esperti.
Ivan sottoponeva la “medicina” -sistematicamente e in modo esemplare- a un’analisi
su tre livelli: cosa compie il sistema medico tecnicamente, cosa compie socialmente e cosa strutturalmente? Cosa promette
come istituzione e che effetti produce? Qual
è dunque, nella società industriale, la sua
specifica “controproduttività” iatrogena sul
piano clinico, sociale, strutturale/culturale.
Iatrogenesi clinica, sociale, strutturale/culturale
Per quella medicina fortemente sviluppata
nei decenni del 1960 e 1970 nel suo libro fu
in grado di documentare che, oltre una certa
soglia, i servizi organizzati da istituzioni e
professionisti non solo non conseguono l’obiettivo proclamato, ma producono il contrario. Provocano cioè una nuova malattia,
la malattia iatrogena, causata dalla stessa
Bolzano 5 luglio, seminario su “Donne e tecnologie mediche: come viene cambiata la percezione di sé e del proprio corpo”. Con Barbara Duden e Olivia
Fiorilli, autrice e ricercatrice. Dottorato di ricerca all’Università La sapienza di Roma su “La costruzione dell'infermiera moderna: genere, controllo dei
corpi, immaginario 1900-1930”
26
medicina usata per combattere la malattia.
Illich dimostrò che si verificavano proporzionalmente più incidenti negli ospedali rispetto agli altri settori industriali, a eccezione
dell’industria estrattiva e di quella edilizia.
Quanto più le più complesse tecnologie penetravano nelle routine degli ospedali, tanto
più grotteschi e inevitabili diventavano gli
incidenti.
Tutti i successivi tentativi di limitare questa iatrogenesi clinica attraverso la stessa
medicina hanno avuto un effetto paradossale: il sistema diventa ancora più dannoso
quando gli specialisti stessi banalizzano gli
effetti generatori di questo tipo di malattie
definendoli “effetti collaterali”.
La iatrogenesi sociale si riferisce invece
alla distruzione del benessere personale che
ognuno può creare da se stesso. Ivan sostiene che, paradossalmente, oltre una certa soglia il tasso di malattia di una popolazione
cresce proporzionalmente alla quantità di
servizi medici disponibili. La medicina rende la società più malata e paralizza la capacità personale di provvedere alla propria
salute. Così il costo dei servizi medico-correlati occupa sempre più spazio nei bilanci
delle società industrializzate. Questa sovrapproduzione che diventa sovra-consumo
tocca anche altre istituzioni: il volume globale dell’educazione impedisce ai bambini di
seguire la loro curiosità, blocca il loro coraggio intellettuale e la loro sensitività. Oggi è
la sovrabbondanza di informazioni a creare
confusione e caos.
La soglia della iatrogenesi sociale si raggiunge quando si rompe l’equilibrio tra l’offerta di servizi medici e la reale possibilità
di guarigione delle persone. Questa vera e
propria invasione farmaceutica porta a ritenere che non esistano né guarigione, né benessere, al di là dei rituali, delle definizioni
e delle normative mediche.
Ivan Illich metteva in luce infine gli effetti
della iatrogenesi strutturale/culturale. Guarire è un verbo che descrive in modo molto
bello l’azione del malato. Non può essere
messo in passivo: non posso “venire guarito”, come non posso “venire andato” o “venire morto”. All’origine della medicina come
istituzione, che avrebbe portato a descrivere
questa azione col verbo al passivo, vi era un
sogno, simile al mito odierno secondo cui se
l’ambiente migliora la malattia si dilegua. I
malati hanno imparato che esistono entità
ostili -malattie astratte- il cui debellamento è compito dei medici. Un nuovo linguaggio, elaborato nelle sfere sociali più elevate,
penetra l’intera società fino alle sua fondamenta. Il dominio dei medici sulla lingua
di coloro che soffrono diventa un baluardo
che tutela l’esclusiva responsabilità della
professione medica. Il continuo ricorso a un
linguaggio specializzato ha impedito a sua
volta che la medicina venisse de-professionalizzata.
Alla fine di Nemesi medica, Ivan riassume:
“In verità, il miracolo della medicina moderna è un inganno diabolico. Consiste nel
portare, non solo individui ma intere popolazioni, a sopravvivere a un livello mostruosamente basso di salute personale. La nemesi medica è l’effetto negativo di un ordine
sociale che in origine voleva offrire pari e
Barbara Duden è una storica, docente emerita all’Università di Hannover. L’elemento centrale della
sua ricerca e del suo insegnamento ruota intorno alla storia del corpo, del corpo vissuto, del corpo rappresentato. Così come la storia dei sensi, dello sguardo in primo luogo.
Sono stati tradotti in Italia due suoi testi da Bollati Boringhieri: Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di vita (1994) e I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico sul
corpo delle donne (2006). In Germania, inoltre, sono stati pubblicati Geschichte unter der Haut, e un
suo parere alla commissione d’inchiesta del Bundestag, Aspekte des Wandels des Verständnisses von
Gesundheit, Krankheit, Behinderung als Folge der modernen Medizin.
Dall’inizio degli anni Ottanta ha lavorato a stretto contatto con Ivan Illich. Negli anni Novanta, fino
alla sua morte nel dicembre 2002, Illich ha insegnato spesso, nei semestri invernali, all’Università di
Brema. La sua casa ospitale gli ha offerto in quel tempo la cornice ideale, tra piatti di spaghetti e buon
vino, per il proseguimento delle discussioni suscitate dalle sue lezioni.
Chi meglio di lei può riassumere e illuminare le posizioni di Ivan Illich sulla medicalizzazione della
vita?
Franz Tutzer
migliori opportunità nella gestione autonoma della vita ed è giunta infine al punto di
distruggerla”.
Cercheremo invano un “No, grazie!” in Nemesi medica, perché in quel tempo si trattava del tentativo di porre dei limiti oggettivi
alla medicina, attraverso una rigorosa analisi economica del sistema industriale e di
sfatare il mito della promessa di guarigione
attraverso il monopolio clinico e l’alta tecnologia. Conclude Illich: “La società in grado
di ridurre al minimo l’intervento di esperti
è quella che offrirà sempre le migliori condizioni di salute”. Sperava in questo modo di
ridurre la dilagante dipendenza dalla medi-
cina come istituzione, dalle sue tecniche e
dalla sua diagnostica classificatoria. Sperava, soprattutto attraverso un indirizzo politico di auto-limitazione sociale, di contribuire a creare le condizioni per un incontro
semplice e sobrio tra medico e paziente.
Auto-integrazione nel sistema
Nella prima edizione inglese, il libro Nemesi
medica aveva il seguente sottotitolo: “L’espropriazione della salute”. Quindici anni
dopo, Ivan ha dovuto constatare che tale titolo si era realizzato in un modo a suo tempo
inimmaginabile e inquietante. Il suo monito di allora, che le persone prendessero in
Ivan Illich e Alexander Langer
“Sandra Mangini, la cantante di Venezia, e io,
una storica del corpo vissuto. In realtà siamo
però in quattro, un quartetto”. Cosí ha aperto
il suo intervento Barbara Duden. “Pensiamo
a due amici, Alexander Langer e Ivan Illich,
per molti anni legati profondamente. Ho incontrato Alexander quando andò a trovare
Ivan a Brema, a Firenze, a Bolzano. Ciò che
mi è rimasto di questi incontri è un particolare
comune a questi due uomini, il vecchio ebreo
cattolico e il più giovane verde cristiano. Come
posso parlarne senza banalizzare? Il modo miglior è farlo attraverso un racconto: quando nel
dicembre 2002 Ivan morì, Madre Jerome, una
monaca benedettina amica di Ivan, scelse una
citazione dal Vangelo di Luca (12, 48): “Sono
venuto a portare il fuoco sulla terra; e come
vorrei che fosse già acceso!” (ignem veni mittere in terram, et quid Volo nisi ut accendatur).
Alexander Langer risplendeva di questa luce.
La condivideva con quelli che gli stavano ac-
canto, li illuminava e li rallegrava. Alexander
brillava di una luce così bella, di certo dovuta
al fatto che conosceva l’oscurità. Esattamente
come Ivan.
Ivan spesso raccontava di Helder Camara, il
quale, nel bel mezzo delle torture che insanguinavano il Brasile, gli aveva detto: “Non arrenderti mai. Fin tanto che una persona è viva, da
qualche parte sotto la cenere c’è un residuo di
brace, e alimentarlo è il nostro totale compito”.
E Ivan raccontava come Helder chiudeva le sue
mani -delle mani magre, particolari- intorno
alla sua bocca, e soffiava, e diceva: “Devi soffiare... con attenzione, con molta attenzione,
e soffiare... Non devi preoccuparti se prende
fuoco nuovamente o no. Ciò che devi fare è
alimentarlo”. Oggi ricordiamo due “soffiatori”
grandiosi. La loro amicizia nacque da questa
speranza comune di accendere allegria, luce.
Penso che i vincitori del Premio siano anch’essi
dei simili “soffiatori”.
B.D.
27
mano la responsabilità sulla propria salute,
si adattava perfettamente alla programmatica politica degli anni Settanta. “Allora,
non mi ero reso conto che quella morbosa
bramosia di salute nell’era del System-Management si sarebbe trasformata in un’epidemia talmente complessa”. Da tempo ormai la salute non aveva più nulla a che fare
con un benessere personale e una capacità
di arrangiarsi concreti, ma era diventata
una risorsa sempre più scarsa influenzata
dalle esigenze economiche e dalle condizioni
ambientali.
Con la frase: “Salute sotto la propria responsabilità, no grazie!”, Illich rifiutava l’imposizione di adattarsi agli irresponsabili inviti
della società industriale a investire nella
propria salute, di migliorarla sotto la guida
di esperti, consulenti e professionisti. “L’auto-limitazione -scriveva- è in contrasto con
la moda dell’auto-aiuto, dell’auto-gestione o
addirittura dell’auto-responsabilità; tutte e
tre rendono l’auto-integrazione nel sistema
mondiale un imperativo categorico”. In questo secondo periodo della sua critica, a Illich
non interessavano tanto le conseguenze iatrogene della società industriale, bensì la distruzione del senso della realtà e la perdita
di significato dell’esperienza corporea sensoriale e personale. “Questa salute -sostenevanon è più una cosa che viene vissuta come
benessere. Viene intesa come adattamento
ottimale nella cornice ecologica ed economica di singoli sottosistemi individuali. Il
consenso a questo bisogno di adattamento si
riduce all’estinzione della soggettività”.
Negli anni Ottanta fu possibile constatare la diffusione di nuovi linguaggi derivati
dal computer e dal pensiero cibernetico. Le
persone parlavano del sistema cardiovasco-
lare come di un computer, del numero dei
Linfociti-T o della debolezza del loro sistema immunitario: punto finale di concetti che possono a malapena ancora essere
considerati delle metafore o come passaggi
sensoriali tra ambiti separati. Dicono certo
ancora qualcosa di “corporeo”, ma non si riferiscono più a quasi niente di fisico o anche
di percepibile.
Riflettere su se stessi alla luce di questi concetti comporta una grave perdita del senso
di realtà, un profondo disorientamento e
una perdita del proprio sentire.
A un’intervistatrice che gli chiedeva nel
1990 cosa fare contro il buco dell’ozono causato dall’industria, Ivan Illich spiegò ciò che
gli stava veramente a cuore: “Io rinuncio
alla salute. È terribile... Riconosco la mia
impotenza, la sento profondamente. Questo
compito non può essere svolto da soli, è necessario partire dall’amicizia, dalla vecchia
‘philia’. È possibile rinunciare. Una rinuncia da esercitare consapevolmente, criticamente, con disciplina, per la quale una volta
c’era un nome: ‘ascesi’”.
solo chi padroneggia l’arte
di morire e di soffrire può coltivare
un’arte del vivere
“È un ‘No, grazie!’ alle ovvietà sulle quali è
costruita la nostra società. Per esempio, la
‘propria responsabilità’ in un mondo dove
non si può nemmeno consegnare decentemente una scheda elettorale, in un mondo
in cui sempre più ciò che precedentemente
si chiamava ‘libertà democratica’ diventa
auto-integrazione simbolica, in un mondo
in cui apparentemente vi viene offerta una
scelta, ma in realtà sottoscrivete solamen-
Sandra Mangini, attrice, cantante e regista veneziana
Il cancro. E poi... (di Carlotta Nobile*)
29 agosto 2012
E poi mi sono accorta che quasi mi fa bene
dire “ho il cancro”, quasi mi aiuta ad accettarlo, chiamando ogni cosa con il proprio
nome di battesimo, traducendo in parole una
condizione di malattia a cui ancora -dopo un
anno- una parte di me non vuole e non può
abituarsi. Pronunciando queste sei lettere è
come se l’incubo prendesse forma concreta,
come se quella patina che ormai vedo fra
me e il mondo diventasse finalmente visibile
anche agli altri. E la cosa, stranamente, mi
aiuta.
Ho capito fin dall’inizio che avrei dovuto
convivere con la mia malattia per un tempo
abbastanza lungo e che avevo davanti a me
due sole possibili strade: fare finta che non
ci fosse e lasciarla al di fuori della mia vita,
oppure farla entrare dentro, lasciarla aderire
ai bordi di me stessa per renderla mia alleata, per tramutarla in bagaglio di viaggio,
in esperienza vissuta consapevolmente e
profondamente.
Ho sempre vissuto ogni cosa fin oltre i suoi
limiti e con il cancro non potevo che fare
lo stesso. In fondo è terribile restare chiusi
dentro se stessi, ma restarne chiusi fuori lo è
ancor di più.
Non chiedo che il cancro sparisca dal mio
corpo, non posso pretenderlo. Chiedo che divenga un nemico da addomesticare, un’ombra cronicizzata con cui poter convivere e
continuare a vivere. Eppure a volte vorrei
stare in silenzio senza sentirmi in dovere
di ricominciare a vivere una normalità che
ormai mi sembra solo la fiera del superficiale e dell’effimero. Vorrei stare zitta e muta
per qualche giorno, senza dover spiegare
questa stanchezza perenne che rende infinite
le mie giornate, questo distacco dal mondo
che sento crescere dentro di me ogni giorno
di più. Vorrei non dover spiegare che forse
all’esterno tutto può ricominciare, che fuori
posso anche essere la stessa di un anno fa,
con i capelli biondi, che la mia terapia non
mi porterà via, e le guance rosa. Ma dentro
ogni cosa è cambiata. Dentro ho tante metastasi che camminano, ormai lontane dal
punto in cui tutto è cominciato. Dentro ho
un’altra percezione di quello che sono sempre
stata. E in giornate come questa mi sento un
po’ più lontana dal mondo reale e molto più
vicina a tutti voi.
Il cancro? Un dono
21 marzo 2013
La cosa più importante di tutte non è quante
metastasi abbiamo in corpo. La cosa più
importante è sentirsi sane, nonostante tutti i
referti dicano il contrario. Così con il cancro
si convive, si cresce, si lotta. Così la vita
diventa ancora più degna di essere vissuta.
Con l’amore intorno e la disciplina dentro.
E la certezza che la Vittoria è lì, da qualche
parte, che mi aspetta. E la certezza che avere
il cancro e poterlo combattere è in assoluto
la cosa di cui sono più orgogliosa nella mia
vita.
Le medicine curano. Poi c’è l’anima, c’è il
coraggio. C’è l’amore intorno e la disciplina
dentro. E queste sono cose che guariscono.
Un giorno tu arriverai, mio “E Poi”, piccola
e bellissima. Di questo sono certa. E se tutto
l’inferno che sto attraversando mi conduce a
te, sono disposta a viverlo altre mille volte.
* Violinista e scrittrice, aveva aperto, dall’ottobre 2011, una pagina (http://ilcancroepoi.com/
blog/) alla quale affidava periodicamente i suoi
pensieri. Se ne è andata il 16 luglio 2013, a soli
24 anni. A lei verrà dedicata la Sala d’attesa del
reparto di Oncologia dell’ospedale di Bolzano.
28
Ivan Illich a Brema
te ciò che faranno con voi, ciò che una certa
professione ha deciso di fare. Lo scenario
di cui ho parlato, in cui, se vogliamo dare
e mantenere un senso, ci ritroviamo molto
soli, è anche una possibilità per coltivare
un’intensa amicizia che non era concepibile
in un mondo di legami ereditari, di cultura
abitudinaria, di decoro borghese, di ricchezza e di sicurezza. La mia speranza è questa.
Altre non ne ho”.
L’eliminazione dell’“io” attraverso la
statistica
Alla fine degli anni Novanta, poco prima
della fine del millennio, Ivan dovette verificare per la terza volta le ovvietà sulle quali
pare poggiare la visione del mondo odierno.
Nel settore dell’attività medica era comparso un nuovo termine: “il rischio”. Un termine che non definiva qualcosa di esistente,
non era una metafora, bensì il simbolo per
un atto costruttivo-matematico. A differenza del pensiero cibernetico, il rischio mina
ogni rappresentazione collegata alla realtà
e con essa la certezza di malattia e salute.
Una delle prime volte che Ivan Illich parlò pubblicamente di “rischio” fu a Bologna.
Lì menzionò la difficoltà rappresentata dal
fatto che non è più sufficiente -com’è invece
il caso del sistema immunitario- intendere
storicamente il potere simbolico di questa
parola, se riferita a se stessi, in una forma
disincarnata. Perché il rischio, diceva Ivan,
non è più la rappresentazione di un quadro
realistico (come quello del circuito cardio-
vascolare pensato come computer). Questo
“spazio” viene creato attraverso un calcolo
di probabilità matematico, con correlazioni
e scenari futuri che prescindono da tutto ciò
che rende identificabile una persona specifica. Nelle sessioni di consulenza genetica
analizzate da Silja Samerski, questo spostamento si esprime, al di là della metafora, in un’estinzione della persona che dice
“io” e parla di sé, in un ammutolire radicale
della “cliente” rispetto all’esperto, alla quale
comunque quest’ultimo si rivolge personalmente.
A sua volta, per il medico che basa il proprio
lavoro su valori di rischio, la prima verità
del rischio significa che non può più agire in
modo medico. In regime di rischio, malattia
e salute non più sono concetti significativi.
Il posto dei sintomi riconoscibili viene preso da mere probabilità, il posto dei giudizi
motivati viene preso dalla correlazione dei
fattori di rischio, il posto delle prognosi sul
decorso della malattia viene preso da un futuro virtuale e calcolato a tavolino e il posto
della pratica esperienziale viene preso da un
poker di probabilità alternative. Trattare un
probabile cancro al seno e operare un tumore evidente -calcolare un rischio o riconoscere un pericolo esistente- sono due attività
non paragonabili, la distanza tra le quali è
almeno pari a quella tra realtà e sogno.
La critica di Ivan colpisce al cuore la colonizzazione del futuro e il rapimento della
persona dal momento presente che determina la sua presenza piena e reale, qui e ora,
e che è all’origine dell’amicizia, del dolore e
della gioia.
Il seme dell’amicizia
Ivan richiamava l’attenzione, passo dopo
passo, sulla potenza mitopoietica della medicina e dell’impresa-salute: la promessa di
rimedi istituzionalizzati contro l’ammalarsi,
l’invecchiare, il morire, come una privazione
della capacità di accettare il proprio destino
e della “conditio” umana.
Ha rivelato le minacce associate a queste
promesse: la cura personale viene scoraggiata; la ricerca del dovere personale viene
estinta; l’ospitalità per il sofferente diventa
apparentemente inutile.
La responsabilità personale per il nostro
prossimo viene affidata all’istituzione. Soprattutto, la terminologia dominante distrugge il senso della realtà e la possibilità
di dire “io” e di parlare di sé con senso e verità. Solo chi padroneggia l’arte di morire e
di soffrire può coltivare un’arte del vivere,
sostenne Ivan in una conferenza. Solo coloro che, insieme ad altri, si fanno carico e
hanno il coraggio dell’incerto procedere sul
filo dell’amicizia, sono in grado di dire “No,
grazie!” alla “salute sotto la propria responsabilità”.
In fondo era questo che Ivan cercava di coltivare: la speranza di una reciproca fraterna vicinanza era quel seme di luce che egli
emanava.
(traduzione di Martina Salvadori)
29
Alexander Langer
Infermiere e pianeta,
elogio della gratuità
II tema “Infermiere e pianeta” lascia riflettere su di una analogia: il “pianeta” è un paziente, un paziente forse di “Area critica”,
come voi dite.
E in tal senso, probabilmente, tutti quanti ci
troviamo nella necessità di fare da infermieri o da medici, dal momento che la salute del
pianeta oggi, per molte ragioni che io adesso
qui non elenco, è spesso in “Area critica”. La
sua condizione di paziente è forse dovuta ad
alcuni fenomeni mai esistiti in epoche precedenti. Dalla Seconda guerra mondiale, ma
soprattutto dagli anni Sessanta, il pianeta,
non riuscendo più a vivere dei frutti, intacca
ormai l’albero. La rigenerazione oggi è seriamente compromessa. La quantità di inquinamento chimico, ma anche radioattivo,
causa l’appesantimento complessivo dei polmoni verdi della terra (le foreste, i boschi);
non ha mai raggiunto i tassi di oggi e non
può che crescere. L’effetto serra, di cui tanto
si sente parlare, è destinato solo a crescere.
Secondo gli esperti, dalla fine della Seconda
guerra mondiale a oggi, un quarto degli alberi della terra è sparito: è come se a ognuno di noi fosse stato tagliato un quarto dei
suoi polmoni. La mutilazione è quindi molto
forte. È stato calcolato, anche se non siamo
in grado di controllarlo, che oggi sulla terra
si brucia in un giorno una quantità di combustibili fossili (benzina, carbone, sostanza
biologica depositata) per la cui formazione
sono stati necessari mille anni. La sproporzione tra distruzione ed eventuale ricostruzione o salvaguardia è quindi enorme. Ed è
interessante a tal proposito notare come la
lista delle tecnologie ambientali sia lunga
almeno quanto quella delle tecnologie sanitarie.
Si discute se per salvare questo paziente occorra una forte autorità, un dirigismo
che sostanzialmente e centralmente decida
quanto si può prelevare dalla dispensa del
pianeta, chi deve controllare il razionamento, a chi spetti eventualmente fare e consumare i prelievi e così via. Come succede
anche nella vostra professione, molto spesso
non si riesce a capire come mai un paziente,
seppure avvertito e consapevole della gravità della sua malattia, della sua situazione,
non abbia né la capacità né la forza necessarie ai cambiamenti. In tal senso è inutile
parlargli della nocività del fumo, dell’alcol o
dello stress, se essi non hanno già compromesso la sua salute; i meccanismi che spingono nella direzione distruttiva sembrano
dunque più forti.
Le norme, le tecniche e le burocrazie non
riescono a dare una risposta adeguata alla
malattia ma possono, a volte anche molto
efficacemente, curare semmai dei sintomi,
bloccare dei degradi e forse anche invertirli.
Nell’insieme possiamo dire che la tenden-
30
za che porta al diffondersi così endemico
di malattia non si corregge se non si lavora
per una svolta, per una conversione, per un
cambiamento.
Il tipo di cambiamento che ritengo sia richiesto per la salute del pianeta mi pare che oggi
consista essenzialmente nella individuazione e nell’accettazione di limiti. Se fosse qui,
Ivan Illich probabilmente parlerebbe della
soglia della controproduttività, superata la
quale il progresso alla fine si ritorce contro
se stesso. È come se si dicesse: “La macchina
dà libertà di movimento a tutti, ma se tutti
la usano c’è l’ingorgo”. Il vantaggio acquisito da questa promessa tecnologica di libertà
viene così capovolto e conduce a paralisi e
frustrazione. Saper scoprire, accettare, valorizzare i limiti, rendersi conto che molte
volte il minimo può dare il massimo, ci ren-
de consapevoli del fatto che nella difficile accettazione di un limite possiamo individuare aspetti positivi.
La questione dei limiti e dei confini è quella che maggiormente ho visto collegata alla
vostra professione. Mi sembrate un po’ come
delle guardie di un confine molto delicato;
che spesso lavorano per spostare un po’ più
in là il confine tra la morte e la vita.
C’è un secondo parallelo tra “infermiere e
pianeta” che vorrei sottoporvi. L’arte sanitaria e quella agricola, fin dall’antichità,
hanno entrambe operato per correggere e
migliorare la natura. Gli specialisti delle
due arti, cioè i contadini, i medici, gli infermieri, gli stregoni, i sanitari in genere,
anche nelle loro versioni femminili, si sono
sforzati di migliorare la natura rilevandone
i limiti e hanno quindi senz’altro lavorato
per spostare il confine. Si pensi, ad esempio, alla fertilità spontanea della terra, alla
durata della vita, al dolore, alla sofferenza,
alla riparabilità dei guasti e dei danni che
possiamo provocare.
Agricoltura e medicina, che dall’inizio dell’umanità intervengono per correggere la
natura, oggi appaiono (ritornando alla riflessione di Ivan Illich) come un monumento
alla controproduttività, dove è stata supera-
ta cioè la soglia in cui i benefici superano in
qualche modo i costi.
Il progresso molte volte è potuto apparire
tale perché è riuscito a distanziare sempre di
più l’ottenimento dei vantaggi dal pagamento dei costi. Vantaggi subito quindi e sempre
più grandi; costi rimandati sempre più lontano nello spazio, nel tempo, magari in altri
paesi, soprattutto dei tanti Sud del mondo.
È come se si lasciasse una bolletta da pagare
-per l’inquinamento, la deforestazione, la distruzione di qualsiasi cosa- a chi verrà dopo
di noi o agli strati sociali più deboli.
Tutto può essere costruito sinteticamente:
la vita, la specie vegetale o animale, attraverso macchine sofisticate, tecniche, grande
professionalizzazione di esperti dei diversi
settori. Tutto questo è stato certamente di
grande aiuto, ma ha anche originato interrogativi sulla sofferenza e sull’importanza
di vivere in buona salute.
Anche nella vostra professione non mancheranno, anzi non mancano, coloro che su
questo aspetto della cura lavorano, guadagnano, motivano le loro carriere e trovano la
loro affermazione.
Uno sforzo in qualche modo controcorrente
può condurre alla riconciliazione, alla ricomposizione, al recupero di interezza, di
riequilibrio, di pacificazione. Ciascuno può
scegliere i termini che crede opportuni per
comunicare un messaggio di semplicità.
Una semplicità non da ingenui, da sempli-
ciotti. È la semplicità di uno scalatore che,
pur volendo affrontare la vetta, è pronto a
rinunciarvi se si rende conto delle cattive
condizioni meteorologiche, senza sfidare
una forza più grande di lui, ma accettando
così anche il suo fallimento.
Non ci resta che cercare di difendere accanitamente, e possibilmente di sviluppare, soprattutto le occasioni di gratuità, di
informalità. Dove lo stare insieme non avviene perché qualcuno fornisce una cornice
ufficiale in cui questo deve verificarsi. Di
difendere e valorizzare cioè tutti i luoghi
in cui ci si può ritrovare, si può sostare, ci
si può parlare, senza dover far parte di una
struttura, senza dover pagare un biglietto
di ingresso, senza essere abbonati a un circuito, senza avere un contratto di assistenza tecnica che dopo si candida a curare la
manutenzione.
Da sempre, e oggi più che mai, la separatezza delle professioni, la salvaguardia
della parcellizzazione e della specializzazione si basano anche sul segreto dei “chierici”, sul fatto che gli addetti parlino nel
linguaggio degli addetti e solo agli addetti,
senza rompere il muro della comunicazione che li separa dai non addetti.
L’eccessiva dipendenza dalle macchine è
tale che la perdita dell’autonomia, la perdita di sapere, di capacità di modulazione,
di adeguamento dell’intervento alla situa-
zione reale, sono ormai tali da rendere necessaria l’introduzione di una voce controcorrente. Purtroppo, finché la nostra società
è organizzata così com’è organizzata ora, è
molto difficile che funzionino degli efficaci “temperamenti”, insomma, qualcosa che
moderi la dinamica spontanea del denaro e
del potere. Nemmeno la ricerca farmaceutica, la ricerca medica, la sperimentazione,
condizionate dalle forti ragioni dell’industria, possono essere affidate solo all’èthos
e alla coscienza dei limiti dello scienziato e
del ricercatore.
Gli esperti difficilmente ci sapranno guarire, sapranno forse aggiustare molti guasti, ma difficilmente sapranno guarire. Chi
serve l’interezza, invece, forse non sempre
vorrà spingersi al massimo nella ricerca e
nel montaggio dei vari pezzi di ricambio,
ma forse aiuterà meglio a guarire. Non si
può rimuovere l’idea di malattia. Dobbiamo
convivere con lei più serenamente possibile,
anche con la prospettiva della morte. Inutile esorcizzarla, rinnegarla o rimuoverla,
facendo finta che non ci sia.
(Estratto dalla relazione di Alexander Langer al
9° Congresso Nazionale dell’Aniarti -Associazione nazionale infermieri di area critica- del novembre 1990, dove sostituì all’ultimo momento
l’amico Ivan Illich)
Quaderno della Fondazione Alexander Langer Stiftung, onlus
dicembre 2013
Dedicato ad Anna Segre
Responsabile: Enzo Nicolodi
Hanno collaborato: Anna Bravo, Bettina Foa, Grazia Barbiero, Mohsen Farsad, Serena Rauzi, Edi Rabini (coordinamento), Franz Tutzer.
Foto: di Fausto Fabbri. Reportage pagg. 16-17, tratte da Segni d’arte in Oncologia, a cura di Tiziana
Tacconi e Maurizio Cantore, edito nel 2008 dal Reparto di Oncologia, Ospedale di Carrara, insieme
all’Accademia di Belle Arti di Brera; a pag. 3, Luxardo; a pag. 9, di Max Guarnieri; a pag. 11, di Roberto Masotti; alle pagg. 21 e 30, archivio “Una città”; alle pagg. 4, 5, 7, 9, 26, 27, 28, di Andrea Rizza; a
pag. 29, archivio Fondazione Alexander Langer.
Archivio delle interviste di Una città: www.unacitta.it
Grafica, impaginazione e realizzazione: Una Città soc. coop., Forlì (www.unacitta.it)
Stampa: Galeati, Imola (BO)
Fondazione Alexander Langer Stiftung, onlus
via Bottai/Bindergasse 5
I-39100 Bolzano/Bozen
Tel. + Fax 39 0471 977691
[email protected] www.alexanderlanger.org
Cassa di Risparmio/Südtiroler Sparkasse, IBAN: IT91S0604511613000000555000
BIC: CRBZIT2B059
Realizzato con il contributo di: Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, Comune di Bolzano, Azienda Energetica SpA
l’altro Iran, diritti delle donne, diritti di tutti
Quaderno nr. 1 della Fondazione Alexander
Langer Stiftung, Onlus, ottobre 2012, con
testi di Narges Muhammadi (Premio Langer
2009), Nasrin Sotoudeh e Ahmad Rafat: informazioni aggiornate e testimonianze vive
di alcuni tra i protagonisti delle lotte per i
diritti delle donne, la libertà e la democrazia
che fanno onore al loro paese.
Per avere copia cartacea:
[email protected]
31
Martin Berkofsky
La malattia ha cambiato la mia vita
Ammalarmi di tumore è stata una delle cose
più importanti della mia vita. Incontrare
una persona ammalata di tumore era per
me un’idea vaga, che non riuscivo a comprendere bene, che non mi toccava personalmente.
Quando a 40 anni ho avuto un incidente in
moto e sono rimasto a letto fermo per quattro mesi, con diverse fratture nelle ossa, i
medici mi avevano diagnosticato l’impossibilità di riuscire a suonare nel futuro.
Ammalarmi di tumore nel 2000 è stato il
mio secondo incontro con la malattia. Le
cure dell’Istituto per il trattamento del cancro della mia città, che devo ringraziare,
sono state per me quella che chiamo una
“Alma Mater”, un passaggio estremamente
prezioso che mi ha portato a sopravvivere e
alla mia meravigliosa posizione odierna: di
dover in qualche modo restituire il miracolo
che mi aveva salvato.
Nel 2003, a 60 anni di età, ho deciso di celebrare la mia nuova vita, il mio ritorno
alla vita, facendo due cose che non avevo
mai fatto. Io sono un musicista, non sono
un mago della finanza e nemmeno uno che
correva. Ho deciso di mettere alla prova le
mie capacità atletiche per una corsa di 800
miglia, raccogliendo fondi per sostenere l’Istituto americano per la ricerca sul cancro.
Ho cominciato dall’ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ho corso fino a Chicago. Ho semplicemente suonato in concerti organizzati
in sale, chiese, nelle strade. Molte persone
si sono avvicinate lungo i 1.400 km del percorso e ho raccolto infine 80.000 dollari per
la ricerca.
La gente mi guardava in modo particolare, a
volte mi seguiva o correva accanto a me per
qualche tratto, veniva poi ai concerti, contribuiva alla raccolta di fondi. Ho incontrato
persone che avevano storie come le mie: di
famiglie perdute, di amici perduti, di amori
perduti. Mi facevano capire quanto importante fosse il rapporto tra musica e guarigione. Una cosa che mi ha fatto molto piacere e
che mi fatto dimenticare il dolore.
Ma adesso basta parlare di me, vorrei solamente festeggiare insieme a voi, Donatori di Musica, che mi avere dato questa opportunità e avete portato gioia, conforto e
guarigione a così tante persone. La vostra
rete di musicisti di encomiabile valore, che
si donano con il loro cuore e la loro umanità
dove c’è dolore e sofferenza, deve diventare
fonte di ispirazione e un bellissimo esempio
per tutti.
Mi ricorda la frase del musicista tedesco
Max Bruch: “Musik ist die Sprache Gottes”,
“La musica è la lingua di Dio”.
(Intervento al convegno Donatori di Musica,
Bolzano, 5 giugno 2010)
La musica cura. Porta la pace allo spirito, gioia al cuore, conforto al corpo fisico. Trasforma
l’umanità in fraternità, incoraggia a lottare con generosità per gli altri, per alti ideali. A
dedicare se stessi e il nostro lavoro per quel che nobilita lo spirito umano, a superare e risolvere, anche le malattie e i conflitti più dolorosi, e tiene alto il piano dei valori per i quali
c’impegniamo in prima persona.
Il ruolo dell’interprete è di donare la bellezza e l’ispirazione agli altri, di farlo con la più
onesta e umile ricerca di questi valori in noi stessi. Abbiamo la fortuna di essere parte di
questo processo vitale che crea bellezza, che la dona agli altri, nella volontà di creare un
mondo migliore. (M.B.)
Suono solo per la mia “Alma Mater”: la medicina
Nato a Washington nel 1943, di origini bielorusse, Martin Berkofsky ha dato i suoi primi
concerti all’età di 8 anni. è diventato un importante pianista noto anche per le sue attività
di ricerca musicale.
Nel 2003, per festeggiare il suo sessantesimo compleanno e la guarigione da un cancro,
intraprende un lungo tour concertistico a piedi, “Celebrate Life Run”, per raccogliere fondi
destinati alla ricerca sul cancro.
Roberto Prosseda entra in contatto con lui per puro caso, cercando un inedito di Mendelssohn. Gli scrive chiedendogli una copia del manoscritto e riceve inaspettatamente una risposta positiva nel giro di qualche ora. Gli chiede informazioni sulle date dei suoi concerti
negli Stati Uniti e si sente rispondere: “Ma io non faccio più concerti dal 2000, ora suono solo
per la mia Alma Mater, la medicina”. Prosseda gli racconta dei Donatori di Musica e gli parla del Primo convegno dell’Associazione che si sarebbe svolto il 5 giugno 2010 all’Accademia
Europea di Bolzano. Lui si autoinvita e fa sapere che avrebbe pagato di persona le spese di
viaggio (riportiamo qui a fianco la sintesi del suo intervento).
Si ferma qualche giorno a Bolzano e a Carrara. “Questi giorni -scrive al ritorno- sono stati
tra i più importanti di tutta la mia vita”. E organizza in ospedali americani una stagione di
Donatori di Musica, mantenendo la dizione italiana, e diventandone autorevole testimone.
Per sostenere e far conoscere Donatori di Musica in Europa e negli Stati Uniti, Martin Berkofsky ha contribuito a realizzare due Cd: “Visions”, Piano Works, con musiche di Franz
Liszt, per l’etichetta Arts; e “Hope”, con musiche di Beethoven, suonate anche da Atakan
Sari, Roberto Prosseda e altri, edito dalla “Fondazione Cristofori”.
Supplemento al n. 200 di “Una Città”. Rotocalco culturale. Anno XXIII, Dir. resp. Gianni Saporetti. Aut. Trib. di Forlì n. 3/91 del 18/2/91. Stampa: Galeati (Imola). Redaz. e amministraz.: via Duca Valentino n.11, Forlì. Poste Italiane SpA - Sped. in A. P. D.L.
353/2003 (conv. in L.27/02/04 n.46) Art. 1 c.1 CN/FC. Tassa pagata