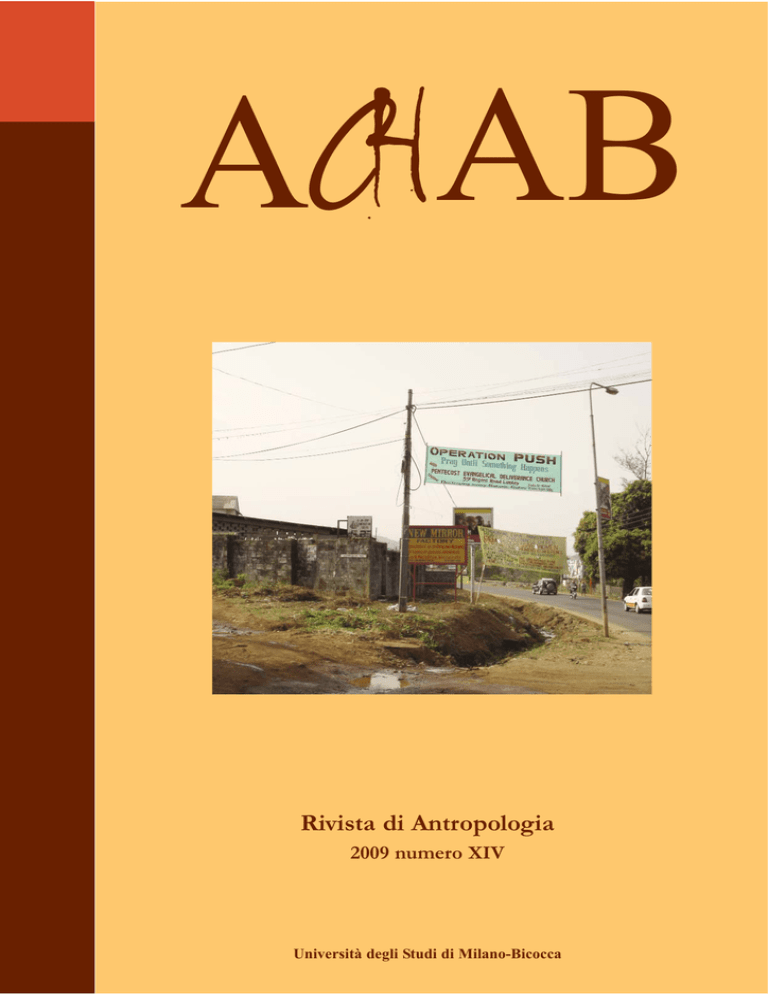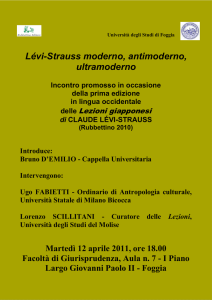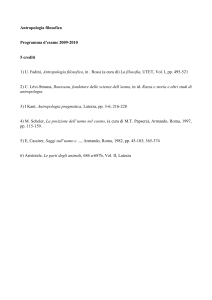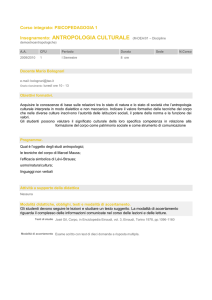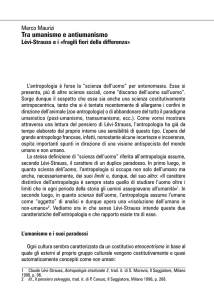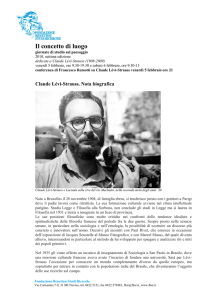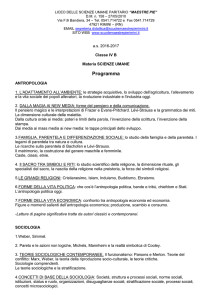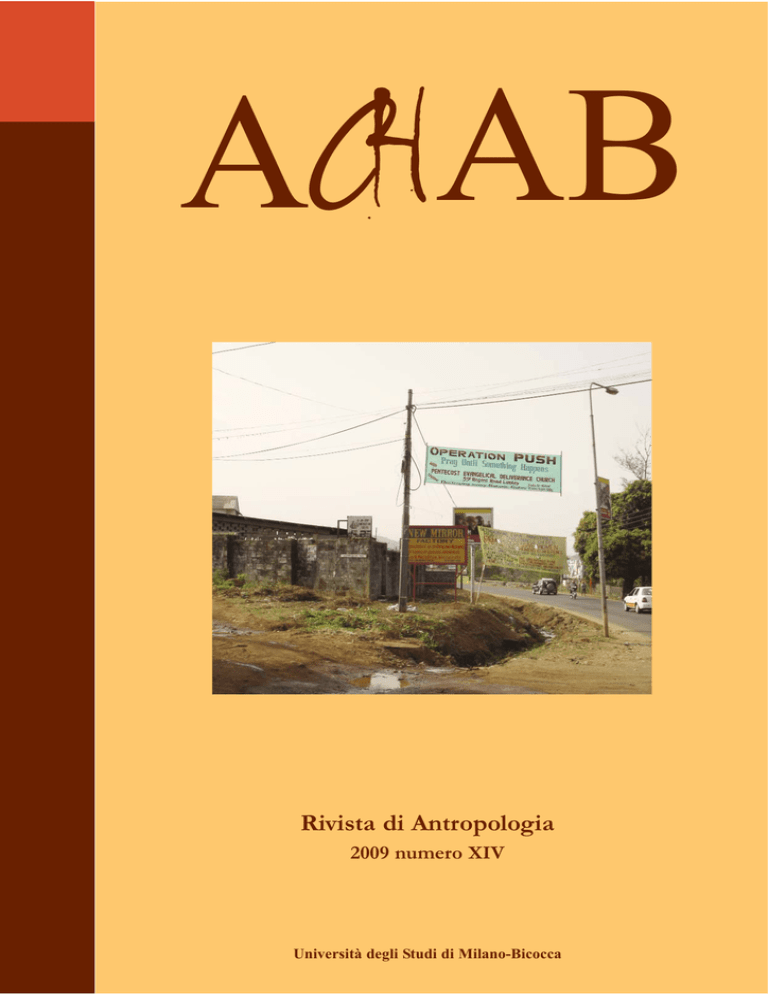
ACHAB
Rivista di Antropologia
2009 numero XIV
Università degli Studi di Milano-Bicocca
AChAB - Rivista di Antropologia
Numero XIV - giugno 2009
Direttore Responsabile
Matteo Scanni
Direzione editoriale
Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi
Redazione
Paola Abenante, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, Fabio Vicini
Progetto Grafico
Lorenzo D'Angelo
Referente del sito
Antonio De Lauri
Tiratura: 500 copie
Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano
Bicocca
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005
ISSN: 1971-7954 (versione online); 1971-7946 (testo stampato)
Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono
invitati a contattarci.
* Immagine in copertina di Lorenzo D’Angelo, Pray Until Something Happens, Freetown, Sierra Leone, 2007
Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,
scrivete a: [email protected]
ACHAB
In questo numero...
3
Lévi-Strauss: Quale eredità per l'antropologia del XXI secolo
di Pietro Scarduelli
6
Antropologia, filosofia, diritto e mondo moderno: dieci anni dopo un colloquio
con Lévi-Strauss
di Lorenzo Scintillani
14
Il pensiero selvaggio nell’era elettrica
di Gianni Trimarchi
17
Lévi Strauss in classe
La top ten dell’antropologia strutturalista
di Fabio Dei
22
Lévi-Strauss erudita
Alcune note critiche sulla genealogia e attualità del pensiero lévistraussiano
di Michele Parodi
29
Suole di vento
Jean Rouch fra antropologia e cinema
di Alessandro Jedlowski
36
Il consumo di funghi allucinogeni fra i Mazatechi della Sierra di Oaxaca nel
mutamento del contesto storico e sociale
di Fabio Pettirino
43
Il gioco del calcio: fra campo, campi e mass media
Interrogativi ed argomenti per un’ antropologia dello sport
di Sara Ferrari
49
La selva degli uomini
Riflessioni sul tema del suicidio nel contesto migratorio
di Davide Bruno
53
La crisi ambientale del lago d’Aral tra realtà e percezione
di Stefano Piastra
58
O fenomeno da intolerancia religiosa
Produtor de novas identidades sociais no interior da religião afro-brasileira
di Álvaro
Roberto Pires
1
ACHAB
64
Recensione : Identità catodiche, rappresentazioni mediatiche di appartenenze collettive
di Pietro Vereni
a cura di : Gianni Trimarchi
66
Recensione : Il Contemporaneo
di Giorgio Agamben
a cura di : Valerio Fusi
2
ACHAB
Lévi-Strauss: quale eredità per l'antropologia del XXI secolo
di Pietro Scarduelli
Lévi-Strauss compie cento anni. Per le culture che
quantificano il tempo e che lo calcolano mediante il sistema
decimale, 'cento' è un numero 'pieno', dotato di notevole valore
simbolico. A ciò si aggiunge la considerazione che i pochi che
toccano il secolo di vita superano di molto la durata media
della vita umana e suscitano stupore e ammirazione. In terzo
luogo è un dato di fatto che Lévi-Strauss, a prescindere dai
suoi compleanni, è entrato a fare parte ormai da decenni
dell'Olimpo dei grandi antropologi del XX secolo. Tutto ciò
concorre a fare di questa scadenza un evento che merita una
celebrazione. Il modo migliore per celebrare un antropologo è
ovviamente offrire un contributo alla riflessione sul posto che
occupa nella storia delle teorie antropologiche. È vero che su
questo tema sono stati scritti innumerevoli libri e saggi e che
un contributo significativo a questo dibattito è stato dato
proprio dall'Italia, dove le opere di Lévi-Strauss vennero
tradotte già negli anni Sessanta e lo strutturalismo si è diffuso
ed è stato assimilato e dibattuto non solo in campo
antropologico ma anche filosofico. Può quindi sembrare che
questo tema sia già stato trattato a sufficienza. Io però vorrei
porre la questione in altri termini. Non intendo proporre una
riflessione sullo strutturalismo, questione troppo complessa
per essere affrontata in queste pagine, ma piuttosto su ciò che
dallo strutturalismo può attingere un'antropologia che ormai ha
imboccato altre strade. In altri termini: che cosa può essere
conservato del pensiero di Lévi-Strauss dall'antropologia che
si affaccia al XXI secolo?
A prima vista, nel panorama dell'antropologia di questi
ultimi anni, sembra che del pensiero di Lévi-Strauss sia
rimasto poco o nulla. Lo strutturalismo di Lévi-Strauss è una
delle ultime cattedrali teoriche edificate dall'antropologia,
probabilmente la più elegante, la più raffinata. In seguito, a
partire dagli anni Ottanta, si è delineata all'interno della
disciplina una progressiva caduta d'interesse nei confronti
delle teorie 'forti'. In proposito osservo, per inciso, che questo
'collasso' teorico si verifica in una congiuntura storica
caratterizzata dal crollo delle ideologie; fra i due fenomeni vi
è, a mio avviso, un nesso che probabilmente, in altra sede,
meriterebbe di essere analizzato. Per quanto attiene al
tramonto delle grandi teorizzazioni in campo antropologico il
'merito' (se così lo vogliano definire) va alla revisione critica
(impietosa, spesso eccessiva) operata dall'antropologia
interpretativa e post-moderna, che ha liquidato le concezioni
essenzialiste delle culture umane, le teorie che a tali
concezioni si ispirano (funzionalismo, strutturalfunzionalismo,
strutturalismo, ecologia culturale) e i loro corollari
metodologici (ad esempio il modo di intendere la raccolta dei
dati sul campo). Gli attacchi dell'antropologia post-moderna
hanno avuto come effetto non solo l'espulsione
dall'antropologia di ogni prospettiva essenzialista; il rigetto
delle vecchie teorie si è trasformato in un atteggiamento di
diffidenza indiscriminata nei confronti di tutti i paradigmi e
delle teorie forti. La conseguenza è stata l'abbandono da parte
delle nuove generazioni di studiosi delle due ultime grandi
teorie nate in ambito antropologico: lo strutturalismo e
l'ecologia culturale neoevoluzionista. Il panorama della
disciplina degli ultimi decenni è caratterizzato dall'assenza di
paradigmi e di modelli solidamente strutturati e dal prevalere
dell'eclettismo e del bricolage teorico.
Fra gli antropologi oggi nessuno si ispira più allo
strutturalismo lévistraussiano. Questo silenzio significa che
nulla di questo grande corpus teorico è ritenuto utilizzabile? Io
vorrei indicare almeno due aspetti dello strutturalismo che
considero patrimonio irrinunciabile dell'antropologia. Il primo
è il rapporto fra cultura e linguaggio. Ponendo questo tema al
centro della propria riflessione Lévi-Strauss si colloca nel
solco di un filone antropologico in cui è preceduto da Boas,
che aveva sostenuto la 'equipotenza' di tutte le lingue umane e
sottolineato l'importanza delle lingue indigene come via
d'accesso alla comprensione delle culture, Malinowski che
aveva legato il significato degli enunciati verbali al loro uso e
al contesto in cui vengono prodotti, Whorf, sostenitore della
teoria secondo cui dalle categorie linguistiche dipendono le
categorie fondamentali del pensiero.
Lo strutturalismo si caratterizza perché disegna il rapporto
cultura-linguaggio in termini di radicale dipendenza della
prima dal secondo, una dipendenza che in seguito, negli anni
Ottanta e Novanta, è stata messa in discussione da prospettive
teoriche che tendono a ridisegnare il rapporto fra linguaggio e
cultura ridimensionando portata e influenza del primo sulla
seconda (Bloch, D'Andrade, Strauss e Quinn). Ciò a mio
avviso non intacca la rilevanza del contributo lèvistraussiano.
Lévi-Strauss più di ogni altro antropologo sostiene la natura
linguistica dei fenomeni culturali, utilizzando la struttura della
lingua (più precisamente la sua struttura fonologica) come
modello per la comprensione della cultura nei suoi diversi
3
ACHAB
aspetti, dalle relazioni di parentela ai miti. Ciò lo porta a
formulare una tesi che rappresenta uno dei suoi contributi
teorici più rilevanti alla riflessione antropologica, la tesi
secondo cui, a somiglianza della lingua, la cultura ha una
matrice inconscia e un'organizzazione sistemica basata su
strutture di relazioni.
Vale la pena di sottolineare che questa attenzione nei
confronti della dimensione linguistica è condivisa dallo
strutturalismo di Lévi-Strauss e dalla teoria interpretativa di
Geertz, cioè da due prospettive teoriche lontanissime l'una
dall'altra. Geertz considera la cultura un 'testo' che
l'antropologo deve essere in grado di 'leggere' e interpretare
ricostruendo le trame dei significati indigeni. Questo
approccio ermeneutico è ovviamente del tutto diverso
dall'impianto teorico dello strutturalismo ma non bisogna
dimenticare che il 'testo' di cui Geertz ci parla è pensato e
formulato tramite il linguaggio. Strutturalismo e antropologia
ermeneutica sono dunque accomunate dall'attribuzione al
linguaggio di un ruolo predominante nella produzione della
cultura (anche se per Lévi-Strauss il linguaggio è inteso come
struttura inconscia e per Geertz come dimensione del
significato).
Il secondo aspetto del pensiero di Lévi-Strauss la cui
importanza, a mio parere, trascende le specificità della teoria
strutturalista e che può essere considerato un contributo
irrinunciabile alla riflessione teorica in ambito antropologico
va rintracciato nella sua teoria dei modelli. Questa teoria è
caratterizzata da più distinzioni: modelli consci e inconsci,
modelli meccanici e statistici, modelli del nativo e
dell'osservatore. Io ritengo che la duplice distinzione modelli
nativi/dell'osservatore e consci/inconsci sia di importanza
strategica per la ricerca antropologica. Si pensi alle pagine da
lui dedicate all'organizzazione sociale degli indios Bororo nel
saggio del 1952 poi inglobato nell'Antropologia strutturale,
dove egli spiega come la rappresentazione del villaggio bororo
diviso in due metà esogamiche abitate da due diversi clan
matrilineari e legate da un rapporto di scambio matrimoniale
per cui gli uomini di una metà possono sposare solo le donne
dell'altra metà costituisca non una descrizione esatta
dell'organizzazione sociale ma il modo in cui gli indigeni se la
rappresentano, un modo incompleto perché parziale, in quanto
in realtà ogni metà è a sua volta suddivisa in tre sezioni
(superiore, media e inferiore) e gli uomini di una sezione
superiore possono sposare, nell'altra metà, solo le donne della
corrispondente sezione superiore, quelli della sezione media le
donne della corrispondente sezione media e quelli della
sezione inferiore le donne della corrispondente sezione
inferiore.
Dunque la struttura dualistica descritta dai nativi 'nasconde'
una soggiacente struttura tripartita: mentre la rappresentazione
indigena disegna un villaggio diviso in due metà, questo è in
realtà costituito da tre gruppi, ognuno dei quali è diviso in due
metà. A commento di questo esempio Lévi-Strauss sottolinea
l'importanza di non appiattire la descrizione etnografica sui
modelli espliciti enunciati dagli indigeni perché "il
funzionamento reale" di una società è "diversissimo da come
appare in superficie"; pertanto l'osservatore non deve
"confondere le teorie degli indigeni sulla loro organizzazione
sociale… e il funzionamento della società". Le
rappresentazioni native - aggiunge - possono riflettere (spesso
solo parzialmente) il funzionamento della società ma anche
"ignorarne alcuni elementi" o "contraddirlo". Si tratta, a mio
avviso, di una riflessione fondamentale, da cui emerge una
concezione deterministica del comportamento umano, le cui
cause (per Lévi-Strauss ma anche, ad esempio, per Bourdieu e
per Godelier e più in generale per i pochi antropologi di
ispirazione strutturalista o marxista) dovrebbero essere
ricercate non nelle scelte degli attori sociali ma in fattori o in
meccanismi che esercitano la loro influenza al di là della
consapevolezza e al di fuori della coscienza degli individui.
Questa prospettiva si discosta radicalmente da quella
interpretativa, la cui egemonia si è affermata nell'ambito
dell'antropologia a partire dagli anni Ottanta. La differenza fra
le due prospettive va ricondotta ad una diversa scelta del
livello a cui collocare il significato: gli antropologi
interpretativi privilegiano i significati manifesti, letterali,
elaborati dagli attori sociali, cioè l'esegesi indigena; gli
antropologi che io definirei 'esplicativi', come Lévi-Strauss,
distinguono fra un significato letterale e un significato latente,
implicito, inconscio, l'accesso al quale è possibile solo
all'osservatore.
Oggi la nozione di 'inconscio' non è più di moda in
antropologia ma vale la pena di riflettere sul potenziale
esplicativo di tale nozione, sia nella prospettiva strutturalista
che in quella marxista. Lévi-Strauss - come è noto - si ispira
per la costruzione della propria teoria alla struttura fonologica
della lingua, di cui i parlanti sono inconsapevoli: essi ignorano
le leggi che regolano la formazione degli enunciati eppure
costruiscono continuamente enunciati corretti. Qualcosa di
analogo viene sostenuto dal marxismo su un altro piano: gli
attori non sono consapevoli dei reali meccanismi di
funzionamento della società, anzi ne elaborano interpretazioni
distorte e mistificanti (come i Bororo di Lévi-Strauss…) ma
ciò non impedisce che essi agiscano 'correttamente' per
garantirne il mantenimento e la riproduzione. Naturalmente il
significato di inconscio cambia a seconda che venga riferito ai
processi linguistici o ai comportamenti sociali. Il carattere
inconscio dei processi linguistici va inteso nel senso che la
consapevolezza non è necessaria all'attivazione e al
funzionamento dei meccanismi che presiedono alla produzione
di enunciati linguistici corretti. Invece nel caso dei meccanismi
sociali la nozione di inconscio viene utilizzata nel senso che la
non consapevolezza è necessaria affinché sia garantito il loro
funzionamento.
Sia
nella
loro
versione
linguistico-strutturale,
lévistraussiana, sia in quella sociologico-marxista, le nozioni
di 'struttura' e 'inconscio' sono state letteralmente spazzate via
dal dibattito teorico antropologico. La rapidità con cui
4
ACHAB
strutturalismo e marxismo sono spariti di scena e la radicalità
dell'epurazione richiamano, su un altro piano, la solerzia con
cui dopo l'implosione dell'Unione Sovietica e la caduta dei
regimi socialisti, ogni traccia culturale, simbolica e
topografica del socialismo è stata cancellata. Naturalmente è
ovvio che il rinnovamento teorico all'intero dell'antropologia è
inevitabile perché, banalmente, il mondo cambia con rapidità
impressionante: i nuovi scenari creati dalla globalizzazione
(migrazioni
planetarie,
deterritorializzazione
e
delocalizzazione delle culture, flussi di merci, tecnologie,
informazioni verso i paesi extraeuropei, anche quelli più
periferici e marginali, presenza sempre più massiccia e
invasiva di turisti, nuove forme di consumo e di
comunicazione) creano letteralmente nuovi 'oggetti' di
indagine e obbligano gli antropologi a forgiare nuovi strumenti
concettuali e nuove tecniche d'indagine. Tuttavia trovo che non
avrebbe molto senso celebrare il centenario di Lévi-Strauss se
ci limitassimo a collocarne prematuramente il busto nella
galleria dei padri della disciplina e considerassimo la sua
teoria obsoleta e 'inutile' per l'antropologia contemporanea. Le
teorie nascono, vivono la loro vita e muoiono ma la scelta di
fondo di Lévi-Strauss, una scelta metateorica, cioè la sua
opzione 'esplicativa', l'idea che lo sguardo dell'antropologo
debba andare al di là degli enunciati degli indigeni perché essi
non ci dicono tutto della cultura a cui essi appartengono, l'idea
che esistono aspetti della organizzazione sociale che si
collocano al di là della consapevolezza degli attori sociali, che
pertanto la ricerca della spiegazione debba tenere conto della
divaricazione oggettiva fra pratiche e interpretazioni indigene,
l'idea, in sostanza che il senso del comportamento umano non
coincida esclusivamente con ciò che gli uomini dicono, è amio
avviso, un’idea viva e vitale a cui la’ntropologia del XXI
secolo non deve rinunciare.
***
Una pagina del libro di Lévi-Strauss, Saudades do Brasil, Companhia das Letras,
São Paulo, 1994.
5
ACHAB
Antropologia, filosofia, diritto e mondo moderno:
dieci anni dopo un colloquio con Lévi-Strauss
di Lorenzo Scillitani
come quella di Norbert Rouland, esploratore delle terre di confine fra il diritto e l'antropologia (5) mi aveva probabilmente
preparato ad un impatto meno 'traumatico' con la realtà vivente e
parlante di un'autorità presente in carne ed ossa.
C'è da aggiungere che, qualunque fosse l'interesse, o forse anche
solo la curiosità, capace di spingermi alla richiesta di un
appuntamento con Lévi-Strauss, non vi ero stato esortato da
nessuno: qualcuno, anzi, alla vigilia della mia partenza per la
Francia, aveva provato a dissuadermene, chiedendomi, beffardo,
se il personaggio fosse ancora in vita…(e lo è ancora, per sua e
per nostra fortuna, dieci anni dopo). Ma al dunque, a colloquio
finalmente avviato con Lévi-Strauss, si trattava di entrare nella
questione, non più rinviabile: che cosa sono, in ultima analisi, le
strutture elementari della parentela? Testimone la mia amica
Isabelle Bourbon:"Elles ne sont que le droit", Lévi-Strauss dixit.
Una risposta del genere, secca e senza perifrasi, data ad uno che
si era impegnato a ricercare il giuridico nel pensiero e nell'opera
di Lévi-Strauss, fu quantomeno confortante. Mi astengo da
qualunque commento, del tipo: mi diede ragione. Spesso si può
dare ragione a qualcuno per tenerlo contento, per pura
compiacenza, o perché non si ha tempo da perdere con lui. In
questo caso, se anche così non fosse, l'avere ragione sarebbe
semplicemente riduttivo. E poi: avrebbe a sua volta 'ragione' LéviStrauss a parlare del diritto, quando non ne ha scritto (quasi) mai?
E, quando pronuncia il termine 'diritto', a quale parametro di
identificazione Lévi-Strauss fa riferimento? Ne parla da
antropologo, o si atteggia anche lui a filosofo, o teorico, del
diritto? Le obiezioni potrebbero fioccare copiose, e non è certo
questa la sede in cui poter affrontarle. Resta che la formula in cui
si risolve la società umana - corrispondente alle strutture
elementari della parentela - è qualificata da Lévi-Strauss in
persona come giuridica. Per chi si agita a tentare di 'fare giustizia'
del diritto (6) è un duro colpo. Vorrà pur dire qualcosa se LéviStrauss si è 'sbilanciato' a tal punto, e con estrema e sorprendente
lucidità, da nominare il giuridico come elemento qualificante la
socialità elementare: in senso proprio e pieno, Lévi-Strauss ha
detto il diritto, affermando la sua competenza a chiamare le cose
con il loro nome.
In un'epoca in cui 1'esperto di diritto - il giurista -, identificando
il diritto di volta in volta con la 'norma', col 'sistema', con le
'procedure', confessa di fatto di rinunciare a dire che cos'è il
diritto, e che cosa ne è del diritto, assecondato in questo da una
filosofia giuridica che, assimilandosi sempre più ad una 'teoria
generale' (7), mostra paradossalmente di non voler più sapere del
A colloquio con Lévi-Strauss
In un freddo pomeriggio dell'inverno parigino del 1999 - il 12
febbraio -, ebbi al Collège de France il sospirato rendez-vous con
uno degli ultimi 'grandi vecchi' (forse l'ultimo?) del secolo. La
sorpresa destata dall'incontro con l'uomo fu pari a quella riportata
dall'ascolto delle parole dell'antropologo. L'agilità dei movimenti
ed il timbro di voce di una persona di oltre novant'anni mi
colpirono forse più di quanto dovettero colpire, a suo tempo, un
testimone illustre ed autorevole come l'antropologo, e storico, del
diritto Norbert Rouland, che in proposito aveva avuto a scrivermi,
nella primavera del '99, riferendosi al suo incontro con Claude
Lévi-Strauss: "la sua mano tremava, ma non il suo spi-rito!
Confesso di essere stato affascinato dall'avere dinanzi un uomo di
tale statura". L'aver condiviso con l'amico Rouland questa
singolare esperienza mi fece comprendere meglio il senso della
sua testimonianza.
Per la verità, nonostante uno scambio epistolare incoraggiante con
Lévi-Strauss mi avesse portato a vincere le mie ultime esitazioni
a rendergli visita, alcune considerazioni sul temperamento
dell'uomo - comunicatemi tempo addietro da Alessandro Di Caro
(1) e dalla lettura di un articolo polemico dello stesso Lévi-Strauss
(2), poc'anzi pubblicato - non mi lasciavano ben sperare nella
cordiale accoglienza della quale egli mi avrebbe invece onorato
nel suo studio, che domina la biblioteca del Laboratorio di
Antropologia Sociale. La fortuita coincidenza della pubblicazione
di un numero di 'Critique' celebrativo della figura e dell'opera di
Lévi-Strauss (3), in distribuzione proprio nei giorni in cui mi
trovavo a Parigi, sembrava propiziare un buon esito dell'atteso
incontro. Atteso perché, e da quanto? La mia conoscenza della
produzione dell'antropologo francese risale ai tempi della mia tesi
di laurea in giurisprudenza, un capitolo della quale fu dedicato dietro suggerimento del mio professore, Pierfranco Ventura - alle
Strutture elementari della parentela; in seguito, sotto la guida del
mio tutor di dottorato, Sergio Cotta, impostai una tesi in filosofia
del diritto sulla giuridicità nell'antropologia strutturale (4). A
questo lavoro era limitata la mia 'conoscenza' di Lévi-Strauss - per
quanto e nella misura in cui un lettore può conoscere, sempre in
via indiretta, l'autore dei libri che adopera. Non essendo a mia
volta antropologo, tantomeno 'sul campo', non avevo mai
nemmeno potuto accedere a quel tipo di conoscenza, certo un po'
meno indiretta, che la condivisione di una medesima vocazione o,
per lo meno, di una medesima proiezione professionale talvolta
permette. Nel caso specifico, la mediazione rappresentata dal
frequentare, con un intenso rapporto epistolare, una personalità
6
ACHAB
diritto stesso, vietandosi di pensarlo (8), l'affermazione di LéviStrauss per cui qualcosa è diritto (piuttosto che: il diritto è questo
o quello...) non può non dare, oltre che da conoscere, anche da
pensare. Che un'indicazione del genere venga da un antropologo
come Lévi-Strauss, per quanto sollecitatovi e non di sua
spontanea iniziativa, è da registrare come un contributo
suscettibile certo di essere ridiscusso e problematizzato in altra
sede - attorno a domande come: il diritto è solo una struttura?, è
essenziale alla determinazione del giuridico una fenomenologia
della parentela, e della famiglia?, l'elementare coincide col
'fondamentale'?, e via di seguito -, ma anche come testimonianza
che il diritto esiste, e che ha una sua consistenza
fenomenicamente osservabile.
Partito col desiderio di conoscere personalmente Lévi-Strauss, mi
sono dunque trovato a dover riconoscervi un pensiero giuridico
vero e proprio, da lui esposto nei termini seguenti: che le strutture
elementari della parentela siano il diritto - piuttosto che: esse
siano semplicemente diritto - è dovuto al fatto che i cosiddetti
primitivi pensano queste strutture non già come qualcosa che è,
ma come qualcosa che deve essere, nei termini di quella che per
noi si dà come normatività obbligante. La precisazione che LéviStrauss, su questo punto non richiestone, ha voluto fare è
illuminante: il diritto coincide, nel 'pensiero selvaggio', con ce
qu'il faut, in una maniera tale da implicare un dispositivo di
obbligatorietà che, mentre trascende il piano della pura necessità
biologica, postula al tempo stesso una 'necessarietà' strutturale
delle leggi che sono alla base della socialità umana. In sostanza,
per Lévi-Strauss il diritto non è il prodotto di un'artificialità
arbitraria, ma è la modalità attraverso la quale l'uomo esprime il
suo essere in società in quanto dover essere, cioè in quanto
regolato normativamente: ce qu'il faut è una struttura, cioè
qualcosa che corrisponde ad un modo di essere che non si dà
altrimenti che in quella forma, benché - come Lévi-Strauss si è
affrettato a soggiungere - la parentela e la famiglia, oggi, non
assolvano più i compiti che, per millenni, hanno assolto.
(strettamente) filosofica, come l'Antropologia pragmatica, il
compito di rappresentare, quale principio dell'unità della stessa
filosofia, niente meno che l'uomo (11). È ancor più significativo
che l'interrogazione antropologica kantiana, filosoficamente
motivata e sostenuta, ma non metodologicamente impostata in
termini filosofici - come Heidegger rilevava (12) - , investa
l'uomo come uomo del diritto (13), come quel-l'ente alla cui
determinazione, come genere umano, è essenziale non solo la
necessità di essere membro di una qualche società civile (14) ma
altresì il suo tendere alla realizzazione di un cosmopolitismus
capace di valere come principio regolativo (15).
A prescindere dai problemi filosofici dell'antropologia kantiana che affronta le questioni non trattate dalla filosofia critica (16) non si può fare a meno di notare la sorprendente coincidenza tra
il registro in cui il filosofo Kant, atteggiandosi ad antropologo,
inscrive il carattere dell'umanità (17), e quello a cui l'antropologo
Lévi-Strauss, duecento anni dopo, consegna l'intero significato
delle sue ricerche: nell'uno come nell'altro caso, si tratta di un
registro declinato in termini di normatività obbligante, e nominato
esplicitamente come giuridico. Se, infatti, "l'umanesimo criticista
si afferma, in Kant (...), come umanesimo giuridico" (18), che
conosce, con l'Antropologia, un punto di fuga (19) di fatto
incollocabile (20), ma cionondimeno centrale nell'insieme della
filosofia pratica di Kant (21), la testuale affermazione, con cui
Lévi-Strauss ha definito l'opera sua principale, Le strutture
elementari della parentela, come un'opera sul diritto, configura la
dimensione giuridica (benché implicitamente) come altrettanto
centrale nella sua antropologia. Da Kant a Lévi-Strauss, passando
per Hegel, Marx, Engels, Durkheim, Mauss, Freud, è come se un
medesimo filo, esile o comunque non ben visibile, avesse fatto
incontrare la filosofia e l'antropologia, fino a far ipotizzare che
una certa proiezione antropologica della filosofia, evidente in
Kant, trovi riscontro in un'altrettale (per quanto non confessata)
proiezione filosofica dell'antropologia che, attraverso LéviStrauss, si ripropone come riedizione della tradizione umanistica
(22) documentata ampiamente dalla prima delle tre conferenze
giapponesi su L'antropologia di fronte ai problemi del mondo
moderno (23). Che questo incontro si sia realizzato sul piano del
diritto accende la possibilità di verificare la portata speculativa
sviluppata da una vocazione (anche educativa) al diritto che la
filosofia, almeno a partire da Kant, mostra di comunicare alla
scienza antropologica, nella persona del suo rap-presentante più
autorevole.
Posto che l'interrogazione antropologica, pur procedendo dalla
filosofia, non si dà essa stessa come filosofica - come si è detto di
Kant, che si astiene dal proporre, dal punto di vista pragmatico,
un'antropologia filosofica -, resta che la posizione dell'uomo come
problema è enunciata, da Kant apertamente, come filosofica, anzi
come il senso ultimo della filosofia in quanto tale. L'impostazione
kantiana del problema sarebbe stata condivisa, ma solo
parzialmente e con molte riserve, da Heidegger: "se l'antropologia
raduna già in sé, in certo senso, tutti i problemi centrali della
filosofia, c'è da chiedersi perché questi si lascino ricondurre alla
domanda: che cos'è l'uomo?"(24). L'aver proposto, da parte di
Da Kant a Lévi-Strauss
Ora, comunque sia apprezzabile il valore delle dichiarazioni
verbali rese da Lévi-Strauss, è degna di nota la singolare
convergenza, a due secoli di distanza, tra la formulazione
antropologica del diritto data da un filosofo, come il Kant del
1798, e la interpretazione levistraussiana dell'antropologia
strutturale in termini di antropologia del diritto. È noto che, nel
suo Corso di logica, Kant riassume le tre domande fondamentali
della Critica della ragion pura - che cosa posso sapere?; che cosa
devo fare?; che cosa posso sperare? - in una quarta domanda
decisiva: che cos'è l'uomo?, la quale da sola occupa tutto il campo
della filosofia (9). Si sa pure che Kant ha insegnato antropologia
- e geografia - per tutta la sua vita accademica (dal 1755 al 1796),
connotando come pragmatica la sua dottrina della conoscenza
dell'uomo concepita sistematicamente: per conoscenza
pragmatica ha da intendersi "quello che l'uomo come essere libero
fa oppure può e deve fare di se stesso" (10). È singolare che Kant
abbia assegnato ad un'opera generalmente riconosciuta come non
7
ACHAB
Kant, un'antropologia non 'pura' ma 'empirica, non un analitica
ontologica del Dasein - per usare un vocabolario heideggeriano ma una analisi condotta a livello ontico-esistentivo (25), sarebbe
tale da frustrare qualunque tentativo di aprire una via filosofica
all'antropologia (26). D'altronde, l'antropologia che Kant ha
insegnato per circa trent'anni, se non filosofica, non è neppure
'scienza umana', nel senso in cui lo è, ad esempio, 1'antropologia
strutturale di Lévi-Strauss. Non collocabile né da una parte né
dall'altra, l'antropologia pragmatica, che Kant ha cura di
distinguere dall'antropologia pratica - identificata come morale
pura a priori (27) - nonché dall'antropologia fisiologica (28),
esprime tuttavia un punto di vista originale, al quale il compianto
Pierre Watté riteneva di poter legare l'antropologia e la filosofia
(29).
Occorre in proposito una precisazione: per pragmatica Kant
intende l'attitudine umana alla civiltà per mezzo della cultura,
"principalmente per mezzo delle qualità sociali e della tendenza
naturale, propria della specie, ad uscire nella vita associata fuori
dalla rozzezza del puro egoismo, e a diventare un essere
accostumato (se non ancora morale) atto a vivere con gli altri"
(30). A questa disposizione pragmatica, che sta fra la tecnica e la
morale (31), è inerente una preoccupazione di ordine educativo,
essendo l'uomo "capace e bisognoso di una educazione intesa
tanto come ammaestramento quanto come disciplina" (32). Si
tratta di educare quell'insocievole socievolezza che altrove Kant
attribuisce agli uomini, nel celebre passaggio - schiettamente
antropologico - della quarta tesi dell'Idea di una storia universale
(33). Non va dimenticato che Kant ha elaborato sue originali
Riflessioni sull'educazione, consegnate a corsi specifici da lui
tenuti sull'argomento: in queste riflessioni l'educazione si dà come
fisica o come pratica - ovvero morale, articolandosi quest'ultima
in tre momenti, corrispondenti alla didattica, alla cultura
pragmatica - che riguarda la prudenza -,e alla cultura morale (34).
La cultura della prudenza ,in particolare, prepara l'individuo
umano a diventare cittadino (35), ad acquisire cioè piena
coscienza di sé in rapporto agli altri secondo il diritto: fa parte
della fase formativa pratica la pedagogia dei doveri - verso di sé
e verso gli altri (36) -, tra i quali i doveri verso gli altri
comportano un'esplicita valenza giuridica, nella misura in cui gli
altri sono riconosciuti titolari di un diritto assoluto ad essere
rispettati in quanto uomini (37).
Dove portano queste considerazioni? Innanzitutto a rilevare che
caratteristica fondamentale dell'essere umano è, secondo Kant,
questa sua attitudine pragmatica che, se ed in quanto sottoposta ad
un processo educativo,viene a maturazione in quella virtù - la
Weltklugheit - che appartiene al modo di essere in società che è il
con-essere giuridico proprio dell'individuo-cittadino. L' invito
formulato da Watté, a recepire il pragmatico come punto di vista
fondamentale, che già per Kant costituiva la base degli altri punti
di vista, compreso quello morale (38), può essere dunque accolto
come sollecitazione ad approfondire i legami che, tra filosofia e
antropologia, si annodano attorno alla declinazione
dell'antropologia pragmatica come pedagogia giuridica, o
quantomeno come fase preparatoria di una educazione al diritto la
quale postula, difatti, la conoscenza dell'uomo come cittadino del
mondo (39).
Come si è di recente sottolineato, con particolare riferimento a
Lévi-Strauss - al quale sto per tornare -, "il fatto che la
comprensibilità integrale della condizione umana implichi di per
sé, dal punto di vista dell'antropologia, il riconoscimento della
presenza della dimensione della giuridicità, mostra il legame
cognitivo fra l'esserci del diritto e la forma del suo dover essere
(deontico)" (40). Nel qualificare come giuridica l'architettura di
prescrizioni e di proibizioni entro la quale si costruisce l'edificio
della società 'primitiva', Lévi-Strauss ha come rilanciato, da
antropologo, la proposta, formulata da Kant in lingua filosofica,
di leggere la condizione umana sotto il segno del diritto. C'è da
chiedersi, a questo punto, se l'Hinsicht pragmatico possa
abbracciare filosofia e antropologia proprio sul terreno, giuridico,
che sembra mettere l'una a contatto dell'altra (41): trattasi di
contiguità tematica puramente occasionale, oppure sono in
questione nessi più profondi, attingibili ad un livello metafisico?
Va ricordato, a tale proposito, dal lato filosofico, che per Kant
"non si può fondare la metafisica dei costumi sull'antropologia,
ma si può ad essa applicarla" (42), in quanto l'antropologia, a
differenza della Weltwissenschaft metafisica, così come della
scienza della natura, indaga il campo della Weltkenntnis,
determinata dall'intersoggettivo (43).
L'intersoggettività è la dimensione propria dell'etica, della
politica, del diritto, ed è tale da poter essere conosciuta
appropriatamente in base non tanto alla ragion pura quanto
all'esperienza, come Kant insegnava nell'Introduzione alla sua
Geografia (44): significativamente, il filosofo di Königsberg
precisava, in effetti, che "per quel che concerne le fonti e l'origine
delle nostre conoscenze, noi vi attingiamo sia nella ragion pura sia
nell' esperienza che, a sua volta, istruisce la ragione" (45). Già la
geografia fisica, prima ancora della stessa antropologia, non
risulta essere filosoficamente indifferente, nella misura in cui le
conoscenze che essa fornisce istruiscono la ragione,
alimentandone la speculazione: essa costituisce una propedeutica
alla conoscenza del mondo, che si sviluppa in quella conoscenza
dell'uomo che è l'antropologia pragmatica (46). A questi livelli
conoscitivi, indicati come pre-speculativi, nel senso di introduttivi
ad una razionalità pratica (47), la filosofia non può restare
indifferente, perché anzi "la vera filosofia consiste nel se-guire la
diversità e la varietà di una cosa attraverso tutte le epoche" (48):
diversità e varietà sono le caratteristiche di prima evidenza, e di
prima approssimazione, che la moderna antropologia culturale
coglie nei fenomeni dei quali si occupa.
Posto che l'antropologia, così come la geografia, non sono capaci
di attingere un'universalità normativa, ma tutt'al più una
universalità empirico-'estensiva' (49), i1 ricorso alla speculazione
critico-razionale si renderebbe necessario ai fini di una
comprensione adeguata dei dati della conoscenza. Ma proprio qui
è il nodo: se una metafisica dei costumi non può fare a meno di
un'antropologia geografica e pragmatica, che altro non è se non
un'antropologia dei costumi, il materiale che questa può offrire a
quella si riduce alla funzione di mero combustibile di una
8
ACHAB
riflessione filosofico-pratica puntata sull'universale, oppure la
fenomenologia antropologica è portatrice di conoscenze già
cariche di significati filosofici?
Si è precedentemente avuto modo di enucleare, nella prospettiva
antropologica indicata da Kant, una specifica dimensione
deontologica (50), propria dell'intersoggettività giuridica:
dimensione, questa, che configura l'antropologia pragmatica,
piuttosto che come una metafisica 'applicata', come il terreno di
sondaggio fenomenologico-empirico di quello che spesso è stato
presentato come il momento saliente dell'intero percorso
filosofico kantiano, vale a dire il diritto (51). Non è forse casuale
il ricorrere, nella Kennmis antropologico-pragmatica, di due
termini, come diritto e prudenza la sintesi - tradizionale - dei quali
dà luogo alla giuris-prudenza: quest'ultima corrisponde ad una
forma di sapere che, da sempre, non è assimilabile né ad un
Wissen né ad una Wissenschaft, semmai è quella che i romani
chiamavano iusti atque iniusti scientia - per dirla con Ulpiano
(cfr. Digesto 1,1,10) - , che si annuncia come divinarum atque
humanarum rerum notitia (52). In una lettera a Christian Garve,
proponendosi come 'professore di prudenza', Kant afferma di
volere "stabilire il sistema della filosofia da un punto di vista
pragmatico come dottrina dell'abilità e della prudenza" (53), la
quale ultima virtù coincide col saper prendersi cura dei propri
interessi, come già sanno fare i primitivi (54). La prudenza riferita
al diritto consente di articolare quello specifico sapere pragmatico
che è il sapere giurisprudenziale, che sta tra il sapere
propriamente scientifico ed il sapere filosofico: il punto di
osservazione kantiano considera la giurisprudenza come sapere
conoscitivo ed insieme pragmatico, la cui specificità,
antropologicamente documentata nonché teoreticamente
argomentabile, libera il sapere giuridico da riduzionismi
tecnicistici, attestandolo su di una posizione dalla quale è la
ragione stessa a dire il diritto, di fronte alla scienza così come alla
morale.
Con l'ispirare 'prudenza', il sapere che procede pragmaticamente
trova nel diritto la sua espressione più adeguata, realizzando un
modo di conoscere e di operare nel mondo che corrisponde ad una
antropologia da intendersi nel senso di scienza delle regole - di
prudenza - della condotta effettiva dell'uomo, come da Kant
puntualizzato nelle sue Lezioni di etica (55). Questa scienza
mostra di sapere che, per conoscere - ed educare - l'uomo, occorre
appunto quella 'prudenza' che né le 'leggi del pensiero' illustrate
dalla metafisica né gli imperativi della morale possono suggerire:
in questo senso, si può supporre che esista un sapere
giurisprudenziale che non è assimilabile né alla metafisica né alla
morale, pur partecipando di elementi dell'una e dell'altra e che a
questo sapere appartengono un'antropologia ed una filosofia. Vi
appartiene un'antropologia perché vi è implicato tutto un modo,
sapientemente impostato ed articolato, d'intendere il
comportamento dell'uomo - informato alla prudenza, che non
dipende né da una tecnica né dall'adempimento di doveri morali;
vi appartiene una filosofia perché vi sono in questione un potere
(sapere), un dovere (di essere e di fare), un diritto (di attendersi
qualcosa da qualcuno), che corrispondono alle tre domande
fondamentali che la Logica kantiana rapporta alla quarta,
riguardante l'uomo. La tensione fra questi due distinti - ma forse
non separabili - poli di interesse, l'antropologico e il filosofico,
genera una modalità di accesso alla conoscenza ed alla prassi che
si sottrae al dualismo fra teoria e pratica, proprio ad un punto di
vista 'sistematico', per attuarsi come concezione pragmaticogiuridica dell'esperienza umana in quanto esperienza
intersoggettiva. Il punto di vista pragmatico formulato da Kant
consente pertanto di pensare l'intersoggettivo, il sociale, i legami
che esso comporta, come modulati secondo il diritto, in una
maniera tale da presentare il diritto non come 'funzione' della
società, e neppure anzitutto come 'forma' di quest'ultima, ma
come un'esigenza - metafisica - della ragione. Ne risulta un modo
di intendere la socialità umana come proiezione di questa
esigenza giuridica, in termini sia di dimensione strutturale testimoniata da Lévi-Strauss - sia di dinamica di sviluppo storico,
che ancora richiede di essere presa in esame, soprattutto alla luce
della Critica della ragione dialettica di Sartre.
Tutto questo complesso di elementi si agita dietro una lettura della
socialità umana elementare - come quella proposta da LéviStrauss - nella quale, nominato apertamente, il diritto incide in via
principale, quale modalità culturale autorappresentativa del
sociale stesso. La ragione giuridica, che presiede al modo di
conoscere pragmatico-prudenziale, interessa più direttamente, in
Kant, la condotta umana e le sue regole, mentre in Lévi-Strauss il
giuridico tende a coincidere con la stessa ragion d'essere della
socialità umana, quale necessità ontologica ad essa intrinseca.
Non si tratta, comunque, a tale riguardo, di ricercare e di accertare
elementi di kantismo nell'opera di Lévi-Strauss, né di accentuare
oltre il dovuto la portata antropologica della filosofia di Kant.
Siamo di fronte, in realtà, a due fonti di pensiero - una
antropologica, l'altra filosofica - che invitano, a diverso titolo e
con differente competenza, a riconoscere nel diritto la modalità
eminente, ad un tempo attuativa e conoscitiva, con la quale
l'uomo si comporta e si concepisce in rapporto all'altro uomo.
Certamente, l'una e l'altra impresa intellettuale ci dicono poco
della relazione inter-umana: Lévi-Strauss evita addirittura di
parlare di 'soggetti', avendo impostato la sua analisi
strutturalistica 'oltre' il soggetto. Tenuto presente questo limite,
non ci si può esimere dal tentativo, sin qui accennato, di appurare
elementi di reciproca fecondità fra le due posizioni.
Freud e Lévi-Strauss
Ora, quando si parla di relazione, si parla del "punto di
riferimento
antropologico-coscienziale
essenziale
dell'introspettiva psicologia del 'profondo' e, in particolar modo,
della psicoanalisi" (56). Non è questa la sede per discutere dei
rapporti fra l'antropologia e la psicoanalisi, anche se va rilevato
che Lévi-Strauss è stato un assiduo lettore di Freud (57). La
circostanza per la quale oggi, dall'interno stesso di importanti
esperienze di ricerca psicoanalitica, cresce l'interesse attorno al
diritto (58) - ma a prescindere da un confronto aperto con
l'antropologia di Lévi-Strauss (59) - è tra i motivi che impongono
di acquisire il contributo della psicoanalisi alla ricerca di
9
ACHAB
interazioni feconde tra filosofia e antropologia in materia di
diritto.
Si sa che, per Lévi-Strauss, la soglia d'ingresso dell'umanità nello
stato di cultura è data dalla proibizione dell'incesto, regola sociale
per eccellenza che consente il superamento della chiusura della
famiglia biologica attraverso l'instaurarsi di reti di reciprocità fra
i gruppi, che ricevono dall'istituzione del matrimonio la loro
forma essenziale, sintetizzabile nel termine polisenso alliance, di
valenza giuridica e insieme politica. È altrettanto risaputo che a
Lévi-Strauss non interessa indagare l'organizzazione psichica di
questo assetto giuridico originario, secondo il quale la società
umana si struttura. Per lui, infatti, la 'coscienza' di un soggetto
umano, sul quale deve pur fare presa qualcosa come una
proibizione, non è altro che il riflesso di strutture inconsce che,
prima di essere pensate dall'uomo, 'si pensano' nell'uomo sotto
forma di miti (60). La vicenda nella quale Totem e tabù e Il
disagio della civiltà di Freud ambientano, sulla scorta del Ramo
d'oro di Frazer, il primo formarsi della società umana come
società giuridica, fa apparire formazioni dell'inconscio riferibili
al lavoro di un soggetto, che prende sempre più coscienza del suo
dovere di diventare Ich in rapporto ad un contesto che si dà come
relazionale in quanto, sin dall'inizio - con il padre, la madre, i
fratelli -, già familiare, e non al contrario (come accade in LéviStrauss, dove la famiglia istituzionale compare per effetto di una
relazione posta da una proibizione). Dell'io, in Lévi-Strauss, non
c'è traccia visibile: già questo basterebbe a smontare qualunque
tentativo di 'psicologizzare' l'approccio dell'antropologo alla
genesi del sociale. Invero, non si può fingere di ignorare che LéviStrauss ha in-dividuato, di questa socio-genesi, il punto focale nel
giuridico, qualificando l'alliance come formula elementare della
socialità umana.
Alliance può voler dire, a seconda dei contesti semantici, ora
'alleanza', ora 'matrimonio', ora parentela-imparentamento.
L'alliance ou la mort potrebbe essere il motto - parafrasato da
un'altra indagine a cavallo tra lo psicoanalitico e l'antropologico
(61) - della socialità umana secondo secondo Lévi-Strauss. Come
dire: il diritto o la morte.
Tutto ciò che per Freud si presenta come organizzazione psichica
profonda del sociale, in Lévi-Strauss acquista il significato
'povero' di organizzazione linguistica: l'uno e l'altro approccio
postulano il giuridico come livello qualificativo comune. Sia l'uno
sia l'altro assumono, però, il giuridico - sia pure a partire da una
diversa interpretazione del fenomeno totemico - come qualcosa
che prima non c'era e, da un certo punto in poi, c'è stato: in Freud,
il giuridico si coglie nel passaggio dal regime del padre detentore
di tutte le donne al regime civile-familiare dei fratelli; in LéviStrauss, la famiglia 'biologica' passa ad essere famiglia civileculturale solo per l'intervento della regola esogamica
rappresentata, in negativo, dalla proibizione dell'incesto.
L'acquisizione del giuridico all'ordine del sociale è data, prima di
essere un dato sociologicamente registrabile: è data come è data
la parola - come in molti miti dei popoli primitivi, dove si narra
che gli uomini hanno cominciato a riconoscersi fra di loro come
tali per il fatto di aver cominciato a parlare -; data come è data la
vita umana, come vita psichica. Dove c'è dello psichico, li c'è già
del giuridico; dove c'è del linguistico, lì c'è già dello psichico e del
giuridico. Questi tre livelli primari di apparizione dell'umano si
danno già come 'familiarizzati', e - se ci si può concedere
l'espressione - 'donativizzati'. La triangolazione edipica struttura,
per Freud, la vita psichica dell'individuo come vita giuridica;
parimenti, la alliance, per Lévi-Strauss, struttura la vita sociale
come vita giuridica. Il punto è: l'alliance o la proibizione
dell'incesto? O tutt'e due? A. Delrieu fa notare che, se LéviStrauss avesse davvero creduto nella tesi della proibizione
dell'incesto, sarebbe dovuto, prima o poi, ritornare a Freud, ed in
particolare a quel che Freud ha detto della colpa che pesa su
legame sociale (62). L'aver declinato, da subito, la proibizione in
prescrizione, esogamica, di alliance ha fatto slittare in termini di
'positività' tutto ciò che il 'negativo' sembrava riferire ad
un'istanza psichica inconscia. Evitando lo scoglio dell'incesto
'freudiano', Lévi-Strauss ha polarizzato la valenza istitutiva del
legame sociale nella versione prescrittivo-esogamica del tabù.
Tutto questo porta ad una domanda: la prima forma del diritto è
negativa - fino al punto che si può immaginare il diritto penale
come primo diritto - o è positiva, dandosi come esistenzialmente
e sociologicamente 'primo' il diritto di famiglia? Ancora: può la
prima forma del diritto, come negativa e positiva ad un tempo,
consistere in un ordinamento giuridico, civile e penale, della
famiglia? Se si ammette, con Delrieu, che il diritto viene prima
dell'interdetto dell'incesto (63), non è la presunta universalità di
quest'ultimo a dare ragione del fenomeno giuridico, ma è
l'universalità del diritto a spiegare l'esistenza, tra le altre, anche di
questa regola. In questione è l'uomo stesso come essere di diritto
(64), portatore di strutture mentali universali - afferenti a quella
che, per Kant, sarebbe la ragion pratica (65) - che Lévi-Strauss
indica nella regola, nella reciprocità e nel dono (66). Il confronto
fra Lévi-Strauss e Freud permette di tornare a Kant con
l'acquisizione, problematica ma imprescindibile, di un pensiero
antropologico che pensa l'universale, il diritto, l'uomo in termini
non empirico-descrittivi, ma filosofici (67).
Si può concludere, con B. Karsenti - uno studioso che ha di
recente rivalutato il pensiero e l'opera di Marcel Mauss (68) - , che
"le scienze umane hanno una portata filosofica che deborda
largamente il quadro limitato e datato della loro formulazione
originaria" (69); che, in particolare, l'antropologia si atteggia da
subito - già con Durkheim - a filosofia sociale, che propone
un'ontologia dell'unità uma-na intesa come unità sociale (70).
Non si può concordare con Karsenti, tuttavia, nel sostenere che
l'antropologia si sviluppa filosoficamente solo quando si libera
della problematica del fondamento giuridico del legame sociale
(71). Si è visto, all'opposto, che l'impulso a sviluppare la portata
filosofica dell'antropologia viene, in maniera significativa,
proprio dall'urgenza delle questioni di diritto che si agitano nella
riflessione del filosofo che guarda all'uomo con gli occhi
dell'antropologo e del geografo (Kant), dello psicoanalista che
scruta le profondità della psiche da quasi-filosofo (Freud),
dell'antropo1ogo, infine, che enuncia, da anti-filosofo, tesi di
filosofia giuridica, morale, sociale non dichiarata (Lévi-Strauss).
10
ACHAB
Note
* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione di un saggio da me pubblicato in appendice al Quaderno 2000 della rivista di scienze
umane 'Nuovo Sviluppo', contenente il testo inedito di Claude Lévi-Strauss che raccoglie le tre conferenze tenute dall'antropologo a
Tokyo, tra il 15 e il 16 aprile del 1986, sul tema L'antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno (chi sia interessato può
rivolgersi al seguente indirizzo: [email protected]). In sèguito, Lévi-Strauss accettò di entrare nel comitato scientifico di 'Nuovo
Sviluppo' - unico caso, a quanto mi risulti, di una sua qualificante ed autorevole partecipazione a sedi editoriali del genere, almeno in
Italia.
1 Vedi A. DI CARO, Lévi-Strauss: teoria della lingua o antropologismo?, Milano 1981.
2 Cfr. C. LÈVI-STRAUSS, Retours en arrière, 'Les temps modernes', 598/1998, pp.66-77, scritto in risposta, ferma e a tratti dura, ad
un articolo, comparso sul n. 596/1997 della medesima rivista, a firma di C. Delacampagne e B. Traimond in merito alla polemica
Sartre/Lévi-Strauss risalente ai primi anni Sessanta.
3 Cfr. 'Critique', 620-621/1999. A dieci anni di distanza dall'incontro con quella che Bernard Henri-Lévy ha definito, forse non
iperbolicamente, l'incarnazione di un momento specificamente francese del pensiero occidentale, dopo i momenti greco e tedesco (si
veda il suo articolo Ce que nous devons à Lévi-Strauss, 'Le Point', 1888/2008), tra le tante ed autorevoli pubblicazioni sull'opera di
Lévi-Strauss mi permetto di segnalare, in particolare, gli agili volumetti di Frédéric KECK, Lévi-Strauss et la pensée sauvage, Paris
2004 (di taglio più spiccatamente filosofico), e Claude Lévi-Strauss, une introduction, Paris 2005, nonché i saggi raccolti nel numero
speciale di 'Le Temps Modernes', 628/2004, dedicato al grande antropologo. In lingua italiana, oltre alla riedizione, ampliata e
ripensata, del libro di Sergio MORAVIA, La ragione nascosta (Firenze 1969), intitolata Ragione strutturale e universi di senso (Firenze
2004), va ricordata la recentissima antologia di testi Lévi-Strauss. Fuori di sé, Macerata 2008. In traduzione italiana va inoltre tenuto
presente l'originale Lévi-Strauss di Catherine CLÉMENT (Roma 2004), della quale si può leggere altresì il recentissimo, interessante
saggio su Lévi-Strauss et la France ('La règle du jeu', 37/2008, pp. 81-96). In questi ultimi anni non ho mancato, dal canto mio, di
proseguire le mie ricerche, discusse con studiosi di lingua francese e inglese, intorno al Nostro, in una chiave di lettura antropologicofilosofica tale da consentire un ripensamento profondo del diritto quale struttura di coordinazione. Traccia di queste ricerche si trova
in lavori in corso di stampa, o appena avviati.
4 Cfr. il mio Dimensioni della giuridicità nell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss, Milano 1994, nonché, per maggiore
autorevolezza, S. COTTA, Soggetto umano. Soggetto giuridico, Milano 1997, cap. IV.
5 Cfr. in particolare N. ROULAND, Antropologia giuridica, Milano 1992.
6 Cfr. G. VATTIMO, Fare giustizia del diritto, in Diritto, giustizia e interpretazione, a cura di ID. e J. DERRIDA, Roma-Bari 1998; in
ideale risposta cfr. Rendre justice au droit, a cura di F. X. DRUET e E. GANTY, Namur 1999.
7 Cfr. B. MONTANARI, Itinerario di filosofia del diritto, Padova1995; ID. - A. COSTANZO, Teoria generale del diritto, Torino 1998.
8 Cfr. P. VENTURA, Pensare oggi al diritto, Introduzione a AA.VV., Pensando al diritto, Torino 1999.
9 Cfr. A. RENAUT, La place de l'Anthropologie dans la théorie kantienne du sujet, in L'année 1798 - Kant sur l'anthropologie, a cura
di J. FERRARI, Paris 1997, p.51.
10 I. KANT, Antropologia pragmatica, Bari 1985, p. 3.
11 Cfr. A. RENAUT, loc. cit., p. 61.
12 Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafìsica, Bari 1989, p.182:"un'antropologia può dirsi filosofica quando segue un
metodo filosofico, ossia, su per giù, quando prende in considerazione l'essenza dell'uomo".
13 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen dans l'anthropologie kantienne, in L'année 1798, cit., p. 97.
14 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 225.
15 Cfr., op. cit., p.227.
16 Cfr. N. DELATTRE-DELEC, Sciences humaines, sciences de l'homme, science de la nature: le laboratoire transversal de Freud, in
AA.VV., Les sciences humaines sont elles des sciences de l'homme?, Paris 1998, pp.54-55.
17 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 225.
18 A. RENAUT, La place de l'Anthropologie, cit., p. 62.
19 Cfr. op. cit., p. 63.
20 Cfr. op. cit., p. 57.
21 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen…, cit., p. 82
22 Cfr. J. B. FAGES, Comprendere Lévi-Strauss, Toulouse 1972, p. 109.
23 Il testo delle conferenze pronunciate da Lévi-Strauss a Tokyo fra il 15 e il 16 aprile del 1986 presso la Fondazione Ishizaka intitolate L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne - non è stato mai pubblicato nell'originale francese, e ha conosciuto,
su autorizzazione dell'autore e di Satoshi Tsuzukibashi, una prima traduzione in Occidente nel Quaderno 2000 della rivista di scienze
umane 'Nuovo Sviluppo', diretta dal compianto Luigi Pasquazi, per poi registrare, nel 2006, una traduzione in giapponese a cura di
11
ACHAB
Kawada Junzo e di Kozo Watanabe, dell'Università Ritsumeikan di Kyoto. Dalla lettura di queste pagine emerge un Lévi-Strauss in
presa diretta con alcuni dei problemi fondamentali del nostro tempo - e, tra questi, vi sono problemi giuridici sui quali Lévi-Strauss
non si è mai soffermato così a lungo -, esaminati con lo spirito dell'antropologo che sa di essere un uomo di cultura di formazione
occidentale a confronto con la cultura e la storia di un Oriente geograficamente e spiritualmente estremo, come quello nipponico. Chi
conosce Lévi-Strauss può ravvisarvi l'espressione di una libertà di opinioni che si ritrova forse solo nelle Riflessioni sulla libertà, che
l'antropologo espose nell'Assemblea Nazionale francese nel maggio del 1976, e in qualche raro intervento polemico. Chi non conosce
Lévi-Strauss potrà rendersi conto della portata complessiva degli esiti principali di tutta una vita di ricerche: esiti che qui incontrano
la 'prova' dell'attualità, oltre che - come nella migliore tradizione antropologica - la prova dell'alterità radicale di usi, costumi, credenze,
lo sguardo da lontano trovando qui di che spaziare da un meridiano culturale all'altro. Chi si interessa all'Oriente, ed in specie al
Giappone, potrà allargare il suo sguardo con l'originale proiezione ottica di Lévi-Strauss, attestata in particolare dalla conferenza di
Kyoto del 9 marzo 1988 su La place de la culture japonaise dans le monde, pubblicata nella 'Revue d'Esthétique' (18/1990). Non
mancherà, infine, chi crederà di poter scorgere, in alcuni passaggi di queste conferenze, l'abbozzo di una 'antropologia dell'alterità' che,
proprio pensando anche al Giappone, un filosofo che vi abitò e vi insegnò da esule tra il 1936 e il 1941, Karl Löwith, tentò in una sua
opera poco conosciuta (Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen), e pubblicata in traduzione italiana soltanto nel 2007.
24 M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, cit., p. 185.
25 Cfr. N. PIRILLO, Morale e civiltà, Napoli 1995, pp. 71-73.
26 Su questo punto, e sulle sue implicazioni problematiche, mi permetto di rinviare al mio L'antropologia culturale alla ricerca del suo
fondamento: l'archeologia fenomenologica, 'Rivista internazionale di filosofia del diritto', 3/1998, p. 403, n. 2.
27 Cfr. S. GOYARD-FABRE, L'homme et le citoyen..., cit., p. 90.
28 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 3.
29 Cfr. P. WATTÉ, Anthropologie et philosophie: un double retour au fondement, 'Revue philosophique de Louvain', mai 1993, p. 227,
n. 30.
30 I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., pp.2l8-219.
31 Cfr. op. cit., pp.2l7-220.
32 Op. cit., pp.219.
33 Cfr. ID., Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino
I971, p. 127.
34 Cfr. ID., La pedagogia, Firenze 1975, p. 21.
35 Cfr. op. cit., pp. 21-22.
36 Cfr. op. cit., pp. 64-65.
37 Cfr. loc. cit.: la proiezione pedagogica dell'antropologia pragmatica di Kant, in termini conoscitivi piuttosto che pratici, è stata
messa in evidenza nel mio L'educazione ai diritti dell'uomo, cap. IX del mio Per una antropologia filosofica dei diritti dell'uomo,
Foggia 2001, in Appendice al quale si può leggere una prima stesura del presente saggio.
38 Cfr. R. BRANDT, Commentaire de la Préface de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, in L'Année 1798, cit., p. 202.
39 Cfr. I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 4.
40 S. COTTA, Soggetto umano. Soggetto giuridico, cit., pp. 86-87.
41 Su questo contatto 'di frontiera', mi permetto rinviare ai miei Studi di antropologia giuridica, Napoli 1996, cap. V.
42 I. KANT, Principi metafisici della dottrina del diritto, in Scritti politici, cit., p. 392.
43 Cfr. N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., pp. 26 e 27.
44 Nella pagina culturale di uno dei principali quotidiani italiani, i francesi sono stati accusati di aver 'perso tempo' a tradurre la
Physische Geographie, pubblicata per la prima volta nel 1802, ed alla quale Kant aveva dedicato un numero di corsi (49) maggiore di
quelli dedicati all'etica (46), all'antropologia (28), al diritto (16), e minore soltanto rispetto a quelli dedicati alla logica e alla metafisica
(54). Se dal 1757 al 1796 Kant ha perso tempo..., è probabile che perdere tempo dietro al Kant geografo e geofilosofo del diritto sia
un lusso che ci si può permettere (su tutto questo cfr. in particolare M. CAMPO, La genesi del criticismo kantiano, Varese 1953, pp.
178-179). "È per questo necessario che l'antropologia - almeno in senso kantiano - non divenga scienza, ma sia in qualche modo di
aiuto e di verifica dell'indagine filosofica e scientifica propriamente detta" (I. F. BALDO, Kant e la ricerca antropologica, in AA.VV.,
Il problema dell'antropologia, Padova 1980, p. 75), anche se il passaggio operato dallo stesso Kant, "dalla Naturbeschreibung alla
Naturgeschíchte, segnerà la prima fondamentale tappa per uno sviluppo effettivo dell'antropologia come scienza" (op. cit., p. 72).
45 I. KANT, Géographie, Paris 1999, p. 66. Se la conoscenza del mondo "ha lo stesso significato di antropologia pragmatica
(conoscenza degli uomini)" (M. HEIDEGGER, L'essenza del fondamento, in Essere e tempo, Torino 1978, p. 655), proprio dalla
conoscenza del mondo che si esprime nella geografia fisica "sorgeranno quegli interrogativi che spingeranno Kant ad impostare un
autonomo corso di antropologia, dopo aver preparato un testo (Urtext) nel 1759 di geografia ed aver ampliato il campo di indagine
della geografia stessa, che dev'essere anche morale e politica oltre che fisica" (I. F. BALDO, Kant e la ricerca antropologica, cit., p.
75).
12
ACHAB
46 Cfr. I. KANT, Géographie, cit., p. 66.
47 N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., p. 29.
48 I. KANT, Géographie, cit., p. 71.
49 Cfr. M. CASTILLO, L'actualité de l'anthropologie kantienne, in L'Année 1798, cit., p. l78.
50 Cfr. op. cit., p. 183.
51 Cfr. O. DEKENS, D'un point de vue géographique sur la philosophie kantienne, 'Revue de métaphysique et de morale', 2/1998, pp.
259-260. Ciò non vale solo per la filosofia kantiana perché, "in una certa maniera, la riflessione sul diritto mette in discussione la
ragione filosofica nel suo insieme, nel suo divenire storico come nella sua attualità, nella sua essenza come nelle sue procedure"
(J.GREISCH , Présentation a AA.VV., Le droit, Paris 1984, p. 5).
52 Sulla discussione della giurisprudenza come specifica forma di sapere 'sapiente', piuttosto che scientifico in senso moderno, cfr. P.
VENTURA, Introduzione a Pensando al diritto, cit., pp.7-16.
53 Cit. in R. BRANDT, Commentaire de la Préface de l'Anthropologie, cit., p. 200.
54 Cfr. ibidem.
55 N. PIRILLO, Morale e civiltà, cit., p. 33, n. 50. Circa il rapporto fra il diritto e la prudenza valgono le seguenti considerazioni del
compianto Sergio Cotta: "il diritto considerato globalmente è il prodotto di un esercizio della ragione in quanto calcolo, previsione,
organizzazione. Per usare un linguaggio classico, la virtù che meglio gli si addice è la virtù della prudenza. Si potrebbe persino dire
che, nel campo della prassi, esso rappresenta lo sforzo maggiore di questo tipo di ragione e di questo tipo di virtù" (S. COTTA, Itinerari
esistenziali del diritto, Napoli 1972, p. 139). Più in generale mi permetto rinviare al mio Phrònesis, prudentia, giuris-prudenza, 'Nuovo
Sviluppo', Quaderno 2004, pp. 59-93.
56 ID. Soggetto umano. Soggetto giuridico, cit., p. l03. Su tutto quanto riguarda i rapporti fra psicoanalisi, diritto, antropologia e
filosofia cfr. in particolare P. VENTURA, Freud e la giuridicità della coesistenza, Milano 1979, e ID., La psicoanalisi collettiva, Milano
1984.
57 Cfr. A. DELRIEU, Lévi-Strauss lecteur de Freud, Cahors 1993: questo libro, del quale qui di sèguito saranno discussi alcuni
passaggi, reca come sottotitolo: Il diritto, l'incesto, il padre e lo scambio delle donne. Centrale, nella considerazione dell'autore, è il
ruolo che il diritto svolge nell'elaborazione levistraussiana, da Delrieu peraltro non condivisa del tutto, di alcune categorie
fondamentali della psicoanalisi freudiana.
58 Si pensi alla pubblicazione su L'esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, a cura di C. ZANZI, Milano 1999, che raccoglie
numerosi e variegati contributi alla riflessione sul diritto, stimolata dal lavoro dello Studium Cartello diretto da Giacomo B. Contri.
59 Cfr. G. B. CONTRI, Libertà di psicologia, Milano 1999, p. 13. Un'inimicizia così aspra, come quella che traspare da questo
volumetto, pur estremamente apprezzabile per la questione filosofica e giuridica che solleva, si può forse spiegare con la fratellanza
intellettuale profonda che legava uno strutturalista come Lacan, maestro di Contri, a Lévi-Strauss (a ciò fa pensare un libro di N.
Panoff, dedicato a Lévi-Strauss e a Roger Caillois, Les frères ennemis, Paris 1993).
60 In proposito cfr., in particolare, M. GALLO, Pensiero e realtà. Logica e ricerca in Lévi-Strauss, Napoli 1998.
61 Cfr. M. SAFOUAN, La parole ou la mort, Paris 1993.
62 Cfr. A. DELRIEU, Lévi-Strauss lecteur de Freud, cit., p. 74.
63 Cfr. op. cit., p. 54.
64 Cfr. op. cit., p. 64.
65 Cfr. op. cit., p. 25.
66 Cfr. C. LÉVI-STRAUSS, Le strutture elementari della parentela, Milano1976, p. 139. È stato rilevato, criticamente, che lo
strutturalismo etnologico si atteggia a teoria generale dell'uomo, filosoficamente pretenziosa (cfr. R. BOUVERESSE, La philosophie
et les sciences de l'homme, Tours 1998, p. 45). Il problema è che gli elementi per una tale teoria - a forte impronta giuridica - non
mancano.
67 Un recente tentativo di far passare Lévi-Strauss per un quasi-filosofo esistenzialista sembra per lo meno azzardato: cfr. A. BRUNO,
Saggio su Claude Lévi-Strauss. Esistenza-Etica, Manduria 1999.
68 Cfr. B. KARSENTI, Marcel Mauss.Le fait social total, Paris I993 e ID., L'homme total, Paris 1997.
69 ID., La philosophie et les sciences de l'homme, 'Revue des Sciences morales et politiques', 3/1997, p. 48. Per un quadro più
generale, si veda anche S. BORUTTI, Filosofia delle scienze umane, Milano 1999.
70 Cfr. B. KARSENTI, La philosophie et les sciences de l'homme, cit., p. 52.
71 Cfr. art. cit., p. 59.
13
ACHAB
Il pensiero selvaggio nell’era elettrica
di Gianni Trimarchi
Non è semplice comparare il rigore scientifico delle opere di C.
Levi-Strauss con l’ironica narratività di McLuhan: egli ama
definirsi, shakespeareamente, come un buffone (fool) che “rompe
gli schemi dati e forza una presa di coscienza attraverso un
linguaggio altro, liberato dalla logica letterale” (Lamberti, p. 3435). Ciò nonostante, alcune analogie fra i due autori appaiono con
molta evidenza, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti
della civiltà industriale avanzata, che McLuhan non esita a
definire come totemici. Certo non a caso, nella prefazione a La
sposa meccanica, viene citato proprio Levi-Strauss.
In sostanza, come scrive Ugo Fabietti a proposito della teoria di
Levi-Strauss:
“Questa prospettiva porta alla caduta dell’antica distinzione tra
pensiero logico, razionale e civilizzato da un lato e pensiero
prelogico, mistico e primitivo dall’altro. Si tratta piuttosto, per
Lévi-Strauss, di definire quelle leggi del pensiero che sono
sempre le stesse” (U. Fabietti, Levi-Strauss moderno..., p. 10).
Anche MacLuhan ravvisa una caduta di antiche distinzioni, così
come, per altro verso, aveva ravvisato una convergenza fra vita e
macchina, intesa a rompere la tradizionale rivalità fra
meccanicismo e vitalismo.1 L’alimentatore delle macchine
elettroniche è in certa misura un cuoco, che prepara alimenti (M.
McLuhan, La sposa meccanica, p. 74), mentre il carburante è
qualcosa di simile a un cibo che la macchina digerisce, (M.
McLuhan, La sposa meccanica, p. 199). Una fabbrica
automatizzata di automobili in certo senso le secerne, come il
fegato secerne la bile, o una pianta fa le foglie (M. Mcluhan, La
sposa meccanica, p. 74).2
Tutto ciò, nel contesto de La sposa meccanica, possiede forti
tendenze distruttive, che sembrano assimilare il pensiero di
MacLuhan ad alcuni aspetti della critica di Horkheimer e Adorno
all’industria culturale,3 come compare da un passo relativo alla
moda femminile, nella società industriale avanzata, che tende ad
assimilare la donna a una macchina.
“Leggendo La sposa meccanica vengono in mente le ricerche di
Levi-Strauss sull’anima primitiva.
(...) È nota l’affermazione di McLuhan, che...ci riporta al
villaggio tribale, anche se su scala planetaria (...). L’americano
medio ricorda stranamente le tribù protagoniste dei viaggi
dell’antropologo francese” (R. Faenza, prefazione a: M.
MacLuhan, La sposa meccanica, p. 7).
Anzitutto il Nostro definisce la nostra epoca come una
sopravvivenza dell’età del cacciatore, dando però a questo
termine un particolare significato; egli parla infatti dell’“uomo in
caccia perenne di dati e informazioni indispensabili per la sua
sopravvivenza” (M. McLuhan, La sposa meccanica, p. 10).
Anche il titolo di un giornale, in questa lettura, esprime elementi
arcaici, poiché si tratta di un “grido primitivo di rabbia”, nato fra
le passioni violente (M. McLuhan, La sposa meccanica, p. 23).
Il mondo nel suo insieme, proprio grazie alla dimensione
“elettrica”, tende sempre più a comprimersi e a dare sempre più
spazio alla dimensione della contemporaneità, assumendo le
caratteristiche di un villaggio tribale (M. McLuhan, La sposa
meccanica, p. 28). In questo contesto la civilizzazione si presenta
in una forma ben singolare, dal momento che in molti casi “un
eminente scienziato ha spesso emotività e gusti di lettura tipici di
un bambino avido di violenza” (M. McLuhan, La sposa
meccanica, p. 28).
Facendo un discorso sostanzialmente analogo, una decina di anni
dopo Levi-Strauss scrive:
“Per la ragazza moderna le gambe come il busto sono punti di
potere, corredo necessario al successo, piuttosto che in senso
erotico, o sensuale (...) sono semplicemente oggetti da mettere in
mostra, come le cromature di una vettura (La sposa meccanica,
197) (...). Quando una donna vuole apparire nella sua luce
migliore non solo si infila una camicia di forza, ma si mette i
tacchi a spillo, per essere sicura che non sarà capace di un solo
gesto libero del braccio, o della gamba” (id: 291).
Questo risulta anche in un certo tipo di narrativa, che mostra una
spiccata tendenza a trasformare in automi gli uomini. Il cow boy
dei grandi western, così come il direttore d’azienda, tutto preso
dal suo lavoro, risulta “emotivamente indurito e insensibile a
tutto, fuorché a una ristretta area di esperienza. Egli è capace di
agire, ma non di sentire” (M. McLuhan, La sposa meccanica, p.
299).
In certa misura per McLuhan, come per Horkheimer e Adorno, un
certo tipo di sviluppo sembra portare a una nuova barbarie, non a
caso i due filosofi parlano dell’illuminismo come “angoscia
mitica radicalizzata” (M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica
“Durante la prima guerra mondiale, Linton aveva fatto parte della
42° divisione, o “Divisione Arcobaleno”, nome arbitrariamente
scelto, perché la divisione raccoglieva unità provenienti da
numerosi stati e quindi i colori dei suoi reggimenti erano tanti
come i colori dell’arcobaleno (...). Cinque o sei mesi dopo si
affermava che si vedeva un arcobaleno ogni volta che la divisione
entrava in azione” (C. Levi-Strauss, Il totemismo..., pp. 13-14).
14
ACHAB
dell’illuminismo, p. 24) e delle sue tragiche conseguenze.
che accosta l’australiano...ma il procedimento...essenzialmente
non differisce” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 135).
“La ripetizione monotona di parole e di gesti sono altrettante
imitazioni organizzate di pratiche magiche, la mimesi della
mimesi. Il capo, dal viso lubrificato e col carisma dell’isteria a
comando, conduce la ridda (...). Il fascismo è totalitario anche in
ciò, che cerca di mettere la rivolta della natura oppressa contro il
dominio direttamente al servizio di quest’ultimo” (M.
Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 197).
In questo contesto, ci troviamo a fare una curiosa scoperta:
“Bergson è un filosofo che, per certi aspetti, pensa come un
selvaggio” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 139). Con sottile
ironia Levi-Strauss cita un passo di Durkheim, dal quale risulta
che il discorso sull’élan vital faceva già parte della cultura dei
Sioux, ben prima che il filosofo francese lo pronunciasse. In
questo senso il suo pensiero “era in simpatia con il pensiero delle
popolazioni totemiche” (C. Levi-Strauss, Il totemismo..., p. 138139).
Ragionando in termini rigorosamente antropologici, secondo
Radcliffe-Brown, abbiamo un’omologia di struttura fra il pensiero
umano e l’oggetto umano a cui si applica. Infatti ogni livello della
realtà sociale appare come un complemento indispensabile, senza
il quale sarebbe impossibile comprendere gli altri livelli. I
costumi rimandano alle credenze e queste alle tecniche, tuttavia:
Anche McLuhan riprende il discorso sull’angoscia come
fondamento di certi comportamenti dell’uomo contemporaneo.
Come un tempo gli uomini terrorizzati entravano spontaneamente
nelle pelli degli animali totemici, noi siamo arrivati ad assumere i
meccanismi di comportamento delle macchine che ci spaventano
e ci dominano.
“La tecnologia è un tiranno astratto che compie le sue
devastazioni sulla psiche a un livello più profondo di quanto non
facessero lo smilodonte e l’orso bruno” (M. McLuhan, La sposa
meccanica p. 73).
“I diversi livelli non si riflettono semplicemente gli uni sugli altri,
ma reagiscono dialetticamente fra loro, in modo che non si può
sperare di conoscerne uno solo, senza aver prima di tutto valutato,
nelle loro relazioni di opposizione e di correlazione rispettiva, le
istituzioni, le rappresentazioni e le situazioni” (C. Levi-Strauss Il
Totemismo..., p. 129).
Questi enunciati divergono da alcune delle conclusioni di C. LeviStrauss; il suo discorso sul totemismo infatti esclude la
dimensione del terrore.4 Egli aveva verificato che il pericolo non
chiama necessariamente il rituale con funzioni di rassicurazione
(C. Levi-Strauss, Il totemismo..., p. 97). Al contrario, in vari casi,
è proprio il rito a creare un senso di insicurezza e di pericolo
(Ibid). Questo modo di intendere diverge decisamente da quanto
affermato da McLuhan ne La sposa meccanica, ma sembra
convergere con quanto da lui scritto una decina di anni dopo.
In questa prospettiva, il totemismo “fa parte dell’intelletto e le
esigenze cui risponde, il modo in cui cerca di soddisfarle, sono
anzitutto di ordine intellettuale. In questo senso non c’è nulla di
arcaico, o di lontano” (C. Levi-Strauss, Il Totemismo..., p. 146).
Assistiamo ad un intreccio di codici diversi, compresenti nel
pensiero. In questo ambito “ciò che vogliamo salvare non sono i
primitivi in quanto tali, ma ciò di cui essi sono custodi. Essi
custodirebbero infatti le ‘verità ultime’ per mezzo delle quali e
nelle quali si è reso possibile ‘dissolvere l’uomo’” (U. Fabietti
Levi-Strauss moderno..., p. 19).
Questo complesso intreccio di strati dialetticamente connessi ci
invita a riflettere sul linguaggio dei nuovi media, che esprimono,
secondo McLuhan, una grammatica e una sintassi ancora
sconosciute. (Lamberti, McLuhan, p. 168-169). L’insieme dei
codici che caratterizzano il pensiero primitivo sembra infatti
richiamare quello dei codici multimediali, reperibili in teatro,
cinema e televisione. Anche a prescindere da McLuhan, vari testi
di mediologia mostrano attenzione alle analisi linguistiche degli
antropologi, in funzione della conoscenza del linguaggio
stratificato, che caratterizza il totemismo. Questo tema ha già una
sua bibliografia, ma potrebbe meritare ulteriori approfondimenti.5
“L’uomo moderno, a partire dalle scoperte elettromagnetiche di
oltre un secolo fa, sta riassumendo tutte le caratteristiche
dell’uomo arcaico e altre ancora.
L’arte e la scienza dell’ultimo secolo e oltre non sono state niente
di più che un monotono crescendo di primitivismo arcaico” (M.
MacLuhan, La galassia Gutenberg, p. 105).
Sappiamo del resto che “fra la logica del pensiero religioso e la
logica del pensiero scientifico non esiste un abisso (...). [La
religione] usa i meccanismi logici con una specie di goffaggine,
ma non ne ignora alcuno” (Durkheim, citato in: C. Levi-Strauss,
Il totemismo..., p. 136).
Levi-Strauss precisa che spiegare significa dimostrare come una
cosa partecipi di una o di molte altre.
“Certo i termini che noi uniamo in questo modo non sono quelli
15
ACHAB
Note
1. Siamo in quell’ambito di identificazione fra uomo e macchina che già era stato previsto anche dai formalisti russi:
“Mentre lui penzolava (da una forca), meschino, ripugnante, nei salottini le donne, fabbriche senza fumo e senza ciminiere, costruivano
baci a milioni, d' ogni genere, grandi, minuscoli, di tutte le misure, con leve carnose di labbra battenti.” ("Qualche cosa a proposito di
un direttore d' orchestra", v. 400-450)
Oltre a questa meccanizzazione della donna, potremmo ricordare l’animalizzazione della macchina in Ejzenstejn, per quanto riguarda
il palpitare del motore della corazzata Potemkin la notte prima della battaglia, ben reso dalla musica di E. Meisel, o per quanto riguarda
una sorta di orgasmo messo in atto da una scrematrice meccanica in La linea generale.
Per quanto riguarda una filmografia più recente, va citato: Jean Rouch, Dioniso e la pantera profumata, del 1980 dove si parla di
mettere in atto un ritorno ai principi dionisiaci in università, in fabbrica e nel bosco. Una Citroen 2CV maculata viene fatta a pezzi e
con i suoi elementi si costruiscono nuovi strumenti musicali (cfr. Canevacci Antropologia della comunicazione visuale, Meltemi, pp.
178-179).
2. Sulla macchina come prolungamento dell’essere umano v. P. Ortoleva, Il secolo dei media, p.120.
3. Cfr. Lamberti, McLuhan, p. 27.
4. Il suo lavoro empirico sui popoli primitivi dell’Amazzonia portò Levi-Strauss a verificare che la barbarie non era lì. Sfuggito al
genocidio in Europa, Levi-Strauss si trova ad essere testimone di un etnocidio in Brasile, le cui radici tuttavia non hanno nulla a che
vedere con l’irrompere del primitivismo barbarico all’interno del mondo civilizzato.
Egli parla dei primitivi che ha incontrato con profonda commozione, forse rivivendo in certa misura la propria storia, ad esempio
quando scrive: “mi sentivo già selvaggina per un campo di concentramento” (Tristi tropici, p. 21). A proposito dei Nambikwara egli
dice:
“Povera selvaggina presa al laccio della civiltà meccanizzata, indigeni della foresta amazzonica... devono febbrilmente saziare delle
vostre ombre il cannibalismo nostalgico di una storia dalla quale siete già stati sopraffatti” (Tristi tropici, p. 39).
“Il visitatore che per la prima volta si accampa nella boscaglia con gli indiani è preso dall’angoscia e dalla pietà di fronte allo spettacolo
di questa umanità così totalmente indifesa...nuda e rabbrividente davanti a fuochi vacillanti, (...) ma questa miseria è animata da
bisbigli e da risa (...). Si indovina in tutti un’immensa gentilezza, una profonda indifferenza, una ingenua e deliziosa soddisfazione
animale e, mettendo insieme tutti questi sentimenti diversi, qualcosa che somiglia all’espressione più commovente della tenerezza
umana”. (Tristi tropici, p. 278)
5. Fra i vari testi che cercano di coniugare antropologia e linguaggio dei media cfr. P. Ortoleva Mediastoria, e Il secolo dei media. V
anche G. Trimarchi, Lev Vygotskij, il «dramma vivente del pensiero» e le premesse della multimedialità.
16
ACHAB
Lévi-Strauss in classe
La top-ten dell’antropologia strutturalista
di Fabio Dei
Lévi-Strauss è considerato difficile dagli studenti. L’argomento
più difficile del manuale di storia dell’antropologia. Quando lo
chiedi agli esami si sparge il terrore, soprattutto fra i non
frequentanti. Si capisce che ne parlano nei corridoi: “Chiede LéviStrauss? Accidenti!”, e via a ripassare quelle pagine sottolineate
con tanti colori. Ho molti studenti non frequentanti, impegnati in
curricola di storia e beni culturali, più raramente di filosofia, che
all’esame devono “portare il Fabietti”, come dicono loro. Sono al
primo approccio con la disciplina (è il loro primo e ultimo esame
di M-DEA/01, qualche volta di soli 5 crediti); trovano difficoltà a
dominarne il linguaggio e soprattutto a seguirne la complessità
argomentativa. Sono abituati più a “storie di fatti” che non a
“storie di teorie”. Di solito sanno meglio la prima metà del libro,
peggio la seconda. Non sono mai riuscito a capire se gli autori e
gli argomenti della seconda parte sono davvero più difficili, o se
semplicemente dopo un po’ si stancano di studiare con la stessa
determinazione. Morgan, Mauss e Malinowski li sanno un po’
tutti. Lévi-Strauss e Geertz quasi nessuno. Io Lévi-Strauss ormai
lo chiedo solo quando l’esame comincia bene e la preparazione si
dimostra solida: è una specie di domanda-bonus che apre la
possibilità di un voto alto. Altrimenti mi imbatterei – lo so già –
in un muro di silenzi o, peggio, di larghi e inconcludenti giri di
parole che nascondono il nulla.
È giusto passare un esame di antropologia culturale non avendo
capito nulla di Lévi-Strauss? Non è come passare un esame di
letteratura italiana senza conoscere Leopardi, o uno di ingegneria
senza conoscere le leggi della statica? Può darsi. Certo, si può dire
che farsi un’idea di un autore così complesso in poche pagine di
manuale è praticamente impossibile. Quasi tutti conservano
qualche appiglio. Si ricordano la proibizione dell’incesto, ad
esempio, o i mitemi. Ma i singoli temi restano isolati, il senso
ultimo dell’approccio strutturale resta incompreso. Io me ne
stupisco sempre. Continuo a dare per scontato, ormai contro ogni
evidenza, che gli studenti di una Facoltà di Lettere e Filosofia
dovrebbero essersi imbattuti nello strutturalismo in chissà quante
altre occasioni: ad esempio nelle teorie della letteratura o del
cinema, nella linguistica, nella storiografia, eccetera. Invece no,
proprio no. Di solito non ne hanno mai sentito parlare (peraltro, in
ciò lo strutturalismo è in buona compagnia). Vorrei evitare le
tirate moralistiche su cosa è diventata oggi l’università, che bella
quella di un tempo eccetera. Non credo siano molto realistiche.
Però è vero che nelle Facoltà umanistiche il nuovo ordinamento
ha prodotto una tendenza alla parcellizzazione che sembra
abbastanza pericolosa. I grandi caposaldi del pensiero
contemporaneo - dal marxismo alla psicoanalisi, dallo
strutturalismo alla filosofia della scienza, da Wittgenstein a
Foucault - non sono affatto patrimonio minimo e irrinunciabile
in una Facoltà di Lettere e Filosofia. Anzi, sono esclusi dalla
maggior parte dei corsi di laurea, a favore di contenuti più tecnici
e specifici. E questo è un problema.
Insomma, Lévi-Strauss come bestia nera per gli studenti? Sì, ma
per fortuna gli usi didattici di Lévi-Strauss non riguardano solo i
non frequentanti e il manuale. C’è la didattica vera e propria, ci
sono le lezioni. Devo fare due premesse a questo proposito.
Prima: nei miei corsi non faccio la storia degli studi in modo
sistematico. Dovendo presentare l’antropologia culturale a
studenti che non l’hanno mai fatta prima, e in buona parte non la
faranno mai più, scelgo di trattarla attraverso corsi monografici di
ampio taglio, che presentino nessi forti con il corso di laurea in
cui il mio insegnamento si colloca (storia). Negli ultimi anni, ad
esempio, i temi sono stati la violenza, il dono, la memoria, la
dimensione quotidiana e il relativismo culturale. La storia degli
studi e gli autori classici sono presentati selettivamente in
relazione a questi fili conduttori.
Seconda premessa: mi ritengo, diciamo, un fedele geertziano, e
dovrei provare una certa avversione verso Lévi-Strauss. “The
cerebral savage” - la critica a Lévi-Strauss poi espunta
dall’edizione italiana di Interpretazione di culture - è uno dei
primi pezzi di Geertz che ho letto; e “Gli usi della diversità” è
stato a lungo il mio Vangelo multiculturalista. Il povero Claude
non ne esce bene. Di fronte alla sensibile fragilità delle ragnatele
di significato, i meccanismi tritatutto della sua analisi strutturale
sembrano goffi e ingombranti, un po’ ridicoli come gli enormi
calcolatori dei film di fantascienza degli anni ’60. E il suo
“sguardo da lontano” ci appare irrimediabilmente impigliato in
una concezione essenzialista della cultura, dalle ambigue
connotazioni etico-politiche.
Eppure, eppure…Nei corsi Lévi-Strauss riemerge sempre, in un
modo o nell’altro. Anche a non volere. Malgré Geertz. Non c’è
nulla di importante su cui quell’uomo non abbia scritto qualcosa
di importante. E di suggestivo. Di ampio respiro teorico, di
spiazzante, roba che apre nuove prospettive – buona da pensare,
come diceva lui. Se riusciamo per un attimo a dimenticarci quei
17
ACHAB
passi un po’ presuntuosi in cui vuol farci credere che
l’antropologia è una specie di cibernetica; se rimuoviamo la
frustrazione per non avercela fatta a leggere fino in fondo le
Mythologiques (via, diciamo la verità: chi non ha saltato un po’ di
pagine, qualche giaguaro e qualche pappagallo ara?); quello che
resta, allora, è un pensiero arioso, ricchissimo, di cui non finiamo
di nutrirci. Su tutto. Qualsiasi corso monografico uno possa
pensare, Lévi-Strauss viene fuori, si impone, c’è bisogno di
confrontarci con lui. Si potrebbe addirittura pensare di adottare le
Introduzioni a Lévi-Strauss esistenti sul nostro mercato librario
(come quella di Enrico Comba, Laterza 2000, o di Catherine
Clément, Meltemi 2004) come manuali generali di antropologia.
In questa occasione celebrativa vorrei divertirmi a compilare una
top ten dei temi lévistraussiani che emergono con più regolarità e
profondità nella didattica – nella mia, almeno. Rovesciamo per
una volta il rapporto fra antropologia e cultura popolare,
applicando alla prima un classico modulo pseudo-classificatorio
della seconda. Una classifica. Ognuno poi potrà continuare il
gioco proponendo la propria. Devo subito avvertire, a proposito di
classificazioni, che la mia predilezione va in modo sfacciato ai
temi del Pensiero selvaggio. La teoria della parentela mi annoia
di più, e la nostalgia per i perduti mondi amazzonici è passata così
a fondo nel senso comune che mi sembra oggi difficile
apprezzarne l’originaria forza. Alberto M. Cirese, negli anni 70,
classificava i suoi studenti in due categorie: quelli che avevano
letto prima Tristi tropici, e quelli che avevano letto prima Il
pensiero selvaggio. E’ come se da queste letture venissero degli
imprinting irreversibili, romantico e letterario il primo, scientifico
e razionalista il secondo. A me piacerebbe rimescolare le carte, e
scegliere un approccio letterario e razionalista al tempo stesso.
Ma, inequivocabilmente, ho letto prima Il pensiero selvaggio. Un
altro peccato di leso geertzismo.
Cominciamo, dunque. Al primo posto, d’obbligo:
cultura vittoriana, come ha scritto una volta Jesi, Lévi-Strauss
introduce la modernità negli incubi. Lo stesso pensiero è in
azione: ugualmente ricco, basato sulle medesime matrici
generative. La dicotomia bricoleur-ingegnere è stata naturalmente
criticata e riletta, ad esempio in termini di tecnologie
comunicative (oralità/scrittura, secondo la nota tesi di Goody e
Watt). Ma senza la logica del concreto non ci sarebbe stata la
cosiddetta “analisi culturale” di Mary Douglas, né il senso pratico
di Pierre Bourdieu. Di quest’ultimo si è detto che ha rimesso
Lévi-Strauss con i piedi in basso e la testa in alto, come Marx
aveva fatto con Hegel. Riprendendo il principio strutturale
secondo il quale occorre analizzare non le cose ma le loro
relazioni, Bourdieu l’avrebbe spostato da una dimensione
astrattamente intellettuale a quelle delle pratiche (e di
conseguenza del potere). Non sono sicuro che si possa proprio
dire così. Pensare Lévi-Strauss come idealista significa, mi pare,
fraintendere proprio il senso della logica del concreto – che
rappresenta, in definitiva, una grandiosa teoria della cultura
materiale.
2. I churinga e il sapore diacronico
Il rapporto tra storia e struttura è l’altro grande tema del Pensiero
selvaggio. Nella didattica è inevitabile tirarlo in ballo ogni volta
che si parla delle concezioni culturali del tempo, della memoria e
dunque di una interpretazione antropologica del concetto di storia
(e nel mio caso, di fronte a studenti di storia che sostengono un
unico esame di antropologia, mettere in discussione alcune delle
loro certezze epistemologiche mi sembra l’unica cosa sensata da
fare). L’immagine suggestiva dei churinga australiani, e il
provocatorio accostamento che Lévi-Strauss propone tra di essi e
i moderni archivi, sta al centro di tutto ciò. Si ricorderà che questi
oggetti sacri e inalienabili, che rappresentano i corpi degli
antenati, sono analizzati nel Pensiero selvaggio come dispositivi
che assimilano la diacronia, il trascorrere del tempo, all’interno di
un ordine meramente sincronico. Attraverso di essi, il passato
arriva ad esistere materialmente nel presente. Anche qui, come
per il bricoleur e l’ingegnere, si apre una possibile dicotomia ma
anche una possibile continuità. La dicotomia è quella fra società
fredde e calde. Le prime sono quelle che cercano di annullare gli
effetti rischiosi del divenire storico, non negandolo ma
ammettendolo come “forma senza contenuto” – nella dimensione
del mito e del pensiero classificatorio. Le seconde, quelle che
“hanno scelto di spiegarsi a se stesse attraverso la storia”, che
“interiorizzano risolutamente il divenire storico per farne il
motore del loro sviluppo” (p. 256). Si tratta di una tra le più
criticate espressioni di Lévi-Strauss, la cui intuizione tuttavia non
è stata mai veramente superata. Non esistono società del tutto
fredde e società del tutto calde, certo. L’ambiguità sta nella
tentazione di utilizzare questa concezione del rapporto fra
struttura e tempo per rileggere la filosofia progressista della
storia. Ma in definitiva, anche qui, l’obiettivo di Lévi-Strauss era
quello di costruire tessuto connettivo piuttosto che di riaffermare
troppo rigide dicotomie. Non voleva sostenere l’esistenza di
società senza storia o fuori dalla storia. La contrapposizione
1. Logica del concreto: il bricoleur e l’ingegnere
Il più classico tema lévistraussiano. Il pensiero che esercita la sua
inestinguibile forza ordinante non solo su simboli astratti ma
anche e soprattutto sulla materia in sé caotica dell’esperienza
sensibile è un tema sempre di grande fascino. Apre a nuovi modi
di guardare le cose, a un riorientamento gestaltico. D’un colpo, un
secolo di speculazioni sul pensiero selvaggio sono spazzate via –
anche se c’è in fondo una qualche continuità con le origini della
riflessione antropologica. Lévi-Strauss si accosta a Tylor e Frazer
non solo perché privilegia una dimensione intellettuale (lo fa,
diversamente dai primi, in una chiave epistemologica
radicalmente antiempirista), ma per il fatto di ipotizzare il
dominio di una forma di pensiero analogico che governa in
profondità la nostra cultura e la nostra vita; laddove il pensiero
“scientifico”, basato sulla trasparenza dei significati e sulle
procedure astrattive, non rappresenta che una superficie forse
inessenziale. Certo, il bricoleur è figura più rassicurante del
frazeriano “orrendo prete” di Nemi – entrambi emblemi
dell’umanità selvaggia che è ben presente appena sotto la
superficie della “civiltà”. Se Frazer introduceva incubi nella
18
ACHAB
serviva a far vedere meglio la strategia della concezione
classificatoria del passato, che è anche nostra. È qui che si colloca
lo splendido riferimento agli archivi. Si perderebbe qualcosa con
la distruzione di un archivio già interamente pubblicato? Sì, il
“sapore diacronico” incorporato nella sua materialità. Anche qui
troviamo una teoria della cultura materiale (altro che idealismo),
nonché l’intuizione di una dimensione simbolica e rituale che si
infiltra nell’intimo del sapere storico – anzi nel nucleo stesso della
sua oggettività, i giacimenti delle fonti.
comparativo. Lavorando non sulle cose in sé ma sulle loro
relazioni, si arriva a vedere la somiglianza laddove meno te lo
aspetti – cioè, la stessa logica generativa al lavoro non solo in
culture diverse, ma in ambiti apparentemente inconciliabili
dell’esperienza. Quella di Lévi-Strauss è una comparazione
particolare: non affianca casi per poi tentare di estrarne
induttivamente i punti comuni. Piuttosto, nel tentativo di
descrivere un meccanismo culturale, ne cerca le componenti in
diversi casi empirici - nessuno dei quali, da solo, potrebbe
esemplificare l’intero modello. Il lavoro sulla parentela e sul mito
è di questo tipo. Ma trovo che la performance più spettacolare,
affsscinante e di immediato impatto di questo uso del metodo
comparativo sia rappresentata dal breve saggio su “Babbo Natale
giustiziato”. Qui c’è tutto quello che serve per far capire a studenti
del primo anno che cos’è l’antropologia. La partenza da un fatto
banale, per quanto curioso, dell’esperienza quotidiana. Un
approccio estraniante, che fa scoprire inaspettate e misteriose
profondità nel tessuto del senso comune. Il “giro lungo”, che
passando da molto lontano ci aiuta a capire meglio certi aspetti
della nostra stessa vita che resterebbero altrimenti opachi e
scarsamente significativi. L’uccisione rituale di Babbo Natale di
fronte alla cattedrale di Digione, nel 1951, per reati di
paganizzazione, eresia ed allontanamento dallo spirito religioso
del Natale, è il punto di partenza per una densa discussione che si
interroga sul significato strutturale di questa sia pur moderna e
consumistica figura. Gli ingredienti del Natale – i bambini e i
nonni, i premi e le punizioni, i doni, la contrapposizione fra tempo
della festa e tempo ordinario, il consumo vistoso e così via – sono
mobilitati ad evocare una grandiosa teoria dello scambio, della
trasmissione tra generazioni, del rapporto tra la vita e la morte. La
comparazione con gli spiriti katchina degli Hopi gioca in ciò un
ruolo cruciale; morti che tornano dall’aldilà per portare minacce e
doni ai bambini, impersonati da nonni e genitori nascosti da
maschere. L’identità emerge in un contesto di radicale alterità:
l’accostamento etnografico fa risaltare la possibilità che il
rapporto tra vivi e morti stia al centro anche del nostro Natale, i
cui doni rappresenterebbero “un vero sacrificio alla dolcezza di
vivere, che consiste soprattutto nel non morire”.
3. La comune umanità si realizza in culture tradizionali
Se Il pensiero selvaggio è la celebrazione dell’Uno, del grande e
universale Linguaggio di Programmazione, un’altra componente
del pensiero lévistraussiano celebra la diversità irriducibile. È la
sua componente rousseauviana, quella che emerge in Tristi
tropici, certo, ma anche e soprattutto in quella linea di riflessione
che va da Razza e storia allo Sguardo da lontano. È il LéviStrauss innamorato delle culture amazzoniche, nostalgico della
loro perduta autenticità, impegnato in una lotta per la difesa,
diciamo, della biodiversità culturale, che lo vedrà alla fine
contrapporsi al troppo facile universalismo dell’Unesco. Il punto
di snodo di tutta questa tematica è quel passo cruciale di Razza e
storia in cui si afferma che la comune umanità si realizza
attraverso e non malgrado le differenze culturali; e che il
contributo delle culture alla civiltà consiste non tanto nella
somma delle acquisizioni di ciascuna, quanto negli scarti
differenziali che presentano fra loro. È questo il punto che non
viene colto dalla cultura illuministica dei diritti: “le grandi
dichiarazioni dei diritti dell’uomo hanno la forza e la debolezza di
enunciare un ideale troppo spesso dimentico del fatto che l’uomo
non realizza la propria natura in un’umanità astratta, ma in culture
tradizionali”. Molto forte. C’è dietro tutto questo una concezione
della soggettività umana come costituita dalle differenze – contro
la visione illuminista secondo la quale le differenze sono
incrostazioni superficiali e “ideologiche” che si innestano su un
nucleo astratto, universale, intercambiabile. È compatibile tutto
ciò con l’idea del Grande Linguaggio di Programmazione? Sì,
certo. Anzi, capire questa compatibilità vuol dire capire LéviStrauss, al di là delle facili etichette che sono state attribuite allo
strutturalismo come “universalismo senza soggetto”; e ben al di là
delle ingenerose accuse di “razzismo differenzialista” suscitate
dalle posizioni di Lo sguardo da lontano. Abbiamo un
razionalista, convinto assertore della universalità delle strutture
cognitive, che si misura però fino in fondo con i problemi del
relativismo etico. In fondo, la visione di una soggettività agente
nella quale le differenze giocano un ruolo costitutivo è ciò che
accomuna Lévi-Strauss e Geertz – e che ci fa leggere “Gli usi
della diversità” non solo come una critica, ma come l’accettazione
di una eredità (per quanto depurata da quella che oggi
chiameremmo una nozione essenzialista di cultura).
5. Efficacia simbolica
“La cura consiste nel rendere pensabile una situazione data
all’inizio in termini affettivi e nel rendere accettabili alla mente
dolori che il corpo si rifiuta di tollerare […] Lo sciamano fornisce
alla sua malata il linguaggio nel quale possono esprimersi
immediatamente stati non formulati ed altrimenti non
formulabili”. La celebre analisi dell’incantesimo cuna per il parto,
pubblicata in Antropologia strutturale, sta alla base di tutte le
successive eleborazioni antropologiche sull’efficacia simbolica –
e, per questo tramite, della moderna antropologia medica. Il
linguaggio e i simboli costruiscono un ordine che si impone sul
caos indifferenziato dell’esperienza di sofferenza, e pone le
premesse della guarigione, del ristabilimento dell’equilibrio.
Anche qui è un raffronto inatteso a produrre una affascinante
comprensione: quello con la psicoanalisi, una tecnica che affronta
4. I regali di Natale e gli spiriti katchina
Ciò che impressiona spesso in Lévi-Strauss, e che rende così
cruciali nella didattica molti suoi passaggi, è la vastità del respiro
19
ACHAB
i conflitti ponendoli “in un ordine e su un piano che permettono il
loro libero manifestarsi e conducono al loro scioglimento”. Lo
stesso Ernesto de Martino, che pure non amava molto LéviStrauss, aveva inserito queste pagine nell’antologia Magia e
civiltà, e le aveva certo usate nella sua rappresentazione del
meccanismo di crisi e reintegrazione della presenza. L’efficacia
dei complessi mitico-rituali, soprattutto nella declinazione che ne
viene data in La terra del rimorso, ha a che fare con questo. De
Martino aveva anzi colto ed evidenziato molto bene un aspetto
importante del testo di Lévi-Strauss: il ruolo del mito, che lo
studioso italiano esprimerà attraverso i concetti di metastoria e
destorificazione. La crisi, che è sempre storica, viene superata
evocando un orizzonte metastorico in cui tutto è già avvenuto ed
è stato risolto, il quale si impone e dà forma all’esperienza
immediata. Lévi-Struass, come sempre, non si accontenta e va
oltre. Nelle pagine conclusive del saggio si allude a un ancor più
profondo e ontologico radicamento dell’efficacia simbolica: una
reale “risonanza” basata sull’isomorfismo fra le strutture
ordinanti che agiscono rispettivamente al livello della psiche e del
corpo. “L’efficacia simbolica consisterebbe propriamente in
questa proprietà induttrice che possiederebbero, le une in rapporto
alle altre, strutture fondamentalmente omologhe, che si possono
edificare, con materiali diversi, ai diversi livelli della vita:
processo organico, psichismo inconscio, pensiero riflesso”. Qui lo
strutturalismo si avvicina a una metafisica; potrebbe sembrare
pura speculazione, se non fosse che il problema posto è
terribilmente concreto e reale.
lessico della disciplina la nozione di credenza, Schneider lo farà
per la parentela – altro concetto apparentemente neutrale che
nasconde in realtà insidiosi e svianti pregiudizi etnocentrici. Si
può discutere sui singoli casi, ma l’istanza critica fatta valere da
Il totemismo oggi resta un fondamentale richiamo metodologico –
la madre di tutte quelle che sarebbero poi state chiamate
“decostruzioni”.
6. La critica del totemismo
Torniamo al clima del Pensiero selvaggio per citarne un corollario
che tuttavia assume vita propria. Lévi-Strauss mostra in modo
eccezionalmente persuasivo come l’insieme di pratiche religiose
che l’antropologia classica aveva definito “totemismo” non abbia
una sua unità sostantiva, ma possa esser meglio compreso in
termini di articolazioni dei sistemi classificatori: quei sistemi che,
come abbiamo visto, cercano di ricomprendere la diacronia
nell’ambito della sincronia e si fondano sul presupposto
dell’omologia tra gli ordini che governano i diversi ambiti
dell’esperienza (il mondo naturale, il corpo individuale, la
parentela e le relazioni sociali). L’uscita di Il totemismo oggi, nel
1962, ha un grande impatto: la tradizione di studi sul totemismo,
profondamente
radicata
nell’Ottocento,
ne
risulta
improvvisamente distrutta. Non si tratta solo di una critica o una
riformulazione teorica. Di più. L’idea è che la categoria stessa di
totemismo abbia rappresentato un idolo, in senso baconiano: un
costrutto che, piuttosto che aiutare a capire la realtà empirica,
impediva di vederla, proiettando su di essa i pregiudizi del nostro
stesso sguardo. “Il totemismo è, innanzitutto, la proiezione al di
fuori del nostro universo, e come per esorcismo, di attegiamenti
mentali incompatibili con l’esigenza di una discontinuità tra
uomo e natura, che il pensiero cristiano considerava
fondamentale”. La forza di questa mossa va anche al di là del caso
specifico. Nell’antropologia successiva, qualcosa di simile sarà
applicato ad altri concetti. Needham proporrà di espungere dal
8. L’uomo nudo: mito e rito
Sono le pagine finali del volume finale della tetralogia. Non so se
sembrano così belle per il sollievo di essere arrivati alla fine di
una lettura tanto impegnativa e a tratti francamente pesante e
noiosa, con tutto quel rincorrersi di infinite varianti e di
accostamenti interpretativi non sempre facili da seguire. Fatto sta
che si esce dalla fitta e intricata giungla di giaguari e ara, miele e
tabacco, crudo e cotto, coccodrilli e snidatori d’uccelli, e ci
troviamo in una radura ariosa da cui ammirare un vasto orizzonte:
nientemeno che una teoria generale del rapporto tra mito e rito. “Il
vissuto, con la sua fluidità, tende perennemente a sfuggire
attraverso le maglie della rete che il pensiero mitico gli getta
sopra…Frazionando le varie operazioni e suddividendole in mille
particolari insancabilmente ripetuti, il rituale si sforza di
effettuare una minuziosa rabberciatura, cerca di chiudere gli
interstizi, alimentando così l’illusione che sia possibile risalire
alla rovescia il mito e ricostruire la continuità partendo dalla
discontinuità”. L’opposizione tra rito e mito è quella fra il vivere
e il pensare, afferma Lévi-Strauss. Il “disperato tentativo, sempre
destinato al fallimento, per ristabilire la continuità del vissuto
smantellato dallo schematismo che il pensiero mitico ha sostituito
a esso, costituisce l’essenza del rituale…”. Bellissimo.
7. Natura, cultura e il tabù dell’incesto
Si sarà capito che Le strutture elementari della parentela non è il
mio libro preferito. Ma sta lì il dispositivo di apertura
dell’antropologia strutturalista. Certo, si è costretti a illustrarlo in
classe semplificando un’argomentazione in sé molto tecnica; ma
la proibizione dell’incesto come universale architrave delle
distinzioni su cui si fondano gli ordini della parentela, e come
garante della separazione della cultura dalla natura, è un tema che
funziona sempre. E anche gli studenti non frequentanti
comprendono l’articolazione fra le strutture della parentela e la
logica dello scambio e della reciprocità. Semmai, c’è da dire che
la teoria della parentela è forse la più datata tra le acquisizioni
lèvistraussiane: o meglio, la parentela è il campo che si è
trasformato in modo più radicale, e chiede oggi di essere pensato
a partire da basi molto diverse. Lo stesso non si può dire del mito,
che dunque finisce per esser preferibile come terreno di
esplorazione della logica strutturale. A questo proposito, scegliere
un aspetto delle Mythologiques da inserire in classifica è molto
difficile. Pensando e ripensando, la mia scelta si indirizza verso:
9. Le pitture corporee caduvee
Concludo con due pagine da Tristi tropici, che ho finora
ingiustamente trascurato. La prima è quella sulle pitture corporee
20
ACHAB
e i tatuaggi fra i Caduvei. Importante perché vi si trovano i
fondamenti di un’antropologia dell’arte, in grado di collegare
un’analisi stilistica, una serie di ipotesi sulla funzionalità sociale
dell’espressione estetica e infine una comprensione del loro
profondo senso strutturale. Le pitture corporee sono prima di
tutto, dice Lévi-Strauss, un modo di caratterizzare l’ “umanità” e
distinguerla dalla natura; in secondo luogo, differenziandosi
secondo la casta, esprimono identità e relazioni sociali. Ma tutto
questo non basta. Anche qui, Lévi-Strauss ha bisogno di trovare
una omologia profonda tra le matrici generative di questa forma
di arte e quello che potremmo chiamare l’ethos della società
caduvea (anzi, del gruppo Mbaya cui i Caduvei appartengono).
Individua così una corrispondenza fra l’essenza dello stile
artistico, l’opposizione fra un principio di organizzazione
simmetrico e uno asimmetrico, e quella della struttura sociale,
fondata sulla sovrapposizione e contraddizione fra un principio
gerarchico e uno di reciprocità. La corrispondenza è non poco
forzata, ma basta per affermare che l’arte è un modo per esprimere
e rendere pensabile la contraddizione costitutiva del sistema
sociale. Non riuscendo a risolverla sul piano istituzionale, come i
loro vicini Bororo e Guana, i Caduvei hanno “sognato” un
rimedio. “Non in una forma diretta che avrebbe urtato contro i
loro pregiudizi; ma sotto una forma trasposta e in apparenza
inoffensiva: nella loro arte”. Analisi troppo forte, si dirà, in cui
mancano troppi passaggi. Il tritatutto strutturalista in azione. Sì,
certo, ma il terreno dell’analisi dell’estetica e del gusto come
fenomeni sociali è gettato. Tutto sommato, e per inciso, non siamo
poi tanto lontani dall’amico-nemico Clifford Geertz, e dall’analisi
della scultura Yoruba proposta in “L’arte come sistema culturale”.
Per nulla lontani.
cui tutte le culture aspirano: la possibilità di distaccarsi “nella
contemplazione di un minerale più bello di tutte le nostre opere;
nel profumo, più sapiente dei nostri libri, respirato nel cavo di un
giglio; o nella strizzatina d’occhio, carica di pazienza, di serenità
e di perdono reciproco che un’intesa volontaria permette a volte
di scambiare con un gatto”.
Fine del divertissment. Un modo per ripercorrere, tra il serio e il
giocoso, la prodigiosa ed a volte emozionante profondità del
pensiero del nostro autore. Si potrebbe naturalmente riflettere
sulle esclusioni. E si potrebbe divertirsi anche a compilare una
lista del “peggio” – i luoghi più datati e più infelici. Se dovessi
farlo, credo che partirei dalla citazione di Tylor posta in apertura
delle Strutture elementari della parentela: “Se ci sono delle leggi
da qualche parte, devono essercene dovunque”. E proseguirei con
una delle metafore più essenzialiste che siano mai state pensate
per esprimere il concetto di cultura, quella dei treni formulata in
Lo sguardo da lontano (“Le culture sono simili a treni che
circolano più o meno in fretta, ognuna sul suo binario e tutti in
direzioni diverse [...] Ogni membro di una cultura le è solidale,
tanto quanto quel viaggiatore ideale è solidale col suo treno [...]
Noi ci spostiamo trascinandoci dietro, letteralmente, questo
sistema di riferimento…). Una reificazione che sta alla base della
nota formula della “sordità agli altri valori” e dei suoi ambigui usi
etico-politici negli anni Ottanta. Forse aggiungerei l’Introduzione
all’opera di Marcel Mauss, un testo decisamente affascinante ma
nel quale Lévi-Strauss si lancia nelle sue più spericolate
previsioni verso una necessaria matematizzazione del sapere
antropologico, il quale, da regno del “completo arbitrio”,
dovrebbe diventare dominio del “ragionamento deduttivo”. Un
testo nel quale, ancora, Lévi-Strauss compie un passo che è
sembrato per decenni eroico e che ci appare invece oggi
singolarmente miope: la liquidazione dell’intuizione maussiana
sullo hau – lo spirito della cosa donata – come chiave dell’obbligo
a ricambiare i doni, e la sua sostituzione con il principio di
reciprocità. Mauss era stato ingannato da una teoria indigena,
diceva Lévi-Strauss: come si può far dipendere un grande
principio strutturale da una mera credenza locale? Ma la moderna
teoria del dono si fonda proprio sul recupero dello hau, visto
come emblema di un rapporto opaco e inestricabile fra persone e
cose – se vogliamo, della presenza di una agency nelle cose stesse
- che sfugge invece al trasparente ed elegante meccanismo
strutturale.
Ma basta. Ognuna di queste affermazioni andrebbe corredata da
bibliografie e note a pie’ di pagina, ed è quello che non voglio
fare. Adesso, come nella cultura popolare, ognuno può divertirsi a
compilare le proprie playlist. Come sarà la cartella “Lévi-Strauss”
sul vostro Ipod?
10. Il gatto di Tristi tropici
Infine, la conclusione del romanzo filosofico – questa volta assai
poco didattica, e anzi oscura e piena di un mistero mai del tutto
risolto, proprio come l’animale cui si fa riferimento. Al culmine
di una discussione del buddhismo, Lévi-Strauss filosofeggia sul
fatto che la civiltà umana consiste in un processo di dispersione di
energia che produce necessariamente effetti entropici, per cui
ogni passo fatto verso il progresso è un passo verso la distruzione.
Le culture – l’ “arcobaleno delle culture” – contribuiscono a
questa schiavitù entropica, ma contengono al loro interno anche il
principio opposto: la tendenza a fermarsi nella contemplazione, a
sospendere il cammino, a trattenere l’impulso ossessivo “a
chiudere una dopo l’altra le fessure aperte nel muro della
necessità”. È questa tendenza o desiderio che ci fa mantenere un
tenue legame con “l’inaccessibile”, cioè con quella parte del
mondo che già c’era prima dell’uomo e che continuerà ad esistere
dopo di lui. Ed è in definitiva questo il bene ultimo e universale
21
ACHAB
Lévi-Strauss erudita
Alcune note critiche sulla genealogia ed attualità del pensiero lévistraussiano
di Michele Parodi
un’osservazione empirica prolungata, contiene dei chiari elementi
polemici e di valore. Per Lévi-Strauss è la società occidentale ad
essere caratterizzata in termini di privazione:
Cercherò nelle seguenti note di ordinare con grande libertà alcune
critiche a Lévi-Strauss che sono venuto formulando durante le
mie ricerche di campo in Brasile tra il maggio 2006 e l’ottobre
2008. La lettura di un libro di Edmund Leach dedicato a LéviStrauss (Leach 1970) e la conoscenza di alcuni dettagli
dell’esperienza brasiliana dell’etnologo francese, hanno ispirato
le mie prime riflessioni sul pensiero lévistraussiano, parte anche
di una indagine personale sulle origini della mia vocazione
etnologica. Nel momento in cui un nuovo interesse per il folclore
(i saperi tradizionali, la cultura materiale, i patrimoni intangibili),
sponsorizzato dalle influenti politiche diffuse dall’UNESCO,
sembra affermarsi con una sorprendente naturalezza, senza che
tale ritorno (come un ritorno del rimosso) sia oggetto di un esteso
ed approfondito esame critico da parte di antropologi e scienziati
sociali1, evidenziare un certo tipo di genealogia del pensiero di
Lévi-Strauss, mostrarne le contiguità con lo stile enciclopedico
estetizzante degli studi folclorici più tradizionali, permette di
rilevare il percorso sotterraneo che l’ideologia folclorica ha
compiuto, sotto false spoglie, negli ultimi decenni.
“Le nostre relazioni con altri non sono più, se non in maniera occasionale
e frammentaria, fondate su un’esperienza così globale, su una
comprensione così concreta dei soggetti tra loro. […] Siamo collegati al
nostro passato, non più attraverso una tradizione orale che implica un
contatto vissuto con persone – novellieri, preti, saggi o antichi – ma per
tramite di libri immagazzinati in biblioteche […]. E sul piano del
presente, comunichiamo con la grande maggioranza dei nostri
contemporanei attraverso ogni sorta di intermediari – documenti scritti o
meccanismi amministrativi – che certo allargano immensamente i nostri
contatti, ma conferendo loro nello stesso tempo un carattere di
inautenticità” (id: 401, corsivo mio).
Certamente, continua Lévi-Strauss, “le società moderne non sono
integralmente inautentiche. […] possiamo anzi constatare che,
interessandosi sempre più dello studio delle società moderne,
l’antropologia si è applicata a riconoscere e isolare in esse livelli
di autenticità” (id: 402). Lévi-Strauss conclude trionfalmente il
paragrafo esaltando i futuri meriti dell’antropologia:
Il criterio dell’autenticità
Nell’ultimo capitolo di Anthropologie Structurale (Lévi-Strauss
1958b)2 appare la traccia del programma di una peculiare
etnologia della prossimità. La progressiva scomparsa reale e
concettuale dello specifico oggetto di studio dell’antropologia, le
società “primitive”, sottilmente ed ambiguamente enunciata da
Levi-Strauss già in Tristi Tropici (Levi-strauss 1955), induce
l’antropologo francese a spostare il suo sguardo di etnologo
rimpatriato dai luoghi esotici della sua iniziazione professionale
al proprio territorio di origine, trovando così una nuova missione
e un nuovo campo di ricerca: la rivelazione dell’autenticità
preservatasi nei complessi meandri della società moderna. È
significativo che il concetto di autenticità tanto caro ai folcloristi
si ripresenti nel testo della svolta strutturalista di Lévi-Strauss.
Nel paragrafo intitolato Il criterio dell’autenticità, l’autore,
ribaltando le tipiche definizioni negative con cui, ancora alla fine
degli anni ’50, erano individuate le società primitive – società
“non civili, senza scrittura” (Lévi-Strauss 1958a: 400) – ne
identifica le sostanziali caratteristiche positive: la raffinata
complessità di relazioni sociali “fondate su relazioni personali, su
rapporti concreti tra individui”, costruite “sul tipo delle relazioni
più dirette, di cui la parentela offre il solido modello” (id). Ciò che
interessa qui osservare, è il fatto che tale ribaltamento, più che
essere il frutto dell’approfondimento di un’analisi fondata su
“L’avvenire giudicherà probabilmente che il più importante contributo
dell’antropologia alle scienze sociali, sta nell’avere introdotto (d’altronde
inconsciamente) questa fondamentale distinzione fra due modalità di
esistenza sociale: un genere di vita percepito in origine come tradizionale
o arcaico, che è anzitutto quello delle società autentiche; e forme, di più
recente apparizione, da cui il primo tipo non è certo assente, ma in cui
gruppi imperfettamente e incompletamente autentici si trovano
organizzati in seno a un sistema più vasto, affetto a sua volta da
inautenticità” (id: 402-3).
Nostalgia di una unità perduta
La nostalgia di Lévi-Strauss per le società “autentiche” – per un
luogo fortemente desiderato e definitivamente perduto, ipotetico
stato di natura originariamente incontaminato, al medesimo
tempo, luogo epistemologico della scoperta e fantasma di desideri
più profondi e inconfessati – è continuamente presente anche in
Tristi tropici. Lo stile riflessivo di Tristi tropici percorre con una
vena angustiante tutto il testo dell’antropologo francese, tentativo
di svelare a se stesso e a noi qualcosa di oscuro. Tale progetto di
auto-indagine sarà però successivamente messo in secondo piano
dall’autore conquistato dal fascino estetico di altre logiche e altre
22
ACHAB
strutture. Un famoso brano di Tristi tropici rimane la sintesi
testuale più compiuta di questa nostalgia:
del rimosso, trovando nuove vesti con cui accedere al livello
dell’espressione. Si tratta di veri e propri sintomi, nella accezione
psicoanalitica del termine, arcaismi che al medesimo tempo
definiscono percorsi di ricerca, posizionamenti teorici,
suggestionano polemiche accademiche tra scuole e dipartimenti
rivali, senza che una riflessione antropologica effettiva ne sveli la
struttura più intima. Secondo Belmont la condanna degli studi del
folklore è avvenuta in Francia “senza processo” (Belmont 1986:
260)3. Mentre al livello internazionale più generale, a partire dalla
fine degli anni settanta, una vasta interrogazione autocritica ha
colpito l’antropologia, fino a mettere in discussione le
fondamenta stesse della disciplina, paradossalmente, la critica
“scientifica” agli studi folclorici, limitatasi in precedenza agli
aspetti teorici metodologici (il descrittivismo, l’assenza di rigore
e oggettività), in seguito, confinata la loro presenza ai margini
dell’accademia, non si è più rivolta all’indagine e allo svelamento
della loro dimensione ideologica più profonda. È questo “non
detto” (id) a consentire l’attuale riemergere dell’ideologia
folclorica in ricerche metodologicamente distanti dal
dilettantismo dei folcloristi del passato, come nel caso dello
strutturalismo o dell’etnosemiotica.4
“il visitatore che per la prima volta si accampa nella boscaglia con gli
indios è preso dall’angoscia e dalla pietà di fronte allo spettacolo di
questa umanità così totalmente indifesa; schiacciata, sembra, contro la
superficie di una terra ostile da qualche implacabile cataclisma, nuda e
rabbrividente accanto a fuochi vacillanti. Egli circola a tastoni fra la
sterpaglia, evitando di urtare una mano, un braccio, un torso di cui si
indovinano i caldi riflessi al chiarore dei fuochi. Ma questa miseria è
animata da bisbigli e da risa. Le coppie si stringono nella nostalgia di una
unità perduta; le carezze non si interrompono al passaggio dello straniero.
S’indovina in tutti una immensa gentilezza, una profonda indifferenza,
una ingenua e deliziosa soddisfazione animale, e mettendo insieme tutti
questi sentimenti diversi, qualche cosa che somiglia all’espressione più
commuovente della tenerezza umana” (Lévi-Strauss 1955: 316)
Affiora qui un desiderio erotico, dove la nostalgia di una mitica
unità perduta non è certo la nostalgia degli indigeni, ma la
proiezione su di essi della nostalgia dell’autore per una “ingenua
soddisfazione animale”.
L’atteggiamento polemico e nostalgico di Lévi-Strauss pur nella
sua inadeguatezza analitica e metodologica, manifesta
l’espressione di un malessere, di una sofferenza interiore che non
riesce ad incontrare forme efficaci di mobilitazione pratiche o
teoriche. È interessante notare come, ad un certo punto, LéviStrauss tenti legittimare le sue affermazioni citando Wiener, il
rappresentante della “più moderna delle scienze sociali – quella
della comunicazione”:
Estetismo enciclopedico
Ciò che accomuna Lévi-Strauss ai folcloristi è l’idea che l’oggetto
dei propri studi sia irrimediabilmente perduto, e che il proprio
impegno debba di conseguenza concentrarsi nella raccolta e
conservazione di ciò che va sparendo. Un misto di romanticismo
e di positivismo che anela alla conoscenza dell’altro, ma al
medesimo tempo lo irrigidisce nei suoi aspetti esteriori, così
piegandolo ai propri fini polemici ed ad uno sguardo estetizzante
che si limita a manipolarne gli aspetti formali in un puro gioco
combinatorio. Vi è in Lévi-Strauss un rifiuto radicale della
possibilità e della opportunità di condividere la vita dei propri
interlocutori di campo. Qui si percepisce l’eredità della tradizione
etnografica maussiana, caratterizzata dal sospetto nei confronto
dei discorsi nativi (dove opererebbero continuamente forme di
mascheramento e di omissione) e dominata dalla stima per la
sicurezza eloquente degli “oggetti autentici e autonomi” (cfr.
Mauss in Clifford 1988: 85). È a partire da queste premesse che
Griaule, seguendo un diverso percorso, non abdicando a
confrontarsi con le difficoltà del campo, svilupperà il suo
peculiare metodo “giudiziario”, “antagonistico” (id: 79, 94).
L’etnografia di Lévi-Strauss, portando agli ultimi esiti questa
logica, si riduce invece alla mera raccolta di reperti, di resti, di
rovine, di miti. Secondo Lévi-Strauss si è irrimediabilmente
troppo lontani o troppo vicini per poter afferrare le stranezze dei
selvaggi. Da qui l’ironia del famoso passo di tristi tropici citato da
Geertz (1988: 52-53): “Alla fine di un viaggio esaltante avevo
trovato i miei selvaggi. Ma ahimè, essi lo erano troppo […] erano
là pronti ad insegnarmi i loro costumi e le loro credenze e io non
conoscevo la loro lingua. Vicini a me […] potevo toccarli ma non
potevo comprenderli” (Lévi-Strauss 1955: 361-62). Questa
impossibilità, che Lévi-Strauss vuol qui far passare come
epistemologica (o episodica: la mancanza di tempo, “le limitate
“It’s no wonder that the larger communities […] contain far less available
information that the smaller communities, to say nothing of the human
elements of which all communities are built up” (Wiener in Lévi-Strauss
1958b: 401).
Lévi-Strauss sembra qui percepire il fenomeno proliferativo
entropico che caratterizza la cultura nelle società industriali, e
l’inflazione dei valori culturali che tale espansione induce (James
Clifford ironicamente lo definisce “rassegnato «entropologo»”;
Clifford 1988: 277), senza però comprendere come la missione
che intende proporre, sostenuta dal metodo analitico strutturalista,
si inscriva proprio in questo stesso processo, essendone anzi uno
dei supporti compensatori: riesumazione nostalgica e consolatoria
di un astratto paradiso perduto infinitamente manipolabile,
decontestualizzata da una seria analisi di ordine storico-politico.
Ritorno del rimosso
L’esame del testo di Lévi-Strauss mostra un funzionamento
discorsivo simile a quello della retorica folclorica, così
confermando la complicità sotterranea tra l’antropologia e gli
studi del folclore segnalata verso la metà degli anni ’80 da Nicole
Belmont (Belmont 1986). Permangono in Lévi-Strauss visioni
polemiche venate di nostalgia in cui i complessi inconsci presenti
nelle concezioni folcloriche riemergono in una specie di ritorno
23
ACHAB
correttamente e utilizzare il lavoro fatto da altri” (Lévi-Strauss
1988: 70, 72)
risorse”, “il deperimento fisico”; cit. in id, p. 361), dipende invece
essenzialmente dalle specifiche finalità conoscitive dell’autore
che lo hanno spinto a vagare per mesi nell’amazzonia piuttosto
che a stabilirsi permanentemente in un villaggio indigeno, guidato
da “un melange di estetismo […] e di enciclopedismo illuminista”
(Geertz 1988: 39). A Lévi-Strauss in verità non interessava
comprendere i significati della vita indigena, ma, con sguardo di
esteta, mettere a sistema la diversità delle manifestazioni materiali
che si davano alla sua vista: tatuaggi, ornamenti, rappresentazioni
grafiche, oggetti rituali, relazioni di parentela, miti e loro varianti.
È questo tipo di attività che ha caratterizzato anche le ricerche
folcloriche, nella fase in cui, verso la fine dell’ottocento e i primi
del novecento, tentarono di darsi una parvenza di scientificità. La
linguistica strutturalista darà a Lévi-Strauss gli strumenti con cui
nobilitare questa attività dandone una veste più filosofica.
L’atteggiamento di Lévi-Strauss, come quello dei folcloristi, è
simile ai fenomeni di fissazione su un “monumento” della vita
passata che caratterizzano certi tipi di nevrosi, dove le
manifestazioni isteriche possono arrivare fino a negare la realtà e
il presente (cfr. Freud 1909: 135-36; cit. in Belmont 1986: 265).
Lévi-Strauss erudita
Quanto detto finora corrisponde alla tesi presentata da Edmund
Leach nel primo capitolo del suo libro dedicato a Lévi-Strauss
(Leach 1970), dove include l’antropologo francese nella
genealogia degli antropologi eruditi, famiglia a cui assegna come
prototipo Frazer e alla quale contrappone la genealogia degli
antropologi che fanno della ricerca di campo intensiva il
momento cruciale della loro professione, primo fra tutti, secondo
Leach, il padre dell’“osservazione partecipante” Bronislaw
Malinowski. In effetti tutta l’esperienza etnografica di LéviStrauss si può ridurre ad alcuni mesi trascorsi tra gli indios
Caduvei e Bororo (tra il 1935 e il 1936, alla fine del primo anno
accademico all’università di São Paulo dove era professore
visitante) e tra gli indios Nambikwara (giugno-dicembre 1938;
cfr. Faria 2001; Domingues, Monte-Mór, Sorá, 1998). Se i frutti
della prima missione etnografica nel Mato Grosso si
concretizzarono nella raccolta di una importante collezione di
artefatti etnografici per conto del futuro Musée de l’Homme, la
seconda missione tra i Nambikwara, nel cui territorio LéviStrauss trascorse circa quattro mesi, fu spesa per la gran parte in
spostamenti. Come riconosce Lévi-Strauss, intervistato
dall’antropologo e fotografo brasiliano Marcelo Fiorini
Lévi-Strauss archeologo
Per Lévi-Strauss il lavoro etnografico consiste nel viaggio
(nonostante il famoso incipit di Tristi tropici dica il contrario:
“Odio i viaggi e gli esploratori; Lévi-Strauss 1955: 19) e nella
raccolta dei “reperti” incontrati lungo il percorso (Geertz
provocatoriamente considera Tristi tropici il risultato della
mescolanza di più generi di testi: un libro di viaggi, una etnografia
polemica, un testo filosofico, addirittura, una guida turistica;
Geertz 1988: 40-50). Lévi-Strauss più che ad un etnografo può
allora essere paragonato ad un archeologo, ad una specie di
“flâneur antropologico” (Clifford 1988: 274) o ad un collezionista
(non ad un viaggiatore “puro” i cui vagabondaggi comportano
sempre anche la possibilità di un non ritorno e da qui
probabilmente l’incipit sopra citato)5. Questa ipotesi è
confermata, dall’idea che egli ha sempre avuto del destino
dell’antropologia. Nel 1988 intervistato dal giornalista francese
Didier Eribon affermava: “[L’antropologia] cambierà la sua
natura. Se l’indagine sul campo non avrà più oggetti, ci
trasformeremo in filologi, storici delle idee, specialisti di civiltà
avvicinabili solamente attraverso i documenti che antichi
osservatori hanno raccolto” (Lévi-Strauss 1988: 202). In realtà
questa trasformazione per Lévi-Strauss è avvenuta precocemente,
alla conclusione della sua esperienza brasiliana nel 1939. In
seguito, scrollatosi di dosso l’impiccio di ogni residuo etnografico
potrà “dedicarsi al tema che – come afferma Geertz – gli è
veramente proprio: il gioco formale dell’intelletto umano”
(Geertz 1988: 37). Non è di conseguenza un caso che la ricerca di
campo tra i Nambikwara, la più prolungata della sua carriera, non
occupi un ruolo di rilievo nella sua produzione teorica. In effetti è
lo stesso Lévi-Strauss a riconoscerlo: “io mi sentii ben presto
uomo da biblioteca piuttosto che uomo da campo. […][Ho
lavorato sul campo] abbastanza per imparare e capire che cos’è
questo lavoro, condizione indispensabile per giudicare
“[i Nabikwara] non parlavano il portoghese, salvo alcuni di essi che
conoscevano una decina di parole. Io stesso non sapevo parlare
Nabikwara, con competenza, e, pertanto, noi costruimmo insieme un tipo
di gergo comune, formato per metà di parole portoghesi e per metà di
parole Nabikwara, il che ci permetteva un minimo di comunicazione.
Evidentemente con ciò non si poteva andare molto lontano” (LéviStrauss in Fiorini 2007: 11).
Leach osserva:
“É perfettamente vero che un antropologo sperimentato, visitando per la
prima volta una “nuova” società primitiva e lavorando con l’aiuto di
interpreti competenti, sarà capace, dopo una permanenza di alcuni giorni,
di sviluppare nella sua mente un “modello” ragionevolmente esauriente
di come funziona il sistema sociale; ma è anche vero che, se permanesse
lì sei mesi e apprendesse a parlare la lingua locale, molto poco resterebbe
di quel “modello” iniziale. Significativamente, il compito di
comprendere come il sistema funziona sembrerà ancora più formidabile
di quanto non lo fosse stato nei primi giorni successivi al suo arrivo.
Lévi-Strauss non ebbe mai l’opportunità di soffrire questa esperienza
demoralizzante […]. [Egli] come Frazer, è insufficientemente critico, in
riferimento al corpo basico di informazioni su cui lavora. […] Qualsiasi
prova, per molto dubbia che sia, è accettabile – dal momento che si
aggiusti ad aspettative logicamente calcolate” (Leach 1970: 20).
Dopo le prime iniziazioni etnografiche in Brasile, Lévi-Strauss
non compirà più alcuna significativa ricerca di campo
dedicandosi interamente allo studio minuzioso dei testi
24
ACHAB
etnografici raccolti da altri antropologi, sulla cui base elaborerà le
sue opere teoriche più famose.
numerose le spedizioni folcloriche nei dintorni di São Paulo a cui
Lévi-Strauss partecipò insieme a de Andrade: “qualcuno ci
informava dello svolgimento di una festa di mori e cristiani o di
Bumba-meu-boi e noi ci andavamo” (Sandroni 1993: 239).
Viceversa fu lo stesso de Andrade, per tramite del “Dipartimento
di Cultura” del municipio di São Paulo, da lui diretto dal 1935 al
1938, a finanziare parzialmente le missioni etnografiche di LéviStrauss nell’interno del Brasile (id: 238). L’elogio della diversità
assumeva per de Andrade un significato emancipatorio, rivelando
la singolarità brasiliana, per Lévi-Strauss un significato etico:
elogio, come dirà nei primi anni ’50, della varietà in sé “in un
mondo minacciato dalla monotonia” (Lévi-Strauss 1952: 407).
Di qui l’irrilevanza di una permanenza prolungata sul campo e la
preferenza per missioni itineranti di breve durata dove
collezionare un vasto e diversificato numero di artefatti
etnografici7. Entrambi erano posseduti da una vera e propria
voracità antropofaga di “oggetti culturali”8: un “cannibalismo
nostalgico” (Lévi-Strauss 1955: 48) di “turisti apprendisti” (nel
1927 de Andrade iniziò a scrivere per il giornale O Diario
Nacional una sorta di quaderno di viaggio poetico e critico
intitolato O Turista Aprendiz) su cui fondare, secondo de
Andrade, la incerta identità nazionale brasiliana, per Lévi-Strauss,
un istintivo gusto per il bricolage e i giochi combinatori consentiti
da un insieme di oggetti, o di stili, sciolti dalle proprie relazioni
sociali. Per entrambi, alle origini di questo comune sentire, vi era
il surrealismo e il simbolismo francese (nel caso di Andrade anche
il futurismo italiano), ma il senso di spaesamento che nei
surrealisti più militanti diventava elemento di trasgressione e di
fiduciosa adesione alla dinamica imprevedibile del reale, era
vissuto in loro in modo più angoscioso, contrastato da un turbato
e contraddittorio bisogno di identità e di confini. Così per
entrambi, ad un certo punto, la dissociazione della cultura e
l’attacco sovversivo surrealista si sciolgono in operazioni di
rielaborazione e sistemazione estetica di frammenti culturali che
la legittimazione scientifica e l’azione ordinatrice delle istituzioni
consentono di accumulare.
Non per caso l’universalismo differenzialista e nazionalista
dell’UNESCO all’inizio del nuovo millennio ha ritrovato in LéviStrauss un interlocutore ideale (cfr. Stoczkowski 2008), mentre il
famoso Anteprojeto di de Andrade (Andrade 1936) – il “Piano
preliminare per la creazione del servizio del patrimonio artistico
nazionale” – da lui elaborato nel 1936 su sollecitazione dell’allora
ministro dell’educazione Gustavo Capanema e accantonato
durante la dittatura di Vargas (1937-1940), è diventato in seguito
una delle principali fonti di ispirazione delle politiche del
patrimonio brasiliane (da Silva 2002).9
Sia Lévi-Strauss che de Andrade, seppur con sfumature diverse,
amano le identità ben definite. Il nazionalismo per de Andrade era
l’unica maniera di universalizzarsi: “Poiché un popolo solo si
universalizza nel momento in cui concorre con il suo contingente
particolare e inconfondibile ad arricchire questa cosa sublime,
uniforme ma multipla che è l’umanità” (Andrade 1924-1936:
150). Citazione che ricorda un famoso brano di Razza e storia
(testo commissionato a Lévi-Strauss dall’UNESCO): “il
Lévi-Strauss e il Brasile
La retorica testuale di Lévi-Strauss, il suo eruditismo e il suo
moralismo (Geertz, nell’articolo già citato, parla di Tristi tropici
anche come di un “trattatello riformista”; Geertz 1988: 46), hanno
la loro origine nella storia personale dell’etnologo francese (ad
esempio nel fatto che il padre fosse un pittore di ritratti rovinato
dall’avvento della fotografia…), nella sua condizione di classe
(borghesia intellettuale in declino), e nella sua specifica traiettoria
accademica (è lo stesso Lévi-Strauss a dichiarare il carattere
autodidatta dei suoi primi studi antropologici; cfr. Fiorini 2007:
11). La lunga intervista rilasciata da Lévi-Strauss a Didier Eribon
nel 1988 è da questo punto di vista illuminante (Lévi-Strauss
1988).
Ci sembra però che la permanenza in Brasile di Lévi-Strauss
abbia assunto un’importanza speciale nel definire la sua
vocazione e la sua traiettoria intellettuale. In particolare nel
definire il suo estetismo etnografico e il suo eruditismo polemico.
È nota l’influenza di Lévi-Strauss e dello strutturalismo sullo
sviluppo dell’antropologia e delle scienze sociali in Brasile (vedi
ad esempio i primi lavori di Roberto da Matta; da Matta 1973 e
1976). Forse meno nota l’influenza del modernismo brasiliano e
delle ricerche folcloriche di questo paese sul suo pensiero. Con la
moglie Dina, durante la sua permanenza in Brasile come
professore visitante, partecipò nel 1936 alla fondazione della
Sociedade de Etnografia e Folclore (FUNARTE, INF 1983: 70),
organizzata da Mario de Andrade – romanziere, poeta, etnografo,
musicologo, tra i fondatori con Oswald de Andrade nel 1928 del
modernismo antropofago brasiliano. Dina, segretaria della rivista
della Sociedade (id: 10, 72), pubblicherà a puntate sul Boletim le
Istruções práticas para pesquisas de Antropologia Física e
Cultural (Lévi-Strauss D. 1936), una specie di Notes and Queries
aggiornato, inspirato dalle esigenze enciclopediche dei lavori di
Frazer e Mauss.6
È qui importante segnalare l’affinità profonda che univa LéviStrauss e Mario de Andrade, accomunati da medesimi studi
umanistici e filosofici, figure poliedriche in cui la scrittura
etnografica e la letteratura si incrociano spesso.
Negli anni del loro incontro si trovarono uniti nella comune
missione per la salvaguardia di un patrimonio di cui temevano la
rapida estinzione: la cultura delle “ultime” popolazioni indigene e
le tradizioni folcloriche del popolo brasileiro, culture localizzate
nel Brasil profundo, sopravvissute alla rapida avanzata della
frontiera brasiliana. Da qui l’urgenza per entrambi di dislocarsi
nei territori “selvaggi”, dove ancora era possibile incontrare
questo Brasile. Si trattava per de Andrade di riscoprire l’inconscio
della nazione, mentre nella visione universalizzante dell’etnologo
francese di rivelare l’inconscio dell’uomo stesso.
Si può forse ipotizzare che il progetto universalista di LéviStrauss sia nato proprio a partire dall’incontro con de Andrade e
il Brasile, dalla mediazione del disegno nazionalista di de
Andrade per tramite della tradizione illuminista francese. Furono
25
ACHAB
contributo delle culture non consiste nell’elenco delle loro
invenzioni particolari, ma nello scarto differenziale che esse
presentano fra di loro” (Lévi-Strauss 1952: 403).
Possiamo così vedere come nazionalismo e relativismo culturale
in Lévi-Strauss e de Andrade (per de Andrade l’identità brasiliana
è sostanzialmente meticcia) si siano influenzati reciprocamente,
diventando le due facce di una stessa medaglia (come nei
paradossi del razzismo culturalista). Entrambi ossessionati dal
confine (Clifford Geertz giunge fino ad accusare Lévi-Strauss di
etnocentrismo; Geertz 1986: 546-547), mossi da un polemico
impulso interventista più sensoriale che politico (id. 1988: 47),
hanno finito per inscrivere parte della loro militanza nelle
istituzioni degli Stati e delle organizzazioni internazionali,
lasciando in esse le tracce del loro pensiero.
asimmetrie di potere e le dinamiche economiche globali che sono
alla base della riduzione a simulacri della diversità delle culture.
Lo sguardo da lontano di Lévi-Strauss che rifiuta di interagire con
i suoi oggetti (interlocutori con cui non vuole interloquire)
limitandosi a contemplarli con nostalgia, finisce per sostenere una
visione depoliticizzata della cultura e della ricerca etnografica,
contribuendo al più generale arretramento della sfera pubblica e
della critica.
Nello strutturalismo levistraussiano la ricchezza della ricerca
etnografica si confonde con la moltiplicazione dei suoi oggetti in
detrimento di una interrogazione più radicale, sostituita da
“un’arte della descrizione che impone la sua propria finalità”
(Jeudy 2005: 34).
L’etnografia, al contrario è il luogo dell’incontro, il luogo di un
apprendimento sensibile e relazionale che si avvera sul piano
etico della pluralità. Luogo dove nella dialettica tra generale e
particolare l’oggetto e i limiti del campo sono decisi nella pratica
(cfr. Bourdieu 1992: 185)
Tale esperienza in Lévi-Strauss risulta impoverita, poiché
sistematicamente scissa dall’impianto teorico. Ed è proprio questa
separazione a definire l’antipolitica del suo metodo. Le culture
sono apprese nella rigidezza dei dati raccolti dall’etnografo e
delle analisi strutturali compiute dall’antropologo, non nella loro
realtà fluida e dinamica.
L’ideologia folclorica, depurata dei suoi residui moralistici (la
critica tradizionalista del presente), aggrappandosi ai vettori
forniti dal contesto competitivo del tardo capitalismo, e da
paradigmi teorici sincronici come lo strutturalismo, si riattiva in
forme nuove purificate dalle passate interdizioni. Si afferma
un’arte seduttiva, come denuncia Henri-Perre Jeudy parlando
degli studi dell’etnologia della Francia, dove le ricerche
etnologiche, abbandonato qualsiasi proposito teorico, si riducono
alla missione di rianimare le identità e le memorie collettive
“mostrando ciò che non si mostra” (come nel caso
dell’esposizione organizzata delle memorie operaie; cit. in Jeudy
2005: 34-35)11. Non vi sono allora più problemi da investigare, ma
solo patrimoni da rivelare.
Conclusioni provvisorie
In queste note sintetiche ho cercato di mettere in luce i punti di
contatto sintomatici tra l’opera di Lévi-Strauss e i tratti
caratteristici degli indirizzi più tradizionali degli studi folclorici:
1) attrazione nostalgica e polemica per le antichità (i “selvaggi” o
i “primitivi” nel caso di Lévi-Strauss); 2) dilettantismo erudito e
autodidatta; 3) contatto diretto, anche se temporaneo e di breve
durata, con gli oggetti di studio; 4) fascinazione per gli artefatti
(compresi le testimonianze orali, i miti, i proverbi) e disinteresse
per i problemi e i processi sociali; 5) organizzazione sistematica e
formale dei materiali empirici; 6) ossessione per i confini e le
classificazioni; 7) più o meno velato campanilismo (regionalismo,
nazionalismo patriottico o etnocentrismo).10
Il gusto estetizzante, quasi antiquario, che ha caratterizzato la
traiettoria complessiva di Lévi-Strauss, ci sembra essere il
medesimo che oggi guida le politiche di selezione e salvaguardia
dei monumenti nazionali (materiali o intangibili, “eruditi” o
“popolari” che siano), così come la messa in ordine delle diversità
culturali organizzate dall’UNESCO nella lista dei patrimoni
dell’umanità. Si tratta di forme discorsive che occultando in
opposizioni distintive e giustapposizioni spettacolari l’artificiosità
convenzionale di queste operazioni, allo stesso tempo
dissimulano, naturalizzandoli, i meccanismi reali di dominio, le
Note
1. Il seminario La costruzione del patrimonio culturale – discussioni critiche tra antropologia e altri territori, organizzato dalla
“Fondazione Basso” e dalla “Società Italiana per la museografia e i beni Demo Etno Antropologici” (simbdea) nel marzo-maggio 2007,
e la pubblicazione di alcuni volumi sulle politiche e le poetiche patrimoniali (Palumbo 2003; Pizza 2004; vedi anche l’“Annuario di
Antropologia” dedicato al patrimonio culturale curato da Irene Maffi nel 2006) segnalano l’emergere tra gli antropologi italiani di una
prospettiva di analisi dei processi di patrimonializzazione più problematizzante e critica. In Francia e nel Nord America un simile
dibattito è iniziato già verso la fine degli anni ottanta (vedi ad esempio i lavori di Lowenthal 1985 e 1997, Handler 1988, Jeudy 1990,
Choy 1992, Poulot 1993). La presenza di questi lavori è però relativamente marginale, almeno in Italia, rispetto al proliferare di
pubblicazioni e ricerche documentarie descrittive. L’elenco di iniziative, conferenze, seminari, master e scuole di specializzazione
inscrivibili in un ottica “applicativa” avente come finalità l’inventario, la protezione o la rivitalizzazione dei patrimoni, è praticamente
infinito. Si verifica qui una convergenza tra gli interessi di certi gruppi accademici (come i settori del design culturale, della
comunicazione, della moda, delle belle arti e del restauro) e le istanze di valorizzazione identitaria organizzate o sponsorizzate dagli
enti locali e condotte da un numero crescente di associazioni ed istituzioni museali (si veda per fare solo un esempio il convegno,
26
ACHAB
Patrimonio culturale immateriale, tradizione locale e rete globale, organizzato dalla Regione Lombardia nel maggio 2008 a Milano;
locandina dell’evento disponibile in internet: http://www.agranelli.net/DIR_rassegna/convegno_LombBBCC_08.pdf; ultimo accesso 3
maggio 2009).
2. Cap. XVII: Place de l’Anthropologie dans les sciences sociales et problèmes posés par son ensegnement (testo già pubblicato nel
1954 nel volume edito dall’UNESCO, Les Sciences sociailes dans l’enseignement supérieur).
3. Le traduzioni italiane di testi citati in bibliografia in lingua originale sono dell’autore.
4. Da questo punto di vista il caso italiano e l’egemonia che gli studi demo-antropologici hanno conservato nel campo delle scienze
antropologiche del nostro paese fino alla fine degli anni settanta, presenta delle specificità rilevanti. In Italia l’influsso del pensiero di
Gramsci ha consentito un precoce rinnovamento teorico e metodologico degli studi folclorici e ha permesso una precoce, anche se non
sempre efficace, critica del folclore e delle analisi folcloriche (v. ad esempio i lavori di Cirese, de Martino e Lombardi-Satriani). Alla
fine della militanza politica degli anni settanta, è seguita, però, una fase di ristagno delle ricerche sul folclore, a partire dalla quale gli
studi folclorici sono potuti riemergere gradualmente in una forma pura, filtrata dalle precedenti finalità politico-ideologiche,
elaborando “conoscenze essenzialmente rivolte al passato” (Bravo, Tucci 2006: 12). In Brasile si è verificato un fenomeno simile in
cui la fase di latenza ha coinciso con il primo decennio della dittatura militare (1964-1985).
5. In un passo di Tristi tropici, Lévi-Strauss si riconosce “viaggiatore, archeologo dello spazio, che invano tenta di ricostruire
l’esotismo con l’aiuto di frammenti e rottami” (Lévi-Strauss 1955: 50). Una delle tante confessioni contenute nel libro e
successivamente rimosse, come se la confessione delle proprie contraddizioni avesse reso Lévi-Strauss più agile e leggero nel
convivere con le proprie ossessioni. Ugo Fabietti, in una recente lezione seminariale, osserva come guardando la traiettoria
complessiva dei lavori di Lévi-Strauss si resti colpiti dall’affiorare, scomparire e riapparire di alcuni nuclei di idee ricorrenti, come se
nel suo pensiero lavorassero delle forme fisse che non si sviluppano in modo irreversibile, ma si ripresentano ciclicamente in forme
solo leggermente variate (Fabietti 2008).
6. Un questionario speciale fu organizzato dalla Sociedade al fine di realizzare una “carta geografica” di alcuni costumi popolari nello
Stato di São Paulo, carta che, su invito di Dina Lévi-Strauss, fu presentata al Congresso Internazionale del Folclore di Parigi nel giugno
1937. Il tema specifico del congresso riguardava la cartografia folclorica (promossa in Francia da Van Gennep; cfr. Cocchiara 1952:
521) e la promozione dell’accesso degli studi folclorici al campo delle scienze antropologiche (FUNARTE, INF 1983: 11, 73-75).
7. Come noto durante le spedizioni del 1935-1936 Lévi-Strauss collezionò un grande numero di oggetti. Il successo della mostra che
egli e la moglie Dina organizzarono sulla base di questi materiali, permise a Lévi-Strauss di ottenere i fondi per la spedizione del 1938
(Lévi-Strauss 1988: 37-38; 1955: 265). Nei “viaggi etnografici” del 1927 e del 1928-1929, e nella famosa missione folclorica nel Nord
del Brasile del 1938, Mário de Andrade raccolse invece una importante collezione di registrazioni musicali, di fotografie e immagini
filmate delle tradizioni popolari brasiliane (cfr. Nogueira 2005).
8. In una lettera a Luís da Câmara Cascudo (fondatore a Natal nel 1941 della “Fundação da Sociedade Brasileira de Folclore”), nel
settembre 1924, de Andrade scrive: “Ho una fame per il Nord, che non immagina. Mi mandi alcune fotografie della sua terra. Vi sono
opere di arte coloniale? Immagini di legno, chiese interessanti? Conosce i loro autori? Ha delle fotografie? Mi creda: tutto ciò mi
interessa più della vita. Non abbia paura di inviarmi un ritratto di una casa abbandonata che sia. O di un fiume, o di un albero comune.
Sono le delizie della mia vita queste fotografie di pezzi familiari del Brasile. Non è per sentimentalismo. Ma so sorprendere le cose
comuni della mia terra. E la mia terra è ancora il Brasile” (Andrade 1991: 34).
9. L’Anteprojeto di de Andrade includeva, già a quell’epoca, tra i patrimoni degni di protezione, l’arte archeologica e amerindia, il
folclore e l’arte popolare (cfr. Andrade 1936), anticipando di più di trent’anni le politiche di protezione dei beni culturali dell’UNESCO
sancite per la prima volta dalla “Convenzione sulla Protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” di Parigi nel 1972.
10. Giulio Angioni, agli inizi degli anni settanta, formulava così le caratteristiche del “quadro clinico” della demologia italiana di
stampo romantico-positivista: “propensione alla genericità astratta o sentimentale”, “gusto del pittoresco”, “vagheggiamento idillico”,
“difesa campanilistica dei buoni villici delle proprie regioni” (Angioni 1971: 183). Secondo Angioni la mancata attenzione critica ai
dislivelli socio-economici e culturali conduceva le ricostruzioni storico-diacroniche a “una sterile ricerca del «fossile culturale» in via
di sparizione, da raccogliere in un museo o da ripristinare più o meno contraffatto in qualcuna delle numerose manifestazioni turisticodopo-lavoristiche (per le quali è sempre facile trovare finanziamenti da parte di burocrati […][e] mecenati provinciali appassionati di
storia locale)” (id: 185), privando al medesimo tempo le ricerche sociologico-sincroniche di oggetti significativi cui dedicarsi.
Concludeva dichiarando l’abitudine dei demologi italiani “a ricercare esclusivamente oggetti («monumenti» dell’arte popolare) e
prodotti «letterari» orali, e non comportamenti e concezioni” (id).
11. Si osserva qui una strana sinergia dove la freddezza delle analisi strutturali può accoppiarsi con gli approcci che puntano a
valorizzare il punto di vista nativo, rinforzando processi antagonistici di estetizzazione e frammentazione identitaria. Si tratta di una
questione complessa e delicata che non abbiamo qui la possibilità di approfondire. Ci sia consentito lasciare questo cenno sperando di
poter in futuro verificare e chiarire la nostra posizione.
27
ACHAB
Bibliografia
Andrade M. de, 1991, Cartas de Mário de Andrade a Luís da Câmara Cascudo, Villa Rica, Belo Horizonte/Rio de Janeiro.
– 1936, Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, “Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, n. 30,
pp. 270-287.
– 1924-1936, Cartas de Mário de Andrade a Prudente de Moraes Neto 1924-1936, a cura di Georgina Koifman, Nova Fronteira, Rio de Janeiro,
1985
Angioni G., 1971, Alcuni aspetti della ricerca demologica in Italia nell’ultimo decennio, in Cirese (a cura di) 1972, pp. 169-195.
Bravo G. L., Tucci R., 2006, I beni culturali demoetnoantropologici, Carocci, Roma.
Borofsky R., 1994, L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma, 2000.
Bourdieu P., 1992, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
Choay F., 1992, L’allégorie du patrimoine, Seuil, Parigi.
Clifford J., 1988, I frutti impuri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Boringhieri, Torino, 1999.
Cirese A. M. (a cura di), 1972, Folklore e antropologia tra storicismo e marxismo, Palumbo, Palermo.
Cocchiara G., 1952, Storia del folklore in Europa, Boringhieri, Torino, 1971.
Da Matta R., 1976, Um mundo dividido: estrutura social dos índios Apinayé, Vozes, Petrópolis.
– 1973, Ensaios de Antropologia Estrutural, Vozes, Petrópolis.
Domingues H. M. B., Monte-Mór P., Sorá G., 1998 (nov.), Retrato brasileiro dos ‘tristes trópicos’. Registro inédito da expedição liderada por
Lévi-Strauss é revelado por Castro Faria, “Ciência Hoje”, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vol. 24, n. 144.
Fabietti U., 2008, Lévi-Strauss moderno, ultramoderno, antimoderno, Lezione del Seminario permanente di ricerca del gruppo di antropologia,
Dottorato di Ricerca di Antropologia della Contemporaneità, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 17 aprile 2008.
Faria L. de Castro, 2001, Um outro olhar: diário de expedição à Serra do Norte, Ouro Sobre Azul, Rio de Janeiro.
Fiorini M., 2007, Paixão pelo Brasil: entrevista inédita com Claude Lévi-Strauss (intervista del nov. 2005), “Cult”, n. 110, Editora Bregantini, pp.
40-43.
Freud S., 1909, Cinque conferenze sulla psicoanalisi, in id. Opere, v. 6, pp. 125-173, Boringhieri, Torino, 1989
FUNARTE, INF, 1983, Mário de Andrade e a Sociedade de Etnografia e Folclore no Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de
São Paulo, 1936-1939, Rio de Janeiro, São Paulo.
Geertz C., 1988, Opere e vite : l’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna, 1990
– 1986, Gli usi della diversità, in Borofsky 1994.
Handler R., 1988, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison, University of Wisconsin Press.
Jeudy H.-P., 2005, Espelho das cidades [traduzione portoghese dei testi francesi: La machinarie patrimoniale (2001) e Critique de l’estetique
urbaine (2003)], Casa da Palavra, Rio de Janeiro.
– (a cura di), 1990, Patrimoines en folie [conferenze del seminario «Patrimoines» tenutosi nel 1987-1988 al Collège international de philosophie],
collezione “etnologia della Francia”, Cahier 5, Ed. de la Maison des sciences de l’homme, Parigi.
Lévi-Strauss C., 1973, Antropologia strutturale due, Il saggiatore, Milano, 1978.
– 1958a, Antropologia strutturale, Mondadori, Milano, 1992.
– 1958b, Anthropologie structurale, Plon.
– 1955, Tristi tropici, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1988.
– 1952, Razza e storia, in id. 1973, pp. 366-421.
Lévi-Strauss C. (in collaborazione con D. Eribon), 1988, Da vicino e da lontano. Discutendo con Claude Lévi-Strauss, Rizzoli, Milano, 1988.
Lévi-Strauss D., 1936, Istruções práticas para pesquisas de Antropologia Física e Cultural, in FUNARTE-INF 1983, pp. 23-56.
Lowenthal D., 1997, The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
– 1985, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge.
Maffi I. (a cura di), 2006, Il patrimonio culturale, “Annuario di Antropologia”, anno 6, n. 7, Roma, Meltemi.
Nogueira A. G. R., 2005, Por um inventários dos sentidos. Mário de Andrade e a concepção de patrimônio e inventário, Hucitec-Fapesp, São
Paulo.
Palumbo B., 2003, L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi.
Pizza G., 2004, Tarantism and the Politics of Tradition in Contemporary Salento, in Pine F., Kaneff D., Haukanes H. (a cura di), Memory, politics
and religion. The past meets the present in Europe, Lit Verlag, Münster (Halle studies in the anthropology of Eurasia 4), pp. 199-223.
Poulot D., 1993, Le sens du patrimoine: hier et aujourd’hui (note critique), “Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, Vol. 48, N. 6, pp. 16011613.
Sandroni C., 2002, Mário, Oneyda, Dina e Claude, [con un intervista a Lévi-Strauss del 9 febbraio 1993], “Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional”, n. 30, pp. 232-245.
Silva F. F. da, 2002, Mário e o Patrimônio, um anteprojeto ainda atual, “Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, n. 30, pp. 128137.
Stoczkowski W., 2008, Claude lévi-Strauss and UNESCO, “The UNESCO Courier”, n. 5, UNESCO.
28
ACHAB
Suole di vento
Jean Rouch fra antropologia e cinema
di Alessandro Jedlowski
"Un regista deve avere le suole di vento, andare altrove,
e riportare indietro, per gli altri, pezzi di tappeto volante" (Jean Rouch)
Jean Rouch, è forse un caso ma ha il suo valore metaforico,
all’inizio della sua carriera di mestiere faceva il costruttore di
ponti. Si era formato come tale nella Parigi degli anni trenta, e
come tale era partito per l’Africa la prima volta, durante la
seconda guerra mondiale. Nel 1954, dopo una serie di episodi che
cambiarono profondamente la sua vita, divenne il quinto dottore
in etnologia della storia della Francia, ma ciò solo dopo aver vinto
nel 1949 un premio al Festival du film maudit di Biarritz, luogo di
consacrazione del nuovo cinema francese.
Come antropologo, egli ha scritto. Ma come cineasta ha
soprattutto filmato. Facendo incontrare queste due vocazioni egli
è riuscito a stimolare da un lato quella rivoluzione che la Nouvelle
Vague ha determinato nel cinema e, dall’altro, a fornire
all’antropologia un nuovo strumento e delle nuove tecniche
capaci di trasformarne in certi casi l’efficacia. L’uso dei
documenti filmati per la costruzione del resoconto etnografico,
ma soprattutto la pratica del feed-back hanno offerto agli etnografi
molti spunti di riflessione.
“Cinema e scienza continuano e continueranno sempre a dividersi
lo stesso schermo, a condividere la stessa avventura, nella quale
lo spirito dell’uomo brucia come una fiamma ardente” (Rouch,
1986: 10). Rouch ha vissuto la sua vita al confine fra scienza ed
arte, senza mai voler far prevalere l’una sull’altra. C’è sempre
qualcosa di poetico nei suoi documentari, così come qualcosa di
profondamente scientifico abita i suoi film di finzione. Il suo
metodo, legato ad una attenta e prolungata pratica
dell’improvvisazione, non è tuttavia anarchico. E’ un metodo
forse irripetibile, poiché esplicitamente fondato su doti e
caratteristiche prettamente personali, ma è un metodo che si lega
intimamente alla realtà e ad una sua espressione sincera e
veritiera.
In questo testo, dunque, considerando proprio il valore innovativo
dell’opera di Rouch e l’interesse specifico che essa ha suscitato
nell’ambito della ricerca antropologica, proporrò un’analisi della
metodologia grazie alla quale tale opera è stata realizzata e delle
riflessioni teoriche che da esse possono scaturire. In Rouch ogni
intuizione pratica ha una stretta rispondenza teorica, l’uso di un
particolare tipo di obbiettivo, piuttosto che di determinate
attrezzature corrisponde intuitivamente ad un prolungamento
della sua personale teoria antropologica. Per questa ragione non
risulta facile dissociare un discorso tecnico sulla presa del suono
o sull’utilizzazione di un cavalletto da uno teorico sulla
condivisione dei risultati della ricerca o sulla presenza
dell’antropologo sul terreno. Per esigenze di chiarezza ho dovuto,
tuttavia, operare ugualmente questa divisione fittizia cercando di
costituire al tempo stesso una rete di rimandi che permetta di
mantenere visibile l’integrità del pensiero di questo autore.
Il ruolo del suono nei film di Rouch
Può sembrare paradossale iniziare l’analisi dell’opera di un
cineasta da quell’unico aspetto che non riguarda il piano
dell’immagine. Il sonoro appare facilmente come un elemento
naturale, dovuto, implicito all’esistenza di un film. Può apparire
come subordinato al valore dell’immagine. Al contrario, come
Rouch sottolinea in diverse occasioni, esso è un elemento
fondamentale, che spesso ha guidato e guida l’elaborazione di un
film, specie dei film documentari. Inoltre si tratta dell’aspetto
filmico che più ha beneficiato delle innovazioni tecniche legate
all’industria cinematografica. L’invenzione della presa sonora in
sincrono, e di conseguenza la possibilità di registrare il sonoro in
presa diretta, ha trasformato il cinema più di molte altre
invenzioni che hanno riguardato la presa di immagini. Il sonoro
dei primi film di Rouch, all’incirca fino alla fine degli anni 60’ è
registrato in studio e successivamente sincronizzato, in sede di
montaggio, con le immagini.
Il cinema italiano, con Rossellini, è forse il primo a porsi il
problema delle riprese in esterno. L’arrivo di nuove telecamere
più piccole e maneggevoli permette ai cineasti di andare in strada,
ma per il momento impedisce di far recitare agli attori
direttamente il copione: le telecamere fanno ancora un rumore
insopportabile, che coprirebbe qualsiasi tentativo di registrazione
del sonoro. Si ricorre allora al doppiaggio ed all’elaborazione di
effetti sonori che riproducano i suoni della realtà.
Il sonoro nei primi film di finzione. Il caso di Moi, un noir
Rouch gira Jaguar2 e Moi, un noir3 in queste condizioni. Si tratta
dei suoi primi due film di finzione. Essi però sono girati con
tecniche prese in prestito dal film documentario. Si tratta dunque
di film basati sull’improvvisazione, privi di sceneggiatura scritta
e immersi nella realtà e nella contingenza delle esperienze
quotidiane di attori non professionisti. Per la sonorizzazione di
questi due film Rouch ha un’intuizione fondamentale, che vede la
29
ACHAB
sua riuscita migliore in Moi, un noir, grazie al talento
sorprendente di Oumarou Ganda, attore principale ed
improvvisatore del sonoro. Gli attori vengono convocati in sala di
registrazione a film già montato e sono invitati dal regista, che gli
offre un canovaccio da seguire, ad improvvisare il sonoro,
mescolando accenni di dialoghi compiuti al momento delle
riprese a reazioni dovute alla visione del film, e ancora a
riflessioni generali sulla loro vita, sul loro passato come sul loro
futuro. Lo spettatore impara a conoscere gli attori, vede “dove essi
vivono, ciò che mangiano, il loro lavoro e ciò che essi fanno del
proprio tempo libero. Ma ciò che è più significativo, li ascolta
parlare di queste cose con le loro proprie parole, e queste parole
non parlano soltanto di ciò che essi sono o del loro modo di
vivere, ma anche di ciò che essi amerebbero essere, del modo in
cui vorrebbero vivere, soggetti a malapena sfiorati dagli scritti
antropologici di quell’epoca” (Piault; 1996: 144). L’innovazione
introdotta da Rouch permette per la prima volta di ascoltare la
voce stessa degli africani commentare le immagini che li
riguardano ed il sonoro diventa così il primo campo entro il quale
Rouch riesce a proporre la possibilità concreta di un’antropologia
“condivisa”.
“Gli attori occasionali di Moi, un noir non conoscono formule,
non conoscono le tecniche, per mettersi al di fuori di sé, o dentro
sé stessi, in un luogo nel quale mantenere uno scarto fra il
personaggio, oggetto mostrato per la riuscita del gioco, e l’attore,
soggetto nascosto dal proprio ruolo. Essi recitano il ruolo di sé
stessi, il che non implica la necessità di questo scarto. Ma in realtà
il dispositivo adottato da Rouch li confronta molto direttamente
agli effetti ed alle emozioni provocate dalla vista della propria
immagine sullo schermo. Credendo di lavorare alla postsincronizzazione del film, essi hanno in verità lavorato attraverso
un effetto particolare, il feed-back. Il cinema non aveva ancora
utilizzato un simile effetto, ed è tanto interessante quanto più per
il fatto che Rouch ha cercato di preservarlo, gesto moderno per
eccellenza del suo cinema” (Scheihfeigel; 1995: 113).
Con l’avvento delle innovazioni tecniche nel campo della
sonorizzazione Rouch ha adottato nei suoi film di finzione la
registrazione del suono in sincrono, mettendo da parte, purtroppo,
la sua originale soluzione. Con l’avvento di queste nuove
tecnologie il suono si è trasformato, il suo peso nell’economia del
film e nella fase del montaggio è aumentato. Rouch sottolinea
come con l’avvento della sincronizzazione, i registi così come i
montatori usino innanzitutto il sonoro come elemento di raccordo
fra le immagini, e su di esso si concentrino nel momento in cui
sono sul terreno. “Quando giravo con la mia “Bell and Howell”
facevo il montaggio mentre riprendevo (bisognava infatti staccare
ogni venticinque secondi per ricaricare la bobina, nda), mentre
oggi, con il suono sincrono, il cinema è diventato terribilmente
chiacchierone: non si sa più tagliare, inquadrare, si ascolta
soltanto parlare”4. Il fascino dei primi film di Rouch, invece, è
quello dei film muti, nei quali il gesto, l’immagine, il movimento
pittorico delle immagini hanno un ruolo centrale. Film muti che
trovano a loro modo un sonoro che, come si vedrà a breve, pur
ampliando il rapporto delle immagini con la realtà, è in grado di
stabilire con essa una relazione di natura poetica.
I documentari antropologici e la peculiarità del commento
Nei documentari antropologici di Rouch il commento è un
elemento fondamentale. Se nei film di finzione la parola
dell’altro, la voce degli africani, protagonisti delle vicende
narrate, ha avuto uno spazio ed una libertà d’espressione ampi e
inattesi, al contrario nei documentari Rouch si è sempre riservato
il ruolo di unica voce narrante. Anche quando negli anni settanta
l’innovazione tecnica apportata dall’introduzione dei sottotitoli
avrebbe permesso di lasciare libera espressione alla voce dei
protagonisti, il commento, la voce sottile e poetica dell’autore
hanno mantenuto il loro ruolo, lasciando emergere il suono
originale solo in brevi e sporadiche occasioni.
Questa ostinazione è costata al Rouch della seconda stagione
creativa, quella fra gli anni 70’ e gli anni 90’, non poche critiche.
Come Colette Piault sottolinea, “dal momento in cui c’era la
possibilità di lasciare all’altro la libertà di esprimersi e tradurre le
sue parole nei sottotitoli, parlare al suo posto è divenuto un
«abuso di potere», presto assimilato ad un’attitudine paternalista,
o peggio neocolonialista” (1996: 146). Di fronte a coloro che gli
ponevano questo problema Rouch ha sempre risposto in modo
piuttosto evasivo, sostenendo che l’uso dei sottotitoli toglieva
spazio all’immagine, distoglieva l’attenzione dalla globalità del
film, e inoltre non poteva che risultare, in termini di contenuto,
riduttivo rispetto alla complessità delle parole pronunciate nelle
lingue locali. Il commento, invece, poteva raggiungere, grazie alla
forza di una parola più volte spinta ai limiti dell’atto poetico,
livelli di chiarezza e di profondità narrativa insperati. “Mettendo
solo dei sottotitoli, non si tradurrà che una parte del messaggio –
le parole – lasciando da parte tutta la varietà del linguaggio
gestuale, allorché con il commento fatto da me, provo a integrare
in un solo linguaggio la parola ed il gesto per trasmettere la
totalità del senso”5.
Al di là delle risposte più o meno esplicite di Rouch
sull’argomento, a mio avviso, una spiegazione a questo suo
attaccamento al commento come parte integrante del suo modo di
fare documentari può essere data a partire dall’analisi della
funzione che tali commenti hanno nell’economia complessiva del
film.
Rouch commenta i propri film in modi assai differenti, a seconda
dei casi. A volte il commento è stringatissimo, accenna a
malapena alla presentazione di ciò che sta avvenendo lasciando
l’attenzione libera di concentrarsi integralmente sulle immagini.
E’ il caso ad esempio di Mamy Water 6, splendido e brevissimo
film sulla cerimonia funebre per la morte di un’anziana
sacerdotessa in Ghana, nella quale la bellezza delle immagini che
ritraggono il corteo funebre lungo la spiaggia non hanno bisogno
d’altro che di qualche parola a proprio supporto.
In altri casi invece il commento è onnipresente, ben studiato,
improntato ad una narrativa di alto livello poetico. Nei suoi
commenti, in effetti, Rouch si è sempre ispirato all’esempio, da
lui ben conosciuto, della narrazione orale dei griot. In tal modo
egli tentava di proporre uno stile narrativo che, almeno nelle
30
ACHAB
intenzioni, avrebbe dovuto ricalcare quello che uno dei
personaggi del documentario avrebbe forse naturalmente
adottato.
Il caso de La chasse au lion à l’arc7 è un esempio chiaro di questo
genere di commento. Girato nell’arco di sette anni, questo film
ripercorre, come si trattasse di un’epopea, le gesta di un gruppo di
cacciatori dell’ansa del Niger, impegnati nella caccia di un
pericoloso leone che da tempo minaccia le loro mandrie. Il tono
della narrazione è tutt’altro che scientifico e non mira certo a dare
una spiegazione di ciò che sta avvenendo sullo schermo (la storia
ad esempio si ambienta nella “brousse qui est plus loin que loin,
le pays de nulle part”). L’obiettivo sembra piuttosto quello di
coinvolgere lo spettatore in un ambientazione mitico poetica
molto più vicina a quella che un esperto griot avrebbe creato per
un uditorio attonito.
In molti hanno criticato tale attitudine di Rouch, sostenendo che
nel vedere i suoi documentari si ha l’impressione che siano le
immagini a fare da supporto al commento piuttosto che l’inverso,
o che ad ogni modo tali commenti nella maggior parte dei casi
non aiutino lo spettatore a capire ciò che succede davanti a lui (è
ad esempio la critica che più spesso è stata fatta relativamente al
commento di Le maître fous), ma piuttosto lo confondano
facendolo assalire da una serie di dubbi sulla natura del fenomeno
che ha visto manifestarsi sullo schermo.
A mio avviso il punto centrale della questione risiede, e lo si vedrà
meglio nell’ultima parte di questo testo, in quello che per Rouch
è un punto centrale: l’indeterminazione del confine fra realtà e
finzione. Se il commento di Rouch non spiega non si può dire che
non sia chiaro, e con altrettanta certezza non si può dire che lasci
lo spettatore nella solitudine del suo dubbio. Piuttosto, ciò che
Rouch cerca di fare è di immergere lo spettatore nella
comprensione dei fatti per via poetica più che razionale, per
intuizione più che per deduzione. Se secondo una critica di LeviStrauss a Rouch tale atteggiamento è pericoloso poiché
“l’approccio poetico e quello scientifico non possono convivere
in uno stesso film” (Grisolia; 1988: 11), per Rouch il problema
non si pone poiché “la poesia, in senso stretto, è già scienza”
(Rouch; 1981: 42).
Il metodo di lavoro che Rouch utilizza è semplice ed immediato
quanto la relazione che lui si propone di stabilire con le persone
verso le quali dirige l’obbiettivo della propria telecamera.
L’antropologo deve essere anche regista ed operatore. La squadra
di lavoro dev’essere ridotta al minimo, poiché “due bianchi in un
villaggio africano formano già una comunità, un corpo estraneo
più solido e dunque maggiormente sottoposto a rischi di rigetto
(Rouch; 1988c: 57). L’unico bianco è l’antropologo, dunque,
accompagnato da un tecnico del suono formato in loco. “Il fonico
deve assolutamente capire la lingua della gente che si registra: è
indispensabile quindi che appartenga all’etnia filmata e che riceva
in aggiunta un’accurata formazione tecnica” (1988c: 57).
Per le riprese la telecamera deve restare libera, priva di cavalletto
e pronta ad improvvisare, fra le mani dell’operatore, una danza
che le permetta di inserirsi anonimamente nell’azione ed
avvicinarsi così con libertà ai protagonisti. “Per me la sola
maniera di filmare è di camminare con la macchina da presa, di
condurla là dove è più efficace e di improvvisare con lei un
particolare tipo di balletto, nel quale la macchina diventa viva
come le persone che filma […] Allora, invece di usare lo zoom,
l’operatore cineasta penetra realmente nel suo soggetto, precede o
segue il danzatore, il prete o l’artigiano, non è più sé stesso ma un
«occhio meccanico» accompagnato da un «orecchio elettronico».
E’ la bizzarra trasformazione della persona del cineasta che ho
chiamato, per analogia con i fenomeni di possessione, la cinetranse” (Rouch; 1988c: 59).
Con ciò che Rouch chiama la cine-transe l’antropologo-cineasta
diventa parte del fenomeno che osserva. La telecamera, che come
tutti gli strumenti di registrazione utilizzati durante la ricerca (la
macchina fotografica, il registratore, ma anche il taccuino e la
penna) è di solito vista come un elemento estraneo, aggressivo ed
intrusivo, diventa, in quest’ottica, un tramite, un potenziale
elemento per la costruzione di un contatto reale ed approfondito.
“A partire dal momento in cui si gira con degli obbiettivi
grandangolari si è molto vicini alle persone che si filma e, se si è
il proprio operatore, c’è qualcosa che può accadere: l’aggressione
diventa uno stimolo alla relazione” (Rouch citato in Prédal; 1996:
13). L’antropologo grazie alla telecamera si espone, si posiziona
al centro dell’azione ed al tempo stesso provoca una reazione. “La
cosa straordinaria è che si è compromessi in prima persona in
un’avventura del genere. Abbiamo inventato, con Blanchet e
Beauviala, una parola per parlare delle macchine da presa di cui
disponiamo ora: diciamo che sono delle camere da contatto.
Effettivamente, la macchina da presa non è assolutamente, o
piuttosto sempre di meno, un ostacolo fra due persone; anzi,
utilizzata in un certo modo diviene uno strumento, uno
stimolatore di contatto. Quando si sa che ci si mette in scena,
durante la ripresa, nel momento in cui si interviene apertamente in
ciò che succede si è coinvolti personalmente” (Rouch; 1988b: 47).
La telecamera “vissuta” secondo questi principi, utilizzata con
spontaneità e sincerità si apre ad una aperta accettazione o ad un
aperto rifiuto da parte di coloro che rientrano nel suo campo
visivo. “Quando si è alla normale distanza di comunicazione, tutti
i problemi di «voyerismo» scompaiono, perché l’altro, a
La telecamera di contatto e la cine transe
Fra le mani di Rouch la telecamera diviene un essere vivente,
protagonista attivo delle dinamiche che determinano lo sviluppo
delle relazioni umane su un terreno di ricerca. Ispirato dalle gesta
dei suoi “padri”, Flaherty e Vertov su tutti, Rouch fa partecipare
la telecamera all’azione, ne fa uno strumento di contatto fra sé
stesso e colui che gli si trova di fronte. “Se Flaherty e Nanook
riescono a raccontare la difficile storia della lotta di un uomo
contro la natura prodiga di doni e sofferenze, questo è possibile
perché c’è fra loro un terzo personaggio. Una piccola macchina
capricciosa ma fedele, con una memoria visiva infallibile, che
mostra a Nonook le sue stesse immagini man mano che vengono
impresse sulla pellicola, la macchina da presa che Luc de Heush
ha magnificamente chiamato « la camera partecipante »” (Rouch;
1988c: 52).
31
ACHAB
cinquanta centimetri da chi filma, non è obbligato a farsi filmare.
Può mandarlo al diavolo con un solo gesto. Ha questo diritto. Chi
filma lo sa. E lo sa chi è filmato. Molto stranamente, chi sarebbe
infastidito a dieci metri, quando è molto vicino all’operatore, se
accetta, accetta completamente. Si produce allora una sorta di
capovolgimento della situazione. Sono gli altri che fanno il film,
e non chi filma” (Rouch; 1988b: 47).
poter cominciare, tutti si erano avvicinati in cerchio intorno al
proiettore, credendo che tutto sarebbe successo intorno a quella
strana macchina. Ma non appena le immagini cominciarono ad
essere proiettate sul lenzuolo bianco, tutto fu chiaro. In breve le
persone cominciarono a riconoscersi, alcuni piangevano perché
rivedevano delle persone che nel frattempo erano morte, altri
gioivano a vedere le loro gesta coraggiose durante la caccia. Il
film dovette essere riproiettato sei o sette volte, e alla fine chiesi
cosa ne pensavano. Ed allora, per la prima volta ricevetti delle
critiche: mi dissero ad esempio che l’ippopotamo non si vedeva
abbastanza […] poi mi rimproverarono perché avevo messo della
musica sulle immagini della caccia, che invece deve svolgersi in
assoluto silenzio: con quella musica l’ippopotamo avrebbe
avvertito la presenza dei cacciatori e sarebbe scappato. Da quel
momento un vero e proprio scambio è nato fra di noi, le cose si
sono evolute. Uno di loro mi ha proposto di fare un vero e proprio
film, un film di finzione, e così abbiamo girato Jaguar e uno dei
cacciatori, Damouré Zika, è diventato un ottimo attore ed uno dei
miei migliori collaboratori” (Rouch; 1996: 72-73).
Senza aggiungere inutili commenti a quanto già Rouch rende
esplicito con le proprie parole, è sufficiente notare che il feedback in quest’ottica diventa il principio in base al quale fondare
una nuova antropologia, un’antropologia polifonica e dialogica, o
meglio, per usare i termini dello stesso Rouch, “un’antropologia
condivisa”. L’osservatore perde la sua abituale centralità
gerarchica, mostrando il proprio sguardo si espone a quello di
coloro che ha osservato. “Con il feed-back gli «osservati» hanno
due rivelazioni fondamentali, da una parte la rivelazione della
propria immagine, che è già uno choc straordinario, ma dall’altra
parte, e soprattutto, essi hanno la rivelazione di che cos’è
l’osservatore” (Rouch; 1988b: 46).
Tutto ciò risulta particolarmente interessante se si tiene conto del
dibattito teorico che negli ultimi decenni si è sviluppato in seno
alle discipline antropologiche. Con grande forza Rouch offre
all’antropologia uno strumento attraverso cui ridimensionare la
posizione dell’antropologo sul campo. La telecamera diventa uno
strumento che l’etnografo non può trascurare. Rouch profetizza
che ben presto “sarà impossibile essere un antropologo senza
essere anche un cineasta” (1981: 44) e, per quanto a livello
accademico questa consapevolezza non sia ancora stata raggiunta,
sono sempre più numerosi i ricercatori che si avvalgono degli
strumenti cinematografici per condurre le proprie inchieste. “Il
metodo della restituzione a posteriori del film è solo agli inizi, ma
introduce già, tra l’antropologo e il gruppo studiato, relazioni
completamente nuove, prima tappa di quella che alcuni di noi
cominciano a chiamare l’antropologia condivisa. Infatti
l’osservatore esce dalla sua torre d’avorio; la sua macchina, il
registratore, il proiettore lo hanno condotto per uno strano
itinerario iniziatico al cuore della conoscenza e, per la prima
volta, può essere giudicato sul posto, dagli stessi uomini che è
venuto ad osservare” (Rouch; 1988c: 65).
Nelle intenzioni di Rouch, ad ogni modo, il processo innescato
dalla restituzione, dal feed-back, non si ferma qui. Se nella prima
fase di questa antropologia condivisa l’antropologo è chiamato a
L’utilizzazione del feed-back, ovvero verso la creazione di
“un’antropologia condivisa”
L’onestà metodologica di Rouch e del suo “cinema diretto”
escludono a priori la possibilità dell’uso di tecniche
«voyeristiche» come quelle della “candid-camera” o delle
“immagini rubate”8. Il principio base dell’antropologia visuale di
Rouch, ciò che per lui fa della telecamera uno strumento
insostituibile per la riuscita di una ricerca sul campo, quello del
feed-back, è un banco di prova sul quale l’onestà metodologica e
critica dell’antropologo sono esposte al giudizio di coloro sui
quali la ricerca è stata compiuta. Tale metodo ha assunto fin dal
principio della carriera di Rouch una tale importanza da indurre
l’autore a parlarne in diversi suoi scritti ed in numerose interviste.
Data la centralità di questo tema, riporto qui di seguito un lungo
estratto nel quale Rouch narra la propria scoperta del feed-back, e
l’importanza che essa ha avuto per lo sviluppo del suo lavoro.
“Il cinema è per me, soprattutto, uno strumento d’inchiesta
insostituibile. In effetti, esso non permette soltanto di vedere e
rivedere i fenomeni analizzati, di cercare di analizzare ciò che
succede, di comprendere meglio ciò che era sfuggito al nostro
quaderno d’appunti, di sapere chi fa cosa, ma soprattutto di
disporre di quello che per me è un elemento essenziale e che noi
chiamiamo nel nostro gergo feed-back, ovvero la restituzione alle
persone che sono state filmate del film nel quale esse sono state
filmate, per approfondire tutte le dimensioni di un’autentica
conoscenza ed al tempo stesso per essere compresi nella propria
attività di antropologi dalle persone che sono state osservate.
Tradizionalmente, in effetti, gli antropologi rimandano i testi che
hanno pubblicato agli informatori che li hanno aiutati durante la
ricerca. Io l’ho fatto con la mia tesi, elaborata in Niger. Dopo
qualche tempo, quando sono tornato a trovare le persone con le
quali avevo lavorato, esse mi hanno ringraziato, ma mi sono
presto reso conto che esse avevano semplicemente ritagliato le
foto e che si erano serviti della carta per altre funzioni; non
sapevano che farsene della mia tesi! Avevano proposto al loro
istitutore di leggergliela in francese e, nonostante avessi cercato di
scrivere in una forma semplice ed immediata, per loro era risultata
incomprensibile. Al contrario, appena hanno potuto vedere i film
che avevo girato, hanno immediatamente capito ciò che avevo
fatto. Ad esempio nel 1951 avevo ripreso una caccia
all’ippopotamo ed ero tornato nel 1954 per proiettare il film nel
villaggio. Quelle persone non avevano idea di cosa fosse il
cinema, tuttavia, in meno di un minuto, si sono adattate ed hanno
capito tutto: il film era a colori, c’era il sonoro e gli interpreti
erano loro stessi. Non ci fu nessun problema di comprensione,
anche se prima della proiezione, aspettando che il buio calasse per
32
ACHAB
negoziare una rappresentazione adeguata con coloro che hanno
costituito l’oggetto della sua ricerca, in un secondo momento egli
deve spingere “gli osservati” a divenire essi stessi osservatori, ed
a restituire una rappresentazione del mondo da cui l’antropologo
proviene. Questa provocatoria ma stimolante idea, è stata
ripetutamente inseguita da Rouch nell’arco della sua carriera. Egli
ha formato, infatti, numerosi giovani antropologi e cineasti
africani9 invitandoli a viaggiare in Europa e a produrre
rappresentazioni e resoconti antropologici sull’Occidente. In un
film dello stesso Rouch, Petit à petit10, si assiste all’esilarante
inchiesta antropologica di un commerciante nigerino, venuto a
Parigi per cercare di carpire il segreto della costruzione dei grandi
grattacieli europei. Egli si ritrova a misurare crani e a porre
astruse questioni sull’uso della cravatta, piuttosto che di qualche
altro “strano” abito, lungo gli Champs Elysées.
L’impegno profuso da Rouch nel tentativo di appoggiare la
nascita e lo sviluppo di un cinema indipendente in Africa è stato
da tutti riconosciuto11. Conscio dell’importanza che le immagini
rivestono oggi nella formazione di rappresentazioni collettive
riguardo culture differenti e lontane, Rouch ha più volte auspicato
una larga diffusione del cinema prodotto in Africa, un cinema
capace di sradicare, grazie alle sue storie ed all’immaginario di
cui è espressione, i pregiudizi che ancora influenzano lo sguardo
occidentale nei confronti di questo continente.
un’epoca come quella in cui viviamo, che si costruisce e si
autorappresenta incessantemente a partire dalle immagini che di
essa vengono diffuse, il confine fra realtà e finzione è sempre più
incerto. La realtà concreta può essere radicalmente influenzata
dalla rappresentazione, per quanto erronea o parziale possa
essere, che di essa è stata data in un determinato momento storico.
L’antropologia conosce bene questo problema, se è vero, come ad
esempio riconosce Amselle (1990), che in non poche occasioni gli
antropologi si sono trovati a risentire i resoconti raccolti dai propri
maestri enunciati da nuovi informatori sul terreno.
I resoconti etnografici, dunque, hanno sempre basato la propria
legittimità su un terreno di confine fra realtà e finzione. Tuttavia
non sono molti gli autori che hanno accettato questa ambiguità
senza riserve e si sono dedicati con continuità alla ricerca di nuovi
equilibri. In Rouch i film cosiddetti di finzione, come Jaguar o
Moi, un noir “smentiscono, grazie ai loro differenti livelli, la
presunzione che qualsiasi film etnografico possa o debba sempre
mirare ad essere la rappresentazione diretta, senza mediazioni, di
un’altra cultura. La differenza sta proprio nella riflessività, cioè in
una forma di partecipazione per cui i registi ed i soggetti
etnografici collaborano nel creare una rappresentazione dialogica
di se stessi e per se stessi” (Asch, Taylor; 1998: 158). La realtà è
in qualche modo negoziata, costruita, e tuttavia risulta essere
veritiera, sincera, poiché nata da un atto creativo spontaneo, non
mediato; un atto creativo che è in se stesso realtà dirompente. “Il
cinema produce bellezza dal reale almeno quanto ne è il riflesso,
semplicemente perché l’unica verità, la sua verità, è l’istante
stesso di questa produzione che ha una parte nell’elaborazione di
ogni film, e su cui invece Rouch pone l’accento considerandolo il
momento del cinema, quello in cui il film si cristallizza”
(Chevrie; 1998: 116).
In effetti, come già si è accennato in precedenza, il cinema, il film
da fare, diventa per Rouch la ragion d’essere della realtà filmata.
Ciò in particolare per ciò che riguarda i suoi film di finzione. Il
film smette di essere “l’illustrazione di una sceneggiatura
prestabilita, […] o la rappresentazione di una fantasmagoria
inventata di sana pianta come nel cinema holliwoodiano. E’
invece fin da subito uno strumento, una tecnica di registrazione
del reale. Il reale, tuttavia, non è la realtà, ma ciò che si produce
nel momento in cui si filma e per il fatto che si filma […] La
finzione non preesiste più al film ma ne è prodotta, nella
coincidenza tra l’atto di filmare e ciò che viene filmato” (Chevrie;
1998: 115, 117).
Se Rouch difende la necessità dell’impiego degli audiovisivi nelle
scienze umane, rivendica con uguale forza i fattori soggettivi che
lo spingono a realizzare film etnografici. “A chi gli chiede perché
faccia questo genere di film, continua a rispondere «Per me».
Rifiuta l’approccio «scientista» all’etnografia che privilegia una
fredda descrizione di tecniche e di riti, mascherando sotto una
presunta oggettività il velo impalpabile, ma indistruttibile, dei
pregiudizi culturali. L’approccio «poetico» che Rouch predilige si
risolve nell’abbandono al ritmo organico della realtà” (Grisolia;
1988: 8).
Attraverso la diversità di forme, figure e luoghi che questo
Fra documentario e finzione
Nell’affrontare l’opera di Jean Rouch la definizione di un confine
fra realtà e finzione appare impropria. Lo dimostrano i suoi film
così come i suoi scritti e le sue interviste. In un articolo del 1988,
per affrontare il problema, Rouch narra una vicenda interessante
riguardo Ejzenštejn.
L’inizio di un movimento di ortodossia comunista negli anni ‘20
aveva portato, in Russia, certi puristi a condannare i film di
finzione sostenendo la necessità di mostrare al popolo solo la
realtà rivoluzionaria. “La finzione è oppio per i popoli”,
sostenevano questi individui. Ad Ejzenštejn fu commissionato in
quegli anni un film sui moti rivoluzionari del 1905. Egli pensò di
realizzarlo a Leningrado, ma dato che in quei giorni non la
smetteva di piovere, decise di trasferirsi ad Odessa e di girare il
film là. Inoltre, per far fronte alle insufficienze del proprio budget
già rimaneggiato dagli spostamenti, ridusse gli episodi
commissionati da tre a uno. Ne uscì un capolavoro, La corazzato
Potemkine, nel quale la maggior parte degli avvenimenti narrati
sono in verità irreali, o quanto meno fortemente modificati
rispetto alla realtà storica dei fatti. Con suo grande stupore, alcuni
anni dopo l’uscita del film Ejzenštejn, facendo una ricerca sui fatti
del 1905, trovò un dossier completo compilato dalla Marina
Militare: le illustrazioni erano tratte dal suo film.
Come si può desumere da questo aneddoto, Rouch riconosce
come il giudizio che lega una data rappresentazione ad una
specifica realtà sia più complesso di quello che sembra. Ciò che si
conosce della realtà è a volte noto a partire da rappresentazioni
che di essa sono state fornite e che rispondono a determinate
esigenze creative (tecniche, metodologiche, artistiche, ecc.). In
33
ACHAB
determinante: materialità per cui l’enunciato sembra il discorso
fluttuante di una soggettività non delimitabile, presente ed al
tempo stesso rifiutata nel corso della sua stessa enunciazione”
(Fieschi; 1998: 100).
Il cinema stesso, il processo che ne determina la nascita, è in
Rouch documentato. Questo può forse essere considerato
l’elemento di incontro fra realtà e finzione nei suoi film. Si può,
infatti, sostenere che l’ingresso del cinema nella realtà, il modo in
cui esso vi si adatta e, per altri versi, le modalità attraverso le quali
la realtà reagisce al suo ingresso, costituiscono il tema
fondamentale dell’opera di Rouch, il filo conduttore implicito di
tutti i suoi film. Rouch non filma soltanto i suoi attori, i riti a cui
è interessato, i luoghi che lo affascinano, egli filma anche se
stesso mentre compie queste azioni, si mette in scena attraverso il
proprio commento, si offre al giudizio ed alle critiche dei propri
collaboratori attraverso il feed-back, non maschera gli
inconvenienti che lo obbligano a modificare i piani delle riprese.
Si tratta di un metodo volto a scardinare la centralità della
posizione che l’osservatore ha da sempre ritagliato per se stesso.
Un metodo rischioso, affascinante, ed al tempo stesso
rivoluzionario. Un metodo che a mio avviso suggerisce
un’interessante via d’uscita dalle complesse reti di critiche entro
le quali l’antropologia si è imbrigliata in epoca postcoloniale.
processo, sul filo del suo percorso avventuroso e persino dei suoi
capricci, acquisisce da un movimento oscillatorio tra tecniche e
culture, viene a costituirsi una vera poetica, con le sue leggi e le
sue norme. “Una poetica la cui appartenenza letteraria è evidente,
e che sembra derivare tutt’intera dal principio surrealista
dell’incontro, dell’accostamento. Questo incontro precipita, come
fanno reciprocamente due elementi chimici, una nuova realtà,
irriducibile alla semplice somma delle sue parti” (Fieschi; 1998:
104).
E’ dunque in questo senso che nei film di Rouch realtà e finzione
non possono essere distinte rigidamente, ma sono piuttosto
rintracciabili in una compenetrazione unica ed irripetibile. Le
tecniche di lavoro tipiche di un film documentario vanno ad
innestarsi sullo svolgimento di una storia inventata. Regista,
attori, tecnici si trovano ad improvvisare un’interazione, che è
fittizia poiché dovuta al film, ma che non può che mostrare, in
modo estremamente perspicuo, la realtà, poiché vive della stessa
spontaneità e della stessa imprevedibilità del reale.
E’ vero, infatti, che “nel cinema di Rouch, per la prima volta,
vengono avanti sul proscenio, messi, si potrebbe quasi dire, sullo
stesso piano della rappresentazione, tutti gli accidenti tecnici con
cui la materia resiste […] E’ probabile che questa scoperta della
materialità del cinema abbia avuto per Rouch un’importanza
Note
1. Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
2. Jaguar, colore 16/35mm, durata 131’, prodotto da Les films de la Pléiade; commento e dialoghi: Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia,
Illo Gaoudel, Amadou Koffo; sonoro: Damouré Zika; musiche: Enos Amelodon, Tallou Mouzourane, amisata Gaudelize, Yankori,
ama, Dijenne, Molo Kari; montaggio: Josée Matarasso, Liliane Korb; interpreti: Damouré Zika, Illo Gaoudel, Lam Ibrahima Dia,
Douma Besso; riprese: Niger, Burkina Faso, Ghana; 1957-1967.
3. Moi, un noir, film colore 16/35 mm, durata 71’; prodotto da Pierre Braunberger, Les films de la Pléiade; musiche originali: Yopi
Joseph Degré; canti: Miriam Touré, N’Daye Yéro, Amadou Demba; montaggio: Marie-Josèphe Yoyotte, Catherine Dourgnon;
commento in francese: Amarou Ganda, Ibrahim Dia; interpreti: Amarou Ganda, Petit Touré, Alassane Maiga, Amadou Demba, Seydou
Guede, Karidyo Faoudou, M.lle Gambi; riprese: Abidjan; 1960; Prix Delluc 1959.
4. Nell’intervista di Colette Piault a Jean Rouch, “Parole dominée, parole dominante…”, in CinémAction n.81/1996, “Jean Rouch ou
le ciné-plaisir”, p. 156.
5. In “Parole dominée, parole dominante…”, op.cit. , p.154.
6. Mamy Water, colore 16/35 mm, durata 19’, prodotto da Pierre Braunberger, Les films de la Pléiade; riprese. Accra e Shama (Ghana),
1953.
7. La chasse au lion à l’arc, colore 16/35 mm, durata 88’; prodotto da Pierre Braunberger, Les films de la Pléiade; sonoro: Idrissa
Meiga, Moussa Amidou; montaggio: Josée Matarasso, Dov Hoenig; interpreti: Tahirou Koro, Wangari Moussa, Issiaka Moussa, Yaya
Koro, Belebia Hamadou, Ausseini Dembo, Sidilo Koro, Alì; riprese: frontiera fra Niger, Mali e Burkina Faso, 1957-1964; Leone d’Oro
alla XXVI Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
8. Per un analisi dei casi in cui tali tecniche sono state utilizzate vedere Chiozzi; 1997, cap. V.
9. Lo stesso Oumarou Ganda, ad esempio, protagonista di Moi, un noir, è diventato un importante regista nel panorama del nascente
cinema africano.
10. Petit à petit, colore, 16/35 mm, durata 90’; prodotto da Les Films de la Pléiade, dal CNRS del Niger e dal Musée de l’Homme;
soggetto: improvvisato; sonoro Moussa Hamidou; montaggio: José Matrasso, Dominique Villain; interpreti: Damouré Zika, Lam
Ibrahima Dia, Illo Gaudel, Safi Faye, Ariane Brunneton; riprese: Parigi (1968), Niger (1972).
11. Si veda ad esempio Diawara, 1992, cap.III.
34
ACHAB
Bibliografia
AA.VV., 1998; Jean Rouch. Le renard pâle, catalogo della retrospettiva omonima organizzata dal Centro Culturale Francese di Torino
e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino;
Asch T., Taylor L.; 1998; “Contributo all’antropologia. Jean Rouch come cineasta etnografico” in AA.VV, 1998; pp. 157-160;
Amselle J.-L.; 1999; Logiche meticce; Bollati Boringhieri, Torino;
Chevrie M.; 1998; “Al vento dell’eventuale. Da Moi, un noir alla Nouvelle Vague” in AA.VV.; 1998; pp.115-118;
Chiozzi P.; 1997; Manuale di antropologia visuale; Unicopli, Milano;
Dei F.; “La libertà di inventare fatti: antropologia, storia, letteratura” in Il Gallo Silvestre, n.13, pp. 180-196;
Diawara M.; 1992; African Cinema. Politics and Culture; Indiana University Press, Bloominghton e Indianapolis;
Faeta F.; 1995, Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media; Franco Angeli, Milano;
Fieschi J.-A.; 1998; “Derive della finzione. Note sul cinema di Jean Rouch” in AA.VV.; 1998; pp. 99-106;
Geertz C.; 1987; Interpretazione di culture; Il Mulino, Bologna;
Grisolia R. (a cura di); 1988; Jean Rouch. Il cinema del contatto; Bulzoni, Roma;
Hoffner P.; 1996; “L’avis de cinq cinéastes d’Afrique Noire”, in CinémAction n.81/1996, “Jean Rouch ou le ciné-plaisir”, pp. 89-103;
Piault C.; 1996; “«Parole interdite», parole sous controle…” in CinémAction n.81/1996, “Jean Rouch ou le ciné-plaisir”, pp. 140-147;
Predal R.; 1996; “Rouch d’hier à demain”, in CinèmAction n.81/1996, “Jean Rouch ou le ciné-plaisir”, pp. 12-18;
id.; 1996a; “La place du Surrealisme” in CinémAction n.81/1996, “Jean Rouch ou le ciné-plaisir”, pp. 56-58;
Rouch J.; 1981; “Etnografia e cinema” in La ricerca folklorica n.3/1981, “Antropologia visiva. Il cinema”, pp. 41-45;
id.; 1986; “Préface” in CinémAction n.38 “La science à l’écran”, pp. 5-10;
id; 1988; “A proposito dei film etnografici”, in Grisolia,1988, pp. 19-23;
id.; 1988a; “Saggio sulle metamorfosi della persona del posseduto, del mago, dello stregone, del cineasta e dell’etnografo”, in Grisolia,
1988, pp. 26-39;
id.; 1988b; “Mettere in circolazione oggetti inquietanti”, in Grisolia, 1988, pp. 44-47;
id.; 1988c; “La macchina da presa e gli uomini” in Grisolia, 1988, pp. 49-67;
id.; 1996; “Filmer pour comprendre soi-même ou pour faire comprendre?” in CinémAction n.81/1996, “Jean Rouch ou le ciné-plaisir”,
pp. 72-73;
id.;1999; Dionysos; édition Arcom, Paris;
Sheinfeigel M.; 1995; “Eclats de voix (Robinson ne dit pas son vrai nom)” in Admiranda. Cahiers d’analyse du film et de l’image
n.10/1995, “Le géne documentaire”, pp. 110-118;
35
ACHAB
Il consumo di funghi allucinogeni fra i Mazatechi della Sierra di
Oaxaca nel mutamento del contesto storico e sociale
di Fabio Pettirino
Dall’analisi di molteplici testimonianze archeologiche e a nascondere i propri culti tanto che in seguito si arrivò addirittura
documentazioni storico-antropologiche (cfr. ad es. Dobkin de a dubitare che i funghi fossero realmente usati come allucinogeni
Rios, 1974) si deduce che i funghi allucinogeni hanno avuto un in determinate cerimonie (Marozzi, Mari, Bertol, 1996: 289).
ruolo importante nei rituali religiosi delle antiche civiltà pre- Infatti, nonostante le intenzioni repressive delle istituzioni
colombiane e tutt’oggi, particolarmente presso le popolazioni del coloniali, l’uso rituale dei funghi sacri riuscì a conservarsi nel
Messico meridionale e del Guatemala, è diffuso l’impiego dei segreto delle pratiche degli uomini di conoscenza, nihe’s o
medesimi funghi per fini di cura o in cerimonie religiose e shinahes in lingua mazateca3, che furono gli artefici della
divinatorie.
perpetuazione del rituale che continuò ad essere celebrato in
I funghi utilizzati oggi in queste celebrazioni appartengono a circa segreto, permanendo simbolicamente come referente culturale
due dozzine di specie. La maggior parte di esse appartiene al indigeno e spazio simbolico di resistenza di fronte alla cultura
genere Psilocybe, una al genere Conocybe ed una al genere dominante.
Stropharia, chiamato anche dagli autoctoni hongo de San Isidro Se le fonti antiche menzionavano soltanto vagamente l’impiego di
(Marozzi, Mari, Bertol, 1996: 284). Attualmente l’uso intensivo funghi sacri, la riscoperta del rituale fra i mazatechi della Sierra
dei sacri funghi è presente soprattutto tra i Mazatechi di Oaxaca. Madre orientale, nella regione che fa capo a Huautla de Jiménez,
Lo scopo di questo articolo1 è quello di ripercorrere l’evoluzione fu merito, come noto, di G. Wasson (Levi-Strauss, 1973, cap. II).
dell’impiego rituale di funghi in epoca recente fra i Mazatechi Nel corso degli anni Cinquanta visitò quelle regioni e partecipò
della regione di Mazatlán, individuando dapprima degli elementi alla velada, la cerimonia notturna in cui si ingeriscono i funghi,
di continuità storica congiuntamente alle ragioni della loro guidato dalla famosa sacerdotessa Maria Sabina che si sarebbe
permanenza, per rilevare in seguito alcune delle trasformazioni poi convertita in un simbolo per la generazione hippie dopo la
occorse nella celebrazione
divulgazione dei primi
del rito in relazione alle
articoli
pubblicati
dinamiche del mutamento
dall’autore. Il rituale
professato
da
Maria
del contesto socio-culturale.
Sabina, dettagliatamente
Nello
specifico,
sarà
dedicata
particolare
riportato da Wasson,
attenzione alle figure che
presenta elementi di
officiano la cerimonia ed
origine pre-ispanica oltre a
chiari riferimenti al culto
all’influenza esercitata delle
cristiano che rivelano
missioni
religiose
sui
alcune
commistioni
significati del culto.
sincretiche che si sono
La storia dei rituali associati
prodotte nel corso del
al consumo di piante
tempo influenzando i
inebrianti in Messico - dopo
significati del rito. In
la Conquista - è stata in
primo luogo una storia di
questo, ad esempio, i
repressione. Prima della
funghi
vengono
a
Conquista, i funghi erano
r a p p r e s e n t a r e
Fig. 1: La regione di Mazatlán
utilizzati in cerimonie di
esplicitamente “la carne di
carattere pubblico2 mentre in seguito il loro consumo continuò Dio” (teonanácatl, in lingua nahuatl) costituendo un tramite fra
soltanto in riunioni private (Wasson, 1998: 11). In epoca coloniale l’individuo e l’entità divina.
il consumo di funghi allucinogeni si convertì, nell’interpretazione Un altro autore ad interessarsi più di recente del culto fu Eckart
dei missionari cattolici, in una manifestazione diabolica che Boege, che affrontò l’argomento in uno scritto monografico
diventò oggetto di forte repressione da parte delle autorità realizzato a seguito di una ricerca etnografica effettuata durante
ecclesiastiche che tentarono con ogni mezzo di estirpare la gli anni Ottanta nel territorio mazateco di Jalapa de Díaz. I
pratica. La persecuzione religiosa indusse la popolazione indigena risultati della sua indagine restituiscono un’interpretazione che
36
ACHAB
descrive il rituale sostanzialmente come una pratica curativa volta
al ripristino dell’equilibrio personale e dell’ordine sociale nel
quale il nihe disimpegna un ruolo privilegiato di mediatore fra
l’esperienza individuale e la realtà sociale della comunità. Boege
intende tutte le tecniche estatiche mazateche adottate dai guaritori
come delle strategie simboliche atte ad intervenire in diversi
ambiti sociali, tale che qualsiasi atto di tipo economico, politico o
sociale può essere tradotto, interpretato e teorizzato in funzione
del mondo simbolico che viene manipolato attraverso differenti
pratiche rituali (Boege, 1988: 167).
Il viaggio estatico4, guidato dal nihe, induce uno ‘stato di sogno’
denso di visioni che assumono significato attraverso
l’interpretazione del linguaggio simbolico dei funghi, i quali a
loro volta forniscono indicazioni sulla natura dei disturbi e dei
problemi che tormentano l’interessato e suggeriscono le possibili
soluzioni alla situazione di disagio. L’alterazione psichica
provocata dall’ingestione dei funghi costituisce soltanto la
cornice fisiologica che rende possibile l’apparizione di visioni
(cfr. Lewis-Williams, Dowson, 1988), mentre il contenuto di tali
visioni è determinato dal contesto culturale, dalle credenze
religiose e dalle rappresentazioni indigene del mondo invisibile
(Scarduelli, 2007: 135). L’associazione tra il viaggio ed il sogno
si basa sulla credenza mazateca che lo spirito umano - inteso
come congiunto ed articolazione di diverse componenti animiche
- possa vagare durante il sonno. Secondo l’interpretazione
indigena il sogno ha carattere conoscitivo e premonitore e può
dare indicazioni verosimili sul futuro degli accadimenti ed
influenzare il destino degli individui precorrendolo. Ma se le
immagini oniriche si presentano quando si dorme, senza che si
possa perciò intervenire sul corso degli eventi ai quali si deve
assistere necessariamente in modo passivo, il viaggio estatico è, al
contrario, uno stato di sogno indotto in condizioni di veglia,
prodotto appositamente per poter intervenire in maniera diretta
sulle questioni che causano il disagio e provocano uno squilibrio
nel rapporto con la natura o con la società. Si tratta di un viaggio
verso una realtà parallela e trascendente nella quale però trova
origine e sostegno la realtà quotidiana. L’intervento trascendente
diviene possibile attraverso l’esperienza degli uomini di
conoscenza. Essi affermano di potersi muovere consapevolmente
nella dimensione estatica del viaggio allucinogeno interpretando
il linguaggio simbolico dei funghi per ricondurlo alla storia
personale del paziente ed al complesso tessuto sociale della
comunità, che essi conoscono profondamente. Tale complesso di
conoscenze si tramuta di fatto in un dominio esercitato dai nihe’s
sulla sfera sacra e simbolica, uno spazio ideologico a sua volta
influente sulle relazioni sociali e di potere (Boege, 1988). Da
questo punto di vista la conservazione della ritualità e la
perpetuazione dell’ordine simbolico e culturale ad essa connesso
può essere relazionata al mantenimento di una forma di autorità
tradizionale. Essa si riproduce anche attraverso l’interpretazione
dei sogni e le divinazioni che possono contribuire al
mantenimento dell’ordine esistente, assumendo la funzione di
determinare il corso degli eventi e la perpetuazione della
percezione del loro corso necessario.
Valutando lo svolgimento del rito da una prospettiva strettamente
formale, è possibile osservare come si sia preservato inalterato il
ricorso ad alcuni elementi cerimoniali5. Essi trovano
corrispondenza e significato nella mitologia e nella cosmologia
tradizionale mazateca e si sono sottratti dalle influenze dei
mutamenti storici, giacché collocati simbolicamente in una
dimensione temporale mitica, destoricizzata ed immutabile. Il rito
si caratterizza inoltre per l’elevata formalità performativa,
simbolica e linguistica. Boege e Wasson descrivono nei loro testi
cerimonie officiate secondo un rituale strutturato in maniera
piuttosto rigida, caratterizzato da una elevata formalizzazione
Fig. 2 Fase rituale: ammollo dei funghi
linguistica con recitazione di preghiere ed orazioni alternate a
canti ed intonazioni ripetute. Analogamente, i miti e le orazioni
tradizionali mazateche tramandati per via orale, non sono recitati
o narrati, bensì cantati e talvolta intonati proprio in forma di
cantilena (Pettirino, 2002). Seguendo le argomentazioni di Bloch
(1974), il ricorso ad una modalità linguistica altamente
formalizzata nei rituali può essere inteso come un tipo di potere
atto specificamente a riprodurre la realtà; l’elevato grado di
formalizzazione riduce infatti in modo drammatico ciò che può
essere detto facendo scomparire la specificità e la storicità di un
evento (Bloch 1974, trad. it, 1980: 192). Allo stesso modo,
Tambiah individua nella formalità e rigidità della comunicazione
rituale non improvvisata e spontanea, ma codificata ed articolata
come in una “ripetizione disciplinata di atteggiamenti corretti”
37
ACHAB
(Tambiah, 1995: 139), una modalità che più che trasmettere nuovi arrivava certo alla tolleranza di pratiche rituali considerate
contenuti ed informazioni punta alla integrazione sociale ed alla idolatre. Il culto dovette poi essere sottratto allo sguardo dei
continuità. Se l’ortoprassi e la ripetizione rituale standardizzata missionari protestanti che, anziché voler assorbire la loro
assolvono a funzioni regolative e di controllo sociale, religione, erano maggiormente interessati ad evangelizzare gli
riproducendo e perpetuando l’ordine esistente attraverso il indios proponendo loro l’abbandono di ogni ritualità cerimoniale
controllo della struttura formale del rito, rimane da spiegare (Wasson, 1998: 15). A partire dalla metà degli anni Cinquanta,
l’evenienza del cambiamento. L’innovazione, in un rito nelle comunità indigene mazateche arrivarono i primi sporadici
contraddistinto da una così elevata formalizzazione, non può gruppi di missionari protestanti appartenenti in parte al
essere portata dall’individuo, giacché la forma sembra resistere movimento dell’ILV (Istituto Lingüistico de Verano); istituto che
proprio in virtù delle caratteristiche linguistiche legate alla a seguito di un accordo stipulato con il governo messicano si
ripetitività ed alla modalità espressiva che non favoriscono, anzi, poneva l’obiettivo di studiare le lingue autoctone e con esse le
ostacolano l’iniziativa e la riflessione personale. L’innovazione ed caratteristiche culturali delle popolazioni indigene. Questo
i mutamenti che investono il rituale sarebbero piuttosto da programma era però affiancato da chiari intenti evangelizzatori a
attribuire al mutevole contesto culturale che piega i contenuti a favore di un protestantesimo volto a sradicare il tessuto sincretico
nuove esigenze, in tal modo favorendo le traslazioni semantiche. che si era sedimentato attraverso i secoli nelle comunità indigene
In particolare, le più recenti variazioni alle strutture formali e (cfr. Cuturi, 2004). Un cambio di prospettiva si ebbe durante gli
semantiche del rito sono da ricondurre all’influenza della anni Ottanta, quando alcuni catechisti formati nella corrente della
moderna stagione dell’attività missionaria e, più in generale, ai teologia della liberazione cercarono di intraprendere la loro opera
processi di progressiva modernizzazione degli stili di vita nelle di evangelizzazione secondo un diverso modello teologico.
comunità mazateche. Sebbene infatti le missioni religiose abbiano Rifiutando la politica evangelizzatrice radicale, tradizionalmente
come fine principale la conversione degli individui, esse finiscono repressiva ed intransigente, che dirigeva i propri sforzi soprattutto
per operare come veri e propri
verso la sostituzione dei valori
agenti del cambiamento che
locali con quelli universali della
influenzano l’assetto dei sistemi
fede cristiana, la teologia della
delle relazioni sociali e politiche
liberazione scelse una condotta
all’interno della società oltre alle
differente,
che
assegnava
pratiche
comunicative
e
maggiore considerazione al
simboliche.
patrimonio
culturale
delle
pratiche locali. In termini teorici
Ne è testimonianza la specifica
si può affermare che nel solco
evoluzione del rito nella regione
concettuale
tracciato
dai
mazateca di Mazatlán Villa de
documenti del Concilio Vaticano
Flores, che viene ancor oggi
II, da una religione legata
realizzato sebbene in forma
metodologicamente alla filosofia
assolutamente discreta (Pettirino,
si acquisì una nuova prospettiva,
2002). Per altro, non solo la pratica
adottando una strumentazione
del consumo dei funghi sacri viene
analitica aperta alle scienze
celata, ma in genere viene
sociali. Dal punto di vista sociale
mantenuto il riserbo relativamente
i teologi della liberazione si
a qualsiasi atto di tipo magicoposero a difesa dei poveri e degli
religioso, come le offerte fatte in
Fig. 3: Processione religiosa
oppressi,
indagando
i
osservanza della topografia sacra
del paesaggio culturale o alla ritualità legata al mondo agricolo. meccanismi sociali dell’oppressione ed auspicando una
Seppur con discrezione, il rituale continua ad essere praticato con liberazione dallo ‘sviluppo’ imposto dall’esterno, anche se non si
continuità sorprendente, potendo calcolare con buona schierarono apertamente contro il cambiamento ma contro la
approssimazione che durante la stagione delle piogge da giugno a dipendenza che esso implica. Dal punto di vista teologico si ebbe
ottobre, quando i funghi sono maggiormente disponibili alla lo sviluppo di una teologia dei ‘segni dei tempi’ fondata sul
raccolta, ogni famiglia può celebrare la cerimonia fra una e discernimento, nella storia e nella società, dei segni della presenza
quattro volte secondo necessità, ricorrendo saltuariamente in altre o del disegno divino, che invita la ricerca dell’azione divina
stagioni dell’anno ai funghi conservati, di solito sotto miele. nell’evento storico (Tomei, 2004: 100).
L’imbarazzo o il timore correlati a queste pratiche sono il risultato Tale impostazione maggiormente ‘accomodante’ consentì
storico dell’azione religiosa del cattolicesimo tradizionale che a l’interpretazione delle espressioni culturali locali come eventi
Mazatlán fu opera soprattutto dei frati Giuseppini. Essi giunsero storici nei quali poteva incarnarsi e rivelarsi la verità universale
nei territori mazatechi intorno alla fine del XIX secolo e la loro della fede cristiana. Da allora il culto dei funghi sacri non soltanto
propensione al compromesso religioso con le credenze locali non iniziò ad essere maggiormente tollerato, ma divenne oggetto di
38
ACHAB
scatenare e fomentare il dissidio e la discordia .
Per i motivi elencati, si è prodotta una progressiva carenza di
nihe’s, che sta determinando la scomparsa dalla scena sociale di
quella figura che in passato ha rappresentato il mediatore tra
l’individuo e la comunità; il depositario dei valori comuni, capace
di ristabilire l’equilibrio biologico e spirituale dell’individuo e
l’ordine delle relazioni sociali attraverso la gestione dell’ambito
simbolico e rituale, oltre a rappresentare l’elemento cardine
necessario alla celebrazione tradizionale del rito di ingestione dei
funghi sacri.
Per questa ragione principale il culto ha cominciato a svilupparsi
necessariamente, senza la presenza di figure specializzate,
indirizzandosi verso una ritualità domestica. In ambito familiare,
il rito viene generalmente officiato dalle donne che, essendo per
tradizione profonde conoscitrici empiriche delle proprietà
terapeutiche delle erbe, hanno ereditato il ruolo di leader nella
conduzione della cerimonia cominciando ad adottare, in ambito
familiare, il ruolo tradizionalmente ricoperto dal nihe.
In altre occasioni il rito può essere celebrato da figure femminili
dette rezadoras, persone solitamente vicine alla chiesa cattolica,
spesso appartenenti a delle confraternite di preghiera. Esse
conducono la cerimonia aderendo principalmente ad una visione
cristiana e perpetuando antichi elementi sincretici ed
introducendone di nuovi.
Il cambiamento più evidente e radicale rispetto alla struttura
tradizionale del rito risiede dunque nell’assenza del nihe,
congiunta alla scomparsa del riferimento alla dimensione
comunitaria per la quale il rituale è divenuto perlopiù una forma
di integrazione familiare e di rafforzamento dell’unità domestica
(Pettirino, 2002). Anche in Boege ritroviamo menzionata
l’importanza del ruolo giocato dai familiari nello svolgimento del
rito, ma sempre relativamente al ripristino dell’ordine riferito ad
una dimensione sociale più ampia.
studio degli stessi catechisti, i quali iniziarono a diffondere l’idea
che Dio potesse essere presente anche nelle pratiche culturali
locali, mentre le visioni che si manifestavano durante il viaggio
estatico potevano essere considerate una rivelazione della sua
grandezza. L’ideologia di questi religiosi, molti dei quali erano
mazatechi formati come catechisti, si realizzava nell’idea di
‘comprendere per trasformare in profondità’. Per loro la pratica
rituale dell’ingestione di funghi, anziché costituire un ostacolo da
rimuovere sulla strada della conversione, poteva favorire
l’interiorizzazione dei valori cristiani attraverso una pratica
storica e locale già radicata nello ‘spirito mazateco’. Tale
atteggiamento strumentale permise di raggiungere quel risultato
che precedenti tentativi di conversione religiosa avevano colto
soltanto parzialmente, riuscendo a colonizzare il profondo dello
spirito e dell’immaginario locale; approfittando peraltro, di un
percorso già tracciato e profondamente segnato da anni di
predicazione di dottrina cristiana, durante i quali si era sviluppato
un sincretismo che, ad esempio, aveva rafforzato
nell’immaginario locale il valore sacramentale conferito al
momento dell’ingestione dei funghi.
***
Si è detto in precedenza del ruolo fondamentale che i nihe’s hanno
avuto nella conservazione del rito e dell’importanza della loro
figura nell’orizzonte delle relazioni comunitarie istituita
attraverso la gestione delle pratiche rituali6. Ma in uno scenario
comunitario sempre più destrutturato dalla modernizzazione degli
stili di vita, si sta determinando una progressiva mancanza di
ricambio nell’officio di ‘specialista del sacro’; mancanza dovuta
ad una sensibile crisi delle vocazioni nella popolazione di giovani
mazatechi. Le giovani generazioni di mazatechi hanno infatti
maturato aspettative differenti e percepiscono le pratiche culturali
legate all’ambito tradizionale e, con esse, il ruolo del nihe, come
appartenenti a un complesso devalorizzato legato simbolicamente
al passato.
I pochi nihe’s operanti subiscono inoltre, in misura sempre
maggiore, la concorrenza della medicina ufficiale sul versante
delle loro pratiche curative, mentre rispetto alla sfera sacra e
rituale si è fatta sempre più presente l’ingerenza dei proseliti
operati da missionari di differenti movimenti religiosi.
La progressiva destrutturazione dell’orizzonte comunitario e la
conseguente riorganizzazione delle relazioni sociali avviene poi,
sempre più spesso, in un moderno scenario religioso e politico
fazioso, che ha incrinato il sistema delle ‘alleanze primordiali’
basate principalmente sui vincoli di parentela. Gli attriti fra nuclei
familiari e fra i loro membri sono sempre più ascrivibili alle
diverse appartenenze partitiche oppure all’adesione a differenti
gruppi di predicazione religiosa. In tale contesto, sono stati molti
i nihe’s accusati di stregoneria esercitata a fini politici e molti di
essi sono stati assassinati a seguito di tali accuse. Dal ruolo
tradizionale di risolutore di conflitti e controversie gestite sul
piano simbolico, il guaritore viene sempre più spesso inteso come
un elemento capace (attraverso le sue conoscenze prodigiose) di
***
In conclusione è interessante notare, in termini comparativi, come
nel capoluogo di un territorio confinante a quello di Mazatlán, il
rituale abbia modificato i suoi significati e la sua forma in
relazione a specifiche dinamiche sociali locali. In netta
controtendenza rispetto al resto della regione mazateca, Huautla
de Jiménez ha conosciuto un rilevante incremento del numero di
guaritori, dovuto in maniera piuttosto evidente all’opportunità di
rispondere alla crescente domanda del turismo psichedelico, che
spinge giovani di tutte le nazionalità verso Huautla per
sperimentare stati di coscienza alterati, ai quali vengono attribuiti
significati edonistici e trasgressivi7. Il movimento turistico verso
Huautla ebbe inizio all’indomani della pubblicazione degli
articoli di Wasson in epoca hippie, ed i mazatechi residenti nella
cittadina e negli immediati dintorni8 hanno colto l’opportunità di
fornire a questa tipologia di visitatori il servizio richiesto. Come
ogni buon servizio turistico, esso si è costruito principalmente
sulla base delle aspettative dei clienti, tanto che lo scritto che
relaziona la velada - officiata da Maria Sabina e dettagliatamente
39
ACHAB
descritta da Wasson - è divenuta un’eccellente testa di ponte in
grado di mediare il servizio proposto dagli improvvisati guaritori
e le aspettative dei clienti desiderosi di sperimentare un ‘viaggio
autentico’. I funghi, freschi o conservati, vengono anche venduti
ai viaggiatori, i quali in qualche caso preferiscono consumarli
privatamente secondo una propria ritualità, sconosciuta ed
incompresa in quei luoghi.
Il turismo psichedelico è divenuto, nel corso degli anni, una fonte
stabile di ingressi economici per un discreto numero di famiglie
mazateche, anche attraverso lo sviluppo di un artigianato parallelo
di gadgets e di una ridotta economia di accoglienza turistica. Gli
‘specialisti’, in considerevole aumento, si dimostrano in molte
occasioni dei veri e propri ciarlatani, che hanno fatto avverare la
profezia di Wasson (1980:16-17) il quale aveva previsto uno
svilimento dei contenuti originari del rito nella sua celebrazione a
favore di stranieri poco rispettosi dei suoi significati sacri. Ciò sta
inoltre contribuendo ad allontanare dalla coscienza popolare quei
significati profondi che continuano ad essere conservati
nell’esperienza dei rari eredi della tradizione sciamanica del
nagualismo (cfr. Klein, 2002: 392), capaci, secondo le credenze
popolari, di trasformarsi in differenti animali, separare da sé
consapevolmente una parte della loro anima, oltre a poter volare
e disputare memorabili lotte con i propri simili per il dominio
della realtà parallela.
Note
1. Il presente articolo si basa sulla sistemazione di una parte di dati etnografici raccolti durante una ricerca effettuata durante tutto
il 2002 nel territorio mazateco di Mazatlán Villa de Flores, su incarico dell’Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.
Parte dei risultati dell’indagine, particolarmente quelli inerenti alla sfera educativa, sono stati presentati durante una conferenza
tenutasi presso l’Università Pedagogica Nazionale di Tehuacán, Puebla, in data 22 giugno 2002, nell’ambito di un ciclo di
conferenze dedicate alla cultura pedagogica.
2. Seguendo le illuminanti argomentazioni di Lucero (2004), sulle politiche del rituale fra gli antichi Maya, non è da escludere che
anche in altre regioni nell’antichità pre-ispanica si possa essere verificata l’estensione del rituale da una dimensione familiare e
privata ad una collettiva e pubblica incentivata dall’élite dominante che trovava legittimazione nella consacrazione della visione del
mondo popolare amplificata a livello sociale e strumentalizzata a livello politico. La pratica sociale enfatizzata nel rito era dunque
legittimata insieme ai loro esecutori da un orizzonte culturale comune già presente nei riti familiari.
3. La lingua mazateca è classificata come Oto-Manguean, Popolocan e conta otto differenti varianti. Secondo ethnologue.com il
grado di intelligibilità della variante mazateca di Mazatlán è dell’80% con la variante di San Jerónimo, del 78% con quella parlata
nel territorio di Huautla, 16% Jalapa de Díaz e 8% Chiquihuitlán.
4. Le motivazioni per le quali i mazatechi ricorrono al consumo rituale di funghi sono molteplici. Frequentemente si ricerca la
soluzione ad un problema di salute la cui causa non di rado viene collegata alla sfera simbolica, come nel caso di un susto (nella
traduzione letterale ‘uno spavento’); si crede infatti che l’emozione faccia perdere all’individuo parte del suo corredo di forze
spirituali causando anche seri problemi all’organismo. In altri casi i funghi possono essere assunti a scopo divinatorio dal nihe per
poter ritrovare un animale disperso o rubato oppure per stabilire un contatto con il mondo dei defunti. Secondo l’interpretazione
indigena i funghi hanno proprietà curative prodigiose. Sono ingeriti interi sempre in numero pari, solitamente dopo averli ammollati
in una mistura di acqua e cacao con l’aggiunta qualche goccia di sangue di tacchino. Ai funghi sacri ci si può riferire con il termine
ndi xhi jtho, ovvero el que brota (quello che sboccia), oppure na t’iara na’mina, la cui traduzione letterale è saliva di Dio, e sta ad
indicare la capacità che i funghi hanno di parlare a chi lo ingerisce, la metafora della saliva sarebbe dunque da ricondurre alla
‘capacità di parola’ del fungo. Prima della cerimonia bisogna rispettare un periodo di riflessione, digiuno e astinenza da relazioni
sessuali. La giornata che precede la notte della cerimonia deve essere passata in compagnia di un bambino o di una bambina sino
all’inizio del rito, forse per ritrovare un animo giocoso e spensierato privo di preoccupazioni; da notare che i funghi sono
metaforicamente assimilati a figure di bambini e frequentemente appaiono nelle visioni allucinogene proprio in tal forma.
Solitamente il soggetto interessato riceve una quantità maggiore di funghi, mentre non sembrano esserci regole fisse per gli altri
partecipanti al rito che possono anche astenersi del tutto dalla loro ingestione partecipando comunque alla cerimonia. Nella mia
esperienza, anche ai bambini è stata data una piccola coppia di funghi oppure è stata loro fatta ingerire la mistura nella quale i funghi
sono stati lasciati in ammollo prima del consumo. La cerimonia si svolge nella completa oscurità ed il suo fine principale è la ricerca
di un profondo grado di introspezione individuale, un esame di coscienza e una revisione della storia individuale che possa lasciar
emergere ogni possibile disagio che diviene l’oggetto di un’analisi guidata dall’officiante che, secondo necessità, prende le misure
necessarie per diminuire l’intensità dell’effetto allucinogeno oppure invita i presenti alla preghiera o ancora propone soluzioni e
dispensa suggerimenti interpretando il linguaggio simbolico dei funghi. L’introspezione individuale non di rado prende la forma di
un’analisi collettiva. Durante la mia permanenza nella regione mazateca mi è stata data la possibilità di partecipare per due volte
alla cerimonia grazie all’amico, nonché principale informatore, Maximino Bolaños Carrizosa che, in un dato momento, ha ritenuto
di presentarmi alla madre di sua moglie Antonia che si è gentilmente resa disponibile a guidarmi nel viaggio estatico nonostante
40
ACHAB
fossi straniero.
5. A tutt’oggi la cerimonia è officiata ricorrendo a elementi rituali che fanno riferimento al mito ed alla cosmologia indigena: il
copal, resina da bruciare che nell’interpretazione indigena rappresenta l’elemento primo, quello che apre il cammino verso l’altra
dimensione e mette in comunicazione con essa; le uova di gallina, che sono apprezzate come ‘coloro che sanno parlare’ in quanto
possono dialogare con gli spiriti padroni della natura; il tacchino (o qualcosa che lo rappresenta come ad esempio un uovo o delle
piume), stimato come saggio, in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema per la sua capacità di comunicare con l’altra
dimensione e proprio per questa sua caratteristica viene solitamente sotterrato con le offerte rituali; semi di cacao, rappresentano il
denaro e la bontà, nella credenza indigena si offrono ai Chakunes, gli spiriti guardiani, come pegno per poter passare all’altra realtà;
il cacao ha inoltre la proprietà di aiutare a liberare lo spirito di una persona che è rimasta ‘imprigionata’ durante il viaggio; il tabacco
fresco o picietl considerato come una potente difesa contro i malos vientos e gli spiriti maligni, per questo motivo prima della
cerimonia le giunture degli arti vengono strofinate con un trito di foglie di tabacco fresco che viene inoltre confezionato in piccoli
pacchetti da conservare in tasca per ottenere protezione; piume di pappagallo, portatrici di messaggi ed intermediarie ‘senza timore
alcuno’; sono inoltre sempre presenti sull’altare: le candele che rappresentano la vita e l’esistenza umana ed i fiori freschi che
evocano allegria e tenerezza. Sull’altare, rigorosamente collocato in asse est-ovest, figurano anche una molteplicità di immagini ed
icone cattoliche che sono state integrate nello scenario cerimoniale attraverso il corso degli anni a testimonianza di come il rituale
abbia progressivamente incorporato elementi simbolici, pratiche e significati mutuati dalla religione cristiana.
6. A testimonianza di quanto l’ambito simbolico e la sfera sacra possano influenzare la sfera politica fra i mazatechi della Sierra
Madre di Oaxaca è interessante riportare un aneddoto che si inserisce in un contesto di grave disordine politico che, durante il 1991,
portò il territorio mazateco di Mazatlán Villa de Flores ad un’aperta insurrezione politica alla quale seguì l’istituzione della
sovranità dell’assemblea comunitaria e la dichiarazione di autonomia del territorio indigeno: ‘Melquìades R. B. era un diacono con
forti ambizioni politiche che a qual tempo lavorava come aiutante del sacerdote nella chiesa di Mazatlán. Un pomeriggio, in una
rancherìa (piccolo complesso di case, frazione) non distante dalla cabecera municipal (capoluogo territoriale) dove era situata la
chiesa, ad un loquito (folle, visionario) apparve in visione una virgen (madonna). Siccome Melquìades era mazateco poté fungere
da intermediario linguistico fra l’istituzione ecclesiastica ed il racconto del visionario del quale però divenne presto un forte
sostenitore. Al contrario del sacerdote, che aveva tenuto un atteggiamento cauto, fin da subito la gente credette senza riserve alla
versione del loquito sostenuta dal diacono e smise di frequentare la chiesa per iniziare a portare offerte e radunarsi in preghiera nel
luogo dove era apparsa la virgen. L’unica persona a non credere affatto nel miracolo fu il presidente municipale (principale carica
politica della comunità) appartenente allo storico Partido Revolucionario Institucional (PRI) che sottovalutò completamente la
portata simbolica dell’evento. In realtà esso si dimostrò in seguito un solido fondamento metafisico sul quale avviare
un’insurrezione. Infatti il diacono Melquìades interpretò quell’apparizione come un segno trascendente che lo invitava all’azione
politica e ricorse all’aiuto di un nihe il quale decise di indire un’immediata seduta di ingestione di funghi sacri durante la quale una
visione mostrò l’avversario politico vestito da donna. Quella visione fu interpretata come un chiaro segno di debolezza del
presidente, evento che diede origine ad una rivolta capeggiata dallo stesso Melquìades che si rivelò vittoriosa per il fatto di aver
trovato senza indugi l’appoggio del popolo, coinvolto dagli accadimenti simbolici dei giorni precedenti e tradotti in azione politica
dal diacono attraverso il ricorso e la mobilitazione dell’universo simbolico.
7. Per approfondire l’approccio ‘ricreativo’ all’uso di sostanze psicoattive cfr. Piñeiro, 2000.
41
ACHAB
Bibliografia
Bartolomé, M. A. – 1997 – Gente de costumbre y gente de razòn. Siglo XXI ed., INI, México DF.
Bloch, M. – 1974 – “Symbols, Song, Dance and Features of Articulation”, Archives Européennes de Sociologie, XV, trad. it.: “Simboli,
canto, danza e caratteristiche di articolazione. La religione è una forma estrema di autorità tradizionale?”, in Carchia G., Salizzoni R.,
1980, Estetica e antropologia. Arte e comunicazione fra i primitivi. Rosenberg & Sellier, Torino.
Boege, E. – 1988 – Los mazatecos ante la nación. Siglo XXI editores, México DF.
Carmagnani, M. – 1988 – El regreso de los dioses. Fondo de Cultura Económica, México DF.
Cuturi, F. – 2004 – In nome di Dio. L’impresa missionaria di fronte all’alterità. Meltemi ed.., Roma.
Dobkin de Rios, M. – 1974 – “The Influence of Psychotropic Flora and Fauna on Maya Religion”, Current Anthropology, Vol. 15,
June 1974, No 2, 147-164.
Levi-Strauss, C. – 1973 – Antropologie structurale deux. Plon, Parigi.
Lucero, L. J. – 2003 – “The Politics of Ritual”, Current Anthropology, Volume 44, Number 4, August–October 2003, pp. 523-558.
Klein, C. F. – 2002 – “The Role of Shamanism in Mesoamerican Art”, Current Anthropology, Volume 43, Number 3, June 2002, pp.
383-402.
Lewis-Williams, J.D., Dowson, T.A. – 1988 – “The signs of all times”, Current Anthropology, Vol. 29, April 1988, No 2, 201-245.
Marozzi, E., Mari, F., Bertol, E. – 1996 – Le piante magiche. Casa editrice Le Lettere, Firenze.
Pettirino, F. – 2002 – Acercamiento antropológico a la realidad socioeducativa en la región mazateca de Mazatlán Villa de Flores,
CEDI, Centro Estudios Derechos Indígenas, working paper.
Piñeiro, J. J. – 2000 – El despertar del hongo, Editorial Grijalbo, México DF.
Scarduelli, P. – 2007 – Sciamani, stregoni, sacerdoti. Uno studio antropologico dei rituali. Sellerio editore, Palermo.
Tambiah, S. J. – 1995 – Rituali e cultura, Il Mulino, Bologna.
Tomei, G. – 2004 – Alla sinistra del Padre. Teologia e sociologia della liberazione in America Latina. Franco Angeli, Milano.
Wasson, G. – 1980 – The wondrous mushroom. Micolatry in Mesoamerica, McGraw-Hill, NY; trad. sp.: El hongo maravilloso:
Teonanàcatl. Fondo de Cultura Econòmica, México DF, 1998.
42
ACHAB
Il gioco del calcio
fra campo, campi e mass media
Interrogativi ed argomenti per un’antropologia dello sport
di Sara Ferrari
Il est temps que la sociologie du sport échappe à L’Équipe.
(Marc Augé)
People who don’t follow football think of it as just a game, something that can
be packed away when it is finished and forgotten about. But the game, played
out by twenty-two men in an hour and a half, is only the Kernel of Something
greater. The game is the core, you might say, of the Game.
(Pearson, 1994)
comme disent les reporters sportifs. En ces lieux
s’accomplissent encore de grands rituels, des répétitions qui
sont aussi des recommencements. De tout rituel on attend
qu’il s’accomplisse (semblable à lui-même, immuable
comme le latin d’Église) et qu’il accomplisse: qui la pluie
tombe, qui l’épidémie s’arrête, que les récoltes soient
bonnes et les dieux favorables. Le ritual répète mais il
inaugure, ouvre l’attente. Dans le rituel sportif l’attente se
comble avec la célébration elle-même: à la fin du temps
réglementaire les jeux seront faits mais le futur aura existémorceau de temps pur, grâce proustienne à usage
populaire.”
Il calcio e l’antropologia. Questo mio interesse è nato
chiedendomi perché, considerando il gioco del calcio un
“fatto sociale totale”, una sorta di quasi-religione
contemporanea, un mito e un rito, un evento-spettacolo di
grande impatto mediatico e globale, esso sia stato, a mio
parere, oggetto di limitato interesse da parte delle scienze
sociali, interesse che negli ultimi anni va crescendo.
Il calcio è, in primis, un gioco, ma spesso è stato studiato
prescindendo da tale prospettiva. Così le scienze sociali,
sulla scia degli studi relativi alla “tribù” dei fans del
Manchester United, si sono inizialmente concentrate sulle
indagini
del fenomeno hooligans. Inizialmente la
sociologia sugli hooligans ha acquisito dignità accademica
(Amstrong, Giulianotti; 1997; Sociological Review,1991)
soprattutto per l’analisi dei risvolti “psicologici” delle
guerriglie urbane, fuori e dentro gli stadi, provocate dai
gruppi più aggressivi del tifo inglese. Nei successivi studi
post-hooligans l’interesse sullo sport inizia a concentrarsi
sul tema della globalizzazione e sulle questioni identitarie
insite nei fenomeni del tifo. Un pionieristico articolo di
Marc Augé sull’ argomento (1982) si concentra sulla
possibile natura religiosa dello sport (del calcio in
particolare):
Augé individua quindi una connessione fra il rituale
religioso e la partita di calcio, oltre a constatare
l’importanza della dimensione televisiva globale del
football affermando che, per la prima volta nella storia
dell’umanità, gran parte della popolazione del pianeta
segue lo stesso evento (la finale di un mondiale di calcio)
contemporaneamente. Tale suggestione ci conduce così,
attraverso i mediascape (Appadurai, 1996 ), in scenari
glocali.
Augè nota inoltre come nelle colonie francesi d’Africa il
calcio si diffuse in modo analogo al cristianesimo.
L’amministrazione coloniale del resto tenne un
atteggiamento ambiguo verso uno sport “importato”. Da un
lato lo considerò un modo sano di canalizzare le energie
giovanili, dall’altro lato gli assembramenti per le partite di
“Si, de Charléty à Santiago, les stades deviennent peu à peu
un lieu de sens, de contresens et de non-sens, un symbole
d’espoir, d’erreur ou d’horreur, on pressent bien que ce
n’est pas simplement à cause de leur “capacité d’accueil”,
43
ACHAB
calcio e il nascere di associazioni sportive facevano paura
(divide et impera).
Una specificità antropologica negli studi sul football va
inoltre individuata nell’indagine sulle identità locali e
nazionali catalizzate nel tifo verso una compagine
calcistica. In Italia e in Francia tale tematica è centrale nei
lavori di Dal Lago (1990) e Bromberger (1995), sulle
manifestazioni del tifo a Milano, Torino, Napoli e
Marsiglia. Altri interessanti articolazioni sull’argomento
sono raccolte in Actes de la recherche en sciences sociales
(1994; volume 103, numero 1). Nell’introduzione al
volume, sulla base delle argomentazione di Pierre Bordieau
(1980; 1987; 1989), s’individua l’ambito di ricerca socioantropologica dello sport, oltre che nella composizione
sociale dei suoi praticanti e tifosi (ambito che riporta ai
primi studi sul fenomeno
hooligans), nell’interesse
collettivo che esso riveste
come spettacolo e nel suo
essere
investito
di
significati e simbolismi
identitari,
politici
e
religiosi.
Scegliere il calcio come tematica di ricerca implica il porsi
nella prospettiva della de-localizzazione; il campo
dell’etnografo si pluralizza così nei campi, anche nella loro
valenza mediatica ed immaginaria, ove si gioca, si guarda,
si parla, di football. Il campo antropologico può allora
diventare il bar (sempre più sostituito nella sua accezione
classica di osteria in Italia, o pub nel Regno Unito, dalle
caffetterie dei grossi centri commerciali) attrezzato di
maxischermo per gli eventi sportivi, il campetto
dell’oratorio, un parco cittadino, uno stadio di provincia,
S.Siro, il Maracanã o il divano di casa dal quale:
“regarder la télévision, et rendre compte du fait que pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, à intervalles
réguliers et à heure fixe,
des millions d’individus
s’installent devant leur
autel domestique pour
assister et, au sens plein
du terme, participer à la
célébration d’un même
rituel” (Augé, 1982).
Nella
precisa
Un certo disinteresse verso
localizzazione spaziale
il calcio quale sport
del
campo
glocale (Appadurai,1997,
dell’antropologo va forse
A m s t r o n g ,
cercata una seconda parte
Giulianotti,1994)
per
di risposta al perché le
quanto
riguarda
scienze sociali si siano
l’antropologia culturale
disinteressate in modo
può essere messo in
quasi
snobistico
relazione al suo classico e
Fig. 1: Kribi, Cameroon 2006: partita a pallone sulla battigia
(nonostante
ci
siano
fondante oggetto di studio,
esempi di intellettuali
i gruppi umani “primitivi
ed esotici” da preservare nella loro olistica etnicità, appassionati e dediti al football: Pasolini, Maurice Merleaurinchiusa in un a-storico contesto locale ben Ponty, Jean-Paul Sartre che nella “Critique de la raison
dialectique” si riferiva ad una squadra di calcio per
geograficamente e culturalmente delimitato.
Anche in tempi più recenti rispetto a quelli dell’ etnografia verificare la teoria dei “gruppi in fusione”), al gioco più
coloniale, avvicinarsi ad argomenti di ricerca sottintendenti popolare dell’ultimo secolo, in larga parte del mondo.
fondamento
un’idea dell’Altro come simile all’uomo bianco occidentale, Il campo in antropologia è stato
un “altrove” più vicino ai luoghi dove il sapere, la politica epistemologico oltre che “rito di passaggio” e d’iniziazione
e la storia credono d’avere pieno ed esclusivo diritto e per potersi definire vero antropologo (Clifford,1999); il
potere d’esistenza, avrebbe allontanato da un’ idea campo è stato, anche e soprattutto, costruito attraverso
romantica ed esotica di antropologia, quale studio delle operazioni di de-storificazione (Fabian, 2001). Porre lo
differenze culturali, ça va sans dire: diversità aventi quale sguardo scientifico su un fenomeno popolare globale,
termine di riferimento il contesto euro-americano. Come interconnesso e contemporaneo nella sua storicità
allora poter studiare uno sport che per certi aspetti sembra (rappresentata nella ciclicità di campionati e coppe del
essere, nella sua diffusione e nella sua interdizione nei mondo) avrebbe probabilmente anticipato la formulazione
di pressanti interrogativi epistemologici. Se l’antropologia
contesti coloniali, metafora e paradosso del colonialismo?
Forse che osservare il “selvaggio”, ai tempi di una certa ha trovato, per buona parte della sua storia, un fondamento
etnografia coloniale, e constatarne la passione per un gioco disciplinare oltre che metodologico in una certa idea di
“occidentale” avrebbe potuto significare renderlo meno campo, oltre che in certi e specifici temi, cosa ne sarebbe
stato dei fondamenti positivisti, garanzia di scientificità,
Altro, tribale e primitivo?
44
ACHAB
metaforizzati nel campo dell’antropologo, un campo
immaginato e rappresentato come un laboratorio chiuso e
auto-referenziale, sul modello delle scienze naturali?
Cosa ne sarebbe di quel campo se esso potesse essere,
metaforicamente e paradossalmente, ovunque si rincorra un
pallone in cuoio o una palla di carta e stracci. Forse per gli
stessi motivi, come nota Hannerz (1998; 2001) ci sono così
pochi lavori di etnografia della televisione?
La questione coinvolge quelli che, per un lungo periodo di
tempo, e ancora oggi per chi è legato a certi presupposti
esotici della disciplina, sono stati i fondamenti
dell’antropologia culturale, oltre che i suoi confini
disciplinari, soprattutto verso la disciplina “sorellastra”, la
sociologia.
Il campo, nella sua accezione antropologica e in quella di
campo da gioco, diviene allora luogo d’incontro-scontro fra
“culture”
ed
“identità”,
ma
anche
non-luogo
dell’immaginario; un non-luogo rappresentato e mediato
dagli schermi televisivi, attraverso i quali, una finale di
coppa del mondo diviene l’evento più seguito del pianeta.
dei mondiali del 1998. Come nota Jean-Loup Amselle
(1999,29) sull’argomento:
“in quell’occasione, la stampa scritta, radiofonica e
televisiva sia francese sia internazionale non ha mancato di
celebrare il carattere multicolore della nostra squadra
riproponendo il vecchio scenario di una Francia meticcia
che occupava la Ruhr dopo la prima guerra mondiale con i
suoi fucilieri senegalesi e che si opponeva così a una
Germania razzialmente pura.”
Due facce di una stessa medaglia appunto: parlando di
Black-Blanc-Beur i media non hanno fatto altro che
rafforzare la credenza nelle razze e nelle loro differenze:la
discriminazione positiva crea quindi altrettanti problemi di
quanti cerchi di risolverne (Amselle, 1996:37). Nella
rappresentazione mediatica dei rituali del calcio tale
meccanismo è abusato ed evidente; la nazionale diventa
stereotipo, rappresentazione teatrale e catartica del
“carattere nazionale”.
La partita di calcio può così assumere i connotati di una
battaglia (Dal Lago,1990), di una “continuazione della
guerra con altri mezzi”, e non mancano i casi in cui la
guerra negli stadi ha anticipato la guerra reale, come nella
dissoluzione della ex-Jugoslavia.
Il calcio si presta inoltre fin troppo agevolmente
nell’inquadrare ed ampliare i meccanismi di messa in atto di
Il propagarsi d’immagini mediatiche relative allo sport (e di
immaginari globali: gran parte della popolazione mondiale
può infatti immaginare di vivere altre vite o avere nuove
possibilità, sulla scia di spot pubblicitari, documentari
impegnati o “polpettoni” sentimentali) può arrivare a
strutturare il modus vivendi, le rappresentazioni, gli usi e i
costumi dell’evento sportivo. Lo studio del pensiero di
Baudrillard può essere strumento teorico per comprendere
più a fondo come l’impatto della tecnologia possa aver
modificato la vita sociale e le sue manifestazioni, gioco del
calcio compreso. In estrema sintesi, per Baudrillard (1999)
il virtuale ha assorbito il reale. Nel tempo del virtuale,
ridotto all’istante, lo spazio si moltiplica interagendo nel
tramite degli schermi mediatici. Anche le manifestazioni del
football, nella loro diffusione “virtuale” televisiva,
rientrano quindi in significativi ambiti
d’indagine
dell’antropologia dei media. Le rappresentazioni
mediatiche del calcio, soprattutto per quanto riguarda gli
eventi quadriennali di Mondiali ed Europei, sono inoltre un
esempio di quella città virtuale che Paul Virilio (1999)
contrappone alla città reale, influenzandola nel tramite delle
reti mediatiche.
Il calcio è dunque anche uno spettacolo visivo, una forma
d’arte del corpo, ma questo lo è sempre stato. La differenza,
banale certo, e forse per questo poco considerata ed
interpretata, fra i tempi di Giuseppe Meazza e quelli di
David Beckam, è la sua diffusione in diversi angoli di
mondo attraverso il mezzo televisivo. Differenza banale ma
rilevante, oltre che rivoluzionaria, nel modificare pratiche,
Duala, Camerun aprile 2006: Eto’s fan club
quelle “comunità immaginate” teorizzate da Benedict
Anderson (1983). La nazionale di calcio è così la più
seguita, famosa ed amata rappresentante di stereotipi
nazionali nell’interpretazione mediatica delle sue vittorie o
sconfitte; può inoltre diventare l’oggetto di “culto” di
pericolose derive verso il biologismo culturale. In questo
senso due esempi diversi, ma quasi due lati della stessa
medaglia, appaiono molto significativi: la nazionale
dell’Italia fascista, vincitrice dei mondiali del 1934 e 1938,
dove l’idea di purezza razziale implicò la credenza in una
superiorità fisica, e i Black-Blanc-Beur francesi, vincitori
45
ACHAB
rappresentazioni, immagini ed interpretazioni del football.
In tv il gioco del calcio è oggi strumento di marketing,
sponsor, oltre che (aspetto inquietante dell’epoca “videns”)
vetrina, scenario, luogo di decisione e propaganda
ideologico-politica.
Il calcio televisivo veicola quindi una forma di consumo
dello spettacolo, funzionale al mantenimento di una società
dei consumi. Non è casuale che la gran parte dei centri
commerciali sia dotata di appositi spazi per la visione delle
partite in onda sulle tv a pagamento. L’evento della partita
di calcio attira potenziali compratori, oltre ad essere
in quanto performance mediatica.
Come nota Sartori (1999), la radio, oltre ad aver
musicalizzato le nostre vite, ha lanciato sport
“raccontabili”, come il calcio. Nell’ascoltare una partita per
radio più spazio è quindi lasciato all’immaginazione della
sfera visuale. Nel calcio televisivo invece il vedere prevale
sul parlare, il telespettatore è quindi soprattutto un essere
vedente. La televisione svaga e diverte, gratifica l’homo
ludens, trasformando tutto in spettacolo. E ciò riguarda, in
particolar modo, l’oggetto calcio, trasformato in spettacolotelevisivo, in evento mediatico per eccellenza. Negli ultimi
dieci anni, gli spazi nei palinsesti televisivi dedicati al
football si sono moltiplicati e pluralizzati, così com’ è
cambiata l’immagine del calciatore professionista: da
semplice sportivo a personaggio televisivo a tutto tondo,
attento all’estetica e seguito da specialisti addetti alla cura
dell’ immagine. Nonostante tali metamorfosi, la
moltiplicazione del calcio in tv non è stata accompagnata da
un disinteresse per le performance “dal vivo”, piuttosto dal
suo contrario. Tale moltiplicazione di spazi televisivi ne ha
piuttosto accentuato l’interesse da parte d’individui
precedentemente profani, l’universo femminile per
esempio, colpito dagli immaginari legati al calciatore quale
soggetto veicolante mode e stili. L’evento televisivo sta
dunque influenzando le pratiche del calcio giocato e della
sua fruizione. Durante il lavoro d’indagine fra oratori,
parchi e campi sportivi di periferia ho sentito spesso
pronunciare l’espressione: “succede anche nelle partite fra
professionisti, che vedi in televisione” riferendosi in
particolar modo a tafferugli in campo o disaccordi fra
giocatori. La mimesis (la riproduzione di rappresentazioni
per imitazione, nel caso specifico soprattutto di linguaggio
ed immagini) sembra quindi entrare in campo, non solo per
quanto riguarda le mode, di cui è testimonial il calciatore,
ma nelle pratiche del gioco stesso. La pubblicità addensa
gran parte della sua efficacia sulla capacità di suscitare
desideri di mimesis, verso stili di vita assimilabili e
rappresentabili in oggetti di consumo. La partita di calcio
assume quindi le sembianze di oggetto di consumo (di
spettacolo) veicolante, nella sua ormai intrinseca
dimensione pubblicitaria, altri fini consumistici.
Attraverso gli schermi televisivi inoltre il calcio entra
maggiormente nella vita famigliare ed amicale,
scandendone spesso i momenti di ritrovo e strutturando
pratiche di socialità condivisa. Nella mia storia personale il
seguire una partita di calcio in tv, o le accese sfide dei
tornei universitari di cui sono memore, o la “gita” allo
stadio, son momenti di ritrovo, riti condivisi con famiglia
ed amici. Oggi seguo gli stessi riti, sul campo o attraverso
i campi mediatici, con sguardi e pensieri antropologici.
El Jadida, Marocco dicembre 2007: Linee del campo
prodotto esso stesso. Il calcio-consumo, subordinato a
nuovi spazi di marketing diffusi tramite vecchi e nuovi
media, sta aprendo nuove dinamiche e interpretazioni della
sua ritualità. Gli attuali videogiochi (che riproducono
fedelmente l’immagine del calciatore), i blog di tifosi, il
proliferare di video relativi a gesta sportive o alle
celebrazioni di vittorie e sconfitte, conducono inoltre a
nuovi modus viventi di una passione collettiva.
Dai telefoni cellulari, ormai trasformati in accessori
multifunzione, ci si può collegare, in audio o video, al
rituale della partita. La domenica pomeriggio capita
d’incontrare chi, ascoltando le partite via telefonino,
ricorda modalità “tecnologiche” d’ altri tempi: la radio
portatile, oggetto d’uso ricorrente nelle passeggiate
domenicali degli italiani. La questione sui modi di
trasformazione di un rito e delle memorie sociali ad esso
connesse, sulla selezione a cui tali rappresentazioni
collettive del ricordo siano sottoposte in relazione agli
sviluppi tecnologici, è aperta e coinvolge molteplici fatti,
pratiche, immaginari ed interpretazioni sociali; il calcio è
solo una fra queste dimensioni, e lo è in modo emblematico,
46
ACHAB
Bibliografia
Amselle Jean-Loup, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot&Rivages, Paris, 1990. Trad.it.
Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Amselle Jean-Loup, Vers un multiculturalism français: l’empire du coutume, Aubier, Paris, 1996.
Amstrong G., Giulianotti R., Entering the field, New Perspectives on World Football, Berg, Oxford,1997.
Amstrong G., Giulianotti R., Football Cultures and Identities, Macmillan, London, 1999.
Amstrong G., Giulianotti R., Football in Africa: Conflict, Conciliation and Community, McMillan, London, 2004.
Anderson Benedict, Imagined Communities, Verso/New Left Books, London, 1983. Trad.it. Comunità immaginate: origini e fortuna
dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma, 1996.
Appadurai Arjun, Modernità at large:cultural Dimensions of Globalitation, University of Minnesota Press, Minneapolis-London,
1996. Trad.it. Modernità in polvere, Melteni, Roma, 2001.
Augé Marc, Football. De l’histoire sociale à l’anthropologie religieuse in Le Débat, n°19, febbraio 1982.
Baudrillard J., Le Crime Parfait, Galilée, Paris, 1995 Trad.it Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà, Cortina, Milano,
1996.
Boniface Pascal, Football & mondialisation, Armand Colin, Paris, 2006.
Bromberger Christian, De quoi parlent les sports? in Terrain n°25 septembre 1995.
http://terrain.revues.org/document2837.html#txt
Bromberger Christian, Le match de football. Etnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin, Ministère de la culture/
Maison des sciences de l’homme, Paris,1995. Trad.it. La partita di calcio. Etnologia di una passione, Editori Riuniti, Roma, 1999.
Carrington Ben, McDonald Ian, Marxism, Cultural Studies and Sport, Routledge, London, 2009.
Clifford James, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge-London, 1997.
Trad.it Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Dal Lago Alessandro, Descrizioni di una battaglia. I rituali del calcio, il Mulino, Bologna, 1990.
Darby Paul, Africa, the Fifa Presidency, and the Governance of World Football: 1974, 1998, and 2002, in Africa Today, vol. 50, n°1:
3-24, 2003.
Darby Paul, Africa Football and Fifa Politics Colonialism and Resistance, Frank Cass, London, 2001.
Gastaut Yvan, Mourlane Stéphane, Le football dans nos sociétés. Une culture populaire 1914-1998, Éditions Autrement, Paris, 2006.
Giulianotti Richard, Supporters, Followers, Fans and Flaneurs. A Taxonomy of Spectator Identities in Football, Journal of Sport &
Social Issues, February 2002.
Giulianotti R, Robertson R, The globalization of football: a study in the glocalization of serious life” The British Journal of Sociology,
December 2004.
Goody Jack, Representations and Contradictions. Ambivalence Towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexuality, Blackwell,
London, 1997. Trad.it L’ambivalenza della Rappresentazione. Cultura, ideologia, religione, Feltrinelli, Milano, 2000.
Hannerz Ulf, Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, Colombia University Press, New York, 1992.
Trad.it. La complessità culturale, il Mulino, Bologna, 1998.
Kuper Simon, Football Against the Enemy, Orion, 1996. Trad.it Calcio e potere,Il Saggiatore, Milano, 2008.
Kapuściński Ryszard, Wojna Futbolowa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa, 1978. Trad.it La prima guerra del football e altri
racconti, Feltrinelli, Milano, 2002.
Müller Denis, Le football comme religion populaire et comme culture mondialisée: Brèves notations en vue d’une interprétation
critique d’une quasi-religion contemporaine, 2005.
http://contrepointphilosophique.ch/Ethique/Pages/DenisMuller/Football.htm
Turner Victor, The Anthropology of Performance,Paj Publications, New York, 1986. Trad.it. Antropologia della performance, Il
Mulino, Bologna, 1993.
47
ACHAB
Filmografia
A due passi dal paradiso, Fabio Martina, Circonvalla, Italy, 2006.
Bend It Like Beckham, versione it. Sognando Beckham, Gurinder Chadha, Deepack Nayar, Regno Unito-Germania, 2002.
Black Starlets. How to survive a Broken Dream, Christoph Weber, WDR Cologne Arte, Germany, 2006.
Chemusa Strars, Cyril Gfeller, Nicola Carpi, Martin Schaer, Switzerland, 2006.
El nascimento de una pasion, Jesus Sanchez, Wanda Vision, Spain, 2005.
Football land, Brazil green grass, Ali Maddahi, I.R.I.B. Channel 2, Iran, 2004/2005.
Friendship Cup, Aziz Allah Mohammadpoor, Training & Education Center of Babol, Iran, 2006.
Fuga per la vittoria, John Huston, General Video, USA, 1981.
Gambe d’oro, Turi Vasile, Mondadori Video, Italia 1958.
Goodbye World Cup, Reza Atefi, Bod Graphic Company, Iran, 2006.
Grunden Boys, Kjell Kjellman, Stv sveriges television ab, Sweden, 2001.
Hotel Colonial, Cinzia Th Torrini, Italia, 1987.
Il primo nazionale, Alessandro Jghenti, Federazione cinema Tv sport Georgia, Georgia, 2002.
Italia-Germania 4-3, Andrea Barzini, Ricordi Video Commedia, Italia, 1990.
L’arbitro, Luigi Filippo D’amico, Avo Film Commedia, Italia, 1974.
L’arcidiavolo, Ettore Scola, General Video, Italia, 1966.
La gran final, versione it. Il grande Match, Gerardo Olivares, Mikado, Spagna-Germania, 2006.
Phörpa., versione it. La Coppa, Khyentse Norbu, Palm Pictures/Coffee Stain Production, Australia/Bhutan 1999.
The game of life. Life gamble, Mysa Shootback, Mathare Youth Sports Association, Kenya, 2003.
Ultimo minuto, Pupi Avati, Avo Film, Italia, 1987.
Ultrà, Ricky Tognazzi, Mastervideo, Italia, 1991.
When the game kicks off, Hans Christian Ostermann, Deutsche Welle Tv documentaries and reports, Germany, 2006.
Nairobi, Kenya luglio 2008:Gli azzurri
48
ACHAB
La selva degli uomini…
1
Riflessioni sul tema del suicidio nel contesto migratorio
di Davide Bruno2
Il suicidio è considerato, nella nostra società, un atto legato alla
sfera dell’intimo e del privato. La sua prevenzione è affidata alle
competenze del medico, in quanto esso viene giudicato come la
possibile conseguenza di uno stato di mente inquadrabile
all’interno della psicopatologia e pertanto trattabile con strumenti
di ordine psicologico e chemioterapico. Già Durkheim (1897) ha
dimostrato come influenze di ordine sociale possano giocare un
ruolo fondamentale nella genesi dell’atto suicidario, nel momento
in cui l’equilibrio tra fattori protettivi e spinte suicidogene si
rompe a sfavore dei primi. Il gesto suicidario ripropone pertanto
il tema del rapporto tra la dimensione individuale e il contesto
sociale. L’obiettivo che mi propongo in questo lavoro è quello di
tentare una riflessione sul suicidio nel contesto migratorio
attraverso un approccio che tenga conto non solo degli aspetti
idiosincrasici della personalità dell’individuo o dell’assetto
neurotrasmettitoriale del cervello (cosa di cui si occupa con
maggior o minor successo un certo tipo di psichiatria), ma che
abbia come punto di partenza una visione integrata di ordine biopsico-sociale.
ripresentarsi sulla terra per vendicarsi delle persone che gli hanno
arrecato danno (samsonic suicide). Presso i Serer, invece, chi si
suicida apparterrebbe alla categoria dei “tji:d a paxer”, individui
che intrattengono con il mondo dei morti particolari legami che
fanno sì che essi siano continuamente tentati di ritornarvi
(Collomb, Collignon 1974).
Il carattere trasgressivo e di “rottura” proprio dell’atto suicidario
si ritrova in alcune storie di persone che hanno tentato il suicidio.
Verrà quindi presentato il caso di Alfonso, giovane Miskito,
raccolto da Moro e Martin (1989) e una vignetta clinica relativa
ad un paziente afferente al Servizio di psichiatria in cui mi trovo
a lavorare.
Alfonso e il Bla
Il Bla è un fenomeno che, sotto forma di crisi, interessa
essenzialmente gli adolescenti della popolazione Miskito del
Nicaragua recentemente esiliata in Honduras. Chi è colpito dalla
crisi cade (caer) in uno stato di trance per cui corre brandendo un
machete o un bastone. E’ possibile che gli adolescenti colpiti
feriscano o uccidano le persone che incontrano sul loro cammino,
ferendosi e uccidendosi a loro volta.
La crisi di Bla ha dei segni prodromici specifici quali malessere
generalizzato, nausea, cefalea, irritabilità e lipotimia. In uno stato
alterato di coscienza emergono visioni che hanno una sequenza
fissa: un uomo a cavallo invita l’adolescente a montare in sella
attraverso l’offerta di una coppa di sangue e di un pugnale. Al
termine della crisi chi ne è colpito si risveglia tranquillo, in uno
stato di torpore, non ricordando nulla di ciò che è avvenuto.
Alfonso, uno dei giovani che frequentemente va incontro a crisi,
descrive così a Moro e Martin (1989:109) il momento in cui
questa inizia:
Vivere ai confini, qui e altrove
Svariati sono i motivi addotti a spiegazione del gesto suicidario
ma nessuno è, di per sé, capace di renderne interamente conto. In
alcune società africane si può rinunciare alla vita in seguito alla
sconfitta in battaglia, alla vergogna per aver compiuto atti contrari
alla morale condivisa o per un lutto familiare improvviso
(Calderoli, 2001). Nella società occidentale Durkheim individua
diverse motivazioni a spiegazione del suicidio, tra cui la miseria e
i rovesci della fortuna, i dispiaceri in famiglia e nella vita
amorosa, il disgusto della vita. Inoltre, mentre in alcune società il
comportamento suicidario è culturalmente determinato, in altre le
tecniche per darsi la morte sono variabili. Da ultimo, il giudizio di
valore riguardante il suicidio può cambiare a seconda delle
differenti società e delle differenti epoche storiche (Barbagli
2009).
Quello che pare però accomunare i giudizi e i discorsi che la
società fa sul suicidio è il suo carattere extra-ordinario e, per così
dire, trasgressivo. I suicidi sono dei revenants che necessitano di
peculiari riti di fissazione e purificazione (Coppo 2005). La
possibilità, per le vittime di morte violenta, di tornare nel mondo
dei vivi è legata per la psicoanalisi all’azione che il senso di colpa
esercita sui sopravvissuti mentre in altre società è legata alla
mancata azione di rituali specifici. Presso i Nyoro dell’Uganda, ad
esempio, è prescritto che se un soggetto si impicca ad un albero,
quell’albero venga sradicato, tagliato in pezzi e bruciato.
Parimenti la sua abitazione dev’essere abbandonata e distrutta.
Questi accorgimenti eviteranno che lo spirito del defunto possa
“Inizialmente mi sento male, ho nausea. Dopo ho male alla testa,
sento come dei colpi in testa. E poi comincia il cuore, come se
volesse fermarsi, come se volesse battere più forte del normale. In
quel preciso istante perdo conoscenza, tutto sparisce. appare una
persona strana, non come la gente che si vede in giro, un altro tipo
di persona, con occhi immensi, denti grandi. […] Quando perdo
conoscenza appare un uomo a cavallo, spesso non se ne
percepisce che la testa, oppure è nudo come i bambini…E’ sempre
un uomo e mai una donna…non assomiglia né ai Miskito, né ai
Sumo, né ai Garifuna. […] Il suo cavallo è nero, ha sulla fronte
una stella a cinque punte e sulla testa è scritto il mio nome. “E’ il
tuo cavallo, sali in sella, vai” mi dice l’uomo. E’ un cavallo strano,
la testa somiglia a quella di un orso e il corpo a quello di un
cavallo. E’un cavallo alto come quelli che ci sono qui. L’uomo
porta infine una coppa di sangue e dice “prendi questa coppa di
49
ACHAB
sangue”. E se si beve il sangue allora accade il peggio. Se non lo
si beve ci si calma, ma se lo si prende è lui che ti guida…”3.
psichiatrica.
Passare le frontiere: la storia di Juan6
In qualità di medico ospedaliero mi capita sempre più spesso di
prendermi cura di adolescenti in difficoltà: tra gli altri mi viene
alla mente il caso di un giovane ragazzo poco più di diciottenne
che un collega che lavora in ambulatorio aveva deciso di
ricoverare in seguito ad un tentativo di suicidio7. Egli mi aveva
chiesto di occuparmene in quanto era preoccupato dalla giovane
età del ragazzo e per il fatto che non c’erano apparentemente
ragioni per un gesto così grave, né problemi familiari né altro.
In occasione del nostro primo colloquio mi sono trovato di fronte
un adolescente dall’aria un po’ persa che non diceva una parola.
Mi guardava, sorridendo. Decisi di iniziare la nostra
conversazione proponendogli di dirmi qualcosa di lui: mi
raccontò così che si chiamava Juan ed era originario del Perù
essendo stato adottato all’età di sei anni da una coppia di Livorno.
In effetti egli pronunciava il suo nome, cosa che mi aveva molto
colpito, con una G aspirata tipica dell’accento toscano. Continuò
il suo racconto riferendomi quali erano i suoi gusti in tema di
vestiti e di musica. Gli domandai se c’erano delle cose che amava
a scuola. Mi rispose che andava piuttosto bene, se la cavava, e che
le sue materie preferite erano il corso di italiano e di inglese.
“Ami le lingue?”, gli chiesi. Juan esita un po’, mi guarda e sospira
dicendo di sì: gli piace abbastanza l’inglese, ma avrebbe preferito
imparare lo spagnolo in quanto è la sua lingua di origine.
Rimango un po’ stupito da questa affermazione così improvvisa,
ma il ragazzo non mi lascia il tempo di riprendermi e aggiunge
immediatamente che è tempo di fare un viaggio in Perù: con i suoi
o, se non lo desiderano, da solo. Gli domando quindi come
immagina questo suo paese, ma senza rispondere, mi torna a
guardare sorridendo.
Quel giorno era presente in reparto una infermiera dell’èquipe
originaria del Perù. Decisi quindi di invitarla al colloquio insieme
alla madre di Juan. Nel corso delle presentazioni, come di
consueto, pronuncio il nome del ragazzo e l’infermiera lo ripete,
spontaneamente, con il suo accento. Juan ( e la sua mamma!)
restano come di sasso e, dopo qualche secondo, egli aggiunge: è
così che mi chiamavano da me! Racconterà quindi che prima di
arrivare in Italia era un ragazzo di strada e che guadagnava la
giornata frugando nella spazzatura. La madre riprende il discorso
del figlio dando maggiori notizie riguardo all’adozione e alla vita
che Juan conduceva nel suo paese. Ricorda inoltre che il figlio,
una volta arrivato da loro, aveva molta paura di attraversare le
frontiere: un giorno, avendo deciso di passare le vacanze in
Svizzera, l’intera famiglia è stata costretta a tornare indietro in
quanto Juan era stato preso da una crisi di profonda angoscia
all’idea di essere abbandonato all’estero.
Il padre di Alfonso afferma che quando il figlio è preso dalla crisi
afferra un machete e comincia a correre. Nessuno può fermarlo né
togliergli l’arma in quanto sarebbe troppo pericoloso, solo gli altri
giovani colpiti a loro volta dalla crisi possono avvicinarlo. Gli
adulti assistono alla scena in uno stato di totale impotenza e con
il timore che i figli possano defenestrarsi o gettarsi nel fiume.
Anche i medici occidentali non possono intervenire perché nulla
appare efficace: solo alcuni trattamenti tradizionali sembrano
avere un qualche effetto terapeutico.
L’inefficacia della presa in carico da parte dei terapeuti nostrani
ripropone non solo il problema dell’adeguatezza delle cure in
contesti culturalmente diversi4, ma mette anche l’accento sul fatto
che una medicina centrata sull’esperienza individuale della
sofferenza quale quella occidentale si rivela del tutto impropria ad
affrontare i problemi legati a comportamenti culturalmente
codificati che sembrano trarre la loro forza da motivazioni di
origine sociale. Non è qui la sede per discutere approfonditamente
delle vicende di ordine storico e politico che hanno portato alla
migrazione della popolazione Miskito (Lanternari 2006), basti
però ricordare che per i due autori citati il Bla sarebbe originato
da una sorta di resistenza nei confronti di un processo di
acculturazione che per gli indios è stato rapido e massivo5. Torna
in questa visione l’idea del trauma migratorio come “ferita
aperta” attraverso cui emergerebbero elementi culturali ancestrali
legati ai riti di iniziazione. Il tentativo sarebbe quindi quello di
proporre una “ristrutturazione sociale” utilizzando componenti
traumatofiliche che trovano la loro incarnazione nell’azione degli
adolescenti Miskito i quali si trovano a vivere un’età considerata
essa stessa fragile e di passaggio.
Utilizzare categorie ben note alla psicologia in campo
antropologico è un’operazione che è stata oggetto di diverse
critiche, in particolare in riferimento alla nozione di trauma quale
strutturante psichico proposta, ad esempio, da Tobie Nathan
(1991). Tuttavia, questa nozione contiene in nuce l’idea di una
circolazione di materiali “perturbanti” a livello della società
allargata che coagulerebbero in comportamenti culturalmente
determinati nel tentativo di trovare una via di scarica e di
risoluzione nei confronti di questi materiali ansiogeni attraverso il
linguaggio del rito. Com’è noto, il rito è stato oggetti di diversi
studi in campo antropologico (Turner 1982, Severi e Houseman
1994), alcuni dei quali hanno dato avvio a interessanti teorie che
hanno permesso il dialogo con alcune discipline appartenenti alle
scienze della mente quali, ad esempio, la psicologia sistemica
(Bateson 1936). La domanda che va qui definendosi è se il
comportamento suicidario sia in qualche modo legato alla
possibile risoluzione di un momento di crisi (nel caso,
ovviamente, che questo non venga portato a termine) e qual sia il
luogo occupato dalla società in queste condotte, cercando di
tenere una prospettiva di comprensione sovraindividuale.
Per tentare di definire meglio il problema ritornerò al “campo” di
osservazione che mi è proprio rappresentato dalla clinica
Alcune considerazioni conclusive
La riflessione sul suicidio propone il tema del legame tra
individuo e gruppo sociale. Questo legame sembra trovare nel
corpo un mezzo privilegiato di espressione: come nel caso di
Juan, molti pazienti che hanno tentato il suicidio riportano che in
50
ACHAB
quel momento sentivano preclusa ogni capacità di pensiero che
potesse alleviare l’angoscia. Il corpo rappresenta quindi l’unico
polo di scarica di emozioni ed affetti vissuti in maniera massiva
ed insopportabile. Per la psicoanalisi la fantasia suicidaria “deriva
da un abbassamento di livello del processo simbolico con un uso
del simbolo di tipo feticistico. Si ha invece una perdita di esso
quando dalla fantasia si passa all’atto, al suicidio. Nel primo caso
l’angoscia di separazione o di perdita funziona come segnale che
mette in moto difese adattative; nel secondo, invece, travolge le
possibilità di contenimento e di integrazione e viene espulsa in un
agito” (Giaconia 1889).
L’idea del suicidio non realizzato come un tentativo di rimettere
in circolazione materiali ansiogeni che paralizzano il pensiero per
cercare una via d’uscita sembra trovare nella psicologia
individuale delle possibili spiegazioni. Per cercare tuttavia
un’articolazione con il sociale sembra necessario tornare alla
riflessione sul corpo che si mostra a tal proposito come un oggetto
ambivalente e sovradeterminato: il corpo può infatti essere
considerato la quintessenza della soggettività (si pensi ad esempio
all’idea del DNA come caratterizzante specificamente ogni
individuo), ma esso può essere anche inteso come una costruzione
tipicamente culturale. Il terreno del corpo non è infatti un terreno
neutro: esso viene plasmato dalla società grazie a tecniche e rituali
specifici (Calderoli 2006) a mezzo dei quali ogni gruppo sociale
inscrive su di esso ciò che è considerato possibile o al contrario
interdetto, ciò che è considerato desiderabile o al contrario
disprezzato. Al corpo come mera “res extensa” si contrappone un
corpo fantasmatico, in senso individuale e collettivo: come gli
orifizi corporei sono luogo di introduzione ed espulsione di
sostanze da e verso l’esterno, il corpo di trova ad essere luogo di
proiezione ed interiorizzazione delle relazioni affettive, delle
prescrizioni, degli interdetti e delle istituzioni sociali (Berlincioni
2001). Corpo anatomico e corpo fantasmatico si trovano quindi in
un rapporto di scambio continuo in cui l’uno rimanda all’altro e
viceversa.
Non è quindi un caso se l’eliminazione del corpo biologico da
parte del suicida scatena violente reazioni da parte della
collettività per cui sono necessari particolari atti di purificazione
e di messa a distanza: la società si sente minacciata non solo in
quanto uno dei suoi membri ha rinunciato alla vita, ma anche
perché il gesto suicidario rimette in discussione quei sistemi di
valori e di norme condivise che, inscritti nel corpo, permettevano
la vita stessa. Si pensi a questo proposito ai veri e propri processi
ai corpi dei suicidi che venivano celebrati prima dell’avvento
delle teorie illuministiche in Europa: l’individuo era considerato
appartenente alla società e per disincentivare il suicidio venivano
inoltre confiscati i beni suoi e della famiglia. Analoghe misure
erano prese se il suicida apparteneva al corpo militare in cui i
legami di appartenenza erano ancora più forti (Barbagli 2009). Da
un punto di vista complementare si possono citare come esempi
dello stretto legame che intercorre tra società e corpo
dell’individuo le eccellenti descrizioni di Mauss (1950) in
relazione alla morte psicogena di individui che avevano ricevuto
un giudizio di condanna a morte da parte della collettività.
Il disagio di molti individui sottoposti a processi di acculturazione
massiva sfocia spesso in attacchi al corpo attraverso gesti autoeteroaggressivi che sembrano proporre il problema identitario di
come cambiare rimanendo fedeli a sé stessi. Se nel nuovo
contesto di vita i costumi appresi nel paese di provenienza non
hanno più lo stesso valore, com’è possibile sottoporsi al
cambiamento senza tradirsi? La migrazione è una situazione
liminale di grande rischio in quanto può sì portare a trovare
soluzioni creative al problema identitario, ma può anche
sottoporre a gravi stress che determinano condizioni inquadrate
dalla biomedicina nel campo della psicopatologia.
Come emerge da quanto esposto finora, il tema del corpo si presta
come luogo interdisciplinare di riflessione (Pandolfi 2007), esso è
inoltre oggi di grande attualità, come dimostra ad esempio la
recente proposta del testamento biologico in campo legislativo
(id). In questo contesto, l’assunzione ed il mantenimento di una
prospettiva interdisciplinare a carattere bio-psico-sociale può
permettere una miglior esplorazione e comprensione dei
significati sottesi a questi temi.
Note
1. “La selva degli uomini” del titolo allude emblematicamente al paesaggio tratteggiato da Dante nel secondo girone del settimo
cerchio dell’Inferno dove sono collocati coloro che avevano avuto “in sé mano violenta”.
2. Psichiatra, ha partecipato al Corso di perfezionamento in Antropologia Medica presso Università degli Studi di Milano-Bicocca,
durante l’a.a. 2007-2008.
3. Traduzione mia.
4. Vedi a tal proposito Berlincioni (2002), Bruno (2008).
5. Interpretazioni analoghe sono state date a proposito di altre sindromi culturalmente determinate: per alcuni autori l’amok è da
leggere in senso eminentemente politico, come un modo nazionale e onorevole di commettere l’atto suicidario, diventando la strategia
più estrema di riparazione a una ferita narcisistica che coinvolge l’intera società (Beneduce 2007).
6. Questo caso clinico è stato presentato, con qualche variante, nel corso del congresso “Le bébé, l’enfant, l’adolescent et les langues”,
Bobigny, 12-13 dicembre 2008 (Atti in corso di pubblicazione). I nomi e gli elementi non fondamentali alla comprensione del caso
sono stati variati per ragioni deontologiche.
7. Sul tema dell’adozione e dell’attacco al corpo cfr. Bruno 2007.
51
ACHAB
Bibliografia
Barbagli M. (2009), Congedarsi dal mondo. Il suicidio in occidente e in oriente, Il Mulino, Bologna
Bateson G. (1936), Naven. Un rituale di travestimento in Nuova Guinea, Einaudi, Torino, 1988
Beneduce R. (2007), Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra storia, dominio e cultura. Carocci, Roma
Berlincioni Petrella V. (2002), “Etnopsichiatria, etnopsicoanalisi: problemi vecchi e nuovi”, Quaderni de gli Argonauti, 4.
Berlincioni V. (2001), “Gestione culturale dell’identità: le mutilazioni genitali”, Gli Argonauti, n 83, anno XXI
Bruno D. (2008), “Migration et exclusion sociale: l’exemple des Centres de rétention en Italie”, l’Autre vol 9, n 2
Bruno, D. (2007), “Raccontami una storia…una lettura transculturale dell’adozione internazionale”, Il Vaso di Pandora, 15, 2, 49-57
Calderoli, L. (2006), “Cicatrici significative. Un approccio antropologico alle tecniche di modifica permanente del corpo”, in Pasini,
N., a cura di, Mutilazioni genitali femminili: riflessioni teoriche e pratiche. Il caso della regione Lombardia, Milano: Fondazione
ISMU
Calderoli L. (2001), “L’utensile e la terra nel discorso dei fabbri africani”, Il Verri, n° 17
Collomb H, Collignon R (1974), “Les conduites suicidaires en Afrique”, Psychopathologie Africaine X, 1
Coppo P. (2005), Le ragioni del dolore. Etnopsichiatria della depressione, Bollati Boringhieri, Torino.
Durkheim E. (1897), Il suicidio. Studio di sociologia, tr. it, Rizzoli
Giaconia G., (1989), “Adolescenza: mutamenti e patologia” in Trattato di psicoanalisi, Semi A. (a cura di), Raffaello Cortina,
Milano
Lanternari V. (2006), Dai «primitivi» al «post-moderno». Tre percorsi di saggi storico-antropologici, Liguori, Napoli
Mauss M.(1950), “Effetto sull'individuo dell'idea di morte suggerita dalla collettività”, In Teoria generale della magia e altri saggi,
Einaudi, Torino 1965.
Moro M.R., Martin D. (1989), “Alfonso, le président des fous…Approche ethnopsychiatrique du « Bla kira » en Moskitia
Hondurienne”, in Cliniques nomades, n. 13
Nathan T. (1991), “L'art de renaître. Fonctions thérapeutiques de l'affiliation au moyen du traumatisme sexuel”, Nouvelle revue
d'ethnopsychiatrie, 18, 15.
Pandolfi M., (2007), “Le arene politiche del corpo”, in Antropologia, n. 3
Severi C., Houseman M., (1994), Naven ou le donner à voir. Essai d’interprétation de l’action rituelle. Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme, Paris
Turner V., (1982), Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna 1986
52
ACHAB
La crisi ambientale del lago d’Aral
tra realtà e percezione
di Stefano Piastra
Introduzione
Il lago d’Aral, posto al centro del bassopiano Turanico al confine
tra Kazakistan ed Uzbekistan, conserva tuttora un forte impatto
sul paesaggio regionale, essendo l’Asia centrale un territorio
caratterizzato da deserti sabbiosi (Kyzylkum, Karakum) o da
ambienti steppici.
Se sino a pochi decenni fa questo corpo d’acqua veniva
menzionato nei manuali di geografia come il quarto lago più
grande al mondo, vera e propria oasi nel cuore dell’Asia, negli
ultimi 40 anni esso ha subìto, a causa di interventi antropici, una
drastica riduzione di volume, superficie e livello. Non è dunque
un caso che Al Gore, vincitore del Premio Nobel 2007 per la Pace,
nel suo libro e relativo film Una scomoda verità (a metà strada tra
il saggio ed il pamphlet politico) citi tale crisi ambientale come
esempio emblematico di un uso non sostenibile delle risorse
idriche (Gore 2006); il disseccamento dell’Aral è inoltre
ampiamente utilizzato in ambito educativo, sia italiano che
internazionale, come caso paradigmatico di uno squilibrato
rapporto uomo-ambiente (Piastra 2008a).
Il contributo in oggetto, dopo aver accennato alle cause di innesco
e agli sviluppi di quello che nella bibliografia viene
frequentemente menzionato come il più grave disastro ecologico
del XX secolo (Feshbach, Friendly 1992), frutto di una
pianificazione dissennata ai tempi dell’Unione Sovietica, intende
focalizzarsi sull’impatto psicologico e sugli aspetti percettivi di
tale processo.
In particolare, limitandoci qui al solo caso italiano, sarà analizzata
la macroscopica contraddizione legata alle odierne
rappresentazioni cartografiche dell’Asia centrale, dove non vi è
quasi mai traccia della regressione del lago, e verranno
successivamente presi in esame alcuni articoli giornalistici,
racconti di viaggio e opere artistiche e letterarie dedicati a questo
fenomeno, distinguendo tra realtà scientifica e trasfigurazioni in
chiave simbolica: presso larghi strati dell’opinione pubblica, la
crisi dell’Aral è infatti stata assurta al rango di ammonimento
circa il futuro del pianeta, qualora non si adotti concretamente, a
livello globale, una prospettiva di sviluppo sostenibile.
Il presente lavoro si inserisce in un filone di studi ormai
consolidato, legato alla percezione delle tematiche ambientali e
geografiche (Corna Pellegrini 1985; Milani 2005); dal punto di
vista delle fonti utilizzate, alla tradizionale bibliografia cartacea
sono state affiancate ricerche su internet, in quanto importante
strumento di divulgazione, pubblicazione e dibattito circa questo
argomento.
La crisi ambientale del lago d’Aral
Il lago d’Aral ha conosciuto negli ultimi decenni un
disseccamento drammatico di cui si sono occupati i media di tutto
il mondo.
L’origine di tale disastro va collocata storicamente negli anni ’50
del Novecento, quando l’URSS, sotto la guida di Nikita Krusciov,
cercò di potenziare la coltivazione del cotone nelle steppe centroasiatiche, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere
l’autosufficienza riguardo ad esso e di diventarne il primo
produttore mondiale, sorpassando gli USA. I nuovi campi
coltivati a cotone furono irrigati derivando, tramite canali, enormi
quantità di acqua dall’Amu-Darya e dal Syr-Darya, i due fiumi
del bacino endoreico dell’Aral.
Fig. 1 – Il progressivo disseccamento del lago d’Aral (da Micklin 2007).
La produzione cotoniera aumentò sensibilmente, ma il rovescio
della medaglia di questi interventi fu che il lago iniziò
progressivamente ed inesorabilmente a disseccarsi. I due
immissari, depauperati dai prelievi idrici, non erano infatti in
grado di bilanciare le acque perse per evaporazione.
A partire dagli anni ’60 del Novecento l’Aral ha quindi
sperimentato la più rapida fase di regressione della sua storia,
abbassando il proprio livello di oltre 20 metri e riducendo la
propria superficie di circa il 75% ed il proprio volume di circa il
90% (fig. 1). Questo processo, a lungo tenuto nascosto
dall’URSS, è stato talmente intenso che nel 1989-1990 l’Aral si è
frazionato in due distinti corpi d’acqua: il piccolo Aral (detto
anche Aral del nord), alimentato dal Syr-Darya ed interamente in
territorio kazako, ed il grande Aral (detto anche Aral del sud),
53
ACHAB
alimentato dall’Amu-Darya e diviso tra Kazakistan ed
Uzbekistan, a quel tempo ancora ricompresi all’interno
dell’Unione Sovietica.
Tale disseccamento ha provocato uno dei più gravi (e dimenticati)
disastri ambientali del Novecento (Lètolle, Mainguet 1996;
Glantz 1999; Micklin 2007). Conseguentemente alla riduzione
del livello delle acque è esponenzialmente aumentata la salinità,
passata dagli originari 10 g/l ai 160 g/l attualmente riscontrabili in
aree ben specifiche, trasformando buona parte del lago da bacino
salmastro a bacino iperalino. Quest’ultimo fatto ha avuto
gravissime ripercussioni sul piano ecologico, provocando
dapprima la scomparsa totale dell’ittiofauna locale, sostituita da
specie esotiche introdotte dall’uomo; in seguito un drastico calo
anche di queste ultime. L’economia e la cultura della zona, basate
sulla pesca, sono state così cancellate nell’arco di pochi decenni:
i pescherecci che oggi arrugginiscono arenati sulle sabbie laddove
un tempo si estendeva l’Aral sono diventati l’emblema di questa
crisi ambientale (fig. 2) (Cencini, Piastra 2008). La riduzione
della superficie del lago ha inoltre causato cambiamenti climatici
a scala regionale: venuta meno l’azione mitigatrice della massa
idrica, il clima ha visto cioè un accentuarsi del suo carattere
continentale, sperimentando estati più calde e secche ed inverni
più freddi. Ma non è tutto. Laddove l’Aral si è ritirato, l’antico
fondale, caratterizzato da depositi salini e da sostanze inquinanti
raccolte dai fiumi del bacino lungo il loro corso (metalli pesanti,
fertilizzanti, pesticidi, ecc.), è ora esposto ai venti, con gravi
ripercussioni sull’ecosistema e sulla salute della popolazione
locale. Nel cosiddetto Priaralye, la regione che si affaccia
conflittuale delle acque
del bacino da parte delle
neonate
repubbliche
centro-asiatiche
( K a z a k i s t a n ,
Kirghizistan, Tagikistan,
Turkmenistan,
Uzbekistan).
Nonostante il quadro
generale appena esposto,
negli ultimi decenni si
sono moltiplicati progetti
ed interventi, soprattutto
ad
opera
di
enti
internazionali (UNEP,
UNDP, Banca Mondiale),
finalizzati al ripristino di
alcune aree (Piastra
2008b). Ma se il piccolo Fig. 3 – Stralcio cartografico relativo al lago
d’Aral dall’Atlante Geografico De Agostini,
Aral, interamente in edizione 2008. L’Aral è rappresentato ai livelli
territorio kazako, da più degli anni ’50 del Novecento,
di un decennio appare precedentemente cioè all’innesco della fase
avviato
verso
una regressiva odierna: il più grave disastro
ambientale del XX secolo è di fatto
gestione sostenibile delle completamente ignorato. Il centro di Moynaq
acque del suo bacino e ha (nella carta indicato come Mujnak, seguendo
conosciuto una rinascita la dizione russa), in Uzbekistan, appare
del comparto locale della affacciato sul lago, mentre oggi è in realtà
posto a circa 40 km dalle sue sponde.
pesca, nel caso del grande
Aral l’assenza di serie politiche rivolte alla sua salvaguardia ne
fanno prevedere agli studiosi, nel giro di pochi decenni, un
disseccamento totale.
L’“inganno cartografico”
Sebbene la crisi ambientale del lago d’Aral possa essere a buon
diritto considerata, come detto, una delle più gravi catastrofi
ecologiche del Novecento, ciononostante, almeno nella
maggioranza dei casi, essa non è stata recepita dalla produzione
cartografica italiana.
In altre parole, anche se il volume del nostro corpo idrico negli
ultimi 40 anni si è ridotto del 90%, le carte regionali e i planisferi
continuano tuttora a rappresentare l’Aral ai livelli degli anni ’50
del Novecento, precedentemente cioè al programma di
potenziamento del cotone in Asia centrale voluto da Krusciov e
all’innesco della fase regressiva odierna.
Sulla base di una pluralità di fattori, quali le poche informazioni
in Occidente circa l’Asia centrale post-sovietica, le difficoltà,
limitatamente alla toponomastica, connesse alla situazione
linguistica (il russo è stato repentinamente sostituito come lingua
ufficiale dagli idiomi centro-asiatici; questi ultimi, in alcuni casi,
sono nel frattempo passati per la scrittura dall’alfabeto cirillico a
quello latino), oppure ancora l’assenza, in questi Paesi, di enti
cartografici dagli standard occidentali, e sulla scia del diffuso
quanto errato convincimento dell’immutabilità di alcuni aspetti
fisici (idrografia, orografia, ecc.), quasi tutti gli atlanti geografici
Fig. 2 – Il cimitero delle navi di Moynaq (Uzbekistan), un tempo principale
porto dell’Aral (foto S. Piastra, maggio 2007).
sull’Aral, la falda acquifera, pesantemente contaminata e non più
utilizzabile a fini potabili, si è abbassata, contribuendo alla
salinizzazione dei suoli ed alla desertificazione.
La gravità della situazione è stata nel frattempo ulteriormente
peggiorata dall’implosione dell’URSS (1991), che ha portato ad
una instabilità geopolitica a livello regionale e ad una gestione
54
ACHAB
italiani, i globi, i libri di testo scolastici mostrano una cartografia
non aggiornata, cristallizzata alla situazione di 50 anni fa. È il
caso ad esempio dell’Atlante Geografico De Agostini nelle sue
ultime edizioni sino a quella più recente (2008) (fig. 3), oppure
del Calendario Atlante che esce annualmente per la stessa casa
editrice (e che quindi più di ogni altro dovrebbe essere
aggiornato).
Quella che a prima vista potrebbe apparire come una svista di
poco conto, in realtà è un fatto grave, in quanto nega
completamente, in sede di rappresentazione, il dramma vissuto
dalla popolazione locale negli ultimi decenni. Si tratta di uno di
quegli “inganni” o “violenze cartografiche” su cui si è soffermato
F. Farinelli (Farinelli 2003, pp. 78-79): la cartografia, in questo
come in altri casi, mostra cioè apertamente il suo carattere
soggettivo, e non oggettivo come siamo solitamente abituati a
pensare.
La “negazione cartografica” del disseccamento dell’Aral presenta
inoltre importanti implicazioni nel campo della divulgazione della
regressione del lago, in quanto un discreto numero di persone che
potrebbero sapere del disastro ambientale dalla cartografia,
proprio da quest’ultima ne vengono tenute all’oscuro. In altre
parole, in questo caso le carte vengono completamente meno alla
loro funzione di medium della conoscenza, facendo anzi passare
come esatte informazioni in realtà sbagliate.
Moynaq (Uzbekistan), un tempo principale porto sull’Aral. La
trattazione di Cecchi è emozionale, e insiste sull’aspetto lunare
dell’ex fondale lacustre ora esposto ai venti, sulla desolazione e,
di riflesso, sul senso di angoscia che deriva dalla visione del
disastro ambientale (Cecchi 2005, pp. 287-308). Sullo sfondo, si
staglia la politica ambientale dell’URSS incardinata su uno
sfruttamento scriteriato delle risorse naturali, considerate
all’epoca virtualmente illimitate: il disseccamento dell’Aral
costituisce forse la conseguenza forse più eclatante di tale
avventata politica.
Ultimo in ordine di tempo, Duilio Giammaria ha dedicato un
volume alla sua esperienza di inviato giornalistico in Asia
centrale. Il capitolo sull’Aral (Giammaria 2007, pp. 6-66) è
dichiaratamente scritto con piglio da romanzo d’avventura; il suo
limite principale è costituito dallo scollamento temporale tra la
pubblicazione del libro (2007) e la narrazione, che fotografa la
situazione ai primi anni ’90 del Novecento: molti dati risultano
oggi completamente inattendibili, a partire dai timori relativi
all’ex isola di Vozrozhdeniye, sede di una base sovietica per la
sperimentazione delle armi batteriologiche, attualmente
bonificata e monitorata.
In tutti i casi qui analizzati, la crisi ambientale dell’Aral è
implicitamente tratteggiata come una sorta di monito per le
generazioni future, affinché non ripetano gli errori del passato.
Sullo sfondo, sono ben presenti le incertezze e le grandi
contraddizioni nate dalla disgregazione dell’Unione Sovietica.
Solo Ettore Mo, sebbene a sproposito, accenna ai buoni risultati
ottenuti dagli interventi di ripristino ecologico messi in atto nel
piccolo Aral.
Gli articoli giornalistici e i racconti di viaggio
I pezzi giornalistici e la letteratura di viaggio, oggetto di una
diffusione più ampia rispetto alla bibliografia scientifica, possono
contribuire notevolmente a divulgare un determinato tema presso
la popolazione; allo stesso tempo però, la qualità
dell’informazione fornita al lettore dipende direttamente dal
controllo critico operato dall’autore sulle proprie fonti, dal
metodo più o meno scientifico adottato, dalla capacità di accedere
alla letteratura internazionale. Un taglio sensazionalistico o
iperbolico può inoltre concorrere a radicare nel pubblico opinioni
errate o distorte. Nel caso del disseccamento del lago d’Aral, un
problema comune a tutta quanta la pubblicistica dedicata
all’argomento riguarda il fatto che vengono spesso diffusi come
attuali dati o situazioni riscontrati dai vari inviati nel corso dei
propri viaggi, ma che ormai appartengono al passato. Del resto, la
regressione del lago è un fenomeno ad evoluzione estremamente
rapida, soggetto a notevoli variazioni nell’arco anche di un solo
anno: ogni affermazione in proposito necessiterebbe dunque di un
controllo rigoroso.
Accade così che Ettore Mo, autore nel 2006 di un reportage
sull’Aral per il Corriere della Sera, avanzi l’ipotesi che i progetti
di ripristino ambientale intrapresi nel piccolo Aral possano avere
ripercussioni positive sul grande Aral, quando invece i due corpi
idrici sono totalmente indipendenti l’uno dall’altro (Mo 2006).
Riguardo ai racconti di viaggio, mentre Tiziano Terzani fa solo un
brevissimo accenno alla crisi ambientale del lago (in quegli anni
poco nota in Occidente) (Terzani 1992, p. 233), Umberto Cecchi
dedica un intero capitolo del suo libro al cimitero di barche di
Le guide turistiche
I testi che forse più di altri contribuiscono alla formazione di un
immaginario collettivo in riferimento a un territorio estero vanno
ricercati nelle guide turistiche.
La guida più diffusa al mondo relativa all’Asia centrale va
individuata con certezza in quella della casa editrice australiana
Lonely Planet. Nel testo, alla crisi dell’Aral sono dedicati alcuni
paragrafi specifici, con informazioni puntuali (Mayhew et al.
2005, pp. 77-79); l’apparato cartografico risulta aggiornato,
mostrando la bipartizione tra piccolo e grande Aral e l’avvenuta
saldatura alla terraferma, in seguito alla regressione delle acque,
da parte dell’ex isola (attualmente penisola) di Vozrozhdeniye
(Mayhew et al. 2005, pp. 4, 95, 180, 245). Ulteriore pregio, la
guida delinea correttamente le situazioni antitetiche odierne del
piccolo e del grande Aral: nel primo, in Kazakistan, il quadro è
notevolmente migliorato negli ultimi anni (Mayhew et al. 2005, p.
143); nel secondo, diviso tra Kazakistan e Uzbekistan, la
situazione continua a peggiorare (Mayhew et al. 2005, p. 257)
Nel complesso, la trattazione della guida Lonely Planet offre
un’informazione obiettiva, chiaro frutto di riscontri autoptici,
senza incoraggiare il cosiddetto Dark (o Black) Tourism (turismo
“estremo” collegato a guerre, disastri, ecc.) e non nascondendo i
seri problemi logistici di un viaggio di questo tipo.
55
ACHAB
Le rappresentazioni artistiche e letterarie
Chernobyl, esso è inoltre diventato il simbolo di uno sbilanciato
L’odierna fase regressiva dell’Aral ha attirato l’attenzione di approccio tecnocratico alle risorse naturali, tipico dell’allora
scrittori ed artisti, che lo hanno scelto come sfondo della propria URSS.
produzione.
In ambito italiano, se alcune guide turistiche (in primis quella qui
Ciò che oggi resta del lago d’Aral può dunque essere annoverato analizzata della Lonely Planet) si sforzano nel dare
tra i cosiddetti luoghi letterari (Anselmi, Ruozzi 2003; Dossena un’informazione obiettiva riguardo alla regressione del lago, nei
2003), siti in cui è cioè possibile comparare la situazione reale con reportage giornalistici così come nei racconti di viaggio, tutti
la sua trasposizione letteraria.
dedicati al grande Aral, prevalgono un'informazione incompleta e
Si svolge tra Moynaq e l’isola di Vozrozhdeniye il nucleo una suggestione “nera” legata al disastro ambientale; in aggiunta
principale del romanzo L’anatra dalla testa bianca di G. Brayda a ciò, non sono quasi mai riportate le positive esperienze di
(Brayda 2004). Si tratta di un Ecothriller, all’interno del quale si ripristino ecologico effettuate in territorio kazako nel piccolo Aral.
intrecciano le vicende di terroristi
In molti casi, tale pubblicistica
alla ricerca di armi batteriologiche e
risulta attardata su vecchi dati,
di ricercatori e tecnici impegnati in
palesando ad esempio di ignorare
progetti di ripristino ambientale nel
come, pur permanendo una
delta dell’Amu-Darya (di qui il
situazione critica, la fase più acuta
titolo, connesso a un uccello
relativa all’emergenza sanitaria sia
migratore a rischio ancora attestato
ormai alle spalle: anche nel
nel delta fluviale). La narrazione di
Karakalpakstan,
Repubblica
Brayda indugia notevolmente sul
Autonoma ricompresa all’interno
pericolo antrace collegato all’ex
dell’Uzbekistan e affacciata sul
centro di ricerca sovietico di
grande Aral, a partire dagli anni ’90
Vozrozhdeniye.
del Novecento i tassi di mortalità
E. Burlini ha ambientato nella
infantile, che a metà degli anni ’80
Moynaq odierna il suo racconto
dello stesso secolo avevano
Come un soffio (Burlini 2006),
raggiunto un picco assimilabile a
spronando il lettore, nelle righe
valori tipici dell’Africa subconclusive, a documentarsi circa la
sahariana, hanno iniziato a scendere
tragedia dell’Aral. F. Maccioni ha
(Cencini, Piastra c.s.).
invece elaborato un racconto
La
stessa
trasfigurazione
futuribile, che ha luogo nel 2036 Fig. 4 – Il mare della morte, albo a fumetti della serie horror Dampyr “apocalittica” della crisi dell’Aral è
ambientato sul lago d’Aral (da Boselli 2002).
quando ormai il lago d’Aral si è
ben
presente
anche
nelle
completamente disseccato ed al suo posto si è formato un nuovo ambientazioni di alcuni racconti, romanzi e fumetti: il lago
deserto di sale, l’Aralkum (in uzbeko, letteralmente “il deserto disseccato, le barche in secca, i villaggi semiabbandonati sulle
dell’Aral”) (Maccioni 2008).
rive, sono cioè percepiti come la location ideale in cui ambientare
Da ultimo, Moynaq e l’isola di Vozrozhdeniye fanno da sfondo a storie post-moderne o horror.
un episodio della collana di fumetti horror Dampyr (Boselli 2002) L’aspetto forse più sorprendente relativo alla percezione in Italia di
(fig. 4).
questo disastro ecologico consiste però nella sua mancata
In tutti e quattro i casi qui presi in esame, l’Aral è trasfigurato nel rappresentazione nella cartografia, sia negli atlanti che nei libri di
luogo, per antonomasia, dell’inquietudine, della solitudine, della testo scolastici, dove le carte dell’Asia centrale mostrano una
desolazione.
situazione vecchia di più di 40 anni, precedente all’innesco della
regressione del lago. Tale constatazione va ricondotta in parte alla
Conclusioni
poca informazione circa le repubbliche centro-asiatiche, in parte a
La crisi ambientale del lago d’Aral, accanto al filone della ricerca superficialità, ma forse ancor di più all’errata convinzione che gli
scientifica, mostra ormai anche una dimensione psicologica e elementi di geografia fisica di un territorio (le montagne, i
culturale. In Italia, come anche a livello internazionale (cf. ad ghiacciai, i fiumi, i laghi, ecc.) siano qualcosa di fisso e
esempio Sinoué 2001; Kapuscinski 2007, pp. 214-222), il immutabile.
disseccamento del corpo idrico è stato infatti assurto a emblema di
uno sviluppo non sostenibile; accanto al disastro nucleare di
E-mail [email protected]
56
ACHAB
Bibliografia
ANSELMI G.M., RUOZZI G. 2003, Luoghi della letteratura italiana, Mondadori, Milano.
BOSELLIM. (a cura di) 2002, Dampyr. Il mare della morte, n. 31, Sergio Bonelli Editore, Milano.
Burlini E. 2006, Come un soffio, pubblicato on-line alla pagina web
http://www.cascinamacondo.com/download/scritturalia/11_2006/EdoardoBurlini.pdf.
BRAYDA G. 2004, L’anatra dalla testa bianca, Sperling Paperback, Milano.
CECCHIi U. 2005, Sulla via dorata per Samarcanda, Vallecchi, Firenze.
CENCINI C., PIASTRA S. c.s., L’impatto socio-economico della crisi del lago d’Aral: il caso del Karakalpakstan (Uzbekistan), in
CENCINI C., MENEGATTI B., FEDERZONI L. (a cura di), Una vita per la geografia. Scritti in ricordo di Piero Dagradi, Pàtron,
Bologna.
CENCINI C., PIASTRA S. 2008, La crisi ambientale del lago d’Aral, “Natura e Montagna” LV, 2, pp. 11-26.
CORNA PELLEGRINI G. 1985 (a cura di), Ricerca geografica e percezione dell’ambiente, (Atti del Colloquio Internazionale),
Unicopli, Milano.
DOSSENA G. 2003, Luoghi letterari. Paesaggi, opere e personaggi, Bonard, Milano.
FARINELLI F. 2003, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino.
FESHBACH M., Friendly A.Jr. 1992, Ecocide in the USSR: Health and Nature under Siege, Basic Books, NewYork.
GIAMMARIA D. 2007, Seta e veleni. Racconti dall’Asia Centrale, Feltrinelli, Milano.
GLANTZ M.H. (Ed.) 1999, Creeping Environmental Problems and Sustainable Development in the Aral Sea basin, Cambridge
University Press, Cambridge.
GORE A. 2006, Una scomoda verità. Come salvare la Terra dal riscaldamento globale, Rizzoli, Milano (trad. it. di Id., An Incovenient
Truth, Washington, 2006).
KAPUSCINSKI R. 2007, Imperium, VIII ed., Feltrinelli, Milano (trad. it. di Id., Imperium, Varsavia, 1993).
LETOLLE R., Mainguet M. 1996, Der Aralsee. Eine ökologische Katastrophe, Springer, Berlino.
MACCIONI F. 2008, Aralkum, pubblicato on-line alla pagina web http://www.xii-online.com/storie/usam/aralkum.pdf.
MAYHEW B., CLAMMER P., KOHN M. 2005, Asia centrale, III ed., EDT-Lonely Planet, Torino (trad. it. di Id., Central Asia, Lonely
Planet, Londra, 2004).
MICKLIN P. 2007, The Aral Sea Disaster, “Annual Review of Earth and Planetary Science” 35, pp. 47-72.
Milani R. 2005, Il paesaggio è un’avventura. Invito al piacere di viaggiare e di guardare, Feltrinelli, Milano.
MO E. 2006, Viaggio nel mare conteso ucciso da Mosca, “Il Corriere della Sera”, 26 aprile 2006, pp. 14-15.
PIASTRA S. 2008a, Crisi ambientali, desertificazione e didattica della Geografia. Il caso del lago d’Aral, “Ambiente, Società,
Territorio. Geografia nelle scuole” LIII, n.s. VIII, 6, pp. 31-35.
PIASTRA S. 2008b, Esperienze di ripristino ambientale nel delta dell’Amu-Darya (Uzbekistan), in Pattee E., Vianello G., Vittori
ANTISARI L. (a cura di), La qualità delle acque di superficie, (Atti del Convegno, Imola, 13-15 maggio 2008), GeoLab, Imola, pp.
85-90.
SINOUE’ G. 2001, A mio figlio all’alba del terzo millennio, Corbaccio, Milano (trad. it. di Id., E mon fils a l’aube du troisieme
millenaire, Parigi, 2000).
TERZANI T. 1992, Buonanotte signor Lenin, Longanesi, Milano.
57
ACHAB
O fenômeno da intolerância religiosa
Produtor de novas identidades sociais no interior da religião afro-brasileira
Álvaro Roberto Pires*
Sommario
Durante gli ultimi vent’anni, i conflitti promossi in Brasile dalle chiese pentecostali contro le religioni brasiliane di radici africane
(candomblé, umbanda, tambor de mina e altre) sono divenuti più frequenti e difficili. Recenti scontri hanno provocato la parziale
distruzione del terreiro [casa di culto] Oyá Onipó Neto, nella città di Salvador. Simili eventi mettono a rischio le fondamenta delle
religioni afro-brasiliane, sostegno simbolico costititivo in Brasile dell’identità del popolo “negro” e della cultura brasiliana in generale,
interferendo sulle basi che permettono la manutenzione delle matrici africane radicatesi sul suolo brasiliano. Il presente articolo
pretende riflettere sulla postura reattiva assunta di fronte a questi episodi da molti sacerdoti e sacerdotesse dei culti afro-brasiliani, dal
povo de santo [insieme dei fedeli delle religioni afro-brasiliane], dai ricercatori e dal movimento negro brasiliano.**
A despeito dos argumentos carregados de pré-noções acerca das
manifestações culturais dos “africanos no Brasil” (título do
conhecido livro de Nina Rodrigues), que foram sendo construídas
ao longo da história brasileira, particularmente das estruturas
religiosas que vieram juntamente com os corpos dos homens e
mulheres reclusos nos porões das naus estrangeiras, catapultadas
pelos ventos do “progresso” rumo a construção da sociedade
contemporânea que hoje conhecemos, podemos afirmar que tais
estruturas cheias de sentido, a partir do aparato mítico-religioso
encontrado nos terreiros onde brota a religiosidade afro-brasileira
bem como em suas comunidades, foram fundamentais para o
adensamento da cultura brasileira.
As matrizes africanas encontradas no bojo das religiões afrobrasileiras puderam ser observadas e estudadas a partir da
primeira viagem realizada por Roger Bastide em 1944 ao
Nordeste brasileiro, conforme se evidencia em seu livro Imagens
do Nordeste Místico em Branco e Preto [1945], que segundo as
afirmações do autor é o local “onde sopra o espírito”.
Expressando-se a partir de um texto que faz a apresentação da
utopia africana de Roger Bastide em seu livro O Candomblé da
Bahia: rito nagô, Fernanda Arêas Peixoto diz que “a “opéra
fabulosa” das danças, a linguagem gestual e a marcação rítmica
expressam a “complexidade da alma”, que as metamorfoses do
corpo e da personalidade evidenciam. O que está em jogo nessa
dramaturgia particular é uma concepção alargada do “ser”, que
rejeita a concepção kantiana de que não existiram estágios
intermediários entre o “ser” e o “nada””. (BASTIDE, 2001: 12).
Desta feita as religiões afro-brasileiras disseminadas nas capitais,
pequenas cidades, interiores, lugarejos desconhecidos de nosso
país puderam incorporar-se as dobras e ranhuras que compõem o
denso tecido da cultura brasileira, feito de pequenos eventos
cotidianos que vislumbram a grandeza do espírito humano no
momento em que a relação homem/sagrado se estabelece pela
presença do encantado, vodum, caboclo, preto-velho, erê, orixá,
muito próximo do filho ou filha de santo que concebe sua
presença emprestando seu corpo a cosmogonia de origem. A
dimensão que a prática mítico-religiosa possui no interior dos
terreiros da religião afro-brasileira pode ser entendida pelo olhar
mais aguçado para dentro da cultura brasileira, na qual poderemos
ver o papel do negro(a) na trama que é vivida diariamente, ou
através do entendimento que possuímos da noção de patrimônio.
Muniz Sodré ao fazer a análise das relações existentes entre
brancos e negros, dando ênfase ao direcionamento dos
descendentes de escravos afirma que
“O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural
da África) afirmou-se aqui como território político-míticoreligioso, para a sua transmissão e preservação. Perdida a antiga
dimensão do poder guerreiro, ficou para os membros de uma
civilização desprovida de território físico a possibilidade de se
“reterritorializar” na diáspora através de um patrimônio
simbólico consubstanciado no saber vinculado ao culto dos
muitos deuses, à institucionalização das festas, das
dramatizações dançadas e das formas musicais. É o egbé, a
comunidade litúrgica, o terreiro, que aparece na primeira metade
do século dezenove (...) como a base físico-cultural dessa
patrimonialização. (...) “Os terreiros podem dizer-se de
candomblé, Xangô, pajelança, jurema catimbó, tambor de mina,
umbanda ou qualquer que seja o nome assumido pelos cultos
negros em sua distribuição pelo espaço físico brasileiro.”.
(SODRÉ, 1988: 50-51).
É importante frisar que Sodré ao mencionar a solidariedade
existente entre os negros cativos, durante o suplício que se tornou
a passagem do Atlântico para as terras brasileiras, e o intercâmbio
encontrado por aqueles que conseguiram fazer a perigosa e
dramática travessia, hoje alocados por seus descendentes nos
terreiros tradicionais da Bahia, abre espaço para nossa reflexão
acerca da compreensão que deverá ser apreendida pelos
negros(as) brasileiros(as) a respeito da cultura que agora fazem
58
ACHAB
Nosso pensamento acostumado a conceber tão somente estruturas
lógicas a partir do ponto em que estamos situados, considerando
também o foco de nosso olhar (quase sempre treinado a não
enxergar as particularidades dos processos culturais, detendo-se
apenas nas generalidades) é pego na rede da perplexidade ao
enxergar os orixás, voduns, inquices ou outras entidades do
panteão que funda a religiosidade afro-brasileira, em suas
diversas matizes, concebidos aquém das manifestações religiosas;
são suportes simbólicos que oferecem sentido a condução das
regras de trocas sociais para o povo de santo. São as regras das
trocas sociais estabelecidas internamente a partir da hierarquia
assentada em cada terreiro, por intermédio das ações cotidianas da
yalorixá2 ou babalorixá3, declinando até o mais jovem neófito e,
irradiando-se pela comunidade de pessoas que circulam no
entorno do local onde está “plantado” o axé4, que revitaliza a
relação entre divindades e nossa condição humana.
parte, considerando que a matriz da cultura brasileira possui
muitos elementos simbólicos ou materiais que reafirmam esse
entendimento. Os argumentos acerca da travessia feita pelas
centenas de milhares de negros e negras do continente africano
para o chamado “novo mundo”, nos leva diretamente a mencionar
o fundamental trabalho de Paul Gilroy intitulado O Atlântico
negro: modernidade e dupla consciência, no qual o autor
estabelece as matrizes fundantes de seu pensamento abordando
um fragmento no interior da complexidade existente na conjunção
histórica vivida. Nela o autor lança luz “...as formas culturais
estereofônicas, bilíngües ou bifocais originadas pelos – mas não
mais propriedade exclusiva dos – negros dispersos nas estruturas
de sentimento, produção, comunicação e memória, a que tenho
chamado heuristicamente mundo atlântico negro”. (GILROY,
2001: 35 [49 ed. It.]). O mundo atlântico negro construído por
Gilroy possui a sutileza de transparecer o sentido do movimento
dado pela densidade líquida dos mares por onde as naus com sua
preciosa carga deram continuidade ao suplício humano. Para o
autor
“A imagem do navio – um sistema vivo, microcultural e
micropolítico em movimento é particularmente importante por
razões históricas (...) Os navios imediatamente concentram a
atenção na Middle Passage [passagem do meio]1, nos vários
projetos de retorno redentor para uma terra natal africana, na
circulação de idéias e ativistas, bem como no movimento de
artefatos culturais e políticos chaves: panfletos, livros, registros
fonográficos e coros” (idem, pg. 38 [51 ed. It.]).
É lícito pensar que as religiões afro-brasileiras já reúnem as
objetivas condições para que possam ser compreendidas por
todos(as) aqueles(as) que a freqüentam, não apenas como o lócus
privilegiado onde seus filhos e filhas irão em busca tão somente
do conforto espiritual, simbolismo que será automaticamente
revertido nas condições concretas de sua existência, mas enquanto
construção histórica e cultural à qual por intermédio do sentido de
pertencimento ao grupo criador das concepções acerca de uma
determinada condição de ver e agir no mundo, oferece a seus
adeptos e simpatizantes o equilíbrio de quem pode ser a parte,
porém dinamicamente em sintonia com o todo. Tal equilíbrio
somente poderá ser conquistado através da permanência de nossas
divindades na polifonia entre universo simbólico (religioso) e
aquele pertencente ao mundo material. Sodré argumenta que
Caminhada Contra a Intolerância Religiosa na cidade de Salvador/BA
apresentada no dia 21 janeiro de 2009, Dia nacional de combate à intolerância
religiosa. A Tarde on line. Fernando Vivas.
Assim podemos perceber que a comunidade-terreiro ganha uma
dimensão fundamental para o conjunto dos filhos de santo ou
aqueles que não o são, justamente pela cosmovisão que é
estruturada através dos suportes simbólicos que lhe dão
sustentação. Esta concepção do mundo concreto aliado a contra
parte simbólica, mítica, vai delineando contornos diferenciados e
definidos muito mais pelas relações mantidas no interior do
terreiro, simultaneamente irradiadas para a comunidade, que
afetam seu cotidiano, do que as relações que são determinadas
pelas regras dadas na sociedade abrangente, estas distanciadas dos
conteúdos míticos proporcionados pelo sentimento de pertença a
uma comunidade que cunhou sua história a partir do
conhecimento ancestral. Tal conhecimento penetrou fortemente
nas fundações da cultura brasileira oferecendo um resultado nada
convencional no que se refere às representações simbólicas,
materiais que seu povo elaborou, contrariando as projeções feitas
pelas nações européias que colonizaram este país bem como
aqueles que apostaram no mito da degradação cultural,
primeiramente dos africanos e, posteriormente de seus
descendentes. A despeito daqueles que fizeram deste mito sua
“Fatos dessa ordem são importantes para a compreensão da
cultura negro-brasileira, porque demonstram que os orixás ou os
voduns ou os inquices (bantos) não são entidades apenas
religiosas, mas principalmente suportes simbólicos – isto é,
condutores de regras de trocas sociais – para a continuidade de
um grupo determinado. “Zelar” por um orixá, ou seja, cultuá-lo
nos termos da tradição, implica aderir a um sistema de
pensamento, uma filosofia, capaz de responder a questões
essenciais sobre o sentido da existência do grupo”. (1988: 55).
59
ACHAB
razão de existir no novo continente “...foi o negro quem viu/a
crueldade bem de frente/e ainda produziu milagres/de fé no
extremo ocidente...” [Milagres do Povo, Caetano Veloso].
Acompanhando pari passu o desenvolvimento da cultura
brasileira é possível perceber o movimento de estruturação e
fixação da religião afro-brasileira no Brasil. Sob diversas
denominações que lhe foram dadas, considerando o conjunto de
nações africanas que para cá vieram, hoje é possível perceber a
rica gama de manifestações desta religiosidade em nosso país,
afirmando a força das ritualísticas, cantos, musicalidade,
vestimentas, comida votiva que foi transformada em alimentação
profana e muito apreciada por todos (a culinária baiana, por
exemplo, possui sua base construída na “comida de santo”,
preparada para receber em festa as divindades do panteão negro,
na reciprocidade do receber, dar, retribuir) [Mauss]. Desde os
tempos mais remotos em que foram instalados os terreiros
tradicionais sejam de candomblé, umbanda, tambor de mina,
batuque, xangô, até nosso complexo e virtual tempo globalizado,
os terreiros da religião afro-brasileira adquiriram visibilidade e
respeito em todas as instâncias da vida citadina de nosso país,
apesar das manifestações de intolerância e truculência que ainda
assistimos nas relações sociais cotidianas que são travadas por
pessoas e instituições que desconhecem os amálgamas
encontrados em nossa cultura a partir da presença do negro no
interior de sua construção mítica, religiosa, simbólica, a qual
oferece sustentação para o modus vivendi aqui “plantado”.
Focalizando nosso olhar para o interior dos terreiros,
encontraremos uma sociedade hierarquicamente construída cujo
funcionamento acopla as orientações do universo mítico-religioso
e aquelas determinações sociais que estabelecem as regras e
normas que deverão ser executadas coletivamente no espaço
sócio-sagrado. Começando pelos neófitos na religião cujo
caminhar nas dependências do ilê5 apresenta-se inseguro, quase
sempre temeroso em cometer qualquer atitude desabonadora
diante dos filhos de santo mais velhos, passando por estes que já
tendo um certo “traquejo” frente às formalidades que fazem o
cotidiano desta religião, podem a partir do ponto onde estão
situados negociar certas regalias com aqueles que ocupam cargos
mais elevados, sem com isso subverter a hierarquia estabelecida,
até chegarmos às sacerdotisas e sacerdotes que ocupam os altos
postos no terreiro, na qual sua sabedoria e conhecimento nas
“coisas do santo” devem atuar no sentido de agregar a
comunidade interna e externa que circunda aquelas dependências
religiosas, dirimindo os conflitos que possam existir e
potencializando o axé plantado para sua expansão intra e
extramuros.
Se por um lado as hierarquias forçam os membros do terreiro a
postarem-se de uma determinada maneira no cotidiano sóciosagrado ali instaurado, desempenhando seus papéis com a
máxima atenção para que a concepção de mundo afro-brasileira
possa concretizar-se, por outro lado os seres sociais que ali estão
desempenham papéis dinâmicos de cunho ideológico, político na
sociedade abrangente, muito embora não os definamos com estas
categorias, dentro do barracão, apesar de estarem implícitas.
Quase sempre encontraremos nos filhos de santo deste ou daquele
terreiro a qualidade de um(a) ativista do movimento social,
dirigente sindical, professor(a), vendedor(a) de doces, e afins,
papéis que são desempenhados na tessitura social. Esta
interposição de papéis sociais encontrada com freqüência em
nosso cotidiano, muitas vezes encobre os componentes dinâmicos
que os estruturam, oferecendo ao adepto(a) da religiosidade afrobrasileira a condição de manutenção daquilo que George Marcus
define como a reflexividade essencial por ser “...uma
característica integrante de qualquer discurso” (MARCUS,
1994: 18) por ser uma parte inerente ao uso da linguagem. No
entanto o que mais interessa ao autor é justamente a dimensão da
reflexividade ideológica, aquela que é usada para determinados
fins políticos bem definidos. Embora Marcus esteja referindo-se,
em parte, aos tipos de reflexividade encontrados na antropologia,
após o surgimento do pós-modernismo ter influenciado as
ciências sociais, acredito que seja possível operarmos estas
categorias no ambiente social da religiosidade afro-brasileira.
Os eternos “sujeitos” pesquisados por diferentes categorias de
cientistas sociais, até bem pouco tempo considerados “objetos” de
estudo, receptáculos de um conhecimento que não seria partilhado
em igualdade de condições com o “outro”, informante
privilegiado do pesquisador profissional, este, ávido em recolher
os “dados” que pudessem tornar mais conhecido as concepções
acerca do mundo construído por aquele, sua estrutura social,
religiosa, a manutenção de suas festas e afins, dedicaram-se a
construir seu conhecimento, sua sabedoria, no universo próprio da
religiosidade à qual foram iniciados, na maior parte das vezes
ocupando-se das inúmeras tarefas reservadas a eles dentro do
terreiro, considerando o grau de importância que é conferido ao
cargo ocupado. Um diminuto grupo de sacerdotes e sacerdotisas
postados nos ilês de algumas capitais brasileiras, principalmente
aqueles mais próximos dos grandes centros, conseguem conciliar
as atividades intramuros dos terreiros com aquelas voltadas para
o aperfeiçoamento das práticas sócio-religiosas pertinentes ao
conjunto de iniciação comum, pertencentes a mesma matriz.
Situação diferente pode ser constatada junto aos terreiros que
possuem suas casas nas cidades periféricas aos grandes centros
urbanos. Por haver maior dificuldade para a locomoção, além da
escassa comunicação destes com outros sacerdotes e sacerdotisas,
pela do acesso à comunicação pela internet, criando assim redes
construídas com a finalidade de amplificar a interlocução,
constatamos que este grupo de sacerdotes e sacerdotisas pouco
usufruem dos canais de comunicação hoje existentes.
As duas situações apresentadas nas quais encontram-se inseridos
sacerdotes e sacerdotisas, povo de santo, evidenciam a relação
abismal estabelecida no universo da religião afro-brasileira, cuja
implicação terá seu rebatimento nas dificuldades relacionadas
com a capacidade de mobilização visando a resolução de
problemas comuns, principalmente aqueles voltados para a
relação externa entre o terreiro e a sociedade abrangente. Optei
aqui por partir do geral para chegar ao particular no enfoque da
relação existente entre os terreiros da religiosidade afro-brasileira
e as instituições da sociedade civil brasileira.
60
ACHAB
Dentre os problemas visualizados entre os terreiros e a sociedade
abrangente podemos destacar aquele que tem colocado sacerdotes “A perspectiva dualista, a interpretação bíblica que hipertrofia a
e sacerdotisas, povo de santo numa situação de superação relação agonística entre Deus e diabo e a defesa contumaz do
permanente: nos últimos anos o Brasil tem presenciado o resgate e da difusão de crenças e práticas do cristianismo
recrudescimento das ações de acirramento proporcionadas pelas primitivo, em especial das práticas mágicas e taumatúrgicas
religiões neopentecostais contra aquelas de matriz africana ou identificadas com o ministério terreno de Cristo, constituem as
afro-brasileiras. Conforme afirma SILVA “os casos de principais razões e justificativas pentecostais para: 1) disseminar
intolerância, antes apenas episódicos e sem grandes a crença na ação e no poder maléficos do diabo e dos demônios
repercussões, hoje se avolumaram e saíram da esfera das sobre a humanidade; 2) realizar rituais exorcistas; 3) evangelizar
relações cotidianas menos visíveis para ganhar visibilidade tendo como foco a missão concomitantemente conversionista e
pública, conforme atestam as freqüentes notícias de jornais que salvacionista e de combate às forças demoníacas e a seus agentes
os registram em inúmeros pontos do Brasil.” (2007: 10). A e representantes terrenos. Em suas doutrinas, tais missões são
visibilidade pública das ações belicosas contra a religião afro- indissociáveis”. (2007: 129-130).
brasileira tem instaurado um clima de intranqüilidade, medo,
desespero da parte de vários sacerdotes e sacerdotisas que já Assim a justificativa que oferece sentido aos ataques
foram (ou serão) alvo das atrocidades cometidas por conta proporcionados pelas religiões neopentecostais, cujo fundamento
daqueles que almejam tão somente a existência de uma única encontra-se estruturado em teorias facilmente apreendidas pelos
maneira do homem relacionar-se
fiéis freqüentadores das igrejas e
com o sagrado, evitando por
locais de culto, também vão
todos os lados o surgimento do
deslocar-se para um terreno
contraditório. A justificativa que
propício em se tratando da
oferece sentido aos ataques
sociedade civil brasileira. Cabe
efetuados
pelas
religiões
certamente uma explicação a
neopentecostais estão baseadas
esta afirmação. Por mais que
numa “...teologia assentada na
estejamos hoje vivendo sob os
idéia de que a causa de grande
ventos da “democracia”, sem a
parte dos males deste mundo
presença coercitiva dos regimes
pode ser atribuída à presença do
totalitários, quer do ponto de
demônio, que geralmente é
vista político e sócio-cultural,
associado aos deuses de outras
ainda guardamos resquícios do
denominações religiosas. (...) o
período colonial que deu
panteão
afro-brasileiro
é
sustentação a formação da
especialmente
alvo
deste Filhas de santo da comunidade-terreiro Axé Abassá de Ogun participando da sociedade brasileira. No interior
Caminhada Contra a Intolerância Religiosa na cidade de Salvador/BA. A Tarde da construção erguida sob a
ataque...”. (idem, pg. 11).
Os argumentos que servem on line. Fernando Vivas, 2009.
égide da separação, do
como base de sustentação para justificar a postura intolerante das preconceito, do racismo, da dor, da morte, reservando ao
religiões neopentecostais contra a religiosidade afro-brasileira em indivíduo social pertencente ao conjunto da escravaria aqui
nosso país, configuram-se como sendo a reedição contemporânea presente a condição periférica de “coisa”, aquela condição de uso
das concepções de mundo oriundas de um imaginário social com a qual os senhores de engenho, os administradores, a polícia
construído a partir de elementos separatistas, xenófobos, os quais foram acostumados a tratar o contingente de trabalhadores nas
viam as manifestações culturais advindas dos negros e negras no fazendas e arredores das cidades na colônia. O termo “coisa” aqui
interior do sistema colonial como aberrações construídas por uma utilizado aproxima-se da condição humana degradante ocupada
gente destituída da racionalidade e do comportamento sócio- pelos africanos trazidos ao Brasil como escravos, diferentemente
cultural adequado, entregue as mais perversas manifestações da do termo utilizado por Durkheim quando define o que vem a ser
animalidade, inclusive do ponto de vista religioso. Estas o fato social. Embora salvaguardadas as devidas diferenças entre
maneiras de conceber o “outro” sob a ótica na qual o olhar os termos mencionados, existe alguma analogia que poderá ser
encontra-se focado, foram determinantes para que ao longo da traçada entre eles. Para ele uma coisa é definida como
construção da história e cultura brasileiras estas matrizes
pudessem ser persistentemente usadas, a fim de justificar a “...todo objeto do conhecimento que não é naturalmente
negatividade dos negros no Brasil. O sociólogo Ricardo Mariano penetrável à inteligência, tudo aquilo de que não podemos fazer
ao falar sobre a demonização dos cultos afro-brasileiros evidencia uma noção adequada por um simples procedimento de análise
argumentos que nos faz compreender as principais razões das mental, tudo o que o espírito não pode chegar a compreender a
construções teóricas e práticas que dão sustentação as ações menos que saia de si mesmo, por meio de observações e
daqueles considerados fiéis das igrejas pentecostais:
experimentações, passando progressivamente das caracteres
61
ACHAB
mais exteriores e mais imediatamente acessíveis aos menos
visíveis e aos mais profundos”. (1995: XVII).
receberá os serviços essenciais gerados pela sociedade (educação,
saúde, trabalho, lazer). Cabe frisar que tal processo não ocorre
sem o aparecimento de posições contrárias e favoráveis a sua
implementação, instaurando dessa forma o consenso com o
contraditório, condições necessárias para se repensar a práxis aqui
existente.
Os debates que começam a ser travados no interior da sociedade
brasileira impõem novos olhares e responsabilidades na esfera
pública, visando absorver as demandas que são apresentadas
pelos movimentos sociais em geral e pelo movimento negro em
particular. Dentre estas demandas podemos citar a Rede Nacional
de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, instância de articulação
da sociedade civil que envolve adeptos da religiosidade afrobrasileira, gestores e profissionais de saúde, integrantes de
organizações não-governamentais, pesquisadores e lideranças do
movimento negro, que possuem o intuito de: a) lutar pelo direito
humano à saúde; b) valorizar e potencializar o saber dos terreiros
em relação à saúde; c) monitorar e intervir nas políticas públicas
de saúde, exercendo o controle social; d) combater o racismo, o
sexismo, a homofobia e todas as formas de intolerância; e)
legitimar as lideranças dos terreiros como detentores de saberes e
poderes para exigir das autoridades locais um atendimento de
qualidade, onde a cultura do terreiro seja reconhecida e
respeitada; f) estabelecer um canal de comunicação entre os
adeptos da tradição religiosa afro-brasileira, os gestores,
profissionais de saúde e os conselheiros de saúde. A Rede
Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde a partir de seus
objetivos propõe um diálogo profícuo com a esfera pública da
mesma forma que aprofunda a interlocução com a sociedade civil
organizada, demonstrando que o espaço do terreiro também é o
lócus privilegiado para a troca de saberes. Os conhecimentos
produzidos no interior do terreiro como aqueles descobertos a
partir do trabalho profissional de pesquisadores alocados no
interior dos órgãos de estado, relacionados com a saúde, muito
embora sejam provenientes de universos distintos, a partir de
concepções diferentes de mundo, operam a polifonia de seus
discursos e práticas, considerando que o(a) adepto(a) da
religiosidade afro-brasileira trafega em lógicas opostas, porém
pertencentes a mesma realidade social. É perfeitamente plausível
pensar o diálogo entre a saúde e as dinâmicas sócio-religiosas
encontradas nos terreiros de candomblé, tambor de mina,
umbanda e afins.
A partir desse contexto é fundamental conceber que “... ao reunir
numa só estrutura religião e saúde, a ser enfocada no interior das
comunidades-terreiro ultrapassa, e muito, a dimensão consciente
tanto da religião quanto da saúde para o bem-estar do ‘povo-desanto’; digamos que os atores, direta ou indiretamente,
envolvidos com este projeto encontram-se diante de processos
sócio-culturais, éticos, políticos, filosóficos, os quais
redimensionam o sentido coletivo e individual de suas existências
concretas (...)”. Estas interações “contribuem sobremaneira no
re-ordenamento dos elementos que envolvem questões referentes
à saúde e que secularmente permeiam todas as relações nos ilês6,
além de abrirem diversas possibilidades e caminhos a serem
Com o passar do tempo a sociedade brasileira assimilou o
tratamento inferiorizado dado ao escravo bem como ao seu
sucessor liberto, cujos predicativos da subalternidade
permaneceram incólumes, oferecendo a seus descendentes os
piores lugares na pirâmide do desenvolvimento social e cultural
(desenvolvimento visto pelos descendentes dos senhores de
engenho, sem considerar que o negro possuía nas diversas nações
africanas, um ethos cultural relevante cuja matriz disseminou-se
nos lugares onde sua mão, seu corpo, seu ritmo, sua
espiritualidade fez morada). Com maior ou menor empenho os
diversos governos que assumiram o controle do país, após a
proibição definitiva do tráfico negreiro, pressionados também em
maior ou menor grau pelo movimento social organizado (nele está
contido o movimento negro nacional), desenvolveram ações
paulatinas que pudessem minorar a condição degradante pela qual
passava a maioria dos negros e negras no Brasil. Numa tomada
panorâmica veremos os diversos estágios da sociedade brasileira
onde a discussão e, principalmente as ações, voltadas para a
inclusão do negro(a) na sociedade brasileira avançaram ou
retrocederam, expondo nosso encantamento e nossa desilusão
acerca da possibilidade de vislumbrarmos um novo país. No
contexto atual a sociedade brasileira é convidada a travar um sério
debate a respeito das relações étnico-raciais, colocando-as na
agenda nacional, muito embora setores conservadores da
sociedade brasileira não queiram enfrentá-lo. Este debate
proporcionará as condições objetivas para que a nação possa
pensar a inclusão de políticas públicas em todos os quadrantes da
vida ativa de seus cidadãos e cidadãs. Este debate vem sendo
travado com alguma dificuldade, a partir dos obstáculos
colocados pelos setores mencionados acima.
A sociedade brasileira já se encontrava acostumada a ver o
negro(a) em seu “devido lugar”, ocupando os espaços subalternos
na pirâmide social tal qual havia sido estabelecido pelas nações
detentoras do cobiçado papel de dirigir o processo civilizatório
[Elias]. As ações desenvolvidas pelos movimentos sociais em
geral e o movimento negro em particular alavancaram as
condições propícias para pressionar os gestores do estado
brasileiro a fim de que afirmassem publicamente a intenção de
erradicar o racismo, o preconceito das relações sociais aqui
existentes. Cabe frisar que a organização do movimento negro
ocorre desde os tempos coloniais, por intermédio dos quilombos,
da capoeira, das irmandades religiosas, etc. Delineava-se assim o
papel político/ideológico da organização negra em nosso país,
cujo aperfeiçoamento ganhará sua consolidação no século XXI
com a intervenção mais qualificada destes atores sociais nos
embates travados. As afirmações publicitadas a partir do
movimento negro e outros movimentos sociais ajudaram a
implementação em determinados locais (por exemplo, as
universidades públicas e estaduais) das políticas de ações
afirmativas ou políticas de inclusão positiva visando o ingresso de
jovens, homens, mulheres e crianças no interior do grupo que
62
ACHAB
trilhados pelos adeptos e adeptas das religiões de matriz africana, nas questões relacionadas à saúde e, conseqüentemente do
fortalecimento da autoconfiança, da auto-estima e do sentimento de pertença do povo-de-santo, possibilitando também o
reconhecimento do seu patrimônio imaterial, despertando o respeito devido a este segmento pelo sistema oficial de saúde e pela
sociedade em geral.” (PIRES/AQUINO, 2004: 8).
A partir do diálogo que deverá existir entre os órgãos que compõem a esfera pública e os altos sacerdotes, sacerdotisas, povo de santo
da religiosidade afro-brasileira, muito possivelmente estaremos assegurando a manutenção das bases de fundação da cultura brasileira,
esta devedora da contribuição oferecida pelas culturas indígena e africana. A interlocução entre estas esferas devem possibilitar novos
desafios surgidos dos dilemas a nós apresentados na trama social. Tal qual Exu, o orixá que comanda os princípios da comunicação e
da transformação, a organização do mundo deve acontecer através da fala, sendo a palavra proferida o elemento recriador das
dinâmicas sociais. A analogia entre a figura de Exu e a comunicação entre as comunidades-terreiro e a esfera pública devem legitimar
o universo da cultura brasileira, aceitando as contribuições valiosas da cultura indígena e negra em sua totalidade.
Note
*
Università Federale del Maranhão, membro do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros (NEAB), coordenador em exercício do Comitê de
Ética em Pesquisa da UFMA.
**
Traduzione del sommario a cura della redazione.
1. A expressão Middle Passage possui uso consagrado na historiografia de língua inglesa e designa o trecho mais longo – e de maior
sofrimento – da travessia do Atlântico realizada pelos navios negreiros (N. do R.) (pg. 38). [Si riferisce al momento decisivo
dell’attraversata quando, superata la metà del tragitto, il ritorno diventa più lungo e difficile della continuazione del viaggio. N.d.R].
2. O mesmo que a mãe zeladora dos orixás.
3. O mesmo que o pai zelador dos orixás.
4. Utiliza-se este termo para designar o poder de realização que move indivíduos, suas ações, as cerimônias religiosas. É a mistura de
elementos minerais, animais, e vegetal.
5. Palavra utilizada para designar casa.
6. Plurale di “ilê”, in lingua yorubá “casa”, quindi per estensione “casa di culto” [N.d. R.].
Bibliografia
BASTIDE Roger, Image du Nordeste mystique em noir et blanc. Paris, Ed. Pandora, 1978.
id.,.O Candomblé da Bahia: rito nagô. SP, Cia. das Letras, 2001.
DURKHEIM Émile, As Regras do Método Sociológico. SP, Martins Fontes, 1995.
ELIAS Norbert, O Processo Civilizador. RJ, Jorge Zahar Editor, 2001.
GILROY Paul,O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. RJ, UCAM/Editora 34, 2001.
MARIANO Ricardo, Pentecostais em Ação: a demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner Gonçalves da. Intolerância
Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. SP, EDUSP, 2007.
MARCUS George E., O que vem (logo) depois do pós: o caso da etnografia. SP, EDUSP, Revista de Antropologia, 1994.
MAUSS Marcel, Sociologia e Antropologia. SP, Cosac & Naify, 2003.
PIRES Álvaro Roberto & AQUINO Hildenir Salomão, Avaliação do Projeto Ato-Ire: religiões afro-brasileiras em São Luís/MA. São
Luís, 2004.
RODRIGUES Nina, Os Africanos no Brasil. SP, Cia. Editora Nacional, 1976.
SILVA Vgner Gonçalves da, Intolerância Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. SP, EDUSP,
2007.
SODRÉ Muniz, O Terreiro e a Cidade: a forma social negro-brasileira. Petrópolis, Vozes, 1988.
63
ACHAB
Recensione :
Identità catodiche, rappresentazioni mediatiche di appartenenze
collettive. Pietro Vereni, Meltemi, Roma 2008
Nel panorama della recente bibliografia sui media si
distingue il testo di Piero Vereni. L’autore definisce il suo
lavoro in forma rapsodica, come «una serie di riflessioni di
impronta antropologica sul rapporto fra i media e l’identità
collettiva» (12). Non si tratta, in senso stretto, di un lavoro
di antropologia dei media, che «deve disinteressarsi al
messaggio in sé per ricostruire i percorsi produttivi e la
sua funzione di innesco per l’immaginazione come pratica
sociale» (ibid.) e nemmeno di un testo dedicato
all’etnografia, che pure costituisce «l’obiettivo della
ricerca» (ibid.). L’oggetto di riflessione dichiarato sono i
media, che «non esistono come struttura autonoma e
slegata dalla cultura. Il loro ruolo è mediare fra cultura
come esperienza vissuta e cultura come rappresentazione»
(17).
Rifacendosi in certa misura ad alcuni temi elaborati da
Stuart Hall, Vereni parla della dimensione attiva dello
spettatore che non si limita alla decodifica dei programmi,
ma si traduce anche anche «in pratiche sociali» (17), in
certo qual modo esterne alla funzione mediatica.
Ciò del resto già avveniva nel mondo di Madame Bovary,
il cui sentimento amoroso era «il prodotto delle letture
romantiche della protagonista, piene di sofferenze, dolore,
passioni ed effluvi di lacrime». (17) Anche nel nostro
mondo «ogni storia romantica che leggiamo e ogni soap
opera che guardiamo può incrementare le nostre reali
sperienze» (18). Superando l’ormai obsoleta concezione di
un universo mediatico autonomo e determinante per lo
spettatore, Vereni afferma: «Si tratta di due livelli di
esperienza fra i quali si dà uno scambio continuo». (18)
In questa prospettiva viene citato Ugo Fabietti, che in un
suo recdente saggio parla di antropologia come «studio di
una simultaneità di vissuti immaginati», difficilmente
riscontrabile per le società prive di scrittura (34), ma
facile ad attuarsi oggi. Infatti i mezzi elettronici risultano
efficacissimi in questo ambito, proprio in quanto sono in
grado di intensificare la contemporaneità, per cui «l’alter
ego non mi è mai dato in carne ed ossa, ma io so della sua
coesistenza con me». (34)
Partendo da questa base, l’autore rielabora in forma
significativa il discorso di Pierre Bourdieu relativo
all’habitus. Ogni classe detiene un capitale economico e
un capitale culturale, risultato del curriculum di studi
seguito dalle singole persone. La mobilità sociale non
modifica in toto gli elementi acquisiti in precedenza, che
sopravvivono, dando luogo ad una complessa
diversificazione fra appartenenza di classe, titoli
accademici conseguiti e stili di vita.
A queste considerazioni, ricavate dal grande sociologo
francese, Vereni aggiunge alcune significative glosse,
concernenti le variazioni di habitus legate alla fruizione
mediatica.
« Il gusto quindi può configurarsi non solo in base al titolo
di studio, o alla storia familiare, ma anche in base a ciò
che vediamo in TV» (61).
Nel testo viene citato Marx, quando afferma, ne
L’ideologia tedesca, «non senza una certa brutalità» (58),
che « l'uomo riesce a vedere solo in funzione della sua
borsa... Le classi popolari non hanno nessuna idea del
sistema di bisogni delle classi previlegiate» (58). Nel
nostro tempo però la situazione risulta in buona parte
cambiata, proprio a causa dei media, che portano alla
conoscenza dell’opinione pubblica vari sistemi di bisogni,
o di valori.
Oggi le classi popolari hanno ben assimilato
l’immaginario borghese, del quale sono forse molto più
esperte dei borghesi stessi. (59-60)
In questa diffusione universale di concezioni del mondo
che una volta appartenevano a ristrette élites, Vereni
ravvisa ciò che definisce come «soapizzazione
dell’anima». Usando la normale terminologia degli
sceneggiatori, egli parla dei programmi high concept,
caratterizzati dall’azione, che tendono ad essere
soppiantati dai programmi low concept, caratterizzati da
personaggi che agiscono poco, in quanto sono
essenzialmente alla ricerca di una loro collocazione
sociale e affettiva. (62)
Questa dimensione, per il nostro autore, è facilmente
attribuibile anche alle trasmissioni di Maurizio Costanzo e
Maria De Filippi. In sostanza questa coppia di autori
«democratizza la crisi borghese del soggetto» (65)
permettendo allo spettatore medio di conoscerla e di
viverla, ovviamente nel disprezzo dei ceti colti, che «si
vedono svelare sotto il naso il trucco fondativo della loro
identità». (66)
Non a caso, con sottile ironia Vereni osserva che questo
passaggio dalle narrazioni high a quelle low era già
avvenuto ai tempi di Fichte (67). In questo ambito «Le
masse, attraverso la televisione, fanno in un paio d'ore un
corso accelerato sulla filosofia del soggetto da Hegel a
Heidegger». (66)
Le categorie enunciate sino a qui vengono poi verificate
64
ACHAB
attraverso due indagini empiriche alle quali il nostro
autore dedica gli ultimi due capitoli del testo.
Nel primo excursus, Vereni prende in esame l’immagine
degli albanesi che veniva diffusa dai media italiani intorno
al 1997. Qui assistiamo a una vera e propria campagna
denigratoria messa in atto dai nostri mezzi di
comunicazione, secondo i quali la ferocia degli albanesi
era in pesante contrasto con la bontà italiana. Si parlava di
«Migliaia di prostitute, ragazzini ai semafori schiavizzati
dai loro zii... consuetudine etnica al saccheggio... lotta per
il controllo del territorio secondo i costumi africani»
(sic!). (81)
A partire dal 2002 Kledi Kadiu inizia a comparire nelle
trasmissioni di Maria De Filippi. Si tratta di un giovane
serio, di buona famiglia, fornito di un diploma rilasciato
dall’accademia di danza di Tirana. Per un verso egli
esprime compiutamente i comportamenti scrupolosi e
professionali di una certa borghesia albanese, peraltro la
sua presenza nella trasmissione gli permette di affermarsi
come sex symbol e come uomo di successo per le giovani
spettatrici del programma. A partire dalla comparsa di
Kledi in televisione, l’immagine degli albanesi in Italia
risulta sensibilmente cambiata, anche nei media cartacei,
in un processo in cui la fiction e le pratiche quotidiane del
nostro personaggio non si contrappongono staticamente,
ma interagiscono dialetticamente. (106)
Nel secondo excursus, dedicato all’immagine del sud,
Vereni ci spiega che la televisione riproduce elementi della
realtà meridionale, mentre va ad un tempo ricordato che
certi suoi programmi rappresentano «una delle forme di
produzione del sud». (150)
della situazione» (150) (Testimonianza di un giovane di
Corigliano Calabro, recentemente raccolta da Vereni).
Tornando al libro, il discorso si snoda secondo una precisa
linea direttrice, mostrandoci la televisione ad un tempo
come prodotto storico e come «agente di storia», capace di
modificare l’habitus dello spettatore medio, sia pure nella
sua stratificazione. Nello svolgersi dell’argomentazione si
verifica «quanto della cronaca passi nella fiction... e
quanto della fiction passi negli usi e nelle pratiche
quotidiane». (150)
Sorprende peraltro un certo pessimismo di fondo
dichiarato dall’autore, in base al quale l’emittenza
sembrerebbe potersi muovere esclusivamente in base a
canoni a carattere sostanzialmente conservatore. «Le
domande non sono più "come arrivo a fine mese?", ma
"Chi sono io veramente?". Qui non rimane spazio per
progettare. La borghesia è in crisi, ma anche i subalterni
non stanno meglio. Vorrà dire che ci faremo sopra un bel
talk show». (68) Ben altrimenti Benjamin e Brecht si erano
espressi, già negli anni venti, sulle valenze potenzialmente
positive dei media. Questo discorso potrebbe meritare oggi
un approfondimento, soprattutto tenendo conto del fatto
che l’abbattimento dei costi legato al digitale modifica di
molto il quadro dell’industria culturale, aprendo
possibilità di accesso a soggetti sociali che risultavano
esclusi fino a qualche anno fa. Questo aspetto, forse un po’
opinabile del nostro testo, non toglie tuttavia nulla alla
serietà del lavoro nel suo insieme e all’originalità delle
tesi sostenute, che trascendono l’ambito inizialmente
dichiarato di una semplice «serie di riflessioni di impronta
antropologica».
Non va trascurato il fatto che in questo testo troviamo una
compiuta rassegna di tutti i saggi più importanti relativi
all’antropologia dei media, utile guida per chi inizia a
studiare questo argomento.
«Ogni volta che torno a Corigliano Calabro, non posso
farfe a meno di pensare al porto e alle pescherie, che sono
punti di approdo e di distribuzione della droga... a volte mi
par di rivivere alcune scene da film stile Damiano
Damiani, in cui le comparse impersonano le folle
spaventate e quasi fiancheggiatrici dei sicari, che corrono
in sella alla moto, dopo aver appena ucciso il disgraziato
di Gianni Trimarchi
65
ACHAB
Recensione:
Il contemporaneo. Giorgio Agamben, Nottetempo, 2008
…io sono all’antica, mi piace il moderno
Carlo Rocchi, muratore di Buriano
In mezzo a loro, ma non dei loro…Ectoplasmi del contemporaneo
Filosofia per antropologi
La filosofia occidentale, anche quando esplori o dichiari
apertamente la propria impotenza, anche quando prenda atto dei
propri limiti e del proprio scacco gnoseologico, si offre sempre e
comunque come una visione totalitaria, il prodotto di un pensiero
che ha l’ambizione titanica di rintracciare un senso e una ragione
per tutto quello che c’è, non fosse altro che per dichiararne
l’inesistenza.
In questo senso rappresenta insieme l’apoteosi e la quintessenza
dell’etnocentrismo: una ideologia definitiva che esclude ogni altra
possibile visione. Più ancora della religione, la quale almeno
ammette sincretismi e persistenze ontologiche tra fedi diverse, e
tollera una qualche misura di ecumenismo trascendentale, o
teleologico, e persino una possibile comunità fenomenologica.
E’ per questo forse che sin dall’inizio un dio geloso ha confuso le
lingue dei filosofi, producendo nei secoli quella stupefacente
gemmazione di visioni e architetture di pensiero che ha reso le
nostre vite più ricche e inquiete, senza peraltro raggiungere uno
solo dei suoi scopi.
E’ questa aura sapienziale della filosofia che occulta – ai filosofi in
primis – la sua natura essenziale di prodotto culturale determinato,
di sublimato etnocentrico per eccellenza.
Partendo da una consapevolezza del genere un antropologo
potrebbe fare sua la filosofia come oggetto e caso di studio
(ammesso che riesca a venire a patti con la sua tradizionale
sensazione di minorità nei confronti di quella sofisticata disciplina,
e smetta di risentire delle proprie umili origini epistemiche).
Da questo particolare punto di osservazione, allora, la filosofia
occidentale potrebbe essere studiata, alternativamente, come un
sistema complesso di credenze, un generatore di miti fondativi, un
linguaggio per la narrazione delle origini, una retorica formulare,
una società segreta, uno strumento di propaganda politica, un
preparato etnoiatrico per la cura della depressione e dell’ansia, o un
po’ di tutto questo insieme.
Il testo che segue nasce come reazione allo scritto di un filosofo
[Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo
2008], e anche se non ne offre propriamente una lettura
antropologica, cerca di assumere quel punto di osservazione di cui
66
si diceva, e di liberare - per come può - una riflessione indipendente
sul modo in cui nello spazio culturale dell’occidente contemporaneo vengono confezionati gli interrogativi e le risposte della
filosofia, e su come gli stili argomentativi e la retorica siano
delegati talvolta - in mancanza di meglio - a compensare il difetto
di introspezione e perspicuità del pensiero.
La domanda è un debito
Che cos’è il contemporaneo? Facile a dirsi così, come se si trattasse
di riempire un questionario, nel tentativo di arrivare a quella
definizione vera, autentica, che sta da qualche parte, autonoma e
conclusiva, e che qualcuno già possiede.
Come se si trattasse di sfogliare un dizionario: qui stanno tutte le
risposte, avanti con le domande! Come se il mondo là fuori
contenesse già da sempre tutto quello che c’è, e tutto quello che c’è
da sapere - incurante di noi e delle nostre domande - , e come se
l’unica cosa da fare consistesse nel rintracciare quello che c’è da
sapere in quella confusione di lingue, in quel viluppo di dati nel
quale il mondo ci è stato consegnato da un qualche trickster o
demone dispettoso.
C’è qualcosa che non convince, in questa rassicurante
rappresentazione, qualcosa di poco rassicurante. E se pure siamo in
cuor nostro convinti che non c’è altro modo di procedere che
questo, ogni volta di nuovo ci assale la sensazione che questo
processo proceda avvolgendosi su sé stesso, ritornando sempre sui
propri passi.
Ci interessa allora sapere cos’è il contemporaneo. Ma prima ancora
ci interessa conoscere perché questo ci interessi: la domanda sul
contemporaneo, così come ogni domanda, ne racchiude
inevitabilmente un’altra, dalla quale è a sua volta racchiusa, una
metadomanda, una domanda sulla domanda.
La domanda è un debito, il riconoscimento di un debito, di una
insolvenza nei confronti della realtà che chiede di essere saldata. E
insieme la domanda è un desiderio, la pressione di un desiderio che
aspira alla soddisfazione, ad una condizione di completezza dove
collocare il proprio agio. La tensione verso uno stato temporaneo di
quiete che risolve uno stato temporaneo di inquietudine.
Ma di dove venga, e dove vada poi a finire non lo sappiamo, se pure
viene da qualche parte, e sia diretta da qualche parte. Se c’è
qualcosa oltre l’inquietudine inesausta in nome della quale si
esprime ed insieme interroga sé stessa.
ACHAB
fatto di formulare in questo modo la mia domanda, dò per scontato
che io, o il mio interlocutore, possediamo già, già ci rifacciamo ad
una definizione di contemporaneo, ad una percezione pur
approssimativa della sua natura, estensione, significato, o quello
che sia, rispetto alla quale mi propongo in alternativa di produrre un
sistema, una regolarità, un algoritmo semantico da utilizzare in tutte
le circostanze opportune, uno scenario di verità, insomma, che sia
sottratto alle contraddizioni ed alle ambiguità, alle improprietà, alla
inattualità di quella primitiva definizione.
Nel pormi quella domanda, chiamo allora a raccolta tutte le
definizioni, le percezioni, le accezioni in cui quel termine ha avuto
per me, nel tempo, una legalità semantica, una comprensibilità ed
un uso pratico, tutte le versioni che ho ritenuto accettabili ed
utilizzabili, o che altri come me hanno ritenuto accettabili ed
utilizzabili e in base alle quali ho intrattenuto con i miei
interlocutori diretti o indiretti una discussione, una relazione che
presumeva una preventiva condivisione di significato.
Lo scopo è fare una ricognizione di quel particolare campo
semantico, esplorarne i confini (se è un campo, avrà pure dei
confini), ricondurre a sistema, ad un sistema intelligibile e
ripetibile, comunicabile, i suoi contenuti e le sue contraddizioni, più
o meno come fa un vocabolario.
Lo scopo è quello di poter infine asserire fondatamente, alla prima
occasione in cui dovessi assistere all’entrata in scena di qualcosa di
contemporaneo: “ecco, passa il contemporaneo” (ma il
contemporaneo può davvero passare?).
[Purtroppo il vecchio Quine, che la sapeva più lunga di tutti, ci
aveva già messo in guardia per tempo contro le illusioni di un
simile modo di procedere, anche se, come tutti i buoni filosofi, ci
ha cacciato in una buca dalla quale neanche lui è riuscito a tirarci
fuori].
Vuoti e pieni
La domanda, come ogni altro evento mentale, come in fondo
ognuna delle cose della nostra vita a cui diamo un valore ed alle
quali ci aspetteremmo di riconoscere un senso, è un mistero
assoluto.
Benché volta per volta ci illudiamo di congelarla in una qualche
definizione, di catturarla all’interno di un vocabolario, è la sua
natura più propria che ogni volta ci sfugge. Il fatto di averle dato
un nome l’ha resa con ciò stesso un oggetto come tutti gli altri del
nostro linguaggio, di quella messa in scena della realtà che il
linguaggio ci offre, e ci impedisce di riconoscere al contrario che la
domanda non è affatto un oggetto, una qualità ontologica, il
connotato di un paesaggio mentale rappresentabile
geograficamente, una categoria dell’essere, e neppure un tropo
della retorica argomentativa, o il membro riconoscibile di un
insieme di oggetti simili che possono essere all’occorrenza tirati giù
da uno scaffale e messi in opera.
Un’ipoteca ottimistica sulla verità e realtà del mondo, come se ciò
che non è dato conoscere sia comunque dato di per sé come entità
conoscibile, oggetto potenzialmente descrivibile, spazio definito da
riempire.
La domanda nasce insieme con la sua risposta possibile, un
dualismo inscindibile; è un vuoto al quale deve corrispondere un
pieno, ma un vuoto nel senso dello stampo, un vuoto
predeterminato, che deve essere riempito nella forma e secondo le
regole che quello stampo fornisce.
Che cosa è il contemporaneo?
Prendiamo allora la nostra domanda di oggi, la domanda che si (ci)
pone Giorgio Agamben: “che cosa è il contemporaneo?”
Ora, non ci si chiede di definire un termine assolutamente
sconosciuto, come si fa con chi parla una lingua diversa dalla
nostra, al quale si potrebbe chiedere che cosa è ‘voor’, o ‘drast’, o
‘baxbr’. Cose del genere.
La domanda completa suona invece così: che cosa veramente è
quello che noi chiamiamo ‘contemporaneo’, che cosa vogliamo
significare con questa parola? Riconosciamo così sin dall’inizio un
altro dualismo: la definizione vera (che deve pur esserci) da una
parte, e quella corrente, quella che si presume si abbia in mente o
che venga alla mente all’udirne il suono. Questo approccio già
implica una petizione di verità (ed una istanza ontologica) che,
come sappiamo, in filosofia sono tutt’altro che concetti pacifici, e
insieme una pretesa maieutica: c’è una definizione errata di
contemporaneo, o incompleta, o insoddisfacente, ed una vera, una
buona che in qualche modo dovrà saltar fuori nel corso dell’esame.
Eppure è proprio l’esistenza di quella definizione errata che rende
possibile la domanda. Perchè è a partire da quella che si è potuto
allestire lo scenario: non uno degli innumerevoli, possibili tentativi
frustrati di sciogliere un enigma preesistente ed autonomo, ma la
condizione stessa e lo sfondo ontologico contro il quale soltanto è
possibile praticare l’esercizio del dubbio. Una ipoteca, in fondo,
sulla definizione vera, sulla sua architettura possibile e sulla libertà
e praticabilità dei suoi ambiti cognitivi.
Se (mi) chiedo quindi che cosa sia il contemporaneo, proprio per il
Vocabolari
E’ il modello del vocabolario quello che inevitabilmente si impone
in questo caso, il modello cioè di una macchina che sforna
significati a fronte di domande, appunto, del tipo “cos’è….?”. E’ un
modello che veicola una ingannevole sensazione di stabilità e
corrispondenza, di sazietà cognitiva: i nostri vocabolari possono
essere imperfetti, ma funzionano. Nessuno ci impedisce di
immaginare allora un vocabolario perfetto, che contenga tutte le
domande e provveda tutte le risposte.
Alla voce ‘contemporaneo’ ci aspettiamo allora di trovare ogni
possibile, pensabile, immaginabile accezione. Alcune di queste ci
potranno essere utili, altre avranno senso solo in contesti che a noi
non interessano, altre risponderanno, speriamo, alla nostra ansia di
sapere.
Da un punto di vista strettamente etimologico, la paroletta è
assolutamente innocua: “contemporaneo” implica essenzialmente
un’idea di sincronicità.
Nella sua forma sostantivata ha lo scopo, genericamente, di
alludere ad una entità ed un contesto insieme culturale e temporale,
e, pur essendo usata contrastivamente all’interno dello stesso
ambito semantico di definizioni del tipo di ‘moderno’, ‘antico’,
‘postmoderno’, ‘classico’, e simili, ne è separata da un sostanziale
67
ACHAB
discrimine concettuale e ontologico. Le prime infatti fanno
riferimento tutte ad un determinato, convenzionale arco di tempo,
un dominio cronologico relativo e presumibilmente omogeneo
quanto a tratti caratteristici il cui senso è definito e rappresentabile
esclusivamente nel suo rapporto con ciascuna delle altre.
Al contrario, il contemporaneo o è sempre tale di per sé, o non lo è
affatto. Ciò che era contemporaneo un momento fa cessa di esserlo
ora, sostituito da un contemporaneo altrettanto effimero e
transitorio. L’essenza del contemporaneo è per definizione
l’assenza di tempo, una condizione di immediatezza e simultaneità,
una natura di punto geometrico lungo la retta del tempo (o la
circonferenza, o la spirale, o quello che sia), privo di dimensioni.
Ovviamente - inevitabilmente - nell’uso corrente, e anche in ambito
filosofico, l’accezione implica una sia pur minima
temporizzazione, l’individuazione di una misura pur breve in base
alla quale sia possibile mettere in opera una distinzione significante
all’interno di un sistema classificatorio.
Anche così normalizzato, tuttavia, il contemporaneo conserva
intatta la propria intrattabilità semantica, e la sua discontinuità
ontologica con ogni altra possibile determinazione temporale.
Il moderno, l’antico, il postmoderno, ecc., sono individuati e
discriminati per tipologie, per ambiti di classificazione, per
connotati salienti: la loro identità si produce per mezzo di una
selezione. Il contemporaneo, al contrario, è appunto, né più né
meno, tutto quello che c’è ora, un ‘ora’ che contiene e metabolizza
in sé anche tutte le idee del tempo possibili ora, tutte le sue
pensabili determinazioni, percezioni e sopravvivenze.
Per questo è così difficile definirlo. Per questo è così facile
definirlo.
Valori, ectoplasmi
Vivere nel contemporaneo, essere contemporanei, è quindi un
valore.
Per questo è essenziale sapere che cosa sia il contemporaneo,
perché altrimenti c’è il rischio che qualcuno si illuda di vivere nel
contemporaneo, mentre vive invece in un altro tempo. E vivere in
un altro tempo è – come dice il senso comune, ma anche Agamben,
espressamente – oltremodo deleterio, ed è soprattutto una stolida
illusione nostalgica caratteristica di soggetti mediocri e poco
sensibili.
Anche se siamo tutti - almeno cronologicamente, per definizione contemporanei, è però vero che ce ne sono alcuni più
contemporanei di altri, che si accorgono o si studiano di essere
autenticamente contemporanei, laddove gli altri, poveretti, solo si
illudono di esserlo, mentre sono invece degli sciocchi nostalgici,
oppure gente che aderisce troppo adesivamente al proprio tempo, e
questo non è bene, come ci fa notare Agamben.
C’è un valore, allora, da salvaguardare, una autenticità da
presidiare, e chi meglio di un filosofo può incaricarsi di un tale
compito? Chi meglio di un filosofo contemporaneo, almeno, cioè di
quel particolare tipo di professionista che nel nostro mondo
contemporaneo è chiamato a produrre per mestiere una riflessione
tecnica – dalla quale ricava i propri mezzi di sussistenza – il cui uso
e consumo è riservato ad altri filosofi (che peraltro generalmente
non si trovano affatto d’accordo con lui), a studenti che devono
giustificare la loro presenza nelle università, e a un pubblico
platonico e genericamente colto che ama ascoltare i buoni
ragionamenti, senza per questo sentirsi tenuto a conformare ad essi
le proprie pratiche di vita (quando anche fosse possibile o
consigliato).
Il fatto è che il filosofo, non essendo specialista di niente in
particolare, è costretto ad assolvere a questo terribile incarico, per
così dire, ‘a corpo’, vale a dire rappresentando(si) il contemporaneo
non nelle sue (o in una delle sue) infinite parcelle, nicchie ed atomi
culturali, non nelle percezioni e nei modi di vita di una quantità di
uomini anche sorprendentemente diversi tra loro e da lui, ma come
un tutto unico, una entità omogenea di un qualche genere, di cui si
debba in qualche modo restituire ‘lo spirito’.
Eccolo lì di nuovo, allora, ‘lo spirito’, il flogisto universale a cui
ricorrere in ultima istanza, quando niente altro ha funzionato, che ci
attende al varco sornione come sempre, a ricordarci quanta poca
strada abbiamo fatto da Talete ad oggi.
‘Lo spirito del tempo’, di questo infine si tratta, di qualsiasi cosa si
tratti.
Il filosofo, in un certo senso, non è che uno spiritista, un evocatore
di ectoplasmi con i quali cerca di dare un senso all’invisibile della
nostra esistenza.
Appartenere
Con il termine ‘contemporaneo’ si viene così a circoscrivere una
estensione semantica paradossale ma pur sempre riconoscibile: è
contemporaneo
ciò
che
appartiene
essenzialmente,
ontologicamente al tempo presente, alle circostanze ed alla
congiuntura in cui ci troviamo a vivere. Dove ‘tempo presente’ a
sua volta è il nome collettivo che usiamo convenzionalmente per
indicare il contesto cronologico/storico/culturale/esperienziale
della nostra esistenza, quello nel quale – come dice la stucchevole
metafora – siamo gettati.
Da questo procede una prima fondamentale conseguenza: se infatti
il nostro essere quello che siamo è funzione dell’essere nel nostro
tempo, dell’appartenere autenticamente al nostro tempo [benché il
significato di queste abusate espressioni sia tutt’altro che chiaro],
una tale corrispondenza ed una tale autenticità assumono la statuto
di valore, cioè di ambito esemplare e desiderabile di vita, di
esperienza e di identità, di datore ontologico di senso.
Si capisce allora quale sia la posta in gioco: definire
appropriatamente il contemporaneo significa riconoscere
appropriatamente il nostro posto nel mondo, quale sia il senso della
nostra vita. Due cose a cui, pare, gli umani annettono una capitale
importanza, per ragioni sconosciute.
Odiare il proprio tempo
Nietzsche, ci ricorda Agamben, aveva ben chiaro quale fosse lo
spirito del suo tempo, del tempo di cui lui era contemporaneo. Era
un uomo, sempre per dirla con Agamben, che sapeva ‘fare i conti
con il suo tempo’, ‘prendere posizione rispetto al presente’ [ancora
68
ACHAB
metafore, naturalmente: tutto il discorso sul contemporaneo (e sul
tempo) è infestato di metafore che suppliscono come possono a
quella profondità cui il pensiero non è in condizione di attingere].
Quel tempo era per lui qualcosa di intollerabile e insostenibile,
verso cui nutriva una profonda avversione. La fonte di una
sofferenza tragica e malata che segnò la sua vita e la fine della sua
vita. Un inferno di cecità e follia che rifiuta il riscatto che lui gli
propone e lo condanna a rimanere escluso dal consesso dei suoi
contemporanei.
Sfidando orgogliosamente la semantica negativa delle parole
(inattuale, intempestivo) Nietzsche rivendica il suo essere fuori dal
suo tempo, oltre il suo tempo.
Come scrive ancora Agamben: “un uomo intelligente può odiare il
suo tempo, ma sa in ogni caso di appartenergli irrevocabilmente, sa
di non poter sfuggire al suo tempo”.
Nietzsche odiava il suo tempo, forse sapeva pure di appartenergli
irrevocabilmente, ma tutta la sua vita è stata segnata dalla volontà
di sfuggirvi. Il suo delirio finale, la sua pretesa terminale di
onnipotenza ci restituiscono un uomo che avrebbe voluto che fosse
il suo tempo ad aderire a lui, ad appartenergli irrevocabilmente.
Come che si voglia valutare l’originalità del pensiero e
dell’esperienza di vita di Nietzsche, l’apporto unico e straordinario
della sua riflessione alla consapevolezza del contemporaneo - o
meglio, al rovello tragico e irrisolto del contemporaneo - , la sua
lotta inattuale contro il proprio tempo lo accomuna invece
paradigmaticamente alla vasta schiera di pensatori che hanno
sofferto dell’incomprensione e dell’ostracismo della comunità a cui
appartenevano e dalla quale si attendevano al contrario
riconoscimenti ed onori.
E’ questo rifiuto, l’offesa recata da questo rifiuto, che lo porta a
percepire la contemporaneità essenzialmente come disvalore,
perché essa annette valore (‘va giustamente orgogliosa’) a cose che
sono ‘un male’, ‘un inconveniente’ e ‘un difetto’.
C’è quindi un conflitto di valori tra la follia del contemporaneo e la
follia del filosofo. E dato che il valore, aristotelicamente, non può
coesistere con il proprio opposto, né ammettere alternative, uno dei
due deve trovarsi inevitabilmente nell’errore.
La missione di cui si investe filosofo, allora, che se lo confessi o
meno, è quella di convincere il suo tempo dell’errore in cui vive, o
in subordine, di vivere per sé stesso nella verità, rifiutandosi
all’errore del mondo che gli è contemporaneo.
Come che sia, c’è un percorso da fare dall’errore alla verità, benché
nessun filosofo contemporaneo sia disposto a dichiararlo così
crudamente (né con la stessa determinazione di Nietzsche),
soprattutto dopo Wittgenstein.
profondità di pensiero, ma si risolve poi interamente sulla
superficie di un linguaggio giocato su più registri (la poesia, la
fisiologia, l’astrofisica), a tratti perversamente cavilloso e
pesantemente evocativo:
“Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo
colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue
pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma proprio per
questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli
è capace più degli altri di percepire ed afferrare il suo tempo… La
contemporaneità è una singolare relazione con il proprio tempo, che
aderisce ad esso ed insieme ne prende le distanze; più precisamente
essa è quella relazione con il tempo che aderisce ad esso attraverso
una sfasatura e un anacronismo, Coloro che coincidono troppo
pienamente con l’epoca, che combaciano in ogni punto
perfettamente con essa, non sono contemporanei perché, proprio
per questo, non riescono a vederla, non possono tenere fisso la
sguardo su di essa”.
Questo notevole brano di prosa contemporanea si segnala per
l’(ab)uso fastoso di metafore spaziali, al quale è sottesa per contro
una dialettica alquanto più elementare di distanza/prossimità.
D’altra parte - a dispetto della sicurezza con cui vengono formulate,
come se si trattasse di pure constatazioni di fatto – ciascuna di esse
inviluppa un campo semantico effusivo a cui è difficile dare un
senso compiuto: che cosa significa davvero per esempio [in difetto
di una preventiva e condivisa definizione di ‘tempo’ in questo
contesto] ‘appartenere al proprio tempo’, ‘adeguarsi alle pretese del
proprio tempo’, ‘coincidere perfettamente (‘pienamente’ e
addirittura ‘troppo pienamente’), ‘combaciare in ogni punto
perfettamente’,‘percepire ed afferrare il proprio tempo’, ‘tenere
fisso lo sguardo sull’epoca’ e, all’opposto, ‘prendere le distanze’,
‘aderire attraverso una sfasatura ed un anacronismo’?
Per contro, alla vaghezza del riferimento si accompagna una
perorazione di valore alquanto apodittica (e invero un po’
fastidiosa).
Ridotto all’osso questo ragionamento può essere riassunto nello
stupefacente precetto in base al quale si può aderire perfettamente
al proprio tempo (qualunque cosa si intenda con questo) solo in
quanto non vi si aderisca perfettamente.
Agamben ci chiede cioè di accettare lo stampo della domanda e ci
fornisce una risposta che non combacia, che non corrisponde, fino
all’estremo paradosso: è contemporaneo ciò che non è
contemporaneo, è autenticamente contemporaneo soltanto chi
propriamente non lo è.
Ora, è difficile sfuggire alla sensazione che tutto sia stato risolto
infine in un elegante gioco di parole, a dispetto del rarefatto tenore
retorico della perorazione.
Chi non ha testa abbia Agamben
Nella sostanza, la versione di Agamben non si discosta molto da
questo schema obbligato ed inevitabile. E cosa altro può fare un
filosofo, allora, quando non ha niente di nuovo da dire, se non
tentare di dirlo in un modo diverso, che faccia sembrare nuovi e
sorprendenti anche quei vecchi pensieri?
E’ per questo che sceglie di forzare il suo discorso sin dall’inizio su
una tonalità retorica molto particolare che allude ad una supposta
Un ginocchio paziente
Se lo volessimo riassumere con una parafrasi più accessibile, il
ragionamento non apparirebbe così trascendentale: la persona che
si adegua senza riflettere alle condizioni ed ai condizionamenti del
proprio tempo, che ne subisce impassibile le mode e le conformità,
69
ACHAB
che aderisce alla superficiale deriva collettiva dei costumi morali e
intellettuali, accetta di vivere in una dimensione di valore inferiore
a quella praticata del filosofo, il quale - non facendosi travolgere
dalla corrente inconsapevole del dover essere come tutti gli altri se ne distacca per osservarla più accuratamente e forse,
spassionatamente.
Appartenere autenticamente al proprio tempo significa allora
esperire un distacco etico ed intellettuale, che consente di non
cadere preda dell’ottundimento a cui va soggetto l’uomo comune,
una condizione da disprezzare e temere.
Agamben ci sollecita quindi a non vivere fuori dal nostro tempo
(che è scelta inane e onanista), ma insieme a non viverci troppo
dentro (che è un’opzione ottusa e superficiale).
Una via di mezzo, insomma: uno sfasamento, una adesione non
troppo aderente nella quale si estrinseca un modello di vita
intellettuale che si avvantaggia e trae piacere dalla sua appartenenza
intrinseca al proprio mondo, ma allo stesso tempo è capace di
distanziarsene per guadagnare un punto di vista più efficace: “in
mezzo a loro, ma non dei loro” come diceva il poeta “non ho
piegato un paziente ginocchio alle sue idolatrie, né gridato forte
nell’adorazione di un’eco, ecc. ecc.”.
Non è una grande novità, in fondo, né giustifica un tale efferato
dispendio di energie espressive e retoriche, a fronte di un così
magro carniere.
Agamben ci somministra infine una banale lezione di buon senso.
Ma chi ha bisogno di un filosofo per praticare il buon senso?
della neurofisiologia della visione, la quale a suo dire ci offrirebbe
un modello (o un’immagine) convincente di quel buio e della sua
natura. Come se il buio di cui parla le neurofisiologia e quello di cui
parla Agamben siano (in un senso qualsiasi) qualcosa di simile,
come se il buio neurofisiologico, invece che essere, appunto,
fisiologico, debba richiedere “una attività ed una abilità
particolare”, e come se, infine, la filosofia avesse bisogno di
affidarsi al frusto carisma cognitivo della scienza per legittimare le
proprie metafore.
Nel buio degli spazi siderali
Ma la neurofisiologia non è la sola scienza che può dirci qualcosa
di significativo sulla tenebra del contemporaneo. L’astrofisica, ad
esempio, ci insegna - come diligentemente fa notare ancora
Agamben - che quello che percepiamo come il buio del cielo altro
non è che la luce delle galassie che si allontanano da noi, e che
viaggia velocissima verso di noi senza tuttavia poterci raggiungere.
Nella visione di Agamben l’astrofisica ha il curioso e
controintuitivo compito di rimettere l’uomo al centro dell’universo:
non solo la luce delle galassie viaggia verso di noi (cosa già difficile
da mandare giù per un astrofisico), ma addirittura cerca di
raggiungerci: “percepire nel buio del presente questa luce che cerca
di raggiungerci e non può farlo, questo significa essere
contemporanei”.
Non che Agamben voglia dirci che è contemporaneo colui che
percepisce la luce delle galassie in fuga, né forse neppure lui
intende veramente che questa luce (o la luce buia del
contemporaneo, di cui è la metafora) ci stia cercando.
Il tentativo è piuttosto quello di praticare una alternativa retorica
originale tra il linguaggio della scienza e quello della poesia, che ci
metta in condizione di riaffermare un magistero qualsiasi della
filosofia (o anche semplicemente un ruolo, una giustificazione di
senso), in questo contesto contemporaneo nel quale essa non può
invece che registrare il suo fallimento e la sua impotenza.
Ma per Agamben il ricorso all’autorità della scienza è appena un
pretesto. E’ invece soprattutto alla forza emotiva della poesia che si
affida, alla persuasività di un argomentare prevalentemente effusivo
che riduca al minimo il dominio dei processi logici e razionali per
asserire una verità che riluce di per sé stessa, in ragione della sua
sola forza emozionale ed etica.
E’ questo il senso del riferimento alla poesia di Mandelstam, il
quale ci viene proposto senza meno come interprete autentico del
contemporaneo, come colui che in virtù dell’arcano potere
medianico della parola poetica ha penetrato perfettamente la natura
e l’essenza del nostro tempo: il poeta come vate e sensitivo,
evocatore del mondo invisibile, la poesia come via maestra per la
comprensione dell’essere.
Se non è possibile conoscere con la ragione, cioè crudamente con il
ragionamento, con il semplice uso della logica e
dell’argomentazione raziocinante - perché questo non fa che
rimandarci sempre di nuovo ad un punto di origine inspiegato ed
inattingibile - allora non resta che affidarsi alla via esoterica. Quello
che non può essere descritto, composto in algoritmi, strutturato in
una immagine, forzato in un linguaggio, allora forse può essere
Vedere la tenebra
Il contemporaneo autentico, con una postura caratteristica, si
distacca quindi dal suo tempo per poterlo osservare con agio, sotto
una luce di verità. Ma anche questa osservazione non è un atto così
neutrale. Dopo essersene distaccati, si deve anche evitare di venire
abbagliati dalla luce di quello che si vede. Dove i falsi
contemporanei sono accecati dal luccichio ingannevole del loro
tempo, il vero contemporaneo ne percepisce invece il buio,
l’oscurità e la tenebra, nella quale addirittura riesce ad ‘intingere la
penna’ (dopo averne ricevuto il fascio ‘in pieno viso’). Non per
vedere nel buio, ma per vedere il buio (“contemporaneo è colui che
tiene fisso lo sguardo sul suo tempo, per percepirne non le luci, ma
il buio. Tutti i tempi sono, per chi ne esperisce la contemporaneità,
oscuri. Contemporaneo è, appunto, colui che sa vedere questa
oscurità, che è in grado di scrivere intingendo la penna nella tenebra
del presente”).
Se vedere il buio vi sembra un obiettivo modesto e tutto sommato
facile da raggiungere vi ingannate: “il buio non è un concetto
privativo, la semplice assenza della luce…. Ciò significa che
percepire questo buio non è una forma di inerzia o di passività, ma
implica un’attività ed un’abilità particolare che, nel nostro caso,
equivalgono a neutralizzare le luci che provengono dall’epoca per
scoprire la sua tenebra, il suo buio speciale che non è, però,
separabile da quelle luci… Contemporaneo è colui che riceve in
pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo”).
Per sostenere questo punto di vista Agamben si impegna –
abbastanza sorprendentemente – in una breve incursione nel campo
70
ACHAB
attinto attraverso una sorta di percezione extrasensoriale.
Poiché c’è comunque qualcosa, qualcosa che sentiamo, che fa parte
di noi, qualcosa di cui siamo parte, e poiché questo che sentiamo
non possiamo vederlo, sentirlo, percepirlo con i nostri sensi,
descriverlo con le nostre parole e le nostre grammatiche, allora ci
deve essere un sistema per evocarlo - come si fa con un ectoplasma,
o uno spirito, in una seduta medianica - che eviti di rappresentarlo
e renda possibile comunicarlo attraverso una condivisione di
sensibilità e di simpatie esoteriche.
un elementare teatrino delle ombre.
La domanda sul contemporaneo è sbagliata perché ci chiede ancora
una volta di comporre e acquietare la nostra inquietudine ed il
nostro disagio nella costruzione di un ennesimo, rassicurante
simulacro cognitivo, quando anche rivestito di brume esoteriche e
scintillanti metafore.
Ci chiede di accettare un principio generale (universale?) ed
insieme un precetto etico, quando dovrebbe invece metterci in
guardia da principi e precetti.
Ci chiede di accettare l’onnipotenza dell’argomentazione e della
retorica, quando dovrebbe invece riconoscerne la sconfitta ed il
fallimento.
Ci chiede di dare corpo ad una entità che non esiste, che non ha
riscontro in natura, nella realtà, nel mondo là fuori, in nessun posto
in particolare che non sia il linguaggio, la mente, l’esperienza, la
cultura, il mestiere e gli interessi di chi si interroga su di lei.
Un luogo immaginario e assolutamente sospetto, nel quale si è
insediata una realtà virtuale totalitaria (quella che noi chiamiamo
‘realtà’, tout court) che pretende di annullare ed assimilare a sé tutte
le altre, e che ci rende ciechi alla vista di ogni altra cosa. Una realtà
che fa funzionare il nostro mondo (nel modo tragico, inutile e
doloroso in cui ci riesce) a danno dei mondi di tutti gli altri.
E’ così che il nostro contemporaneo, la luce e la tenebra del nostro
contemporaneo, sopravvivono nel mondo artificiale che abbiamo
costruito per loro, che essi hanno costruito per noi, all’interno di
una fortezza planetaria circondata da una muraglia sempre più
spessa di macerie e di ossa umane.
Questa è la tenebra sulla quale non si può fissare lo sguardo, un
contratto sociale nel quale anche i filosofi hanno stretto un patto di
ferro con i macellai perché ognuno possa fare tranquillamente il
proprio mestiere. Una assicurazione sulla nostra vita pagata con la
vita di tutti gli altri.
Se la filosofia non riesce a dirci niente di tutto questo, se continua
a riproporci i soliti vecchi, frusti, manierati e retorici interrogativi,
ai quali pretende di offrire, in risposta, una scelta elegante di
universali, o - in alternativa - una rassegna patetica ed effusiva di
angosce esistenziali e di innocui esoterismi, o una poetica
collazione di arcani.
Se non riesce a chiedersi per una volta che cosa sia veramente
quello che vogliamo sapere, da dove nasca lo sconcerto ed il dolore
delle nostre vite, allora davvero resterà confinata per sempre nel
suo giardino di principe felice, dove tutte le domande hanno una
risposta, ma né le une né le altre sono quelle di cui abbiamo
bisogno.
Che bisogno abbiamo di filosofi, se solo un poeta può dirci
quello che vogliamo sapere?
Il filosofo si sente sempre di più a disagio con il proprio linguaggio,
con la lingua normalizzata, disinfettata e sublimata cha ha utilizzato
fino ad oggi come lo strumento ideale per depurare la cruda
percezione della realtà dalle sue imperfezioni, per riprodurre
algoritmi che funzionino come per le scienze cosiddette esatte.
Quel linguaggio è un altro dio che ha fallito, ed è venuto il
momento di sostituirlo con una nuova retorica.
Ecco allora venire in soccorso il poeta e la sua poesia. La poesia,
che tutto riduce al suo impasto: utilizza la scienza, la filosofia, e
quello che vuole, e attinge direttamente alla nostra inquietudine.
E tuttavia Agamben - come tutti gli altri prima di lui che hanno
tentato la stessa strada, rinunciando alla via impraticabile
dell’argomentazione razionale per affidarsi al solo potere della
parola poetica, alla suggestione dell’arcano e dell’allusivo - non
riesce infine ad essere convincente né sul piano di una possibile
condivisione di senso e di sensibilità, né su quello della potenza
delle immagini e dell’evocazione.
Il filosofo, che in origine si era incaricato del compito titanico di
dare un senso al mondo, deve accontentarsi ora del ruolo sussidiario
di chiosatore del poeta, il solo che in virtù della sua sprezzatura
oracolare e del suo dono medianico possa avere accesso alla
autentica essenza del suo tempo.
E però alla fine quello soltanto che il poeta (e il filosofo con lui)
riesce evocare è l’interno, un dentro del nostro sconcerto, ma non la
sua soluzione. Dà voce alla nostra ansia, ma non ci offre quello
stato di soddisfazione che cerchiamo con le nostre domande.
Sbagliare domanda
Arriva quindi il momento di chiedersi se davvero sono le nostre
risposte ad essere sbagliate, o inadeguate, oppure se sia sbagliata la
domanda. Se cioè la tenebra che dovremmo cogliere, conoscere ed
esperire, la tenebra in cui dovremmo fissare lo sguardo, non sia
infine così inguaribilmente tenebrosa da occultare sé stessa insieme
a tutto il resto, offrendoci in cambio la modesta messa in scena di
di Valerio Fusi
71
ACHAB
“Pare um istante” (fermati un istante), foto di Michele Parodi,
Abaixada maranhense, Brasile 2007
72
ACHAB
Visitate il nuovo sito di Achab
www.achabrivista.it
La rivista è interamente scaricabile in formato pdf
“Clinica da alma” (Clinica dell’anima), foto di Michele Parodi
Abaixada maranhense, Brasile 2007
Note per la consegna e la stesura degli articoli
Gli articoli devono essere in formato Word o Rich Text Format (.rtf). Si consiglia di usare il carattere times o times
new roman corpo 12.
L'articolo deve avere una lunghezza minima di 3 cartelle e massima di 15 (interlinea 1,5; corpo 12).
Si consiglia di ridurre al minimo le note che non dovranno essere inserite in automatico ma digitate come testo alla
fine dell'articolo. Nel testo il numero della nota deve essere inserito mettendolo tra parentesi.
Gli articoli devono essere spediti al seguente indirizzo: [email protected]. La redazione provvederà a contattare
gli autori.
FINITO DI STAMPARE NEL GIUGNO 2009 DALLA TIPOGRAFIA INGRAF Industria Grafica Srl - Milano.
ACHAB
Clicia Abreu, Santo perdido, gruppo folclorico “Bumba-meu-boi Capricho de União”, Santa Helena, Brasile 2007
ISSN 1971-7946