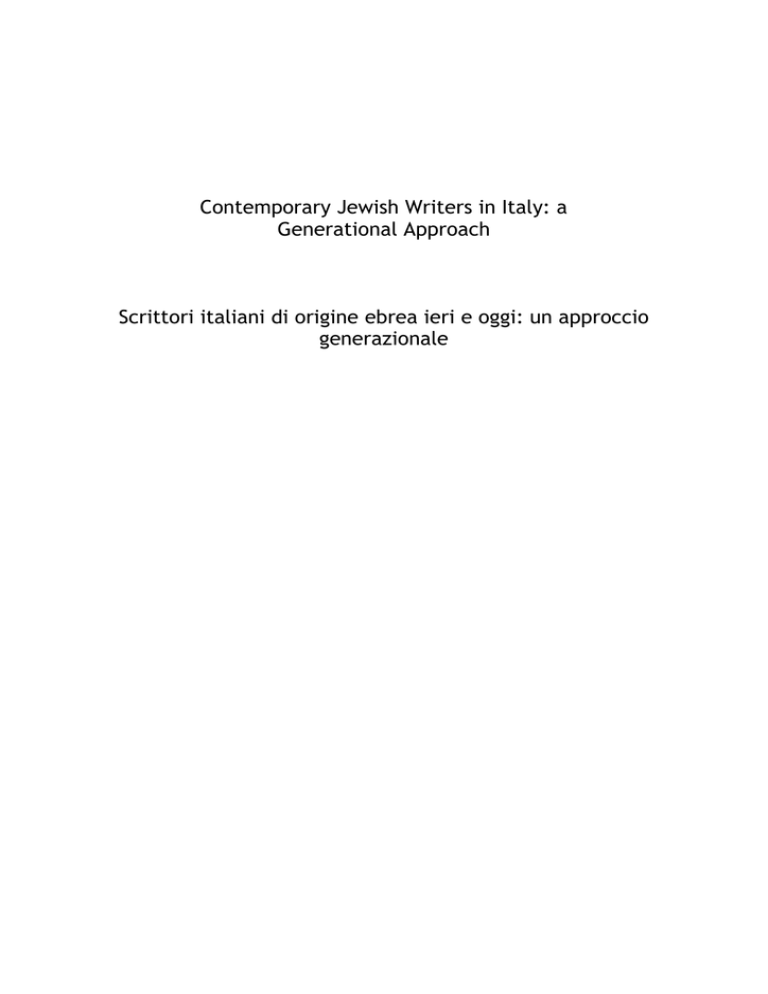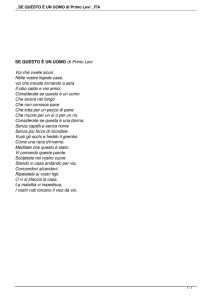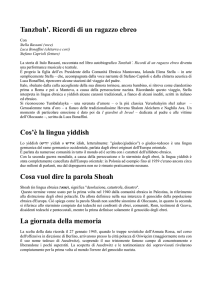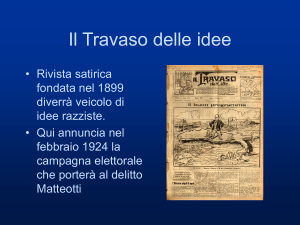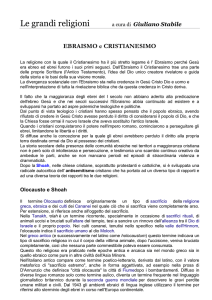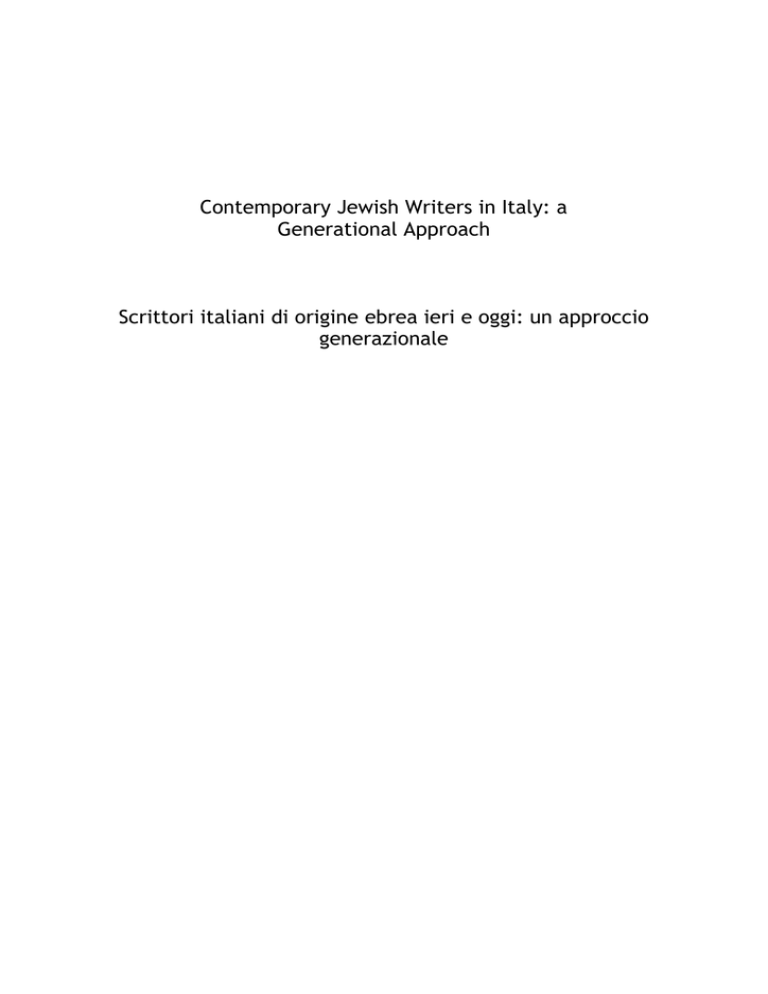
Contemporary Jewish Writers in Italy: a
Generational Approach
Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2
Studi di letteratura e cultura italiana
Pubbicati dall’Università di Utrecht
Studies in Italian Literature and Culture
Published by Utrecht University
Studies over Italiaanse literatuur en cultuur
Uitgegeven door de Universiteit Utrecht
Études de littérature et culture italienne
Publiés par l’Université d’Utrecht
Diretta da/ Directed by/ Samengesteld door/ Dirigée par
Harald Hendrix
1.
Monica Jansen, Paula Jordão, eds., The Value of Literature in and After the
Seventies: The Case of Italy and Portugal
2.
Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds., Contemporary Jewish Writers
in Italy: a Generational Approach.
Proceedings of the International Conference:
Contemporary Jewish Writers in Italy: a
Generational Approach
Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale
Utrecht-Amsterdam, 5-7 oktober 2006
Edited by Raniero Speelman, Monica Jansen &
Silvia Gaiga
Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds., Contemporary Jewish Writers in Italy:
a Generational Approach.
ISBN: 978-90-6701-017-7
ISSN: 1874-9577
© With the authors, November 2007
Published with assistance of Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services (University Library
Utrecht), November 2007.
All proceedings have been electronically published by Igitur, Utrecht Publishing & Archiving
Services at:
http://www.italianisticaultraiectina.org
Typesetting
Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services (University Library Utrecht)
Printed by
Holland Ridderkerk
TABLE OF CONTENTS
Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational
Approach
RANIERO SPEELMAN
Introduzione: particolarità e ricchezza della letteratura italoebraica
I
ELRUD IBSCH
Memory, History, Imagination: How Time Affects the Perspective on
Holocaust Literature
1
LUCA DE ANGELIS
Come un amore illecito. Sulla teshuvah di Zeno
13
PAOLO VANELLI
Gli eteronomi di Bassani nel romanzo di Ferrara
27
GANDOLFO CASCIO
L’estetica dell’ebreo e del cristiano nei racconti de Lo scialle andaluso di
Elsa Morante
39
STEFANO MAGNI
Le parole di felicità e la coscienza della tragedia nell’opera di Primo Levi
47
SARA VANDEWAETERE
Primo Levi e le future generazioni: l’etica del dialogo
57
ALFREDO LUZI
L’altro mondo di Levi. Scienza e fantascienza ne Le Storie Naturali
67
STEFANIA LUCAMANTE
Non soltanto memoria. La scrittura delle donne della Shoah dal dopoguerra
ai giorni nostri
77
CRISTINA VILLA
Perché la Shoah talvolta parla italiano? La letteratura italiana della
deportazione razziale nelle opere di Edith Bruck ed Elisa Springer
97
PHILIP BALMA
Edith Bruck’s experience in Italy: publishing, cinema, and the thematic
ghetto
107
DOMINIQUE BUDOR
Il “romanzo genealogico”, ovvero la memoria viva dei morti
115
LAURA QUERCIOLI MINCER
Romanzi della seconda generazione dopo la Shoah: strategie del ritorno fra
memoria ed oblio. Lezioni di tenebra di Helena Janeczek e Lo zio Coso di
Alessandro Schwed
129
GIORGIO PRESSBURGER
Budapest-Roma. Realtà ebraica fuori della lingua
137
INGE LANSLOTS
L’ineluttabilità del destino nell’opera narrativa di Giorgio Pressburger
143
MIRO SILVERA
La necessità di raccontare
153
RANIERO SPEELMAN
Multiculturalità ottomana e scrittori italiani da Saul Israel a Miro Silvera e
Daniel Fishman
157
MARIA CARMELA D’ANGELO
La dimensione transculturale della letteratura in lingua italiana di scrittori
afferenti alla cultura ebraica del Novecento postbellico
167
MARILENA RENDA
Lo spazio e il linguaggio. Note a margine su ebraismo e scrittura
185
ADA NEIGER
Da Elsa Morante a Elena Loewenthal. Breve viaggio nell’ebraitudine
193
HANNA SERKOWSKA
La Shoah ha un genere? Il caso di alcune scrittrici ebree di lingua italiana
201
MARIA GRAZIA COSSU
Voci di frontiera. il Ritorno in Lettonia di Marina Jarre
217
GABRIELLA DE ANGELIS
Clara Sereni: la sfida della differenza
231
SERENA ANDERLINI D’ONOFRIO
Utopias, Metabolized: Queering Communism and Zionism in Clara Sereni’s
Testimonial Narratives
243
MIRNA CICIONI
Speaking “as a” and Speaking “for”: Multiple Appartenenze in the
Autobiographical Macrotexts of Aldo Zargani and Clara Sereni
261
FEDERICO PELLIZZI
Casalinghitudini tra identità e storia: La scrittura pluristratificata di Clara
Sereni
277
SOPHIE NEZRI-DUFOUR
Alessandro Piperno: una visione iconoclasta dell’ebraicità
293
STEFANIA RICCIARDI
Filippo Tuena, Le variazioni Reinach: l’inferno del lager dalla musica del
niente
303
Gli Autori/ The Authors
315
INTRODUZIONE PARTICOLARITÀ E RICCHEZZA DELLA LETTERATURA ITALOEBRAICA Raniero Speelman Universiteit Utrecht Gli ebrei d’Italia occupano all’interno dell’ebraismo un posto particolare. In maggioranza, non appartengono né ai sefardim (ebrei spagnoli) né agli azhkenazim, ma fanno gruppo a parte, anche se arricchita nel corso dei secoli di immigrazioni da altri paesi, come la Spagna (dopo il 1492) e la Germania. Ciò non vale solo per la storica provenienza, ma anche per il loro minhag (tradizione liturgica), di cui in Piemonte è rappresentato, accanto ai predetti tre gruppi, un rito interamente a sé stante, detto di APAM (anacrostico di Asti, Fossano – ‘p’ e ‘f’ sono espresse dalla stessa lettera ‘’פ in ebraico – e Moncalvo).1 Strettamente parlando, gli ebrei italiani o italkim non appartengono nemmeno a pieno titolo al mondo della galut, alla diaspora, perché la loro presenza in Italia data da ben prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Tito (70 E.C.). Infine, si potrà dire che hanno vissuto in Italia più a lungo degli stessi italiani, indicazione che potrebbe valere per la popolazione della penisola forse a partire del settimo secolo dell’Era Comune. Ma tutto ciò non esaurisce ancora la loro importanza per la storia e cultura italiane. Esiste una letteratura italiana di provenienza ebraica sia in lingua italiana che in lingua ebraica. Sarebbe scorretto presupporre che gli ebrei del medioevo scrivessero in ebraico e quelli moderni in italiano: già al tempo di Dante, il dotto Immanuello Romano scrisse alcune delle poesie più originali del suo tempo, in ‘puro’ volgare, come l’affascinante frottola Bisdibis, descrizione impressionistica della corte veronese di Can Grande Della Scala. ‘Manoello’ compose pure un sonetto comico in cui giustappose scherzosamente le tre religioni monoteistiche, trattandole alla pari. Nel Rinascimento, i Dialoghi d’amore del modenese Leone Ebreo appartengono ai capolavori della trattatistica filosofica. Nel Settecento, Lorenzo da Ponte, convertito solo per motivi di comodità sociale alla religione dominante, critica nelle sue commedie da musica – i libretti de Le nozze di Figaro, Così fan tutte e Don Giovanni – la società del suo tempo. Ma è a partire dall’Unità d’Italia, che vide protagonisti parecchi israeliti, che gli ebrei fanno il loro vero ingresso nelle lettere italiane. Di grande rilievo sarà l’annessione della città irredenta di Trieste al Regno d’Italia, città dove gli ebrei erano una minoranza attiva in tutti i campi dell’economia e della cultura. Ebrei erano, fra tanti altri, Italo Svevo, Giani Stuparich, Carlo Michelstaedter, Umberto Saba, Bobi Bazlen, Guido e Giorgio Voghera, Bruno Piazza, Fery Fölkel e Alma Morpurgo. I
Ma è, come tutti sappiamo, il Fascismo che con le sue leggi razziali del 1938 impose agli ebrei un’identità non più d’italiani ma di popolo inferiore, cui non era nemmeno concesso l’impiego di una serva cristiana, il possesso di una radio o un posto sull’elenco telefonico. Da quel momento in poi, l’ebreo sarà il diverso, prima da isolare e poi, all’epoca della Repubblica Sociale Italiana e del terrorismo nazista, da sopprimere. Ormai dall’esperienza e identità ebraica non si può più staccare la Shoah. Ovviamente, la discriminazione razziale nutrì e rinforzò l’orgoglio di un’identità riscoperta nonché ideali di sionismo, che, nati alla fine dell’Ottocento grazie a Dante Lattes ed altri, porteranno numerosi ebrei italiani a fare prima o poi ‘aliyah (emigrazione in Terra d’Israele). Molte saranno le testimonianze dei campi di concentramento, molte quelle della vita di rifugiati e sfollati che allontanò gli ebrei dalle proprie case in cerca di un nascondiglio sicuro, anche oltre confine (in Palestina, Svizzera o America). Più in genere, la posizione di antifascisti assunta ben prima, cioè a partire dai primi anni venti, dai fratelli Rosselli, assassinati in Francia da sicari fascisti, da Leone Ginzburg, morto nel carcere fascista, e del gruppo torinese Giustizia e Libertà intorno a Sion Segre Amar permette una identificazione generalizzante tra ebrei e Resistenza, anche se non sono mancati ebrei fascisti (ad esempio, quelli della rivista La nostra bandiera come Ettore Ovazza).2 Pochi ebrei emersero dalla guerra senza una precisa coscienza storico‐culturale e identitaria. Infatti, gli anni quaranta‐sessanta o settanta sono – pare, alla luce dell’immediato passato, un paradosso – un periodo aureo o argenteo della letteratura italoebraica, grazie a scrittori come (in ordine alfabetico) Giorgio Bassani, Natalia Ginzburg, Carlo Levi, Primo Levi, Elsa Morante, Alberto Moravia, che furono annoverati giustamente fra i maggiori scrittori italiani (e, in qualche caso, europei). Intanto, un nuovo fattore nella storia politica regionale e mondiale era nato con la costituzione dello Stato d’Israele (1948), Paese che per i suoi successi militari, politici ed economici perse gradualmente gran parte dell’appoggio sia della sinistra che della destra italiane. Gli ebrei italiani si trovarono talvolta identificati con un gruppo straniero, non più a pieno titolo italiano. Alcuni cercarono di distanziarsi dalla identificazione gratuita con Israele e il sionismo, altri scelsero l’‘aliyah, altri ancora accentuarono la propria ebraitudine nel proprio ambiente o nella ricerca storica. Ciò culminò, nel 1982, con manifestazioni con carattere aggressivo contro gli ebrei a Roma, che costò la vita ad un bambino di tre anni. Da quel momento, per molti ebrei italiani, les jeux sont faits: aumenta l’attenzione per la propria identità, soprattutto in scrittori della generazione (un po’) più giovane. Abbiamo in tal modo i libri di Fausto Coen, Alberto Lecco, Alberto Vigevani. In alcuni il cambiamento da materia generale, non ebraica, verso la materia ebraica avvenne durante o verso la fine della carriera di scrittore (è il caso di Paolo Levi, prima scrittore di gialli, del diplomatico Guido Artom, in un certo senso anche di Elsa Morante, quello di Alberto Vigevani e più tardi di Alain Elkann), in alcuni la scelta avvenne prima (Angela Bianchini, Alberto Lecco, Lia Levi, Giacoma Limentani, Sandra Reberschak, Clara Sereni e Roberto Vigevani); in altri si trattò di un interesse emerso in un solo libro II all’interno di un’opera dedicata a problematiche ben diverse (Natalia Ginzburg). I suddetti eventi, insieme al revisionismo ossia la negazione della Shoah da parte di finti studiosi come Faurisson e Irving, contribuirono alla nascita del romanzo genealogico volto a salvare la memoria minacciata dall’oblio (si veda, qui sotto, il contributo di Dominique Budor). Un altro cambiamento avvenuto nel corso degli anni cinquanta è quello dell’interesse per i campi di concentramento nazisti e per la testimonianza di chi ci è sopravvissuto. Importante è la mostra viaggiante3 che sensibilizzò molti italiani e condusse anche alla ‘scoperta’ di Primo Levi. Ma, come racconta Augusto Segre, anche ben prima c’erano state rappresentazioni di filmati e conferenze sull’argomento, che raggiunsero però un pubblico molto più limitato. La lunga serie di testimonianze iniziata, senza quasi riscontrare l’interesse dell’editoria e del pubblico italiano negli anni quaranta (è noto il caso di Primo Levi, rifiutato dall’Einaudi per voce di Natalia Levi in Ginzburg), porta ancora frutti talvolta ricchissimi, come dimostrano le recenti testimonianze di Teo Ducci, Nedo Fiano, Piera Sonnino e Piero Terracina, pubblicate tutte nel nuovo milennio. Dalla fine degli anni sessanta data la prima autobiografia ebraica contemporanea, Anni di prova (1969) di Arturo Carlo Jemolo, seguita dalle Memorie di
vita ebraica di Augusto Segre (1979). Poco posteriore è quella di Giancarlo Sacerdoti, Ricordi di un ebreo bolognese (1983). Saranno le capostipiti di tutto un genere, che descrive la formazione e vita dello scrittore in quanto ebreo, opere spesso segnate dalla guerra e dalle difficoltà incontrate prima e dopo il periodo bellico. Il genere continua a produrre lavori di grande interesse e non poca importanza letteraria, anche se troppo poco conosciuti dal grande pubblico. Fra le opere più belle potremmo annoverare le memorie di Vittorio Dan Segre, Sion Segre Amar, Corrado Israel De Benedetti, Franco Levi e del giovane Shulim Vogelmann. Un altro fattore che ha lasciato un’impronta sull’ebraismo italiano è l’immigrazione in Italia di ebrei provenienti dalle ex colonie italiane o il rientro di ebrei di cittadinanza italiana da Paesi diventati poco attraenti come domicilio. Ad essi si affiancano esuli dagli stati del Patto di Varsavia, specialmente dall’Ungheria. Tra essi si trovano i grandi talenti della nuova generazione, come Edith Bruck e i fratelli Pressburger, e dell’ultimissima leva, come Moni Ovadia, Viktor Magiar e Daniel Fishman. Il paesaggio letterario nel quale si trovano gli scrittori italoebraici si delinea in tal modo come stratificato e complesso. Il fatto che il nostro discorso interessi un gruppo consistente pari a forse l’uno per mille della popolazione italiana, lo rende tanto più interessante e può essere annoverato fra le questioni che sono state approfondite nel presente convegno. Sarà chiaro che la definizione di ‘ebreo’ in senso religioso ci interessi meno dell’influsso letterario e culturale di una provenienza ebraica anche se non strettamente halachica (secondo la dottrina rabbinica che vede un ebreo come figlio di madre ebrea). Ciò per vari motivi. Innanzitutto, non era eccezionale che un ebreo italiano benestante sposasse una ragazza cattolica, dunque goyah, che talvolta si convertiva all’ebraismo e III
talvolta no. Ovviamente si trattava qui di ambienti altamente assimilati, in cui l’albero di Natale conviveva con la Channukiah e tavolta, il prosciutto di oca era stato sostituito con quello di maiale. Inoltre, chi non era di madre ma solo di padre e cognome ebreo, o anche convertito alla fede cattolica, spesso si è trovato a partecipare alle vicissitudini del popolo ebraico. Così la letteratura italoebraica include ebrei convertiti come Ettore (Aron) Schmitz e Elsa Morante, e ‘mezzi’ ebrei di madre cristiana come Alberto Pincherle‐Moravia, Marina Jarre e Alessandro Piperno (vedi sotto). Un’altra definizione (per cui si veda l’articolo di Ada Neiger) è quella di Abraham Yehoshua: “ebreo è chi si identifica come tale”, interessante perché amplierebbe l’orizzonte della ebraitudine a chi non è ebreo halachico ma si sente ciononostante yehudi, e sceglie la cultura ebraica come propria. Anche se nessun rabbino potrebbe mai accettare una simile definizione, ciò offrirebbe almeno un messaggio di speranza a chi vuole vedere l’ebraismo in primo luogo come cultura che si può condividere (non dimentichiamo qui che Yehoshua è israeliano e vive in una realtà diversa da quella diasporica). È doverosa un’altra osservazione sulla (spesso scarsa) religiosità degli scrittori italiani.4 Infatti, a‐religiosi erano sia i fratelli Rosselli, cugini di Moravia, che Carlo e Primo Levi, tanto per limitarci a pochi nomi. È famoso però quanto disse Nello Rosselli al congresso di Livorno del 1924: Sono ebreo di coscienza, sono ebreo perché credo nelle memorie ebraiche, sono ebreo perché credo nella tradizione ebraica, sono ebreo perché credo nei valori e negli ideali dell’ebraismo.5 Ebrei non religiosi riconoscono dunque l’ispirazione biblica dei propri ideali di progresso e giustizia. Ciò aiuta a spiegare il ruolo importantissimo svolto dagli ebrei nella haskalah in Germania (l’illuminismo tendente all’assimilazione) e nella storia del socialismo e comunismo (per l’Italia, ricordiamo qui, oltre ai Rosselli, Claudio Treves, Leone Ginzburg, Umberto Terracini, Vittorio Foà, Emilio e Clara Sereni, Bice Foà Chiaromonte). Ma si può aggiungere altro. Leggiamo in Shemoth (Esodo) 19,6: “Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”. In queste parole della Torah la tradizione rabbinica vede la missione del popolo d’Israele: diffondere fra le genti il nome del Dio Unico e quindi il monoteismo, qualunque forma esso assuma. A prescindere dalle implicazioni religiose, tale missione si chiamerebbe oggi intermediazione culturale. Nella nostra società globale, in cui siamo in continuo contatto con una varietà di popoli e di culture, l’ebreo, grazie ad una preparazione culturale adatta – si pensi alle conoscenze linguistiche superiori alla media o sovente ai più frequenti contatti internazionali – sembra chiamato a svolgere questo compito. Non per niente, fra i traduttologi – tanto per menzionare una disciplina che a livello teorico si occupa di uno dei tipi più comuni di comunicazione interculturale – non pochi sono di origine ebraica (ad esempio, Jakobson, Levý, Steiner, Toury e Osimo). Già in epoca ottomana – solo per fare un esempio di come questa missione possa essere traslata a livello diplomatico – i soldani si servivano per le loro missioni diplomatico‐commerciali spesso di inviati ebrei, incaricati di fare da tramite fra musulmani e cristiani di cui conoscevano bene le rispettive lingue e culture, nonché le reciproche paure. IV La posizione tra varie culture, tra Occidente e vicino Oriente, l’apertura a idee universali come uguaglianza e giustizia, il rispetto del Paese di residenza che li fece sempre fedeli cittadini di quest’ultimo, ha permesso agli ebrei un grande ruolo nella formazione dei moderni Stati nazionali (come Gran Bretagna, Germania, Italia, Stati Uniti e Turchia) e in particolare della società civile e dei movimenti progressisti europei, compreso il sionismo che ne è una variante esclusivamente ebraica ma non per questo meno idealista. Per i suddetti motivi, non sorprende la tenace sopravvivenza dell’antisemitismo che continua a colpire il mondo ebraico. Questa malattia mentale e culturale del non‐ebreo oggi ha assunto oggi una quadruplice identità: di estrema destra, di tradizione cristiana (in primo luogo, quella ortodossa), islamica6 e, da ultimo ma non da meno, di sinistra (spesso sotto la forma di solidarietà con i popoli arabi).7 Meno preoccupante è l’idea persistente che gli ebrei non siano veri italiani, francesi, polacchi o belgi. Spia di questo pregiudizio è il ‘complimento’ “lei parla benissimo l’italiano!” che è stato osservato da più d’uno scrittore italoebraico. Lo studio della letteratura degli ebrei d’Italia sembra avere come svantaggio il fatto che venga rinforzato questo isolamento o che si costruisca una specie di ‘ghetto’ tematico, termine non casualmente usato da Edith Bruck (si veda, qui sotto, il contributo di Balma). Ciò pare comunque inevitabile per chi vuole analizzare l’elemento ebraico nelle lettere italiane nella sua complessità e ricchezza. I CONVEGNI ‘ICOJIL’ E I PRESENTI ATTI Gli Atti in lingua italiana e inglese che presentiamo al pubblico come secondo volume nella nuova collana elettronica ‘Italianistica Ultraiectina’8 sono quelli di un convegno in cui gli organizzatori hanno cercato un approccio generazionale della letteratura italoebraica. Distinguendo, con le debite riserve di periodizzazione, tra la generazione di chi ha vissuto il Fascismo, le leggi razziali e la Shoah da adulto e come tale ne riferisce, la generazione di chi è nato subito dopo la guerra o l’ha vissuta da bambino, senza capirla pienamente, e la generazione dei figli degli ultimi decenni, dagli anni cinquanta in poi. Il Convegno tenutosi ad Amsterdam, dal 5 al 7 ottobre 2006, ha riunito per la prima volta un numero di specialisti di letteratura italoebraica contemporanea provenienti dal mondo intero, convenuti per fare l’inventario degli studi finora compiuti e dichiarare quanto sarebbe desiderabile cercare di raggiungere ancora. I presenti hanno affermato all’unanimità che il Convegno non doveva restare un’esperienza isolata, bensì assumersi il ruolo di essere il primo di una serie di incontri dedicati ai tanti argomenti del campo di studi. È nato così il nome di (First) International Conference on Jewish Italian Literature (ICOJIL). Siamo fieri che a questa prima iniziativa ne siano seguite già due altre, la prima, Lingua e memoria. Scrittori ebrei di lingua italiana, a Varsavia (29‐30 gennaio 2007) e la seconda, Memoria collettiva e memoria privata: il ricordo della Shoah come politica sociale, a Roma (6‐7 giugno 2006), mentre si riallaccia agli incontri in più d’un aspetto anche il convegno Mémoire oblige. Riflessioni sullʹopera di Primo Levi, dedicato a Primo Levi nel ventennio della morte ed organizzato a Trento da V
Ada Neiger e Luca De Angelis. Gli atti della conferenza di Varsavia appariranno in forma di libro a cura di Hanna Serkowska, mentre quelli della conferenza romana usciranno come il terzo volume di questa serie “Italianistica Ultraiectina”, a cura di Stefania Lucamante. È dovuto un cordiale ringraziamento a tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare questo Convegno, in primis alla direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Amsterdam, Carmela Paternoster, alla KNAW (Reale Accademia Neerlandese delle Scienze), all’OGC e all’OSL dell’Università di Utrecht per i finanziamenti da loro concessi, ai volontari che ci hanno assistiti in ogni fase e ai presidenti delle sessioni. Grazie anche al Joods Historisch Museum di Amsterdam e alla Libreria Bonardi dell’accoglienza fatta ai partecipanti durante il convegno e dell’interesse dimostrato nei nostri confronti. Fra i relatori non qui presenti con i loro contributi, vorremmo ringraziare Elena Loewenthal e Roberto Vigevani di averci resi partecipi delle loro esperienze umane e di scrittore. Non va dimenticato infatti che senza l’impegno degli scrittori, la letteratura non esisterebbe nemmeno. I CONTRIBUTI DEL PRESENTE LIBRO: LE PRIME GENERAZIONI E IL RICORDO DELLA SHOAH Nel suo articolo ‘Memory, History, Imagination: How Time Affects the Perspective on Holocaust Literature’ (Memoria, storia, immaginazione: come il Tempo influisce sulla prospettiva della letteratura della Shoah), Elrud Ibsch, che aprì il convegno, fa una distinzione molto importante per la letteratura che cerca di descrivere o s’ispira alla Shoah: quella tra memory (memoria), remembered history (storia ricordata) e imagined history (storia immaginata). Tale distinzione è innanzitutto cronologica: le prime testimonianze, quelle dei sopravvissuti, avevano il carattere di opere autobiografiche o diari; più tardi seguirono i racconti autobiografici con maggiore lavorazione letteraria, che non di rado avevano il carattere di storia familiare descritta dai discendenti delle vittime, mentre di data posteriore, spesso scritti non dai superstiti ma da autori più giovani (seconda e soprattutto terza generazione), è la fiction che si avvicina alla materia attraverso l’immaginazione. A tal punto, la materia storica è entrata a far parte della letteratura ‘normale’ e canonica. In alcuni casi eccezionali, sono gli stessi sopravvissuti in cui si realizza tale trasformazione (Gary e Hilsenrath). In questo modo si delinea chiaramente una prima divisione generazionale, anche fuori della letteratura italoebraica. Infatti, gli esempi di Ibsch includono scrittori tedeschi, francesi, israeliani e neerlandesi. Ibsch analizza anche alcuni procedimenti stilistici usati dai vari scrittori, in particolare l’ironia (riscontrabile già in Primo Levi), la ricerca dell’identità e l’interrogazione del passato (Gutfreund, Modiano), e la satira (come in Grunberg e Piperno). Ovviamente, le opere più propriamente letterarie sono maggiormente esposte al giudizio critico. Incontreremo la suddivisione di Ibsch in vari dei seguenti contributi. VI Se parliamo della generazione dei superstiti come prima di tre generazioni, la letteratura precedente dovrebbe essere indicata, in mancanza di meglio, come la generazione ante‐Shoah o ‘zero’. Essa è ovviamente interessante per più motivi. In Italia, era l’era della nation building nella quale gli ebrei ebbero un ruolo di prim’ordine, ma che ‘pagarono’ rinunciando a gran parte della loro identità in cambio di quella di italiani a tutti gli effetti. Fu quella, dunque, il momento dell’assimilazione. Molti scrittori, come i già menzionati triestini, contribuirono all’affermarsi di una nuova coscienza nazionale ed alla nascita di una società laico‐
borghese. Tra gli scrittori del primo Novecento, Italo Svevo è l’esempio più conosciuto. La lettura di Svevo in chiave ebraica pare, quindi, a prima vista un compito arduo e ingrato, che non potrebbe essere in grado di far luce su come Aron/Ettore Schmitz vivesse la propria identità di origine. È merito di Luca De Angelis, in un suo libro recente (Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica del Novecento italiano: da Svevo a Bassani) nonché nel suo articolo nei presenti Atti, ‘Come un amore illecito. Sulla teshuvah di Zeno’, di aver affrontato questa tematica complessa. De Angelis analizza il percorso formativo di Svevo come tipico di una certa forma di ‘marranismo’ (ebraismo coperto). Anche se Schmitz si convertì al cristianesimo (come Heine, Mahler e Werfel), l’interesse morale per la religione degli avi non si estinse mai in lui, ma aveva il carattere di un moto interiore dell’anima che si chiama teshuvah (da tradurre piuttosto con ‘ritorno’ o ‘voltar indietro’ che con il più comune ‘pentimento’, di tono troppo religioso in questo contesto) ed è un’idea portante tra le più forti dell’Ebraismo. Tipica ‘spia’ di Svevo ebreo è il conflitto con il padre‐patriarca, figura molto importante nella letteratura ebraica e simbolo della realtà sociale vissuta dall’ebreo. Per questo motivo, si potrebbero trovare spunti fecondi in una varietà di scrittori da Kafka a Morante e Bassani (si pensi al rapporto di Elio Corcos col proprio padre). Vari scritti anche e soprattutto privati di Aron Schmitz mostrano questo spirito intimo ebraico di cui anche il fratello Elio nel suo Diario (riedito dallo stesso De Angelis nel 1997) ha fornito una preziosa testimonianza. La prima generazione dei sopravissuti alla Shoah ha prodotto alcuni degli scrittori internazionalmente più riconosciuti. Innanzitutto, Giorgio Bassani. Il contributo di Paolo Vanelli, ‘Gli eteronimi di Bassani nel Romanzo di Ferrara’ si concentra sugli aspetti autobiografici dei personaggi bassaniani e del modo in cui questi riflettono la sua conflittualità interiore e esteriore. Nelle Cinque storie ferraresi, il primo segmento del grande Romanzo di Ferrara, non incontriamo mai lo scrittore in veste di personaggio, ma questi si serve di eteronimi che rispecchiano varie attitudini e fasi della sua vita. A queste novelle segue la trilogia dell’io (Gli occhiali d’oro, Il giardino dei Finzi‐Contini e Dietro la porta), in cui Bassani parla in prima persona. Il giardino dei Finzi‐Contini presenta un’iniziazione alla vita e un passaggio quasi leopardiano dal Bello al Vero. Vanelli dimostra che la conoscenza dei Finzi‐Contini significa per l’io narrante in primo luogo ritrovare il senso più alto e più raffinato dell’ebraicità ‘incontaminata’, e quindi scoprire la propria identità ebraica. VII
Dobbiamo rincrescere che la conferenza di Lucienne Kroha ‘A Case of Mistaken Identity: Giorgio Bassani’s L’Airone’ (Un caso di identità sbagliata: L’Airone di G.B.) in attesa dell’apparizione di un maggiore suo studio sullo scrittore ferrarese non è potuto apparire in queste pagine. La ricca e scrupolosa analisi della Kroha è complementare a quella di Vanelli, non solo nella scelta del romanzo. Da un lato abbiamo la (sbagliata) coscienza identitaria del protagonista Limentani, che lo spingerà al suicidio, dall’altro la fitta rete di simboli sapientemente usati da Bassani per incastrare il personaggio, riferimenti che ricordano Il Gattopardo, di cui il ferrarese era stato ‘padrino’. Non meno sottili dei simboli bassaniani sono quelli della Morante, come dimostra Gandolfo Cascio nel suo ‘L’estetica dell’ebreo e del cristiano nei racconti de Lo scialle andaluso di Elsa Morante’. L’articolo parte da alcuni elementi fisiognomici. Cascio postula la presenza di due categorie di archetipi: quello vincente, apollineo e solare, e quello saturnino o lunare, simbolo della sconfitta. Per illustrare ciò, l’autore si riferisce a testi chiave dell’iconologia morantiana: il Paradiso dantesco, l’opera del Beato Angelico e il lavoro sulle gerarchie angeliche di Dionigi Areopagita. Si possono riscontrare i detti tipi in vari racconti, come ‘Il ladro dei lumi’, ‘Il soldato siciliano’ ed altri. Gandolfo Cascio riesce così a rivendicare in modo convincente un posto di rilievo per i racconti nell’opera di Morante, con un’analisi che giova anche all’interpetazione delle opere di maggior respiro narrativo, da Menzogna e sortilegio a Aracoeli. A Primo Levi sono dedicati tre contributi. Ne ‘Le parole di felicità e la coscienza della tragedia nell’opera di Primo Levi’, Stefano Magni ha voluto esaminare un aspetto finora poco studiato dalla critica leviana: quelle parole che esprimono, nelle opere dedicate alla tragedia della Shoah, la felicità. Partendo dall’osservazione di Levi “che nessuna felicità è mai assoluta, perfetta, e allo stesso modo nessuna tristezza è mai assoluta”, Magni traccia quel che mi piacerebbe chiamare lo schema di yin‐yang presente in gran parte dell’opera leviana. In Se questo è un uomo, come constatato anche da Elrud Ibsch, ricorre una certa ironia. Espressioni come ‘con sollievo’, descrizioni come il ritratto del kapo Alex, e l’esame chimico in cui ironia e sarcasmo si alternano con il grottesco, ne sono ottimi esempi, mentre il capitolo ‘Una buona giornata’ forma un intermezzo che grazie alla funzione di contrasto fa risalire meglio il buio dal quale è circondato il soggiorno in inferno. Ne La tregua, dopo le prime pagine dolorose (scritte nello stesso periodo del primo libro), nei capitoli seguenti cambia il tono e il romanzo si svolge all’insegna di una narrazione che tocca spesso il comico. Invece ne I sommersi e i salvati sono pressoché assenti le parole di ‘sollievo’, alle quali si sostituisce il concetto di ‘fortuna’. Anche se poter comunicare con i tedeschi costituisce per Levi una certa soddisfazione, mancano gli slanci emotivi del primo libro e l’analisi più profonda di Auschwitz toglie ogni speranza di redenzione, come avrebbe illustrato poco tempo dopo la morte dello scrittore. Anche Sara Vandewaetere in ‘Primo Levi e le future generazioni: l’etica del dialogo’ inizia il suo contributo dai libri dedicati ad Auschwitz. Partendo dal VIII carattere di Hurbinek, il bambino scomparso poco dopo la liberazione, Vanderwaetere dimostra la scelta particolarmente felice di Levi, che testimoniando per il bambino muto che assume il ruolo di simbolo si fa portavoce dei veri testimoni, i Musulmänner. In tal modo, questi ultimi svolgono per il lettore il ruolo di ‘Altro’, coinvolgendolo nella loro sorte. Levi viene a trovarsi per certi versi vicino alla filosofia di Lévinas, per cui l’Altro è un concetto centrale. Ma in Levi la funzione dell’Altro è ben diverso. Egli cerca di restaurare il dialogo reso impossibile dalla realtà nazista. Il primo interlocutore è il lettore tedesco che egli vuol costringere a vedere. Più tardi, Levi vedrà soprattutto i giovani lettori come Altro a cui s’indirizza, in un processo di dialogo intergenerazionale. Della continuità fra le generazioni parlano anche altri suoi testi, come Il sistema periodico (in particolare, ‘Argon’). A livello filosofico, piuttosto che a Lévinas e contemporanei francesi, Levi pare riallacciarsi ai pensatori classici e del Settecento. L’articolo di Alfredo Luzi ‘L’altro mondo di Levi. Scienza e fantascienza nelle Storie Naturali’ è dedicato ai primi racconti fantastici scritti da Levi. A prima vista tanto diversi dal dittico della Shoah, in realtà sono nati dalla stessa esigenza di comunicare, di usare la scrittura come terapia. Luzi si inserisce in un filone critico che vuole evidenziare – come reazione ad una tradizione interpretativa troppo limitativa – la sostanziale unità dell’opera leviana, in cui i racconti, romanzi, saggi e poesie vengono a completare a pieno titolo il discorso iniziato con Se questo è un uomo. La dovuta importanza va quindi data a quanto affermato dallo stesso Levi, Sì, sono storie che si svolgono ai margini della storia naturale, per questo le ho chiamate così, ma sono anche innaturali, se si guardano da un certo lato. Ed è ovvio che i due significati si incrocino [...]. Io sono un anfibio, un centauro...9 Questo carattere ibrido, da intendere come metafora, unisce lavoro in fabbrica e letteratura, ma – direi pure – anche il testimone e lo scrittore fantastico, l’ebreo e l’italiano, e in fondo denota uno che aveva sempre la coscienza del ruolo dell’“impurezza” intesa come principio catalitico. Luzi fa vedere l’importanza dell’ironia nella raccolta di novelle, illustrandola con il ruolo rivestito dagli animali, in particolare dalla tenia, “l’amico dell’uomo”. Altrettanto importante è l’intertestualità che lega Levi a svariati scrittori da Plinio il Vecchio e Darwin a Conrad e Saint‐Exupéry. Accanto ai grandi nomi della letteratura italoebraica trattati or ora, appartengono alla prima generazione alcuni dei principali testimoni della Shoah, fra cui non si possono più trascurare le donne. Stefania Lucamante esamina nel suo saggio ‘Non soltanto memoria. La scrittura delle donne della Shoah dal dopoguerra ai giorni nostri’ le testimonianze da un punto di vista di gender. Non è certo incontestato un approccio del lager al femminile, che secondo alcuni rischia di diminuire l’importanza dell’‘unicità dell’evento’. Resta vero che le testimonianze di donne sono rimaste a lungo meno ascoltate di quelle maschili. A partire di iniziative negli anni novanta (del 1995 data il IX
primo convegno promosso dall’ANED del Piemonte sulla deportazione italiana esclusivamente femminile) ciò sta fortunatamente cambiando, grazie anche a studiose come Heinemann, Kremer e Bravo. La testimonianza femminile sulla Shoah si può articolare in tre periodi: l’immediato dopoguerra, con i libri di, fra l’altro, Giuliana Tedeschi, Liana Millu – ad entrambe Lucamante dedica un’analisi più dettagliata – ed Edith Bruck (vedi qui di seguito); gli anni settanta con il diario di Fausta Finzi, pubblicato poi con il titolo A riveder le stelle; e gli anni dal 1990 in poi, con i libri della Springer (come sopra) e, ultimamente, di Piera Sonnino (Questo è stato) e di Liliana Segre (Sopravvissuta ad Auschwitz), quest’ultimo, che non ha alcuna pretesa letteraria, scritto e redatto da Emanuela Zuccala. Lucamante affronta il discorso del cambiamento da testimonianza a fiction, riallacciandosi al saggio di Elrud Ibsch. Cristina Villa esamina nel suo ‘Perché la Shoah talvolta parla italiano? La letteratura italiana della deportazione razziale nelle opere di Edith Bruck ed Elisa Springer’ il fatto che alcuni testimoni della Shoah abbiano scritto in un idioma diverso dalla lingua materna e, per giunta, quella di un paese alleato della Germania nazista. Nel caso della Bruck si tratta di un’ungherese approdata in Italia dopo la Shoah e una ‘aliyah fallita, in quello della Springer di un’austriaca, immigrata in Italia dopo l’Anschluss. Villa accenna anche a Helga Schneider, figlia di una nazista fanatica stabilitasi in Italia e diventata scrittrice. La risposta potrebbe essere che l’italiano era una lingua più adatta e in nessun modo contaminata, come invece era il tedesco, e quindi non sollevava le stesse barriere per chi volesse descrivere gli orrori vissuti. Lo dice chiaramente la Bruck: “mi rifugio nella lingua italiana che sembra meno vera” (di quella materna).10 D’altronde, secondo Villa, bisogna prendere le distanze dal mito del ‘bravo italiano’ che vorrebbe i soli nazisti colpevoli dei soprusi commessi nei confronti degli ebrei. Molti libri recenti e no, hanno dimostrato che in numerosi casi erano i fascisti a comportarsi da energumeni e aguzzini, e i cittadini ‘normali’ a non volersene accorgere; si pensi ad esempio al romanzo autobiografico In contumacia (1967), in cui Giacometta Limentani descrive lo stupro di una giovane ragazza all’indomani della promulgazione delle leggi razziali. Villa ribadisce che è stata l’amnistia Togliatti del 1946 a preparare il mito collettivo dell’Italia antifascista in un tentativo di cancellare il passato recente in cui gli italiani avevano combattuto gli uni contro gli altri. Sempre alla Bruck è dedicato l’articolo di Philip Balma, ‘Edith Bruck’s experience in Italy: publishing, cinema, and the thematic ghetto’ (L’esperienza italiana di Edith Bruck: editoria, cinema e il ghetto tematico). Balma si ispira ad un’intervista che ha fatto alla Bruck nel 2006. A proposito delle sue scelte tematico‐
letterarie la scrittrice rivendica per sé un cosiddetto ‘ghetto tematico’ di pregiudizi, sfruttamento e diritti civili, argomenti cui ha dedicato romanzi talvolta rifiutati dal mondo editoriale italiano. Fra i temi trattati nell’intervista colpisce il conflitto tra Bruck e Pontecorvo, per il cui film KAPÒ aveva svolto attività di consulenza. Questo lavoro di cui non rendono conto le didascalie del film, ha fornito più spunti per il romanzo Transit (1975). Direttamente ispirato ad un romanzo di Bruck è il film X ANDREMO IN CITTÀ di Nelo Risi, marito della scrittrice. Nella sua produzione, la Bruck fu attaccata da un bosniaco che odiava gli ungheresi, un incidente a causa del quale si trovò coinvolta in polemiche in Italia. Se anche questo evento ispirò Transit, scopo della scrittrice resta, più in generale, “denunciare tutti i soprusi, tutte le oppressioni, lo schiacciare l’altro, il non riconoscere l’umanità dell’altro”.11 LA SECONDA GENERAZIONE, IMMIGRAZIONE E TRANSCULTURALITA Della ‘remembered history’ ‒ per riprendere la terminologia di Ibsch ‒ fa parte il ‘romanzo genealogico’, affermatosi a partire dagli anni ottanta e novanta in molti scrittori di origine ebrea e in diversi paesi, ad esempio nei Paesi Bassi In Babylon (1997) di Marcel Möhring. Si tratta ovviamente di letteratura della cossiddetta ‘seconda generazione’. A questi testi è dedicato il contributo di Dominique Budor, ‘Il “romanzo genealogico”, ovvero la memoria viva dei morti’. La nascita di questo genere è da attribuibire a determinati fattori quali il risorgere dell’antisemitismo e il revisionismo nel corso degli anni ottanta. Precursori di questa scrittura sono George Perec (W ou le souvenir d’enfance, 1975) e si potrebbero aggiungere per l’Italia i romanzi di Guido Artom (I giorni del mondo, 1981) e Paolo Levi (Il filo della memoria, 1984). La Budor analizza come esempi Il mio nome a memoria (2000) di Giorgio van Straten e L’orologio di Monaco (2003) di Giorgio Pressburger, esaminandone l’itinerario della scrittura, dall’avvio alla ricerca delle ascendenze, al bisogno di raccontare e il costituirsi di un nuovo legame con la discendenza. Anche se hanno molto in comune (l’attenzione per la storia del nome – “Dunque per salvare un uomo si deve ripetere il suo nome, come in una liturgia” dice Van Straten), spiccano soprattutto le differenze fra i due scrittori. Dove Van Straten cerca di restaurare la memoria, e di seppellire i morti senza sepoltura in quel che si può chiamare un zakhor laico, Pressburger parte dal bilancio di un’esistenza che si dirama poi attraverso la storia, alla fine del quale prende la parola suo figlio Andrea, che afferma che non avrà eredi e incarna la paura della sparizione dello scrittore ebreo. Anche il contributo di Laura Quercioli Mincer ‘Romanzi della seconda generazione dopo la Shoah: strategie del ritorno fra memoria ed oblio. Lezioni di tenebra di Helena Janeczek e Lo zio Coso di Alessandro Schwed’ parte da un confronto di due testi e scrittori, che si potrebbero definire multiculturali. Gli autori, rispettivamente tedesca figlia di ebrei polacchi e figlio di ebrei ungheresi, condividono un posto decentrato nella letteratura italiana. Per entrambi gli autori la discesa verso l’abisso della Shoah sperimentata dai genitori ha come protagonista vera (la generazione de) il genitore, cui i figli devono restituire la parola, e si traduce in un viaggio: Auschwitz per Janeczek, l’Ungheria per Schwed. I viaggi hanno però esiti diversissimi: rinforzamento del legame tra le generazioni in Janeczek, una strana e satirica esperienza in Schwed, nel cui libro il revisionismo nella forma più estrema e assurda prende le sembianze di un veterinario nazista, personaggio ambiguo che il protagonista si trova accanto come compagno di viaggio e che gli spiega che la seconda guerra mondiale è stata solo una grande recita. Un colpo impartitogli XI
dall’uomo e la successiva caduta dal treno, provocheranno un vuoto della memoria da cui la guarigione è lenta ma avviene lo stesso. Ovviamente, anche Schwed attraverso la non leggera satira accusa la dimenticanza imposta da certi ambienti intellettuali, soprattutto di sinistra. Il contributo di Giorgio Pressburger ‘Budapest‐Roma. Realtà ebraica fuori della lingua’, prende le mosse dalle proprie origini di ebreo ungherese, minoranza che ha sempre dovuto scegliere una lingua in cui esprimersi (ungherese, yiddish o tedesco). Grazie ai rapporti plurisecolari con l’Italia, non di rado ebrei magiari come Svevo, Vagliani, Bruck e Kemenyi, nonché gli stessi fratelli Pressburger, scelsero di vivere in Italia e/o di esprimersi in italiano. I risultati di questa metamorfosi linguistica possono essere tra loro assai dissimili, sia a livello linguistico che a quello identitario. Ovviamente per un ebreo, con una fascia identitaria in più, la situazione si può complicare ulteriormente e l’appartenenza – come succedette alla fine dell’Ottocento – rischia di diventare problematica. Pressburger addita alcuni importanti punti interrogativi, come il rapporto mutato tra azkenaziti e sefarditi, e la questione identitaria dopo la Shoah, cui è stata data forse una risposta da Jean Améry, Primo Levi e Edith Bruck. Come la Budor, anche Inge Lanslots analizza nel suo articolo ‘L’ineluttabilità del destino nell’opera narrativa di Giorgio Pressburger’ il romanzo genealogico L’orologio di Monaco. Giova subito constatare che piuttosto che a degli antenati, lo scrittore si dedica a presunti familiari, a legami non più biologici ma culturali o intertestuali che vanno da Heinrich ed Einstein a Schumann e Süsskind. A muovere la ricerca dell’autore sembra essere l’irriquetudine dell’uomo spaesato della galut (l’ebreo errante, dunque) di cui la ‘mania genealogica’ è espressione. Lanslots inserisce giustamente la tematica del libro nel contesto delle opere dei fratelli Pressburger, dal debutto Storie dell’Ottavo Distretto fino a La neve e la colpa, in molte delle quali la tematica sfocia nella morte o ne prende le mosse. Questa linearità ineluttabile è spesso accompagnata dalla ciclicità di microstorie in cui si rivive la grande tragedia della Storia. Nella conferenza di Miro Silvera ‘La necessità di raccontare’, un altro scrittore protagonista del convegno prende la parola in prima persona. Per Silvera l’oralità caratterizza gran parte della letteratura ebraica, in cui il testo scritto diverso dal commento biblico emerge relativamente tardi, e lo scrittore si è per molto tempo mimetizzato, anche convertendosi. Per Silvera, la generazione più giovane è invece fiera della propria identità ebraica in cui si incontrano tradizioni tanto diverse fra di loro. Questa coscienza orgogliosa permette anche allo scrittore di vivere la propria missione etica di narrare e di far riflettere il lettore. Qui, Silvera, come nel suo recente libro Contro di noi (2003), si vede chiamato ad avvisare contro il pericolo dell’integralismo islamico. In ‘Multiculturalità ottomana e scrittori italiani da Saul Israel a Miro Silvera e Daniel Fishman’, Raniero Speelman mette in evidenza la provenienza ottomana (cioè, dal territorio dell’ex Impero, dalla Libia alla Bulgaria e la Siria) di alcuni importanti scrittori italiani. Se in Saul Israel, nato in Salonicco ormai annesso alla XII Grecia, la coscienza ottomana si tradusse in una nostalgia della cultura popolare turca, l’Aleppo di Miro Silvera è segnata dall’imminente espulsione della componente ebraica, descritta nel suo ultimo secolo di splendore e fertilità multiculturale. La nostalgia dell’origine assume i valori drammatici di una discesa agli inferi nel romanzo semimitico e di autobiografia ideale Il prigioniero di Aleppo. La stessa posizione dei Silvera si riflette nell’Egitto di Fishman, che riscopre ed esplora a un’età adulta ne Il chilometro d’oro la terra dei padri e ricostruisce in questo romanzo generazionale il tramonto di una società ebraica e della colonia commercial‐culturale italiana. Sull’espulsione dall’Egitto è intanto apparso anche un altro libro di ricordi di Carolina Delburgo, Come ladri nella notte (2006). Qui si tratta di una testimonianza in prima persona. Come Pressburger, anche Carmela D’Angelo affronta nel suo saggio ‘La dimensione transculturale della letteratura in lingua italiana di scrittori afferenti alla cultura ebraica del Novecento postbellico’ il problema della plurima identità e la conseguente scelta linguistica che hanno dovuto affrontare molti ebrei, con esiti talvolta ibridi e/o di creolizzazione. Anche il ‘nomadismo’ ha condotto a situazioni di poliglossia e di scelte apparentemente sorprendenti di idioma, come si è visto già nei contributi precedenti. Fra la ricca serie di esempi, si possono menzionare oltre alla Bruck e ai Pressburger, Marina Jarre, Alain Elkann, Elena Janeczek e Daniel Fishman. Ma l’uso di altri idiomi, oggi così notevole nell’Egitto di Fishman, è già riscontrabile nel classico Giardino dei Finzi‐Contini di Bassani. D’Angelo finisce con il porsi alcune domande molto interessanti. Innanzitutto quella se la millenaria esperienza ebraica può aiutarci a comprendere meglio, come esempio avant la lettre, la nostra nuova situazione in cui transnazionalizzazione e transculturalizzazione – piuttosto che pluri/multiculturalismo – sono sempre più importanti. Certo che potrebbero illuminare meglio la situazione della stessa Italia e soprattutto della Sicilia come terra dove si sono incontrate e fuse tante culture. Marilena Renda parte nel suo contributo ‘Lo spazio e il linguaggio. Note a margine su ebraismo e scrittura’ dallo stesso dato di fatto, mettendo in rilievo però il ruolo degli ‘spazi bianchi’ (Pressburger, Levi della Torre) da interrogare, del non detto, dell’assenza che comporta la galut – che significa anche ‘rivelazione’. Ciò corrisponde al processo di esegesi biblica praticata da chi legge la Bibbia, in cui si verifica un incessante slittamento dal presente del testo all’assente e al suo potenziale avvenire. Se secondo un filone critico l’ebraicità è definibile solo in negativo (si pensi alla rimozione freudiana, o alla scrittura di Kafka), in che direzione deve andare il nostro sguardo di lettori di testi? La risposta è, secondo Renda, alle pieghe del discorso, al non‐detto. Anche in scrittori come Levi e Bassani, così aperti nel loro porre le persecuzioni subite al centro del discorso, si può scavare in una zona d’ombra, scoprendo che “una parola giunta sull’orlo dell’abisso” non può che “ritrarsi nel pudore o nel silenzio, facendo spazio al silenzio dell’indicibile”. Sarà qui che nasce una parola neutra, che predilige la domanda alla risposta, e che è più in grado di esprimere il vécu ebraico. XIII
LA SCRITTURA AL FEMMINILE: CLARA SERENI ED ALTRE SCRITTRICI L’articolo di Ada Neiger ‘Da Elsa Morante a Elena Loewenthal. Breve viaggio nell’ebraitudine’ fornisce una valida introduzione ad un argomento che si è più volte ripresentato nel corso del convegno, cioè la scrittura ‘al femminile’. Innanzitutto però la studiosa si pone la classica domanda “chi è ebreo” e passa alla rassegna anche risposte polemiche (Yehoshua, Todorov, Atzmon, Freud, Ben Gurion, Luzzatto e Ovadia). Neiger tratta sinteticamente Elsa Morante, le superstiti Giuliana Tedeschi, Liana Millu e Esther Joffe Israel (quest’ultima, scrittrice di un testo in francese e tradotto in italiano come Vagone piombato), le immigrate Edith Bruck, Elisa Springer e Helena Janeczek, e infine Clara Sereni e Elena Loewenthal, scrittrici che vivono la loro ebraicità con naturalezza. Anche Hanna Serkowska esamina nel suo contributo ‘La Shoah ha un genere? Il caso di alcune scrittrici ebree di lingua italiana’ una pluralità di scrittrici: Angela Bianchini, Marina Jarre, Giacoma Limentani, Lia Levi, Edith Bruck e Clara Sereni, unendo la prospettiva di genere a quella del ricordo della Shoah. Se da un lato, infatti, viene ribadito sempre più l’importanza della Shoah per la destrutturazione delle avanguardie, pare sottovalutato d’altro lato il contributo femminile a quel ramo della memorialistica. Le scrittrici esaminate da Serkowska condividono una forte misura di protagonismo femminile (con madri forti e padri spesso assenti) in cui le donne raggiungono un alto grado di razionalismo pragmatico e ingegnosità per far fronte ai problemi della vita. Nel contesto del lager ciò trovò espressione nella costituzione di gruppi femminili di soccorso che assumevano il ruolo di famiglie sostitutive, fatto molto raro fra detenuti maschili, tra cui predominava il dolore della la perdita del ruolo sociale. Altra differenza di genere è l’accento che le scrittrici pongono sulla sofferenza fisica in combinazione con l’umiliazione sessuale, laddove per gli uomini è l’inutilità e assurdità della sofferenze afflitte che si trova al centro dell’esperienza descritta. Analoga differenza si trova nei valori della religione e tradizione ebraica, molto meno enfatizzati da scrittori donna o addirittura percepite come loro imposti.
Maria Grazia Cossu si occupa nel suo ‘Voci di frontiera: il Ritorno in Lettonia di Marina Jarre’ di una scrittrice in cui la travagliata storia famigliare prende dimensioni nettamente multiculturali. In Jarre, separata in giovane età dal padre ebreo e trasferita in Italia, la ricerca della propria origine confluisce con l’interrogazione di una Shoah un po’ particolare, quella in Lettonia, nella quale furono attivamente coinvolti non pochi autoctoni. L’antisemitismo assume così, come per Schwed, un posto importante nell’analisi storica. Al contempo, la ricostruzione della gioventù e della figura del genitore rientra anche in un discorso di letteratura al femminile (si pensi a Cialente, Romano, Morante, Maraini e, forse, Bruck). Ritorno in Lettonia (2003) conclude un discorso iniziato con Un leggero accento straniero (1972) e I Padri lontani (1987). Il caso di Jarre è interessante anche perché l’ebraismo vi si trova filtrato attraverso la fede ed esperienza protestante, quindi di una religione che in Italia ha avuto rapporti di una certa vicinanza con l’ebraismo. XIV Il contributo di Gabriella De Angelis apre una serie di lavori dedicati a Clara Sereni, la scrittrice che si è autodefinita donna, ebrea, comunista, intellettuale e madre handicappata, parole che si incontrano spesso negli studi dedicatile. Nel suo articolo ‘Clara Sereni: la sfida della differenza’, De Angelis si sofferma sulla sfida che la scrittrice ha dovuto affrontare: tenere insieme tutti questi aspetti della propria personalità, senza però ubbidire ciecamente alla pressione di schierarsi. A tale scopo essa parte da due libri che considera testi chiave, Il Gioco dei Regni (1993) e Taccuino di un’ultimista (1998). Dove il primo libro si inserisce nel filone del romanzo genealogico, il secondo, mosaico di brani sparsi che coprono dieci anni di vita e tratta una varietà di argomenti può illustrare la ricchezza delle esperienze che la Sereni descrive (dalla vita in Israele alla condizione femminile e al confronto con il terrorismo e con il mondo arabo). De Angelis confronta i testi di Sereni anche con due recenti opere della letteratura israeliana dedicate alla sfida di continuare a vivere in un mondo travolto dalla violenza terrorista, Inno alla Gioia di Shifra Horn e Il responsabile delle risorse umane di Abraham B. Yehoshua. Serena Anderlini esamina nel suo ‘Utopias, Metabolized: Queering Communism and Zionism in Clara Sereni’s testimonial narratives’ la dimensione politica nei due libri forse più letti della scrittrice perugina: Casalinghitudine e Il gioco dei regni. Anderlini focalizza la sua analisi in primo luogo sul rapporto ambiguo che la scrittrice ha con Israele, l’ebraismo e il pensiero utopico ivi vigente (comunismo, sionismo, eccetera). Il discorso prende in considerazione la corrente dell’ecofemminismo e la politica idrica di Israele. Anderlini pone che l’utopia sionista non sia stata realizzata e invece sia nata una specie di apartheid palestinese. Entrambi i libri di Clara Sereni costituiscono un avvertimento dei rischi in cui incorre chi non riesce a rinunciare in tempo ai propri ideali utopici. Ciò viene illustrato con una citazione dal romanzo, in cui Sereni giustappone comunismo e sionismo. Si potrebbe interpretare il ‘gioco’ del titolo come l’interazione tra i quattro (soprammenzionati) ‘ingredienti’ della personalità della scrittrice. Non è coincidenza la presenza di utopismo nella sua storia famigliare (nonno, zii – Enzo e Ada – mamma, padre), storia ricostruita attraverso la scrittura in un processo terapeutico. Nel suo articolo ‘Speaking “as a” and Speaking “for”: Multiple Appartenenze in the Autobiographical Macrotexts of Aldo Zargani and Clara Sereni’, Mirna Cicioni confronta due scrittori che hanno in comune, oltre al posizionamento politico laico e di sinistra, una vasta produzione di opere ad ispirazione autobiografica. Si rivolgono in gran parte allo stesso pubblico dei ‘ceti medi riflessivi’ e le loro opere costituiscono un macrotesto autobiografico. Laddove per Zargani l’evento centrale della vita è la Shoah vissuta da bambino rifugiato, per cui la vita è spezzata in due frammenti ineguali: il tempo dei sette anni di persecuzione si è moltiplicato a dismisura ed è divenuto un’escrescenza dell’anima.12 per Sereni le appartenenze sono almeno quattro che si incrociano, come abbiamo visto in altri contributi dedicatile. Zargani spiega la propria identità in primo luogo XV
ai non‐ebrei, mentre Sereni parla come ebrea, ed è quella la differenza cui Cicioni riferisce nel titolo del saggio. In entrambi gli scrittori è illustrato l’uso di ironia e umorismo, impiegati per evidenziare una posizione eccentrica. Sereni se ne serve per esporre i conflitti fra le varie sue ‘appartenenze’, e Zargani per mettere in evidenza le contraddizioni e complessità dell’essere ebreo. Nel suo saggio ‘Casalinghitudini tra identità e storia: la scrittura pluristratificata di Clara Sereni’ anche Federico Pellizzi parte da due testi di Clara Sereni: Casalinghitudine (1987) e Le merendanze (2004). Centrale nell’opera di Sereni, scrittrice nata nell’immediata dopoguerra e che si muove dunque nella zona tra la remembered history e la imagined history, per riprendere la distinzione di Elrud Ibsch, è il tentativo di connettere la storia personale e la storia di una generazione. La vita quotidiana costituisce il tessuto sulla quale si innesta la ricerca della scrittrice e il cibo, “regolatore dei rapporti tra le persone”, ne è quasi il simbolo. Fra i generi prediletti da Sereni il diario assume un posto di primo rilievo ed è in qualche modo presente in tutte le sue opere. Attraverso l’esperienza personale avviene in Casalinghitudine la ricreazione del genere libro di cucina, nel quale le ricette si sostituiscono alle date degli eventi vissuti. Pellizzi individua in Casalinghitudine come in molti altri testi sereniani una molteplicità di rappresentazioni del sé e di ricerca delle radici e dell’identità, passando per e facendo i conti con le varie tipologie di personae. I personaggi di Sereni, consci della loro solitudine e dolore, vivono una vita di lotta per la propria autonomia. Pellizzi mette in evidenza l’evoluzione degli elementi diaristici tra Casalinghitudine e Le merendanze. Dove nel primo libro c’è tensione fra il tempo delle ricette e quello del ricordo, nel secondo questa si risolve nel tempo del ‘mondo commentato’. L’EBRAISMO IN TUENA E PIPERNO Una scrittura che merita considerazione in una sezione a parte è quella di scrittori non ebrei che hanno dedicato all’ebraismo opere letterarie. Spetta forse a Walter Scott aver dato, all’inizio dell’Ottocento, dignità a caratteri ebraici in Ivanhoe (1820).13 Sempre nelle lettere inglesi, George Eliot ha creato in Daniel Deronda (1876) una storia con un ebreo come protagonista. Il più illustre figlio di questo ceppo è senza dubbio Leopold Bloom in Ulysses, scritto da uno scrittore che conosceva abbastanza bene l’ebraismo triestino e fu amico di Schmitz/Svevo. Gli ebrei nella letteratura italiana emergono più tardi, forse con il dramma giovanile Emanuele (1852) di Ippolito Nievo e più tardi con la novella pirandelliana Un goj.14 Prima della seconda guerra mondiale non sembra esservi grand’interesse a creare caratteri ebraici. Ciò non va interpretato in maniera negativa, ma consegue dall’alto grado di assimilazione degli ebrei italiani. Neanche la Shoah cambia molto questa situazione. Solo Curzio Malaparte dedicò ampio spazio alla Shoah nell’Est d’Europa nel suo Kaputt, un classico soprattutto fuori d’Italia. Fiorì in Italia una letteratura partigiana, ma personaggi ebrei ne sono generalmente assenti. XVI Solo negli anni novanta appaiono libri che si svolgono in ambiente ebraico, come Un altro mare (1991) di Claudio Magris e i due romanzi La variante di Lüneburg (1993) e Canone inverso (1996) di Paolo Maurensig. Non è casuale che entrambi gli scrittori provengano dalla regione Friuli/Venezia‐Giulia; si sa inoltre che Magris è specialista di cultura tedesca e mitteleuropea, compresa quella ebraica. Non romanzo, ma riflessione autobiografica è La parola ebreo (1997) di Rosetta Loy, dedicata al difficile e doloroso argomento dell’approccio delle leggi razziali e della diversità ebraica da parte dell’italiano comune. Il libro di Loy avrà forse avuto il merito di aver affrontato un soggetto difficile ma, in fin dei conti, inevitabile: il silenzio della maggioranza dei goyim, che dal 1938 voltarono la testa vedendo i propri ex‐amici o concittadini ebrei, quello che è stato descritto da tutta la memorialistica ebraica da Augusto Segre in poi e che la giovane Liliana Segre chiama una “zona grigia”, ampliando il famoso termine leviana oltre il filo spinato dei lager.15 Comunque sia, dagli anni novanta in poi la tematica ebraica è diventata anche interessante per scrittori non ebrei. Viene da pensare a Campo di sangue (1997) di Eraldo Affinati, e Un uomo che forse si chiamava Schulz (1998) di Ugo Riccarelli ed altri testi. Il libro di Filippo Tuena, Le variazioni Reinach (2005) è un esempio recente che ha avuto molto successo ed è stato più volte premiato. Nel suo contributo ‘Filippo Tuena, Le variazioni Reinach: l’inferno del lager dalla musica del niente’, Stefania Ricciardi ribadisce la grande originalità del libro di Tuena, che si trova all’incrocio fra fiction e biografia. Il libro ricostruisce la decadenza di una famiglia di banchieri francese‐ebraici che avrà Auschwitz come ultima tappa. Secondo Ricciardi l’originalità del libro sta nel suo approccio estetico, in cui il documento si fa racconto e il racconto si fa testimonianza della Shoah, simboleggiata dal ritrovamento negli archivi di un’università americana della sonata in re minore per violino e pianoforte composta da Léon Reinach ed ora anche incisa. Il libro di Alessandro Piperno non fa propriamente parte di questa letteratura dedicata dai goyim agli ebrei, bensì a pieno titolo della letteratura ebreo‐diasporica. Laddove l’esser figlio di padre ebreo e madre cristiana prima del 1938 non ostacolava minimamente l’esser considerato ebreo (infatti era il pater familias a determinare l’identità religiosa, anche attraverso il cognome), dal 1938 in poi divenne non di rado possibilità di rifugio dalle misure discriminatorie antisemitiche. Che un figlio di padre ebreo rivendichi la propria ebraicità, culturale ma non halachica e dunque rifiutata dai rabbini, è un fenomeno piuttosto recente che ha accompagnato la maggior presa di coscienza degli ebrei europei. Nei Paesi Bassi esiste ormai una parola per indicarlo: ‘vaderjood’ (ebreo da parte di padre), che è andata a sostituire l’espressione meno corretta di ‘halfjood’ (mezzo ebreo, che ricordava anche le leggi razziali), e non pochi ‘vaderjoden’ si sono organizzati per ottenere la piena ugliaglianza nelle kehillot (comunità). Secondo i Beth Din (i tribunali rabbinici) l’ammissione non può avvenire che attraverso il ghiur, la conversione. Questa però non è affatto facile, nemmeno per il vaderjood. Il dramma identitario di chi nasce con un nome insospettabilmente ebreo e dal mondo esterno è considerato tale ma per gli ebrei non fa parte del loro gruppo, è un motivo importante della letteratura ebraica in senso largo, e – penso – destinato ad XVII
aumentare di peso finché il mondo ebraico non si mostrerà più accogliente nei suoi confronti. Questa problematica costituisce uno dei principali motivi del romanzo Con le peggiori intenzioni. Nel suo articolo ‘Alessandro Piperno: una visione iconoclasta dell’ebraicità’ Sophie Nezri‐Dufour contrasta l’ebraismo intimista delle prime generazioni di scrittori ebrei (Svevo, Bassani e Levi) con l’irriverenza di Piperno, che parla in maniera aperta e sacrilega della realtà e identità ebraica. Nella satira in cui sfocia spesso il romanzo, non è difficile indicare modelli americani come Woody Allen, Saul Bellow e soprattutto Philip Roth, cui Piperno è stato infatti spesso paragonato e che in un certo senso plagia apertamente. Nel problematico rapporto identitario, compare il cosiddetto ‘odio si sé’ (conosciuto anche con la parola tedesca Selbsthass) ebraico, ma al contempo si fa sentire una certa nostalgia dell’ambiente dei suoi antenati, al quale Piperno attinge pure il proprio umorismo nero. Complesso ma importante libro, dunque, che ha condotto a forti polemiche nel mondo italoebraico e no, ma che ha saputo mettere il dito su alcuni punti dolorosi non da sottovalutare. Ancora un altro contributo, non incluso negli atti, è stato dedicato a Piperno, quello dei giovani laureandi Agnese Semprini e Francesco Ziosi. Essi hanno accostato nella loro conferenza ‘Le diasporiche intenzioni di Alessandro Piperno’ il suo romanzo a testi della letteratura israeliana, come Il signor Mani di Abraham Yehoshua e Black Box di Amos Oz. Piperno rappresenterebbe per loro una crisi di identità ebraica, in cui da un lato l’‘aliyah ha cambiato l’idealismo ebraico e, dall’altro, si riscontra una forte rimozione risultante in una ‘antimemoria diasporica’ con tratti esibizionisti. CONCLUSIONE: ANDARE AVANTI Un approccio generazionale permette di riconoscere scelte di genere e tipologie di elaborazione letteraria. Dove dall’epoca dell’Illuminismo in poi l’assimilazione fece vedere l’ebraismo come ‘qualcosa di più intimo’, per rifarci un’altra volta al titolo del bello studio di Luca De Angelis, a partire dal 1938 l’identità ebraica fu motivo di discriminazione e peggio e non si poté più rilegare al margine di una personalità di scrittore. Nel periodo dopo la Shoah si vedono successivamente la testimonianza diretta, il romanzo genealogico e la fiction più neutra come esiti, mentre ancora la generazione dei primi porta la propria testimonianza orale o scritta ad un vasto pubblico italiano. Negli ultimi decenni sono emersi nuove voci, spesso di donne della seconda e terza generazione, che si esprimono coscientemente come ebree. Il presente convegno ha certo prestato attenzione a voci nuove o meno conosciute della letteratura italoebraica, ma ha anche presentato interessanti riletture di autori affermati come Bassani, Morante e Levi. Credo che queste continue letture dei classici si possano certo difendere. Vorrei ricordare il precetto dello Zirkel im Verstehen (cerchio ermeneutico) del grande studioso ebreo Leo Spitzer (1887‐1960), di leggerle sempre di nuovo in modo che le conclusioni di un ciclo di lettura si facciano punto di partenza di una lettura successiva la quale, partendo da un punto di vista e XVIII conoscenza superiore, permetterà a sua volta di raggiungere risultati più ricchi. Quello che pare movimento a cerchio è, quindi, in realtà uno spirale ermeneutico ascendente. Non sembra una coincidenza che si tratti in fondo dello stesso metodo con cui scolari da secoli hanno letto la Torah. Credo non troppo spinto menzionare qui, più in generale, il grande apporto da parte di filologi e critici ebrei allo studio della lingua e letteratura italiana (si pensi a A. Musafia, G.I. Ascoli, E. Auerbach, A. Momigliano, S. e G. Debenedetti, C. Segre, C. Cases, G. Fink, M. Fubini e molti altri). Il convegno ha unito in un incontro intensivo un gruppo internazionale di specialisti e alcuni importanti scrittori odierni. Nel dibattito conclusivo ci si è posti la domanda quali argomenti meriterebbero in particolare di essere approfonditi. Fra quelli indicati e successivamente emersi sono da segnalare il rapporto fra la letteratura italiana e quella italoebraica e la ricezione di quest’ultima, il ruolo del multiculturalismo, la trasmigrazione linguistica, la (auto)definizione di identità, la letteratura italoebraica delle generazioni prima della guerra, il ruolo della religione e tradizione ebraiche nella scrittura, e le relazioni fra tematiche ebraiche e scrittori goy e, vice versa, la maniera in cui scrittori ebrei hanno trattato tematiche tipicamente non‐ebraiche. È nostra intenzione proseguire in questa direzione, e di organizzare altri convegni, possibilmente in Belgio e in Istanbul. Le iniziative future saranno annunciate sul sito gestito da ICOJIL. NOTE Cfr. Disegni 1956, 78‐81. 1
Per gli ebrei fascisti, alcuni dei quali della prima ora e perfino casi isolati fino alla fine del regime, cfr. Stille 1991. 2
3
Per la mostra di fotografie inaugurata in dicembre 1955 a Carpi, la quale ha poi viaggiato in tutta l’Italia, vedi http://www.istoreto.it/didattica/2701_immaginisilenzio_06.htm. Fra le generazioni più vecchie, gli unici scrittori datì (osservanti) sono i rabbini Elio Toaff e Augusto Segre, e sono entrambi memorialisti. 4
Cit. da Ghisalberti 2002. 5
A prescindere dai Paesi arabi, dove esiste in forma spesso ufficiale, anche nell’odierna Turchia cosiddetta ‘moderatamente islamica’, Mein Kampf è stato recentemente un bestseller e abbondano libri su ‘congiure giudaiche’, teorie condivise anche da noti intellettuali. 7 È merito di Pietro Citati aver introdotto in un suo articolo apparso su La Repubblica la suddivisione dell’antisemitismo, distinguendo tre tipi storici diversi (cristiana, di destra, di sinistra). 6
La collana è stata inaugurata nel 2006 con gli atti del convegno internazionale The Value of Literature in and after the Seventies: The Case of Italy and Portugal, http://congress70.library.uu.nl/. 8
Intervista a Edoardo Fadini 1966, cit. da Luzi. 9
Cit. nell’articolo. 10
XIX
Cit. nell’articolo. 11
Cit. nell’articolo. 12
Divertente l’aneddoto raccontato da Enrico Deaglio ne La banalità del bene, a proposito della popolarità di Scott nell’Est dell’Ungheria. Negli anni anni trenta del Novecento, un viaggiatore inglese incontrò un ragazzo che gli chiese se Scott era ancora in vita. Apprendendone la morte, se ne dispiacque moltissimo perché “per lui e per i suoi correligionari era il romanzo dell’ebraismo riscattato” (1991: 106). 13
Il pezzo teatrale di Nievo stato recentemente ripubblicato in Drammi giovanili (2007). 14
Segre 2005, 13. 15
BIBLIOGRAFIA Citati, Pietro. ‘Il nuovo antisemitismo che si aggira per l´Europa’. La Repubblica (28.08.2006). Deaglio, Enrico. La banalità del bene. Milano: Feltrinelli 1991. Disegni, Dario. ‘Il rito di Asti, Fossano, Moncalvo (Appam)’. Scritti in onore di Sally Mayer, Milano‐
Gerusalemme: Fondazione S. Mayer 1956: 78‐81. Ghisalberti, Carlo. ‘Educazione ebraica e patriottismo in Nello Rosselli’. [2002] Pensiero mazziniano ‒ 22‐07‐2007 http://www.domusmazziniana.it/ami/pm/due1/ghisalberti.htm. Nievo, Ippolito. Drammi giovanili. Emanuele. Gli ultimi anni di Galileo. Venezia: Marsilio 2007. Segre, Liliana. Sopravvissuta ad Auschwitz, a cura di Emanuela Zuccalà. Milano: Paoline 2005. Stille, Alexander. Uno su mille. Milano: Mondadori 1991. XX IBSCH, Elrud. ‘Memory, History, Imagination: How Time Affects the Perspective on Holocaust Literature’. Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational Approach. Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐
7. 1‐11. SUMMARY With reference to the concepts memory, remembered history, and imagined history regularities in the historical development of Holocaust literature can be described. In addition to different chronological stages the concepts represent different genre conventions, ranging from testimonies (diaries, autobiographies) to autobiographical novels to, finally, narrative fiction. The first ‘literary’ responses could not come from other sources than the survivors who, after a period of traumatic speechlessness, put their memories into words. Later, others began to write, in particular the descendents of witnesses who felt the need of remembering the history of their families. Finally, from the 1980s on, the Holocaust as a literary theme lost its poetic restrictions and became an element of the imagination. Notwithstanding their primarily documentary function, testimonies carry the traces of the selective recollection of the writing subject (example: Primo Levi’s ironical interventions). Authors of the second and third generation, who try to remember history, frequently use the narrative structure of the quest (examples: Amir Gutfreund, Patrick Modiano, Elsa Morante). A striking element in literary representations based on the imagined history of the Holocaust is the recurrent playing with the identities of victims and perpetrators, the genre of the satire being the most adequate literary expression of that theme (early examples of a satirical representation: Edgar Hilsenrath and Romain Gary; contemporary ones: Arnon Grunberg and Alessandro Piperno). KEYWORDS Memory, history, remembered history, imagined history, irony/satire © The authors The proceedings of the international conference Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational Approach (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 October 2006) are volume 2 of the series ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, published by Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 1
MEMORY, HISTORY, IMAGINATION HOW TIME AFFECTS THE PERSPECTIVE ON HOLOCAUST LITERATURE Elrud Ibsch During my research on the Holocaust literature of various European countries and Israel I observed some regularities in its historical development. Although I am not a specialist of Italian literature, perhaps my theoretical reflections can be of some use to historians of Italian literature. If something happens to a human being, in the first place there is the experience. In principle, experiences are non‐verbal, but usually the transfer into language takes place almost immediately. Verbalising an experience means to respect the logic of narration, including the phonological, syntactical, and semantic rules of the specific linguistic system. If the experience, however, is a traumatic one, the transfer into language may become problematic. A trauma occurs unexpectedly, means the loss of all safety, may threaten one’s life, and is humiliating. With respect to Holocaust traumas Dori Laub argues: The traumatic event, although real, took place outside of the parameters of normal reality, such as causality, sequence, place, and time. The trauma is thus an event that has no beginning, no ending, no before, no during, and no after. This absence of categories that define it lend it a quality of ‘otherness’, a salience […] outside the range of comprehension, of recounting, and of mastery. (Felman & Laub 1992, 69) It is not difficult to imagine that those who have experienced the concentration camps and have lost the categories within which normal reactions develop have a long way to go in regaining both the parameters of ‘reality’ and a sense of self‐
acceptance. Speechlessness with respect to the event may be one of the first reactions. Only when the victims are removed far enough from the traumatic experience to tentatively re‐experience it within the categories of time, place, and sequence may they find the words to tell their life story. At this point memory, briefly defined as the ‘mental repetition’ of a past experience functions as a source of knowledge and communication. This repetition is, of course, not identical with the past experience. An undeniable difference is the chronological distance. But there are others: regaining the parameters of reality and the wish to communicate the (traumatic) experience to others out of necessity involves certain transformations. Memories, in general, do not offer an unmediated access to the past. They have to be re‐created in the present. This applies in particular to traumatic memories that are not fully perceived as they occur.1 The written manifestation of memory is autobiography. Its public character requires a readable structuring and stylistic 2
elaboration: ‘beginning’ and ‘ending’, ‘before’, ‘during’, and ‘after’ are necessary principles of narration. I reserve the concept of ‘memory’ for the testimonies of those who experienced the concentration camps themselves. With respect to Italian literature Raniero Speelman mentions as examples of “testimonianze dei campi di concentramento” (concentration camp testimonies) writers such as Primo Levi, Edith Bruck, Liana Millu, Giuliana Tedeschi (1995, 69‐101). For the remembering of those who “were not there”, and the second and third generation I propose to talk instead of ‘remembered history’. This concept indicates that people who had no camp experiences themselves cannot mentally repeat the experiences of the camp but need the memorial narratives of witnesses, for example their parents. If the parents do not figure as obvious story tellers, they must search for traces of the events in libraries, images, and the official lieux de mémoires. There are many reasons why the parents are reluctant to recall their traumatic past, not the least being the wish not to pass on their traumas onto their children. The ‘remembered history’ of the Holocaust, often the history of their own families, is a frequent theme in the literary production of the so‐called ‘generations‐
after’. It often deals with the silenced past, the enormous efforts of the children to unveil and (re)construct what happened to their parents (or grandparents), and their own problems to survive in an environment which, on an amazingly large scale, appears to have forgotten about the fate of the European Jewry in the twentieth century. In ‘remembered histories’ as a literary genre, literary devices are more prominent than in testimonial memories. Although the historical events are highly respected, the narrator has more freedom with respect to reflecting his own ignorance, his laborious search for the truth and his decisions about dealing with chronology and tracing the characters. Another stage in the writing of the Holocaust is what I call the ‘imagined history’. To date, numerous historical studies about the Holocaust have appeared and a large amount of documentary information has been recorded. Notwithstanding the subjective perspective of any historical report, such information must be submitted to truth claims and be tested. Literature, including ‘imagined history’, is allowed to follow a different convention. A distinguishing feature of literary writing and reading is the need to negotiate fictionality, i.e. the creation or processing of narrated events which, if they happened at all, have been transformed via processes of de‐ and re‐contextualisation. In many cases literature contradicts official historiography instead of echoing it. Unlike fiction that does not subscribe to the task of commemoration, the fictional elements in Holocaust literature often give rise to critical reactions of readers who are not prepared and willing to suspend the truth claims that are part of the history of suffering and intellectual disaster. This, however, does not prevent writers of the younger generations (but not exclusively the younger ones) from resisting the generic restrictions of autobiographical writing and from claiming their own way of narrating the Holocaust. They want to explore their own limits of representation and feel free to choose a genre, a poetic program, a 3
new language. Whether they should write in a realistic, ironic, grotesque, or postmodernist mode depends on their own choice. HOLOCAUST LITERATURE: EXAMPLES OF GENRE CONVENTIONS ‘Memory’, ‘remembered history’, and ‘imagined history’ on the one hand represent different chronological stages with regard to the historical event of the Holocaust and, on the other, different genre conventions, ranging from testimonies (diaries, autobiographies), to autobiographical novels to, finally, narrative fiction. Genre conventions, however, do not exclude strong individual thematic and formal elaborations. Notwithstanding their primarily documentary function, even testimonies carry the traces of selective recollection and the modelling intervention of the writing subject. A comparison between two authors of survivor testimonies, Elie Wiesel and Primo Levi, reveals striking differences. Wiesel has no doubt whatsoever about the existence of God in and after Auschwitz. It is true that he does not abstain from asking why God remained silent, but fully accepts the answer of the Talmud scholar who said: “…et Dieu là‐haut pleure” (Wiesel 1994, 111).2 Primo Levi, on the other hand, considered the language of prayer inappropriate in a place like Auschwitz. He wrote: […] si vede e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn. (Levi 1977, 164)3 Wiesel’s narrative is about the victims. He refuses to write about the perpetrators: Pas les bourreaux. Je ne saurais décrire les Blockführer SS qui nous comptaient à l’appel, ni le Lagerführer qui assistait aux pendaisons. Bizarrement, les bourreaux ne m’intéressaient pas. Les victimes, oui. Les victimes seulement. (Wiesel 1994, 115)4 Levi, however, has no qualms about describing an SS officer: Pannwitz è alto, magro, biondo; ha gli occhi, i capelli e il naso come tutti i tedeschi devono averli, e siede formidabilmente dietro una complicata scrivania. Io, Häftling 174517, sto in piedi nel suo studio che è un vero studio, lucido pulito e ordinato, e mi pare che lascerei una macchia sporca dovunque dovessi toccare. (Levi 1977, 133‐134)5 I assume that readers intuitively will agree with me that the passage quoted can be read as an ironical one. The difficulty, however, appears when it comes to analyze this ironic quality. Supported by modern theorists of irony (i.e. Sperber and Wilson) I propose to define irony as: ‘the transfer of a linguistic utterance from a generally accepted context into a contrasting and unexpected one’. Sperber puts it as follows: “The speaker expresses a derogatory attitude to a meaning he or she merely mentions” (1984, 130). By echoing stereotypical opinions about Germans and Jews 4
Levi expresses an ironic perception of his situation. In fact, irony is his only protection against total and irrevocable submission, a self‐protection in a situation of ultimate threat. If there is no chance of effectively opposing an adversary who is in full possession of power, the only means to maintain human dignity is intellectual superiority. Echoing the norms and values of an adversary is a way of ridiculing their validity. The search for knowledge, however painful it may be, is a strong characteristic of the authors of the generations‐after but also of those who were contemporaries of the genocide but did not experience the concentration camps personally. One example of an author whose novel is based on ‘remembered history’ with clearly autobiographical elements is the Israeli Amir Gutfreund, born in 1963. His novel Our Holocaust (Hebrew: Shoah Shelanu, 2000) is his debut. Living in Israel, Gutfreund experiences the consequences of the Holocaust in a comparatively direct way. The author writes against a silenced past. The theme and structure of the novel represent the search for getting access to the memories of the survivors, in order to recall their history. Briefly after the foundation of the State of Israel in 1948, the annihilation of the European Jewry had not been given much attention to, neither in Israeli politics nor in education or literature, in order not to contradict the national narrative of Zionism. The situation gradually changed with the Eichmann trial in 1961, but only in the 1980s the narrative of the pioneers gave way to the narrative of the victims coming from Europe. Gutfreund communicates a message that breaks an important taboo, namely that the victims of the genocide were not afflicted by the slightest human weakness. Carefully and with all imaginable respect, the author deprives the survivors of the aureole of perfect morality. The existential human desire to save one’s own life and that of one’s beloved requires different strategies than generally accepted morality can offer. In what is called ‘The Quarter’, a district in Haifa where survivors originally coming from Eastern Europe live, people suffer severely from their past experiences. Often their behavior is maladjusted, their mastery of Hebrew is deficient, their languages being Yiddish and Polish. Gutfreund describes the behavioral codes for regulating life in the Quarter mainly from the perspective of two children, the boy Amir and his girlfriend Effi. They suspect that the adults keep silent about important things and attempt to break the silence and unveil the secrets. The confrontation of two incompatible discourses, that of the children who ask their naive questions and that of the adults who avoid clear answers, expresses the gap between the lack of knowledge on the one hand and the burden of knowledge on the other. The efforts to break the silence are sometimes successful, but, whatever the children come to know, it is not a coherent story but only details, often unconnected. Many uncertainties remain and the feeling prevails that they would never be able to understand the Holocaust, because it happened in a completely different world, with different laws, not accessible to them. The merciless analysis of Gutfreund, at the end of his voluminous novel, leads to the conclusion that the attractive solution, i.e. to place the Holocaust on another planet, has to be rejected. The children have learnt an important lesson: 5
The Holocaust was an ordinary event. Ordinary people have committed it and ordinary people have been its victims. (Gutfreund 2003, 620) Authors who try to remember history frequently choose the narrative structure of the quest. The French novelist Patrick Modiano in Dora Bruder (1997) relies on places, dates, and pictures to give an identity to a young Jewish girl whose name he happened to come across in an old newspaper. In an issue of Paris Soir of December 1941 the parents of the girl ask for information about their daughter who suddenly had disappeared. In what follows the narrator describes his search for traces of the girl, his repeated walking to places she should have frequented, given the local indications in the newspaper. He goes to archives and, indeed, is successful to collect some important historical facts, as, for example, “Tourelles: 19‐6‐42 […] Bruder, Dora: Drancy le 13‐8‐42” (Modiano 1997, 114). What remains, however, is a strong feeling of absence and void: J’ignorerai toujours à quoi elle passait ses journées […] C’est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites l’occupation, le Dépôt, les casernes, les camps, l’Histoire, le temps – tout ce qui vous souille et vous détruit – n’auront pas pu lui voler. (147)6 The narrator’s effort to restore Dora’s identity are in vain. The hypotheses and associations he makes in combining data and places are his own. They do not reveal the life of Dora; the dead do not speak, nor the ‘objective’ details. The loss cannot be undone. Looking at Jewish authors in Italy I propose to classify Elsa Morante’s La Storia (1974) as an example of ‘remembered history’. The History with capital H (of World War II) is represented in the novel as introductory shorthand information of the years 1941‐1946. The follow‐up of this documentary information about dates and events tells the personal history of Ida Ramundo. Hers is a history of solitude, anguish, and love for her two sons who die at the end. The microcosm of Ida and her family is incisively, detailed, and touchingly described in the voluminous work. La Storia mirrors the high degree of assimilation of Italy’s Jewish community.7 Although often well established in the liberal professions and the arts, the Italian Jews were not protected from the racial laws and eventual deportation and murder: “The half‐decade of mitigated persecution came to an abrupt end in September 1943” (Hughes 1983, 60). Although Mussolini did not intend the physical extermination of the Jews, after 1943 “began the second and infinitely more brutal phase of Italian Jewry’s sufferings” (60). The character Ida appears to be terrified by her Jewish heritage, of which she experienced the threat but not the support and comfort. Historians of Italian literature are of course in a better position than I am to assess the degree of autobiographical elements in Morante’s La Storia. Proceeding to my third category, the ‘imagined history’ of the Holocaust, one may expect that the rise of this genre occurred at the time that the voice of the victims 6
had become less prominent or even had been silenced. Generally speaking, imagination in Holocaust literature indeed belongs to the poetic principles of the second and third generation. There are, however, remarkable exceptions as, for example, La Danse de Gengis Cohn (1967) by Romain Gary and Der Nazi und der Friseur (1977) (The Nazi and the Barber: A Tale of Vengeance (1975)) by Edgar Hilsenrath. Both authors, one French, the other German speaking, were young men during World War II. Hilsenrath was deported to the ghetto in Mogiley‐Podolsk; Romain Gary, during World War II, served as an officer of the French army; after the occupation of France he joined the air force of De Gaulle in London. Their novels belong to the genre of the satirical grotesque. This means that they are deliberately anti‐realistic and playfully carnivalesque in the sense of Michael Bahktin, who interprets the carnival as a subversive reaction to an illegitimate display of power. Undermining the abuse of power means, as in the case of irony, to defend one’s own dignity. The subversive answer to the claims of those in power mitigates the dichotomy of victim and victimizer, life and death, the self and the other. However, in contradistinction to irony the grotesque is to a lesser degree purely intellectual but explores instead the corporeality of the protagonists. Gary’s novel is a play with Jewish and German identities. A former SS officer has been through the denazification process and, as happened in comparable cases in German political reality, in the 1960s occupies a leading position with the police. The past, however, has caught up with him. He has become possessed by a Dibbuk. A Jew, named Gengis Cohn, whom the officer ordered to be shot in Auschwitz, has taken over his mind and body. He cannot but appropriate Cohn’s opinions and comments. Cohn and the former SS officer are condemned never to leave each other. The attempt to destroy all Jewish identity has had the opposite result: the Jewish identity is now an integral part of German identity. The story, on the one hand, abounds of numerous absurd situations but, on the other, is full of cultural criticism and ethical commitment. In the novel Der Nazi und der Friseur two young boys, Max Schulz and Itzig Finkelstein, are intimate friends. Playing with the stereotypes of racial features, the author provides the Aryan Max with the physiognomy of a Jew, whereas the Jew Itzig looks like a perfect Aryan. During National Socialism Max, as a member of the SS works in an extermination camp and is responsible for the death of many Jews, among them his friend Itzig and his family. After the war he appropriates the Jewish identity of his former friend and continues life as Itzig Finkelstein. He makes a thorough study of Judaism and finally goes to Palestine to become a freedom fighter there for the case of the Jews. At the time of their publication the novels of both Gary and Hilsenrath were not well received. The opinion prevailed, even among the most leading critics, that one should not write about the Holocaust in this way. Today, however, the novels are much appreciated, reprinted and translated. At a time that survivors after a period of silence began to speak, only their authentic report found acceptance. Production and reception followed different paths. Whereas with respect to the 7
production of Holocaust literature the phases ‘memory’ – ‘remembered history’ – ‘imagined history’ show incidental overlap, the reception process appeared to be more strictly sticking to the chronological order. Exceptional during the 1960s and 1970s, the imagined history of the Holocaust came to full blow only two decades later. In 1986 David Grossman (born 1954 in Jerusalem) published the novel See Under: Love. In the first part of it, which tells the story of the boy Momik in search of the truth of the Holocaust, the author uses the theme and structure of remembered history: the child trying to unveil the silenced past of his parents. The three other parts, however, rely heavily on intertexts, such as (1) the fictionalized life story of the Polish poet Bruno Schulz,8 (2) a parody of Thousand and One Night, and (3) the imitation of an encyclopedia of which the first entry is ‘love’ (in accordance with the Hebrew alphabet rather than with the English one). These devices place See Under: Love in the literary tradition and, in a sense, have it protected by this tradition. Here the free play of imagination is the primary impulse. The Dutch author Arnon Grunberg (1971) published the novel De Joodse Messias (The Jewish Messiah) in 2004. He was already well‐known as the author of Blauwe maandagen (1994) (Blue Mondays, 1997) and other novels. Grunberg’s novels deal with sex, alcohol, troubles within the family and at school. The author unmasks ideals, illusions, and authorities, even the authority of the Holocaust. His style is full of wittiness, verbosity, over‐ and understatements, and plays on words. The Jewish Messiah is a remarkable mixture of tragedy and comedy. The author leaves the Holocaust at a distance, although it appears to be a decisive element in the history of the main character’s family. The grandfather of the high school student Xavier was a Nazi officer who held a position in a death camp. His grandson set out to give the Jews comfort, reduce their pain and become a perfect Jew himself. The first Jew he tried to save from distress was his schoolmate and lover Awromele. Instead of attaining this end, however, he loses his friend, who is murdered by terrorists. The novel is full of ironical situations, jokes, and witty dialogues. But irony can nowhere conceal the essentially tragic foundation of the lives of the many characters, Jews and non‐Jews alike. I think that one may easily detect a comparable language of irony and thematic deep structure in Alessandro Piperno’s novel Con le peggiori intenzioni (2005), which deals with the strained relationship of Judaism and Catholicism in Italy, in particular the problems of intermarriage. In Con le peggiori intenzioni pity and love are hidden behind merciless cynicism. A striking element in literary representations based on the ‘imagined history’ of the Holocaust is the recurrent playing with the identities of victims and perpetrators. In particular for authors ‘who were not there’ it apparently remains a tormenting question how it was possible that the Germans – with a philosophical tradition of humanist values and a culture which was very close to that of educated Jews – turned into their most irreconcilable enemies. Rewriting the history of the Holocaust is a frequently used and genuinely postmodernist procedure of ‘imagined history’. American novelists, Jews and non‐
8
Jews alike, have contributed a lot to the genre. As a Dutch author I could mention Marcel Möring with his novel In Babylon and his most recent one, called Dis, a rewriting of both Dante’s Inferno and Joyce’s Ulysses. The non‐Jewish Austrian author Christoph Ransmayr wrote Morbus Kitahara which is a striking example of rewriting postwar history. I come to my conclusion. Indeed, time changes the perspective with respect to the possibilities of writing and reading the Holocaust. The first ‘literary’ responses could not come from other sources than the survivors who, after a time of traumatic speechlessness, put their memories into words. Later, others began to write, in particular the descendents of witnesses who felt the need of remembering the history of their families. Finally, from the 1980s on, the Holocaust as a literary theme lost its poetic restrictions and became open to the imagination. This happened not without consequences: the ‘imagined histories’ of the Holocaust are more at the mercy of critical judgments than the genres that are deemed to be more authentic ones. It was surprising, as I mentioned already, that a number of satirical grotesque novels appeared almost at the same time as most of the testimonies, although it is clear that one cannot think of literary genres more opposite to each other than memorial and satirical writing. However, keeping in mind that irony, mockery, and carnivalesque distortions are important sources of knowledge of oneself and the other, one may assume that they are helpful for human beings who are suffering. The intellectual superiority expressed in these modes of writing may be a means for emotionally regaining the respect of oneself. In my view the grotesque genre has been the appropriate counterpart of the testimony. The belated acceptation by literary critics does not contradict my analysis: we all had to learn and are still learning how to cope with inhumanity.
NOTES See Caruth 1995. 1
“God in the highest is crying”. The translation of the quotations is mine, unless otherwise specified. 2
“[ …] I see and hear old Kuhn praying aloud, with his beret on his head, swaying backwards and forwards violently. Kuhn is thanking God because he has not been chosen. If I was God, I would spit at Kuhn’s prayer” (Levi 2000, 154‐155). 3
“Not the perpetrators. I would not be able to describe the SS Blockführer who counted us during the roll call, nor the Lagerführer who assisted at the hangings. It is bizarre, but I am not interested in the victimizers. I am interested in the victims, yes, only the victims”. 4
“Pannwitz is tall, thin, blond; he has eyes, hair, and nose as all Germans ought to have them, and sits formidably behind a complicated writing table. I, Häftling 174517, stand in his office, which is a real office, shining, clean and ordered, and I feel that I would leave a dirty stain on whatever I touched” (Levi 2000, 125). 5
9
“I never came to know how she spent her daily life […] That’s her secret. A poor and precious secret that neither the brute and orderly, occupational authorities nor the Depot, the barracks, the camps, History or time could deprive her of”. 6
See: Hughes 1983. 7
An Italian rewriting of the life of Bruno Schulz is Ugo Riccarelli’s novel Un uomo che forse si chiamava Schulz (1998). 8
WORKS CITED Primary Sources Gary, Romain. La Danse de Gengis Cohn. Paris: Gallimard, 1967. Grossman, David. Ayen’Erekh: Ahavà. Jerusalem: Hoza’at Hakibbutz Hameuchad, 1986 (See Under: Love. London: Jonathan Cape, 1990). Grunberg, Arnon. De joodse Messias. Amsterdam: Vassallucci, 2004 (The Jewish Messiah). Gutfreund, Amir. Shoa Shelanu. Tel Aviv: Zmora‐Bitan, 2000 (Unser Holocaust. Berlin: Berlin Verlag, 2003). Hilsenrath, Edgar. Der Nazi und der Friseur. 1977. München: Piper, 1990 (The Nazi and the Barber: A Tale of Vengeance. London: W.H. Allen, 1975). Levi, Primo. Se questo è un uomo. 1958. Torino: Einaudi, 1977 (If This is a Man. The Truce. London: Everyman Publishers, 2000). Modiano, Patrick. Dora Bruder. Paris: Gallimard, 1997. Möring, Marcel. In Babylon. Amsterdam: Meulenhoff, 1997. ‐‐‐. Dis. Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. Morante, Elsa. La Storia. Torino: Einaudi, 1974. Piperno, Alessandro. Con le peggiori intenzioni. Milano: Mondadori, 2005. Wiesel, Elie. Tous les fleuves vont à la mer: mémoires. Paris: Seuil, 1994. Secondary Sources Bachtin, Michael. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. München: Carl Hanser, 1969. Caruth, Cathy, ed. Trauma: Explorations in Memory. Baltimore, MD: Johns Hopkins UP, 1995. Felman, Shoshana & Dori Laub. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York: Routledge, 1992. Hughes, Stuart. Prisoners of Hope: The Silver Age of Italian Jews 1924‐1974. Cambridge Mass. and London: Harvard UP, 1983. Ibsch, Elrud. Die Shoah erzählt: Zeugnis und Experiment in der Literatur. Tübingen: Niemeyer, 2004. ‐‐‐. ’Comfort and Scandal of Memory. Anne Michaels and Amir Gutfreund: Two authors of the second‐and‐a‐half generation’. Journal of Modern Jewish Studies 5/2 (2006): 213‐228. 10
Speelman, Raniero. ’Dall’argon al carbonio: la letteratura italiana ebraica del dopoguerra’. Gli spazi della diversità. Atti del Convegno Internazionale: Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992, volume secondo. Serge Vanvolsem, e.a., eds. Roma: Bulzoni/ Leuven: Leuven UP, 1995, 69‐101. Sperber, Dan. ‘Verbal Irony: Pretence or Echoic Mention?’ Journal of Experimental Psychology: General 113/1 (1984): 130‐136. 11
DE ANGELIS, Luca. ‘Come un amore illecito. Sulla teshuvah di Zeno’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 13 – 26. RIASSUNTO Nell’ambito della raffinata cultura del privato che definisce lo scrittore ebreo diasporico occidentale, esiste un movimento dello spirito più che intimo, che non si può dire che non esista solo perché non è comodamente evidente, solo perché ha a che fare con le profondità dell’anima. Questo moto interiore si chiama teshuvah ed è un’idea portante tra le più forti dell’Ebraismo, ravvisabile nel ritorno alla religione della sua infanzia di Zeno di cui si narra nel capitolo terzo de La coscienza di Zeno. L’area semantica di questo termine (dal verbo la‐shuv, ‘tornare’) interessa essenzialmente tre ordini di significato: innanzitutto significa ‘ritorno’, un tornare a Dio o alle radici ebraiche del proprio essere, ma nello stesso tempo suggerisce l’idea del ‘voltarsi indietro’ e dell’inversione della ‘direzione’, la risoluzione per un altro orienamento pratico; in terzo luogo significa ‘risposta’. In altri termini, configura nel profondo una presa di coscienza del proprio sommerso giudaismo attraverso cui sì avvia un processo di rigiudaizzazione‐riebreizzazione, preludio ad una sorta di riappropriazione dell’identità. Nel caso specifico, la condizione ebraica determina in modo rilevante la scrittura. Si devono, infatti, far risalire ad una sorta di teshuvah anche in letteratura, le palesi variazioni di poetica, le scelte stilistiche dell’ultimo Svevo. Si comprendono meglio le ragioni per cui l’ebraicità si mostri più accentuata e più presente nel tardo e più maturo Svevo, che più invecchia e più diventa scrittore ebreo. Evidentemente la teshuvah di Aron Schmitz, alias Italo Svevo, è possibile rinvenirla rispecchiata nella scrittura, che risente visibilmente di questo ritorno a se stesso come ebreo, dolce e celato come un amore illecito. PAROLE CHIAVE Intimità, Teshuvah, marranismo, patriarca, ironia © Gli autori/The authors Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 13
COME UN AMORE ILLECITO SULLA TESHUVAH DI ZENO Luca De Angelis Università di Trento MARRANISMO “L’uomo o almeno molti uomini non amano che le cose comodamente evidenti”, così scrisse Italo Svevo in Del Sentimento in arte.1 Se è così, allora come fare se le cose che riguardano l’ebreo sono tutt’altro che di comoda evidenza? Senza contare che più di ogni altro caso la carente cognizione, se non addirittura la partecipazione alla specifica realtà socio‐psicologica di ebreo, soprattutto negli episodi tutt’altro che rari ed infrequenti di un’ebraicità celata, gioca un ruolo decisivo nel riconoscimento dei riflessi della spiritualità ebraica provenienti dalle latenze della scrittura di Svevo, di uno scrittore che è segreto ed allusivo come pochi altri. Per di più, a complicare ulteriormente le cose, interviene un dato rilevante che ad uno sguardo non distratto è impossibile possa sfuggire: nel corso della storia moderna, interpretata nella sua accezione più larga, e con tutta la molteplicità dei suoi significati simbolici, la costante dell’“esperienza marrana rivela l’esistenza nell’Ebraismo e tra gli ebrei di una potenzialità del marranismo, di una predisposizione al marranismo”; alla fine la questione di una sindrome marrana connaturata allo spirito di Israele si risolve in una domanda e in una constatazione (che è anche una risposta): è il marranismo strutturalmente inerente all’Ebraismo, era esso inscritto sin dalle origini nell‘Ebraismo? Questa domanda è dettata e corroborata nella sua realtà dai fatti.2 E i fatti quali sono, letterariamente parlando? Sono quelli che lo scrittore ebreo ha sentito doversi presentare sotto copertura, se non mascherato. Beninteso, tuttavia, che ogni parola può essere una maschera, così come ogni opinione può essere un nascondiglio: “Tutto ciò che è profondo ama la maschera”, come recita un pensiero rivelatore del Nietzsche di Al di là del bene e del male.3 La stessa cadenza paradossale struttura del resto quella ‘formula iperformalizzata’ di un destino votato al segreto di Jacques Derrida che rivela, e non poteva che essere così: “io gioco sempre più spesso con la figura del marrano: meno ti mostrerai ebreo, più o meglio lo sarai”.4 Senza contare – Peter Handke ha ragione – che l’esibizionismo non ha niente a che fare con la verità, tanto meno con l’ebreo. In pratica, compresa quella letteraria, essere ebreo coincide con la propria intimità e proprio questo aspetto tende a caratterizzare anche l’ebreo in quanto scrittore. Si tratta dell’evidente inevidenza di molti scrittori ebrei, quella diafana 14
qualità, qualcosa di non comodamente evidente comunque, ma un quid familiare che li rende riconoscibili alla lettura. Senza star lì troppo ad almanaccare (troppe prove non stancano la verità?) si pensi a Giorgio Bassani, il quale ne Il giardino dei Finzi‐
Contini, con pochi dubbi davvero, ribadiva questa convinzione: essere ebreo è “qualcosa di più intimo. Ma che cosa propriamente? Si capisce: in primo luogo eravamo ebrei, e ciò in ogni caso sarebbe stato più che sufficiente”.5 Proprio questa fondamentale idea dell’intimità dell’ebreo restituisce in gran parte il mondo raccolto e segreto dello scrittore ebreo, che si alimenta di una vera e propria cultura dell’intimità. Il narratore, interrogandosi in alcune pagine intense, e con immagini di rara finezza, sulle “occhiate d’intesa” e su quei “cenni confidenziali” che legavano il protagonista a Micòl e ad Alberto Finzi‐Contini, aveva pochi dubbi: essere ebreo era senz’altro qualcosa di segreto e di sottaciuto, “qualcosa di più intimo”, qualcosa “riguardante noi e soltanto noi”.6 Perché non erano le poche parole distrattamente scambiate ad instaurare una relazione umana, una forma di solidarietà ed un sentimento comunitario espresso con quel noi, non tanto, almeno, quanto il semplice fatto di presentarsi per Pesach o per Jom Kippur davanti al portone del tempio di via Mazzini regolarmente alle feste ebraiche, in uno spazio separato, in una temporalità diversamente ritmata e in una condizione di minaccia. Avvenimenti più che sufficienti perché anche altrove, e “soprattutto in presenza di estranei” trascoresse negli occhi dei ragazzi “l’ombra o il riso di una certa speciale complicità e connivenza”. Perché si è inconfondibilmente ebrei nello stile di vita, nella mentalità e nella condotta; e l’Ebraismo è fondamentalmente una religione del comportamento. Essere ebrei solo in quanto iscritti nei registri della comunità ferrarese non significava poi tanto: che valore e che significato potevano avere termini come ‘Comunità israelitica’ o ‘Università israelitica’, o la stessa parola ‘ebreo’ in fondo, inadeguati com’erano a render conto di quella particolare intimità, se poi prescindevano completamente dall’esistenza di quell’ulteriore intimità, segreta, apprezzabile nel suo valore soltanto da chi ne era partecipe, derivante dal fatto che le nostre due famiglie, non per scelta, ma in virtù di una tradizione più antica di ogni possibile memoria, appartenevano al medesimo rito religioso, o meglio alla medesima Scuola?7 Segretezza, discrezione, pudori, complicità visibili se non da chi ne era partecipe, richiami familiari, sentimentalismi del ghetto, e in genere tutto quanto proviene dal privato, lo si assume alla stregua di categorie interpretative al fine di esplorare la cosmografia interiore dello scrittore ebreo occidentale, che si delinea essenzialmente come qualcosa di riposto, di celato con riserbo. UNA TESHUVAH C’è un movimento dell’anima ebraica, invisibile, che non produce strepiti, che non si può dire che non esista solo perché non è comodamente evidente, perché ha a che 15
fare con le profondità dell’anima, proprio di quella strana cosa che si chiama anima. Questo moto interiore si chiama teshuvah. Quella di teshuvah è un’idea portante (dal verbo la‐shuv ‘tornare’), tra le più forti dell’ebraismo. Come spiega Adin Steinsaltz: “la parola ebraica per pentimento, Teshuvah, ha tre diversi significati che sono tuttavia in relazione fra loro. Prima di tutto significa ‘ritorno’, un tornare a Dio o alla fede ebraica. In secondo luogo può significare ‘voltarsi indietro’ o ‘invertire direzione’, scegliendo un altro orientamento, un’altra direzione nella vita. Terzo significa ‘risposta’”.8 Ora, qualcosa del genere avviene nella Coscienza dove Zeno mima una personalissima Teshuvah. Per quanto egli ostenti i panni del positivista razionalista, come potrebbe indossarli uno “studente scioperato” che però non riesce a sbarazzarsi anche della pletora di riti scaramantici ed apotropaici, nel momento stesso in cui si appresta a ridere della religione, la coscienza sembra come arenarsi nelle paludi della colpabilità, “il sentimento della colpa ce lo avevo ad ogni respiro, ad ogni mio respiro”, non diversamente dall’Ettore Schmitz, ebreo converso, nel quale si può presumere – a ragion veduta – che “lo sradicamento dalla comunità triestina doveva lasciare in lui l’uomo eternamente perseguitato dai dubbi e dalle rane, il rimorso di un tradimento nei confronti del clan familiare”.9 Il padre‐patriarca di Zeno, che appartiene alla medesima genealogia degli inflessibili padri kafkiani, con la sentenza dello schiaffo, sembra accusare il figlio di un oscuro e perturbante peccato, un nuovo peccato originale che Zeno, con una tardiva e posteriore obbedienza al padre, cercherà se non di espiare, almeno di esorcizzare, con il ritorno alla religione dell’infanzia. Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero – e qui voglio confessarlo – che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l’anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta – raramente – non si può fare a meno.10 Il rapporto di Svevo con l’Ebraismo, che è riferibile massimamente all’autorità tradizionale paterna, viene vissuto proprio come qualcosa di intimamente dolce e celato nel profondo. Sotto le mentite, larvatissime spoglie di free thinker e con dissimulazioni di distacco filosofico, gelosamente custodito “in un cantuccio del cuore”, essere ebreo risultava né più né meno che un segreto amore illecito. Una segreta corrispondenza di amorosi sensi. A dispetto di ogni possibile definizione che non definisce, essere ebrei diventa un affaire privé, la medesima cosa vale anche per lo scrittore ebreo. Non a caso il dialogo, che non ebbe luogo quando il padre era in vita, iniziò nella coscienza del figlio alla sua morte, a causa della “solita debolezza di noi miscredenti”,11 contraddistinto dal ritorno al giudaismo familiare, alla “religione 16
dell’infanzia”, come ad una religione essenzialmente intima, segreta, autentica, perché non necessita di essere professata “ad alta voce”. Questi moti dell’animo hanno dei principi agenti nel profondo: “La coscienza si risveglia grazie alla possibilità offerta dall’infanzia ebraica nascosta sotto gli strati profondi dell’inconscio e del subconscio”.12 Sigmund Freud avrebbe certamente avuto di che argomentare intorno al patriarca ebreo della Coscienza, giacché ‘il complesso del padre’ del protagonista ha tutta l’aria di presentarsi come una faccenda strettamente ebraica. Non per nulla, proprio con Freud il problema dell’’Ebraismo del padre’, che ossessionava larghi settori dell’Ebraismo occidentale, si trasforma – senza per questo perdere il suo spessore storico – nel problema generale del rapporto di ogni figlio con il padre e la legge. Il riferimento alla mitologia greca e alla cultura classica, a lui così care, non deve trarre in inganno”.13 Questo spiega anche perché, le “opere degli scrittori ebrei risuonano sempre di conflitti con il padre. Kafka e Wassermann, per esempio. In un certo modo, la famiglia ebraica, il padre ebreo, sono il simbolo di una realtà sociale sola, vissuta direttamente dall’ebreo”.14 Nel suo memoriale auto‐analitico, che si caratterizza pure come Familienroman, l’episodio della morte del padre viene considerato da Zeno di un’importanza fondamentale. Nel capitolo in cui si propone l’antagonismo con il padre, Zeno prova a trattare la tormentosa questione con ironia, ovvero con la qualità preminente della sua parola, senza però molto successo. Come ha scritto Judith Stora‐Sandor: “La morale ebraica è perpetuata nell’educazione di ogni bambino ebreo, e il peso di questa morale non è sempre facile da portare […] L’autorità divina, una volta demolita, sopravvive nell’autorità dei genitori. Ed il bambino reagisce come i bambini di Dio, non potendo farne a meno, egli preferisce riderne, anche se qualche volta la sua auto‐ironia è così amara che il riso gli resta nella gola”.15 In molti casi, in tempi di dissoluzione post‐emancipazione, il figlio ebreo propenderà verso forme ribellistiche con nette prese di distanza dalla tradizione. Come Zeno, che può ridere della religione, o almeno ci prova. Accade però che questa insubordinazione dei discendenti di padri semi‐assimilati e transfughi spesso assuma i connotati di un ritorno al religioso, conseguenza dell’impulso dato dall’ebraismo del padre, anche quando si mostri non del tutto inappuntabile, come nel caso dell’eterno figlio Franz Kafka e del suo famigerato padre zero‐giudaico.16 Nella Coscienza di Zeno compaiono ambedue le mentalità. Zeno, infatti, ora è figlio, ora è patriarca. Che poi Zeno non sia un ebreo devoto, questo nessuno lo dice, per quanto non si veda il motivo per trascurare ammissioni come questa, che sarebbe poi il classico tipo di ‘ritrattazione’, come la definisce Neher, che segue di norma ad una teshuvah. Per esempio, Eduardo Saccone ha ritenuto opportuno, a detrimento dell’episodio, che viene sminuito e banalizzato (nonostante Zeno avesse indicato – e non senza motivo – l’avvenimento della morte del padre con il susseguente ‘ritorno alla religione dell’infanzia’ come il più importante della sua vita), liquidare questi 17
richiami e questi moti dell’intimità di Zeno alla stregua di “un ricorso nevrotico ad una religione in cui non crede”.17 Ma è assai diffusa la tendenza a ridurre l’Ebraismo e l’essere ebreo ad un puro e semplice affare di credo (nei commenti di Saccone non si accenna per niente neanche al background ebraico). Sembra quasi che l’Ebraismo venga pensato unicamente come una religione, e che si debba riferirlo ed associarlo esclusivamente alla sfera del sacro. Più che mai opportune giungono le precisazioni di Neher: “Non è affatto così. L’Ebraismo eccede i suoi limiti religiosi, raggiungendo degli uomini, una società, uno Stato, una storia, le cui componenti sono spesso puramente profane e potrebbero, perciò, essere relegate al di fuori di uno ‘studio su un fatto religioso’ e perciò esiste una letteratura ebraica anche quando è ‘agli antipodi del sacro’, anche quando è in ‘conflitto con esso’”.18 Per altro verso si possono riscontrare affermazioni ebraiche anche al di fuori di ogni specifica articolazione dichiaratamente religiosa che inclinano ad assumere una carica religiosa, come chiarisce Mandel: “ogni affermazione ebraica, ogni azione ebraica, qualunque siano le modalità, hanno un significato religioso ed è del tutto impossibile separare il fattore ebraico reso manifesto da questa connotazione essenziale”.19 Si dice che l’ateo costruisca una sinagoga per non andarci, e non è un controsenso, per quanto paradossale possa sembrare parlare anche di ateismo religioso: “Il termine ‘ateismo religioso’ – avanzato da Lukacs a proposito di Dostoevsky – permette di individuare questa figura paradossale dello spirito che sembra cercare, con l’energia della disperazione, il punto di convergenza messianico tra sacro e profano”.20 LA GENEALOGICA DI ARON Si dice questo perché le analisi interpretative dello scrittore ebreo e della sua letteratura non di rado vengono inficiate da pregiudiziali all’origine che si sviluppano a partire da un vizio di forma, consistente in una sorta di sistematica normalizzazione degli strumenti critico‐teorici, nell’indiscriminata, per aberrante esprit de système, riduzione ad unum, di radici culturali che differiscono da quelle dominanti e maggioritarie. “Nella cultura occidentale l’ebreo viene sempre valutato usando metri che non fanno per lui”.21 Con queste parole Wittgenstein lamentava la cronica inadempienza all’uso di misure ermeneutiche adeguate all’ebreo, e di rimando allo scrittore ebreo, che viene calcato nello stampo di questa normalità con una normopatica metodica di critica testuale in modo tale che le differenze, anziché essere salvate e microscopicamente evidenziate, sono annullate, rigidamente appiattite. In questo modo tutte le vacche sono nere, come nella notte fonda dell’assoluto schellinghiano dell’immagine di Hegel, per cui uno scrittore ebreo scompare nel confuso regno dell’insignificanza e dell’indifferenziato. Detto altrimenti, alla maniera sveviana, forse potrà sembrarlo, ma non tutti sono cristiani! Così Aron Hector Schmitz, in arte Italo Svevo, scrive in data 7‐6‐1913 da Murano alla moglie Livia Veneziani un piccolo episodio, reso sottilmente arguto dal racconto dello scrittore: 18
Antonio Fonda mi scrisse che non sono notato in nessun luogo. Non ammise subito ch’io sia Aron. Si trova ancora nell’età in cui tutti gli sembrano cristiani. Farò poi del mio meglio per cancellare l’Aron dalle liste elettorali e l’”Italo Svevo” dalla Guida [civica]. Ho veramente una vita che pare un guazzabuglio […]. Da vero Aron gli propongo di scommettere che sono iscritto nella lista.22 Sono provocazioni come queste a dare senso a tutto, a non lasciar dubbi: Italo Svevo è ebreo, un ebreo che si ritiene malgrado tutto ebreo, e non solo per via dell’iscrizione all’anagrafe, ma anche perché in coscienza ritiene di poter parlare ancora da ebreo, da vero Aron. In questo modo si resiste ai tentativi di uniformazione, ed è quanto più conta: “La prima distinzione, la primissima, che ho imparato […] ne sono sicuro, non era quella fra notte e giorno, o caldo e freddo, ma tra goyische ed ebreo” ricorda Portnoy nel romanzo di Philip Roth. A salvare l’ebreo è questo vitale differenziare, non certo quell’ipocrita, ambigua specie di “generosità semplificatrice”23 che si adopera per far sparire l’ebreo nell’irreale astrazione umana. È vero (ed Arnold Mandel che non sa che farsene di questo bon ton urticante lo lascia intendere senza mezzi termini) che “negare l’esitenza di una questione dell’essere ebreo vuol dire coprirsi gli occhi, e ció deriva da un sottile antisemitismo”,24 come sottile e tuttavia palpabile antisemitismo è anche il non accettare un dato di fatto semplice e solare, così come viene espresso da Edmond Jabes: “Sei ebreo e ti esprimi come tale”. Nonostante questo, quanta fatica ancor oggi nel parlare di scrittore ebreo e di scrittura ebraica… Si comprende perché all’indomani della conversione di Aron Schmitz al cattolicesimo, che senz’altro non “aurait fait grand plaisir au pape”, come confidò lo stesso Svevo a Marie Anne Comnène, moglie dell’italianisant Benjamin Crémieux, trattandosi piuttosto di un’abiura dovuta, più che a personale e a maturata convinzione, al desiderio di compiacere la consorte, Svevo lasciava intendere di essere rimasto, nonostante tutto, ebreo. Le acque battesimali della chiesa di San Giacomo non potevano dans l’espace d’un matin far svanire l’Aron, e non solo perché esse asciugano in fretta, come ricordava Heine, anch’egli Wasserjude, che di questo svaporare istantaneo ne sapeva qualcosa. In questa maniera l’improbabile autodafé dell’ebreo e dello scrittore insieme finisce piuttosto per trasmutarsi in un bon mot, e dunque a risolversi in una chiara, inequivocabile professione di ebraismo, se non di fede, di appartenenza. Parimenti Ettore Schmitz, fino a prova contraria, non ha mai smesso di essere ebreo così come non ha mai cessato, anche in clandestinità, e con la prassi da marrano, di scrivere. Da vero Aron. Si ha un ritorno a se stesso attraverso il proprio nome ebraico. Si direbbe che Zeno ritorni alla religione della sua infanzia nei termini più elementari, proprio “come un adulto che conserva i ricordi dell’infanzia o altre reminiscenze della vita ebraica”, al di là degli aspetti meramente esteriori e religiosi. Essa si configura come “un ritorno al proprio modello, al prototipo dell’identità ebraica” che si può operare attraverso una specie di “ricordo dell’archetipo fondamentale che è parte della struttura dell’anima di ogni ebreo”. 19
Indipendentemente dalle alienazioni e dalle estraniazioni in cui si è avventurato un ebreo, comunque “egli conserva impressa metafisicamente, quasi geneticamente, l’immagine del suo essere ebreo”. Ritornare al proprio ed inimitabile modello personale di ebreo sarà più semplice se, come nel caso di Aron Schmitz, nella memoria permangono impressi momenti e ricordi della mishpachah, di una teologia privata a richiamare una stilistica di vita ebraica. Naturalmente, questo riappropriarsi da parte dell’ebreo del suo personalissimo prototipo “può essere in molti modi, non soltanto nell’accettare una fede o un credo, o nell’adempimento di certi obblighi tradizionali”.25 È plausibile, infatti, ritenere che Svevo si sentisse lontano dalla religione ebraica, come da qualsiasi altra religione: “la sua religione – spiegava Marie‐Anne Comnène, moglie di Benjamin Crémieux – era quella del sentimento umano; egli pensava che Dio fosse in ogni uomo che vive la propria vita pienamente; che non gli importava il nome che avesse il Dio che gli uomini adoravano; l’importante era non adorare”.26 Eppure Svevo assicurava sull’entità di certi momenti sentimentali e di certi stati d’animo sinceri che così tanti rassomigliavano a religione: “Parola d’onore che ho in un cantuccio del cuore qualche cosa che somiglia a religione”, scriveva in una lettera lo scrittore alla moglie e Zeno parlava proprio di una religione vera, anzi: “la religione vera” perché ebraicamente intima, che “non occorre professare ad alta voce”. Ma questo è un modo, probabilmente il modo per essere ebrei, per ritornare ad essere ebrei. In realtà, in quel ritornare alla religione dell’infanzia di cui si narra nel capitolo terzo della Coscienza di Zeno, sospendendo ad un certo punto, in via eccezionale, il dispositivo dell’umorismo, si configura nel profondo una presa di coscienza del proprio sommerso giudaismo, attraverso cui si avvia un processo di rigiudaizzazione‐riebreizzazione, preludio ad una sorta di riappropriazione dell’identità. In occasioni come queste, in virtù di una rivelazione intima, ci si accorge di essere ebrei, e con sentimenti assai prossimi ad una improvvisa nostalgia, irresistibilmente si rinnova il senso di appartenenza, perché questo è di ‘conforto’, e di questo conforto, seppure raramente, “non si può fare a meno”. Importa dire che l’essere ebreo molto spesso si fonda su tutta una serie di ragioni mistiche non ben definite. Qualcosa di semplicemente emozionale, se non di irragionevole, come sovente lo sono le cose importanti e profonde. Di certo l’episodio della morte del padre può essere davvero considerato l’avvenimento più importante della sua vita, ma solo se questo ritorno viene individuato ed inquadrato in termini di teshuvah, mantenendo, come vuole Wittgenstein, le sfumature ebraiche che rendono il termine irriducibile ad ogni altra espressione che non sia quella di teshuvah ed il ritorno dell’ebreo diverso da ogni altro: “Che il concetto di penitenza – scrive Franz Rosenzweig al cugino Rudolf Ehrenberg, che doveva essere il suo padrino al battesimo che poi non ci fu (4/11/1913) – (che in ebraico viene reso con ‘ritorno’, ‘inversione del cammino’, ‘ritorno indietro’), che quindi la parola teshuvah nel Nuovo 20
Testamento venga tradotta con metànoia, è uno dei punti in cui la storia universale risiede nel dizionario”.27 Sorvolare bellamente sull’inestinguibile ascendente che il retaggio familiare israelitico, soprattutto nei termini di tradizione culturale, esercitava su Zeno, non può che essere un atto interpretativo sviante e fondamentalmente falsante. Per di più, lo scrittore ha sentito il bisogno di parlare di questo ritorno e alla fine di tutto è questo a fare la differenza. L’ULTIMO SVEVO Probabilmente lo scrittore triestino, come Kurt Tucholsky, avrebbe potuto dire: “Nel 1911 ho abbandonato la religione ebraica ed ora so che non è possibile”.28 Perché accade proprio quello che ricordava Eugenio Levi in uno scritto su Svevo: “[…] anche se l’Ebreo lo volesse, non potrebbe cancellarsi. Se pur gli riuscisse di camuffarsi del tutto da Ariano, la sua vecchia anima ebraica, come accade nel poe‐
metto di André Spire, l’andrebbe a cercare”.29 In effetti, presso molti letterati ed intellettuali ebrei si verifica un processo per cui “la loro assimilazione e acculturazione sono la precondizione e il punto di partenza della loro disassimilazione e anaculturazione”.30 Ad un primo momento di de‐ebreizzazione, che si manifesta con tentativi assimilazionistici, succede una de‐assimilazione ed una forma più o meno decisa di ri‐ebreizzazione. Anche in Svevo si verifica questa dinamica; anche per lui si può parlare di ebraismo di ritorno e senz’altro lo si può collocare tra gli ebrei cosiddetti rientranti. Si comprendono meglio le ragioni per cui l’ebraicità, intesa come qualità dell’ebreità o dell’essere ebreo, si mostri più accentuata e più presente nel tardo e più maturo Svevo, che più invecchia più diventa scrittore ebreo. Questo è un dato concreto, oggettivo, prontamente rilevabile nella sua opera letteraria. Che tra i primi romanzi e le prove narrative della maturità (dalla Coscienza ad Una burla riuscita) ci sia uno scarto non da poco, una diatesi vistosa, non è vaga sensiblerie. Più che mai palese è il fatto che è la condizione ebraica a determinare la scrittura. Insomma, si devono ad una sorta di teshuvah anche in letteratura, le variazioni di poetica, le scelte stilistiche dell’ultimo Svevo se, per esempio, per menzionare solo i segnali più appariscenti di discontinuità, la terza persona viene abbandonata in favore della prima persona, estremamente più congeniale alle oscillazioni di coscienza e all’autoironia di Zeno. Con Stuart Hughes non si può fare meno di registrare come nei suoi ultimi lavori “la sua primitiva passività è rimasta ma l’autodenigrazione che l’accompagnava ha assunto un tono più ridente e, per la stessa ragione, è diventata autenticamente ebrea”, tanto e vero che “all’epoca in cui si accinse a creare il suo Zeno Cosini, nel quale c’era molto più di lui stesso di quanto non vi fosse in Emilio Brentani, aveva imparato a tramutare la disfatta in una ironica specie di ‘vittoria’”, con ciò smentendo Debenedetti che, se aveva riconosciuto il sottosuolo ebraico nella narrativa sveviana, ne aveva tuttavia rimarcato (affezionato com’era alle sue tesi filo‐
21
weiningeriane) unicamente l’aspetto negativo rendendo: “l’intera questione della ebraicità nascosta più lesiva ed angosciosa di quanto non fosse necessario”.31 Evidentemente la teshuvah di Aron Schmitz, nello specifico in quanto Italo Svevo (ovvero come ebreo che scrive), letterariamente parlando, deve pur esserci stata in uno di quei rari momenti di cui diceva Zeno. Per carità, non ci è dato di saperlo con esattezza, ma è possibile (trattasi una volta tanto di faccenda comodamente evidente…) rinvenirla rispecchiata nella scrittura, che risente profondamente di questo ritorno dolce e celato come un amore illecito a se stesso come ebreo. In tutto questo gioca un ruolo vitale il fattore pedagogico che è essenziale nella vita dell’ebreo per la trasmissione del patrimonio tradizionale, avendo il mondo ebraico assunto “l’educazione e la sua pervasità spazio‐temporale come suo elemento centrale, strutturante e dinamicamente costitutivo”.32 Quello che un bambino impara da piccolo deve rimanergli per tutta la vita e, se “[…] Dio non voglia, da adulto dovesse avere dei tentennamenti o smarrire la strada, ciò che ha imparato nell’infanzia probabilmente lo aiuterebbe a ridiventare un buon ebreo. […] Questo comportamento viene assorbito nel sistema di valori dell’infanzia, che avrà un influsso anche da adulto, e verrà usato come metro nel considerare le proprie azioni, e le eventuali possibili modificazioni di abitudini”.33 Sono i presupposti educativi improntati sulle parole del Pirke Avot: “Presto apprendere, tardi dimenticare” che nel caso di Zeno, almeno in parte, raggiungono lo scopo, visto che dopo la morte del padre, in chiusura del capitolo, confessa di essere ritornato alla religione che caratterizzò la sua infanzia. Il fratello Elio non manca di ricordare le consuetudini ebraiche della famiglia Schmitz, come la celebrazione dell’ingresso di Shabbat: Al venerdì sera era festa per noi. Restavamo a casa tutti insieme e papà ci contava delle novelle che noi ascoltavamo.34 Questi scampoli diaristici materializzano quella “religione dell’infanzia” rievocata nella Coscienza. Attraverso di essi è possibile visualizzare il piccolo Ettore nelle occasioni rituali domestiche, così emozionalmente intrise di costumi giudaici, in cui si intravede altresì il dovere del padre di raccontare alle orecchie dei figli e, successivamente, ai figli dei figli. Nella sacra intimità nel tempo ci è consentito individuare gli elementi formativi che sono andati a costituire l’essenza di ebreo del romanziere. La confessione di Zeno allude anche ad un ritorno alla mishpachah. Il significato di questo movimento spirituale viene illuminato come meglio non si potrebbe ancora da Adin Steinsaltz, secondo cui: “la relazione reciproca tra il singolo ebreo e l’Ebraismo, tra l’uomo e il suo Dio dipende dal fatto che l’Ebraismo non è soltanto la Legge, la pratica religiosa prescritta, ma uno schema di vita che comprende la sua intera esistenza; inoltre è in definitiva la sola struttura entro la quale egli, nel suo distacco e la sua ricerca, sarà in grado di trovare se stesso. Anche 22
se potenzialmente l’uomo può adattarsi, esiste, che egli lo riconosca o no, ad un sentiero che è il suo, che è legato a lui, alla sua famiglia, alla sua casa”.35 Con parole di ogni ebreo Heine, da Svevo considerato il ‘suo Dio’, avrebbe chiosato, ricavando direttamente dalla propria esperienza, l’impossibilità di cessare di essere ebreo dal fatto stesso che il suo destino singolare di ebreo era stato sigillato già da parecchio tempo dai suoi padri, tanto da risentirne ognora l’oscura vibrazione nel suo sangue. Quell’autocoscienza di essere ebreo si perpetuava anche attraverso il proprio nome, considerabile come una radice cui far risalire, di generazione in generazione, sentimenti, emozioni, mentalità che strutturano la grammatica del suo essere, culminante nella consapevolezza, nelle alterne stazioni della vita, di appartenere ad una mishpachah di destino, comunque di scelta sempre più vasta. La religione dell’infanzia di Zeno sarà conservata a lungo nell’animo dello scrittore, trovando un’espressione conforme in una scrittura marraneggiante dalle sembianze anebreizzate. In qualche modo la parvenza è l’essenza di un modo di essere ebrei. CONCLUSIONI Per la vexata quaestio Svevo‐Ebraismo, sarà bene puntualizzare, su un piede solo che più di ‘reticenza’, come pretendeva Giacomo Debenedetti in alcuni scritti controversi e rigati di ambiguità (che però sono ormai un locus classicus inevitabile per entrare nella disputa e dirimere la questione), la scrittura anebreizzata di Svevo si nutre preferibilmente di “gusto del segreto” (Derrida), attivando con espressioni efficaci di Norman Manea, un “‘codice’ di complicità implicita”, da intendersi come una forma particolare di “allegoria della prudenza”,36 che è una virtù ebraica non solo per Spinoza, ma anche per Svevo.37 Già che ci siamo si aggiunga che una delle qualità che contraddistingue la scrittura ebraica è proprio la ‘segretezza’, che talora concede qualcosa all’allusività, da catalogarsi come una forma particolare di scrittura tra le righe derivante da una condizione di persecuzione, come quella prodotta dall’antisemitismo.38 Forse meglio di tutti ha detto Ludwig Wittgenstein, sempre così interessante quando parla di ebrei e di cose ebraiche, che su questa segretezza ha detto cose assolutamente fondamentali: Si è detto talvolta che la segretezza e il riserbo propri degli ebrei sarebbero dovuti alla lunga persecuzione. Questo certamente non è vero: al contrario, è sicuro che essi esistono ancora malgrado questa persecuzione, appunto perché tendono a questa segretezza.39 Teshuvah e segretezza sono, per così dire, un’endiadi. Sono due aspetti reciproci e complementari. Come per Kafka la scrittura e la narrativa di Svevo, con il loro anebraismo e le loro diversioni si prestano ad una duplice lettura: una che prescinde dal sottosuolo ebraico ed una che lo sottintende, ma alla fine è da quest’ultimo che 23
trae la sensatezza del suo discorso, anche perché può essere relativamente facile mettere fra parentesi i connotati ebraici, non così il senso della vita derivato dalla propria esistenza di ebreo. Cosicché la letteratura, finanche la stessa prassi letteraria, concorrono a modo loro ad illustrare la realtà e l’esistenza dell’ebreo. Nelle latebre della scrittura, l’anima di Svevo è riconoscibilmente ebraica, così come di riflesso lo è la sua opera, proprio perché rifatta grazie alla teshuvah. NOTE Svevo 1968, 60. 1
Trigano 2000, 19. 2
Nietzsche 1977, 72. 3
Derrida 2005, 52. 4
Bassani 2001, 341. Su questi temi mi sono soffermato in Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica della letturatura italiana del Novecento, Firenze, Giuntina, 2006, da cui riprendo alcuni stralci. 5
Bassani 2001, 341. 6
Ibidem, 342. 7
Steinsaltz 2000, 104‐106. 8
Ghidetti1980, 198. 9
Svevo 1994, 60. 10
Svevo 1968, 468. 11
Neher 2006, 88. L’unico appunto che muovo a Rosanna Cuomo, impeccabile curatrice del volume di Neher, riguarda la scelta di modificare il titolo originale (Ils ont refait leur âme). 12
Meghnagi 1992, 31. 13
Memmi 1967, 325. 14
Stora‐Sandor 1984, 64. 15
A questo proposito rimando a Löwy 2004. 16
Saccone 1973, 111‐120. 17
Neher 1988, 7. 18
Mandel 1978, 198‐199. 19
Löwy 2001, 99. 20
Wittgenstein 1980, 42. 21
Svevo 1968, 639. 22
Memmi 1967, n.p. 23
Mandel 1978, n.p. 24
Steinsaltz 2000, 104‐106. 25
24
Comnène 1960, 113. 26
Rozenzweig 1991, 292‐293. 27
Grünfeld 1986, 24. 28
Levi E. 1956, 123. 29
Löwy 1992, 44. 30
Stuart Hughes 1983, 52‐55. 31
Pissi 1987, 12. 32
Pinter 1975, 181. 33
Schmitz 1997, 48. 34
Steinsaltz 2000, 106. 35
Manea 2006, 291‐292. 36
Più volte ci si imbatte nella consapevolezza sveviana di determinati intenti strategici dettati dalla prudenza, adottabili nella scrittura. Per esempio, Mario Samigli, il candido letterato protagonista di Una burla riuscita, scrisse favole “dal senso dubbio”, in ragione di una virtù collaterale e affine al gusto del segreto: “per prudenza” (Svevo 1968, 80). Altrove lo scrittore, per una volta, sembra del tutto d’accordo con il già ricordato Marco Bliznakoff, che la prudenza fosse da considerare una virtù acquisita dell’ebreo: “quella prudenza che Maro attribuiva alla mia razza” (Svevo 1966, 446). Si rievoca la saggezza del caute spinoziano che preserva, allo stesso modo della paura e del timore: “è certo che la paura è una qualità della carne. È come una protezione che la involge già quando arriva all’aria. La travia ma certamente la protegge” (Svevo 68, 411‐412). La prudenza inoltre non lesina i buoni consigli, come quello dato all’amico Benjamin Crémieux di non recarsi in Romania, a causa del forte antisemitismo rumeno. 37
Per questi aspetti si veda: Strauss 1990, 22‐34; in riferimento a Svevo invece De Angelis 1995. 38
Wittgenstein 1980, 52. 39
BIBLIOGRAFIA Bassani, G. Opere. Milano: Mondadori, 2001. ‐‐‐. Il giardino dei Finzi‐Contini. Opere 2001. De Angelis, L. ‘La reticenza di Aron. Letteratura e antisemitismo in Italo Svevo’. L’Ebraismo nella Letteratura Italiana del Novecento, a cura di Carlà & De Angelis. Palermo: Palumbo, 1995. ‐‐‐. Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica della letturatura italiana del Novecento. Firenze: Giuntina, 2006. Comnène, M.A. ‘Italo Svevo’. Europe 9 (1960): 113. Derrida, J. Abramo, l’altro. Napoli: Cronopio, 2005. Ghidetti, E. Italo Svevo. La coscienza di un borghese triestino. Roma: Editori Riuniti 1980. Grünfeld, F.V. Profeti senza onore. Bologna: Il Mulino, 1986. 25
Hughes, H. S. Prigionieri della speranza. Bologna: Il Mulino, 1983. Levi, E. ‘Italo Svevo e l’anima ebraica’. Scritti in memoria di Sally Mayer. Gerusalemme: Fondazione Sally Mayer, 1956. Löwy, M. Rêveur insoumis. Paris: Stock, 2004. ‐‐‐. ‘Anarchismo ed ebraismo nella Mitteleuropa: il caso Franz Kafka’. L’anarchico e l’ebreo, a cura di A. Bertolo. Milano: Elèuthera, 2001. Mandel, A. Nous autres Juifs. Paris: Hachette, 1978. Manea, N. La quinta impossibilità. Milano: Il Saggiatore, 2006. Meghnagi, D. Il padre e la legge. Venezia: Marsilio, 1992. Memmi, A. Ritratto di un ebreo. Milano: IPL, 1967. Neher, A. Hanno ritrovato la loro anima. Percorsi di teshuvah. Genova‐Milano: Marietti 2006. ‐‐‐. Chiavi per l’Ebraismo, Genova: Marietti, 1988. Nietzsche, F. Al di là del bene e del male, a cura di F. Masini. Roma: Newton Compton, 1977. Pinter, A. ‘Valori educativi nella cultura di un gruppo hassidico’. Becchi e.a. Scuola genitori cultura. Ricerche su famiglia, condizione operaia e tradizione culturale. Milano: Franco Angeli Editore, 1975. Piussi, A.M. E li insegnerai ai tuoi figli. Firenze: Giuntina, 1987. Rosenzweig, F. La scrittura. Saggi dal 1914 al 1929. Roma: Città Nuova, 1991. Schmitz, E. Diario. a cura di L. De Angelis. Palermo: Sellerio, 1997. Steinsaltz, A. La rosa dai tredici petali. Un incontro con la mistica ebraica. Firenze: Giuntina, 2000. Stora‐Sandor, J. L’Humour juif dans la litérature. Paris: PUF, 1984. ‐‐‐. Redenzione ed utopia. Torino: Bollati‐ Boringhieri, 1992. Strauss, L. Scrittura e persecuzione. Venezia: Marsilio, 1990. Svevo, Italo. Racconti, saggi, pagine sparse. Milano: Dall’Oglio, 1968. ‐‐‐. Epistolario. Milano: Dall’Oglio, 1966. ‐‐‐. La coscienza di Zeno. Firenze: Giunti, 1994. Trigano, S. ‘Le mystère d’Ester et de Joseph. La mystique politique du marranisme’. Le Juif caché. Marranisme et modernité. Pardès 29 (2000): 19. Wittgenstein, L. Pensieri diversi. Milano: Adelphi, 1980. 26
VANELLI, Paolo. ‘Gli eteronomi di Bassani nel romanzo di Ferrara’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 27‐37. RIASSUNTO
Nelle Cinque storie ferraresi sono rintracciabili alcuni personaggi che in qualche modo rappresentano la condizione dell’autore giovane a Ferrara, quando avvertiva un senso di esclusione e di non appartenenza nei riguardi della comunità cittadina e anche del suo stesso clan ebraico. Tali figure divengono eteronimi dell’autore e gli permettono di assumere una posizione distanziata e giudicante, senza comparire direttamente sulla scena. L’antagonismo tra il Bassani, giovane studente universitario, e la città, il suo senso di solitudine, la sua malinconia e la sua estraneità alla degenerazione morale e alla cecità del mondo cittadino si trasferiscono nelle anime dei suoi protagonisti, che egli guida dall’esterno e indirizza ad esprimere le zone della sua coscienza, che ancora non vogliono apparire allo scoperto. Il caso più emblematico è quello di Bruno Lattes, nella cui vicenda, scissa cronologicamente in due momenti – quello dell’esperienza diretta e quello posteriore della riflessione memoriale – l’autore raffigura i due tempi della sua vicenda esistenziale: il vissuto e la scrittura. Ma, concluse le Cinque storie ferraresi, l’autore abbandona gli eteronimi e la terza persona e con coraggio scende in prima persona, senza maschere né diaframmi, sul palcoscenico della sua città. Inizia così la trilogia dell’io (Gli occhiali d’oro, Il giardino dei Finzi‐Contini e Dietro la porta), dove continua e si approfondisce la problematica storica ed esistenziale già individuata, filtrata però da una nuova voce narrante, quella dell’io dell’autore, narratore e protagonista. PAROLE CHIAVE Solitudine, diversità, antagonismo, sguardo, rispecchiamento © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 27
GLI ETERONIMI DI BASSANI NEL ROMANZO DI FERRARA Paolo Vanelli GLI ETERONIMI E IL LORO SGUARDO SULLA CITTÀ Quando Bassani inizia la composizione delle sue storie ferraresi è spinto da un bisogno di chiarificazione e di indagine su se stesso e sulla realtà storico‐ambientale che ha conosciuto negli anni della sua formazione culturale e civile. Con la sua opera dunque egli cerca di risolvere artisticamente quello che è il principio fondante della grande narrativa, cioè l’esigenza di conoscenza. Conducendo questa operazione gnoseologica, il nostro scrittore fa convergere in un’unità letterariamente indissolubile due diversi piani conoscitivi: un’indagine storica, che coinvolge circa mezzo secolo di vita ferrarese ed è sorretta da una forte e ineludibile esigenza etica, e un’indagine psicologica, che lo sollecita a scendere a contatto con l’anima di alcuni personaggi e con l’ambigua complessità delle loro esistenze. Per cui, a livello contenutistico, si può parlare di due linee di forza, sempre intersecantesi tra loro: la problematicità della storia e l’enigma dell’individuo, ossia le ragioni storico‐sociali (della pòlis) e quelle psicologico‐esistenziali (dell’individuo). Ne deriva un grandioso e drammatico affresco i cui protagonisti sono: da una parte la città – Ferrara – emblema della storia collettiva, una storia desolata e rovinosa, intessuta su gli egoismi e le viltà di una cittadinanza, in gran parte schiava delle passioni e succube dell’ignoranza; dall’altra parte alcuni esseri, che in quel contesto non si riconoscono e se ne distanziano, in quanto avvertono in sé un’ansia di purezza e di verità, di bellezza e di vita, che sentono negate nella deriva della ragione e del sentimento (dell’umanesimo), a cui stanno assistendo. Pertanto Il Romanzo di Ferrara (1974) poggia su un modulo costante, che è l’antagonismo tra l’omologazione dei più allo scadimento morale della pòlis, alla sua letargia morale e al sonno delle coscienze, e la diversità di alcuni – pochi, eletti, enigmatici individui – che vivono in una sofferta autoesclusione. Ora, se è vero che “l’arte è un’attività psicologica, o un’attività umana dovuta a motivi psicologici”,1 e che il processo creativo porta in luce l’Io dell’artista, dobbiamo dedurne che il modulo inventato dal Bassani, interagendo con l’anima e con la sensibilità dello scrittore, rappresenta la forma visibile e leggibile di quello che era il suo sentimento della realtà. L’antagonismo Individuo‐Città è allora la struttura intenzionalmente scelta dall’autore per rappresentare in termini narrativi il suo stesso dramma. Egli infatti pone alla base delle sue storie eventi che hanno a che fare con la sua esperienza personale, con ricordi e vicende di cui, in gran parte, è stato spettatore o protagonista, ma sa bene che la vera opera d’arte nasce nel momento in cui il racconto si innalza al di sopra di ciò che è personale e attinge qualcosa di 28
universale, rappresentando un aspetto della vita di tutta l’umanità. Il suo sentimento della realtà rinuncia dunque all’effusione immediata e si rivela in altro modo, rifondandosi sulla forza espressiva e simbolica di un’immagine primordiale e trascendendosi nel valore illuminante di un archetipo (o, per meglio dire, nelle strutture di una figura mitologica, che nel nostro caso sarebbe l’antagonismo tra lo spirito puro di Antigone e le leggi della città di Tebe) che, ripetendosi nella storia, da sempre rappresenta nella vita psichica dell’umanità la drammatica dicotomia tra le ragioni dello spirito e le norme della collettività – ovvero il contrasto tra Individuo e città. Ebbene, nella vasta complessità del Romanzo di Ferrara quest’immagine primordiale, che ne è il modulo fondante, si sviluppa in due diversi momenti, che possiamo indicare come: il tempo degli eteronimi e il tempo dell’io. Il tempo degli eteronomi caratterizza le Cinque storie ferraresi, ovvero il primo segmento dell’opera narrativa bassaniana, che già nel 1973 era stato rielaborato e riedito da Mondadori col nuovo titolo di Dentro le mura. Qui lo scrittore non compare mai in prima persona, ma rispecchia il proprio sentimento della realtà, ovvero la sua condizione di escluso e di diverso, quindi di antagonista al clima morale e politico della città, nelle figure di altri personaggi, che si pongono dunque come veri eteronimi dell’autore. Lida Mantovani (nel racconto omonimo delle Cinque storie ferraresi) è eteronimo dello scrittore: in lei egli riflette l’inquietudine esistenziale di chi si sente tarpato dalla condizione psicologica del carcerato, che guarda la vita attraverso i vetri della finestra. È una condizione che gli deriva anche, e soprattutto, dall’essere ebreo, quindi sofferente il trauma della diversità, la quale gli impedisce di godere di ciò che agli altri è permesso e di espandersi liberamente, come se qualcosa di indefinibile lo facesse accartocciare su se stesso, in una continua implosione dei suoi sentimenti e delle sue attese. Come su Lida grava un’atavica condanna che la costringe a ripetere il ruolo di vittima che fu della madre, così forse sull’autore si ripete un’atavica colpa che imprigiona ad una condizione di rinuncia e a un destino di esclusione. La città è là fuori, oltre i vetri, irraggiungibile, e la collettività, dove cominciano a serpeggiare le prime velleitarie tensioni di una nuova stagione politica – e a questo proposito si veda la bellissima figura di Oreste – sembra rimanere insensibile alle sofferenze degli esclusi. Ma nello stesso racconto la figura di David rispecchia un’altra inquietudine e un altro disagio, quello con cui il giovane scrittore ha vissuto l’appartenenza al suo stesso clan, avvertendo anche tra i suoi un senso di inautenticità, una condizione di alienazione e un vuoto di valori che li rende insensibili alle voci più profonde della coscienza. Il gesto velleitario di David, pur fallendo e concludendosi nella definitiva omologazione del giovane alle leggi del clan, mostra che qualcosa non funziona; è il primo avvertimento, da parte di un giovane ancora fragile e inadeguato a reagire consapevolmente e ad ergersi come figura antagonista, di una distonia, ovvero di una difficoltà a omologarsi alle categorie del lògos epocale e alle cosiddette leggi dei padri. 29
Rispecchiandosi in Lida e in David, Bassani ci rivela, subito all’inizio della sua opera, i nodi che ha dovuto sciogliere nella difficile elaborazione della sua personalità: quello dovuto alla sua diversità di ebreo, all’interno di una comunità non ebrea, e quello relativo al rapporto conflittuale con la sua stessa comunità ebraica. Questa latente conflittualità si incarna in un altro personaggio eteronimo dell’autore, Elia Corcos (ne ‘La passeggiata prima di cena’). Tutta bassaniana è la sua tendenza all’isolamento e all’introversione, e poi quell’intima dicotomia tra i richiami della vita e del successo e le misteriose gioie che lo corteggiano come impalpabili fantasmi, quando, ad esempio, sta seduto alla scrivania e contempla le “grandi nuvole dorate che occupavano il cielo dalla parte di Bologna”, lasciandosi trasportare dal suo sguardo raffinato verso emozioni e sensazioni personalissime, che scendono a lenire la sua anima inquieta (Bassani 1974, 68). Ma l’affinità si rivela ancora meglio nel suo rapporto col clan ebraico ferrarese. I correligionari di Elia stanno vivendo un’età di grande euforia: sono le generazioni postunitarie di fine Ottocento, uscite dal ghetto ed emancipate dallo Stato liberale; esse sono certe di aver raggiunto la sicurezza e la stabilità civile e con orgoglio celebrano questa nuova felice età dell’oro. Tale temperie storica è magistralmente interpretata dal padre di Elia, Salomone, sanguigno rappresentante di un mondo ebraico che sogna la rinascita secondo i valori e gli ideali dell’antico mondo patriarcale. Elia invece è l’ebreo sofferente nelle zone fonde dell’anima, avvolta da un velo di inquietudine, forse perché su di lui pesa sempre una tara, una vecchia tara congenita, che gli crea inconsciamente un senso di colpa e quindi la necessità di un’espiazione. Elia è l’ebreo che si sente perennemente esiliato, diverso, prigioniero di una fragilità psichica, a causa della quale non riesce a sintonizzare col suo stesso clan, ormai proiettato a dimenticare il passato, ad assumere acriticamente tutte le forme della società italiana, a sfruttare la nuova temperie storica e politica per i propri interessi, e soprattutto a intendere l’avvenuta emancipazione non tanto come la possibilità di affermare liberamente e pienamente l’ebraicità, ma piuttosto come l’occasione di alienare la propria individualissima cultura e la propria irripetibile esperienza storica nell’euforica (e interessata) omologazione al clima storico di fine Ottocento. In Elia viene perfettamente riprodotto il disagio esistenziale del giovane Bassani, le cui origini troviamo in Dietro la porta. Questo romanzo fa parte della trilogia dell’io (insieme a Gli occhiali d’oro e a Il Giardino dei Finzi‐Contini), quindi siamo nel secondo tempo dell’opera bassaniana, quando cioè l’autore non usa più personaggi eteronimi per descrivere il suo sentimento della realtà, ma si affida ad un io narrante. Ebbene, il giovane protagonista del romanzo rivela, come Elia, la stessa difficoltà di inserimento fra gli altri, perché anche lui è tormentato da un forte senso della diversità (una chiara metafora dell’essere ebreo) e da un congenito sentimento di inferiorità che lo spinge ad “un inconscio desiderio di autodegradazione e autodistruzione”2 – e anche Elia sembra aver costruito la sua vita proprio per autocastrarsi e impedirsi di raggiungere i successi adeguati alle sue autentiche potenzialità. 30
Se l’io narrante di Dietro la porta è figura del giovane liceale Bassani, Elia Corcos è interprete del disagio esistenziale del Bassani cresciuto, quando negli anni trenta sta silenziosamente soffrendo in una città avvolta da un clima stagnante e greve, dove le tensioni morali e civili si stanno dissolvendo nel vuoto morale di una mediocre tranquillità. Le forme del conformismo e dell’utilitarismo hanno azzerato ogni senso etico e civile, e tutti gli strati della popolazione – anche il clan ebraico – hanno subito passivamente un processo di degrado, che li ha resi insensibili e miopi alla degenerazione dei valori collettivi. In questo capolavoro bassaniano c’è un’altra figura da ritenersi un’ipostasi dell’autore, uno schermo su cui il narratore riflette il suo modo di osservare la realtà e la sua posizione di distacco e di dolorosa solitudine. Si tratta di Ausilia, la sorella di Gemma. Il secondo capitolo del brano si apre infatti con un’efficace inquadratura dello sguardo di Ausilia: L’unica persona, in casa, ad essersi accorta del dottor Corcos, del dottor Elia Corcos, era stata Ausilia, la sorella maggiore. (Bassani 1974, 53) Qui Ausilia usa però ancora soltanto la vista, gli occhi di carne: insieme alla madre spia dalla finestra della camera l’arrivo della sorella accompagnata dal dottore. Le vere doti dello sguardo di Ausilia si riveleranno nel quinto capitolo, quando il narratore si servirà proprio degli occhi di Ausilia per introdursi nelle anime e nei segreti del Corcos, del vecchio Salomone e di Elia, per ridisegnare la vita interiore di questi personaggi e animare le vicende della famiglia. Ausilia ama “spiare”, “congetturare”, “dedurre”, abbandonarsi alle “segrete delizie” dello sguardo che le permettono per quarant’anni di vivere con i Corcos in una posizione defilata e solitaria, instaurando però con tutti i famigliari una silenziosa, ma intima corrispondenza. È lei che, mentre “sfiorava con lo sguardo, passando, i noti, innumerevoli oggetti” (67) che ingombravano le stanze, percepiva intanto la chiusa e orgogliosa superbia di quella famiglia; è lei che “prima ancora di rivederlo, si raffigurava Elia” (67) e osservandolo riusciva ad avvertirne l’anima dolente; ed è ancora lei che intuisce la diversità tra il vecchio Salomone e gli altri Corcos: sdegnosi, orgogliosi, chiusi, malinconicamente superbi gli ultimi, quanto invece gentile, pieno di attenzioni, affabile e cortese anche con la stessa Ausilia il buon Salomone. La donna è attratta dalle cose di quel vecchio, dai suoi abiti, dai suoi libretti di devozione, da cui emana, come dalla persona stessa un profumo strano, che faceva pensare all’incenso. Avvolta da queste sensazioni, Ausilia spesso si chiude in salotto e ad occhi chiusi pensa, immagina e ridisegna nella mente quello che il suo sguardo, supportato dall’olfatto, ha percepito. L’attenzione del suo sguardo le permette di avvertire i sensi nascosti delle cose, di coglierne l’anima, e quindi di rimanere in una posizione di incantato distacco, che le impedisce di esserne sensualmente coinvolta, come è stato per Gemma. La sua però sarà anche la condizione “crudele” e “atroce” di chi per tutta la vita dovrà “spiare da lontano” o sognare “a palpebre abbassate” (72) di chi, cioè, grazie alla sua particolare sensibilità ha intuito tutto e, purtroppo, 31
anche il limite doloroso e invalicabile della sua condizione di escluso, di anima sola e sofferente, che può trovare lenimento solo nelle “segrete” e solitarie “delizie” del suo sguardo e della sua percezione ad occhi chiusi: quello sguardo che le provocava “la sensazione che il povero signor Salomone ci fosse anche lui […] e respirando in silenzio, le sedesse accanto” (71). Lo sguardo di Ausilia per tanti versi è simile allo “sguardo di Elia! Nulla poteva sfuggirgli, davvero. Eppure, insieme, sembrava quasi che non vedesse” (72). È uno sguardo estraneo alla realtà, tipico di colui che sembra guardare ma in realtà contempla i suoi fantasmi mentali, da una posizione esterna alle cose, anzi “da fuori del tempo”(73). È lo sguardo di chi osserva tutto sotto la luce del destino, come se vedesse le cose e i fatti già compiuti, trascendendo quindi la loro contingenzialità e scoprendone invece il senso ultimo, l’estremo approdo. LA FIGURA DI BRUNO LATTES Ben presto la frattura esistenziale apertasi tra l’autore e la collettività cittadina, ariana ed ebrea, evidente in un latente senso di esclusione e di diversità e nelle doti singolari di uno sguardo fortemente analitico e introspettivo, assume precisi contorni morali e politici, anche in seguito a importanti incontri, ferraresi e bolognesi e a varie vicende autobiografiche, che Alessandro Roveri ha magistralmente raccontato nella sua documentatissima ricerca storico‐biografica.3 Non dobbiamo dimenticare, innanzi tutto, che la personalità morale e culturale del Bassani si era formata sull’insegnamento del professor Francesco Viviani, al Liceo Ariosto di Ferrara. Da questo grande maestro, che lo scrittore non dimenticherà mai, poi allontanato dall’insegnamento per il suo anticonformismo culturale e passato nel CLN di Verona, per finire – e morire – a Buchenwald, il giovane aveva assorbito l’idea di un umanesimo impegnato e implicato anche politicamente – l’umanesimo di Tacito e di Tucidide – proiettato all’affermazione della libertà e della giustizia. Poi c’era stato l’incontro e l’amicizia con Claudio Varese, con Giuseppe Dessì e con Mario Pinna, giovani insegnanti di origine sarda, venuti a Ferrara dopo la laurea a Pisa, dove avevano accolto con entusiasmo le idee liberal‐socialiste di Guido Calogero e di Aldo Capitini. E dal Varese, con cui instaurò un legame fraterno, Bassani fu iniziato alla lettura del Croce e alla sua religione della libertà. A Bologna il Bassani universitario era venuto a contatto con Carlo Ludovico Ragghianti, da cui era stato introdotto all’attivismo politico antifascista, all’idea cioè di organizzare un grande partito antifascista non comunista (che sarà poi il Partito d’Azione): così a Ferrara il giovane scrittore divenne la guida di un piccolo gruppo che costituiva l’ala borghese e intellettuale dell’antifascismo attivo. I contenuti ideali offertigli dalla cultura, dall’insegnamento del Viviani, dalle amicizie sarde, dal Croce, prendevano corpo in forme concrete, nell’azione, e quel senso di estraneità esistenziale alla propria città e al proprio clan, tutti irrimediabilmente compromessi col regime, si precisava sempre meglio come diversità morale e politica. Pertanto, se Elia Corcos rappresentava un sentimento della realtà tipico del Bassani, ma ancora a livello vago e inconscio – un sentimento di non appartenenza 32
psichica – sarà invece un nuovo eteronimo, Bruno Lattes (ne ‘Gli ultimi anni di Clelia Trotti’) a ergersi come figura emblematica nel momento in cui l’autore prende chiara coscienza delle ragioni del suo antagonismo con la città, quando cioè il suo senso di non appartenenza da psichico diviene storico e politico. Non a caso la storia di Bruno Lattes e della Trotti si svolge su due livelli temporali: l’evento da cui parte l’indagine memorialistica (il ritorno di Bruno a Ferrara e i funerali della Trotti) risale al 1946, mentre la vicenda dei due personaggi è del 1939. Ciò significa che solo attraverso la memoria – una memoria volontaristica, razionale, storicistica e non emozionale, come è sempre quella del Bassani, ben diversa dalla memoria proustiana, filtrata dalla conoscenza e dalla coscienza, Bruno recupera il vero senso del suo passato e di quelli che furono i suoi tormenti esistenziali e morali, vissuti allora senza percepirne fino in fondo le ragioni e il significato. Bruno Lattes è quindi eteronimo dello scrittore che, dopo essersi allontanato da Ferrara, ritorna memorialisticamente nella sua città e solo attraverso il diaframma della distanza spaziale e temporale può recuperare il se stesso degli anni trenta, il senso delle vicende di quell’epoca, e può finalmente dare un nome e raccontare quel sentimento di disagio psichico e di estraneità che lo metteva in crisi di fronte al comportamento negligente e distratto degli altri.4 Bruno nel 1946 potrà narrare il se stesso del 1939, così come l’autore negli anni cinquanta potrà raccontare le sue esperienze giovanili nella sua opera letteraria, poiché ha fatto chiarezza su quell’età e ha individuato la linea di forza su cui si consoliderà la sua opera, ossia il modulo mitico‐archetipico, sofocleo, dell’antagonismo tra l’io dell’individuo ricco di spiritualità e la città asservita ad un potere privo di humanitas. La recherche operata dal Lattes è la stessa recherche del Bassani scrittore, che alla luce delle esperienze posteriori potrà finalmente dare un giudizio storico sulla città e sul suo stesso clan: potrà cioè raccontare con coraggio e con dolorosa obiettività storica che la comunità degli ariani e quella degli ebrei erano accomunate dalla stessa miopia storica, dallo stesso conformismo, da un’identica visione delle cose, dalla volontà di salvaguardare il proprio particulare, che impediva di vedere il degrado delle istituzioni e di reagire alla retorica di un regime, che in nome di una pianificazione improntata all’ordine, alla sicurezza e al rispetto dell’autorità, stava macchinando la rovina di tutti. Questo tema antagonistico si ripropone nella figura di Geo Josz (ne ‘La Lapide di via Mazzini’), dove Geo diviene eteronimo del Bassani postbellico, che riscopre nella città gli stessi mali del periodo fascista: un torpore morale, una letargia della coscienza, un desiderio di dimenticare e di azzerare la memoria storica e una volontà di “ricomporsi a poco a poco nel profilo assonnato, decrepito” (Bassani 1974, 96). Lo scrittore, attraverso il suo eteronimo, vorrebbe invece muovere le coscienze, ma purtroppo deve assistere all’immobilismo morale della città, ancora e sempre antagonistica alle sue profonde esigenze spirituali. 33
LO SGUARDO DELL’AUTORE COME OCCHIO INDAGATORE Lo sguardo dell’autore, supportato da profonde motivazioni etiche e politiche, si trasforma quindi in un occhio indagatore, che scruta Ferrara e diviene lo “spietato guardiano che domina la città col suo occhio inquisitore”.5 Ora l’eteronimo di Bassani è veramente l’occhio cupido e ossessivo, giudicante e sarcastico di Pino Barilari, in ‘Una notte del ‘43’. Barilari non riuscirà mai a uscire dalla sua stanza‐prigione, e lo spazio circoscritto in cui si chiude diviene simbolo dell’incapacità di lasciare un luogo protetto, e quindi della paura di affrontare quella realtà che da anni spia e giudica. Barilari è succube di una sorta di masochismo, dovuto anche ad un ipertrofico sentimento della sua malattia, e gode quindi nel sentirsi vittima, per poi autopunirsi di questa inconscia colpa con l’autocarcerazione. La quale, però, a sua volta viene come risarcita dall’attività incessante e giudicante del suo occhio. È un personaggio ambivalente, perseguitato e persecutore insieme, che esiste solo come occhio che guarda da uno spazio riparato, che non può mai abbandonare. Ma gli eventi tragici di quella ‘notte del ‘43’ trasformano Barilari da occhio guardante in occhio guardato: è l’occhio della moglie che, sorpresa dall’eccidio al ritorno dal convegno con l’amante, si ferma sotto la finestra del marito e lo scorge mentre guarda i cadaveri riversi sulla strada. È il momento della verità, che denuncia apertamente la loro rovinosa situazione famigliare, quando occorre prendere atto e ammettere ciò che finora era stato taciuto, rimosso e ipocritamente nascosto. Il giorno successivo è Sciagura, il capo fascista, che alza gli occhi verso la finestra di Barilari e scrutandolo in un silenzioso sguardo d’intesa gli impone il silenzio. In una sola giornata Pino da occhio che guarda è diventato, per due volte, un uomo guardato, con occhi che l’hanno spiazzato, facendogli intendere che anche lui è direttamente coinvolto, a livello sentimentale, morale e politico, con quella realtà che finora ha voluto solo osservare e giudicare attraverso il rassicurante diaframma della distanza. Ora quegli occhi l’hanno tirato in causa, e se vuole assumersi le sue responsabilità e i suoi doveri di uomo e di cittadino, dovrà rinunciare alla “tana” e uscire allo scoperto, scontrandosi con la realtà e con la verità. Qui è lo snodo di tutta l’opera di Bassani: mentre Barilari rinuncia ai suoi doveri e si chiude in un mutismo folle, rimanendo aggrappato alla finestra della sua stanza, e continuando ad essere l’occhio che guarda, l’autore invece chiude con questa storia le narrazioni in terza persona, in cui il suo io è stato solo uno sguardo che è penetrato nei recessi delle anime o un occhio che ha guardato e giudicato la città, mascherato dietro eteronimi, e scende in campo direttamente, presentandosi sulla scena della città e assumendosi anche le sue responsabilità di protagonista: inizia così la trilogia dell’io (Gli occhiali d’oro, Il giardino dei Finzi Contini, Dietro la porta). Ora cadono i paraventi e i diaframmi: A partire da adesso, valeva forse la pena che l’autore […] provasse a uscire anche lui dalla sua, di tana, si qualificasse, osasse dire, finalmente, io. (Bassani 1974, 815) 34
VERSO L’IO NARRANTE Quali esperienze possano aver favorito questa svolta dagli eteronimi all’io narrante, ci viene detto, ovviamente in maniera artistica, quindi simbolica, nella storia del Giardino. Questo romanzo, come ha giustamente osservato nella sua brillante analisi Oddo De Stefanis, è infatti la storia di un percorso, quasi un pellegrinaggio dantesco, che porta l’io narrante dal culto del Bello al culto del Vero, ovvero da un sentimento estetico caratterizzante il tempo adolescenziale e giovanile, ad una necessità etica, propria della raggiunta maturità.6 Quello che entra nel giardino, infatti, è un giovane che aspira a rinchiudersi in un paradiso proibito, a scoprirne i segreti e a godere dei rituali estetici che lì vengono celebrati (come Pino, chiuso nella sua tana, dedito ai suoi solitari appaganti rituali). Ma l’esperienza del giardino porterà alla demitizzazione dei sogni del giovane, al crollo del mito, e il giovane uscirà dal giardino, morendo al Bello, per rinascere maturo, pienamente cosciente del Vero. E questo grazie all’educazione che proprio lì ha ricevuto, attraverso il rapporto con tre figure: Micòl, emblema dell’Anima, che educa il giovane al sentimento delle cose, cioè ad avvertire il senso del tempo, a capire l’amore, a percepire la forza del destino e della morte, a sentire il piacere del passato, a godere sì del Bello ma a privilegiare il Vero, sconsacrando lei stessa attraverso il rapporto col Malnate il mito estetico del giardino; il professor Ermanno, emblema del Grande Padre, che percepisce la forza intellettuale e la naturale disposizione alla scrittura del giovane e quindi lo investe del ruolo – sacro – di testimone e di narratore delle memorie della sua gente; infine Malnate, emblema della Coscienza civile, che risveglia nell’amico i suoi doveri di cittadino e il suo impegno politico. Ma entrare a contatto con i Finzi‐Contini significa soprattutto ritrovare il senso più alto e più raffinato dell’ebraicità. Si tratta di una famiglia di ebrei che non si sono compromessi come gli altri, né tanto meno si sono omologati al degrado morale e spirituale dei tempi. La separatezza dei Finzi‐Contini è da intendersi come volontà di salvaguardare le peculiarità della propria gente, di mantenere viva una brace che la storia collettiva stava spegnendo. Il rifiuto del professor Ermanno di prendere la tessera fascista simboleggia la resistenza di un piccolo nucleo, che si chiude e si distanzia dagli altri, orgoglioso della propria individualità e di una diversità che non vogliono inquinarsi. A contatto con i Finzi‐Contini il giovane recupera la propria identità, si sente finalmente ebreo, e questo sentimento non lo vive più con un senso di colpa e di inferiorità, ma con l’orgoglio di chi avverte l’appartenenza a un mondo culturale e morale di altissimo livello, e, in più, con la coscienza di non averlo mai tradito. Così, riallacciati i legami sentimentali col proprio clan, quando il professor Ermanno7 lo consacra come testimone della sua gente, avverte che forse proprio in quel ruolo sta il suo destino di uomo e di scrittore. D’altra parte tutto il Giardino è attraversato da premonizioni, da segni inequivocabili e da eventi che sono come il triste e grottesco preludio della tragedia incombente sul popolo ebreo: oltre le varie discussioni sulla situazione storico‐
35
politica che l’io narrante ha con l’amico Malnate, occorre soprattutto ricordare le pagine intensissime della cena pasquale del 1939,8 tutta avvolta da una “misteriosa fatalità mortuaria”, quasi un grottesco convegno di spettri, su cui si scatena “un vento d’uragano, e viene dalla notte”, “quella notte” che “tanto, non sarebbe finita mai”. E allora, nel momento in cui la storia stava per spazzare via una civiltà e per annientare una razza, quando stava per riversarsi sul mondo una di quelle catastrofi, le benjaminiane catastrofi che rendono come illeggibili le opere superstiti, occorreva reagire, ancorandosi in maniera più intima alle proprie radici, fare uno sforzo estremo per testimoniare, rivolgendosi al passato, alle memorie e ai padri, perché tutto non andasse perduto. Il Giardino dunque viene distrutto: sia perché rappresenta il mito irrecuperabile della giovinezza e quindi è soggetto alle regole ineludibili del Tempo (che segna con un’ossessiva scansione tutte le parti del romanzo), sia perché è metafora di una sublimazione estetica della vita, del Bello, che si chiude in se stesso per autocontemplarsi nel tentativo di una resistenza passiva, e non può che cedere all’attacco della Storia, con i suoi orrori e le sue violenze. Ma proprio dalle ceneri del Giardino rinasce l’uomo nuovo, che ha superato la conflittualità col suo clan, testimoniata negli eteronimi delle Cinque storie ferraresi (e anche ne Gli occhiali d’oro), e ritorna nel grembo della sua gente, con una piena consapevolezza di sé, della sua identità di ebreo. Il suo processo di individuazione si è compiuto e quindi non ha più bisogno di supporti, di schermi o di eteronimi, su cui riflettere spicchi e porzioni di un Sé vagamente intuito o timoroso di palesarsi: la stagione delle Cinque storie ferraresi è finita, aprendo però ad una nuova grandiosa stagione narrativa e dalla terza persona degli eteronimi la scrittura può passare all’io narrante. NOTE Jung 1979, 19. 1
De Stefanis 1981, 198. 2
Roveri 2002, 23‐62. 3
Dolfi 2003, 11‐16. 4
De Stefanis 1981, 73. 5
De Stefanis 1981, 91‐187. 6
Parte III, capitolo 6. 7
Parte III, capitolo 7. 8
36
BIBLIOGRAFIA Bassani, Giorgio. Il Romanzo di Ferrara. Milano: Mondadori, 1974. Dolfi, Anna. Giorgio Bassani. Una scrittura della malinconia. Roma: Bulzoni, 2003. Jung, C. Gustav. Psicologia e Poesia. Torino: Bollati Boringhieri, 1979. De Stefanis, Oddo G. Bassani entro il cerchio delle sue mura. Ravenna: Longo, 1981. Roveri, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936‐1943). Sabbioncello Ferrara: 2G Editrice, 2002. 37
CASCIO, Gandolfo. ‘L’estetica dell’ebreo e del cristiano nei racconti de Lo scialle andaluso di Elsa Morante’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 39‐45. RIASSUNTO Quest’articolo indaga alcuni elementi fisiognomici ricorrenti nelle figure che popolano le novelle de Lo scialle andaluso di Elsa Morante. Cioè, qui suggeriamo l’ipotesi che nel piano narrativo ci sia una categorizzazione estetica che si riversa nel progetto dei contenuti e si proponga di dedurre i caratteri psicologici e morali dell’individuo dai suoi tratti fisici. Nel libro ritroviamo due categorie di archetipi: quello apollineo e solare, che vive di luce propria e che è modello vincente, e quello saturnino o lunare che, al contrario, è paradigma della sconfitta, e che vive di una luce riflessa. Il primo incarna nella sua corporalità le teorie della ‘Metafisica della luce’, mentre l’altro le sconosce, eppure in modo subcosciente ne soffre. Per giustificare questa nostra tesi si fa riferimento alle varie fonti che hanno ispirato l’iconologia morantiana: dal Paradiso dantesco, all’opera del Beato Angelico, fino al lavoro sulle gerachie angeliche di Dionigi Areopagita. Questo ultimo testo farà da collante all’idea che anche tutta l’onomastica dei personaggi si rifaccia a quella che qui definiamo ‘estetica dei destini’. Per la scrittrice questo non sarà un processo empirico, ma una ‘macchinazione’ perfetta che nelle descrizioni di ebrei e cristiani ne anticipa – senza determinarlo – il loro incredibile destino morale e biografico. PAROLE CHIAVE Morante, estetica, fisiognomica, cristiano, destino © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 39
L’ESTETICA DELL’EBREO E DEL CRISTIANO NEI RACCONTI DE LO SCIALLE ANDALUSO DI ELSA MORANTE Gandolfo Cascio Universiteit Utrecht Gli ebrei, i siciliani: atavica affinità della loro condizione. Di energia. Di difesa. Di dolore. Un toscano del ‘500 aveva detto che i siciliani sono di intelletto secco. E anche gli ebrei. (Leonardo Sciascia, Il cavaliere e la morte) Lo scialle andaluso fu pubblicato da Einaudi nel 1963. Alcuni testi erano già presenti in una precedente raccolta, Il gioco segreto, del 1941, per il catalogo garzantiano. Sono anni difficili per la Morante; la relazione con Moravia è in crisi, Bill Morrow, il pittore americano a cui si è legata, è morto tragicamente l’anno prima a New York, ed ella non pubblica dal 1958, quando per Longanesi uscì la raccolta di liriche Alibi. Giustamente Garboli dice che “Raccogliere questi racconti, ritornare su quelli vecchi e riscriverli, fu per lei un atto di sopravvivenza”.1 Il volume, poi, può considerarsi come l’anello di congiunzione tra i precedenti Menzogna e sortilegio (1948) e L’isola di Arturo (1957). Infatti l’ultima novella, che dà anche il titolo a tutta la raccolta, è quasi contemporanea al romanzo isolano. Se per la Morante non si può mai parlare di modelli stilistici, qui sarà però bene ricordare il suo profondo interesse per la narrativa ottocentesca tutta: russa, francese e verista. Ma ci teniamo anche a far notare che i ‘modelli’ citati servirono esclusivamente per le riprese degli esterni, diciamo pure nella scelta di determinate situazioni. Non a caso nella produzione morantiana, oltre al particolare ritratto datoci in Aracoeli, non troviamo la rappresentazione della borghesia. Per quanto riguarda le strutture narrative e linguistiche, invece, la scrittrice ha come modello solo se stessa. E questo perché Elsa Morante ha reso testimonianza al mondo intero di una letteratura tanto precoce, quanto preziosa. Minima e superba, estranea al canone, e ai miti, del Novecento. Una cronaca personale, la confessione di quella fascinazione per la mistica, che ha saputo sentire e tramandare in anni di razionalismo e contestazioni, anticipando anche il revival religioso che caratterizza il nuovo millennio. Questa nostra breve premessa spiega come mai fin dal primo racconto, ‘Il ladro dei lumi’ (1935), si mostrino i caratteri principali di questa seduzione spirituale, condensata nelle figure esemplari dell’ebreo e del cristiano. ‘Il ladro dei lumi’ è la storia di Jusvin, il guardiano del tempio, predisposto ad accendere le lucette che devono fiammeggiare anche di notte per le anime dei morti. Ma un giorno il custode inizia a spegnerle dopo la chiusura del portone, sebbene continui a riscuotere il dovuto tributo. Da lì a poco morirà di cancro, “la strana bestia africana” (Morante 40
1994, 15), provocato dalle maledizioni, e ricevuto come castigo di Dio. Maledetto e punito colui che, errando, poteva sembrare un prediletto: Era un uomo bruno, d’aspetto bello e solenne, con occhi neri, e capelli e barba ricciuti. Nella penombra, cosí [sic] oscuro, pareva un profeta o un angelo, mentre saliva al Tempio, col suo passo obliquo, portando le pesanti chiavi. (Morante 1994, 13) Egli non solo incarna gli elementi fisiognomici più tipici del semita, ma anche quelli più canonici della rappresentazione dei protocristiani, rifacendosi probabilmente all’iconografia michelangiolesca. Agli attributi fisici si aggiungono anche quelli simbolici delle chiavi petrine che consentono l’apertura delle porte del Paradiso. Il luogo che nella tradizione medievale è ancora un luogo di luci gradualmente più potenti, fino alla Luce suprema che dalla Candida Rosa irradia il Paradiso. Udiamo contemporaneamente i toni biblici e le tonalità barocche caravaggesche. Una lingua alla maniera napoletana del Merisi che ci mostra nella stessa pagina le luci – i lumi – e le ombre che ricadono sugli oggetti, sulle persone, sulle coscienze. È una luce mitica e mistica, che rimanda alla cosmogonia biblica e ad alcuni elementi della scolastica e della Metafisica della luce. Concetti che deduciamo Elsa Morante ha probabilmente ripreso dalla terza cantica dantesca. Nell’elemento luminoso vi rivede non solo la riflessione divina, ma anche la restituzione dell’amore e della memoria. Non a caso sono qui i vivi che fanno accendere i lumi per i morti, per tranquillizzarli e ricordare loro che noi non li abbiamo dimenticati. La componente luminosa si irradia quindi in un moto inverso, dal basso verso l’alto. Nel nostro caso, l’amore di Dio e la sua benevolenza si manifestano nella grazia e nella bellezza fisica. Jusvin, infatti, era amato prima della sua colpa, ma se guardiamo la storia nell’insieme dell’intero volume, ma questa nostra osservazione potrebbe allargarsi allo studio delle altre opere, possiamo proporre la formula sintetica di ‘estetica dei destini’. Cioè, qui suggeriamo l’ipotesi che nel piano narrativo ci sia una categorizzazione estetica che si riversa nel progetto dei contenuti. La Morante va oltre la fisiognomica, che si propone di dedurre i caratteri psicologici e morali di un individuo dai suoi tratti fisici. Supera questo processo empirico, e con le sue descrizioni di uomini e bambini, nobili e popolane, ebrei e cristiani, ne anticipa – e qui non diciamo determina – il destino morale e biografico. Ne Lo scialle andaluso ritroviamo due archetipi: quello apollineo e solare, che vive di luce propria e che è modello vincente, e quello saturnino, o lunare che, al contrario, è paradigma della sconfitta e che vive di luce riflessa. Il primo incarna nella sua fisicità le teorie della Metafisica della luce, mentre l’altro le sconosce. Ad esempio, per Jusvin l’errore è effettivamente già ‘preannunciato’ dal suo passo obliquo. Una malformazione che certamente vuole ricordarci anche l’inclinazione umana all’errore. Nell’effige del custode si fondono allora sia gli elementi mortali, caratterizzati dalla mancanza, che quelli metafisici riflessi nell’immagine della bellezza angelica e incarnazione della simpatia divina. La bellezza ereditata dai figli sarà segnata per sempre dall’incubo della colpa paterna, cioè la colpa adamitica. La 41
dialettica della luce e dell’ombra, della venustà e dell’orrore, della potenza e della piccolezza umana, si ritrova nei vari elementi che costituiscono la struttura del racconto. Una corale sinestesia dove anche l’architettura del ghetto è dimessa, abbandonata, con i cortili senz’erba, abitati dalle meretrici chiassose che prendono in giro e invogliano al peccato. Ma le grida profane delle prostitute sono speculari al momento ieratico della maledizione sul ladro, che viene pronunciata in modo solenne e invocata in lingua ebraica. Due situazioni dove il senso dell’udito si contrappone a quello dominante della vista, ma che ad esso è comunque complementare nell’alternanza anche qui di luce e ombra, o, per meglio dire, di toni alti e bassi, delineati dai due registri linguistici basso‐comico e alto‐tragico. Un atto teatrale che si contrappone, ancora una volta, alla meschina quotidianità, quando la nonna ordina di spegnere il lume di casa – ancora un lume spento, vogliamo sottolineare –, perché sarebbe uno spreco tenerlo acceso solo per due persone. E anche in questo caso il carattere e la grettezza della nonna sono anticipati dal suo fisico consumato, “un piccolo scheletro di legno” (Morante 1994, 12), notando ancora che anche il legno, potenzialmente, è materiale lucifero. Un artificio di contrasti che contraddistinguerà la scrittura morantiana, seppure su livelli diversi ed eterogenei, fino a un cambio del suo catalogo linguistico ne La Storia, che trova la sua pienezza nella figura del figlio, che in sé racchiude le eredità della (in)coscienza cristiana e ebraica. E anche in questo caso si tratta non di un mero retaggio autobiografico, ma di una personificazione dall’ampio valore mistico, dove la creatura e il creatore si uniscono in un’unica entità. Una maternità mancata quella della Morante che ha generato, però, una magnifica figliolanza. Ne ‘Il soldato siciliano’ la gravidanza è addirittura invertita. Così è il padre a occuparsi della figlia, e cerca la morte per ritrovarla nell’aldilà. Il militare riassume in sé molti caratteri dell’estetica angelica cristiana, direttamente mutuata dall’angelologia. Egli entra nella camera buia pronto a proclamare la sua santa annunciazione, anticipato da “un fascio di luce bianca” (Morante 1994, 139). Un incontro privato che la scrittrice rielabora come topos della letteratura classica. Di questo ci convincono anche le osservazioni di Michail Bachtin, che dice che: Il motivo dell’incontro è strettamente legato ad altri importanti motivi, in particolare al motivo dell’agnizione‐non agnizione, che svolge una funzione enorme nella letteratura (ad esempio, nella tragedia antica).2 Ma la vocazione della Morante è ancora più ambiziosa. Ella si propone, infatti, di voler riprodurre, oltre alla scena dell’annuncio della maternità, anche quella del Natale, mescolati a una virtuosa casistica dell’agiografia legata alle saghe della verginità delle sante. Una seduzione della tradizione cattolica che viene rinforzata nella scelta dei luoghi: le tre capanne (una con l’asino), il letto di fieno, la strada come segno della persecuzione; e anche dall’intera onomastica: Assunta, Marietta, Giuseppe. Anche il soldato si presenta al suo arrivo, e lo fa proprio come l’Arcangelo biblico, annunciandosi con il solenne “Il mio nome è Gabriele” (Morante 1994, 140). 42
Un nome che indica quel legame sancito tra Dio e la Sua Prediletta, la ragazzina ebrea che aiuterà il progetto della salvezza del mondo. Ma qui vorremmo anche ricordare che Gabriele è il nome che lega fortemente la tradizione cristiana alle sue radici giudaiche. Nell’esperienza anticotestamentaria è sempre Gabriele che fece le rivelazioni a Zaccaria. L’emblema angelico, e per epicherèma intendiamo apollineo, ritorna nel racconto ‘Il cugino Venanzio’, sebbene incompiuto e mimetizzato in una corporatura malaticcia ma che non lascia dubbi sulle sue potenzialità: […] il cugino Venanzio era minuscolo, e cosí […] magro che le sue scapole sporgevano simili a due piccole ali mozze. (Morante 1994, 117) Qui probabilmente dobbiamo intendere che la morte del cugino, fosse preavvisata nella sua corporatura gracile, e la sua gloria, e vittoria, la ritrova nella sua ‘assunzione prematura’, come nel vaticinio menandreo ‘muor giovane colui ch’al cielo è caro’. Poi in modo anche più palese la raffigurazione dei cori paradisiaci si manifesta nei racconti ‘Via dell’angelo’ (1937) e ‘Il compagno’ (1938). Nel primo dove, oltre ai suggerimenti della toponomastica, ritroviamo anche l’elemento architettonico del convento e dell’alto muro come hortus conclusus; mentre nel secondo il protagonista cambia il nome del proprio compagno in ‘Arcangelo’ proprio a causa del suo aspetto. Un’epifania che si tramuta, o per meglio dire cresce, in battesimo: A rievocarlo con questo nome, rivedo i suoi capelli dorati e piuttosto lunghi, la curva delle sue guance che si accordava cosí […] gentilmente con quella delle sue labbra, l’orgogliosa luce degli occhi. (Morante 1994, 98) Gli elementi estetici qui si combinano con quello più prettamente metafisico della luce che coincide con la salvezza eterna. Anche per questo, nella novella Il battesimo, la donna che convince Francesco Esposito (nome dato agli orfani) si chiama Lucia, un nome che in sé raccoglie significati etimologici, agiografici e di titolatura che qui convalidano la nostra tesi. Ma la descrizione fisica, determinata ancora dal colore biondo dei capelli, ritorna anche nello scultore di santi del racconto ‘Donna Amalia’ e, non dimentichiamolo, più tardi anche ne L’isola di Arturo e La Storia, dove biondi sono sia il padre di Arturo che il padre di Useppe. A proposito di quest’ultimo titolo, possiamo anche ricordare che il figlio della violenza subita, dall’ipocoristico nome Useppe, come terzo nome portava proprio una variante vezzeggiativa del prototipo. Il suo nome completo era, infatti, Giuseppe Felice Angiolino. Un’estetica del candore celeste che nella Morante è sicuramente retaggio della cultura iconica rinascimentale, e in particolare del Beato Angelico, e rielaborata dal lavoro sulle gerarchie angeliche di Dionigi Areopagita.3 Aggiungiamo poi che a questi componenti radiosi si contrappone sempre più frequentemente quello del pallore. Una bianchezza lunare e di malattia, che proprio 43
come la radiosità dei personaggi angelicati, ha una valenza metafisica più ancora che descrittiva. E proprio questo colorito da malato è l’elemento che unisce le due dottrine che nella Morante trovano una comunanza formale, prima ancora che storica. Pallidi sono gli ebrei Jusvin, la nonna e la narratrice stessa ne ‘Il ladro dei lumi’, come Donna Amalia, come i leopardiani fanciulli de ‘Il gioco segreto’ e poi Elena e la madre ne ‘La nonna’. E questo biancore viene esaltato da due caratteristiche che possono alternarsi, e cioè i capelli neri, e nerissimi e ricci per gli ebrei, e gli occhi chiari, celesti, ma di una tonalità smorta e lieve. Comunque, la malattia nei tratti fisici di questi personaggi non crediamo sia l’eco dei modelli decadenti, dannunziani per intenderci, bensì il risultato di una continua analisi di se stessa. Pallido è anche Andrea, il protagonista de ‘Lo scialle andaluso’. Ma quel biancore che prima lo illuminava, “che bel figlio maschio ha la Campese” (Morante 1994, 168), dice inorgoglita la madre, diviene sempre più marcato, irreale e patetico, man mano che la sua crisi si aggrava e la sua pena cresce. Alla diafanità corrisponde la magrezza ialina, una pochezza di carne che è ben diversa dalla piccolezza graziosa, per capirci quella minutezza di bambola che caratterizza il piedino di Donna Amalia (Morante 1994, 147). I suoi personaggi sono la sua immagine riflessa in uno specchio. Sono loro che sostituiscono la sua apatia, loro possono agire o scomparire per sempre. Un’estetica o fisiognomica dei destini che vaticinano il vissuto interiore della scrittrice. Infatti i personaggi che rispondono a questo modello sono il suo doppio, il suo passato e le sue proiezioni. E lo sono soprattutto quelli sconfitti, quelli che vivono pienamente il mistero del dolore. Per convincerci di questa affermazione, ricordiamo qui il ritratto che Elsa Morante ha fatto di se stessa: Ero una bambina anemica; la mia faccia, fra i riccioli ‘ala di corvo’, era pallida come quella di una bambola lavata, e i miei occhi celesti erano cerchiati di nero. (Morante 1994, 219) Il pallore non è una caratteristica esclusiva del cristiano, ma un più, un segno condiviso con l’ebreo, e che definisce più l’anima che il credo. Anche per questo tra raffigurazione delle due tipologie di fedeli nella narrativa morantiana non troviamo fattezze diverse, che spesso in altri autori possono facilmente cadere nello stereotipo, ma assistiamo a una contaminazione che ella, del resto, ha vissuto in prima persona, essendo di madre ebrea e di padre siciliano. E la cultura primitiva della Morante è sicuramente di matrice meridionale. E quella siciliana, non dimentichiamolo, è una civiltà che molto deve agli ebrei che fino alla diaspora del 1492 rappresentavano circa il 10% della popolazione.4 L’eredità di una comunità che ancora oggi si ritrova nei cognomi, in alcuni proverbi e anche nell’aspetto arcaico, semita, di molti siciliani. Un amalgama che dai lineamenti si traduce in carattere e natura. Conseguentemente, secondo la dialettica della fisiognomica e del fato, ai valori più razionali, “l’intelletto secco”, come lo definisce Leonardo Sciascia ne Il Cavaliere e la morte. E a questi princìpi si accostano anche le virtù più prettamente morali, di matrice evangelica dell’umiltà, dell’onestà e della dignità, strutture portanti dell’ultimo racconto e 44
rappresentate nella figura di Andrea, giovane prete e nuovo Edipo, emblema della cristianità contemplativa e dedicata (Morante 1994, 174, 180‐81). Tutto ciò ci suggerisce quindi che le valenze estetiche, dei personaggi, ma anche dei luoghi, non possono relazionarsi alla cultura religiosa, ma bensì al ruolo specifico del personaggio, a cui si attribuisce una valenza di valore morale, più che genealogico, o di razza. Pare proprio che con Elsa Morante la letteratura ritorni al suo proposito più antico, cioè la catarsi dall’angoscia. Sebbene in lei questo tentativo fallisca felicemente, essendo priva di ogni colpa e da ogni errore. NOTE Garboli 1997, 111. Bachtin 1997, 245. 3 Quest’ultima affermazione, che all’inizio era solamente una supposizione, è stata poi confermata da una conversazione avuta con Giorgio Pressburger, il quale testimonia di aver visto Elsa Morante leggere l’Areopagita in Piazza del Popolo. 1
2
‘Introduzione: Gli ebrei siciliani ieri, oggi e…domani!’. [2004] Sicilia Ebraica ‐ 5.06.2007 http://www.geocities.com/siciliajudaica/main.html. 4
BIBLIOGRAFIA Bachtin, Michail. Estetica e romanzo. Torino: Einaudi, 1997. Garboli, Cesare. Il Gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante. Milano: Adelphi, 1995. Morante, Elsa. Lo scialle andaluso. Torino: Einaudi, 1994. Sciascia, Leonardo. Il Cavaliere e la morte. Milano: Adelphi, 1995. 45
MAGNI, Stefano. ‘Le parole di felicità e la coscienza della tragedia nell’opera di Primo Levi’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐
7. 47‐55. RIASSUNTO La lettura delle opere di Primo Levi stupisce per la lucidità dell’analisi del periodo più buio dell’umanità, la Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, del suo aspetto più tragico, l’esistenza dei campi di concentramento. In particolare, i romanzi Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati offrono l’esempio di una riflessione profonda e acuta sull’immensità della tragedia che Levi stesso ha vissuto in prima persona, e sull’assurdità di una sofferenza immane procurata da un sistema perverso. La critica ha osservato in molte occasioni la straordinaria capacità di Levi di raccontare in modo preciso e analitico la sua atroce esperienza e, giustamente, in molti hanno sottolineato lo sforzo di Levi per esprimere una realtà che doveva essere percepita come assurda e lontana dai suoi lettori. Il nostro intervento si inserisce nel vasto panorama della critica leviana, per osservare alcuni dettagli della scrittura dell’autore piemontese su cui fino ad ora quasi nulla si è detto. Levi, infatti, non solo ha dato vita con le sua parole all’immagine di un incubo, di un inferno inconcepibile da una società civile, ma ha anche vissuto, nella sua esperienza, insieme alle sensazioni di sconforto e di disperazione, quelle di speranza, di sollievo, di effimera felicità. È su questi ultimi aspetti che ci siamo soffermati con il nostro articolo, per cercare di capire quali potessero essere, nell’incubo del lager, gli elementi che potevano dare la forza per resistere, per trovare una ragione per mantenere dei rapporti umani disinteressati e generosi. Abbiamo così analizzato le parole che esprimono sollievo, momentaneo benessere, cercando anche di capire in che modo la scrittura immediata di Se questo è un uomo si differenzi dalla riflessione a posteriori de I sommersi e i salvati, giungendo alla conclusione che la nostra analisi concorda con le posizioni tradizionali degli studi leviani. PAROLE CHIAVE Primo Levi, memoria, felicità, campi di concentramento, Nazismo © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 47
LE PAROLE DI FELICITA E LA COSCIENZA DELLA TRAGEDIA NELL’OPERA DI PRIMO LEVI Stefano Magni La critica su Primo Levi ha sottolineato la capacità analitica dello scrittore, le sue straordinarie doti morali e umane, la sua capacità di riflessione. Si è soffermata sull’immensità della tragedia ch’egli ha vissuto e sull’assurdità di una sofferenza immane procurata da un sistema perverso e parossistico che voleva annientare l’uomo. Questi argomenti, uniti ad altri strettamente correlati, costituiscono sicuramente la perfetta chiave di lettura per interpretare l’opera di Primo Levi e per capire l’immane tragicità dell’universo dei campi di concentramento. Senza quindi voler aggiungere nulla a ciò che è stato già ripetutamente ed esemplarmente detto, con questo piccolo contributo vorrei solo tentare di analizzare le frasi che, all’interno del terribile orrore, esprimono sensazioni di positività o di sollievo. Gli esempi saranno estratti da Se questo è un uomo (1947), La tregua (1963) e I sommersi e i salvati (1986), le opere più importanti per studiare la deportazione di Levi. Non è certamente mio intento descrivere un Levi nostalgico o frivolo, vorrei semplicemente porre l’attenzione sulla sua forza d’animo e sui meccanismi che potevano trasformare la tragedia in riso o in serenità momentanea. Mi sembra interessante inoltre analizzare questi passi anche a livello stilistico, per osservarne la relazione con la lucida descrizione della tragedia. Vorrei essere preciso nell’introdurre il mio intervento, per non suscitare interpretazioni pericolose. Tempo fa, infatti, ad un convegno, una studiosa di Jorge Semprun affermò che l’autore spagnolo rievoca la sua detenzione nel campo di concentramento di Buchenwald con un tono di nostalgia, perché comunque lì aveva passato i suoi vent’anni. Questa asserzione portò un certo scompiglio tra il pubblico. Ricordo questo episodio per prevenire ogni dubbio in questo senso. Mi pare evidente nel più limpido dei modi che in Primo Levi non c’è nessun intento nostalgico, che l’esperienza vissuta è assolutamente tragica e che l’esistenza dei campi di concentramento è il più grande orrore che l’umanità abbia prodotto. La mia ricerca non nega, non smentisce o non rilegge, quindi, la critica precedente, ma tenta semplicemente di inserirsi in un discorso esistente, trattando un soggetto, secondario, ma allo stesso tempo trascurato. È chiaro infatti che Levi concentra i suoi sforzi di narratore sulle parole per descrivere l’orribile. Si rende conto a quel punto che la lingua è incapace di raccontare la globalità dell’universo dei lager. Come dice lui stesso: Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. (Levi 1997, 20) 48
La problematica dell’impossibilità di testimoniare è d’altronde un tema centrale nell’analisi dei testi di Levi e si collega all’assurdità dell’esperienza che non può essere creduta. Si ricordi a questo proposito anche il sogno ricorrente tra i prigionieri, quello di rientrare in famiglia e di raccontare la propria esperienza, senza essere ascoltati o creduti. Per reazione a questa paura e a questo difetto linguistico, Levi applica la sua precisione di uomo scientifico alla ricerca di una terminologia appropriata alla terribile situazione, ma di tanto in tanto ricorre comunque ad espressioni che, in un modo o nell’altro, si collegano all’idea di ‘benessere’ o al concetto di ‘comico’. Si trovano così alle volte episodi ilari, alle volte momenti grotteschi o tragicomici, alle volte un’insperata leggerezza. In Se questo è un uomo Levi stesso, conducendoci nell’inferno della Buna e di Auschwitz, osserva che nessuna felicità è mai assoluta, perfetta, e allo stesso modo nessuna tristezza è mai assoluta (Levi 1997, 11): come l’uomo borghese non riesce mai a vivere appieno né una dimensione, né l’altra, così anche i ‘penitenti’ dei lager riuscivano a trovare momenti di sollievo. Questa effimera sensazione di benessere ha una funzione estremamente varia nei tre libri che ho scelto per la mia analisi, e corrisponde alla diversa natura delle opere. Se questo è un uomo (1947) è nato infatti da una necessità immediata, da un bisogno di liberarsi dall’incubo appena vissuto e di soddisfare l’urgenza di raccontare cosa ossessionava i prigionieri. La tregua (1963) è stato scritto quindici anni dopo e raccoglie i materiali di varie conferenze.1 Il soggetto, il rientro picaresco in patria dopo la deportazione, si presta maggiormente ad una narrazione ricca di spunti ameni. Si tratta di un libro in cui le qualità narrative sono superiori a quelle del primo, in cui la capacità di raccontare svela un vero scrittore. Anche I sommersi e i salvati (1986) è un testo scritto a distanza dagli eventi. Si tratta di una riflessione morale e filosofica a posteriori che ritorna con serietà e dolore sulla tragedia dei campi di concentramento e che precede di poco il suicidio dell’autore. Per gli ultimi due casi, a livello emozionale, si interpone il filtro della distanza tra narratore ed eventi narrati. In altri autori una simile distanza ha comportato l’intervento della figura comica della distanza, cioè l’ironia. Senza attardarmi in un’analisi che sposterebbe troppo l’asse del mio intervento, posso ricordare le memorie di Lussu sulla Prima Guerra Mondiale, scritte nel 1938 (Un anno sull’altipiano), o i ricordi resistenziali di Meneghello (I piccoli maestri del 1964), testi in cui rispetto ai diari di guerra pubblicati ‘a caldo’ dopo il conflitto, si trova ripetutamente la figura dell’ironia. È interessante osservare, perciò, se in un paragone interno tra l’opera prima, Se questo è un uomo, e l’ultimo scritto, I sommersi e i salvati, il secondo ricorra con più frequenza all’ironia. L’IRONIA DI SE QUESTO È UN UOMO Per iniziare, mi pare opportuno partire dalle prime pagine di Se questo è un uomo, che sono il riflesso di una certa incoscienza della situazione. Anche se Levi precisa quando è ancora nel campo di raccolta di Fossoli che non c’erano illusioni sull’esito del viaggio: “[...] noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati, e 49
sapevamo che cosa voleva dire partire” (Levi 1997, 9), l’incognito domina i giorni a venire. Nella situazione di incertezza, all’inizio dei ricordi di Se questo è un uomo, si può osservare un doppio uso del vocabolo “sollievo” che non può non suscitare sorpresa nel lettore che conosce la storia di Levi. In un primo caso, all’inizio del viaggio, ormai già stipato nel treno merci, Levi apprende “con sollievo” la destinazione: “Auschwitz: un nome privo di significato” (9). Alla fine del viaggio abbiamo un uso speculare dello stesso termine. I deportati arrivano nel campo e sono fatti scendere e alcuni sono trasportati con un camion in un campo attiguo. Durante questo ultimo tragitto, il soldato che fa la guardia, con un’iniziativa personale, chiede ai prigionieri orologi e moneta spicciola. Levi ricorda che questo comportamento provoca collera e riso e “uno strano sollievo” (15). Il viaggio che conduce all’inferno è dunque bizzarramente segnato all’inizio e alla fine dall’uso del vocabolo “sollievo”. Nel primo caso si spiega con la necessità di dare un volto all’ignoto. Il solo fatto di conoscere una destinazione è più sopportabile dell’ignoto stesso. Nel secondo caso, il riconoscere nella guardia un comportamento ‘umanoʹ anche se basso, meschino, aiuta a riportare in un ordine delle cose più vicino e quindi comprensibile, l’assurdità e l’insensatezza di tutto ciò che accade. Il sollievo sembra quindi essere spiegato da un bisogno di conoscenza. La parola “sollievo” torna, qualche pagina dopo, quando il narratore comincia a notare l’assurdità del lager. La bestiale paradossalità dei campi è tale che Levi, dopo essere stato immatricolato e, dopo aver toccato con mano la realtà del lager, riesce comunque ad avere un’osservazione sarcastica, chiedendosi se le cerimonie cui assiste non siano “una colossale buffonata di gusto teutonico” (24). Questo pensiero porta “un’ombra di sollievo” (24). Un benessere effimero è anche dato da un comportamento gentile. Quando Levi è ancora un novizio, un prigioniero straniero, Schlome è cordiale e gli dà alcuni consigli, abbracciandolo. Levi si sente allora “pieno di una tristezza serena che è quasi gioia” (25). Oltre ad esprimere alcuni momenti di sollievo, Levi trova anche il tempo per una rappresentazione comica del campo. In particolare, riesce ad essere sarcastico. Il capitolo in cui gli viene assegnato il lavoro di chimico in laboratorio offre degli spunti di analisi interessanti. Evidentemente, nei ricordi del narratore, questo momento è vissuto come il passaggio di un crinale decisivo. Da quel momento in poi, Levi riesce a vivere in condizioni moderatamente privilegiate: potrà infatti lavorare al coperto, evitando i compiti pesanti della manodopera. Nella scrittura si percepisce di rimando un tono più leggero. Analizzo ora alcuni momenti che mi paiono emblematici. All’inizio, gli aspiranti chimici si radunano davanti al kapò del nuovo reparto. Questi è Alex, uno dei personaggi su cui si scagliano l’ira e il disprezzo di Levi. Egli si pulisce la mano sulla giacca del prigioniero Levi, provocando un giudizio perentorio sulla meschinità del gesto e del suo autore. Ma ciò che è interessante rilevare ora è che l’odio per questo Alex è filtrato da una buona dose di effetto comico. Levi, per descrivere il kapò, invece di mostrarne la mostruosità, si sofferma sulla sciocchezza e sulla pochezza dell’uomo. Tecnicamente sceglie il discorso indiretto libero. Quindi ci racconta la scena dal punto di vista di Alex, con un effetto ilare: 50
Quelli erano dunque i chimici: bene, lui era Alex, e se loro pensavano di essere entrati in paradiso sbagliavano. (97) e ancora subito dopo: Poi, se credevano, per essere degli Intelligenten, degli intellettuali, di farsi gioco di lui, Alex, un Reichsdeutscher, ebbene, Herrgottsacrament, gli avrebbe fatto vedere lui, gli avrebbe [...]. (97) L’anomalia del passo è lampante. Il tono leggero scarta dalla norma e l’uso del discorso indiretto libero costituisce un hapax nel testo. I candidati chimici vengono in seguito ammessi ad un esame, definito una “prova grottesca”, e già l’attesa costituisce un momento di gradito riposo. In poche righe, infatti, Levi per due volte dice “siamo contenti”: “Aspettare in silenzio. Di questo siamo contenti” e subito dopo: “Noi siamo sempre contenti di aspettare” (100). La scrittura, in queste pagine, per quanto non dimentichi mai la dura realtà che sta testimoniando, trova spazi di leggerezza. Qui, il narratore, poi, per la prima volta, rievoca senza il dolore di altre occasioni la sua vita da civile, gli esami universitari, la brillante carriera studentesca. Il tutto è coronato da un’altra frase di sollievo: “L’esame sta andando bene” (102). In questo caso, il sollievo che traspare anche nella scrittura è dato dal fatto di riconoscersi come uomo. Il ricongiungersi all’’io’ civile e borghese, il recuperare i ricordi della cultura sono fattori che contribuiscono a reagire all’annientamento umano, cioè alla prima arma che il lager usa per uccidere. Riuscire ad elevarsi per un attimo dallo stato larvale cui il lager conduce, provoca una reazione emotiva positiva. Ve n’è testimonianza, oltre che in questo passo, in un capitolo intitolato significativamente “Una buona giornata” o nell’episodio in cui Levi cerca di tradurre ad un prigioniero francese il canto dell’Inferno dantesco che ha come protagonista Ulisse. In questi casi, la rinata primavera, un supplemento di zuppa e, ancora, il ricordare la propria cultura, la propria identità, sono fattori che aiutano a reagire alla distruzione dell’individuo. In questo contesto si possono quindi cogliere espressioni come “ho provato un certo fugace piacere” (59) o “ho compreso come si possa adorare il sole” (66). In tali momenti, Levi ha anche il tempo per osservare volti che sorridono e voci che cantano. Se questo è un uomo, racconto scritto a caldo, testimonia quindi la disperazione ma esprime anche i momenti di speranza del prigioniero Levi. L’INTERMEZZO DE LA TREGUA Il libro seguente, La tregua (1963), rievoca il lungo ritorno in patria. Il romanzo è costruito su una serie di episodi avventurosi e anche intrinsecamente comici e la scrittura cambia rispetto a Se questo è un uomo. Il libro parte dagli ultimi giorni passati nel campo di Buna‐Monowitz, in cui Levi è abbandonato a sé stesso dai tedeschi in fuga. Le prime pagine sono ancora intrise di un profondo dolore e continuano il ritmo e lo stile del romanzo precedente: la libertà non riempie di gioia, perché si 51
sente un “doloroso pudore” (Levi 1997, 206) e si sente anche “che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato” (206). Analogamente, i primi momenti senza carcerieri e il trasporto in un’infermeria nel campo principale di Auschwitz sono vissuti e raccontati con un ritmo lento e un tono mesto. È vero che le condizioni fisiche di Levi sono all’estremo e che la sua percezione dell’esterno è per forza segnata, ma nel racconto fatto anni dopo traspare la sofferenza più che il sollievo della liberazione. Dopo questi primi istanti, il libro cambia e diventa molto più leggero. L’episodio che segna in qualche modo il cambio di registro è l’incontro con un borghese che Levi definisce il “portavoce del mondo civile” (244). A partire da questo istante, c’è veramente la transizione che porta il narratore nella realtà esterna al campo di detenzione. Poco dopo compare infatti una delle frasi più intense del romanzo: “Sentii l’onda calda del sentirsi libero, del sentirsi uomo fra uomini, del sentirsi vivo [...]” (245). In seguito, gli episodi che suscitano ilarità e un tono ameno sono riscontrabili con una certa frequenza e sono spesso legati ai nuovi ‘padroni’, i russi. Lo sguardo sull’organizzazione e sul comportamento dei salvatori è spesso filtrato da un sottile velo ironico tanto che, dopo l’austera organizzazione tedesca, l’allegra e scomposta disorganizzazione russa pare una parodia del contrappasso dantesco.2 Non mi pare il caso di soffermarmi sugli esempi, che potrebbero essere numerosi, mi preme invece sottolineare che come l’inizio è cupo, anche la fine non riserva quella gioia che ci si potrebbe attendere. L’arrivo a casa è descritto con una scrittura estremamente laconica, essenziale, e non lascia spazio alle emozioni: Giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. (395) Anche in questo caso, in un certo senso, la mancanza di gioia si può giustificare, come all’inizio del romanzo, con la mestizia dovuta alle sofferenze subite che non potranno essere redente da nessuna bellezza. IL ‘RITORNO AL LAGER’: I SOMMERSI E I SALVATI Invece di restare a lungo su La tregua, che esula per il resto dall’esperienza del lager, mi pare più interessante passare all’analisi de I sommersi e i salvati (1986), l’ultima riflessione di Levi sul campo di concentramento. Se ho anticipato che in alcuni casi l’aver ricordato una tragedia a distanza di anni ha permesso l’uso di un filtro ironico, mi pare invece di poter affermare che l’ironia è completamente assente ne I sommersi e i salvati. Come cercherò di mostrare, l’ultima riflessione sulla deportazione è la più tragica in assoluto. Le parole che esprimono una certa leggerezza sono rarissime e, se in Se questo è un uomo ho rilevato un ritorno del vocabolo ‘sollievo’, ne I sommersi e i salvati, mi pare di poter constatare un utilizzo parallelo del vocabolo ’fortuna’, usato nelle sue varie accezioni. All’inizio, ricordando l’immensità della tragedia, Levi nota 52
che “Fortunatamente le cose non sono andate come le vittime temevano e come i nazisti speravano” (Levi 1997, 998). In queste pagine d’introduzione l’autore sta spiegando che i nazisti erano coscienti del fatto che stavano compiendo una mostruosità, ma che erano altrettanto convinti che sarebbero riusciti a distruggere le tracce dei campi di concentramento, come erano sicuri che, anche se qualcuno fosse restato per raccontare, nessuno avrebbe creduto all’esistenza di un sistema talmente crudele. In un altro caso, Levi si permette di scrivere ancora: “[...] ma qualcuno ha pure avuto la fortuna di sopravvivere, ed è rimasto per testimoniare” (999‐1000). Come ho già detto, per Levi, come per ogni altro recluso, il bisogno di raccontare era primario e quaranta anni dopo, cosciente della memoria che è stata fissata nero su bianco, intravede un piccolo successo, anche personale. La parola ‘fortuna’ torna anche più avanti, quando il narratore afferma : “A me [...] è toccata la rarissima fortuna di poter scambiare alcune lettere con la mia famiglia.” (1072). In questo caso l’osservazione riguarda il periodo di prigionia. In due pagine all’inizio, Levi usa quindi il concetto di ‘fortuna’, per poi riprenderlo anche più avanti. Ai fini dell’interpretazione del pensiero di Levi si può notare che la nozione di ‘fortuna’ è laica e si contrappone alle nozioni religiose di provvidenza o destino e infatti, come risaputo, Levi uscì dal campo di concentramento convinto che nessun Dio può esistere se è esistito Auschwitz. La mancanza di un’idea suprema di giustizia contribuisce forse al rifiuto integrale di ciò che è accaduto, perché nessuna volontà superiore o divina può averlo deciso. Ne I sommersi e i salvati, il benessere non viene quindi da un’accettazione del passato, anzi, si ha l’impressione che la scrittura provochi, a distanza di anni, ancora più dolore rispetto al racconto immediato del 1946 e i momenti di relativa gioia o le considerazioni che supportano una certa ‘felicità’ sono ancora più ridotti rispetto a Se questo è un uomo. I motivi che suscitano benessere sono sempre gli stessi: un appagamento fisico, per esempio. Un episodio conosciuto è quello del rubinetto. Levi racconta dell’estate passata nel campo di Buna‐Monowitz. Arso dalla sete, egli trova per caso un rubinetto, chiuso, ma che lascia scivolare qualche goccia di acqua condensata. Come dice egli stesso: “ad ogni modo, una delizia” (1053). L’aneddoto ha anche un risvolto imbarazzante, perché Levi sceglie di dividere questa scoperta con l’amico Alberto, ma non con un terzo prigioniero, Daniele, che si accorge della macchinazione dei due. Il sollievo è quindi macchiato da una sorta di egoismo che peserà poi a Levi per anni. Daniele si salva e, in Russia Bianca, a liberazione avvenuta, dice a Levi: “perché voi due sì e io no?” (1053). Questa mancanza sarà un fardello continuo perché, negli incontri tra reduci, negli anni a venire, come dice Levi: “quel bicchiere d’acqua non condiviso, stava fra noi, trasparente, non espresso, ma percettibile e costoso” (1053). La sensazione del benessere, a distanza di tempo, è oscurata in questo modo da un giudizio sul comportamento. Come in Se questo è un uomo, anche ne I sommersi e i salvati, il sollievo è dato dal soddisfacimento, parziale e modesto, di un bisogno fisico primario, ma è permesso anche dallo stimolo culturale che salva dall’annientamento della persona. Levi 53
riconosce che la cultura poteva “[...] servire, anche se solo in qualche caso marginale, e per brevi periodi” (1053), però nota subito dopo che forse era meglio dimenticare la cultura, come gli affetti famigliari, per diminuire la sofferenza (1103). Anche in questo caso, rispetto alla sensazione spontanea di benessere che il rinascere della cultura aveva provocato in Se questo è un uomo, abbiamo un giudizio critico a posteriori che offusca la sensazione del momento. Forse per questo motivo, ne I sommersi e i salvati, la felicità più piena non è data da un momento vissuto durante la prigionia, ma dal racconto dell’esperienza della traduzione in tedesco di Se questo è un uomo. In primo luogo, per Levi conta la possibilità di raccontare ai ‘carnefici’ quello che ha patito: Quando, verso il 1959, seppi che un editore tedesco (la Fischer Bücherei) aveva acquistato i diritti per la traduzione, mi sentii invadere da un’emozione violenta e nuova, quella di aver vinto una battaglia. (1124) La soddisfazione di poter testimoniare è finalmente realizzata pienamente e anche in modo umanamente positivo, grazie al rapporto umano con un traduttore che aveva osteggiato il nazismo e che aveva vissuto in esilio. Rispetto a Se questo è un uomo, la scrittura de I sommersi e i salvati lascia in definitiva ancora meno spazio a sprazzi di sensazioni positive, di sollievo, di felicità e, come sappiamo, l’anno dopo Levi si suicida, senza aver cacciato gli incubi degli orrori vissuti. L’ultima riflessione sulla Shoah testimonia inequivocabilmente che l’autore non si è mai liberato dal peso del campo di concentramento, anche a livello stilistico, poiché la differenza tra le due opere è interessante anche dal punto di vista formale. In Se questo è un uomo, gli inserti che esprimono sollievo, benessere, gioia costituiscono infatti l’esempio di una scrittura diversa: il benessere che è definito attraverso il sollievo, la beatitudine di un attimo, il fugace piacere, rompono con la scrittura analitica caratteristica di Levi. Se la critica ha sottolineato più di una volta la straordinaria capacità di osservazione di Levi, accompagnata da un’acutissima capacità di riflessione che riflette lo spirito scientifico del chimico, alla fine della mia catalogazione dei casi, mi sembra interessante poter notare che i momenti di benessere risentono di una scrittura meno lucida, che tende piuttosto a cogliere le sensazioni e a esprimere un certo senso onirico. In Se questo è un uomo, la scrittura onirica è presente nel racconto del sogno del racconto alla famiglia (ne ‘Le nostre notti’), e mi pare che gli episodi di benessere tendano verso questa scrittura, piuttosto che verso la ricerca della precisione tecnica. Il sole sulla pelle, la doppia razione di zuppa, e così altri esempi, sono espressi attraverso le sensazioni, non attraverso l’analisi. La stessa dinamica compare all’inizio de La tregua. I rari momenti di felicità presenti ne I sommersi e i salvati risentono invece di una scrittura più controllata e analitica: l’acqua è un grande benessere, ma comporta l’osservazione morale dello sgarbo fatto all’amico Daniele; la presenza della cultura come elemento che poteva risollevare l’uomo è sottoposta ugualmente ad analisi. Alla parola ‘sollievo’ che 54
indica una sensazione, si sostituisce la parola ‘fortuna’ che comporta un giudizio di merito. Le considerazioni fatte su questi passi rientrano allora perfettamente nella critica che è stata fatta ai due libri. Se questo è un uomo è nato da un bisogno liberatorio di raccontare, e quindi propone degli slanci emotivi all’interno di una struttura razionale. I sommersi e i salvati controlla ancora di più le emozioni e le analizza, come studia la struttura del lager e gli abusi dei carcerieri. Ma soprattutto, ne I sommersi e i salvati, più ancora che in Se questo è un uomo, anche i comportamenti dei prigionieri – e di conseguenza del prigioniero Levi – sono sottoposti ad analisi, togliendo ogni speranza di redenzione. NOTE Il romanzo La tregua è stato scritto molti anni dopo gli avvenimenti (1963). Nel frattempo, Levi era stato chiamato più volte a fare opera di testimonianza (in conferenze, incontri di reduci dai campi di concentramento, incontri con gli studenti nelle scuole e altro ancora). Lui stesso dice che quando ha iniziato la redazione di La tregua aveva già raccontato spesso in pubblico gli episodi del suo ritorno in patria e li aveva affinati dal punto di vista narrativo, osservando le reazioni del pubblico al suo racconto. Per un’analisi letteraria del testo, la conoscenza di questo dettaglio risulta fondamentale. 1
Questa figura si lega alla metafora infernale che ho usato nel testo. Infatti, i prigionieri, anche dopo essere stati liberati, restano per alcuni mesi in una condizione ‘penitenziale, infernale’, poiché sono ancora dipendenti dai russi e in condizioni estremamente difficili. Ma se nei lager – e nell’inferno dantesco – le pene erano orribili, la comicità dei loro demoni torturatori (i russi) risulta parodia, poiché i dolori che loro affliggono ai penitenti risultano più dalla loro goffaggine che da altro. 2
BIBLIOGRAFIA Levi, Primo. I sommersi e i salvati. 1986. Opere (vol. II). Torino: Einaudi, 1997. ‐‐‐. La tregua. 1963. Opere (vol. I). Torino: Einaudi, 1997. ‐‐‐. Se questo è un uomo. 1947. Opere (vol. I), Torino: Einaudi, 1997. 55
VANDEWAETERE, Sara. ‘Primo Levi e le future generazioni: l’etica del dialogo’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 57‐66. RIASSUNTO L’intera opera di Primo Levi si può leggere ed analizzare secondo quella che vorremmo chiamare ‘un’etica del dialogo’. Il primo libro di testimonianza dell’autore, Se questo è un uomo, rievoca la parola e il volto (nel senso del faccia‐a‐faccia di Levinas) del cosiddetto musulmann, o ancora di “chi ha perso la voce ad Auschwitz”, restaurandolo come ‘Altro’ e spingendo in tal modo il lettore – un nuovo ‘Altro’ – ad un autentico coinvolgimento con la sua sorte. La figura del bambino‐sopravvissuto, Hurbinek, che appare all’inizio de La Tregua – il secondo libro di testimonianza di Levi – può essere considerata il simbolo dell’impegno etico dell’autore, volto a ’restaurare‘ i dialoghi precedentemente annientati dalla storia: Hurbinek muore senza aver imparato a parlare, ma l’autore – testimone della sua vana ricerca del parlare – precisa che il bambino testimonia attraverso il suo libro. Insieme al tentativo di rievocare l’Altro ‘assente’, Levi cerca di raggiungere con i propri testi gli Altri ‘presenti‘, vale a dire i lettori. Inizialmente, Levi ha in mente come lettori ideali i responsabili della Shoah, i quali avevano palesemente negato l’alterità delle vittime nel Lager. Più avanti, i libri si aprono più chiaramente ai lettori della ‘nuova’ generazione post‐Shoah. Levi vorrebbe che i suoi libri possano rappresentare per i lettori più giovani dei veri e propri ‘Altri‘ – sostituti di Altri ormai scomparsi nella storia – capaci di incidere realmente sulle loro vite. PAROLE CHIAVE
Altro, dialogo, testimonianza, Shoah, musulmann
© Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 57
PRIMO LEVI E LE FUTURE GENERAZIONI: L’ETICA DEL DIALOGO Sara Vandewaetere Universiteit Antwerpen L’ALTRO ASSENTE Chiunque abbia letto La tregua di Primo Levi si ricorderà del ritratto del piccolo Hurbinek, il bambino misteriosamente sopravvissuto ad Auschwitz e ricoverato nella stessa stanza dell’autore nel ‘campo grande’, il campo principale di Auschwitz trasformato dai liberatori in un luogo di ricovero per i prigionieri malati che i nazisti in fuga avevano abbandonato. La descrizione si conclude con un susseguirsi di frasi, tutte scandite dal nome Hurbinek: Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek, che aveva combattuto come un uomo, fino all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole. (Levi 1997, 216) In questo caso la ripetizione anaforica di Hurbinek non è usata con lo scopo, tipicamente leviano, di “articolare e concatenare con chiarezza i successivi segmenti di discorso”, secondo la formula di Mengaldo, ma è piuttosto un’illustrazione dell’uso dell’anafora svolto ad esprimere “le emergenze di tonalità espressive accusate, dell’eloquenza solenne e commossa”, usato da Levi “con parsimonia”, sempre secondo Mengaldo.1 Un tale uso è in realtà più caratteristico del Levi poeta che ci rincorse volentieri per conferire ai versi quel tocco di drammaticità di cui la sua prosa è generalmente spoglia. È stato Fortini a descrivere i versi come un “grido di apertura” che serve ad introdurre la prosa, “la sua arte più rara e più grande”.2 Con il ritratto di Hurbinek, tuttavia, sembra che trapeli nelle pagine di prosa proprio un’eco di questo grido che tende al patetico. Quale lettore, in fin dei conti, non si commuoverebbe davanti alle sofferenze di un bambino nato e morto ad Auschwitz? Non si tratta di uno degli ingredienti fissi del buon cinema hollywoodiano? L’ultima frase, tuttavia, dovrebbe già rivelare che la funzione di questa scena nel libro è ben più complessa: “egli testimonia attraverso queste mie parole”. Proprio su questa frase si è soffermato Giorgio Agamben, che ne riferisce nel primo capitolo di Quel che resta di Auschwitz.3 La frase rivela la problematicità dello statuto di 58
testimone. Se è possibile far parlare qualcun altro – un bambino muto in questo caso ‐ attraverso le proprie parole, chi è il soggetto della testimonianza, chi parla veramente?4 Levi ha osservato e ripetuto spesso che i “veri testimoni”, i “testimoni integrali” del campo non sono loro, i sopravvissuti, ma sono i Muselmänner. Con questo nome, di origine incerta, si indicano i deportati nei Lager che hanno perso ogni forza fisica e mentale.5 Allo stesso modo, Levi si presentò come porta‐parola di Hurbinek. Si è posto, in altre parole, rappresentante di un gruppo privo di voce. Questo atto ha provocato in Agamben una nuova domanda: come evitare che il prestito della propria voce diventi un’imposizione di voce?6 La risposta formulata da Agamben a tale questione si concentra sulla posizione dell’io narrante. L’atto di parlare, non solo quello del testimone, implica sempre, secondo Agamben, una sorte di desoggettivizzazione. L’io cui il soggetto si riferisce parlando, non coincide mai interamente con la propria personalità.7 L’esperienza del Muselmann è una desoggettivizzazione estrema provata da ogni soggetto parlante. La perdita di se stesso come soggetto è rafforzata in lui dal programma nazista dell’annullamento del soggetto. I testimoni che parlano per i Muselmänner non si sostituiscono semplicemente a loro, perchè non occupano loro stessi una posizione sicura che pretendono gli appartenga. Il vero soggetto non si può definire. Questa situazione risulta, secondo Agamben, nel fatto che: […] il muto e il parlante, il non‐uomo e l’uomo entrano – nella testimonianza – in una zona d’indistinzione in cui è impossibile assegnare la posizione di soggetto, identificare la ‘sostanza sognata’ dell’io e, con essa, il vero testimone.8 Il ragionamento di Agamben, senz’altro impressionante da un punto di vista filosofico, lascia tuttavia aperte alcune domande. Tornando al testo di Levi, infatti, non si può che constatare che solo una piccola parte della testimonianza di Levi è dedicata veramente al Muselmann. Il capitolo di Se questo è un uomo intitolato ‘I sommersi e i salvati’, per esempio, contiene due pagine sui Muselmänner, mentre dieci parlano dei salvati. In che modo il Muselmann trova la propria ’soggettivizzazione’ in queste pagine? In realtà, benché le pagine sui sommersi siano poche, funzionano come introduzione alla lunga descrizione dei salvati: sono loro ad ‘inquadrare’ i salvati. Levi scrisse a proposito dei Muselmänner: Essi (i Muselmänner) popolano la mia memoria della loro presenza senza volto, e se potessi racchiudere in un’ immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare: un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. Se i sommersi non hanno storia, e una sola e ampia è la via della perdizione, le vie della salvazione sono invece molte, aspre ed impensate. (Levi 1997, 86) 59
I quattro ritratti di salvati dipinti uno ad uno dallo scrittore hanno un valore soprattutto in quanto negazione del numero ‘sterminato della massa anonima’ alla quale essi sopravvivono. Tolgono letteralmente lo spazio all’Altro, il ’sommerso’, il vero ’soggetto’ del libro che, malgrado la maggioranza numerica, perde ogni significato agli occhi dei salvati. Questo capitolo diventa così un primo esempio di un’etica notevolmente vicina all’etica di un altro filosofo, il francese Lévinas, in cui l’individuo è sempre costituito da una relazione all’Altro, svolta in questo caso tuttavia chiaramente in negativo.9 I salvati descritti nel capitolo sono individui concentrati sul proprio sviluppo personale e negano continuamente l’imperativo etico dell’Altro che incontrano. Ci troviamo, per così dire, al punto di partenza dell’etica levinassiana, la cui filosofia, spesso anche senza menzionarlo esplicitamente, è impregnata dalla memoria della Shoah. Si potrebbe mettere in questione la validità del Muselmann come ‘Altro’. Lo stesso Levi scrisse a proposito di loro che “si esita a chiamarli vivi” (Levi 1997, 86). Colin Davis dedicò un interessante articolo al significato della morte altrui secondo De Man, Agamben e Levinas. Quest’ultimo tenne diverse lezioni sul soggetto della morte, pubblicate con il titolo Dieu, la mort et le temps, in cui spiegò la possibilità dei morti di continuare ad essere ‘significativi’ per i vivi, a ’investirli’ di significato, anche quando non sono più in grado di comunicare. Proprio l’assenza della loro risposta ha per Lévinas un’influenza sui vivi: Autrui me concerne comme prochain. Dans toute mort s’accuse la proximité du prochain, la responsabilité de survivant, responsabilité que l’approche de la proximité meut ou émeut.10 Davis precisa come per Lévinas la morte dell’Altro non restituisce semplicemente l’identità che l’io aveva prima dell’incontro con esso: l’Altro continua ad occupare la sua esistenza. Il sopravissuto, poi, si definisce in base alla sua ‘sopravvivenza’ all’Altro, ed è investito a maggior ragione di quest’assenza significativa dell’Altro.11 Il Muselmann, tra vita e morte, assomiglia all’Altro già deceduto. Come lui continua a emettere significato, senza disporre della forza del ‘volto’ realmente presente. In questo senso è significativa la descrizione che Levi dà degli occhi dei Musulmänner, ‘vuoti’, senza più espressione. Nel Lager, la vulnerabilità della faccia è portata ad un tale estremo che l’imperativo etico diventa addirittura difficilmente leggibile. In quest’ottica della testimonianza continuamente investita da un Altro ‘invisibile’, si può rileggere il ritratto di Hurbinek. È come se Levi avesse voluto, nelle prime pagine de La tregua sul ‘rientro’ nella vita rendere di nuovo chiaramente visibile la sollecitazione del Muselmann. Con Hurbinek, il significato etico che emerge dagli occhi ‘vuoti’ del Muselmann, è reso esplicito, rappresentabile: Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi: ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli 60
mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio ed umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. (Levi 1997, 215) Benché lo sguardo di Hurbinek sia difficilmente sostenibile per i presenti, ognuno di loro tenta nondimeno di dare una risposta alla sua pena. Le donne polacche incaricate di curarlo lo “ubriacano di carezze e di baci” (216). Henek, un giovanissimo sopravvissuto gli sta vicino e gli è “materno più che paterno” (216). Lo stesso Levi, infine, non ancora nelle condizioni di potersi occupare del bambino essendo lui stesso malato, provvederà più tardi a colmarne il mutismo attraverso la testimonianza. Con il ritratto di Hurbinek Levi presenta esplicitamente il proprio scrivere come la risposta ad un imperativo etico emerso dal Muselmann del Lager. Si tratta del primo passo verso il restauro del dialogo reso impossibile dalla realtà nazista. L’ALTRO PRESENTE: IL LETTORE TEDESCO Per poter portare a buon fine questo progetto di scrittura, inteso come un continuo rispondere alla domanda dell’Altro, è necessario un terzo elemento, un ‘nuovo’ Altro che risponda a sua volta alle mie domande costituite a partire delle richieste ricevute. I primi che Levi vorrebbe vedere in questa posizione dell’Altro ‘rispondente’ sono i tedeschi. Ne I Sommersi e i salvati egli scrive che con la scrittura di Se questo è un uomo voleva “legare i tedeschi davanti ad uno specchio”. Con la sua scrittura Levi vuole obbligare i tedeschi a vedere: Da soverchiatori, o da spettatori indifferenti, sarebbero diventati lettori, li avrei costretti, legati davanti ad uno specchio. (Levi 1997, 1125) Un altro sguardo, infatti, da ‘spettatore indifferente’, precede lo sguardo significativo del piccolo Hurbinek: non quello ‘invisibile’ del Muselmann, ma quello di chi non vuole vedere, appartenente ai nazisti. L’emblema di questo sguardo indifferente è quello del Dottor Pannwitz, il chimico tedesco con cui Levi deve passare un esame nel Lager, per essere ammesso come addetto al laboratorio: Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. Da quel giorno, io ho pensato al Dokter Pannwitz molte volte e in molti modi […] Perché quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l’essenza della grande follia della terza Germania. (101‐102) Levi insiste sul fatto che lo sguardo indifferente dei tedeschi davanti alla sofferenza è per lui incomprensibile. Dagli occhi senza difesa, in specie quelli dello stesso Levi, emerge chiaramente l’imperativo ‘tu non ucciderai’, la vulnerabilità presente nello sguardo è un imperativo al soccorso.12 Un tale imperativo, per Lévinas soprattutto un 61
obbligo morale, dovrebbe essere per Levi addirittura un’evidenza, un imperativo categorico kantiano. Nel breve saggio Contro il dolore, incluso ne L’Altrui mestiere, l’autore riferisce ad una norma scritta in noi, e riconosciuta da tutte le religioni e le legislazioni, [che] ci intima di non creare dolore né in noi né in alcuna creatura capace di percepirlo. (Levi 1997, 674) Per Levi, il fatto stesso di vedere dovrebbe portare ad una reazione, ad una presa di responsabilità. Questa convinzione è tanto forte in Levi da non fargli accettare l’idea che i tedeschi abbiano potuto semplicemente guardare e sopportare le sofferenze inflitte dal regime. Se non sono intervenuti, è perché si sono rifiutati di guardare. Da questa riflessione nasce nella scrittura una metafora ricorrente della “cecità volontaria”, a cui Levi ritorna sempre per esprimere la colpa del tedesco ‘comune’, rimasto indifferente. Sono questi tedeschi che Levi ha voluto ’legare davanti allo specchio’ con le sue parole. Questa speranza, non da poco, la dice lunga sulla sua concezione dello scrivere e della lettura, come azione che invade la realtà per investirla e cambiarla. I suoi libri, quindi, diventano nuovi Altri, in cui partecipano, per così dire, i sommersi e salvati, che richiedono di nuovo una risposta: Il libro lo avevo scritto sì in italiano, per gli italiani, per i figli, per chi non sapeva, per chi non voleva sapere, per chi non era ancora nato, per chi, volentieri o no, aveva acconsentito all’offesa; ma i suoi destinatari veri, quelli contro cui il libro si puntava come un’arma, erano loro, i tedeschi. […] Era venuta l’ora di fare i conti, di abbassare le carte sul tavolo. Soprattutto, l’ora del colloquio. (1125) Levi non solo vuole parlare ai tedeschi, obbligarli a confrontarsi con il proprio sguardo che avevano sempre negato, ma li vuole anche convocare ad un colloquio, si aspetta da loro una risposta. Nella prefazione all’edizione tedesca, apparsa in Germania nel 1960, Levi invita implicitamente i tedeschi a reagire. Riceve molte lettere che lo lasciano perlopiù insoddisfatto. Tuttavia, tiene al fatto di pubblicare gran parte di queste lettere ne I Sommersi e i salvati. L’ultimo libro che ha scritto, quindi, contiene, forse inconsapevolmente, il compimento del dialogo ’tedesco’ materializzatosi nelle lettere sopracitate. L’ALTRO PRESENTE: IL LETTORE GIOVANE Il secondo gruppo con cui l’autore ha voluto riallacciare il dialogo è quello dei giovani. In un testo quasi contemporaneo alla stesura de I Sommersi e i salvati, scritto in occasione di un convegno sulla testimonianza, Levi indicò i giovani come un altro lettore modello che aveva in mente al momento della scrittura: 62
Fin dal primo libro, Se questo è un uomo, ho desiderato che i miei scritti, anche se li ho firmati io, fossero letti come opere collettive, come una voce che rappresentasse altre voci. Più ancora: che fossero un’apertura, un ponte fra noi ed i nostri lettori, specie se giovani. È gradevole, fra noi ex deportati, sedere a mensa e raccontarci a vicenda le nostre ormai lontane avventure, ma è poco utile. Finché siamo vivi, è il nostro compito parlare sì, ma agli altri, a chi non era ancora nato, affinché sappia ‘fin dove si può arrivare’. (3151) Levi ripetè la sua concezione della testimonianza come un discorso ‘per delega’ ma – si noti – non si tratta più di un discorso a due voci, si tratta di un discorso ‘collettivo’, una voce che ne rappresenta ‘altre’. Parlando ai tedeschi, Levi voleva rendere partecipe un Altro specifico, da loro negato all’epoca degli eventi. Ai giovani, Levi vuole mostrare una moltitudine di Altri che essi non hanno potuto conoscere. Il compito di rendere l’Altro partecipe si sposta, per così dire, dal sincronico al diacronico. Ai giovani non bisogna soltanto portare la voce dei Muselmänner, ma anche rendere visibili due ‘generazioni’ a loro sconosciute, quella cosiddetta pre‐olocausto e quella dell’olocausto. Solo in quel modo, i giovani possono dare un senso alla propria generazione. Diversi libri di Levi, anche non specificamente legati alla Shoah, svolgono il compito sopracitato di opera ‘intergenerazionale’. Ne diamo qualche rapido esempio. È significativo, per esempio, l’inizio de Il Sistema periodico con il capitolo Argon, che contiene una descrizione delle generazioni di ebrei specie piemontesi che precedevano l’autore. La prima redazione del capitolo è anteriore al progetto de Il Sistema periodico ed è una sorte di “divagazione filologico‐narrativa” sulla lingua ebraico‐piemontese dei suoi antenati.13 Sarebbe stato logico per questo suo approccio preso in prestito da un ‘mestiere diverso dal suo’, quello del filologo, includerlo tra i saggi de L’Altrui mestiere che Levi stava scrivendo e pubblicando proprio in questi anni in diversi giornali. Al contrario, Levi ha adattato il saggio per poterlo integrare nel romanzo biografico Il sistema periodico. Per il ripercorso della sua vita, ha voluto iniziare proprio da questi antenati, instaurando una chiara continuità tra la sua generazione e quelle precedenti. Per l’adattamento del capitolo per il libro ha aggiunto una parte dedicata alla nonna paterna e al padre, riavvicinando così queste generazioni alla propria (Levi 1997, 1448). È interessante notare che Levi ha riferito in un’intervista di una spaccatura tra la sua generazione e quelle precedenti.14 Nel libro, tuttavia, inserendo Argon come primo capitolo, ha insistito sulla continuità generazionale. Quando propose il manoscritto a Calvino, questi gli consigliò di inserire il capitolo a metà del libro.15 Un tal ordine avrebbe reso più evidente come la continuità familiare avesse cambiato di significato dopo la guerra, ma anche per la stessa generazione di Levi. Con la posizione introduttiva, invece, Levi insistette subito sul valore di una continuità familiare e generazionale che il suo libro doveva restaurare. Il tema, tra l’altro, è dominante anche all’interno del capitolo. Nella descrizione dei parenti diventa impossibile ricostruire con esattezza chi appartenga a quale generazione. Nonni, bisnonni, cugini lontani ecc. sono tutti chiamati ‘zii’. I loro nomi si confondono con 63
l’appellativo e questi strani nomi si “tramandano invariati di generazione in generazione insieme con le vicende, le memorie e i detti che li ha a lungo portati”.16 Persino in un libro come La chiave a stella, di per sé uno dei più lontani dalla tematica della Shoah, è presente l’etica di questo dialogo intergenerazionale, minacciato dagli avvenimenti della guerra. Il protagonista Faussone, più giovane dell’autore, è un personaggio un po’ ’vecchio stile’, attaccato a norme e valori che si stanno perdendo. Non a caso, lo studioso Segre17 ha notato come molti dei valori di Faussone, soprattutto quelli legato al lavoro, sono da riportare alla concezione ebraica del lavoro manuale, un altro universo in via di sparizione in questa Torino del dopoguerra di cui Faussone è originario. Citiamo infine un ultimo libro che si pone, in qualche modo, come libro ‘intergenerazionale’: in Se non ora, quando? Levi raccontò la storia di un gruppo di ebrei partigiani che si spostano dall’Oriente all’Italia. Oltre al progetto di rendere noto ad un pubblico italiano il mondo ‘cancellato’ degli ebrei orientali, Levi disse nelle interviste che il libro conteneva una ‘tesi’ rivolta in particolare ai giovani ebrei d’Israele.18 Secondo lo scrittore, la giovane generazione di coloro che sono nati in Israele accusava quella precedente di essersi fatta massacrare senza opporre resistenza. Con il libro Se non ora, quando? Levi volle dimostrare loro una realtà diversa. CONCLUSIONE: LA FILOSOFIA APPLICATA DI LEVI Lo sforzo di rendere presente l’assente, inizialmente tipico dell’opera di testimonianza di Primo Levi, diventa una costante della sua scrittura, tanto che ogni libro successivo si può leggere come un tentativo di restaurare la linea interrotta tra le generazioni, come se si trattasse da una linea di tanti Altri consecutivi nel tempo e continuamente minacciati dal negarsi a vicenda. Per capire fino in fondo l’attitudine di Levi verso l’Altro – prima il Muselmann e poi il lettore, il filosofo Lévinas è un’ottima guida. Nondimeno, ogni legame tra i due autori rimane meramente ‘virtuale’: Levi e Lévinas non si sono conosciuti, forse non si sono neanche letti. La quasi totale mancanza di conoscenza da parte di Levi dei filosofi d’oltralpe a lui contemporanei, fra cui Merleau‐Ponty, Sartre e Lévinas, è senz’altro legata ad un ritardo nella ricezione di tali filosofi in Italia. D’altra parte Levi sembra voler preferire tornare a punti di riferimento settecenteschi – si pensi a Kant – o addirittura antichi – fra cui Aristotele, piuttosto di rivolgersi ai nuovi filosofi. Questo continuo volgersi all’indietro gli è valso l’appellativo di scrittore ‘pre‐moderno’ appartenente a tempi a lui anteriori. Non può tuttavia sfuggire l’attualità dei testi di Levi, che sono – quasi involontariamente – vicini al pensiero dei filosofi del dopoguerra. Dopo la prigionia ad Auschwitz, Levi ha continuamente riflettuto nei suoi scritti sulle esperienze da lui vissute – talvolta riferendosi a testi ‘classici’ da lui letti e riletti e adattandoli a nuove realtà. La sua filosofia più ‘moderna’ è quindi da cercare nei suoi scritti più che nelle 64
sue letture. Se è giustificato parlare di una ‘svolta etica’ di Levi,19 essa si trova proprio in questo spostamento dalla lettura – più intensa nell’età giovanile – ad una scrittura rivolta all’Altro. NOTE Mengaldo in Levi 1997, 173‐174. 1
Fortini 1991, 166. 2
Agamben 1998, 36. 3
Due articoli mi hanno guidato nella lettura e l’interpretazione del complesso libro di Agamben: McCellan 2005 e Leshem 2005. 4
Levi diede la seguente spiegazione di Muselmann in una nota di Se questo è un uomo: “Con tal termine, Muselmann, ignoro per qual ragione, i vecchi del campo designavano i deboli, gli inetti, i votati alla selezione” (Levi 1997, 84). 5
Agamben 1998, 111. 6
Ibidem, 113. 7
Ibidem, 112. 8
Levinas 1980. 9
Levinas 1980, 26. 10
Davis 2004, 82. 11
Levinas 1980, 91. 12
Belpoliti 1997, 1448. 13
Papuzzi in Belpoliti 1997, 31. 14
Belpoliti 1997, 1451. 15
Levi 1997, 743. 16
Segre 2002, 173‐190. 17
Kleiner in Belpoliti 1997, 81. 18
Gordon 2003, 24. 19
BIBLIOGRAFIA Agamben, Giorgio. Quel che resta di Auschwitz, L’archivio e il testimone. Torino: Bollati, 1998. Belpoliti, Marco. ‘Note ai testi’. Opere 1. A cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1997. 1372‐1469. Davis, Colin. ‘Can the Dead Speak to Us? De Man, Levinas and Agamben’. Culture, Theory and Critique 45/1 (2004): 77‐89. 65
Fortini, Franco. ‘L’opera in versi’. Il presente del passato. A cura del Consiglio Regionale del Piemonte‐
Aned. Torino: Angeli, 1991. 137‐10. Ristampato in Primo Levi: un’antologia della critica. A cura di Ernesto Ferrero. Torino: Einaudi, 1997. 163‐68. Gordon, Robert S.C., Primo Levi: le virtù dell’uomo normale, Traduzione di Dora Bertucci & Bruna Soravia. Roma: Carocci, 2003. Kleiner, Barbara. ‘Ritratto della dignità e della sua mancanza negli uomini’. Traduzione di Roberto Gilodi. Neue Musikzeitung (agosto‐settembre 1986). Ristampato in Primo Levi: Conversazioni e interviste, a cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1997. 77‐83. Levi, Primo. Opere 1. A cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1997. ‐‐‐. Opere 2. A cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1997. Lévinas, Emmanuel. Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité. 1961. La Haye: Martinus Nijhoff, 1980. ‐‐‐. Ethique et infini. Dialogues d’Emmanuel Levinas et Philippe Nemo. Paris: Fayard, 1982. ‐‐‐. Dieu, la mort et le temps. Paris: Grasset, 1993. Leshem, Dan. ‘The Question of Ethical discourse: Emmanuel Levinas, Primo Levi, and Giorgio Agamben’. The Legacy of Primo Levi, a cura di Stanislao G. Pugliese. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 153‐160. Mengaldo, Pier Vincenzo. Introduzione: ‘Lingua e scrittura in Levi’. Primo Levi, Opere III, a cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1987. Ristampato in Primo Levi: un’antologia della critica, a cura di Ernesto Ferrero. Torino: Einaudi, 1997. 169‐244. McCellan, William, ‘Levi, Agamben and the New Ethics of Reading’. The Legacy of Primo Levi, a cura di Stanislao G. Pugliese. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 147‐52. Papuzzi, Alberto. ‘L’alpinismo? È la libertà di sbagliare’. Rivista della montagna (marzo 1984). Ristampato in Primo Levi: Conversazioni e interviste, a cura di Marco Belpoliti. Torino: Einaudi, 1997. 27‐
32. Segre, Cesare. ‘Primo Levi et la conception hébraïque du travail manuel’. Primo Levi, Le double lien, a cura di Walter Geerts e Jean Samuel. Paris: Editions Ramsay, 2002. 173‐190. 66
LUZI, Alfredo. ‘L’altro mondo di Levi. Scienza e fantascienza nelle Storie Naturali’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, a cura di. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 67‐76. RIASSUNTO La produzione narrativa più nota di Primo Levi è quella dei cosiddetti romanzi ‘testimoniali’ mentre i racconti, come Storie Naturali, costituiscono un insieme di testi a cui non sempre la critica ha riservato la giusta attenzione, pur essendo essi funzionali ad una prospettiva globale della scrittura di Levi. Storie Naturali è un titolo ripreso da Plinio, che ha un carattere antifrastico: tra scienza e fantascienza, queste storie sono naturali proprio perché prevedono l’errore, l’imprevisto, l’abnorme. Così Levi chimico‐scrittore, deportato‐ritornato, scienziato‐letterato, è nello stesso tempo autore di romanzi drammatici e di racconti ironici e in qualche modo fantascientifici. Il punto di partenza comune è il tema della genesi, della creazione, dell’ebraismo utilizzato come elemento ontogenetico della scrittura fantastica. In realtà nessuna pagina di Levi si distacca dall’evento iniziale, la deportazione ad Auschwitz. È dal campo di sterminio dove, come dice lo scrittore, “la morte era il prodotto principale”, che è nata la necessità di raccontare, di utilizzare la scrittura come terapia, come luogo espressivo di resistenza. Anche in Storie Naturali si sente l’esigenza di Levi di avviare una comunicazione, mescolando l’influsso dell’oralità come rito di conoscenza alla necessità di testimoniare, che è uno dei temi ricorrenti della fantascienza tradizionale. Levi, nei suoi romanzi e racconti, è sempre la persona che ritorna dal mondo dei morti e racconta perché gli uomini non dimentichino. Utilizzando la metafora del centauro e dell’anfibio Levi dichiara che in lui convivono due mezzi cervelli, l’uno proiettato verso il mondo della fabbrica e l’altro verso il mondo della letteratura. È l’aver preso coscienza di questo destino a spingerlo ad una narrativa in cui è fortemente presente l’ambiguità della fantascienza. Non c’è dunque altra prospettiva, per uscire dalla contaminazione del male che egli ha conosciuto attraverso la destituzione dell’uomo, che realizzare attraverso la scrittura, che per Levi coincide con la libertà, la proiezione nel mondo del possibile. PAROLE CHIAVE Levi, racconti, scienza, fantascienza, ibrido © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 67
L’ALTRO MONDO DI LEVI SCIENZA E FANTASCIENZA NELLE STORIE NATURALI Alfredo Luzi Università degli studi di Macerata La pubblicazione del libro di racconti Storie Naturali avviene nel 1966 con lo pseudonimo di Damiano Malabaila. Scrive Levi:
Credevo di averlo scelto casualmente: è il nome di un esercente, davanti alla cui bottega passo due volte al giorno per andare al lavoro. (Poli & Calcagno 1992, 37) Ma poi scopre, a livello semantico, che in piemontese malabaila vuol dire ‘cattiva balia’. E in effetti, egli dice: Mi pare che da molti miei racconti spiri un vago odore di latte girato a male, di nutrimento che non è più tale, insomma, di sofisticazione, di contaminazione e di malefizio. Veleno in luogo dell’alimento: e a questo proposito vorrei ricordare che per tutti noi superstiti, il Lager, nel suo aspetto più offensivo e imprevisto, era apparso proprio questo, un mondo alla rovescia, dove fair is foul and foul is fair, i professori lavorano di pala, gli assassini sono caposquadra e nell’ospedale si uccide. (37) Ad una prima lettura il volume sembra molto lontano dalla tematica testimoniale delle opere più famose di Levi. Lo stesso autore dichiara che nella costruzione dei personaggi c’è una certa ‘frettolosità’: Tutti questi racconti io li ho scritti quando lavoravo in fabbrica ed avevo fretta. Avevo fretta in fabbrica perché la vita di fabbrica – in una fabbrica seria come la mia – consiste nell’aver sempre troppe cose da fare; e in più c’era una mia fretta privata perché queste cose le scrivevo non durante le ore di lavoro, ma dopo. Quindi può darsi che si rifletta una fretta mia propria che era costante. (Belpoliti 1997, 75) Sicuramente ciò che colpisce a prima vista il lettore è la componente ironica, un’atmosfera di divertissement che sembra contrastare con i toni drammatici di Se questo è un uomo, Se non ora, quando, e così via. Ma non dimentichiamo che Massimo Mila ha scritto: Direi che Levi era un umorista. Saba, a proposito di un altro ebreo, Svevo, ha detto che ‘l’umorismo è la forma suprema della bontà’. E questo vale anche per Levi che ha sempre dichiarato di non portare odio nei confronti dei suoi aguzzini. Ma l’umorismo nasce anche dall’atteggiamento dello 68
scrittore‐chimico, interessato alle contraddizioni della vita, dello scrittore che, per sua stessa ammissione, dichiara di essere letteralmente un voyeur, un osservatore, diremmo oggi un etologo. Questa condizione è adombrata nel racconto ’Trattamento di quiescenza’, in cui il personaggio rivive esperienze di realtà virtuale. Levi sembra addirittura essere stato profetico: L’ascoltatore, anzi il fruitore, non ha che da indossare un casco, e durante tutto lo svolgimento del nastro riceve l’intera e ordinata serie di sensazioni che il nastro stesso contiene: sensazioni visive, auditive, tattili, olfattive, gustative, cenestesiche e dolorose; inoltre, le sensazioni per così dire interne, che ognuno di noi allo stato di veglia riceve dalla propria memoria. […] Insomma, tutti i messaggi afferenti che il cervello, o meglio (per dirla con Aristotele) l’intelletto paziente, è in grado di ricevere. La trasmissione non avviene attraverso gli organi di senso del fruitore, che restano tagliati fuori, bensì direttamente a livello nervoso, mediante un codice che la NATCA mantiene segreto: il risultato è quello di una esperienza totale. (Levi 1990, 166) Ma è presente anche nel racconto ‘La misura della bellezza’, in cui il personaggio in prima persona dice: È questa, di vedere non visto, principalmente se dall’alto, una occupazione che mi ha sempre appassionato. Peeping Tom, che preferì morire piuttosto che rinunciare a sbirciare Lady Godiva dalla fenditura delle persiane, è il mio eroe; spiare i miei simili, indipendentemente da quanto fanno o stanno per fare, e da ogni scoperta finale, mi dà una sensazione di potenza e di appagamento profondo: forse è un ricordo atavico delle attese estenuanti dei nostri proavi cacciatori, e riproduce le emozioni vitali dell’inseguimento e dell’agguato. (Levi 1990, 109) L’attività di osservatore è dunque all’origine della narrazione che si sviluppa secondo uno schema molto vicino a quello dei romanzi gialli: da una congerie di indizi il narratore cerca di individuare una serie di rapporti, come in un thriller, per poi arrivare, dopo un lieve rallentamento del tempo di lettura, alla costruzione di un finale. In Storie Naturali l’ironia è un meccanismo aggiustatore, un contenuto stabilizzante (per usare il linguaggio di Wayne Booth in A Rhetoric of Irony (1974)). Eppure esiste un legame intimo tra l’opera precedente e quest’opera che si potrebbe collocare grosso modo nell’ambito della fantascienza. In un’intervista di Edoardo Fadini, egli risponde: No, non sono storie di fantascienza se per fantascienza si intende l’avvenirismo, la fantasia futuristica a buon mercato. Queste sono storie più possibili di tante altre. Anzi, talmente possibili che alcune si sono persino avverate. Per esempio quella del ‘Versificatore’ (un poeta commerciale acquista una macchina per far versi per servire meglio la clientela; la macchina è poi l’autrice della stessa commedia che ascoltiamo); sono noti i tentativi, anche interessanti, già realizzati in questa direzione. Sì, sono storie che si svolgono ai margini della storia naturale, per questo le ho chiamate così, ma sono anche innaturali, se si guardano da un certo lato. Ed è ovvio che i due significati si incrocino [...]. Io sono un anfibio, un centauro (ho anche scritto dei racconti sui centauri). E mi pare che l’ambiguità della fantascienza rispecchi il mio 69
destino attuale. Io sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un’altra, invece, è totalmente distaccata dalla prima, ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli […]. E sono due parti di me stesso talmente separate che sulla prima, quella della fabbrica, non riesco nemmeno a lavorarci su con la penna e con la fantasia […]. È l’altro mondo che si realizza nei miei libri […]. Ma tutto si è svolto al di fuori della mia vita di tutti i giorni. Stando così le cose, mi pare, è naturale che uno scriva di fantascienza. Queste Storie Naturali sono inoltre le proposte della scienza e della tecnica viste dall’altra metà di me stesso in cui mi capita di vivere. (Levi 1997, 106‐107) Non c’è dunque altra prospettiva per uscire dalla contaminazione del male che egli ha conosciuto attraverso la destituzione dell’uomo, che realizzare attraverso la scrittura, che per Levi coincide con la libertà, la proiezione nel mondo del possibile. Ma Levi precisa anche, in un’ intervista del 1972 , che Quando questa mia funzione (di scrittore d’occasione, testimone di importanti avvenimenti storici) si è esaurita mi sono accorto di non poter insistere sul registro autobiografico, e insieme di esser stato troppo “segnato” per poter scivolare nella fantascienza ortodossa: mi è sembrato allora che un certo tipo di fantascienza potesse soddisfare il desiderio di esprimermi che ancora provavo, e si prestasse a una forma di moderna allegoria. (150) Tra le sue fonti Levi cita Verne, Wells, Swift, ma in qualche modo il retroterra ispirativo è molto più ampio e comprende non solo scrittori ma anche filosofi, scienziati, biologi, zoologi. L’attenzione alla biologia e alla zoologia deriva dalla suggestione di opere come Il mondo nuovo di Huxley e dagli studi di Lorenz. Ma è indubbio che in Storie Naturali il rapporto tra natura e civiltà risenta dell’etica della conoscenza del monod de Il caso e la necessità, per trovare poi il suo sostrato nella problematica rousseauiana del rapporto tra umanità e animalità. L’atteggiamento etologico di Levi è confermato dal processo di regressione mimetica che egli adotta, avvicinando i livelli dell’istintuale e del razionale, nel continuo riferimento agli animali che caratterizza la tematica di Storie Naturali. Incontriamo galline, polli, rospi, orsi, angeliche farfalle, conigli, libellule, formiche, pesci‐vacca, serpenti, termiti, superbestie e infine centauri. Ma il caso di più stretto contatto tra mondo animale e mondo umano è quello della tenia, del parassita (l’amico dell’uomo è il titolo chiaramente ironico del racconto) che cerca una forma di simbiosi con il corpo che lo ospita. E Levi, imitando per straniamento il linguaggio dei salmi biblici, si sofferma a descrivere i rapporti affettivi fra il parassita e l’ospite. In questo racconto sono anche citati scienziati come Serrurier, Flory (chimico e premio Nobel) e Bernard Losurdo, che è un calco di Antonio Losurdo. L’influenza di Darwin e dell’evoluzionismo, peraltro, è individuabile in testi come ‘Angelica farfalla’ e ‘Pieno impiego’. Von Frisch (Il linguaggio delle api) viene chiaramente citato mettendo in rapporto la vita gregaria delle api con quella sperimentata nel lager. Nel racconto ‘Quaestio de centauris’ inoltre Levi cita un libro 70
di fantascienza di Ph.J. Farmer, in cui l’autore inventa un organo supplementare per risolvere le difficoltà di respirazione dei centauri. Sul piano letterario è evidente la vicinanza con il Conrad di Giovinezza (un tema ricorrente in Storie Naturali: vedi ‘La bella addormentata nel frigo’) e con Saint‐
Exupéry, soprattutto nei riferimenti al volo, all’ascesa, alla liberazione dal peso della materia. Ma è soprattutto la letteratura classica, da Plinio a Lucrezio a Rabelais, ad essere l’humus ispirativo delle Storie Naturali. In fondo tutta l’opera di Levi è un grande affresco de rerum natura. Il titolo del volume è ovviamente ripreso da Plinio. E vorrei ricordare che Levi ha dedicato allo scrittore e naturalista latino una poesia, ‘Plinio’, in cui questi, spinto dall’avventura della conoscenza, muore per essersi avvicinato troppo al vulcano Vesuvio: “Voglio osservare da presso quella nuvola fosca” (Levi, Ad ora incerta, in Levi 1988, 552). Ma Levi affida al titolo anche un valore antifrastico: naturali queste storie lo sono proprio perché prevedono l’errore, l’abnorme, l’imprevisto. Levi chimico‐scrittore, deportato‐ritornato, scienziato‐letterato, è nello stesso tempo autore di romanzi drammatici e di scherzi letterari, ed apre le Storie Naturali con una citazione da Rabelais, in cui c’è il richiamo al mito, alla fecondità della natura, ai parti contro natura: Car je vous dis que à Dieu rien n’est impossible. Et, s’il vouloit, les femmes auroient dorenavant ainsi leurs enfants par l’oreille. Bacchus ne fut il pas engendré par la cuisse de Jupiter? […] Mais vous seriez bien davantaige esbahis et estonnés si je vous exposois presentement tout le chapitre de Pline, auquel parle des enfantements estranges et contre nature. Et toutesfois je ne suis point menteur tant asseuré comme il a esté. Lisez le septiesme de sa Naturelle Histoire, chap.III […]. (Levi 1990, 3) In effetti il tema della genesi, della creazione, ritorna molto spesso in Storie Naturali e ritengo che sia comunque da ricondurre al peso della sua presenza nella cultura ebraica. In realtà nessuna pagina di Levi si distacca dall’evento iniziale, la deportazione ad Auschwitz. È dal campo di sterminio dove, come dice Levi, “la morte era il prodotto principale” (Belpoliti 1997, 95) che è nata la necessità di raccontare, di utilizzare la scrittura come terapia, come luogo espressivo di resistenza. Anche in Storie Naturali si sente l’esigenza di Levi di avviare una comunicazione mescolando l’influsso dell’oralità come rito collettivo di conoscenza (spesso in Storie Naturali l’oggetto della scrittura è un racconto orale) alla necessità di testimoniare che, non a caso, è uno dei temi ricorrenti nella fantascienza tradizionale secondo la sequenza narrativa canonica: ritorno da un altro mondo – risveglio dal sonno o dal sogno – valore della memoria e della ricezione sensoriale‐racconto. Per contrasto, nelle opere testimoniali di Levi è ricorrente il sogno di raccontare e di non essere ascoltato. Levi quindi è la persona che, come nella fantascienza, ritorna dal mondo dei morti perché gli uomini non dimentichino. 71
Ne ‘I mnemagoghi’, ad esempio, è presente una tipica struttura enumerativa da racconto orale: Parlò a lungo, dapprima con molte pause, poi più rapidamente […]. Si trattava evidentemente di un soliloquio, di una grande vacanza che Montesanto si stava concedendo. Per lui le occasioni di parlare (e si sentiva che sapeva parlare, che ne conosceva l’importanza) dovevano essere rare, brevi ritorni ad un antico vigore di pensiero ormai forse perduto. Montesanto raccontava; della sua spietata iniziazione professionale, sui campi e nelle trincee dell’altra guerra; del suo tentativo di carriera universitaria, intrapreso con entusiasmo, continuato con apatia ed abbandonato tra l’indifferenza dei colleghi, che aveva fiaccato tutte le sue iniziative; del suo volontario esilio nella condotta sperduta, alla ricerca di qualcosa di troppo mal definibile per poter mai venire trovato; e poi la sua vita attuale di solitario […]. (Levi 1990, 7) Il racconto intitolato ‘Censura in Bitinia’ si sviluppa, invece, su un tono sarcastico contro i regimi totalitari che impongono la censura e vietano la libertà di comunicazione, dimostrando mancanza di intelligenza. Levi immagina un episodio di esecuzione dovuto ad un semplice refuso tipografico, il banale equivoco che scatena la reazione ottusa del potere, che nella parola ‘reggipento’ invece di ‘reggimento’ legge un’allusione oscena. In questo caso la trasmissione orale è addirittura l’unica alternativa alla censura sui documenti scritti: si venne a sapere di altri episodi “di cui corse voce di bocca in bocca”. Il racconto ‘Il versificatore’ finisce con un’ipotesi di autonomia creativa dello strumento: […] gli ho insegnato a comporre in prosa e se la cava benissimo […]. Il testo che avete ascoltato, ad esempio, è opera sua […]. (41) Anche in ‘Quaestio de centauris’ ci sono spesso degli inserti che fanno riferimento alla narrazione orale e alla veridicità della storia raccontata: […] lo attesta la storia che sto per raccontare […]. […] ( il maniscalco) raccontava all’intero villaggio del suo strano cliente […]. Mi pesa scrivere questa storia. E’ una storia della mia giovinezza, e mi pare, scrivendola, di espellerla da me […]. (121‐26) In una conversazione con Anthony Rudolf, Levi ha affermato che: Raccontare una storia non è privilegio esclusivo dello scrittore. Tutti possono farlo, oralmente, verbalmente. Tutti dovrebbero farlo. (Levi in Belpoliti 1997, 104) Ma il punto di partenza sta nella difesa della memoria, tavoletta di cera in cui si incidono non solo eventi ma anche odori e sapori e insieme prezioso magazzino nel quale rinvenire reperti che ci aiutino a capire come procede il mondo. Da una parte la mancanza di memoria è in Storie Naturali indizio di incapacità a comprendere e ad interpretare la realtà: non a caso le galline di ‘Censura in Bitinia’, a differenza di altri 72
animali, hanno la memoria evanescente e Maria, la smemorata di ‘La bella addormentata nel frigo’, ha “veramente una memoria da gallina” (Levi 1990, 92); dall’altra Levi attribuisce alla memoria umana una grande funzione evocativa e di collegamento concettuale tra passato, presente e futuro. In ‘Trattamento di quiescenza’ egli differenzia qualitativamente la memoria umana, che era alla base delle prove olfattive proposte dal personaggio Montesanto all’interlocutore Morandi – “i ricordi per essere suggestivi devono avere il sapore dell’antico” (11) – da quella tecnologica, sempre rinnovabile e concentrata sull’attualità – “Il Torec non dà assuefazione, purtroppo: ogni nastro può essere fruito infinite volte, ed ogni volta la memoria genuina si spegne, e si accende la memoria d’accatto che è incisa sul nastro stesso” (183). Ne ‘I mnemagoghi’ (scritto nel 1946) Levi, sulla base della sua esperienza di chimico e recuperando suggestioni letterarie che gli derivano da Baudelaire e Rimbaud, i poeti dei profumi, o psicologiche che lo avvicinano alla Gestalt, crea un personaggio che interroga la propria memoria attraverso gli odori. Ed ogni singolo odore, raccolto in boccette, determina il riemergere di un’esperienza esistenziale (“Comprendo che per lei non sia niente: per me è la mia infanzia” (10) esclama Morandi, aspirando da una boccetta). D’altronde nel saggio ‘Il linguaggio degli odori’ Levi ha parlato dell’ “odore di Polonia”: […] innocuo, sprigionato dal carbon fossile usato per il riscaldamento delle case, mi ha percosso come una mazzata: ha risvegliato a un tratto un intero universo di ricordi, brutali e concreti, che giacevano assopiti, e mi ha mozzato il fiato. (Levi 1985, 229) Ricordare dunque non è mettere a fuoco razionalmente una situazione pregressa ma riassaporare un grumo di sensazioni sedimentate. Dice ancora Levi: […] è anche vero che un ricordo troppo spesso evocato, ed espresso in forma di racconto, tende a fissarsi in uno stereotipo, in una forma collaudata dall’esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna, che si installa al posto del ricordo greggio e cresce a sue spese. (I sommersi e i salvati in Levi 1987, 664) Egli insiste così sulla reattività sensoriale dell’individuo che lascia le tracce della sua esistenza nel suo DNA, lo scrigno della nostra soggettiva memoria biologica. Nel misterioso cammino dal non vivente al vivente, dall’oscurità profonda del grembo terreno dagli archetipi ctonii alla fecondazione totale (panspermia) Levi trova il punto di contatto tra creazione ed evoluzione. In questo senso è emblematico il racconto ‘Quaestio de centauris’, scritto agli inizi degli anni sessanta e pubblicato su Mondo nel 1961. Egli riprende il mito greco del centauro (simbolo della commistione tra istinto e raziocinio) ma nello stesso tempo rielabora un mito ebraico. Dal fango, dall’argilla, ha origine la vita. E il Noè centauresco non ospita nell’arca animali immondi ma solo le specie archetipe. Attraverso la presenza totale dell’amore (“la terra fornicava col cielo”) l’universo è un ribollire di fecondità, quasi un ritorno al caos primigenio. In questa cosmogonia 73
scandita da parti e germinazioni, attraverso l’innamoramento di Trachi, il centauro, per Teresa De Simone (la fanciulla amica d’infanzia del protagonista‐narratore), s’innesta il tema dell’evoluzione (“sto mutando […] sono diventato un altro”): e non dimentichiamo che il mutamento è uno dei topoi narrativi della fantascienza: i mutanti, gli alieni, eccetera. Ma per un tradimento sessuale dell’uomo si rompe l’armonia cosmogonica tra uomini e animali e Trachi si vendicherà trasformando la sua vis erotica in violenza distruttrice, restando per sempre lontano dal mondo degli uomini. Ma la quaestio è anche emblematica da un punto di vista stilistico, strutturata com’è tra cultura classica e cultura ebraica, tra linguaggio classico‐mitologico e linguaggio scientifico, tra nascita (il suo luogo di nascita era Colofone, ovvero compimento) e nozze (unione di sessi diversi, nostalgia dell’unità ermafrodita). Nella condizione prebiotica descritta nella ‘Quaestio’ si determina il gioco aleatorio e combinatorio comune alla chimica e alla scrittura, che porta alla complessità del reale. Dal caos come morte, come lager, al disordine come energia vitalistica. Il tema della creazione è anche l’asse portante del racconto ‘Il sesto giorno’. Levi ironizza, imitando il linguaggio burocratico e retorico dei consigli d’amministrazione delle società industriali, su un progetto di creazione dell’uomo da parte delle divinità zoroastriane del bene e del male, continuamente rinviato per i conflitti di competenza tra vari consiglieri, come lo psicologo, il ministro delle acque, l’anatomista, che non riescono a trovare un accordo tra gli ipotetici modelli di uomo (uccello, mammifero, terrestre o acquatico, con o senza cervello, sessuato o meno) fino a quando non arriva la notizia che ormai ogni discussione è inutile perché il Signore ha impastato sette misure d’argilla con acqua di fiume e di mare ed ha creato l’uomo. Anche questo racconto oscilla fra la problematica della creazione e quella dell’evoluzione. In un’ambientazione arcaica su tema tecnologico moderno, Levi torna sul rapporto uomo‐bestia e uomo‐donna. Con modalità diverse anche altri racconti affrontano l’argomento della creazione, come ‘Angelica farfalla’ (ambientato in Germania) o come ‘L’ordine a buon mercato’ (che affronta il tema inquietante della clonazione, che non riesce mai perfettamente perché subentra sempre il caso, l’errore, l’imprevisto). Ciò che interessa a Levi è ribadire la forza generatrice dell’ibrido, della commistione. Anche se drammaticamente, egli ha scoperto che “l’ibrido è l’uomo dopo Auschwitz” (Belpoliti 1997, 189), egli sa anche che è dalla commistione, dall’impuro, dall’annullamento dei confini fra animale e vegetale, fra meccanico e organico, fra animato ed inerte, che può nascere il sogno alchemico di una ‘creazione seconda’, cullato dalla chimica e realizzato per forza metaforica dalla letteratura. Levi ha detto: Ibrido io sono nel profondo, e non è un caso che l’ibridismo tanto profondamente compaia nei miei racconti. (Poli & Calcagno 1992, 214) 74
Ma l’ibridismo come sostrato generativo di una nuova forma di conoscenza si ritrova anche nello stile di Levi. Dalla lingua classica (utilizzata nella chimica come matrice di segno distintivo) Levi deriva una consapevolezza etimologica e semiotica su cui innesta lo sperimentalismo linguistico fondato sulla tradizione ebraica che fa del multilinguismo (l’impasto dello yiddish) una struttura mentale che porta allo sforzo conoscitivo e successivamente ad un’etica del sapere e dell’agire. La lingua, dunque, anche sul piano etico, ha il compito di ordinare il caos. Levi, in fondo privilegiato proprio dalla sua condizione di centauro, di ibrido, vuole rompere il muro d’incomprensione, d’isolamento tra la cultura umanistica e la cultura scientifica. Nell’introduzione a L’altrui mestiere egli sostiene che nel mondo attuale scienza e letteratura devono fare a meno del principio di certezza. E d’altro canto Popper ha sostenuto che “il mondo è aperto”. La scienza e la tecnica sono nate non per verificare le regolarità ma per fabbricare eccezioni, anomalie, capricci della ragione. Ecco perché, nei racconti di Storie Naturali, in linea con le strategie narrative dei testi di fantascienza ottocentesca e novecentesca, è sempre presente il meccanismo (ben conosciuto dal chimico) dell’errore. Il versificatore si mette a comporre rime senza senso, obbligato comunque al rispetto della versificazione, in ‘Angelica farfalla’ l’axolotl, animale che si riproduce allo stato larvale senza completare il ciclo evolutivo, è una sorta di scandalo biologico. In ‘Versamina’ l’errore determina il rovesciamento dei comportamenti. In ‘Trattamento di quiescenza’ un errore di lettura del nastro del torec (total recorder) determina lo scambio di sensazioni e l’equivoco sessuale: il protagonista uomo che vuol vivere l’esperienza virtuale di un incontro sessuale la percepisce come se fosse la donna da incontrare. Ciò spiega anche il fatto che spesso nei racconti di Storie Naturali ci imbattiamo in figure di scienziati in bilico tra la monomania della ricerca e la follia. Ne ‘I mnemagoghi’ il medico è “uno strano vecchio”, ‘Il versificatore’ è “foolproof” (a prova di pazzo), in ‘Angelica farfalla’ “Leeb era una strana persona”; in ‘Alcune applicazioni del Mimete’ Gilberto è uno sperimentatore un po’ matto quando cerca di duplicare sua moglie, fino all’autoironia di ‘Versamina’ (“non gli mancava neppure quel filo di follia che nel nostro lavoro non guasta”). Insomma la follia è vista come scarto dalla norma ma anche come irruzione dell’errore nel codice genetico umano. Come per Calvino, anche per Levi c’è una sorta di erranza, un mutuo trascinamento tra le due culture. Su questa base possiamo individuare in Levi un’epistemologia implicitamente antidogmatica. La scienza, la tecnica, la letteratura derivano tutte da un istinto quasi biologico alla conoscenza; le accomuna l’idea di fare, di produrre, di trasformare, del poiein appunto. Esse non fanno altro che costruire l’ordine, dando un senso all’apparente disordine del mondo e dell’universo. Cucire molecole e cucire parole può avere la stessa finalità: collocare un elemento al posto giusto, determinare simmetrie euristiche. 75
Levi stesso ha detto: “Scrivo proprio perché sono un chimico: il mio vecchio mestiere si è largamente trasfuso nel nuovo” (Levi 1985, 14). Addirittura, linguistica e genetica sono apparentate da un linguaggio comune: si pensi all’uso di termini come ‘codice’, ‘ridondanza’, ‘pregnanza’, ‘ambiguità’. La letteratura dunque è la chimica delle parole come la chimica è la letteratura della vita. Ma tutti i sistemi organici complessi, quindi anche quello umano‐sociale, hanno bisogno di una lingua, di un’organizzazione di segni riconoscibili. Da qui l’importanza del nome che in Storie Naturali si individua nella variabilità etimologica, nelle invenzioni lessicali, nelle allusioni semantiche ma che, per contrasto, in Se questo è un uomo si era rivelata nell’annullamento d’identità, nella perdita del soggetto trasformato in numero, in ‘pezzo’. Consapevole della necessità del segno, Levi, anche in Storie Naturali, ha adempiuto al suo ruolo di ‘scriba’, d’esegeta che interpreta e fissa la tradizione orale. Per lui, parafrasando il titolo di Jorge Semprun, “La escritura es la vida”. Ma, trasformando per noi la scrittura in un altro sogno, come in questi racconti, ha poi lasciato il suo monito di testimonianza legata al dolore: Pensava una cosa che non aveva pensata da molto tempo, poiché aveva sofferto assai: che il dolore non si può togliere, non si deve, perché è il nostro guardiano. Spesso è un guardiano sciocco, perché è inflessibile, è fedele alla sua consegna con ostinazione maniaca, e non si stanca mai, mentre tutte le altre sensazioni si stancano, si logorano, specialmente quelle piacevoli. Ma non si può sopprimerlo, farlo tacere, perché è tutt’uno con la vita, ne è il custode. (Levi 1990, 87‐88) BIBLIOGRAFIA Belpoliti, Marco, a cura di. Primo Levi. Riga 13. Milano: Marcos y Marcos, 1997. Booth, Wayne. Rhetoric of Irony. Chicago/London: U of Chicago P, 1974. Fadini, Edoardo. ‘Intervista a Primo Levi’. L’Unità (4.01.1966); poi raccolta in Primo Levi. Conversazioni e interviste. 106‐107. Mila, Massimo. ‘Il sapiente con la chiave a stella’. La Stampa (14.04.1987). Levi, Primo. Storie naturali. Opere ,vol. III. Torino: Einaudi, 1990. ‐‐‐. Conversazioni e interviste (1963‐1987). Torino: Einaudi, 1997. ‐‐‐. Ad ora incerta. Opere, vol. II. Torino: Einaudi, 1988. ‐‐‐. L’altrui mestiere. Torino: Einaudi, 1985. ‐‐‐. I sommersi e i salvati. Opere , vol. I. Torino: Einaudi, 1987. Poli Gabriella, Primo Levi & Giorgio Calcagno. Echi di una voce perduta. Incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi. Milano: Mursia, 1992. 76
LUCAMANTE, Stefania. ‘Non soltanto memoria. La scrittura delle donne della Shoah dal dopoguerra ai giorni nostri’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Reinier Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 77 – 95. RIASSUNTO Ancora oggi esiste una documentazione relativamente esigua sia sull’esperienza precipua della deportazione vissuta dalle italiane che su coloro che, tra queste, hanno deciso di intraprendere la prassi della scrittura per confrontarsi con la loro esperienza, parlandone sia con modalità autobiografiche sia attraverso quelle finzionali. Assai prezioso risulta invece il contributo delle deportate e scrittrici italiane poiché la comprensione e studio della trasmissione della Shoah si configura e si arricchisce tramite la loro diretta testimonianza come anche mediante il trattamento di questo tema nella scrittura letteraria ed in quella saggistica da parte di scrittrici tuttora viventi. Questo saggio fa parte di uno studio più ampio riguardante l’analisi dell’importante materiale della testimonianza, della memoria e delle modalità scrittorie con cui le italiane (e le donne che hanno scritto in italiano) ci hanno affidato dal 1945 in poi la rappresentazione della Shoah. Scopo del presente lavoro è quello di rendere merito ad alcune donne il cui contributo scritto è servito a far conoscere sia la vita nei lager che il ‘dopo’ Auschwitz, offrendo una prospettiva femminile ed italiana. Si iniziano in questa sede a stabilire dei rapporti fra i temi svolti negli scritti memoriali di Giuliana Tedeschi, Liana Millu, Fausta Finzi e quelli che verranno illustrati in seguito in opere a carattere spiccatamente romanzesco. PAROLE CHIAVE Deportazione, memoriali, Liana Millu, Giuliana Tedeschi, Anna Bravo © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org) 77
NON SOLTANTO MEMORIA LA SCRITTURA DELLE DONNE DELLA SHOAH DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI Stefania Lucamante Catholic University of America Nel mio percorso di ricerca sulla rappresentazione letteraria della Shoah ho potuto notare alcune lacune rispetto all’analisi testuale ed all’inserimento di un cospicuo numero di scritti di italiane in una bibliografia propria sull’argomento. Le lacune nel campo letterario della prassi testuale riflettono d’altronde quelle già presenti negli studi storiografici – italiani e stranieri – rispetto alla presenza delle donne nei campi e ad uno specifico discorso della deportazione al femminile, questo sicuramente fino all’inizio degli anni Ottanta. Quali possono essere i motivi per tale ingiustificata esclusione? Come riportano Marlene Heinemann in Gender and Destiny: Women Writers and the Holocaust e Lillian Kremer in Women’s Holocaust Writing, uno degli ostacoli ad uno studio determinato anche dal genere dei testimoni derivava dalla diffusa opinione che separando la voce femminile da quella collettiva – maschile – si rischiasse di affievolire la potenza di un unico coro di tali testimonianze. Che si rischiasse insomma di diminuire l’importanza dell’’unicità dell’evento’ secondo la tesi sostenuta da Lawrence Langer, oltre a stabilire una ‘gerarchia delle sofferenze’.1 Al di là del pericolo di una gerarchia di sofferenza, tesi sostenuta ancora oggi da Langer, Lillian Kremer nota invece che, principalmente, la storiografia e la critica letteraria dell’Olocausto, come virtualmente qualsiasi aspetto della civilizzazione occidentale, ha posto solitamente l’uomo al centro dei suoi discorsi. Dato che i cronisti di storia ebraica, come molti storici, privilegiano quale normativa l’esperienza maschile, le donne sono state regolarmente poste ai margini della storia ebraica. Marginalità e scarso interesse hanno spesso connotato la figura della deportata e sopravvissuta ebrea, e questo atteggiamento nei suoi confronti si allinea al vettore intercettato dal discorso storiografico sulla Shoah, articolato essenzialmente o intorno all’uomo come promotore o vittima di eventi storici, o all’essere umano piú in generale, senza distinzioni. Se le donne costituivano un ingentissimo numero di vittime della Shoah, e quindi erano importanti all’interno della collettività oppressa da tale tragedia, le loro voci, le loro esperienze udibili attraverso i loro scritti, sono rimaste invece inascoltate per molto tempo. Questo saggio fa parte di uno studio più ampio riguardante l’analisi dell’importante materiale della testimonianza, della memoria e delle modalità scrittorie con cui le italiane (e in genere, le donne che hanno scritto in italiano) ci hanno affidato dal 1945 in poi la rappresentazione della Shoah dal loro punto di vista. 78
Scopo del presente lavoro è quello di dare merito ad alcune donne il cui contributo scritto è servito a far conoscere sia la vita nei lager che il ‘dopo’ Auschwitz, offrendo una prospettiva femminile ed italiana. Si iniziano in questa sede a stabilire dei rapporti fra i temi svolti negli scritti memoriali di Giuliana Tedeschi, Liana Millu, Fausta Finzi e quelli che verranno svolti in seguito in opere a carattere spiccatamente romanzesco. Ancora oggi esiste, infatti, una documentazione relativamente esigua sia sull’esperienza precipua della deportazione vissuta dalle italiane che su coloro che, tra queste, hanno deciso di intraprendere la prassi della scrittura per confrontarsi con la loro esperienza, parlandone sia con modalità autobiografiche sia attraverso quelle finzionali. Assai prezioso risulta invece il contributo delle deportate e scrittrici italiane poiché la comprensione e studio della trasmissione della Shoah si configura e si arricchisce tramite la loro diretta testimonianza, come anche mediante il trattamento di questo tema nella scrittura letteraria ed in quella saggistica da parte di scrittrici tuttora viventi. STORICIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLE DEPORTATE ITALIANE Nel 1995 si tenne il primo convegno promosso dall’ANED del Piemonte, l’associazione italiani deportati, sulla deportazione italiana esclusivamente femminile. Nella prefazione agli atti gli organizzatori del convegno, Gianfranco Maris e Bruno Vasari, sostengono l’importanza della diffusione dei testi delle deportate, soprattutto quelli “aventi un eventuale pregio analitico letterario” che in definitiva “allargherà la conoscenza della deportazione” (9). Sempre nello stesso volume, la storica Anna Bravo fa luce circa l’esiguità delle testimonianze femminili nell’immediato dopoguerra, appena 20 su 149, individuando tra l’altro delle cause che sono assai note a chi si occupa di ‘women’s studies’. Bravo insiste sulla scarsità di testi femminili, scarsità che poco ha che vedere con l’effettivo numero di deportate, sia pure basso rispetto a quello delle deportate di altri paesi dell’Europa orientale. Una scarsità che poco ha a che vedere con il tema dell’‘indicibile’ e molto, invece, con la mancanza di un ‘senso e valore’ da dare alla storia di queste. “Copione diffuso” – sostiene Bravo – “anche negli studi sulla resistenza, dove ci si è limitati a rendere un generico omaggio al ‘contributo femminile’, come viene definito riduttivamente il mosaico delle tante e diverse iniziative realizzate dalle donne” (16). Con ragione, Bravo attribuisce al femminismo e alla presa di coscienza delle donne la vera ‘esplosione’ in questi ultimi anni di testi di donne, il terzo periodo, cioè, del paradigma da me delineato. Donne che fino a poco tempo fa erano relegate a posizioni marginali da critici oppure, fatto ancora più grave, non erano neppure menzionate, trovano adesso l’opportunità di dire. “Dire o non dire” – avverte comunque Bravo – “dipende però anche dall’accoglienza che la parola incontra. Vista dalla parte di chi ascolta, l’indicibilità ha spesso funzionato come pretesto per sottrarsi allo sforzo di immaginare una condizione estrema che si preferisce rimuovere” (17‐18). Bravo attribuisce alle forze politiche, alle scuole storiografiche e ai singoli studiosi il silenzio che ha gravato per 79
decenni sulle deportate: “Per autoassolversi, si sostiene che le donne non avrebbero parlato, anzi non avrebbero neppure voluto farlo; e si ricorre allo stereotipo dell’innata modestia femminile o ad altri luoghi comuni inconsistenti” (18). E inoltre: La crescita d’interesse per la deportazione femminile ha coinciso sia con la responsabilizzazione di intellettuali, centri studi, comunità ebraiche […] sia con l’affermarsi del femminismo e della storia della donne, vale a dire con una determinazione collettiva a introdurre nel panorama politico e storiografico l’aspetto nuovo rappresentato dalla soggettività femminile. (18) In seguito, la figura della donna – in veste di deportata/sopravvissuta – viene spesso utilizzata in prodotti commerciali di scarso contenuto artistico sostiene Anna Bravo nella presentazione all’edizione italiana di Women in the Holocaust – per conferire all’evento storico un effetto “sentimental‐banalizzante”. Si tratterebbe quindi della solita ‘femminizzazione’ di un evento, che ha spesso come risultato o obiettivo la sua propagazione di massa. La chiusura rispetto ad uno studio di genere rimane comunque una ‘posizione di retroguardia’, in quanto “negare il rilievo del genere equivale a sostenere che il canone narrativo debba restare maschile, una pretesa oggi desueta in quasi tutti gli ambiti di ricerca” (xi). Le parole di Bravo, forse dotate di maggior ottimismo in quanto pronunciate anni dopo, riecheggiano il commento di Lillian Kremer in precedenza citato in questo saggio. Se esiste una chiusura allo studio di eventi legati alla donna, in qualunque campo essi siano avvenuti, non è tanto perché non degni di interesse di per sé, ma in quanto parte di un universo che non è originato dal pensiero o dall’esperienza di un uomo. Così come l’universalità di alcuni personaggi storici e/o romanzeschi può oggi essere messa in discussione, così come il canone letterario o narrativo rifiuta di definirsi entro gli spessi e statici argini di un tempo accettando per sé una maggiore duttilità, così anche lo studio e l’analisi della Shoah in tutte le sue dimensioni deve comprendere un esame approfondito di quella che è stata l’esperienza, la testimonianza, e la re‐
interpretazione finzionale non con personaggi femminili, ma di autori donne e italiane. Arduo risulta quindi non associarsi a Bravo nelle sue affermazioni perché effettivamente obsoleto sembra ai giorni nostri l’ostinato e (forse) inconsapevole rifiuto di analizzare le peculiarità del discorso di donne. E questo non tanto, e non solo, per affermare una differenza poi fine a se stessa, un essenzialismo inutile e nocivo persino alle stesse donne, ma per arricchire ulteriormente il campo d’indagine e di ricerca del problema legato alla memoria della Shoah. La tematizzazione delle esperienze di donne, nota Bravo, crea sconcerto e allarme fino ad essere tacciata di ‘revisionismo’, perché si teme che un’attenzione alla sessualità desacralizzi la morte, o che affrontare le relazioni uomo/donna riveli il sessismo degli stessi maschi ebrei; perché si ritiene che maternità, gravidanza, aborto, vulnerabilità sessuale, siano troppo identificati con la normalità della vita femminile per trovare posto in un evento definito unico. (xi) 80
L’assurdo, riporta ancora Bravo così com’era stato in precedenza notato da Joan Ringelheim nel suo articolo ‘Women and the Holocaust: A Reconsideration of Research’, risiede nel porre in relazione l’accanimento con cui il “nazismo temeva e colpiva le donne ebree proprio in quanto generatrici della ‘razza’” (xi) con la relativa insufficienza di studi sull’argomento, o addirittura il rifiuto di presentarne le ovvie particolarità. Il nazismo intendeva estirpare alla radice la razza ebraica, modificando per quanto possibile lo stesso patrimonio genetico, intervenendo con ogni genere di esperimenti sull’apparato genitale femminile. D’altro canto, incrementare le nascite ariane era una necessità primaria nella Germania di Hitler, come nell’Italia di Mussolini, per assicurare demograficamente l’ascesa della razza ‘superiore’. Non analizzando la peculiarità di genere, peculiarità su cui il Nazismo si è fortemente basato per le proprie politiche di pulizia etnica,2 indistinguibile dall’assimilazione forzata e dalla deportazione di massa, sino al genocidio, si rischierebbe di non vedere come l’aspetto riproduttivo fosse sempre e comunque unico fondamento nella sessualità stessa delle donne, così essenziali nell’esito del genocidio. Non si trattava infatti di vincere il nemico, ma di eliminare una razza. Il paradosso del discorso critico e storiografico intercettato da Bravo nei suoi frequenti interventi sul tema risiede quindi nel non voler dividere le voci della coralità quando, in realtà, la sessualità nel suo particolare era di sovrana importanza nell’eliminazione della razza. Una sessualità che era usata come strumento per negare la condizione umana al femminile alle deportate come portatrici di geni ‘inferiori’. Il processo di disumanizzazione per cui si potevano eseguire esperimenti genetici, torture, ed ogni sorta di vile accanimento sul corpo femminile, interveniva sulla femminilità, quindi sulla particolarità del genere femminile. Una sorta di crudele controcanto alla riproduzione per uso esclusivo del regime dei ‘figli della lupa’ o Hitlerjugend. La femminilità diventa quindi un problema in quanto “può facilmente capovolgersi in bersaglio” (Bravo 2001, xv) e diventare oggetto di stupro e violenza, di molestie e curiosità morbose. Se esistono dati comuni al destino nel campo di uomini e donne quali la morte, la fame e il lavoro come strumento per la perdita della dignità umana, esistono situazioni per cui le donne erano molto più vulnerabili proprio a causa del loro genere: Abituate alla sicurezza delle loro case e del loro privato, ora sono costrette a vivere in una comunità che è quasi animalesca. I loro corpi sono esposti nudi davanti a tutti, ma in particolare a sguardi di uomini che cercano nel loro fisico la capacità di lavoro nelle fabbriche.3 Una gravidanza troppo evidente all’arrivo alla rampa equivaleva al crematorio immediato. Se arrivavano con bimbi piccoli, il destino di queste donne era sempre fatale, oppure dovevano liberarsi del bimbo gettandolo in un mucchio, come raccontano alcune testimoni quali Elisa Springer ne Il silenzio dei vivi, donne che vivranno portando per sempre l’onta ed il dolore di aver ucciso il loro bambino. Da queste esperienze si dipanano poi gli scritti, i ripensamenti e le riflessioni della scrittura di matrice non esclusivamente autobiografica. 81
LE ITALIANE E LA SHOAH La peculiarità della situazione delle italiane attende ancora dei testi critici e di analisi testuale. Né Women’s Holocaust Writing di Lillian Kremer4 né Gender and Destiny di Marlene Heinemann menzionano italiane. Persino la versione italiana di Women in the Holocaust, curato da Dalia Ofer e Lenore J. Weitzmann, raccolta peraltro ricca di riflessioni importanti nel presentare le complesse vicende legate alla deportazione femminile, non include analisi e/o studi sugli scritti memoriali di italiane. In uguale misura, pochi sono gli studi che si occupano della rappresentazione finzionale della Shoah da parte di autrici italiane. Quali sono allora i motivi di questa ulteriore indifferenza, un’indifferenza di secondo grado (in quanto donne ed in quanto italiane), che colpisce la testimonianza delle ebree italiane? Perché questa doppia marginalizzazione? Queste ultime appaiono essere testimoni e sopravvissute doppiamente penalizzate rispetto ad altri gruppi di donne che vissero la loro stessa condizione nei campi ma furono (forse) meno marginalizzate. Le italiane sono state, e sono tuttora, in minoranza negli studi sulla Shoah in quanto testimoni eccentriche (nel suo etimo latino) innanzi tutto rispetto a quel che Annette Wieviorka considera ‘il testimone per eccellenza’, cioè l’ebreo/a orientale. Penalizzate per via della loro appartenenza a un gruppo ebraico assai assimilato e comunque esiguo rispetto ai numeri degli ebrei orientali. E infine penalizzate in quanto donne, ed in quanto appartenenti per forza di cose ad un métissage culturale che mesce spesso – anche nelle testimonianze – le abitudini italiane della celebrazione del Natale, per esempio, con le abitudini e gli usi più propri dell’ebraismo. Negli scritti, simili paragoni ed immagini compaiono spesso alternati ad un atteggiamento prettamente italiano, al limite dell’agnosticismo – si veda il caso di Liana Millu – e comunque di indifferenza rispetto alla religione. Se per alcuni lettori non italiani, ignari della realtà italiana così complessa e sfaccettata, desta sorpresa che Primo Levi recitasse a memoria i versi di una delle somme opere del Cristianesimo, la Commedia dantesca, anche l’abitudine a festeggiare il Natale di molte italiane costituisce un deterrente per la loro integrazione ad uno studio critico‐letterario sulle donne e la Shoah. Così come le italiane erano invise nei campi alle ebree orientali, anche per via di un’altra pregiudiziale, la loro diffusa ignoranza dello yiddish, a mio avviso si ripete anche oggi questa marginalizzazione dell’ebrea italiana la cui scelta non è la rappresentazione delle proprie particolarità culturali, ma il dove situarsi, capire il proprio grado di appartenenza all’identità ebraica come a quella italiana. E questo è un ulteriore problema che si aggiunge agli altri esposti rispetto al loro studio. Vi erano e vi sono altri motivi per cui sin dai giorni del campo le italiane erano segregate dal resto delle prigioniere. Erano ebree occidentali, non vivevano in ghetti, non parlavano, si è detto, lo yiddish, e per tutti provenivano da una nazione che era alleata con la Germania di Hitler. Ragioni politiche le rendevano invise alle altre prigioniere. Ricorda Bianca Paganini Mori dell’arrivo a Ravensbrück dove le italiane arrivarono fra le ultime, nel 1944: 82
All’improvviso capiamo che noi italiane non siamo ben accette; siamo considerate fasciste, donne, cioè, che appartengono a un popolo che ha scatenato la guerra, che ha distrutto le loro case e la loro famiglia, e per le tedesche siamo sporche donne di Badoglio, cioè l’espressione stessa del tradimento. A questo punto per noi è evidente che, se vogliamo sopravvivere a quell’inferno, dobbiamo saper trovare dentro di noi la forza di reagire. È per ragioni etico‐estetiche, e non soltanto di giustizia letteraria e anche critica nei confronti delle deportate italiane, che penso si debba iniziare proprio dall’analisi dei loro testi elaborati non per fini letterari, ma, azzardando un termine, liberatori. La loro elaborazione del dolore risulta essenziale nel delineare quali motivi e quali temi presenti nella testimonianza diretta delle italiane ‒ o che hanno usato l’italiano come medium linguistico – abbiano determinato in parte la genesi di scritti in cui l’elaborazione degli stessi motivi prosegue seguendo un tracciato finzionale. Esiste un filo assai importante che lega la memoria diretta a quella indiretta, che costruisce il raccordo fra ciò che alcune donne hanno vissuto e quello che queste stesse, come anche altre non testimoni dirette in seguito, hanno poi voluto riprendere ed elaborare in scritti successivi. Per comprendere la linea che conduce dagli scritti delle deportate a quelli in cui queste stesse sono divenute autrici letterarie – il tragitto compiuto cioè dai testi dal mémoire al romanzesco – vanno esaminati con attenzione i nessi fra gli scritti composti nell’immediato dopoguerra con quelli di coloro che soltanto prendendo distanza sono riuscite a descrivere e trascrivere le loro sofferenze nel lager o nella vita dopo il lager. Ancora più importanti risultano i lavori delle deportate quando si devono trattare testi romanzeschi scritti attraverso l’esperienza e la memoria indiretta degli eventi. Molti sono gli esempi di finzione sulla Shoah, sulla fuga dall’Italia dopo il 1938, e più in generale sulle ripercussioni emotive subite dalle donne italiane. Uno fra tutti, il bellissimo I ponti di Schwerin di Liana Millu, edito presso Lalli nel 1978, rimane a tutt’oggi uno degli esempi piú illuminanti di una scrittura che sa mediare il dato autobiografico con quello romanzesco. LA TESTIMONIANZA E L’ESEMPIO DI LIANA MILLU Tra queste italiane ricordo oggi in particolare Liana Millu e Giuliana Tedeschi. Il vero nome della prima era Liana Millul, originaria della Toscana, Pisa per la precisione. Si trasferì da giovane a Genova dove condusse attività antifasciste. Nata nel 1914 e scomparsa nel 2005, Liana Millu rappresenta la testimone ideale per la sua inesausta attività di raccontatrice e testimone di fronte ad intere scolaresche in Liguria, sua regione d’adozione. Nei suoi discorsi Millu iniziava la testimonianza partendo sempre dal proprio numero di registrazione tatuatole ad Auschwitz Birkenau, ‘A5384’. Il tatuaggio, una “invenzione auschwitziana autoctona”, come la definisce Primo Levi ne I Sommersi e i salvati,5 costituiva lo scarto fra la realtà e la finzione. L’attività di scrittrice di Millu, cominciata ben prima del suo atto di testimonianza sui lager, fu bruscamente interrotta in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Alla ripresa della vita civile questa sua difficile esperienza fu decisiva nel senso che Millu non abbandonò mai il discorso del sacrificio di tutti gli innocenti deportati ed 83
uccisi nei campi di sterminio, che divenne la tematica più essenziale della sua opera letteraria. La accomuna ad altri scrittori della Shoah il concetto di testimonianza, di sopravvivenza da interpretare quale mezzo per la testimonianza in nome di coloro che non ci sono più, l’osservazione del proprio mutare ‘dopo’ la Shoah a causa di quello che si era vissuto ‘durante’. Uno scritto di Millu, apparso su Il Corriere del Popolo l’11 ottobre 1945, fu forse uno dei primi scritti in italiano sui campi intitolato ‘Auschwitz lager della morte’. Grazie all’intercessione della scrittrice Willy Dias, Millu potè pubblicare questo pezzo così difficile proprio perché difficile era spiegare l’atroce realtà dei campi a chi nulla di questi conosceva. In seguito al primo articolo, ‘Auschwitz lager della morte’, Millu collaborò al giornale sino al suo ultimo numero. Come sottolinea Stefano Verdino, nell’ottobre del 1945 si poneva un duplice problema per Millu: far comprendere l’esperienza del lager a compatrioti e concittadini che tendevano ad equiparare la loro esperienza con quella dei sopravvissuti, e “scontare la ‘colpa’ della propria sopravvivenza, nei confronti della tribù dei morti, con un impegno quindi a non dimenticare”.6 Il pezzo di Millu per Il Corriere del Popolo, un giornale genovese, inizia con una sua riflessione sulla propria incredulità prima della deportazione rispetto ai fatti riportati da un giornale radio, “la propaganda esagerava troppo: possibile che accadessero realmente simili orrori?” (11). Uno strano sarcasmo, un umorismo amaro accompagna la scrittura di Millu. Parlando delle gassificazioni, racconta la narratrice: – Ora andate a fare la doccia– li avvertirono gentilmente. Questa fu una bella notizia, ed essi se ne rallegrarono molto. Un po’ di pulizia finalmente! Chi diceva che questi tedeschi erano dei barbari? Così, lieti, entrarono nella sala delle docce: col viso alzato aspettavano impazienti l’acqua benefica. Invece scese il gas, sibilando, e i polmoni lo ricevettero in pieno. Strozzarono in rantoli il primo grido. (14) La descrizione dello sterminio sistematico continua mentre cresce il sarcasmo autoriale, che reminisce mutatis mutandis quello di Tadeusz Borowski in Paesaggio dopo la battaglia. A proposito dello sterminio, la narratrice avverte che tale spettacolo […] avveniva tutti i giorni, ed era uno spettacolo tanto abituale che nessun anziano del campo ci badava più. Anzi poiché c’era la guerra, e da Berlino ammonivano che ‘tutte le ruote devono girare per la vittoria’, il comando di Auschwitz, che era zelante, aveva pensato che anche le ceneri umane possono essere un buon concime chimico, e le faceva spargere nei campi per fertilizzante. (14) Una simile amara ironia, la capacità di ironizzare sullo spargere delle ceneri umane come fertilizzante sui campi circostanti il campo con un fermo controllo e rifiuto di cedere all’invettiva, denotano da subito la mano di colei che della scrittura non farà uso sporadico e/o terapeutico, ma di chi scrittore lo era già per inclinazione e che ora lo fa per necessità morale ed etica.7 Al di là di questa componente ironica in cui l’accanimento dei soldati sui corpi dei prigionieri viene equiparato ad una 84
dimostrazione di ‘zelo’, Millu mostra con potenti mezzi retorici l’unicum Auschwitz evidenziando quel che prima d’allora non s’era mai fatto col corpo dei prigionieri. Disporre del corpo dei prigionieri oltre la morte diventa durante lo sterminio lo scarto più terribile rispetto a qualunque altro tipo di prigionia. Non è un genocidio soltanto, ma qualcosa che, se possibile, è ancora più grave: considerare il corpo dei prigionieri come un corpo non‐umano, e per questo consono a diventare letame. Il fumo di Birkenau, potentissimo scritto autobiografico dell’esperienza ad Auschwitz‐Birkenau, uscì nella sua prima edizione nel 1947 presso La Prora di Milano. Successivamente fu ripubblicato presso Mondadori nel 1957, e a Firenze per i tipi editoriali della Giuntina nel 1979 prima e nel 1986 poi. L’ultima edizione viene accompagnata da una prefazione di Primo Levi, il quale definisce quella di Liana Millu “la più toccante fra le testimonianze italiane”. Nella prefazione alla quarta edizione de Il fumo di Birkenau Levi conferma quello che le stesse prigioniere da tempo avevano capito. Come cioè la loro condizione fosse ben più dura di quella degli uomini per tutta una serie di motivi. La morte, e soltanto la morte, è l’argomento chiave in ciascuno dei racconti che compongono Il fumo di Birkenau: ogni racconto si chiude intorno all’immagine di una morte diversa incontrata dalle donne nel lager. Un casellario, una campionatura dei possibili assurdi motivi per cui una donna moriva ad Auschwitz: rivalità in amore nel caso di ‘Lily Marlene’, una gravidanza nascosta, aver ritrovato un figlio il cui abbraccio attraverso il filo spinato diventa anche un abbraccio letale ed eterno. Ma non per questo le donne si danno per vinte, tutt’altro. Per Bravo […] forme e momenti di resistenza inerme si realizzano anche in Lager. […] È resistenza quando ci si sforza di agire e di far fronte alla situazione estrema, di manipolare le norme, di ritagliarsi, pur nel precipizio di un mondo capovolto, spirali per fare e pensare: non allo stesso modo di prima, ma neppure al modo del Lager, anzi lottando per esserne contaminate il meno possibile. […] Resistere è allora tutto quel che mira a preservare, insieme alla vita, piccoli frammenti di identità, a mantenere un minimo di distanza psichica da un universo che pretende di essere l’unico.8 Millu identifica la “resistenza delle donne”, la loro resistenza alla tortura della femminilità con tre elementi: “pragmatismo, frivolezza e fantasia” (1986, 19). I ricordi di come le francesi, le uniche donne secondo Millu “che si sono conservate civili nel lager”, non rinunciavano alla cura del proprio corpo, fatta d’igiene certo, ma anche di qualcosa che il lager non poteva cancellare, la cura della propria avvenenza, di “quando avevano leccato quasi tutto, con l’ultimo grasso che era rimasto se lo passavano sotto gli occhi: la crema antirughe”,9 sicuramente colpisce. A questo gesto Millu attribuisce – e con ragione – la convinzione della giovane che voleva tornare al mondo opponendo questa forma di resistenza ed impegno per evitare l’immiserimento, la disumanizzazione nel (e del) campo. Se Levi ricorda giustamente il monito fattogli dall’anziano soldato ad osservare le regole dell’igiene per una conferma della propria dignità a dispetto delle proprie condizioni, come se non si trovasse in un campo di prigionia, Millu afferma lo stesso principio, andando oltre le 85
regole d’igiene. Per le donne, per la sua amica Jeannette, applicare l’ultimo brandello di grasso sotto gli occhi era un atto di resistenza contro la disumanizzazione, non superficialità. Era un atto di ribellione contro la logica nazista improntata alla tipologia antisemita della ‘non‐donna’ e che rispettava invece pienamente la costruzione socio‐culturale che allora formava il genere femminile. Significa la loro piena adesione all’essere ‘donna’ sia secondo uno schema societario francese che italiano. Sebbene automaticamente connesse al Fascismo, le italiane si ribellano ed anelano ad un punto di coesione, di forza, che trovano con le francesi le più simili a loro. LA TESTIMONIANZA DI GIULIANA TEDESCHI Giuliana Tedeschi, di Torino, fu deportata insieme al marito che morì durante una marcia della morte. Questo povero corpo fu pubblicato nel 1946 dalla casa editrice Edit di Milano. In un’intervista concessa ad Edgarda Ferri, Tedeschi enucleò le motivazioni che l’avevano spinta, come il vecchio marinaio di Coleridge che Levi usò quale miglior esempio del proprio bisogno di raccontare, a parlare, a parlare nonostante tutti le ingiungessero di dimenticare. Come nel caso del sopravvissuto, anche la sopravvissuta decide infatti di parlare, o meglio di “non poter fare a meno di parlare”, oppure – più frequente questa seconda reazione fra le donne – osservare un silenzio totale in famiglia, soprattutto con i figli, per paura di risuscitare fantasmi, di risvegliare paure che in realtà mai si sarebbero sopite. “Ho scritto tutto questo”, dice Tedeschi riferendosi al proprio memoriale, “ed è stata la mia salvezza. Nessuno voleva ascoltarmi: ed ecco che un quaderno mi aiutava a sfogarmi, a liberarmi. Infatti, quando ho finito, mi sono sentita più leggera, più sollevata”.10 Al contrario di un’altra testimone, Edith Bruck, la quale privata dei genitori e senza prole non aveva nessuno ad impedirle di parlare, a costringerla a dimenticare, per Tedeschi lo scrivere è stato un atto essenziale di resistenza proprio a chi voleva per il suo stesso bene che lei ‘dimenticasse’ Auschwitz. Tedeschi sostiene che non si possa infatti né dimenticare né perdonare. “Il perdono, a noi non l’ha chiesto nessuno”.11 Come per Millu, anche per Tedeschi Auschwitz e Birkenau non sono luoghi da dimenticare, bensì da ricordare e da far ricordare per il processo di rinascita cui l’atrocità dei luoghi le ha entrambe costrette. Il concetto di tempo vissuto dai prigionieri come “un paradosso”; una “prigionia interminabile e brevissima ad un tempo”; quello di corpo/cadavere inteso come “un insulto alla composta e serena dignità della morte”; la dignità tolta persino con l’eliminazione del riposo festivo; “il paesaggio innaturale” spoglio d’alberi in cui si ergevano le baracche, la mancanza assoluta di colore e di movimento: sono questi solo alcuni fra i motivi delineati dalla testimonianza Questo povero corpo di Tedeschi.12 Sono racconti slegati fra loro, ritratti di una situazione i quali, proprio com’è nudo il paesaggio circostante il campo, mettono a nudo l’implacabile essenza del ricordo più traumatico in un esercizio di memoria che tende giustamente a monumentalizzare gli episodi più tormentosi del suo vissuto. L’odore continuo di 86
carne bruciata che si accompagna alla Grande fuga di Beethoven suonata dall’orchestrina; l’importante logica della “conquista dell’esperienza di vita nel campo”, che equivaleva alla rinuncia della logica come la si era intesa fino ad allora, fino all’arrivo nel campo, “abbandonarsi al destino” come unico mezzo per la resistenza in un luogo in cui persino il lavoro su cui si fonda l’etica occidentale perdeva il significato originario rovesciandosi in fatica “inutile ed offensiva”.13 Tedeschi analizza molte tematiche legate al corpo femminile. Accanto alla descrizione della morte, più accentuata nell’opera prima di Liana Millu, prende rilievo – quasi per un paradosso – l’aspetto vitalistico di tale esperienza, l’attenzione cioè a quel corpo femminile che, umiliato e vilipeso in tutti i sensi, si oppone alla sua stessa degradazione, dettando la propria necessità a non soccombere a delle entità immateriali e che pure ne costituiscono la sua stessa forza: Pensavo al mio corpo brutalmente mutilato della sua vitalità, alla rinuncia alla funzione più femminile imposta dalla natura […] Non potere sottrarmi, essere nell’impossibilità di tutelare il mio corpo: mi sentivo impazzire. (1946, 51) Nonostante tutto, la resistenza più vera fra tutte quelle possibili rimane ancora quella di volere “ripetere l’esperienza della procreazione” (52), un diritto inalienabile del corpo femminile e pure mortificato in queste non‐donne. E la procreazione mortificata diventa l’argomento di uno dei passi più toccanti del libro, ‘Vigilia di Natale’. Alla vigilia di Natale, una compagna di Tedeschi dà alla luce un bimbo, un maschietto, che morrà dopo aver aperto gli occhi. Moriranno entrambi dissanguati, madre e figlio, mentre le compagne devono – pena la morte – andare a mettersi in fila. Con amarezza forse maggiore, se confrontato con altri finali di racconti, si conclude ‘Vigilia di Natale’: “ciò che è logico e naturale non si può pretenderlo in un campo tedesco. E l’epoca delle favole e dei miracoli è tramontata da un pezzo. Così la stella cometa, il bue e l’asinello” (75). Qualunque emozione è vietata, pena la sopravvivenza. Ci si astrae per non vedere qualcosa che – in una vita normale – rappresenterebbe una tragedia: “L’emozione nel Lager è considerata un nemico, è uno spreco inutile di energie, un consumo infruttuoso di nervi” (98). La rappresentazione di questa natività cristiana in negativo, “la stella cometa, il bue e l’asinello”, si fissa negli occhi di Tedeschi per tutta la vita, per il ‘dopo’ lager, per un ‘dopo’ che non sarà mai più come il ‘prima’. Un ‘dopo’ per cui bisogna vivere. Vicina alla morte, convinta di non possedere più forze per resistere alla “tortura morale e fisica” (118), la protagonista di Questo povero corpo riflette sulle sorti del nuovo mondo ‘dopo’ Auschwitz. Un mondo che purificato, nuovo da questa gigantesca sofferenza sarebbe stato migliore, doveva essere migliore, doveva appagare il nostro bisogno di perfezione, la nostra sete di miglioramento, perché il martirio di tanti non andasse perduto. Voglio vivere: estrema aspirazione alla resistenza. (119) 87
E nell’esistenza del dopo‐Auschwitz, Tedeschi continuerà ad adottare il punto di vista dello stato di eccezione in cui aveva vissuto nel Lager. Il quotidiano non avrà più lo stesso peso: “Dopo, non ho cambiato idea. Non mi sono più adeguata. I valori, per me, sono sempre gli stessi che ho ritrovato uscendo dal lager”.14 DALLA STORICIZZAZIONE DELLA MEMORIA/CRONACA ALLA STORICIZZAZIONE DELLA FINZIONE A fronte della lettura dei primi scritti di italiane sulla Shoah, cosa intendiamo allora per esperienza? Soprattutto quando si parla di scrittura anamnestica, testimoniale, memorialistica, essa può significare anche altro dall’esperire in prima persona. “Le testimonianze, a volte”, sostiene Annette Wieviorka, […] prendono la strada della letteratura. Si pensa che un vero libro possa assicurare meglio la trasmissione. Ma soprattutto, in un paesaggio in cui la morte è onnipresente, si diffonde l’idea che l’opera, per lo meno, sia immortale, che essa sola possa assicurare il ricordo, ossia l’eternità.15 È da questa iniziale esperienza collettiva ed insieme singola, insostituibile, che ne trovano origine altre, motivate da cause diverse e tutte assai rilevanti. Se la testimonianza diretta è quella da cui si dipanano tutta una serie di riflessioni e considerazioni anche, e non soltanto, storiche, da cui però gli stessi storici ci prevengono per tema di attribuire esattezza alla testimonianza, mi riferisco tra l’altro alla stessa voce autorevole di Wieviorka, la testimonianza costituisce una possibile e gravissima esperienza che ingenera altre testimonianze traslate, di secondo grado, che aiutano la prima. Tutte però testimoniano la gravità della Shoah. Esiste infatti un’esperienza di secondo e di terzo grado, qual è quella vissuta dai figli dei sopravvissuti, che ricalca spesso un silenzio grave di dolore vissuto in famiglia, oppure atteggiamenti parentali che malcelano il desiderio di dimenticare. Esiste l’esperienza di chi ha ascoltato e letto dell’orrore e sente il peso della responsabilità di studiare, scrivere, ed analizzare un simile accadimento per timore che le generazioni più recenti non ricordino chi ha sofferto per problemi che esistono spiccatamente anche oggi quali l’intolleranza, l’antisemitismo, l’odio razziale. E questo non perché sia di moda avere un amico ebreo,16 ma per un senso di giustizia e di etica che non conoscono facili trend che si coniuga all’interesse più soggettivo di conoscere meglio anche la propria cultura, un melting pot nostrano, se è vero che la cultura italiana annovera tanti dialetti, sostrati, usanze, influenze culturali, che rendono assai difficile parlare di omogeneità culturale nel nostro Paese, questo persino oggi. La scrittura italiana femminile sulla Shoah si divide per grandi linee in tre periodi: l’immediato dopoguerra, con gli scritti di Liana Millu, Giuliana Tedeschi, Edith Bruck (pubblicati più tardi) ed altre; pochi esempi negli anni settanta, uno, importante, quello di Fausta Finzi che regalò il proprio diario al CDEC nel 1972, poi 88
pubblicato col titolo A riveder le stelle. La lunga marcia di un gruppo di donne dal lager di Ravensbrück a Lubecca,17 e l’ultimo decennio del ventesimo secolo, primi del ventunesimo, in cui molte deportate – alcune incoraggiate da figlie e nipoti come non mancano di menzionare nei loro testi – scrissero, oppure fecero riemergere, la loro testimonianza prima che la morte si portasse via il loro ricordo di quegli anni. Se la periodizzazione di questi scritti ci fa pensare ad un parallellismo temporale con il ritmo seguito dalla sterminata bibliografia degli studi sulla Shoah, l’apporto massiccio su un piano storico‐critico ed anche letterario da parte di donne si è avuto soltanto negli ultimi anni. Negli altri due periodi sono state edite diverse pubblicazioni, certo, ma non quante avrebbero potuto essercene. Inoltre, se da un lato si è tentati di parlare di tre periodizzazioni che offrono con chiarezza un percorso di genere, bisogna invece affermare che, pur trovando in linea di massima con maggiore intensità esempi di scrittura di testimonianza nel primo periodo, romanzi nel secondo, e saggistica e romanzi nell’ultimo, in realtà questi tre generi sono presenti in tutti e tre i periodi, se non a tratti addirittura mescidati in interessanti ibridazioni generiche. La mia scelta di periodizzazione anche per generi non è arbitraria, ma guidata dunque dall’intensità delle pubblicazioni a carattere testimoniale nell’immediato dopoguerra, un’intensità che si giustifica parzialmente con la vicinanza temporale col fatto storico e con l’incapacità di ‘lavorare’ stilisticamente sugli eventi. Dico parzialmente giustificata perché questa contiguità produsse due effetti diversissimi tra loro. Sappiamo che nel caso di molti sopravvissuti il desiderio fu quello immediato di scrivere quasi nella speranza di sottrarsi alla vista continua e non revocabile di quel che avevano visto. Immagini che si legavano alla retina impedendo di non filtrare qualunque altro evento della propria esistenza attraverso quella esperienza. Per altri ed altre invece fu la reazione opposta a prendere il sopravvento: il desiderio cioè di liberarsi del fatto non parlandone, tuffandosi nel quotidiano per non continuare a vedere i volti delle compagne che non c’erano più. La coesistenza di tali sentimenti, il desiderio di parlare e la sensazione che troppe parole fossero pesanti se proferite al di fuori del locus che le aveva provocate, si faceva vivo in molti fra i testimoni18. Oltre a questi motivi, che accomunano nelle loro reazioni binarie tutti i sopravvissuti – reazioni che non determinano una voce di genere – esistono comunque altre motivazioni legate al genere ed al particolare delle donne. LA FANTASIA, CHE È L’OCCHIO DELL’INGEGNO... La plasticità del mezzo letterario, la presenza che la scrittura letteraria fornisce agli strati di storia umana, la qualità mimetica e a tutto tondo della letteratura sono le basi teoriche delle mie riflessioni sulla problematicità della rappresentazione della Shoah nel passaggio da autobiografia a finzione romanzesca. Ampliando una definizione di Elaine Marks sulla metafora ‘Auschwitz’,19 si potrebbe inferire allora che le scrittrici si interessano e scrivono sulla Shoah partendo da prospettive diverse: 89
ne scrivono trattandola come argomento, per capire come scriverne, e in ultimo, credo di poter aggiungere, ne scrivono per meglio identificare la Shoah come un punto fermo anche in letteratura, uno zenith in negativo della civiltà occidentale. Come Tolstoj e Stendhal trovarono la parola quale mezzo insostituibile per descrivere – anche ekfrasticamente – le guerre napoleoniche nel romanzo ottocentesco realista, così è naturale e non banale che alla testimonianza diretta di un fatto storico segua la sublimazione, l’ibridazione dell’evento, del ‘vero’ con la finzione letteraria che, con i suoi infiniti mezzi retorici e figurativi, amplia e prolunga – senza per questo relativizzare – la possibilità di ricezione del dato storico. Nonostante Alessandro Manzoni avesse poi rifiutato le sue stesse importanti scoperte riguardo al componimento misto del vero e della finzione, il problema dell’oppressione del popolo colonizzato ne I Promessi sposi rivela anche oggi una struttura di potere e usurpazione di diritti dei deboli la cui importanza poco deve alla precisione cronachistica con cui lo scrittore eseguì le sue ricerche.20 La trasmissione dell’esperienza subita dai testimoni sopravvissuti, da coloro che hanno scelto di raccontare, può avvenire attraverso una vera e propria rielaborazione del fatto da loro vissuto, nell’esercizio di sublimazione e novellizzazione degli eventi. Quella ‘fantasia’ attraverso cui, secondo le teorie vichiane, l’essere umano riedifica la reminiscenza, “combatte il passato con il soccorso della fantasia del futuro e il futuro con il soccorso della memoria del passato”.21 Dopo un processo di sedimentazione degli eventi ricordati, la memoria erige, trasformandoli, monumenti ai fatti più eclatanti della propria esistenza, non soltanto nella scrittura più direttamente mnemonica e aneddotica, ma anche servendosi di un contesto più propriamente finzionale. La trasmissione del proprio vissuto da parte dei sopravvissuti può cioè scegliere di porre la Shoah quale sfondo finzionale anche dopo la prima e più immediata stesura del ricordo, prediligendo quindi il romanzo come genere per una successiva stesura che, oltre al fatto mnemonico, intende anche utilizzare elementi estetici e stilistici pertinenti al genere romanzesco. La necessità di continuare a reperire quale sfondo per un romanzo la Shoah va ricercata in una imprescindibile urgenza di continuare a considerarla un fatto storico ed inalienabile anche a distanza di tempo, sia pure nella trasfigurazione dei fatti. I motivi degli autori in questo caso sono vari: arginare il pericolo del relativismo negazionista, eliminare l’aura di ‘indicibililità’ o di male assoluto che improduttivamente ingombra il lavoro delle generazioni successive, e riguardano in parte le preoccupazioni estetiche rispetto alla rappresentabilità dell’evento. Così come altri eventi terribili che hanno irrimediabilmente segnato il secolo appena trascorso, come le due guerre, la Resistenza, i bombardamenti nucleari in Giappone, la Shoah è diventata lo sfondo storico su cui si stagliano le figure dei personaggi finzionali, ma mai del tutto immaginari o casuali. Non del tutto, perché molti degli scritti non‐finzionali, come i mémoires e le cronache dei campi, hanno indelebilmente sorretto l’operazione di messa in scena di questi romanzi. Questa tragedia costituisce uno sfondo per romanzi ambientati nel Novecento sia per i diretti testimoni che per altri che hanno vissuto di riflesso o per immaginazione tale evento. 90
In questo caso, quando cioè il ricordo è volontariamente trasfigurato nella visione narrativa romanzesca, la memoria, il “fallace strumento” di cui ammoniva Primo Levi ne I Sommersi e salvati, se utilizzata nel caso di una veridica ed esatta testimonianza da un punto di vista storico, resta un potentissimo e convincente strumento per creazioni letterarie che sostengano ed incoraggino comunque la necessità del ricordo per motivi civili, etici e morali. Uno strumento utile, la memoria, non per un senso di esattezza storica (dato che il ricordo di un evento raramente si giustappone e combacia esattamente coi dati effettivi dell’evento stesso ricordato), ma perché è nell’essere umano il desiderio di coinvolgere altri ed altre coscienze con il ricordo tramandato dalla parola. E questo coinvolgimento a livello personale non si ottiene soltanto mediante l’enunciazione di fatti inalienabili che pretendono un’oggettività comunque sempre relativa e per questo pericolosa, come ci ricorda Hayden White, anche nel discorso storiografico. Le nostre nozioni rispetto a quello che costituisce una rappresentazione ‘realistica’ devono essere rinegoziate per tenere conto di esperienze che sono uniche del secolo appena trascorso e per cui modelli di rappresentazione precedenti sono inadeguati.22 Recuperando il concetto enunciato dallo storico per inserirlo nel nostro diverso contesto di analisi critica, l’interpretazione e narrativizzazione dei fatti quindi può essere utile al ricordo ed alla perpetuazione di questi, non tanto per raggiungere la precisione documentaria dell’evento ma per portarne ad eterno monito la sua gravità, una gravità solenne che non inficia la precisione dei dettagli (che pure non sono da escludere a priori) ma che poggia con tutto il suo peso sulle coscienze umane contribuendo alla costruzione di nuovi elementi strutturali e discorsivi del genere ‘romanzo’. CONCLUSIONI La resistenza di queste donne, così come viene registrata dalle loro testimonianze, alcune tra le venti pubblicate al termine della seconda guerra mondiale (non sappiamo bene infatti quante ne fossero state scritte e tenute nel cassetto da queste donne la cui voce è stata a lungo soppressa), rivela la compresenza di un innato pragmatismo femminile, quello che ancora Bravo definisce la loro “razionalità robusta” scevra però di cinismo, ed ancora “aperta all’amore per il corpo e le sue sensazioni”. Una razionalità che ancora “mantiene un legame stretto con la sfera dell’emotività e dell’immaginazione” da contrapporre al “culto dell’intelletto e il primato dell’individuo” esercitati dai deportati uomini che “spesso sono così forti da schiacciare altri aspetti”. Un rispetto per l’emotività che non ottempera alle virtù eroiche esibite dagli uomini, come ci ricorda Millu, ma che forse le ha aiutate nella loro vita dopo Auschwitz, una vita difficile se, come racconta Paganini Mori, nessuno credeva ai loro racconti, costringendole in qualche modo al silenzio in famiglia, […] quando tornammo da Ravensbrück cercammo di raccontare qualcosa ma eravamo guardate in modo strano persino dai nostri compagni di prigionia. Nessuno sapeva di 91
Ravensbrück e nessuno immaginava che ci potesse essere un campo esclusivamente femminile.23 In virtù delle osservazioni elaborate da Liana Millu, da Giuliana Tedeschi, da Fausta Finzi, Bianca Paganini Mori e da altre sopravvissute, in virtù della produzione che ha seguito i loro difficili esordi, ritengo che i ‘brandelli della vita domestica’ da cui furono strappate queste narratrici non siano andati perduti invano. Voglio pensare che il monito di queste donne coraggiose si dilati nel tempo e giunga oggi fra di noi, che ci serva a capire come, oggi più che mai, le donne stiano perdendo ogni diritto, anche, e soprattutto, quello della parola in altre parti di questo mondo che credevamo rinnovarsi per il bene. Un mondo nuovo per tanti versi, certo, forse anche nel senso sperato da Tedeschi, ma che non per questo si è dimostrato necessariamente migliore. In un ‘dopo’ tutto al femminile bisogna continuare a combattere, a resistere. La metafora della maglia il cui filo deve restare tenace, pena la perdita del punto, quel punto esile sulla terra di cui Tedeschi così bene ha scritto, mi sembra sia la metafora più convincente per ricordare la necessità che la parola di donne vada ascoltata, registrata nel suo messaggio che non può fermarsi temporalmente ma deve proseguire il suo cammino di resistenza. Donne dalla testimonianza scomoda e complessa, quindi, queste ebree italiane, per tutta una serie di motivi. Rimane in chi scrive il fermo convincimento dell’importanza di uno studio approfondito su queste espressioni di scrittura che, sublimandosi e formando materia letteraria e non più testimoniale, si dilatano acquistando una diversa importanza nelle opere narrative delle generazioni più recenti e di quelle future. NOTE Così come ricorda Anna Bravo nella presentazione dell’edizione italiana di Donne nell’Olocausto (2001, xi). 1
Si veda il volume Gendercide and Genocide edito da Jones per le politiche di pulizia etnica che accompagnano genocidi in ogni paese. Jones elabora le proprie teorie sul gendercide preventivo che vedono nel mondo moderno una specifica enfasi rispetto a quello latente o ‘retributivo’ (2004, 1‐38). Per le politiche di manipolazione genetica del Nazismo, si veda il fondamentale Mothers in the Fatherland: Women and the Family in Nazi Politics di Koontz (1981). 2
Paganini Mori 1999, 167. 3
Soltanto nella sua enciclopedia Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their Work appare una scheda minima sugli italiani in generale in cui vengono citati i nomi di Millu e Tedeschi (Kremer 2002, xxv). Kremer dà invece spicco alla scrittrice Natalia Ginzburg la quale in verità non lasciò molti scritti sull’argomento, ma solo riferimenti casuali e non ragionati su eventi legati al fascismo (2002, 424‐26). 4
Levi 1985, 94. 5
92
Verdino 2005, 90. 6
In ben altri toni si esprime Luciana Nissim in ‘Ricordi della casa dei morti’ (1946), uno scritto doloroso in cui non v’è spazio per la dimensione ironica nel resoconto di eventi simili a quelli elaborati da Millu. 7
Bravo 1995, 23. 8
Tono 2003, 17. 9
Ferri 1988, 26. 10
Ibidem, 32. 11
Tedeschi 1946, 24‐26. 12
Ibidem, 30; 50; 56. 13
Ferri 1988, 29. 14
Wieviorka 1999, 39. 15
Per questo annoso problema del razzismo celato dietro il velo dell’amicizia si veda Lettera agli amici non ebrei. La colpa di Israele (2003) di Elena Loewenthal in cui l’autrice riprende punto per punto gli argomenti trattati da Sergio Romano in Lettera a un amico ebreo (1997). 16
Grazie alle ricerche svolte presso il CDEC di Milano ho potuto infatti trovare questa preziosa informazione. 17
La ‘scelta’ coraggiosa ed ‘inusuale’ degli ex‐deportati, nota Anna Bravo riferendosi in particolare ai deportati italiani, risiede nel voler ‘amministrare la loro memoria’. Lo è ancora di più, insiste Bravo, “se si tiene conto che era in gioco l’esperienza forse più complicata e delicata della contemporaneità, spesso oggetto di fraintendimenti consapevoli o inconsapevoli – non solo quelli derivanti da una conoscenza approssimativa dei fatti – ma anche quelli impliciti nel posto del tutto inadeguato attribuito alla deportazione nella ricostruzione dell’immagine nazionale a guerra finita” (Bravo 1995, 15). 18
L’articolo di Elaine Marks, ‘Céndres juives. Jews Writing in French after Auschwitz’, viene citato da Paola Di Cori nel suo intervento su Lidia Beccaria Rolfi in Un’etica della testimonianza: La memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (1997, 11). 19
Quello dell’impossibilità di una coesistenza fra vero e finzione è un annoso problema di cui si occupa da ben prima di me Alberto Cavaglion. Il contributo di Cavaglion è essenziale al mio lavoro in quanto considero la sua posizione rispetto alla finzionalizzazione della Shoah la più vicina al mio punto di vista. Cavaglion si pronuncia a favore dell’inserimento del vero nella finzione per tutta una serie di motivi, enucleati in modo assai convincente nel suo saggio ‘Parola, silenzio e memoria: esiste una forma letteraria per la testimonianza?’ (1999). 20
Gessa Kurotschka 2006, 194. 21
White in Friedlander 1992, 50. 22
Paganini Mori 1999, 168. 23
93
BIBLIOGRAFIA Borowski, Thadeusz. Paesaggio dopo la battaglia. A cura di Roberto Polce. Torino: Il quadrante, 1988. Bravo, Anna. ‘Presentazione’. Ofer & Weitzman 2001, ix‐xxi. ‐‐‐. ‘Relazione introduttiva’. Maris & Vasari 1995, 15‐27. Cavaglion, Alberto. ‘Parola, silenzio e memoria: esiste una forma letteraria per la testimonianza?’ AA.VV., Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema. Milano: I quaderni della porta, 1999. 25‐37. Di Cori, Paola. ‘Intervento su Lidia Beccaria Rolfi’. Maida 1997, 10‐14. Ferri, Edgarda. Storia di Giuliana Tedeschi. Il perdono e la memoria: A che prezzo si può dimenticare il prezzo che abbiamo subíto? Milano: Rizzoli 1988, 23‐33. Finzi, Fausta. A riveder le stelle. La lunga marcia di un gruppo di donne dal lager di Ravensbrück a Lubecca. Udine: Gaspari, 2006. Fontana, Laura & Giorgio Giovagnoli, a cura di. ‘I nemici sono gli altri’. Atti del convegno del Comune di Rimini. Firenze: Giuntina, 1999. Friedlander, Saul, a cura di. Probing the Limits of Representation: Nazism and the ‘Final Solution’. Cambridge: Harvard UP, 1992. Gessa Kurotschka, Vanna. Etica. Napoli: Guida, 2006. Heinemann, Marlene. E. Gender and Destiny: Women Writers and the Holocaust. Westport, CT: Greenwood Press, 1986. Jones, Adam, a cura di. Gendercide and Genocide. Nashville: Vanderbilt UP, 2004. Koontz, Claudia. Mothers in the Fatherland: Women and the Family in Nazi Politics. New York: St. Martin’s Press, 1981. Kremer, S. Lillian, a cura di. Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their Work. New York: Routledge, 2002. ‐‐‐. Women’s Holocaust Writing: Memory and Imagination. Lincoln: U of Nebraska P, 1999. Levi, Primo. I sommersi e i salvati. Torino: Einaudi, 1985. Loewenthal, Elena. Lettera agli amici non ebrei. La colpa d’Israele. Milano: Bompiani, 2003. Maida, Bruno. Un’etica della testimonianza: La memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi. Milano: Franco Angeli, 1997. Maris, Gianfranco e Bruno Vasari, a cura di. ‘La deportazione femminile dei lager nazisti’. Atti del convegno ANED. Milano: Franco Angeli, 1995. Millu, Liana. ‘Auschwitz lager della morte: gli orrori dei campi di annientamento’. Il Corriere del Popolo (11.10.1945); ristampato in Resine 27/103 (2005): 11‐14. ‐‐‐. Il fumo di Birkenau. 1947. Firenze: Giuntina, 1986. ‐‐‐. I ponti di Schwerin. 1978. Genova: Le Mani, 1998. Naldi, Neda. L’ebrea. Bologna: Cappelli, 1955. Nissim, Luciana. ‘Ricordi della casa dei morti’. Nissim & Lewinska 1946, 18‐58. 94
‐‐‐, & Pelagia Lewinska. Donne contro il mostro. Torino: Vincenzo Ramella editore, 1946. Ofer, Dalia, & Lenore J. Weitzman, a cura di. Donne nell’Olocausto. Traduzione di David Scaffei. Firenze: Le Lettere, 2001. Paganini Mori, Bianca. ‘L’universo femminile nei lager: le donne a Ravensbrück’. Fontana & Giovagnoli 1999, 167‐72. Ringelheim, Marlene. ‘Women and the Holocaust: A Reconsideration of Research’. Signs 10/4 (1985): 741‐61. Romano, Sergio. Lettera a un amico ebreo. Milano: Longanesi, 1997. Springer, Elisa. Il silenzio dei vivi: all’ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione. Venezia: Marsilio, 1997. Tono, Mirella. ‘Storia e memoria: Liana Millu. Una donna, il Lager, la testimonianza’. StoriaE 3 (dic. 2003): 16‐19. Tedeschi, Giuliana. Questo povero corpo. Milano: Edit, 1946. Verdino, Stefano. ‘Memoria di una testimone: l’opera di Liana Millu’. Storia e memoria 14/1 (2005): 87‐
95. White, Hayden. ‘Historical Emplotment and the Problem of Truth’. Friedlander 1992, 37‐53. Wieviorka, Annette. L’era del testimone. Milano: Raffaello Cortina, 1999. 95
VILLA, Cristina. ‘Perché la Shoah talvolta parla italiano? La letteratura italiana della deportazione razziale nelle opere di Edith Bruck ed Elisa Springer’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 97‐105. RIASSUNTO In Italia si assiste ad un fenomeno interessante. Alcuni sopravvissuti della Shoah decidono di portare la loro testimonianza e scrivere riguardo alla loro esperienza in una lingua non loro, l’italiano, in quanto essi sono stranieri. Ecco apparire tra gli altri l’ungherese Edith Bruck e l’austriaca Elisa Springer. Il tentativo di questo intervento è di fornire una plausibile spiegazione alla scelta di questi autori. PAROLE CHIAVE Deportazione, Edith Bruck, Elisa Springer, bravo italiano, testimonianza © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 97
PERCHÉ LA SHOAH TALVOLTA PARLA ITALIANO? LA LETTERATURA ITALIANA DELLA DEPORTAZIONE RAZZIALE NELLE OPERE DI EDITH BRUCK ED ELISA SPRINGER Cristina Villa University of Southern California Nell’ambito della letteratura italiana dedicata alla deportazione razziale si assiste ad un curioso fenomeno: alcuni dei protagonisti del panorama letterario dedicato a quest’argomento, quali Edith Bruck ed Elisa Springer, sono stranieri che decidono di adottare una lingua non loro, l’italiano, per descrivere le persecuzioni razziali e il mondo dei Konzentrazions‐ und Vernichtungslager. Edith Bruck, nata in Ungheria nel 1932 e deportata ad Auschwitz ancora adolescente, alla fine della guerra si è trasferita in Italia ed ha dedicato la sua esistenza a testimoniare la sua esperienza nel Lager. A questo scopo ha scritto in italiano numerosi romanzi, racconti e raccolte di poesie su questo argomento: Due stanze vuote (1974), Il tatuaggio (1975), Transit (1978), In difesa del padre (1980), Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà (1993), Lʹattrice (1995), Lettera da Francoforte (2004) e un testo autobiografico, Chi ti ama così (1959) ed ha collaborato nel 1966 col marito, il poeta Nelo Risi, alla realizzazione del film ANDREMO IN CITTÀ, tratto da un suo racconto del 1962, con l’attrice Geraldine Chaplin. Edith Bruck è in continuo pellegrinaggio nelle scuole italiane ed europee con il compito di mantenere viva la memoria della Shoah. L’altra scrittrice è Elisa Springer, nata a Vienna nel 1918 da una famiglia di commercianti ebrei di origine ungherese. Dopo la deportazione dei genitori nel 1938 in seguito all’annessione dell’Austria al Terzo Reich, ha deciso di fuggire e, scappando attraverso mezza Europa, è giunta in Italia nel 1940 e si è fermata a Milano, dove ha vissuto fino al 1944 un’esistenza semiclandestina. Nel 1944, poi, in seguito a delazione, è stata arrestata e, dopo aver trascorso un mese di carcere a Milano, è stata deportata ad Auschwitz, Bergen Belsen ed infine Terezin. Dopo la guerra, come Edith Bruck, si è trasferita in Italia, a Manduria, vicino a Taranto, dove ha trascorso buona parte della sua vita col marito ed il figlio. Dopo aver tenuto nascosta per decenni la sua vicenda di ebrea perseguitata, ha scritto con lʹaiuto del figlio medico, Silvio, la sua autobiografia, Il silenzio dei vivi, pubblicata dallʹeditore Marsilio nel 1997 e successivamente L’eco del silenzio. La Shoah spiegata ai giovani nel 2003. Impegnata come Edith Bruck a portare la sua testimonianza nelle scuole, è morta recentemente nel 2004. Altra figura interessante e non centrale per il mio discorso, ma sulla quale vale la pena fare un accenno, è la scrittrice Helga Schneider. Non si tratta di una letterata di origini ebraiche ma di una ragazzina che si è trovata dall’altra parte della 98
barricata. Nata in Polonia nel 1937, è stata abbandonata dalla madre col fratellino nel 1941. La madre si è arruolata nelle SS ed ha prestato servizio ad Auschwitz‐Birkenau. Dopo la guerra, trasferitasi dapprima con il padre e la matrigna a Berlino, è fuggita poi a Salisburgo ed infine verso l’Italia. Durante il viaggio in Italia ha incontrato il marito e si è trasferita a Bologna, dove vive dal 1963. Nel 1995 ha pubblicato Il rogo di Berlino in italiano e successivamente Porta di Brandeburgo (1997), Il piccolo Adolf non aveva le ciglia (1998) e Lasciami andare, madre (2001), Stelle di cannella (2002), L’usignolo dei Linke e L’albero di Goethe (2004) ed infine Io, piccola ospite del Führer (2006). Lasciami andare, madre è significativo e viene scritto dopo l’ultima visita alla madre anzianissima nel 1998, una madre ancora fiera del suo passato nazista.1 Questo incontro turba profondamente Helga e le causa un forte malessere anche fisico. Helga desidera sapere e comprendere come può un essere umano abbandonare due figli per inseguire un sogno di morte, come si può assistere agli orrori che si svolgono quotidianamente sotto i propri occhi senza alcun turbamento. Queste scrittrici, e con loro altri scrittori di origine ebraica quali i fratelli ungheresi Giorgio e Nicola Pressburger, hanno deciso di far ricorso ad una lingua non loro, ed in particolare la Springer e la Bruck, per narrare l’indicibile, le persecuzioni e l’orrore della deportazione. Ciò risulta apparentemente sorprendente se si pensa che l’Italia, alleata del Terzo Reich durante il secondo conflitto mondiale, è stata teatro di persecuzioni della popolazione ebraica sia italiana che straniera presente nel territorio della penisola, come ricorda Primo Levi: Sarà bene ricordare a chi non sa, e a chi preferisce dimenticare, che l’Olocausto si è esteso anche in Italia, benché la guerra volgesse ormai alla fine e benché la massima parte del popolo italiano si sia mostrata immune al veleno razzista.2 Sembra incredibile che alcuni scrittori abbiano usato a) una lingua straniera e b) una lingua grossolanamente definibile ‘del nemico’, nel tentativo di ‘dire’ la Shoah, e che non abbiano avuto quel rifiuto o rapporto problematico verso l’italiano che, al contrario, si è avuto nei confronti della lingua tedesca anche in scrittori non ebrei e anche in scrittori nati nel dopoguerra. Significativamente l’autore austriaco Peter Handke, nato nel dopoguerra e di origine non ebraica, esprime il suo riserbo nell’utilizzare una lingua non piú innocente come quella tedesca ed afferma: Die Wörter Lager, Hitler, Auschwitz, Lübke, Berlin, Johnson, Napalbomben, sind mir schon zu bedeutungsgeladen, zu politisch, als das ich sie, als Wörter, literarisch noch unbefangen gebrauchen könnte.3 A maggior ragione forte è il rifiuto di coloro che hanno vissuto il mondo dei lager dove il tedesco era diventato una lingua barbara, rozza, urlata, violenta. Scrive infatti Edith Bruck nel romanzo Lettera da Francoforte del 2004, nel descrivere le reazioni della protagonista nel sentire le voci in tedesco provenire dalla TV mentre si trova a Capri, “Cambia canale!”, urla al marito, e questi risponde: 99
“Ci provo, non vedi!” “Allora spegni.” “Ce ne sarà uno in italiano, perdio.” “Ti prego”, lo guardo supplichevole prima di uscire e mi rendo conto per l’ennesima volta che è difficile capire cosa assale un sopravvissuto ai Lager nazisti nell’udire voci violente nella lingua di Goethe, anche se fossero versi di Rilke.4 Perché tale fenomeno non si è avuto nei confronti dell’italiano? Una semplice risposta è che questa non è la lingua parlata nei campi del Terzo Reich (ma solo in quelli di transito in Italia) e che quindi non crea forti e traumatici ricordi. Tuttavia perchè l’ungherese Edith Bruck e l’austriaca Elisa Springer decidono di trasferirsi in Italia e adottare questa lingua nello scrivere i loro testi? Molte potrebbero essere le ragioni. Lo scopo del mio intervento è sottolineare come questo sia anche dovuto, ma non esclusivamente, alla forte presenza del ’mito del bravo italiano’, che permette di cancellare le colpe del passato e vedere l’Italia nel dopoguerra spesso come un luogo di rifugio e ristoro dopo le terribili persecuzioni e la lingua italiana come un mezzo di espressione preferibile alla propria lingua madre, maggiormente ‘confortevole’ e meno traumatico. Afferma a questo proposito Edith Bruck in un’intervista a Maria Teresa Cinanni: L’Italia era una nazione impreparata alla ghettizzazione e allo sterminio. Lo testimonia l’aiuto che gli italiani cercarono di dare agli ebrei ricercati, offrendo loro nascondigli e improvvisando sotterfugi, e, ancor di più, il fatto che, anche dopo il lager, noi ebrei fummo accolti benevolmente dalla popolazione italiana. Ricordo la mia esperienza di ragazzina sballottata per l’Europa e poi finalmente accolta in una grande famiglia sconosciuta, disposta a dividere con me la minestrina della cena o il pasto di mezzogiorno. Era l’Italia degli anni ’50 che, dietro tante contraddizioni, celava però un calore umano che sapeva ancora di guerra e di miseria. E di memoria viva.5 È questa una visione leggermente edulcorata dell’Italia, conforme a ciò che Attilio Milano scrive a proposito della spiegazione etimologica che tutti gli ebrei davano della parola Italia, in ebraico I Tal Yah, cioè ‘isola della rugiada divina’, è il paese dove ‘fioriscono i limoni’ di goethiana memoria. Si legge nelle prime pagine della Storia degli ebrei in Italia di Attilio Milano: I‐tal‐Jah: l’isola della rugiada divina. Il paese su cui il Signore ha riversato con abbondanza una delle benedizioni che Isacco inventò sulle terre di suo figlio Giacobbe: la rugiada ristoratrice.6 Al tempo stesso, anche la lingua italiana diviene un mezzo di espressione meno forte e traumatico, maggiormente dolce e sopportabile nel raccontare l’orrore. Significativamente, nelle prime pagine del romanzo Lettera a Francoforte di Edith Bruck la protagonista riceve una lettera in varie lingue riguardo una sua richiesta di risarcimento in seguito alla deportazione. Dopo aver letto la prima parte in ungherese, si legge: 100
Auschwitz, Kaufering, Landsberg, Dachau, Christianstadt, Bergen‐Belsen. La suddetta (mi rifugio nella lingua italiana che sembra meno vera), con il numero di prigioniera 11152 è stata liberata dall’esercito a Bergen‐Belsen.7 In aggiunta, quando parla con un’amica tedesca, l’unica tedesca con cui riesce ad avere dei contatti, afferma: Solo con Christa, l’amica mia e di Ellen, ho un contatto rilassato, forse perchè vive in Italia e parliamo in italiano.8 Ci si chiede giustamente cosa s’intenda quindi per ‘mito’ del bravo italiano? Significative sono le sopracitate parole di Primo Levi che sottolineano il raro antisemitismo diffuso all’interno del popolo italiano. Durante il dopoguerra sia lo Stato italiano che la popolazione e la comunità ebraica italiane contribuiscono a creare la leggenda (con un fondo di verità) di un intero popolo avviso al regime fascista ed al conflitto che dilaniava l’intera Europa ed unito nella lotta per la libertà sotto la bandiera della Resistenza. L’italiano diviene quindi una figura caratterizzata da innata bontà ed incapacità di compiere azioni feroci e crudeli. La colpa di azioni cruente viene scaricata su rari ‘crudeli’ fascisti e piú in generale sui mostri teutonici responsabili di tutti i mali, sulle gelide e sadiche SS disposte ad utilizzare ogni mezzo per poter raggiungere i loro scopi, dotate di potere assoluto di vita e di morte e illuminate da bagliori satanici. I colpevoli sono quelli che, per riprendere l’immagine di JUDGMENT AT NUREMBERG di Stanley Kramer del 1961, possono essere considerati gli eschimesi di casa nostra. In questo film che tratta del processo di Norimberga contro alcuni gerarchi nazisti nel secondo dopoguerra, l’avvocato dell’accusa Tad Lawson, rivolgendosi al giudice Dan Haywood (interpretato da Spencer Tracey) e riferendosi all’atteggiamento generale del popolo tedesco ed alle loro giustificazioni nei confronti dei crimini commessi nel loro paese, afferma: There are no Nazis in Germany. The Eskimos invaded Germany and they took over. That’s when all those terrible things happened. It wasn’t the fault of the Germans. It was the fault of the damned Eskimos!9 Nessun tedesco sembrava essere colpevole. Tale affermazione è valida anche per gli italiani. Non sembrano esserci stati fascisti in Italia e se ci sono stati non erano così terribili e malvagi come quei maledetti invasori tedeschi, gli eschimesi di casa nostra. Tale atteggiamento è dovuto al forte tentativo di cancellare il passato di una nazione dove gli italiani hanno combattuto gli uni contro gli altri e molti sono stati inviati alla morte dai loro stessi compatrioti. L’importante è guardare al presente e al futuro, ricostruire il paese e riappacificarsi per poter svolgere questo arduo compito. Esemplare è la cosiddetta ‘amnistia Togliatti’ del 1946 per i reati politici e militari, firmata dal Ministro di Grazia e Giustizia, il comunista Palmiro Togliatti. Come si legge nella relazione di Togliatti, tale provvedimento è dovuto ad un desiderio di 101
pacificazione e riconciliazione di tutti ‘i buoni italiani’ nel nome di una Repubblica sorta dall’ispirazione al rinnovamento della vita nazionale. Afferma Togliatti: Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e della riconciliazione di tutti i buoni italiani.10 Anche la comunità ebraica italiana dimostra col suo atteggiamento la totale assimilazione all’intera popolazione italiana, condividendo la stessa attitudine dei compatrioti e sancendo la propria fede nel mito del bravo italiano. Scrive, infatti, lo studioso David Schaumann: Si possono comprendere le illusioni degli ebrei italiani che da secoli erano avezzi ad una pacifica, amichevole e cordiale convivenza nel loro paese. Anzi, nell’Ottocento gli ebrei italiani erano stati i promotori del Risorgimento e nessun gruppo consistente della popolazione italiana si era mai pronunciato contro di loro. […] Cosicché, considerando che fino al ’38 il fascismo non aveva perseguitato gli ebrei, questi ultimi furono indotti ad attribuire la colpa del razzismo ai soli nazisti tedeschi. Le persecuzioni, dunque, apparvero come una luttuosa, tragica parentesi, dopo la quale era fondato auspicare il riaprirsi di un’epoca di serena integrazione nella società italiana.11 Le vicende degli ebrei vengono incluse nella tragedia nazionale ed i martiri ebrei collegati a quelli della Resistenza, sottolineando il desiderio di riconciliazione ed integrazione nell’ambito dell’epos nazionale. Afferma significativamente Giacomo De Benedetti in Otto ebrei: È quello che gli ebrei già liberi hanno patito, e quello che i perseguitati patiscono ancora, desiderano sia versato, messo in comune, mescolato al lungo, collettivo, unanime tributo di lacrime e supplizi, che gli uomini degni di questo nome hanno offerto, e offrono tuttavia, per assicurare al mondo la più lunga serie di secoli civili. Se una rivendicazione gli ebrei hanno da fare, è questa sola: che i loro morti di violenza e di fame […] siano messi in fila con tutti gli altri morti con tutte le altre vittime di questa guerra. Soldati anche loro come altri soldati.12 Significativo a questo proposito è il Manifesto agli italiani del 25 aprile 1955 affisso dalla comunità ebraica italiana: Gli ebrei d’Italia […] esaltano riconoscenti l’opera coraggiosa, talvolta sino al sacrificio, di tutti quegli italiani – partigiani, militari, religiosi e laici, gente modesta di ogni ceto e ogni credo – che, riscattando le colpe di una minoranza, italianamente si prodigarono per salvare i perseguitati inermi entro i confini d’Italia e fuori di essi, ricordano con gratitudine l’appoggio dato dalla risorta democrazia nell’immediato dopoguerra ai profughi ebrei superstiti dei campi di sterminio.13 Di conseguenza l’Italia vive un momento di deresponsabilizzazione e forte desiderio 102
di dimenticare. E si assiste in Italia a quel fenomeno che Remo Bodei nel Libro della memoria e della speranza definisce “amnistia‐amnesia della memoria” creando l’immagine degli italiani ‘brava gente’ disposti ad accogliere anche nel dopoguerra le vittime della deportazione che la eleggono come ‘casa’, malgrado i forti ed ovvi problemi di reintegrazione.14 Scrive Edith Bruck in Lettera da Francoforte: Faccio un buon caffè con del latte condensato. È buono. Tutto è buono a casa. L’Italia diventa il mio paese per davvero solo quando sono lontana.15 L’Italia diviene un luogo accogliente e di rifugio e la sua lingua un mezzo meno forte per descrivere la Gorgone, l’orrore dei campi ed i traumi subiti. Questa rimane nondimeno solo un’ipotesi di lavoro cui solo gli autori potranno rispondere e le parole di Edith Bruck possono smentire il tutto: Question: How difficult was it to write your memoir in Italian, a language you learned as an adult? Why did you choose to write in Italian? E.B.: The difficulty of the language never was and never has been a problem for me because what I want to say is already formed inside me and already has its own language. Writing for me is like conceiving a child and when the time comes, I put it into the world, I deliver a finished work with its own fingernails, its own hair, its own heart more or less strong. I never reread my books already lived, already over with. The Italian language is an accidental choice. If I had emigrated to America, I would have written in English. Italo Calvino even said to me that I should live in America because my audience is American.16 Tuttavia, malgrado queste parole, vale la pena riflettere su come questi sopravvissuti siano rimasti a vivere in una nazione alleata del Terzo Reich, con campi di internamento e uno di sterminio (la Risiera di San Sabba), luogo di persecuzioni e deportazioni e l’abbiano eletta quale ‘casa’ adottandone persino la lingua. NOTE Nel 1971 Helga scoprì che la sua vera madre era ancora viva e decise di andarla a trovare a Vienna. Quell’incontro fu brevissimo. La madre la portò in una stanza dove conservava lʹuniforme nazista che indossava il giorno in cui venne arrestata ad Auschwitz. A distanza di tanti anni era ancora fiera del suo passato passato. Tentò anche di farla indossare ad Helga che, inorridita, decise di tagliare definitivamente i ponti con la madre. 1
Levi 2002, 93. 2
Handke 1972, 25: “Le parole Hitler, Auschwitz, Lubke, Berlin, bombe napalm sono troppo piene di significato, troppo politiche perché io le possa utilizzarle senza remora alcuna in letteratura”. Traduzioni a cura di Cristina Villa. 3
Bruck 2004, 111. 4
Cinanni 2000. 5
103
Milano 1963, 2. 6
Bruck 2004, 9. 7
Ibidem, 23. 8
“Non ci sono nazisti in Germania. Gli eschimesi hanno invaso la Germania e ne hanno preso il comando. Ed è allora che tutte quelle terribili cose sono successe. Non è stata colpa dei tedeschi. È stata colpa di quei dannati eschimesi!”. 9
Canosa 1999, 435. 10
Schaumann 1977, 106‐107. 11
Debenedetti 1944, 33‐34. 12
Schwarz 1998, 121. 13
Bodei 1995, 25. 14
Bruck 2004, 20. 15
Interview Bruck 2000. “Domanda: Quanto è stato difficile scrivere le Sue memorie in italiano, una lingua che ha imparato da adulta? Perché ha scelto di scrivere in italiano? E.B. La difficoltà linguistica non è mai stata un problema per me, in quanto, quando voglio dire qualcosa, questo ha già preso forma dentro di me e possiede già la sua propria lingua. Scrivere per me è come concepire un bambino e, quando giunge il momento, lo metto al mondo, partorisco un lavoro finito con le unghie, i capelli, un cuore più o meno forte. Non rileggo mai i libri che già vivono, che ho già finito. La lingua italiana è una scelta casuale. Se fossi emigrata in America, avrei scritto in inglese. Italo Calvino mi ha persino detto che dovrei vivere in America, in quanto il mio pubblico è americano”. 16
BIBLIOGRAFIA AA.VV. ‘An Interview with Edith Bruck, author of Who Loves You Like This’. [2000] Pauldry Books Catalogue – 20.9.2006 http://www.pauldrybooks.com/complete_catalog/wholovesyou/An%20Interview%20with%20Edith%
20Bruck.htm. Bodei, Remo. Libro della memoria e della speranza. Bologna: Il Mulino, 1995. Bruck, Edith. Lettera da Francoforte. Torino: Einaudi, 2004. Canosa, Romano. Storia dell’epurazione in Italia. Milano: Baldini & Castoldi, 1999. Cinanni, Maria Teresa. ‘Il dovere della testimonianza’. [2000] Caffè Europa – 20.9.2006 http://www.caffeeuropa.it/attualita/98ebraismo‐bruck.html. Debenedetti, Giacomo. Otto ebrei. Roma: Atlantica, 1944. (Ristampato in: Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943. Palermo: Sellerio, 1993). Handke, Peter. Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Frankfurt: Suhrkamp, 1972. Levi, Primo. L’asimmetria e la vita. Torino: Einaudi, 2002. Milano, Attilio. Storia degli ebrei d’Italia. Torino: Einaudi, 1963. 104
Shaumann, David, a cura di. Pensieri e insegnamenti. Milano: Federazione sionistica italiana, 1977. Schwarz, Guri. L’elaborazione del lutto. La classe dirigente ebraica e la memoria dello sterminio (1944‐1948). Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, a cura di Sarfatti Michele. Firenze: Giuntina, 1998. 167‐180. 105
BALMA, Philip. ‘Edith Bruck’s experience in Italy: publishing, cinema, and the thematic ghetto’. Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational Approach. Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 107‐
113. SUMMARY This study is the result of an interview with Edith Bruck which took place on May 3, 2006, in her apartment in Rome. The purpose of my paper is, in part, to expose and discuss in detail a series of conditions that created a new ghetto for the novelist who survived Auschwitz; this time a thematic ghetto. Focusing on the author’s recent statements, this essay will begin by discussing some of the difficulties encountered by Primo Levi in his dealings with the Einaudi publishing house; moving on to Edith Bruck’s experiences as a Holocaust witness who, eventually, found herself blocked in this role, in part because of pressures she felt from the Italian publishing industry. Analyzing her experiences in the world of cinema, I will then transition to a discussion of some stormy events which took place in the former Yugoslavian republic, and later in Italy, during the shooting of two films on the holocaust: KAPÒ by Gillo Pontecorvo for which the author worked as a consultant (without ever appearing in the credits), and ANDREMO IN CITTÀ by her husband Nelo Risi, based on Bruck’s story contained in the homonymous book. In particular, the author’s difficult relationship with director Pontecorvo will be brought to bear, and the surprising behavior of Italian newspapers (from the political right and left) following an unfortunate incident when the writer was assaulted by a Bosnian man who hated Hungarians. KEYWORDS Edith Bruck, Holocaust literature, Italian cinema, censorship, Primo Levi © The authors The proceedings of the international conference Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational Approach (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 October 2006) are volume 2 of the series ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, published by Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 107
EDITH BRUCK’S EXPERIENCE IN ITALY PUBLISHING, CINEMA, AND THE THEMATIC GHETTO Philip Balma Indiana University of Bloomington University of Notre Dame The bulk of the considerations which I am about to offer have been either directly cited from or inspired by a recent interview with the Hungarian novelist and poet Edith Bruck. I feel I should point out that my intention is merely to bring her words and thoughts to your attention. I should mention that one of the main points in my presentation concerns a past disagreement between two artists, namely Edith Bruck and Gillo Pontecorvo. While my considerations might strike you as controversial, they nevertheless have to do with an old dispute that has since been resolved in some fashion. During our conversation, which took place on the afternoon of June 3rd, 2006 in her apartment in Rome, she spoke of her friend Primo Levi’s disappointment at the rejection of his first book, Se questo è un uomo (Survival in Auschwitz). It is a known fact that its rejection by the Turinese publishing house Einaudi came at the hand of an acquaintance of Primo Levi, the late Natalia Ginzburg. Levi’s disappointment was discussed in detail in an article written by Fernando Camon for the italian newspaper La Stampa on December 23rd, 1996, titled ‘Lʹincubo del rifiuto’ (The nightmare of rejection). Perhaps, the worst repercussion of this rejection, which came at the beginning of Levi’s literary career, was that it mirrored the fear caused by a much more painful and personal nightmare, one that Levi had shared with other inmates in Auschwitz only to discover that it haunted them as well: the fear that, upon finally returning home after the camps, and being reunited with family, friends, and peers, oneʹs testimony of the Holocaust would be either rejected as falsehood, or avoided and hidden like an unbearable and uncomfortable truth (Camon 1996). There is certainly a symbolic affinity between the nightmare here described and the reality of rejection once experienced by Primo Levi. Simply put, the message he was being conveyed was that he was not going to be allowed to share his truth about the Holocaust through publication, or at least, not according to the timeline he would have preferred. While Edith Bruck has first hand knowledge of this uncomfortable situation that developed between Levi and Ginzburg, her reaction at the time was a mixture of sympathy and disappointment. While she supported Levi’s contention that the rejection was decidedly ill‐advised, she was disappointed by his unwillingness to denounce this treatment publicly. Perhaps Levi simply did not want to speak out against Natalia because of the position she held in the Italian publishing industry, but one must also consider that the two of them were part of the same community. 108
Edith Bruck’s many re‐visitations of the subject of the Holocaust in her books has been well documented over the course of the last 10‐15 years, thanks to such scholars and translators as Ruth Feldman, Brenda Webster, Gabriella Romani, Rita Wilson, and Adalgisa Giorgio. Giorgio studied Bruck’s progressive thematic movement away from the concentration camps in a significant selection of her works, adopting the author’s autobiographical debut Chi ti ama così (1959) as a necessary point of departure. She traced and quantified the references to the Shoah in Bruck’s novels, and also analyzed a tendency that the author has since abandoned; or rather, the use of third person narration instead of first person. Although Giorgio’s essay titled ‘Dall’autobiografia al romanzo. La rappresentazione della Shoah nell’opera di Edith Bruck’, was published in 1999, Giorgio’s considerations do not include the novel Il silenzio degli amanti from 1997, in which the author reverted to the use of a first person narrator. Since 1997, Bruck has, in fact, consistently produced fiction written in the first person. In her essay Signora Auschwitz (1999) Bruck discussed the role of the writer‐witness at length, a role that has defined much of her literary activity, as well as that of Primo Levi before her. In this text she freely admitted that this role has been both a blessing and a burden, as it has both brought her strength and drained her of it over the years. While she recognizes the need to educate schoolchildren on the Shoah, she has – at times – felt inclined to never visit a school again. In Signora Auschwitz she mentioned the publication of her novel Il silenzio degli amanti (1997, The silence of the lovers, still unavailable to Anglophone readers), and described it as a “cute idea”, a sort of thematic vacation from the difficult subjects she often chooses to address in her writing. The novel in question allowed her to explore the use of a male protagonist, in this case a homosexual, or perhaps bisexual man whose (female) friend is involved with a married person. The plot deals candidly with some very modern and current issues, and allowed her to remain within the literary niche that she considers her own; or rather, the use of literature to expose and condemn the injustices present in society, particularly those caused by the proliferation of hatred, bigotry, and stereotypes. With the exception of Il silenzio degli amanti, the issue of the Shoah is present in the majority of Bruck’s publications, in one form or another. In some cases, we can see evidence of her using the Holocaust as an implied element in the lives and experiences of her protagonists, instead of making it the central motivation and inspiration behind her works. Hence, Adalgisa Giorgio was correct in saying that Bruck has taken to exploring the long‐term repercussions of the camps on the individual and on society. A perfect example is the novel Transit (1975), in which a woman is hired to be a consultant for a film detailing the female experience in Auschwitz. This text brilliantly exemplifies how such negative experiences (and the ability and willingness to recall them) can be inextricably linked to someone’s professional and financial worth. In a more recent work titled Nuda proprietà (1993, Bare property), a woman residing in Rome is evicted from her apartment, and decides to pursue an unlikely and uncomfortable relationship with an elderly woman whose late husband had been an SS officer – in order to gain her favor, and eventually, 109
upon her death, take possession of her residence. The protagonist, a Jewish woman named Anna, is not dissimilar from other characters created by Bruck: she is a Holocaust survivor who has made a life for herself in Europe, a fact that she only attempts to share with the old woman, referred to as Frau Kremer, at the end of the novel. The word ‘Holocaust’ never appears in this text, and there is only one specific reference to Auschwitz. Nevertheless, these elements of history are the single strongest source of conflict and tension between the two main characters. These are just two examples of how Bruck has tried to find some form of creative distance from the Shoah, without going as far as removing it from the consciousness of her characters. Until recently, her readers have been left to wonder if she has ever attempted to publish another book that has absolutely nothing to do with World War II. It is thanks to a recent interview by Maria Cristina Mauceri (2006), if the issue of a ‘thematic ghetto’, in which Bruck finds herself enclosed, has made its way into this paper. In fact, Mauceri’s work was a great source of inspiration behind my decision to interview the author. When I asked Bruck about two novels that she has been unable to secure a publisher for, she spoke frankly about the limitations that have been placed on her literary and journalistic endeavors. Issues of prejudice, exploitation, and civil rights in modern Europe have become her niche, her self‐
proclaimed area of specialization. Her desire is simply to expand on this niche and her exploration of it, to use her craft to speak for all the victims of injustice who do not have a voice. The author freely admits that she may be, in part, complicit in the creation of this ‘ghetto’, these walls that have encapsulated her artistic production. While she certainly wishes at times that her name were not automatically (and often exclusively) associated with Holocaust literature, she is aware of the choices she made that could have contributed to this tendency exhibited by many scholars and editors. Surprisingly enough, the manuscripts she has been unable to place with Italian publishers tackle some very current and important issues, such as the abduction and sexual exploitation of young Albanian girls, and the plight of a woman whose lover is more than thirty years younger than her, crushed by the impossible standards of perennial beauty imposed by society and the media. These daring and highly relevant works have been, up to this point, summarily rejected by Italian editors, to the extent that Bruck has been tempted to give up on ever seeing them in print (Bruck, personal interview 2006). One might argue that the thematic ghetto she has been trapped in puts her in a situation which is the exact opposite of Primo Levi’s first experience with Einaudi: editors seem to only be interested in her writings that deal with the Shoah. Bruck’s aforementioned novel Transit presents scholars of literature and cinema with a most unusual conundrum. The innumerable references to the film KAPÒ by Gillo Pontecorvo (1959) within this text are undeniably specific, so much that anyone who compares the film to the novel could identify it as a source of inspiration behind this work of fiction. Despite my many efforts and research strategies, I was initially unable to find any tangible evidence of the author having 110
been involved in the production of this motion picture. Only by speaking to her in person was I able to verify my theory that she had, in fact, worked as a consultant for Pontecorvo on this project, as an expert on the female experience in Auschwitz. During our interview Bruck stated that Pontecorvo’s attitude in the workplace was reminiscent of a “concentration camp commander” ordering people around, being inflexible and insensitive to the needs of his colleagues, and, on one occasion, scaring the author by showing her artificial cadavers. Such treatment caused Edith to leave this job earlier than she would have foreseen, and the director’s reaction was to keep her name and contributions out of the credits, and to pretend, over the course of the last four decades, that she had no involvement in the making of this film. After the author published Transit in the 70s, Pontecorvo refused to even greet her for ten years, until her husband Nelo Risi eventually helped make peace between them. The director had apparently adapted some portions of her autobiographical text Chi ti ama così and included them in the script for KAPÒ without acknowledging this fact. Those who are familiar with the motion picture are possibly aware that the first half of the movie is judged by some film scholars as superior (in both quality and authenticity) to the second part, in which a love story develops between two of the main characters. One can only speculate as to how much better the film could have been if Edith Bruck had remained until the project was completed. The result of this experience could be considered a misappropriation of intellectual materials for personal and commercial gain. This regrettable event recalls yet another form of ghetto, aside from a thematic one, in which artists can find themselves: one created by plagiarism; or rather, a failure to give credit where it is due. Just like the motion picture KAPÒ, Nelo Risi’s film ANDREMO IN CITTÀ (1966), based on Bruck’s short story by the same title, was filmed in Belgrade. Only a few years after her experience working with Pontecorvo, Edith returned to this city to embark on another cinematic endeavor. While she certainly had no trouble having her contributions to this project acknowledged in the credits (and recorded in the annals of film history), this return to Belgrade to work on a movie brought about yet another highly unfortunate incident, one that still haunts her to this day. It was during this period of her life that Bruck was assaulted by the manager of a clothing store because of her Hungarian accent. This man who broke her wrist had apparently lost his brother in the war and still harbored an intense hatred for all Hungarian nationals, whom he considered to be fascists. This frightening assault, and the subsequent mistreatment suffered by Bruck at the hand of police agents, is described vividly in the novel Transit. The most fictional aspect of this novel is not the reality it depicts, but the mixing of events from two different moments in Bruck’s life. After having been marooned in the woods at night by a policeman, Bruck found that the local papers had smeared her good name, and accused her of causing an incident instead of being a victim. To make matters worse, the chief of police and a mysteriously appointed lawyer began visiting her frequently, pushing forth an agenda designed to bury this incident without any admission of guilt by anyone. Her desire to have the slanderous statements retracted from the newspaper turned this 111
into a potentially explosive situation, to the point that the local authorities even threatened to block the production of the film. The result of this discrimination towards Edith is symmetrically opposite to the thematic ghetto she spoke of recently. Instead of delaying or preventing her from sharing an artistic representation of life and history, like in the case of the film ANDREMO IN CITTÀ, the thematic ghetto Bruck is currently operating in limits her creative expression to the subject of the Shoah, as if to suggest that she has nothing else to offer the Italian and European literary scene. Upon her return to Italy after the completion of ANDREMO IN CITTÀ, Bruck found that, because of the incident in Belgrade, for the first time, she was being “attacked by leftist newspapers, and both supported and exploited by the right‐wing press”. Although she would certainly not describe herself as a Communist, Bruck also admits that she never would have expected to receive any form of support in writing from those journalists that align themselves with the political right. This incident reminded her of the need to protect her privacy and her own interests from those who are willing to use the misfortunes of others as ammunition for their own political battles. This is one of a variety of reasons why she has given up on her desire to be a member of the Italian albo dei giornalisti. Although she was given considerable creative freedom during the time she spent working for the national broadcast corporation RAI, Italian newspapers in particular have always been interested in her work because of her heritage and life experiences. Unwilling to be relegated to writing only about ‘questioni ebraiche’ (Jewish issues), the author prefers to concentrate on the themes of her choosing. In conclusion, it is important to remember that the author is not accusing or placing blame on anyone in the Italian publishing industry. In fact, she admits that her writing is, in one form or another, completely related to a single purpose: the desire to denounce all injustices and abuses of power – not in order to seek revenge, but because someone has to speak out. When asked about her motivations for writing Transit, Bruck mentioned both the mistreatment she had suffered 47 years ago at the hand of her friend Pontecorvo, as well as the Belgrado incident in the mid 60s, but she proceeded to relate this novel to the authorial intent behind all of her other writings by offering the following commentary: Non [l’ho scritto] per vendetta, questo deve essere molto chiaro, io non ho un sentimento vendicativo nei confronti di nessuno, né odio nessuno, neanche i tedeschi, anche perché me lo chiedono sempre quando vado nelle scuole. Io sono libera proprio di questi sentimenti così terribili e negativi che ti avvelenano la vita, la tua vita, quindi è una cosa per cui mi sento molto graziata, molto liberata, molto benedetta, molto favorita per questo mio non sentire odio verso assolutamente nessuno. Quello che io sento molto invece è l’ingiustizia. Ho pensato che, prima o poi, questo mio lamento contro le ingiustizie che ho subito, sia perché mi hanno rotto il polso, sia perché lui [Gillo] si è comportato in questa maniera così sbagliata, non amichevole, anche perché era un amico, ho detto che va denunciata, quindi secondo me Transit, come tanti altri miei libri, è una denuncia: denunciare tutti i soprusi, tutte le oppressioni, lo schiacciare l’altro, il non riconoscere l’umanità dell’altro. (personal interview) 112
WORKS CITED ANDREMO IN CITTÀ. Screenplay by Edith Bruck & Cesare Zavattini. Directed by Nelo Risi. Starring Geraldine Chaplin, Nino Castelnuovo & Aca Gavric. Milano: Mondadori Video (Il Grande Cinema), 1966. Bruck, Edith. Chi ti ama così. Milano: Lerici Editori, 1959. (Who Loves You Like This Translation by Thomas Kelso. Philadelphia: Paul Dry Books, 2001). ‐‐‐. Signora Auschwitz: Il dono della parola. Venezia: Marsilio, 1999. ‐‐‐. Il silenzio degli amanti. Venezia: Marsilio, 1997. ‐‐‐. Transit. Venezia: Marsilio, 1975. ‐‐‐. Nuda proprietà. Venezia: Marsilio, 1993. ‐‐‐. Personal Interview (recorded on audiotape). 3 June 2006. Camon, Ferdinando. ‘Primo Levi. L’incubo del rifiuto’. La Stampa (23 December 1996). Giorgio, Adalgisa. ‘Dall’autobiografia al romanzo. La rappresentazione della Shoah nell’opera di Honess, Claire E. & Verina R. Jones, eds. Le donne delle minoranze: le ebree e le protestanti d’Italia. Torino: Claudiana, 1999. KAPÒ. Directed by Gillo Pontecorvo. Starring Susan Strasberg, Laurent Terzieff & Emmanuelle Riva. 1959. DVD. Cristaldifilm, 2003. Mauceri, Maria Cristina. ‘Dove abito è il mio villaggio. A colloquio con Edith Bruck’. Kuma.Creolizzare l’Europa 11 (2006). 113
BUDOR, Dominique. ‘Il “romanzo genealogico”, ovvero la memoria viva dei morti’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 115 – 128. RIASSUNTO Il cosiddetto ‘romanzo genealogico’, affermatosi a partire dagli anni Ottanta e Novanta in molti scrittori di origine ebrea e in diversi paesi, si sviluppa sulla base di una sensibilità ben specifica legata alla rinnovata discriminazione. In un contesto di offesa alla memoria, ripercorrere la genealogia (sulla scia letteraria di Georges Perec) significa voler situare se stesso nel filo dell’eredità ebraica e rifondare la stirpe, ritrovando l’ordine e le classifiche che legano le generazioni nella Storia, malgrado la perdita e lo sterminio. Tale motivazione crea una forte propensione espressiva per un io narrante che articola spinta autobiografica e libertà d’invenzione, dentro una forma ‘romanzo’ atta a suscitare una varietà infinita di ‘effetti di realtà’: servendo da motivi dinamici dell’azione a partire da poche o frammentarie tracce, essi permettono che la finzione riempia i vuoti e i silenzi delle realtà che sono state perdute o non sono mai esistite. A titolo di esempio, sono analizzati Il mio nome a memoria di Giorgio van Straten (del 2000) e L’orologio di Monaco pubblicato da Giorgio Pressburger nel 2003. Se i due romanzieri – dai destini individuali assai differenti – danno ugualmente alla scrittura la funzione simbolica di ‘sepoltura’ per gli antenati spariti nella diaspora o assassinati durante la Shoah, essi divergono del tutto nel definire la loro condizione da ultimo della stirpe e la vita dei ‘figli’: al pacato ritrovamento di se stesso nella memoria familiare da parte di Giorgio van Straten si contrappone l’ansia di disparition di Giorgio Pressburger. PAROLE CHIAVE Scrittori ebrei, romanzo genealogico, nome, autobiografismo, scrittura/sepoltura © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 115
IL “ROMANZO GENEALOGICO”, OVVERO LA MEMORIA VIVA DEI MORTI Dominique Budor Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 GENEALOGIA E SCRITTURA L’interesse per la genealogia si manifesta oggidì in maniera dilagante: documenti anagrafici e atti notarili consultati da ‘archivisti’ di circostanza, conferenze, incontri, società, un servizio ‘Minitel’ in Francia, specifici manuali o programmi di software. Spiegazioni globali sono spesso fornite: la ricerca delle origini riscatta dallo sradicamento e dall’anonimato derivati dalla civiltà di massa. Su questa scia, appare logico, in termini di sociologia della letteratura, che forme ormai tradizionali del genere romanzo vengano modificate da questa disposizione culturale: con l’estensione del romanzo familiare a parecchie generazioni nasce, a un livello quanto mai commerciale, la moda della saga; il romanzo storico, corretto dalla lente dell’individualità e dell’intimo, conosce uno spettacolare revival. Il cosiddetto ‘romanzo genealogico’, affermatosi a partire dagli anni Ottanta e Novanta in molti scrittori di origine ebrea, e in differenti paesi – si deve menzionare l’originalità e l’importanza fondamentale del romanzo dell’olandese Marcel Möring, In Babylon (1997) – si sviluppa però sulla base di una sensibilità ben diversa. Dopo la fase di attenzione storica e di ascolto sociale nel periodo del processo Eichmann (1961), i primi tentativi di negazione di quell’unicum che è la Shoah sono apparsi presto – per l’Italia, vale forse come primo segno, mascherato dietro l’alibi della creazione artistica, il film di Liliana Cavani IL PORTIERE DI NOTTE (1974), che con dignità e notevole ritegno Primo Levi giudicò “bello ma falso”. Nel 1982, l’entrata delle truppe israeliane in Libano e i massacri nei campi palestinesi danno luogo, da parte di certi gruppi ideologici, ad amalgami tra politica nazionale o internazionale, religione e comunanza culturale. La polemica del revisionismo, inoltre, si scatena nel 1987. In un tale contesto di offesa alla memoria e nella dolorosa percezione della rinnovata emarginazione, ripercorrere la genealogia significa voler situare se stesso nel filo dell’eredità e, per individuare la propria posizione nell’albero genealogico, rifondare la stirpe, ritrovando l’ordine e le classifiche che legano le generazioni nella Storia. Dentro a quest’operazione si annida il bisogno – ossia la necessità – di indagare la propria appartenenza, di definire o scoprire la propria judéité.1 Il discorso familiare si ricollega allora, anche per chi non ha subito direttamente le persecuzioni, alla traumatica rottura di trasmissione sofferta dagli Ebrei: nella dispersione dell’esilio, nell’impossibile lutto dopo i pogrom e lo sterminio, nella permanenza dell’odio razziale, una parola frammentaria tenta di riannodare i fili della memoria e, 116
a partire dalla forza del nominare insita nella tradizione ebraica, manifesta la volontà di far riapparire i morti rimasti senza sepoltura. Nell’operazione di scrittura, intanto, la ricerca del nome si connette inevitabilmente alla questione della firma e alla posizione dello scrittore nel panorama culturale. La scrittura genealogica negli scrittori italiani di origine ebrea ha quindi una motivazione etica e sentimentale ben specifica: non si può perciò caratterizzare, riguardo alla tipologia letteraria, né come variante del romanzo familiare né, anche se rievoca i secoli passati, come sottogenere del romanzo storico. Dovendo cercare eventuali antenati letterari – il che non significa influenze ma solo affinità – si potrebbe invece evocare la via aperta nel 1975 da Georges Perec in W ou le souvenir d’enfance: una parola familiare ancorata alla Storia e sempre generata dall’assenza (la vocale mancante de La Disparition) e dalla perdita (le figure femminili ne La Vie mode d’emploi, legate alla deportazione della madre).2 Tale motivazione crea una forte propensione espressiva per un io narrante. L’io può essere un personaggio, tramite delega dal costruttore del testo a una voce parlante, come nel già citato In Babylon di Möring, in cui il talento da narratore del protagonista Nathan Hollander viene, attraverso volontà testamentarie, messo alla prova con l’obbligo di scrivere la biografia dello zio: l’impossibile biografia diventa un’autobiografia finta e la cronaca di tutta la famiglia venuta dall’est. In altri casi, l’io narrante è apertamente autobiografico, nel senso in cui nei lontani anni 1975 Philippe Lejeune definì il patto di autenticazione stretto tra narratore e lettore: identità tra autore, narratore e protagonista come, per esempio, ne Il mio nome a memoria di Giorgio van Straten (2000). Tuttavia, quandunque è ovvia l’unica realtà della triplice struttura, essa non mira, come nell’autobiografia canonica, a garantire la precisa realtà di tutte le altre storie che si aggregano a quella dell’io: essa pretende solo stabilire le condizioni effettive della mossa alla scrittura da parte dell’autore, così come la verità simbolica della Storia collettiva che viene poi ‘illustrata’ dalle storie di tutti gli antenati che compaiono nel racconto. La forma ‘romanzo’ – la categoria generica serve da sottotitolo al libro di Van Straten – si impone allora come l’unica soluzione narrativa atta a rispondere alle necessità di rifondazione della genealogia. Il romanzo, con i suoi esorbitanti privilegi da genere indefinito come lo diceva Marthe Robert,3 potendo inventare una varietà infinita di ‘effetti di realtà’ per farli servire da motivi dinamici dell’azione, si soddisfa difatti delle poche o frammentarie tracce della realtà: permette così che la finzione sostituisca la realtà perduta, che la fantasia riempia i vuoti, le mancanze, il silenzio, l’oblio. Il romanzo autorizza un’enorme quantità e varietà di personaggi che si possono situare in tanti luoghi e temporalità: apre ad una dispersione in cui si riassume l’essenza della diaspora (Möring sceglie ad epigrafe per In Babylon una frase dello storico Isaac Deutscher: “les arbres ont des racines. Les juifs ont des jambes”).4 Infine, il romanzo esige una struttura di azioni per collegare i personaggi: questa rete funge da sostituto del legame familiare, di modo che l’opera, nel senso concreto di costruzione, faccia esistere gli esseri e le cose che non sono mai stati o non sono più. Il romanzo genealogico si differenzia dunque tramite dati relativi alla storia narrata, per esempio 117
il gran numero di generazioni prese in esame; si qualifica in quanto tale dall’intento complessivo di chi scrive: conoscere se stesso attraverso tutta la stirpe, invece di fare di pochi antenati vicini e di pochi nuclei spaziali la base della ricostruzione di una famiglia frantumata; e si caratterizza da una contrattuale accettazione da parte del lettore della differenza tra ‘verità’ del racconto di finzione e ‘realtà’ della vita. Si deve quindi notare che molti racconti su temi intimi legati alla giudaistica, scritti da autori o autrici scampati per caso alla morte segnata oppure appartenenti alla cosiddetta ‘seconda generazione’ (nati dopo Auschwitz), sono attinenti alla memorialistica familiare o a forme storicizzate dell’autobiografia ma non rientrano nella linea del romanzo genealogico. Basterebbe citare Lo strappo nell’anima di Elena Loewenthal (2002), che si confronta con l’irreparabile ferita del passato, un inesistente patrimonio di familiarità e un confuso sentimento di colpevolezza, prima di descrivere una dolorosa riappropriazione dell’identità perduta. Oppure Ritorno in Lettonia di Marina Jarre (2003) che, dopo il resoconto del viaggio di ritorno dell’autrice‐narratrice verso la storia privata del divorzio dei suoi genitori e le condizioni dello sterminio degli Ebrei di Riga, approda a un ricordo pacificato del padre morto e a un ritrovamento dell’origine. La scrittura intima mira alla riconquista del sé. IL CORPUS Nello spazio di una comunicazione, è ovvio che possono essere indagate solo poche modalità di come alla continuità del romanzo genealogico sia affidato il compito di ridare ‘vita’ ai morti. Data dunque la necessità di eleggere un campionario a corpus, con l’inevitabile rischio di maggiore arbitrarietà che ne consegue, intendo almeno precisare i criteri della scelta. Mi è parso opportuno prendere in esame due romanzi italiani pubblicati a distanza di pochissimi anni – vale a dire in un contesto di ricezione teoricamente molto simile – ma generati invece da situazioni personali assai diverse: Il mio nome a memoria di Giorgio van Straten, del 2000, e L’orologio di Monaco pubblicato da Giorgio Pressburger nel 2003. Esaminerò le diverse modalità formali e, soprattutto, l’itinerario della scrittura: l’avvio alla ricerca delle ascendenze e al bisogno di raccontare, l’approdo a un nuovo legame con la discendenza. Una differenza essenziale appare subito: i due testi divergono del tutto nel rapporto tra seppellimento simbolico degli antenati e affermazione della vita dei discendenti. E quindi, al di là della nozione di ‘personalità stilistica’ dei due scrittori, considerando le situazioni storiche vissute da loro in quanto ebrei e la diversità del loro legame con le loro culture (nazionali e/o askenazita), dovrà essere indagata la funzione stessa dello scrivere. IL NOME In entrambi i testi, la mossa alla scrittura è simile: il nome. In un capitolo iniziale al quale il titoletto di parte (‘I. Il tempo delle leggende’) e il racconto in terza persona, 118
che coesiste nel libro con l’io narrante, consentono la massima libertà d’invenzione, lo scrittore Giorgio van Straten (con una ‘a’) immagina come si fece, in seguito all’obbligo imposto nel 1811 agli Ebrei olandesi di scegliere un cognome, la scelta del suo antenato Hartog: Straaten, con due ‘a’. Un nome, non si trattava che di un nome. […] Un nome, nient’altro che un nome. E i nomi non possono cambiare l’esistenza degli uomini. […] Un nome, non si trattava che di un nome. Anzi, per essere precisi, di un cognome. […] Un nome: come se da quello dipendesse la sua salvezza; come se non averlo servisse a nascondersi, a sfuggire al destino, e averlo desse più forza e insieme creasse molto più pericolo. […] Ma era soddisfatto della sua scelta. Straaten, come il piccolo paese fiammingo dal quale erano arrivati i suoi antenati. Così nessuno avrebbe scordato le origini, fino all’ultimo dei suoi discendenti. / E poi Straaten perché erano ebrei: erranti, quindi, per il mondo. (Van Straten 2000, 9‐19) L’autore si cura (o lascia l’editore prender cura) di un’esatta e neutra ricezione: una nota, a piè di pagina, precisa che ‘straaten’ in olandese significa strade. Tutta la narrazione, nondimeno, invita il lettore all’interpretazione. Nella ripetizione, che suona come un’ossessione, della parola ‘nome’ echeggia l’interrogazione dell’Esodo sul nome di Dio: Yahvéh – ossia la forma arcaica del verbo essere in ebraico, che significa ‘Egli è’, (I. 2. 13‐15) – non è affatto un nome‐definizione bensì l’affermazione dell’essenza divina. Sicché il nome di ogni ebreo, lungi dall’essere solo un mero strumento di identificazione, concentra il destino del popolo ebreo: designazione di sé all’odio antisemita ma anche scoperta di sé e permanenza del popolo nel vocabolo. Nel “pericolo”, il lettore deve dunque leggere lo sterminio; e il perenne ricordo delle origini, che per Hartog vale positivamente come tradizione familiare e fedeltà ai comandamenti di Dio (lo Zakhor biblico), riassume per il lettore – che sa cosa è successo nella Storia – il fondamento dell’emarginazione, della persecuzione, dell’esilio: “erano ebrei: erranti, quindi, per il mondo” (Van Straten 2000, 19). Nell’Italia del 2000, uno scrittore italiano nato a Firenze nel 1955, di origine ebrea, importante esponente culturale nella sua città e nel suo paese, impegnato a sinistra – verrebbe da analizzare il significato unitario del titolo di un suo successivo saggio: L’impegno spaesato. (Decalogo di un uomo di Sinistra) – riflette sulle proprie origini, esamina il passato e per via di conseguenza rimisura il futuro, creando dei personaggi e una trama che il nome colloca inevitabilmente sotto il segno della paura: “La paura, entrata da poco nella sua vita, era destinata a non uscirne più” (Van Straten 2000, 19). La “scelta” di Giorgio van Straten non può non echeggiare della scelta di Hartog van Straaten, in un’operazione di scrittura che si afferma come necessità di dire il nome per conservare la memoria dei morti: La peggiore maledizione ebraica dice: sia cancellato il tuo nome e anche il ricordo di te. Dunque per salvare un uomo si deve ripetere il suo nome, come in una liturgia. Ma il ricordo? Quello, come ho detto, si spegne con le persone che lo conservano. A meno che qualcuno non decida di trasformarlo: di scriverlo su un foglio, tanto per fare un esempio. (Van Straten 2000, 22) 119
Il romanzo appare allora come la forma elaborata e letteraria di una preghiera terrena e pure sacra che, nel presente, recita il passato. L’incipit, nel romanzo di Pressburger, sembra invece aprirsi con la connotazione positiva di un titoletto di capitolo (‘I. La coscienza felice’) prima di comunicare un’informazione quasi casuale: A metà della mia vita sono venuto a sapere che alcuni uomini davvero determinanti per la storia degli ultimi due secoli sono nati da una famiglia che porta il mio stesso nome. (Pressburger 2003, 3) Il cognome, che inserisce il singolo dentro una rete comune, dà accesso alla ‘famiglia’, ma il campo semantico circostante, nel carattere positivo della scoperta (‘nuova patria’, ‘un paterno abbraccio’) o nell’evocazione negativa della situazione anteriore (l’Antico Testamento come ‘patria portatile’, cioè sola patria possibile), delinea subito il tormento dell’ebreo errante. Il primo capitolo, decisamente autobiografico, convoca difatti il primo antenato o presunto antenato, il poeta Heinrich Heine, sotto il segno dell’esilio. Giorgio Pressburger, nato a Budapest nel 1937, che ha lasciato l’Ungheria nel 1956 e vive fin d’allora in Italia, ha provato direttamente le persecuzioni della Seconda guerra mondiale e il lutto del paese natìo. La ricerca degli antenati è raccontata mediante uno scarto linguistico in cui si riassume il dolore: la lingua italiana veicolare, adottata da Pressburger nella sua attività giornalistica, poi da regista teatrale o cinematografico, diventa lingua di scrittura. Ma in questa lingua di acquisizione, diversa dall’ungherese dei genitori (il cibo preparato dalla mamma: il grenadier marsch, le pogace) e dalle lingue dell’infanzia – il famoso Hochdeutsch della nonna e lo yiddish del nonno, entrambi uccisi nelle camere a gas di Bergen‐Belsen – risuona a tratti la memoria di una lingua primitiva: per spiegare come il ferroviere che lavorava da scultore nel suo schufni salvò i rotoli della Torah, per evocare la burla fatta dal nonno allo shames o, più dolorosamente, per combattere l’indifferenza in campo storico: […] quando cominciarono i pogrom, cioè la caccia agli ebrei. (Pressburger 2003, 71) La necessità in cui si trova lo scrittore di tradurre o di spiegare, a destinazione del lettore italiano e non ebreo, è il pudico ma sofferto e persistente segno linguistico dell’estraneità: il mio giovane antenato era un vero haham, uno studioso colto e ferratissimo in materia di fede. (33) Venne il Kipur, la festa del pentimento. (45) Più illustrativa ancora dell’insanabile lacerazione della lingua (e dalla lingua) è l’apparizione della parola yiddish non tradotta, spiegata poi indirettamente, solo tre righe più avanti, e in maniera comprensibile solo per chi l’ha già capita: 120
– Tu, meschügge, cosa pensi di fare? Di stravolgere il mondo con il tuo pisello? – mi domandava la zia Ilona. / Aveva ravvisato nel mio comportamento buona parte della follia amorosa di cui ero pervaso. (137) In quel momento, la scrittura dell’autobiografo è solo memoria per sé: tenta di resuscitare la lingua assassinata, quella dell’adolescenza e della tradizione. LE VIE DELLA NARRAZIONE Nei due romanzi, il nome, oltre a dare l’impulso alla narrazione, ne fonda le modalità. In Van Straten, la ricerca delle radici prende addirittura le vesti dell’indagine e, per restituire le singole vicende degli antenati, il narratore prende in esame la natura diversa delle poche tracce ritrovate: la scrittura romanzesca trae la sua dinamicità da questa eterogeneità. Il titoletto del capitolo secondo, ‘Firenze 1996. DI RICORDI E RESTAURI’, esplicita e commenta il metodo. L’autore valuta l’efficacia della memoria, la sua memoria personale e quella collettiva; è consapevole delle lacune oggettive: “Mi manca un’intera generazione”, “di lui [il padre] non c’è una lettera, un appunto, tanto meno un diario” (Van Straten 2000, 21); capisce l’irreparabile (le domande che non è riuscito a fare a suo padre); riconosce gli errori (le indicazioni genealogiche erronee che gli sono state trasmesse per via di un’omonimia). Le poche tracce reperibili – gli oggetti rimasti, le fotografie, i dati conservati sotto forma scritta (lettere) o orale (aneddoti) – diventano i materiali della ricostruzione a partire dai quali la fantasia si mette in moto. Proliferano le metafore, spesso di matrice dantesca, per evocare la situazione iniziale (la foresta) e il processo di cognizione (il viaggio, il percorso, il sentiero). Più personale e più artistica è invece la metafora del restauro che descrive una tecnica di scrittura simile a quella adoperata per le opere pittoriche, e già applicata alla musica da Luciano Berio quando, per comporre Rendering (1989), egli aveva utilizzato e completato i primi materiali lasciati da Schubert per una sinfonia n. 10 mai realizzata. Ma se la traccia, per Berio, era servita in senso positivo a segnalare l’impulso creativo ricevuto da un grande modello, nella scrittura di Van Straten essa manifesta la carenza trasmessa dal passato al presente. Ritorna, in modo insistente, il paragone tra il testo e il polittico ed è spesso evocata la decisione che deve prendere il restauratore davanti alle lacune: stendere uno strato bianco con il quale è segnalata e accettata la mancanza oppure ricostruire gli elementi mancanti come sono esistiti (riprodurre grazie al sapere storico) o come forse sarebbero esistiti (inventare in base alla fantasia). In entrambi i casi comunque, la ricerca costituisce per Van Straten un’esperienza vitale: E se quando ho iniziato sapevo ancora distinguere ciò che era vero da ciò che era semplicemente verosimile, ciò che era mio e ciò che era delle persone di cui parlavo, adesso questa chiarezza non l’ho più. Le cose si vanno confondendo e mescolando, si sovrappongono fino a confluire in un quadro che, per fortuna, sta assumendo la prospettiva e la profondità della vita. (Van Straten 2000, 117) 121
Il raccontare produce il piacere inaspettato della scoperta: quando nella vicenda professionale di Henry Goldstück, il piccolo orologiaio che viveva in Lettonia nel 1878, viene ritrovata l’origine dell’orologio d’oro che l’autore ricevette dal nonno come regalo di nascita. Porta alla frustrazione del frammentario e allo strazio dell’esilio quando le tracce di Isaac o di Emmanuele svaniscono dopo il 1811. Sbocca, inevitabilmente, sulla perdita irrimediabile dei parenti assassinati durante la Shoah, come Betsy denunciata da una donna in un tram di Amsterdam nel 1943. Appare allora che il romanzo non può mantenere la doppia logica di interpunzione narrativa che lo aveva finora sorretto: l’organizzazione a capitoli separati delle storie dei diversi membri della famiglia, connesse tuttavia da una logica quasi cronologica e l’inserimento di capitoli ‘fiorentini’ in cui erano commentate le condizioni della scrittura. Difatti, man mano che il racconto procede e che le tracce si accumulano, quando dunque la memoria trova o quando la fantasia crea punti di appoggio, l’incompletezza diventa, per via della sempre maggiore permeabilità dell’io‐autore agli Altri, sempre più intollerabile. Quello che tra il 1942 e il 1945 è avvenuto a molti dei Van Straten impone la cessazione della forma romanzo. Il capitolo 31, ‘Europa 1945. QUESTI SONO I NOMI’ è un elenco: i nomi, l’età, la data della morte. Il ritegno della scrittura affida a questo elenco – come alla lista dei nomi recitata ogni anno nel giorno di Yom ha‐Shoah dai superstiti o dai discendenti dei deportati – il dovere sacro di fare, nella memoria e nel dire, esistere i morti. Così, i vivi affermano il loro legame di vita con i morti. Si palesa allora che lo sfaccettarsi del nome in un vasto gioco di variazioni, attraverso la diversità dei paesi (Olanda, America, Lettonia, Inghilterra, Svizzera, Brasile, Georgia…), delle epoche (dal 1811 al 1996, per sei generazioni), delle condizioni sociali e culturali (dal venditore di cetrioli all’orologiaio o al proprietario di una ditta internazionale di controllo delle granaglie), delle situazioni politiche infine (il periodo napoleonico, la rivoluzione russa, lo stalinismo, il fascismo italiano e il nazismo) era, a partire dal comune ceppo indicato dal cognome, moltiplicazione e conservazione dell’io stesso. L’io autore‐narratore deve quindi cambiare le modalità del suo intervento: “Voglio fare ciò che ogni uomo ha, una volta o l’altra, sognato: entrare nel quadro […]” (Van Straten 2000, 284), afferma Giorgio van Straten. Ciò significa assumere anche per se stesso l’invenzione, il travolgimento delle temporalità e degli spazi: diventare, prima della propria nascita, il personaggio‐testimone del viaggio del padre e del nonno, nel capitolo 33 ove finisce il racconto. Giorgio van Straten, con una sola ‘a’, da quando nel 1906 il nome di George Henry van Straten venne scritto sulla partecipazione di matrimonio con una sola ‘a’, trova ormai il suo posto nella parentela. La riproduzione dell’albero genealogico sui piatti interni della quarta di copertina costituisce solo provvisoriamente un paratesto editoriale che aiuta il lettore a seguire le ramificazioni della famiglia: vale, anzitutto, in quanto approdo simbolico. Lo scrittore e la scrittura hanno ormai adempito la loro missione. Raccontando, Giorgio van Straten ha capito il proprio padre. Raccontando, l’io scrivente e vivo ha riassunto nel proprio nome il destino di tutta la sua stirpe, ha seppellito i morti senza sepoltura, facendoli rivivere in una voce unica e collettiva: 122
Io sono tutte le storie che ho raccontato: non la somma di ogni destino, il risultato necessario o la linea di arrivo. […] Io sono le storie che ho raccontato, il lento cammino di un nome. Uomini e donne che non ho conosciuto. […] Ognuno di loro è entrato dentro di me e minaccia di restarci, come se raccontare una storia non fosse una liberazione, ma la sottoscrizione di un patto con tutti coloro di cui si è parlato. / Ora so che non devo dimenticare, che devo tenere il mio nome a memoria. / Ho recitato la mia genealogia, come fosse la preghiera di un non religioso, come se fosse un impegno preso: ho tradito e mentito, ma sono arrivato alla fine. (Van Straten 2000, 294) Lo zakhor biblico si è laicizzato: esprime la judéité. Nel romanzo di Giorgio Pressburger, il raccontare si origina diversamente; è presentato sin dal primo capitolo come il bilancio di un’esistenza: Ormai ‘uomo fatto’, e dopo aver sperimentato l’amarezza della solitudine tra stranieri, le difficoltà di trovare un indirizzo nella vita, la crudezza della lotta per l’esistenza, gli stenti, la miseria, l’insuperabile bellezza del paese che mi aveva accolto, e anche i grandi attestati d’amicizia, potevo finalmente ritornare sul ‘caso Heine’. (Pressburger 2003, 13‐14) Il libro è difatti teso tra i due volti opposti del principe dal nome “Israele” cantato da Heine, nella poesia tradotta da Pressburger, ‘La principessa Sabbath’: il cane errante “sbeffeggiato dai ragazzacci” e “l’Uomo con tratti umani, con il capo e il cuore in alto” (Pressburger 2003, 16). La mossa della scrittura avviene mentre Pressburger, aiutando il figlio a prepararsi per l’esame di maturità, specie in filosofia, si imbatte nel cognome della madre di Marx: Henriett Pressburg. A partire dal nome, l’“ossessione genealogica” definisce l’asse che struttura la scrittura e traccia il principio di sviluppo delle azioni: Nelle diramazioni della mia famiglia ci sono anche altri indizi di connessioni. Cercherò di parlare anche di queste. La mia odierna ossessione genealogica non mi permette di parlare d’altro. (Pressburger 2003, 3) Le “diramazioni” legittimano tutte le invenzioni romanzesche in termini di spostamenti geografici (Germania, Francia, Slovacchia, Ungheria, Russia, Italia, America, Australia, Sudafrica, Cina…), scarti di temporalità (tra Ottocento e Novecento soprattutto ma anche, per allusioni, in un più lontano passato), diversità sociologica e culturale dei personaggi: un rabbino, un ferroviere, un metalmeccanico, un giocatore di poker morfinomane, un professore… Così si delinea la diversità della condizione degli Ebrei in Europa centrale dentro alla comunità askenazita. Ma questi dati narrativi che creano ‘effetti di realtà’ a livello della storia narrata illustrano, più profondamente, le ferite e le interrogazioni personali dello scrittore. La perdita irreparabile è, evidentemente, quella creata dalla Shoah. Sono segni narrativi strutturali o linguistici, apparentemente minuti e in realtà solo smorzati dal pudore, ad urlare il dolore. Aprire il racconto con l’evocazione di Heinrich Heine equivale a 123
dichiarare tuttora aperta, per un uomo di cultura e malgrado tutte le spiegazioni economiche o politiche o storiche allegate, la questione di capire come la Germania, la grande Germania dei poeti e dei musicisti, fu capace di concepire la soluzione finale. Discostarsi dalle denominazioni stabilite dagli storici evocando i nonni “morti, secondo una relazione inviata dalla Croce Rossa Internazionale al termine della Seconda guerra mondiale, poco più che settantenni, nel campo di sterminio di Bergen‐Belsen in Germania” (121) – Pressburger scrive sterminio invece di concentramento5 – manifesta che, per i discendenti, la perdita degli antenati non si iscrive nella modulazione delle categorie storiche bensì in un globale tormento. E, pudicamente, la riflessione sulla distinzione bestia/uomo, la questione dell’espèce humaine (mutuo evidentemente l’espressione di Robert Antelme) che il Nazismo tentò di distruggere, si annida nella bellissima storia di Zigano, il cagnolino fedele che incarna l’umanità dell’amore di fronte alla bestialità della signora Finster, delatrice e assassina per cupidigia. Si rivela allora la logica che presiede all’invenzione delle trame e alla tipologia dei personaggi. Pressburger intende evocare la situazione degli Ebrei e le forme della persecuzione in fasi della Storia e sotto regimi politici diversi, in Ungheria (la storia dello zio Gustavo) e in tutta la Mitteleuropa; illustra i grandi dibattiti e le rotture dentro alla cultura ebraica: il dissidio tra amore di Dio e amore terreno (ne ‘La leggenda del rabbino di Cifer’), l’antisemitismo ebreo e la corruzione della sete di giustizia (l’odio di sé in Marx), l’attaccamento ai valori tradizionali e le sirene del materialismo (‘L’anima’), il rapporto tra ideologia e morale (‘Il ferroviere scultore’). Sono convocati grandi e piccoli antenati, o antenati immaginari, senza la minima distinzione di importanza tra di loro in modo da comporre un’unica comunità dei vivi e dei morti. A quel punto però, Pressburger prova a nascondere la pulsione familiare del romanzo genealogico, quella più dolorosamente patita, dietro una disposizione generale alla scrittura: Immaginare dialoghi con grandi personaggi era la mia mania, dieci anni fa. Ne ho riempiti interi quaderni. Li ho bruciati quasi tutti. Alcuni li ho gettati nello scarico del gabinetto. (Pressburger 2003, 25) Ma se, in un genere letterario come il dialogo, si giustificano il giudizio e il rifiuto, nell’operazione di memoria invece, la materia che si impone non consente nessuna cancellazione. Storie e personaggi inventati rinnovano il dolore ben reale dell’esilio e del lutto sicché la formalizzazione letteraria rimane indispensabile per mettere a distanza una rivisitazione del passato che altrimenti sarebbe insopportabile. L’io narrante è fortemente implicato nella materia narrata. Il legame esistenziale si manifesta e si espande nelle forme varie di apparizione della parentela nel racconto e nella costante attività scrittoria o interlocutoria dell’io: sono, al di là dei legami di parentela, le ‘connessioni’ evocate da Pressburger ossia le diverse modalità dell’avvio alla trasmissione delle storie (Pressburger 2003, 3; 89; 92). Ricostruire la comunità significa raccontare in prima persona la propria ‘storia’ (15; 60), dialogare (26‐27), 124
comunicare una ‘leggenda’ durante una ‘conferenza’, poi durante una ‘conversazione’ e infine ‘ripetere quel racconto’ (31). La connessione si è estesa: è ormai intra‐ ed extra‐diegetica, tenta di includere il lettore nella comunità costituita dai personaggi, dai narratori e dall’autore e fonda così, in una specie di macchina associativa e creativa, corrispondenze tra storie inventate e problematiche personali: la tensione tra contemplazione e azione (IX), la forza dispersiva della pulsione amorosa (VI, X), l’esitazione tra il materialismo dell’uomo nuovo e una fedele spiritualità (X), il rapporto tra vita terrena e fede. Riprendendo possesso del passato e organizzando la trasmissione, l’io narrante si rivela a se stesso ma il dolore della perdita non si sopisce (appare emblematica l’iscrizione del nome del fedele cane Zigano nel volume degli antenati). L’ULTIMO DELLA STIRPE E LA FINE DELLO SCRIVERE Quando e come terminare il racconto? In questa fase dell’explicit l’io narrante del romanzo genealogico subisce, dal punto di vista scritturale, alcune delle costrizioni legate all’autobiografia e opposte alla libertà del romanzo, come spiega Serge Doubrovsky: Je n’avais qu’à écrire un roman, comme tout le monde. Un roman, on est maître de le terminer à sa guise […] Si l’on décide d’écrire sa vie, la vie décide de ce qu’on écrit. L’enchaînement des épisodes, suite et fin, le récit ne nous appartient plus […] Une histoire peut rester en suspens; pas un livre, il lui faut début, milieu et fin.6 Il libro di Giorgio van Straten termina con un’affermazione autobiografica in cui echeggia questa tensione tra romanzo e autobiografia. La nascita del libro corrisponde alla morte del padre, la fine del libro coincide con il momento in cui il ‘pegno’ del nome e la vertiginosa riesumazione dei morti della diaspora possono e devono lasciare il posto al contatto attivo con la realtà circostante. La scrittura di memoria e di invenzione ha adempito il proprio compito e deve tacere: Rappresento, nella sesta generazione dei van Straten, l’ultimo che conservi ancora il nome scelto da Hartog Alexander quasi due secoli fa a Rotterdam: è giusto che ne abbia narrato il percorso. […] Per concludere la genealogia: io sono nato il 6 luglio 1955, ed è allora che, come ho già detto, ho ricevuto in regalo l’orologio di Benjamin, anch’esso pegno per il nome che porto. […] Anch’io ho riesumato i miei morti, molti dei quali sepolti non so dove. Li ho contati, ma più li contavo e più crescevano di numero. Bisogna sempre fermarsi, a un certo momento. I confini non si vedono, ma vanno tracciati nella mente, perché se non lo facessimo il mondo ci sfuggirebbe di mano. (Van Straten 2000, 294‐295) Il dovere di memoria e l’autodefinizione di sé, la scrittura insomma, sono congedati in una pacata affermazione di vita: si effettua il ritorno al mondo. 125
La fine del romanzo di Pressburger è molto più inquieta. Le interrogazioni sugli antenati hanno corrisposto, dentro alla cornice storica, a quello che il narratore definiva “altri indizi di connessioni”: le interrogazioni personali si sono approfondite, e non pacate, nell’esame e nell’invenzione della genealogia. La ferita rimane aperta e la fine del racconto può avvenire solo con un espediente narrativo che ricollega e distrugge la genealogia insieme, in corrispondenza con quel peso schiacciante che grava sull’ultimo discendente di una lunga stirpe travolta dalla Storia – il tema è ovviamente ricorrente nella narrativa legata alla memoria della Shoah: si ripensi al giovane ebreo in Mendels erfenis di Marcel Möring (1990) o a Nathan Hollander nel già citato In Babylon –. L’espediente, insieme funzionale nella narrazione e simbolico, è un oggetto, quasi un feticcio, che vale da punto di appoggio per ricostruire i silenzi di un passato muto: ‘l’orologio di Monaco’, che dà il suo titolo all’ultimo racconto del narratore e al libro. Questo capitolo 12, in maniera molto significativa ed unica nell’architettura del libro, incomincia con un appello diretto al lettore, destinato a rompere la solita comunità sociologica e letteraria per instaurare una comunanza solo familiare e personale: Non pensate al famoso orologio del municipio di Monaco di Baviera […] L’orologio di Monaco è per me un altro: uno strano oggetto domestico, legato alla morte della mia ultima parente […]. (Pressburger 2003, 163) È rilevante notare che, a sostegno di questa dimensione intima, ricorre nei tre romanzi genealogici presi in esame (In Babylon, Il mio nome a memoria e L’orologio di Monaco) lo stesso simbolo della trasmissione familiare – tale funzione dell’oggetto, e dell’oggetto ‘orologio’, potrebbe certo dare l’avvio ad una più approfondita analisi –. Limitando comunque in questa sede le considerazioni al romanzo di Pressburger, si costata che il legame genealogico è, contemporaneamente, stabilito e distrutto. I sei orologi comprati dalla zia di Budapest per essere, oltre a quello conservato da lei, regalati ai suoi cinque nipoti, tra cui il narratore, sono sparsi sui cinque continenti: e il valore simbolico della geografia è completato dal significato umano e cosmico delle quattro palline dorate (i temperamenti o gli elementi) che si muovono sull’orologio a materializzare l’unità delle generazioni e della diaspora. Il giorno della morte della zia, il narratore scopre l’orologio fermo: il congegno e il corpo umano si sono bloccati nello stesso momento. Fragile, il legame permane fino al momento in cui il narratore viene a sapere che il cugino emigrato a Johannesburg ha buttato da tempo il ‘suo’ orologio nella cassa della spazzatura. Il narratore approfondisce allora il simbolo: nei quattro orologi rimasti, i quattro globi si sono fermati così come, simultaneamente, è avvenuto nell’orologio, che però cammina ancora, della zia. Il tempo continua a scorrere ma la continuità genealogica si è infranta. L’ultimo capitolo, il 13, manifesta la rottura: prende brutalmente la parola un altro ‘io’ (“Ho deciso di scrivere un resoconto della mia vita” (177)). È, “nel terzo millennio”, la voce narrante del discendente, Andrea Pressburger, “il ramo secco della famiglia” che afferma: 126
“Questa è la mia conclusione. Non avrò eredi. Non è una tragedia” (199). Giorgio Pressburger riprende infine la parola in un breve explicit: Il romanzo della mia mania genealogica è definitivamente naufragato con la presente, estesa testimonianza della penultima generazione della famiglia. La tenacia della vita appare più fragile e l’Io teme di essere ridotto “a un punto, cioè a un essere senza dimensioni nel tempo e nello spazio”. Trionfa simbolicamente la logica di annientamento che gli Ebrei hanno, fisicamente, subito nella Storia. Nessuna definizione complessiva può (né deve) essere proposta al provvisorio termine dell’analisi: il genere o sottogenere esaminato, il cosiddetto ‘romanzo genealogico’ si caratterizza dal comune intento di ancorare l’Io nella storia familiare e nella Storia collettiva, ridando con il Verbo l’esistenza agli antenati spariti nella diaspora, seppellendo nel libro i morti senza sepoltura della Shoah. Si sviluppa dentro a una grande varietà formale, di memorialistica o di invenzione. Approda però ad esiti diversamente risolutivi in cui si sente il peso dei destini individuali degli scrittori: vita e scrittura sono indissolubilmente legati.
NOTE Intendo lasciare questo termine in francese, non trovando in italiano nessuna parola equivalente, e citare la quasi definizione che, senza però tentare di nominare, ne propone Giorgio van Straten: “In famiglia quindi l’essere ebrei era diventato un modo di sentire che non aveva quasi niente a che fare con la religiosità. Un’identità che prescindeva dalla fede ma restava salda e sicura” (Van Straten 2000, 109). Significa insomma concepire la judeité come comune patrimonio familiare, tradizionale, culturale ed etico, al di fuori di ogni consenso religioso. 1
Si noti l’apparizione della denominazione nel saggio di De Ribaupierre 2002. 2
Robert 1972, 15. 3
Grilli, 2001. Traduzione DB: “Gli alberi hanno radici. Gli Ebrei hanno gambe”. 4
Si sa che gli storici del Nazismo – si veda, tra gli altri, François Bedarida – operano una distinzione tra i campi di concentramento (come Dachau, Buchenwald e Bergen‐Belsen, anche detti “campi della morte lenta”, organizzati sul territorio tedesco sin dal 1933), i campi di sterminio (come Sobibor e Treblinka, tutti situati sul territorio della Polonia del 1939 e che funzionarono dal 1941 al 1944) e i campi misti come Auschwitz‐Birkenau e Lublin‐Maidanek (dapprima campi di concentramento ma che furono poi su larga scala trasformati in impianti di sterminio, con forni crematori e camere a gas). 5
Doubrovsky 1989, 317: “Dovevo solo scrivere un romanzo, come lo fanno tutti. Un romanzo, ognuno lo può terminare a modo suo […] Ma se uno decide di scrivere la propria vita, è la vita a decidere ciò che si scrive. La concatenazione degli episodi, seguito e fine, il racconto non ci appartiene più […] Una storia può rimanere sospesa; un libro, no: gli servono inizio, metà e fine” (trad. DB). 6
127
BIBLIOGRAFIA ‘Antico Testamento’, ‘Pentateuco’, ‘Esodo’. Citato a partire da La Bible de Jérusalem. Paris: Éditions du Cerf, 1956. Bedarida, François. Le Nazisme et le génocide. Paris: Nathan, 1989. De Ribaupierre, Claire. Le roman généalogique – Claude Simon et Georges Perec. Bruxelles: La Part de l’Œil, 2002. Doubrovsky, Serge. Le livre brisé. Paris: Grasset, 1989. Jarre, Marina. Ritorno in Lettonia. Torino: Einaudi, 2003. Loewenthal, Elena. Lo strappo nell’anima. Milano: Frassinelli, 2002. Möring, Marcel. Mendels erfenis. Amsterdam: Meulenhoff, 1990. ‐‐‐. In Babylon. Amsterdam: Meulenhoff, 1997. Citato a partire dalla traduzione in francese di Patrick Grilli: La fabuleuse histoire des Hollander. Paris: Flammarion, 2001. Perec, Georges. W ou le souvenir d’enfance. Paris: Denoël, 1975. Pressburger, Giorgio. L’orologio di Monaco. Torino: Einaudi, 2003. Robert, Marthe. Roman des origines et origines du roman. Paris: Grasset, 1972. Riproduzione anastatica. Paris: Gallimard,1995. Van Straten, Giorgio. Il mio nome a memoria. Milano: Mondadori, 2000. ‐‐‐. L’impegno spaesato (Decalogo di un uomo di Sinistra). Roma: Editori riuniti, 2002. 128
QUERCIOLI MINCER, Laura. ‘Romanzi della seconda generazione dopo la Shoah: strategie del ritorno fra memoria ed oblio. Lezioni di tenebra di Helena Janeczek e Lo zio Coso di Alessandro Schwed’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 129‐136. RIASSUNTO La ‘lotta con l’angelo’ della memoria della Shoah trova espressione in due romanzi italiani: Lezioni di tenebra (1997) di Helena Janeczek, e Lo zio Coso (2005) di Alessandro Schwed. I due testi offrono la possibilità di interessanti paralleli e confronti. Analoga è la posizione decentrata di entrambi gli autori rispetto al canone letterario italiano: tedesca, figlia di ebrei polacchi Janeczek, figlio di ebrei ungheresi Schwed. Per entrambi gli autori la discesa verso l’abisso della Shoah sperimentato dai genitori si traduce in un viaggio: Auschwitz per Janeczek, l’Ungheria per Schwed. Ma mentre per la donna il viaggio, compiuto insieme alla madre, porta a una pur dolorosa presa di coscienza e di responsabilità nei confronti della storia ebraica, a un approfondimento dei rapporti fra le due donne e addirittura alla scoperta di un terzo personaggio femminile finora celato, per Schwed il ritorno in Ungheria, che si articola attraverso incontri e reminiscenze confuse di tre ambigui personaggi maschili, porta a una paradossale e atroce caduta nell’oblio, in cui l’io narrante perde addirittura le caratteristiche individuali e finisce per confondersi con l’ambiente circostante. In questi percorsi si può leggere un ribaltamento delle concezioni di genere sulla percezione della storia ‘delle donne’ e ‘degli uomini’ come indicata da Julia Kristeva, che definisce ‘ciclico’ il tempo delle donne, distinguendolo da quello teleologico e prospettico in cui gli uomini si identificano: qui spetta proprio al romanzo femminile la presa di coscienza razionale, e a quello maschile la percezione cosmica della ciclicità del passato e la paura della ‘perdita delle tenerezza’. “Se il passato scompare” – ha detto Schwed, – “scompare il legame di tenerezza che ci univa alla generazione precedente mentre ci narrava della sua vita”. PAROLE CHIAVE Shoah, memoria, oblio, silenzio,viaggio © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 129
ROMANZI DELLA SECONDA GENERAZIONE DOPO LA SHOAH STRATEGIE DEL RITORNO FRA MEMORIA ED OBLIO LEZIONI DI TENEBRA DI HELENA JANECZEK E LO ZIO COSO DI ALESSANDRO SCHWED Laura Quercioli Mincer Università di Roma “La Sapienza” Una leggenda ebraica racconta che durante i nove mesi di gestazione un angelo insegna al feto tutta la Torà. Prima della nascita, lo stesso angelo colpisce lievemente il bambino sul labbro superiore, imprimendovi una fossetta: con questo gesto il bambino ha dimenticato tutto, e può iniziare il suo percorso sulla terra. Dunque per poter tutto imparare, o anche semplicemente per iniziare a vivere, è prima necessario poter tutto dimenticare. E’ singolare come all’interno di una tradizione, quella ebraica, che si vuole basata sul comandamento stereotipo del Zakhor, ricorda! ad ogni costo, esista anche questa lode dell’oblio. Un oblio che rimane però inciso sul nostro corpo, a sua perenne memoria, nello spazio che divide il naso dalle labbra. Il rapporto contraddittorio o sinergico fra oblio e memoria e fra memoria e identità individuale è uno dei temi ricorrenti della letteratura delle generazioni venute dopo la Shoah. Il romanzo La storia dell’amore della giovane statunitense Nicole Krauss (pubblicato in Italia nel 2005) porta la dedica: “Per i miei nonni ‒ che mi hanno insegnato il contrario di scomparire e le loro foto da ragazzi”. I figli dei sopravvissuti hanno però raramente avuto la fortuna di poter attingere alle memorie dei nonni nella propria costruzione del Sé. La Shoah ha spezzato la catena delle generazioni, i figli si trovano con un terreno straordinariamente friabile sotto i piedi, e per evitare di scomparire devono aggrapparsi ai brandelli di passato trasmessi dai genitori. Divisi fra l’eccesso di memoria del discorso pubblico e l’assenza o la frammentarietà della narrazione familiare, ai figli spetta la responsabilità di traghettare la generazione precedente al di fuori della schiavitù egizia di un passato troppo terribile per essere elaborato. Un tragitto possibile forse solo con la mediazione di almeno una parte di oblio: un oblio, che, come ha ricordato Alberto Cavaglion, opposto all’amnesia e al vuoto di memoria, ha una forte valenza lenitiva ed etica.1 Queste problematiche scorrono più o meno sotterranee nelle pagine di due romanzi para autobiografici, descrizioni di un percorso interiore e materiale. Si tratta di Lezioni di tenebra (di Helena Janeczek, classe 1964, pubblicato nel 1997) e di Lo zio Coso, pubblicato nel 2005, di Alessandro Schwed, di una decina d’anni più anziano di Janeczek, testi che, diversi per convenzione letteraria e intenzioni dell’autore, presentano però una singolare specularità, a riprova ulteriore dell’esistenza di una 130
koiné narrativa ebraica anche – o forse in particolare – per quanto riguarda la letteratura delle generazioni successive alla Shoah. I due autori sono uniti anche da affinità biografiche, affinità tutto sommato bizzarre in un paese, come l’Italia, che solo da poco si è aperto agli influssi delle culture straniere. Janeczek infatti è nata in Germania, dove ha vissuto fino ai vent’anni, da genitori ebrei polacchi; si è quindi trasferita in Italia. Lezioni di tenebra è il suo primo romanzo, scritto in italiano. Alessandro Schwed è nato a Firenze da padre ungherese ed ha alle spalle un complicato percorso di appartenenze politiche ed esistenziali (fra l’altro, con lo pseudonimo di Giga Melik, è stato celeberrimo autore satirico di quella che allora veniva chiamata la sinistra extraparlamentare).2 In nessuna delle famiglie la lingua d’origine (il polacco e l’ungherese) è stata tramandata ai figli, contribuendo ad approfondire la distanza – comunque incolmabile, insondabile – fra le due generazioni e i due mondi: prima e dopo lo sterminio. Plurime appartenenze anche linguistiche e suoni di parlate al contempo sconosciute e familiari si trovano dunque in entrambi i testi, costruiti su diverse triangolazioni: Italia‐Germania‐Polonia per Janeczek, Italia‐
Ungheria‐Israele per Schwed. Cosa significa ricordare: su questa questione si aprono i due romanzi. Quello di Janeczek inizia con l’apparizione televisiva di “una tizia che sosteneva di essere la reincarnazione di una ragazza ebrea uccisa in campo di sterminio” (1997, 9); il romanzo di Schwed, introdotto da un verso del celebre Salmo 136 (Se mi dimenticassi di te, o Gerusalemme…) esordisce con la notizia che “poi la Seconda guerra mondiale non si è svolta” (2005, 9). Dunque la mistificazione del passato oppure, nello stile grottesco‐iperbolico di Schwed, la sua totale cancellazione. Forse anche perchè almeno un poco ‘stranieri’, forse anche perchè l’esperienza del mondo e il contatto con i genitori sono stati mediati da lingue non avvertite interamente come proprie (Janeczek sostiene essere la sua lingua madre il polacco: “ho una lingua madre che non conosco e come ciò sia possibile vallo un po’ a spiegare a qualcuno” (Janeczek 1997, 76), si pone in questi testi la questione di se – e come – sia possibile una trasmissione di memorie che prescinda dalle parole: Io, già da un pezzo, – scrive Janeczek nelle prime pagine del romanzo – vorrei sapere un’altra cosa. Vorrei sapere se è possibile trasmettere conoscenze e esperienze non con il latte materno, ma ancora prima, attraverso le acque della placenta o non so come, perché il latte di mia madre non l’ho avuto e ho invece una fame atavica, una fame da morti di fame, che lei non ha più. (10) Ma la questione si pone innanzitutto perché, come molti sopravvissuti, anche i genitori, la madre di Janeczek e il padre di Schwed, i veri protagonisti di questi romanzi, oggetto da pare dei figli di un amore appassionato e quasi morboso, hanno entrambi scelto di tacere. Una scelta, com’è noto, comune, da alcuni eletta a opzione di sopravvivenza: “Mio fratello ha inventato l’assassinio/i miei genitori il 131
pianto/ io il silenzio” ha scritto nella poesia ‘Autobiografia’ il poeta rumeno Dan Pagis, deportato in Transnistria all’età di 11 anni. Sono grata ai miei di avermi risparmiato le loro reminiscenze, ‐ scrive Janeczek ‐ penso che abbiano fatto bene a tacere. Credo che abbiano taciuto per dimenticare o almeno non risvegliare i ricordi e anche per non assillare me, per farmi crescere come una ragazzina normale. (101) e subito dopo aggiunge: “penso che mi basti sapere quanto so. […] Dal canto mio non ho mai chiesto niente” (101‐102). “Fin dall’inizio non ci eravamo mai parlati, ma ci eravamo amati da spezzare il respiro” (152), scrive Schwed del padre. Un padre il cui silenzio non è dettato solo dal desiderio di proteggere la famiglia, ma è anche il risultato dell’oltraggio subito: Il fatto è che in mio zio e mio padre sono state deformate le vertebre della memoria. La loro anatomia più naturale è il corpo informe del silenzio. (93‐94) La più altera scelta del silenzio della madre di Janeczek sembra nascere invece “dal presupposto che la comprensione sia preclusa anche a sua figlia” (129) e contribuisce a far sì che alla figlia sia impossibile qualsiasi immedesimazione e addirittura raffigurazione del suo passato: È vero: io non ho nessuna idea di come e cosa fosse mia madre fra il 1939 e il 1945. Non posso nemmeno fare finta di conoscerla, mia madre, come credo si faccia comunemente con i propri genitori. Non riesco più di tanto a rendere reale la sua storia, almeno a seguirla come quella di un personaggio letterario. […] E’ tutto così lontano, nel tempo e nello spazio, così privo di un legame evidente con me che non possiedo nemmeno la lingua che lei parlava allora. Mi rendo conto che dev’essere arduo per molti figurarsi la giovinezza dei propri genitori […]. Ma nonostante tutto non credo che si avverta la stessa frattura, la stessa irreparabile separazione da un punto di partenza o di passaggio. Nel caso mio invece c’è un azzeramento: posso anche leggere l’intera biblioteca sullo sterminio […] ma non per questo riesco a riportare dentro di me mia madre e mio padre a un’unità di persone, fosse anche la più precaria. (130) È proprio su questo azzeramento e sull’incommensurabile precarietà delle raffigurazioni del passato di questi genitori che si costruisce il tragi‐comico romanzo di Schwed. Il silenzio, l’afasia protettiva che circonda i figli in realtà ne aumenta la confusione e il disorientamento, il senso angosciante di irrealtà, approfondisce la distanza fra le generazioni: L’impalpabile ricostruzione delle vite di mio zio e di mio padre, questa difficoltà a rimettere insieme le verità, tutto rimonta al dominio del silenzio su di loro, e attraverso loro, su di me. Si allungano le ombre dei discorsi mancati, ombre smisurate che mi traversano il presente, lunghissime ombre che rimarranno con me sino a quando saremo tutt’uno con il buio. (93) 132
È ai figli che spetta il compito di trovare le parole che la generazione precedente ha smarrito e il modo di comunicarle per potersene, infine, liberare. La psicologa italo‐israeliana Dina Wardi ha definito questi figli “Le candele della memoria” e in un celebre libro ne ha descritto le ansie e i problemi; gli stessi che troviamo nelle testimonianze letterarie. Poiché i processi naturali che assicurano la continuità fra le generazioni sono stati troncati, la seconda generazione ha insieme il privilegio e il dovere di rappresentare l’anello di congiunzione che guarisce il trauma del taglio e colma le smisurate aspettative dei genitori: e forse non solo di questi ultimi ma, in certa misura, quelle dell’intero popolo ebraico.3 Si è detto che questi due romanzi descrivono un percorso sia interiore che materiale, concreto. L’immersione nel pozzo del passato, ovvero la ricostruzione, con sbalzi di tempo e di spazio, della propria infanzia e delle memorie famigliari, operata, secondo la definizione di Michał Głowiński, con i “frammenti, ritagli, rimasugli”4 che i genitori hanno salvato dalla loro vita precedente la catastrofe, trova infatti riscontro in entrambi romanzi in uno dei cronotopi letterari più importanti e diffusi, il viaggio. In Polonia, ad Auschwitz e nella cittadina natale della madre per Janeczek, in un’Ungheria boschiva e non meglio identificata per Schwed – è il viaggio il momento in cui i figli verificano la propria capacità di autocreazione e di far fronte alle aspettative implicite dei genitori e del mondo. In Lezione di tenebra Janeczek descrive “l’intensità del contraccolpo” (copertina) lasciatole dalla Shoah e la sua difficoltà di relazionarsi: con la madre anzitutto, ma anche con la Germania e con il tedesco, con gli altri ebrei e con una Polonia lontana e un po’ mitica, aspra e deludente al contatto. Al viaggio ad Auschwitz, con la madre e un gruppo di ex deportati, è dedicata l’ultima parte del libro. Solo poche pagine ma così intense da imporre, forse a dispetto delle intenzioni dell’autrice, una sorta di carattere teleologico all’intero romanzo. Al ritorno da Auschwitz, sostiene l’autrice, “non è cambiato niente, o poco” (Janeczek 1997, 189). Ma la scoperta di un frammento importante di passato che emerge proprio alla fine del libro lascia intendere una possibile catarsi. Opposte ma quasi combacianti erano state le strategie di contenimento della sofferenza delle due famiglie: per Janeczek, l’attenzione morbosa ai dettagli, al decoro, alla forma, corrispondente per alcuni versi all’ambigua scelta di risiedere in Germania; per Schwed, lo svaporare di concetti indefiniti, il baluginare di “asprezze e tenerezze così vaste da poter essere dette solo in quella trance narrativa che era la tavola apparecchiata delle nostre grandi feste ebraiche” (2005, 66). Ed è opposto il modo in cui i due figli si confrontano con il passato. In bizzarro contrasto con gli schemi delle teorie tradizionali di genere, è proprio la donna che riscopre la Storia la S maiuscola.5 Il viaggio di Helena ad Auschwitz, benché accompagnato da una paura crescente, è guidato dal desiderio razionalissimo di ricordare “quello che vedevo strada facendo, per capire dove 133
ero, per capire dove si trova quel luogo esattamente, per convincermi che è un posto in mezzo ad altri posti, nel mondo” (Janeczek 1997, 147). Schwed non arriva in nessun posto e in realtà in nessun posto è diretto, la sua Ungheria è uno spazio mitico, privo di coordinate materiali. La madre di Janeczek aveva intrapreso il viaggio in Polonia “non tanto per rivedere la sua casa e la casa di mio padre, e neanche per mostrarle a me, e ancora meno per confrontarsi con i luoghi dello sterminio” (167), bensì per visitare la tomba del nonno, la sola tomba che potesse visitare. Immaginiamo che alla famiglia Schwed non sia rimasta nessuna tomba, alcun luogo fisico da dedicare al lutto, che le sue tombe e le sue dimore siano d’aria. Lo zio Coso è la storia di un viaggio in treno verso questa lontana Ungheria, la terra della memoria. Alla morte del padre Ruah, vento o spirito in ebraico, il protagonista stravolto dal dolore decide di mettersi alla ricerca “dei segni della sua vita precedente” (Schwed 2005, 15) e del leggendario zio Coso, di cui ha dimenticato il nome, sorta di alter ego del padre. Lo zio Coso, che è allo stesso tempo una sorta di simbolo del popolo ebraico, come ha notato Aldo Zargani, oppure un’ulteriore incarnazione dell’ebreo errante, definito da Harold Fisch “sempre un personaggio in cerca d’autore”.6 Nel treno il protagonista‐narratore in prima persona si imbatte in un veterinario nazista, figura luciferina e grottesca che gli spiega con dovizia di dettagli come la seconda guerra mondiale non ci sia mai stata: si trattava in realtà di un gigantesco spettacolo teatrale, con attori pagati per impersonare i cadaveri; i genitori stessi del narratore, lo zio e addirittura il cane di famiglia non sarebbero altro che comparse al soldo dell’internazionale sionista, oppure pupazzi di gomma gonfiati da un rabbino con una pompa di bicicletta. Al termine di questa educazione alla rovescia il protagonista disimpara tutta la storia europea dai tempi di Cartagine. La notizia della cancellazione del passato è fulminante ma al tempo stesso piacevolmente “analgesica” (Schwed 2005, 76). È una notizia che non è solo metafora letteraria ma ha direttamente a che fare con la nostra quotidianità. In Italia – ha scritto Schwed nel 2006 in un articolo intitolato ‘Gli ebrei vittime dei peccati della sinistra’ andiamo verso sempre più dolorose evaporazioni, e a un tratto le nostre vite ricordano certi momenti dell’infanzia, quando per tutto il giorno si è costruito un castello di sabbia in riva al mare, e a sera è già disfatto e non ve n’è più traccia. Sul treno ungherese il protagonista riceve una botta in testa e, ridotto a una sorta di vegetale, privo di parole e di ricordi, viene gettato su una scarpata dal treno in corsa. La sua coscienza sprofonda nel caos primigenio, nel tohu vavohu che precede la creazione. Grazie a questo oblio emerge alla sua coscienza un kaddish sconvolgente per i morti ungheresi di Auschwitz, pagine e pagine di nomi con la data di nascita e di morte, e quindi gli oggetti, gli oggetti delle montagne di resti degli assassinati (“bambole bambole bambole calze bambole colletti calze 134
fazzoletti calze giacche fazzoletti” (Schwed 2005, 234)), e quindi, ma solo in seguito, brandelli di memorie dallo spessore di costruzioni identitarie: cibi, personaggi (“buster keaton giulio cesare spinosa” (235)), versi di Dante e della Bibbia ebraica. È la memoria collettiva, che paradossalmente il protagonista è in grado di recuperare solo grazie all’oblio del passato. Emersi dalle profondità ctonie del viaggio ad entrambi gli eroi spetta una ricompensa: la reintegrazione della propria storia. Nelle ultime pagine di Lezioni di tenebra, in quello che l’autrice ha definito “uno strano finalino a sorpresa”, si presenta imprevista alla memoria dell’io narrante la balia tedesca, cui la narratrice era stata affidata fino al compiere dei 16 anni e che era stata rimossa dalla afasica narrazione familiare. “Se il passato scompare” – ha detto Schwed – “scompare il legame di tenerezza che ci univa alla generazione precedente mentre ci narrava della sua vita”.7 E una strana, un’aspra tenerezza unisce improvvisamente la narratrice alla goffa, maldestra Cilly che “non mi ha nemmeno coccolato o vezzeggiato […], mi ha solo voluto bene” (Janeczek 1997, 202) e che ha conservato con struggente fedeltà i “disegni, quaderni, scarabocchi” della bambina. È su di lei che si chiude il romanzo. Convinto per diversi giorni di essere uno degli alberi che vedeva innalzarsi intorno a sé, Schwed‐narratore viene infine salvato da un ferroviere ungherese, Peppo Tristan, e da sua moglie. Tornato in Italia e ancora incerto su chi abbia vinto la seconda guerra mondiale, gli si presenta, inaspettato come Cilly, lo zio Coso, che ci eravamo già convinti essere un mero parto della sua fantasia. Posti davanti allo specchio, zio e nipote mostrano due immagini simili, entrambe bizzarramente sbilenche, che infine si confondono in una sola entità dove passato e presente, realtà e immaginazione, acquistano infine una almeno temporanea integrazione. Temporanea, perché la memoria è comunque una materia labile e precaria: Un’altra cosa è la roccia su cui poggia la storia di chi siamo; ‐ scrive Schwed ‐ un’altra la conchiglia a cui accostiamo l’orecchio per risentire l’onda delle parole originali. E un altro è il corno pastorale che suona in tutti i tempi per far udire il racconto di quanto è davvero accaduto. Il guaio è che in modo rocambolesco e sottile, la memoria vive ricomposta in un unico mondo, dove realtà e fantasia, sogno e invenzione, sono un’unica creta sfuggente. (Schwed 2005, 56) Il recupero, l’elaborazione, l’integrazione del passato sono dunque possibili nell’accettazione della fragilità della memoria e nel patto di rinnovata responsabilità verso ‘il racconto di quanto è davvero accaduto’. In questo patto, e in questa fragilità, sia la nitida narrazione razionalistica di Janeczek che la costruzione mistico‐grottesca di Schwed, lasciano socchiusa la porta a una difficile speranza. 135
NOTE Cavaglion 2006, 35. 1
In particolare nella rivista Il Male, una delle più importanti testate satiriche italiane (1978‐1982), di cui Schwed è stato, nelle sue parole, “in effetti protagonista, agitatore surrealista, promotore di happening e infine scrittore” (comunicazione personale dell’autore, 9.09.2006). 2
Wardi 1993, 6. 3
Glowinski 2004, 29: “[…] nella mia memoria di questo mondo assassinato non sono rimasti che frammenti, ritagli, rimasugli”. 4
Il tema dell’esclusione delle donne dalla storia e dal discorso pubblico sulla memoria è ricorrente in tutta la letteratura e critica femminista. Vedi ad esempio la scrittrice ebrea tedesca Ruth Kluger: “le guerre appartengono ai maschi […] le donne non hanno passato”, citata da Calabrese 2004, 108. 5
Fisch 1988, 96. 6
Durante la presentazione di Lo zio Coso al Centro Ebraico Italiano ‘Pitigliani’ di Roma, novembre 2005. 7
BIBLIOGRAFIA Baharier, Haim. La Genesi spiegata da mia figlia. Milano: Garzanti, 2006. Calabrese, Rita. ‘Dalla testimonianza alla letteratura. Memorie tedesche della Shoah negli anni Ottanta’. Oltre la persecuzione. Donne, ebraismo, memoria, a cura di Roberta Ascarelli. Roma: Carocci, 2004. 95-119. Cavaglion, Alberto. Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo: nuove riflessioni. Napoli: l’Ancora del Mediterraneo, 2006. Cometa, Michele. ‘Istantanee sulla dimenticanza. Su identità e memoria (anche ebraica)’. Dopo la Shoah. Nuove identità ebraiche nella letteratura, a cura di Rita Calabrese. Pisa: ETS, 2005. Fisch, Harold. Un futuro ricordato. Saggio sulla mitologia letteraria. Bologna: Il Mulino, 1988. Głowiński, Michał. Tempi bui. Un’infanzia braccata. Firenze: Giuntina, 2004. Janeczek, Melena. Lezioni di tenebra. Milano: Mondadori, 1997. Schwed, Alessandro. Lo zio Coso. Milano: Ponte alle Grazie, 2005. ‐‐‐. ‘Gli ebrei vittime dei peccati della sinistra’. Il Secolo XIX (2.3.2006). Wardi, Dina. Le “candele della memoria”. I figli dei sopravvissuti dell’Olocausto: traumi, angosce, terapia. Milano: Sansoni, 1993. 136
PRESSBURGER, Giorgio. ‘Budapest‐Roma. Realtà ebraica fuori della lingua’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 137 – 142. RIASSUNTO Gli ebrei ungheresi hanno avuto problemi di scelta della lingua in cui esprimersi: ungherese, yiddisch o tedesco. Quando alcuni di essi hanno poi lasciato la patria, il problema si ripresentava. Per gli ebrei ungheresi in Italia, paese col quale esistevano da quasi un millennio stretti rapporti, la lingua diventava spesso l’italiano. È il caso di Svevo, Vagliani, Bruck e Keményi, nonché dei fratelli Pressburger. Il cambiamento di lingua comporta varie metamorfosi. Per lo scrittore ebreo, ciò può avere esiti diversi tra i due poli di perdita o rafforzamento dell’identità. Diverso ancora è il ruolo della religione, talvolta, come in Kafka, mai discussa apertamente. Le cose mutano dopo la Shoah. Si accenna alle differenze interculturali tra cultura ashkenazy e cultura sefardita, nonché tra ebrei magiari e ebrei italiani. Si confrontano gli scrittori d’origine ungherese con gli scrittori italiani ebrei negli anni ‘20. PAROLE CHIAVE Ebrei ungheresi, emigrazione in Italia, scelta della lingua, fortuna di scrittori ungheresi in Italia © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 137
BUDAPEST‐ROMA REALTÀ EBRAICA FUORI DELLA LINGUA Giorgio Pressburger EBREI UNGHERESI: DA UNA LINGUA ESCLUSIVA ALL’ALTRA. LE DUE LINGUE. LA QUESTIONE DELLO YIDDISCH Gli ebrei ungheresi, da un punto di vista della comunicazione, hanno vissuto sempre doppiamente gravati dalla questione della lingua. Se da un lato, in quanto ungheresi, al di fuori del gruppo umano chiamato ‘ungheresi’, con quella lingua non potevano farsi capire da nessun altro membro di un altro popolo europeo, dall’altra parte, con l’uso della lingua ebraica (tranne gli ebrei dei paesi europei e quelli del Medio Oriente) nessuno era in grado di comunicare con loro. Terza aggravante: l’uso della lingua yiddisch, esclusività linguistica degli ebrei dell’Europa orientale, elaborata con l’uso del russo, del tedesco medievale e dell’ebraico. In Ungheria molti ebrei provenienti, all’inizio dell’Ottocento, dai paesi dove erano peggio trattati, parlavano lo yiddisch e, anche chi non lo parlava, uniformava la pronuncia ebraica a quella lingua in cui molte consonanti diventavano dittonghi, per esempio Isreal si pronunciava Jisroel, Slomo diventava Slaimo, Elohenu si trasformava in Elaihenu eccetera. Molti scrittori ebrei, per questo, si rivolgevano al tedesco, lingua egemone a quei tempi in Ungheria o, come spesso capitava, all’ungherese. Al termine della Seconda guerra mondiale e dopo, in seguito alla rivoluzione del 1956, alcuni ebrei ungheresi espatriarono in Italia e in Francia, altri in Inghilterra. Come potevano metterla, se volevano diventare, o erano degli scrittori? L’ITALIA E L’UNGHERIA DA MATTIA CORVINO A OGGI. RELAZIONI D’AMICIZIA E RELAZIONI CONFLITTUALI. CONDIZIONI STORICHE DEGLI EBREI IN UNGHERIA E IN ITALIA; ASSENZA E PRESENZA DI GHETTI Vediamo prima, davvero per sommi capi, qual’è stata la relazione tra Ungheria e Italia nel corso del millennio passato, e poi cosa significava questa relazione per gli ebrei italiani e ungheresi. Tra i due Paesi, uno dei quali ‒ l’Ungheria ‒ fin dall’inizio si è presentato come stato‐nazione, è intercorsa durante il millennio passato una stretta relazione. Dapprima le incursioni dei guerrieri magiari (‘de sagittis ungarorum libera nos domine’), poi la presenza sia in Italia sia in Ungheria della stessa casa regnante (gli Angiò) e ancora la discesa dell’esercito di Luigi il Grande fino a Napoli, dopo che il fratello del re ungherese quivi era stato assassinato ed ancora, sul finire del Quattrocento, il matrimonio di re Mattia Corvino con la principessa napoletana Beatrice d’Aragona, hanno rappresentato momenti significativi di ‘contatto’ (sia positivo che negativo) tra 138 i due popoli. La corte di Mattia Corvino pullulò di artisti italiani, pittori, scrittori, storiografi, musicisti del Rinascimento italiano. Nell’Ottocento, la rivoluzione ungherese, e quella italiana contro gli Asburgo, legò di nuovo strettamente i due popoli. E poi la storia del Novecento. Una guerra (la Prima Guerra Mondiale) vide italiani e ungheresi nemici, l’altra (la seconda) li vide tristemente alleati a fianco della Germania nazista. I contatti culturali, con le reciproche influenze, non si contano (si pensi alla grande popolarità, tra le due guerre, di certi scrittori ungheresi in Italia). Che sorte hanno avuto gli ebrei nei due Paesi nell’arco di tutto il millennio? Diciamo subito che i ghetti in Ungheria non sono mai esistiti. La popolazione ebraica subiva maltrattamenti e ingiuste punizioni in tutti e due i territori ma prediche forzate, roghi, ghetti e soprusi simili sono stati piuttosto appannaggio dei comuni e dei granducati italiani, in qualcuno di essi meno, in altri di più. Manoello è stato pure amico di Dante, e i libri di Cabbala sono stati pure chiosati in latino da Pico della Mirandola e da Giordano Bruno. E quando le porte di certe città italiane come Trieste si sono aperte per gli ebrei provenienti dall’Est europeo, molti ebrei ungheresi si sono stabiliti e hanno incontrato parecchia fortuna proprio nella città dell’Adriatico. Ma anche a Modena e nel Veneto già nel Seicento ci sono state migrazioni dall’Europa centrale, e alcuni opere musicali di quell’epoca, scritte in Italia, hanno libretti in Jiddisch e in ebraico. I commerci fiorenti a Trieste nella seconda metà dell’Ottocento hanno fatto ricchi alcuni ebrei, tra questi i Pulitzer, i Mayer (fondatori del giornale locale Il Piccolo) o famosi come il grande scrittore, uno dei maggiori in tutta la letteratura europea , Italo Svevo (al secolo Ettore Schmitz) il cui nonno venne in Italia muovendo da un villaggio della Transilvania. EBREI UNGHERESI IN ITALIA. SVEVO, VAGLIANI, BRUCK, KEMENYI. I FRATELLI PRESSBURGER Gli scrittori ebrei in Italia, nel corso del diciannovesimo secolo, sono stati tra i più noti e più celebrati. Italo Svevo, appunto, Alberto Moravia, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Giorgio Bassani e soprattutto Carlo e Primo Levi non solo hanno scritto in italiano veri capolavori della narrativa, ma hanno anche rappresentato la spina dorsale delle lettere italiane. A questo panorama si aggiungono vari autori provenienti dall’Europa dell’est, soprattutto dall’Ungheria. Tra queste ondate di emigrazione si possono annoverare arrivi a più tappe: all’inizio del Novecento, tra le due guerre mondiali, e dopo il 1956. Abbiamo già parlato della famiglia di Italo Svevo, arrivata in Italia a metà Ottocento, ma ora possiamo parlare di Elody Oblàth, moglie di Gianni Stuparich, nata nella Trieste di fine Ottocento, autrice di romanzi e racconti, di Marino Szombathelyi, consigliere stilistico di Svevo, di Francois Fejto (anche se non diretto in Italia, ma in Francia), di Koestlin ‒ emigrato in Inghilterra ‒, Martin Esslin (autore e saggista , esperto di radiofonia) finito in Inghilterra e infine dell’ultima ondata verso l’Italia, costituita da Edith Bruck, Tommaso Keményi e i fratelli Pressburger. In Germania, Austria, Svizzera (basti pensare ad Agotha Kristof) sono disseminati parecchi autori, anche molto affermati, di origine ebraico‐
139
ungherese. Tutti costoro hanno abbandonato la lingua materna e scrivono nella lingua dei rispettivi Paesi d’arrivo. BREVI CENNI SULLA METAMORFOSI LINGUISTICA La questione di quale metamorfosi comporti il cambiamento di lingua per la scrittura è molto interessante e merita una trattazione molto ampia e anche complicata. L’approccio a questa nuova realtà, nei vari autori, può essere assai differente. C’è chi diventa un autentico virtuoso della nuova lingua, identificandosi completamente nella cultura da essa rappresentata, chi invece sfrutta proprio gli automatismi della lingua appresa per fini ironici, chi diventa ossessivamente ingarbugliato nelle sue opere, chi riduce la propria scrittura a un livello quasi zero, dove non esiste che la balbuzie e poche frasi elementari, chi adotta un scrittura semplice e neutra, ma lontana dall’argomento la cui realtà, anche emotivamente, sarebbe altrimenti impossibile da sopportare, e così via. Sarebbe doveroso un censimento globale degli autori di questo tipo e uno studio scientifico, anche neurologico di questo tema. Oggi, date le frequenti migrazioni, gli autori non di madre lingua si moltiplicano. Aspettiamo dunque alcuni anni per vedere se questo tipo di emigrazione (cioè dalla lingua materna) trova adeguate valutazioni e studi. EBREO O NON‐EBREO, QUESTO È IL DILEMMA (DON GIOVANNI EBREO DI TAMÀS SIMON‐
EINZIG). LA QUESTIONE DI KAFKA. LE COSE MUTANO DOPO LA SHOAH Che influenza ha sullo scrittore ebreo questo cambiamento di lingua? Corrisponde a una parziale o addirittura totale perdita d’identità, oppure questa identità si accentua proprio per la grande distanza tra mezzi espressivi e realtà rappresentata? Anche qui i casi possono essere i più diversi. Spesso ha un’influenza notevole l’origine culturale dello scrittore, cioè se egli viene da una famiglia osservante, oppure dall’illuminismo di inizio Novecento, in cui la questione religiosa spesso diventa di secondo piano, e si focalizza la questione sociale o ideologica. La conversione di molti artisti del secolo passato al protestantesimo (Schönberg) o al cattolicesimo (Werfel) o al marxismo, porta nuove tipologie, nuovi approcci alla questione dell’appartenenza. Questo tipo di ebrei, specialmente alla fine dell’Ottocento, diventa sempre più frequente e sempre più frequentemente si presenta il problema dell’appartenenza. Mi viene in mente un giovane poeta ungherese, morto nel 1956 appena ventenne, che ha lasciato una poderosa commedia su Don Giovanni, e soprattutto su un suo sosia ebreo perennemente dibattuto tra crudeltà, edonismo e la sua antica fede ebraica. Al termine della commedia questo Don Giovanni ebreo si fa uccidere ‒ una forma di suicidio ‒ perchè non sa decidere la propria appartenenza. Ma anche Kafka, che non ha mai avuto dubbi simili, aveva deciso di non parlare mai apertamente della sua religione, perchè gli ebrei, essendo un piccolo gruppo piantato nel cuore dell’Europa, sarebbero risultati incomprensibili, e quindi rifiutati dalla maggioranza della popolazione europea. 140 Perciò nelle opere narrative di Kafka non c’è traccia di ebraismo, né di religione, né di Dio. Ma dopo la Shoah è ancora possibile continuare questo riserbo, o quei fatti attroci richiedono una dichiarazione esplicita del proprio ebraismo e una testimonanza della propria sofferenza? La risposta sta nell’opera di Primo Levi, ma anche di Hans Mayer, conosciuto come Jean Améry. Questo suicida pacato e sereno ha scritto in francese le sue opere. Edith Bruck le ha scritte in italiano. LA CULTURA ASHKENAZY E LA CULTURA SEFARDITA. C’è un’altra questione in questa migrazione dall’Europa centrale e meridionale. Il rito ashkenazi (significa ‘tedesco’) e quello sefardita (‘spagnolo’) hanno molte cose in comune e molte totalmente differenziate. Già nei suoi scritti apparsi in inglese verso la fine del XVIII. Secolo, Zangwille parla del dissidio tra le due comunità e della prevalenza della seconda, ritenuta più nobile, più aristocratica rispetto agli ebrei ashkenaziti. Ma gli ebrei rappresentati per esempio da Saba o da Bassani sono davvero distanti da quelli che appaiono nei libri della Bruck o da quelli dei fratelli Pressburger, o di Koestlin, o di Tommaso Keményi? Sarebbe stato possibile confrontare tra loro queste due realtà tanto diverse? Ma anche la distanza tra le figure di Umberto Saba e quelle di Giorgio Bassani, per dirne una, è enorme, data l’enorme differenza sociale: quelle di Saba sono piccole figure di commercianti e venditori di robivecchi, mentre quelle di Bassani sono personaggi appartenenti alla borghesia colta, medio‐alta. I due gruppi umani, quello degli ashkenaziti e quello dei sefarditi, si potrebbero distinguere tra loro anche per questa differenza sociale. Sul finire dell’Ottocento il quadro muta. La grande borghesia askenazita darà vita, in modo rilevante, al mondo moderno: Einstein, von Naumann, la sterminata schiera di scrittori, scienziati, filosofi ebrei, saranno le fondamenta del nostro mondo, così come si è configurato, diciamo con precauzione, fino a ieri. Oggi siamo di nuovo di fronte a grandi cambiamenti. Oggi c’è lo Stato d’Israele e la ‘partita’ si è spostata lì. INTERCULTURALITÀ. EBREI MAGIARI‐ EBREI ITALIANI Gli ebrei ungheresi e quelli italiani si sono molto diversificati nel secondo dopoguerra. In Italia le tracce della Shoah sono state meno forti e le piaghe si sono rimarginate più velocemente che in Ungheria. Probabilmente è anche una questione di numeri, ma se in Ungheria il regime comunista ha messo un coperchio sulla pentola in ebollizione, riguardo alla questione dell’antisemitismo, lasciando insoluto l’esame di coscienza della nazione, in Italia tutto il carico è slittato verso il Nazismo, come se soltanto quello fosse stato responsabile della morte degli ebrei italiani. È strano a dirsi, ma gli scrittori piú grandi che abbiano scritto libri fondamentali sulla Shoah, sono stati proprio un italiano e un ungherese: Primo Levi e Imre Kertész, il primo con un approccio quasi dantesco all’argomento, il secondo con un libro terribile e amaro le cui radici sono difficili da trovare, alla lontana evocherei forse la 141
figura di Heine o di Goethe per la presenza di una certa leggerezza e ironia davvero esplosive, dato il contesto dei Lager. Edith Bruck, scrittrice transilvana trapiantata in Italia, si è ritagliata, scrivendo in italiano, un posto preminente nella letteratura italiana della Shoah, ma anche della letteratura tout‐ court. SCRITTORI ITALIANI EBREI: MORAVIA, GINZBURG, BASSANI, CARLO E PRIMO LEVI, UMBERTO SABA MA ANCHE PITTI GRILLI, GUIDO DA VERONA, SABATINO LOPEZ. COME SI CONFRONTANO GLI SCRITTORI ITALIANI D’ORIGINE UNGHERESE CON LORO? Farei alcuni cenni a un altro parallelo che si potrebbe tratteggiare tra gli scrittori ebrei d’Ungheria e d’Italia. Si tratta di un parallelo che può riandare agli anni venti‐trenta del Novecento. In Italia, a quell’epoca, ebbero uno straordinario successo alcuni romanzieri ungheresi, autori di best‐seller. Ferenz Molnàr (I ragazzi della via Pàl) e Ferenc Kormendi (Un’avventura a Budapest) hanno riempito le biblioteche di quasi tutte le famiglie della piccola e media borghesia italiana insieme ad altri scrittori ungheresi non ebrei (Ferenc Herczeg, Màrai, Zilahy). Nello stesso tempo, alcuni autori di romanzi rosa o sentimentali in Italia erano proprio ebrei: Pittigrilli, Guido Da Verona, Sabatino Lopez eccetera. Sono figure che andrebbero esaminate una per una per la loro stranezza e per i destini così diversi, a volte davvero drammatici e volte poco lontani dall’abiezione. Sono argomenti, anche questi, che richiederebbero uno studio approfondito e acuto, giacché testimoniano un’epoca importante e tragica, che ha generato, per dire, anche il Nazismo. CONCLUSIONE In conclusione si può dire che, pur avendo un rapporto percentuale così diverso con le culture della loro nazione, gli scrittori ebrei in Ungheria e ungheresi in Italia, nonché gli scrittori ebrei italiani in Italia e in Ungheria, sono state figure centrali delle rispettive culture e di quelle d’arrivo (Svevo). In Italia, gli ebrei sono un’esigua minoranza, in Ungheria erano, prima della Seconda Guerra Mondiale, assai numerosi (più del dieci per cento della popolazione). Ma nonostante questo, essi hanno dato alla letteratura dei loro Paesi e di quelli che li ha ospitati un contributo davvero importante e duraturo. 142 LANSLOTS, Inge. ‘L’ineluttabilità del destino nell’opera narrativa di Giorgio
Pressburger’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a
cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA
ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN
978-90-6701-017-7. 143-151.
RIASSUNTO
Il presente contributo si incentra sulla narrativa complessiva di Giorgio Pressburger (nato nel 1937 a
Budapest) prendendo le mosse da L’orologio di Monaco (2003), l’ultimo romanzo dello scrittore di
origini ungheresi dall’intento chiaramente autobiografico, allo scopo di indagare la portata della
cosiddetta ‘mania genealogica’ di cui sembra soffrire l’io narrante. Si parte dalla ricerca prettamente
genealogica che si trasforma in un ritorno ai modelli letterari e altri due indizi della presenza di una
cognizione esistenziale che si può solo compiere secondo un percorso erratico e labirintico che a sua
volta può solo sboccare nella morte. Tale percorso richiede un’ambientazione spazio-temporale
fortemente legata alla cultura ebraica.
PAROLE CHIAVE
Vita/morte, intertesto, radici
© Gli autori
Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale (Utrecht-Amsterdam, 5-7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata
da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
143
L’INELUTTABILITÀ DEL DESTINO NELL’OPERA NARRATIVA
DI GIORGIO PRESSBURGER
Inge Lanslots
Universiteit Antwerpen
Il romanzo della mia mania genealogica è definitivamente naufragato
con la presente, estesa testimonianza della penultima generazione
della mia famiglia. Più in là, finora, non ho osato andare, nel timore di
vedere pian piano ridotto me stesso a un punto, cioè a un essere senza
dimensioni nel tempo e nello spazio.
(Giorgio Pressburger, L’orologio di Monaco )
Dimensioni, nello spazio e nel tempo, romanzo-testimonianza, mania, essere-essenza,
genealogia-generazione-famiglia. Sono queste le parole conclusive de L’orologio di
Monaco, l’ultimo romanzo di Giorgio Pressburger, che risale al 2003 e dal quale si è
tratta la citazione soprastante. Le parole chiave caratterizzano i topoi non solo
dell’ultimo romanzo dello scrittore di origine ungherese, 1 ma anche dell’ultima
svolta della sua produzione narrativa complessiva, per il fatto che la narrazione,
dando via libera alla ‘mania genealogica’, si riaggancia ai primi testi con una forte
componente autobiografica.
Allo scopo di corroborare la suddetta affermazione sul legame tra
autobiografia e topoi letterari, il presente contributo proporrà di prendere in esame le
ultime opere confrontandole con la produzione complessiva, incluse quelle scritte
insieme al fratello gemello Nicola, prendendo pur sempre le mosse da L’orologio di
Monaco, romanzo dall’intento chiaramente autobiografico, senza che venga trascurata
la specificità delle singole opere.
GENEALOGIA
Per tre decenni ho errato nell’esistenza come un cieco, cambiando città, paese, avendo con me
soltanto “la mia patria portatile”, come ha definito il poeta Heinrich Heine l’Antico
Testamento. Questo libro è stato per molto tempo il più letto e commentato d’ogni epoca.
Oggi l’ha superato un romanzo per bambini. (Pressburger 2003, 3)
La ricerca autobiografico-genealogica ne L’orologio di Monaco, riavviatasi
esplicitamente in Di vento e di fuoco (2000), in cui la ricostruzione della vita della
figura paterna parte dalla storia dei nonni perseguitati dai fascisti durante la seconda
guerra mondiale, fa sì che varie microstorie s’infilino nella Storia (con maiuscola) per
cui la narrazione di Pressburger non è mai lineare. 2 Nel romanzo, che comprende
tredici capitoli o meglio tredici storie che si potrebbero leggere come racconti a se
144
stanti, la ricerca, come lo sostiene l’io narrante, che si tenderebbe ad identificare con
lo scrittore, assume addirittura le dimensioni di una mania: una ossessione che
riguarda la propria vita, e poi quella della famiglia in senso stretto, da una parte i
genitori e nonni tutti travagliati dal passato tragico – basti pensare alla precarietà
dell’esistenza nel periodo (post)bellico – e, dall’altra, i figli e nipoti, ma la quale si
estende ben presto a zii, prozii e familiari meno stretti passando attraverso presunti
familiari, a legami non più biologici ma culturali, o meglio intertestuali:
A metà della mia vita sono venuto a sapere che alcuni uomini davvero determinanti per la
storia degli ultimi due secoli sono stati da una famiglia che porta il mio stesso nome. Sulle
prime ho provato sgomento a causa della mia piccolezza, poi, a poco a poco un sentimento
d’altro genere si è impadronito di me. Ho avvertito come un senso di protezione, un paterno
abbraccio proveniente da loro. Si è diffuso in me, per qualche settimana o mese, una coscienza
felice. Quegli antenati, o presunti tali, erano diventati la mia nuova patria. Si tratta di un poeta,
di un teorico delle rivoluzioni, di un compositore. (Pressburger 2003, 3)
Nell’inserire – con uno slancio dantesco – nel proprio albero genealogico il poeta
Heinrich Heine, il fisico Einstein, il compositore Schumann (Pressburger 2003, 123124), e altri, quali Roy Lichtenstein, Patrick Süskind (92), si rivela pienamente la
carica simbolica della ricerca dell’io narrante de L’orologio di Monaco: la volontà di
riportare in superficie (“Penso che tutto, per chi viene al mondo, sia la scoperta di
una cattedrale sommersa” (88)) o di capire la irrequietudine detta montaliana che
sembra muovere l’io narrante e i suoi antenati ungheresi: “questa ‘irrequietudine’, di
questo destino errabondo che parla Montale” (84). Condizione che diventa quella
dell’uomo borghese in generale o poi di tutta l’umanità:
Non sono mai riuscito a liberarmene. Sai, io credo che questo tormento non riguardi soltanto
la tipologia femminile della mia nazione d’origine, ma l’uomo borghese di tutti i tempi, e, in
fin dei conti l’uomo in generale: credo che riguardi quel fenomeno che tanti chiamano
“spaesamento” dell’uomo, cioè la sua difficoltà di trovare il proprio posto nell’esistenza. Il
fascino della donna ungherese sarebbe un simbolo dell’uomo moderno. Il filosofo tedesco
Heidegger, lo chiama Geworfenheit, cioè “l’essere gettati” come un dado; dal nulla nella vita.
(Pressburger 2003, 85)
Aveva già stabilito la figura paterna in Di vento e di fuoco (2000) che “Errare è il
destino della vita sulla terra, nell’Universo.[ …] La sete di conoscenza ci spinge oltre.
Non avanti, oltre. Questa è la nostra gioia e la nostra condanna” (Pressburger 2000,
73). Sotto la spinta della figlia del narratore, però, ne L’orologio di Monaco, la volontà
di capire, di rispondere a questa esigenza esistenziale, viene parzialmente
abbandonata, o meglio conclusa, nel senso che si registra una certa rassegnazione da
parte del narratore, che infine si rende conto dell’importanza del distacco dall’albero,
distacco che non va inteso come (sinonimo di) rimozione. Così il padre s’ispirerà
all’atteggiamento, ai propositi della figlia nei confronti del passato e dei legami
genealogici, sperimentati come troppo ingombranti e poco vitali, identificando
145
“queste connessioni” (Pressburger 2003, 92) ai di lei calcoli renali. Materializzate in
questo modo si possono scartare letteralmente espellendole dal proprio corpo:
Quel giorno, all’improvviso come d’incanto, finì la mia ossessione genealogica. Cominciai a
guardare al passato come mia figlia ai calcoli della propria cistifellea. Lo guardavo come se
non ne fossi mai stato tormentato. Era lì davanti a me, chiuso in una teca di vetro. E ora lo può
vedere chiunque, con lo stesso sguardo. (Pressburger 2003, 93) 3
Sono rivelatori il ridimensionamento e la collocazione del passato e della ricerca
genealogica, raddoppiati a livello della narrazione nella misura in cui proprio
nell’ultimo capitolo (intitolato ‘Nel terzo millennio (il ramo secco)’) il padre in
quanto io narrante cede la parola al figlio che non avendo prole non si vergogna né si
colpevolizza di costituire il “ramo secco” dell’albero, perché formano un processo
che in genere non si compie nella narrativa pressburgeriana laddove il sentimento
delle radici e l’immersione in un ampio contesto storico tendono di solito a travolgere
i personaggi principali. Il caso più estremo lo si riscontra in Di vento e di fuoco in cui il
padre, l’unico protagonista maschile, prende forma in una corrispondenza epistolare
tra le donne, l’ex-moglie, le compagne e la figlia, che lo hanno amato come un essere
tormentato dal passato su cui questo non poteva altro che tacere perdendosi infine
nelle sue ricerche che passano da scientifiche in esegetiche. La sua frenesia viene
riferita per il tramite delle suddette donne che così compensano i di lui momenti di
silenzio, di afasia o di incomunicabilità ed incomprensione (quando agonizza si
esprimerà in una lingua incomprensibile). 4 Riporta Rivcà, una delle compagne del
padre, che questo prima di essere toccato dal “bacio della morte” (Pressburger 2000,
95),
aveva ripreso a parlare in modo sconnesso, mescolando le lingue. Conservo le registrazioni
[…] Forse […] quelle parole significheranno qualcosa. (117)
Altri personaggi conosceranno episodi simili in cui il lettore intuisce che, dopo un
percorso intrinsecamente erratico che s’iscrive nel topos dell’ebreo errante ed
un’incapacità linguistica simile a quella durante la cosiddetta follia di Mosé essi,
ormai incapaci di stabilire una comunicazione vera e propria, hanno afferrato
l’essenza dell’esistenza. Ne L’orologio di Monaco il narratore, da bambino, l’ha pure
inteso:
L’anima si era manifestata alla mia mente di bambino, e quel terrore, noto agli psicanalisti, si
era conficcato nella mia persona. (Forse non è un caso che in molte lingue la parola
corrispendente a “anima”, abbia tutt’e due i significati: quello di “persona” e quello,
metafisico, di un’entità che discende in noi dopo la nascita e tre giorni dopo la morte lascia il
corpo “inanimato”. (Pressburger 2003, 119)
L’anima che si manifesta come “una piccola ombra rotonda” (Pressburger 2003, 19) e
che, in genere, risulta essere la stratificazione di esistenze, con una progressiva
146
problematizzazione d’identità (dell’io), anche a livello onirico (vedasi L’elefante verde)
e con, nel caso di fratelli gemelli, una continua redistribuzione del Bene e del Male.
DISTRETTI CONGENITI: PAROLA E SILENZIO
Nella narrativa di Pressburger, il problema dell’esistenza è prettamente legato alla
terra natia. In più occasioni il narratore menzionerà l’Ottavo Distretto a Budapest,
setting del debutto scritto assieme al fratello Nicola, Storie dell’Ottavo Distretto, edito
nel 1986: il distretto della giovinezza, di ricordi, ma anche di un passato
irrimediabilmente perso costituito dal microcosmo dello shtetl e dalle storie degli
abitanti.
Benchè il Distretto, Budapest poi e, per estensione, tutta l’Ungheria,
costituiscano il punto di riferimento, si toccano altri spazi che portano da Monaco
attraverso Parigi e Nimega fino al Canada e al Colorado. 5 Tramite il nipote l’io
narrante arriverà in Italia, a Roma, fortemente sorpreso dall’accento romanesco del
nipote – la terra natia diventa substrato spaziale ma anche temporale.
Il nipote risulta immune a una delle malattie congenite che determinano la
storia della famiglia del narratore. Per l’asma di cui soffre lo zio Francesco, il padre
del narratore, dà una sua interpretazione:
- Quella malatia è congenita. È nell’anima delle persone. C’è chi nasce così.
- Ha quella malattia dalla nascita?
- Temo di sì.
- E cosa c’entra l’anima? (Pressburger 2003, 117)
Laddove la madre gli spiega che lo zio è diventato così per la cattiva compagnia che
ha frequentato. Il narratore, retrospettivamente, aggiungerà:
Heinrich Heine e lo zio Francesco: due morfinomani senza salvezza, uniti, in modo oscuro, da
un lontano vincolo di sangue. (Pressburger 2003, 120)
Nella genealogia dei Pressburger il destino implica quasi per forza la perdita. La
morte si rivela essere cluster a livello contenutistico nel senso che molti testi
prendono le mosse da o sfociano nella morte. Illustrativi in proposito sono i racconti
de La legge degli spazi bianchi, raccolta che si presenta come interrogazione sulla morte.
In poche occasioni, la determinazione della propria vita non si presenta come
così drammatica nella misura in cui la linearità sia senza scossoni. Commenta il
cugino Emmerico che descrive la vita e la morte del padre nel quinto capitolo
intitolato ‘Il ferroviere scultore (un racconto del cugino Emmerico)’:
“Non voglio più nemmeno sognare. L’uomo non merita i sogni”, diceva sempre. A volte
cantava qualche canto operaio con la sua voce da basso. È uscito dalla vita scivolando sui
binari dell’esistenza, fino al capolinea. Lì ha frenato pian piano e si è fermato, senza scossoni.
(Pressburger 2003, 78)
147
La forza della metafora del treno si attenua nella misura in cui non si temerebbe
sempre l’ineluttabilità del destino.
Inoltre, la linearità ineluttabile viene accompagnata da una ciclicità e
circolarità. Si ripetono in modo (in)volontario drammi (persecuzioni…) e si rivivono i
grandi orrori della storia (ad esempio l’eccidio) tramite microstorie
I miei genitori e noi tre figli riuscimmo a sopravvivere per puro caso, per la lotteria con la
morte che si apre durante i grandi bagni di sangue. (Pressburger 2003, 5)
Si pongono problemi di colpe e colpevolezza – lo esemplifica il titolo della raccolta La
neve e la colpa (1998), volume in cui ci si interroga sulla (propria) morte e nel quale si
va alla ricerca di (un) sapere. La ricerca, spesso, oscilla tra uno studio scientifico, la
medicina in particolare – si pensi a La legge degli spazi bianchi (che già risale al 1989),
che è supposto dare una base e un appoggio solido, e uno studio religioso, che
dovrebbe rimediare nel momento in cui la scienza (cioè le scienze o le discipline
metafisiche) risulta insufficiente, anche se i testi scientifici vengono considerati,
parafrasando il narratore quando commenta una biografia di Marx, altro presunto
parente, come un “Vangelo pseudoscientifico” (Pressburger 2003, 19). Sarebbe
auspicabile la loro complementarità ma i protagonisti (e altri personaggi maschili) si
vedono confrontati con un’incompatibilità tra una conoscenza cerebrale ed una
comprensione più intuitiva, più viscerale, come lo afferma il rabbino di Cifer
(Pressburger 2003, 38-39), disperato per la gravità della condizione in cui si trova la
moglie dopo un intervento chirurgico, invocando l’Eterno di togliergli “intelligenza,
pensiero, tutto” (38) affinché si salvi la moglie. Il rabbino rinnoverà il patto con
l’Eterno nel tempio perdendo la parola parlata, ma non la coscienza, o solo
progressivamente, ma nel caso del rabbino Jom Tow la malattia cancella per ultima la
coscienza, il che gli porta a emettere post mortem l’augurio seguente:
Il prossimo (universo) sarà un universo aperto, libero dalle assurde leggi di Lavoisier, secondo
cui nulla si crea e nulla si distrugge e per le quali una vita deve divorare altre vite per durare.
(Pressburger 2003, 57) 6
Altri casi estremi si leggono in Di vento e di fuoco, romanzo epistolare e ricostruzione
della ricerca del Principio da parte della figura del padre – “Devo capire dove si
nasconde il Principio (‘The very beginning’, così mi disse)” (Pressburger 2000, 39) –
ma anche nella raccolta La legge degli spazi bianchi: nel racconto omonimo si assiste
alla trasformazione di un fratello gemello stimato forte ed indipendente in un essere
debole e bisognoso che inizialmente non vuole rassegnarsi al proprio degrado
annunciato dall’Evento per poi diventare il martire della propria amnesia-demenza.
Tornando all’opposizione, si può quindi constatare che la ricerca esistenziale,
effettuandosi in chiave epistemologica, sottende la scrittura di Pressburger, incarnata
da protagonisti per lo più maschili ed introversi. “Non ho mai trovato alcuna
certezza. Ma non smetto di cercare” (Pressburger 2003, 176), concluderà l’io narrante
nell’ultimo capitolo dalla sua mano, cioè il penultimo capitolo intitolato proprio
148
“L’orologio di Monaco”. Nella loro morte, infatti, si incrociano e si incastrano due
griglie interpretative che apparentemente si oppongono diametralmente, vale a dire
quella della religione e della cultura ebraica in generale e quella della scienza, la
medicina in particolare. Ne deriva, in conclusione, una complementarità pur
lacunosa nella misura in cui gli strumenti, le chiavi offerte sia dalla religione sia dalla
scienza si presentino come inadeguate e incomplete.
In questa luce va osservato che l’opposizione scienza-religione richiama quella
tra uomo-donna. I personaggi femminili però non devono compiere il passaggio da
un polo all’altro perché sin dall’inizio tenderebbero di più alla religione, ad una
conoscenza non oggettiva o basata su un approccio empirico, essendo anche più
aperte ad apparizioni epifaniche e messagg(er)i dell’aldilà, come il padre in Di vento e
di fuoco. Dispongono quindi di una maggiore disponibilità e sensibilità a questi
fenomeni. Oltre a ciò, le donne stesse segnano la presenza dell’aldilà, ne possono
essere la personificazione. Si può quindi avverare una Entstellung, quando nella
mimesi la (rap)presentazione di personaggi si sforma perché decontestualizzata e
dislocata. Chi vede una figura spettrale o altro, se ne lascia penetrare come un artista
s’impregna della materia da rappresentare:
Lasciarsi penetrare dalla materia da rappresentare richiede molta forza e molta debolezza. E
pure un po’ di calcolo, certo. La storia degli artisti di tutto il mondo è anche questa.
(Pressburger 2003, 72)
L’OROLOGIO E IL PESO DELL’IMMATERIALITÀ
Ma il breve soggiorno in casa nostra dello zio Giusti è rimasto comunque nella mia memoria e
tra i miti della mia vita. I miti ci visitano, finché, a un certo punto, come sono nati scompaiono
nel nulla. Ma il loro posto viene preso da altri miti e noi viviamo, tra un mito e l’altro, le nostre
rapide esistenze. (Pressburger 2003, 107)
Nella produzione narrativa di Pressburger l’arte viene sperimentata come
indispensabile: laddove ne L’orologio di Monaco si registra la prevalenza sia della
poesia (Montale e Heine) che della musica (Schumann, Debussy), si privilegia
solitamente una disciplina artistica. Uno zio del narratore proclamerà che sono
indispensabili i libri, la cosiddetta patria portatile, come afferma lo zio Giusti, anche
quelli licenziosi:
I libri servono. Io ne ho pochi, ma per me sono la vita. La vita. Altrimenti, che ne so, che ne so
cosa farei. (Pressburger 2003, 101)
Inoltre, si passa alla scrittura quando si è parlato troppo:
Niente. Scrivimi per posta elettronica. Abbiamo già parlato troppo Abbiamo riempito le nostre
stanze di parole. […] Tra noi la parola scritta rappresentava un cuscinetto a sfere capace di
ridurre l’attrito. (Pressburger 2003, 83)
149
Tale rapporto tra oralità e scrittura s’inserirebbe nella dicotomia, a cui si è accennato
prima, tra incomunicabilità-silenzio e parola. Parola che può essere rimandata fino al
momento stimato opportuno che non si presenterà anche perché c’è uno scarto tra
testa e corpo (Pressburger 2003, 104), 7 cosicché la temporalità dei personaggi non
viene segnata dall’orologio, neanche da quello famoso di Monaco, ma si stabilisce
all’insegna dell’attesa a cui “per la tendenza della mente umana a simbolizzare” (164)
attribuire tutto e l’eternità:
– Quell’orologio dice bugie quando batte le ore, – disse Tom Jow. – Perché le ore non esistono.
Esiste soltanto il deserto sconfinato dell’attesa. Dell’attesa che i termini di un patto scadano.
Che venga la fine. Che venga un altro universo. Che l’acqua di sopra si congiunga con l’acqua
di sotto – . (Pressburger 2003, 53)
NOTE
Per la questione delle radici rimandiamo al contributo dell’autore stesso, ‘Budapest-Roma. Realtà
ebraica fuori della lingua’ a p. 137 degli atti.
1
Tale ricerca, come lo dimostra anche l’incipit parzialmente riportato in epigrafe a questo primo punto,
s’immetterà a sua volta in un contesto biblico.
2
L’immagine insolita palesa una strategia narrativa di Pressburger, portata alla luce dall’autore stesso
nel dibattito in seguito alla sessione dedicata alle sue radici e alla sua opera, che consiste nell’uso di
immagini e metafore ‘stonanti’ per creare un effetto di distanziamento, arnese ereditato dal poeta
triestino Saba e il romanziere ferrarese Bassani, ambedue fonti d’ispirazione e maestri della lingua e
del ritmo poetico. Nello stesso dibattito Pressburger sottolineò il ruolo che ha avuto Bassani nella sua
formazione: per ben tre anni c’è stata una stretta collaborazione tra i due scrittori.
3
Il padre commenterà la propria incomunicabilità, frutto del suo errare, nel suo diario: “Mi sono
strappato dalla vita, ho lasciato gli atti della vita sospesi nel niente, e mi sono messo al lavoro per
compiere il mio Viaggio, la mia ascesa, da vivo, dove soltanto pochi vivi sono finora arrivati. Per
questo sono sparito dal mondo. Per prepararmi al Viaggio. Per cinque anni, giorno e notte, ho letto gli
antichi testi. Non sarei potuto morire in pace senza compiere questa ascensione. […] Ho cancellato le
mie tracce. Sono fuggito. […] Dietro di me la confusione di atti, parole, amori, menzogne, davanti a
me il grande Viaggio. […] Io ho volato, ho compiuto il mio Viaggio fino in fondo. Ma ora non riesco
più a parlare. Se solo riuscissi a trasmetterti tutto in un attimo, come tu trasmetterai a mia figlia ciò che
ti dico, in un attimo, premendo un tasto! Ma non è possibile, ancora non è possibile trasmettere
interamente se stessi. Un giorno forse. Non riesco più a parlare” (Pressburger 2000, 82-83).
4
In più occassioni l’io narrante menzionerà Bratislava, dai tedeschi conosciuta come Pressburg, città di
cui l’io s’appropria per motivi onomastici.
5
Nella narrativa di Pressburger la coscienza è prettamente legata alla cultura ebrea: “[…] la figura
dell’ebreo centroeuropeo nella letteratura del XX secolo, del secolo appena passato, è assurta alla
dignità di depositaria della coscienza universale”(Pressburger 2003, 86). O come si legge nel suggello
al primo capitolo, una traduzione di Pressburger di una poesia di Heine, La principessa Sabbath (Ibidem,
15-16): “Certi libri dell’Arabia/ favoleggiano di morti/ che ritornano ogni tanto/ ridiventano avvenenti/
principi con diamanti/ sul vestito, sulle spalle,/ fanno musica, innamorati./ Poi sparisce l’incantesimo/
e d’un tratto noi scorgiamo/ sua altezza tramutata/ in orrendo mostro peloso./ Il mio canto vuole
parlare/ d’un tal principe, dal nome/ “Israele”. L’ha mutato/ un malocchio in un cane./ Cane, con
6
150
mente canina./ Erra qua e là sei giorni/ Digrignando i denti alla vita/ Sbeffeggiato dai ragazzacci./ Ma
venerdì sera sempre,/ proprio all’ora del tramonto/ cessa lo scongiuro e il cane/ torna, sì, a essere
uomo./ Uomo con tratti umani,/ con il capo e il cuore in alto,/ puro, dritto, ben vestito,/ entra
nell’antica sala./ Ti saluto antica sala /Dei miei cari avi regali,/ Tende di Giacobbe, bacio/ Mille volte le
vostre soglie!/[…]”.
Tramite la tipica componente dei vari ritmi dell’età biologica e della maturità e la consecutiva
incomprensione si svela una forte affinità con la narrativa di Erri De Luca, anch’essa impregnata dalla
cultura ebraica.
7
BIBLIOGRAFIA
Lanslots, Inge & Van den Bogaert, Annelies. ‘La lingua del dolore’. AA.VV. Lingue e letterature in
contatto. II. Firenze: Cesati, 2004: 365-374.
---. ‘Op klassieke leest geschoeid’. Streven 69/8(2002): 749-752.
Pressburger, Giorgio. Denti e spie. Milano: Rizzoli, 1994.
---. Di vento e di fuoco. Torino: Einaudi, 2000.
---. I due gemelli. Torino: Einaudi, 1996.
---. La legge degli spazi bianchi. Milano: Rizzoli BUR, 1992.
---. La neve e la colpa. Torino: Einaudi, 1998.
---. L’orologio di Monaco. Torino: Einaudi, 2003.
---. ‘Nel regno oscuro’. Paragone 60-62 (2005): 51-75.
---. ‘Storia personale dell’iniziazione alla lettura: lettura orale e lettura oculare’. Sincronie 13 (2003): 4550.
---. Sulla fede. Torino: Einaudi, 2004.
Pressburger, Giorgio & Nicola. L’elefante verde. Genova: Marietti, 1988.
---. Storie dell’Ottavo Distretto. Genova: Marietti, 1986.
Ricciarelli, Andrea. ‘Esilio, migrazione, frontiera, nell’opera di Magris e Pressburger’. Intersezioni 3
(2004): 423-450.
151
SILVERA, Miro. ‘La necessità di raccontare’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 153‐155. RIASSUNTO Al centro della letteratura ebraica – e della cultura dell’ebraismo in genere – sta, ovviamente, la Bibbia e la sua esegesi. Ma vi è pure una forte oralità, legata all’ambiente famigliare. Molto piú recente è la vera e propria letteratura ebraica scritta. Molti scrittori ebrei, per poter fare lo scrittore, si sono a lungo mimetizzati dietro uno pseudonimo – è il caso di Svevo e Moravia – o addirittura convertiti. Silvera vede la propria generazione, invece, come diversa, e si dichiara fiero della propria identità, in cui si incontrano tradizioni linguistico‐culturali diversissime. Al contempo, vive intensamente la sua missione etica di narrare e di indurre il lettore a pensare, avvertendolo del pericolo dell’intolleranza rappresentato dall’islamismo radicale. PAROLE CHIAVE Ruolo dello scrittore, plurilinguismo, assimilazione, oralità © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 153
LA NECESSITÀ DI RACCONTARE Miro Silvera Per duemila anni ostracizzati, ovunque esiliati, demonizzati e scacciati, noi ebrei non abbiamo avuto altra letteratura che non fosse quella biblica, altri saggi che non fossero quelli di commento al testo sacro, come gli scritti – splendidi – di Rashì o di Maimonide. Ma anche quel disquisire era narrare, correre attorno all’immenso pozzo di storie che è la Bibbia. E chi aveva tempo di scrivere con carta e penna, quando si trattava di salvare la propria pelle, scappando da un paese all’altro con ben poche cose nella sacca, e a volte un solo libro di preghiere bastava, per ancorarsi al filo delle identità perseguitate? I racconti di famiglia erano invece per lo più orali, fatti per tramandare il senso della Storia alle generazioni più giovani, narrazioni svolte attorno alla tavola della cena pasquale, oppure accanto al fuoco di un camino o alle fiamme di un bivacco, durante una drammatica fuga. L’ebreo doveva nascondersi, ma si portava dietro tante parole racchiuse nella memoria e nelle memorie tramandate. E da quando noi ebrei d’Europa e d’America ci siamo permessi di avere una letteratura? In realtà, solo a partire dal ventesimo secolo, cioè da ieri. Molti, nel frattempo, per venire accettati dallo scintillante mondo dei ‘gentili’, avevano avvertito la necessità di convertirsi abbandonando la religione dei padri. In Inghilterra l’ha fatto Disraeli per diventare Primo Ministro, l’ha fatto in Germania il poeta Heinrich Heine per non essere emarginato, e a Vienna l’ha fatto Gustav Mahler per venire applaudito nei teatri di corte. Nel ventesimo secolo, in Italia e in letteratura, si erano ben mimetizzati per ottenere tutto il successo che ebbero sia Pittigrilli che Guido da Verona. Ma anche Ettore Schmitz ha provato la necessità di nascondersi dietro al nome d’arte di Italo Svevo. Nella generazione successiva, saranno Giorgio Bassani, Primo Levi e Carlo Levi, nonché Umberto Saba, a rivelarsi con molta riluttanza in quanto ebrei, senza più la necessità di convertirsi. Primo Levi dovette scoprire la sua condizione di ‘diverso’ nei campi di sterminio, Carlo Levi lo fece al confino, e Giorgio Bassani nella separatezza delle leggi razziali. Quando nel 1981 quest’ultimo lesse un dotto commento di Pietro Citati attorno a un raffinato libro di racconti di Nachman di Breslav, chiese meravigliato al noto critico perché mai avesse scelto di parlare di un autore così peculiare nel suo misticismo ebraico. Quanto ad Alberto Moravia, non si era mai sentito nemmeno ‘mezzo ebreo’. Anche lui aveva cambiato cognome, assimilandosi agli altri con un senso di liberazione. Un fatto è certo: la radice famigliare non fa certo lo scrittore ‘ebreo’. Noi, nipotini di questi autori del Novecento (ma ce ne sono altri che vanno menzionati, come Alberto Vigevani, Alberto Lecco, eccetera) abbiamo invece avvertito imperioso il dovere di raccontarci in maniera diversa, e per quanto riguarda me in particolare, ossessivamente immerso nell’identità ebraica. Sono 154
orgoglioso delle mie origini, e ho voglia di raccontarlo in tante trame. L’ebraismo è per me, più che una religione, sopratutto una filosofia del vivere e un retaggio culturale. Il mio narrare ne è dunque fortemente marcato. Non ho voluto nascondermi, e non voglio mascherarmi. Sono portatore di storie e di un’umanità che vuole a tutti i costi essere tramessa. Questa è la mia linea e questa è la mia urgenza. Nato in Medio Oriente (ad Aleppo, in Siria) in un paese sorto dallo sfaldamento dell’Impero Ottomano, e rimasto per venticinque anni sotto protettorato della Francia, la mia prima lingua udita è stato dunque il francese, e subito dopo è toccato all’arabo. La terza è stata l’italiano, e la quarta, a scuola a Milano, l’ebraico seguito poi dall’inglese. Da questa Babele di idiomi è nata la mia scrittura, una specie di creatura del dottor Frankenstein che cerca di occultare nella semplicità del dettato le tante parti cucite dei fonemi che la compongono. Io credo fermamente che oggi lo scrittore debba assolvere ad una funzione decisamente etica. Forse anche eretica. Nel caso del mondo nuovo, si deve condurre il lettore a pensare. “Lo scrittore, se vuole sopravvivere, deve continuare a essere il veleno del proprio ambiente sociale“, come dice Antonio Scurati. Un dolce veleno, dico io: erbe amare mescolate con il miele, o intinte nell’aceto come si fa ancora per le feste antiche. Adesso che noi scrittori di tradizione ebraica abbiamo ottenuto di scrivere e di far sentire la nostra voce – ma se il nazismo islamico dovesse prevalere, ci toglierà di sicuro questo privilegio perché si può fare dittatura solo sull’ignoranza – non rinunceremo tanto facilmente all’esercizio critico, il più possibile intelligente e attento ai valori umani, narrando la grande Storia e le nostre piccole, infinite storie, dalla barzelletta al romanzo più impegnativo. Dalla devastante esperienza della Storia, e di quella del Novecento in particolare, l’imperativo è più che mai quello di raccontarsi e di raccontare le diversità, troppo a lungo taciute. 155
SPEELMAN, Raniero. ‘Multiculturalità ottomana e scrittori italiani da Saul Israel a Miro Silvera e Daniel Fishman’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 157‐166. RIASSUNTO Dall’ex Impero Ottomano, società multiculturale per eccellenza, della quale facevano parte fra l’altro Grecia e Bulgaria, Siria, Egitto, Libia e Israele, provengono molti ebrei scrittori in lingua italiana. Esaminiamo tre di essi: Saul Israel, scienziato nato a Selanik (Salonicco) e autore di un romanzo a sfondo turco appartenente ad un genere particolarmente turco, il romanzo di briganti (eşkiya romanı), Miro Silvera, nato ad Aleppo e autore di piú d’un libro in cui tratta il Paese d’origine o in cui dei personaggi ne provengono, e Daniel Fishman, la cui famiglia proviene dall’Egitto. In comune essi hanno una certa nostalgia di un mondo cosmopolitano di forti contrasti sociali e religiosi ma anche esempio di plurisecolare convivenza e tolleranza. Ma sono società ormai tramontate, dove i conflitti all’indomani delle grandi guerre hanno portato ad un antisemitismo spesso di regime e all’espulsione degli ebrei. PAROLE CHIAVE Antisemitismo, Vicino Oriente, ottomani (ebrei), immigrazione ebraica, espulsione dall’Egitto © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 157
MULTICULTURALITÀ OTTOMANA E SCRITTORI ITALIANI DA SAUL ISRAEL A MIRO SILVERA E DANIEL FISHMAN Raniero Speelman Universiteit Utrecht EBREI OTTOMANI Nella storia dell’Europa moderna l’Impero Ottomano si profila come il primo stato multiculturale e multietnico per vocazione e non per casuale sviluppo territoriale‐
politico. Anche se la scelta di tale politica si può ricondurre fino al periodo piuttosto esteso della conquista, in cui il beylik della casa di Osman, situato intorno all’attuale Bursa (la Prussia bizantina), si estese sempre di più fino ad incorporare gran parte dell’Asia Minore e dell’Europa balcanica, il momento cruciale di quest’atteggiamento è da individuarsi nella famosa reazione di Bayezit II alla pulizia etnica della Spagna nel 1492, in cui furono espulsi sia gli islamici che gli ebrei: “vengano pure qui gli ebrei, saranno benvenuti!”. Gli ebrei sefarditi da quel momento hanno avuto e mantenuto il ruolo di minoranza privilegiata e vicina al potere degli Osmanlılar. Come si sa, l’Impero del Bosforo annoverava cristiani di ogni rito, greco, cattolico, siriano e armeno, occidentali di cui nell’ ‘800 non pochi nazionalisti esiliati, oltre a vaste comunità di cittadini genovesi, veneziani e così via. Di tale situazione persistono tutt’ora cospicue tracce, soprattutto nelle città di Istanbul e Izmir. La presenza italiana in quei centri comprende una componente ebraica che supera di gran lunga la media italiana. È mia intenzione soffermarmi sull’influsso che alcuni ebrei ottomani hanno esercitato sulla letteratura italiana e analizzare il loro rapporto con la loro cultura di provenienza. In molti casi essa è particolarmente sentita come una doppia appartenenza, per non dire un doppio debito a due mondi: Occidente e Oriente. Ciò è tanto più notevole in quanto molti scrittori (e vale certo per il nostro ospite in questi giorni, Miro Silvera), non hanno vissuto molto a lungo o mai nei Paesi dell’ex impero, ma si sono sopratutto formati su e nutriti di storie e ricordi di parenti. Il rapporto tra il passato ottomano e il presente italiano non è cosa tipica della letteratura ebraica internazionale, se anche non lo vediamo spesso nell’ebraismo americano, britannico o neerlandese, tanto per nominare alcuni dei filoni della diaspora. Ma nel caso degli italiani si spiega con una storia plurisecolare di rapporti commerciali o diplomatici fra le varie sponde del Mediterraneo dove si trovarono di casa. In secondo luogo, la conquista, nel secondo decennio del Novecento, di due entità territoriali ottomane da parte dell’Italia fece sì che gli ebrei locali divennero sudditti italiani. Mi riferisco alle isole del Dodecaneso (in ispecie, Coo e Rodi) e della Libia, territori con una cospicua presenza ebraica. 158 Vorrei concentrarmi in questo contributo – anche per non ripetere quanto ho previamente pubblicato sul soggetto – su Silvera e Fishman, ma non senza iniziare da un curioso libro che è fra i primi provenienti dal mondo ebraico‐ottomano.1 Si tratta della Leggenda del Re Horkham di Saul Israel, un prestigioso scienziato italiano di origine ottomana. Infatti Israel era nato nella città di Selanik ossia Thessaloniki, il maggior centro ebraico dell’impero e fino alla Seconda Guerra Mondiale, la città europea che contava in assoluto il maggior numero di cittadini ebrei. Se anche nel 1913 Selanik era stato incorporata nel regno greco, l’influsso ottomano vi era rimasto ben presente, ed era a quel mondo che lo scrittore ritornò con la fantasia. Non so di preciso quando nacque il libro che sarebbe stato pubblicato dopo molti anni dalla Adelphi, e che si muove in “un’aria sanza tempo tinta”. Ma il testo potrebbe datare dai tardi anni trenta o dal decennio successivo. Il testo si presenta come un racconto a cornice a stampo orientale, che si svolge in gran parte ad Ankara, negli anni in cui la vecchia Angora era diventata col suo nome nuovo la capitale del giovane stato turco voluto da Atatürk. La città era già stata visitata da un importante scrittore italiano come Corrado Alvaro (e descritto nel suo Viaggio in Turchia). Israel descrive però un’Ankara arcaica, pre‐kemalista, una tipica città turca piena di case di legno e catapecchie di fortuna, scrigno di secreti. È lì che viene alla luce, nella miglior tradizione romantica, un manoscritto, il quale costituisce il testo vero e proprio del racconto fantastico. Il testo di Israel ha una forte ispirazione moralistico‐sociale. Ho definito il libro in un articolo un romanzo di briganti (eşkiya romanı).2 Si tratta di un tipico genere turco di ispirazione social‐critica, in cui l’eroe in cerca di giustizia sociale si erge a protettore dei deboli. Infatti, lo scrittore fu licenziato dal regime fascista nel 1933 per motivi di dissidenza politica. Senza entrare nel merito del romanzo, mi preme porre qui la domanda perché uno scrittore nato a Salonicco e vissuto a lungo in Italia sceglie la Turchia come sfondo per il suo libro. E perché mai Ankara, la sua città più moderna e quindi meno caratteristica del Paese? Suggerirei che in un periodo di virulento antisemitismo, che aveva colpito gran parte dell’Europa, lo scrittore abbia provato nostalgia del (forse) unico paese che non avesse mai conosciuto questo male e in cui un ebreo fosse sempre stato libero a vivere indisturbatamente la propria vita. A parte un forte interesse filosofico, che accomuna Israel a grandi pensatori ebraici, nel libro non appare traccia di ebraismo, il che non può destare meraviglia per un ambiente completamente islamico. Ma non dobbiamo dimenticare che dietro i tanti Allah di cui abbonda il libro si nasconde l’interrogazione continua che un intellettuale ebreo porta avanti intorno al Dio unico, comunque lo si chiami. Non ho ancora risposto al perché di Ankara. Qui si può pensare al rifiuto di Istanbul quale locus orientalis per eccellenza. A voler cercare più profondamente, la scelta tradisce una certa sfida: l’idea che nello stato nuovo o città nuova si nasconda sempre il passato, ispirazione o lezione per il presente. O si tratta semplicemente del topos del quartiere vecchio della città moderna? Credo di no. Il contrasto a ciò necessario non viene creato nel libro. Manca assolutamente nel libro ogni elemento 159
moderno che potesse far risalire maggiormente l’elemento misterioso insito nel vecchio. L’ORIENTE UTOPICO DI MIRO SILVERA Veniamo a Silvera, figlio di quell’Aleppo che per molti vale come una delle vere porte dell’Oriente, punto d’incontro di molte strade ed esperienze diverse, circondata da una piccola galassia di cosiddette ‘città morte’, impressionanti insediamenti urbani lasciati dalla popolazione bizantina all’apparir degli arabi o di altre tribù temute. Questo figlio però è stato strappato giovanissimo alle proprie origini, e come più di un millennio prima i bizantini, in un passato recente anche gli ebrei, da tanto tempo presenti nella città ottomana e siriana, sono stati costretti alla fuga. Chi oggi visita Aleppo (o Damasco), dopo aver dichiarato di non essere mai stato in Palestina e senza aver commesso l’imprudenza di identificarsi come ebreo (in entrambi i casi il visto non viene rilasciato), trova città spogliate da questo elemento vitale che fungeva da traît‐d’union fra est e ovest, città ove non è raro incontrare case una volta abitate da ebrei e ormai in rovina, sinagoghe diventate depositi o cortili adibiti a varie funzioni. Naturalmente è difficile ragguagliarsi bene sull’identità di questi beni culturali, anche se la popolazione locale fa capire talvolta di ricordarsi un passato diverso. Ma prevale un senso di assenza e di incompletezza. Uno dei tanti meriti di Silvera è stato quello di aver tentato una ricostruzione di quel mondo scomparso e inaccessibile, basandosi per lo più sulla documentazione di famiglia. Due suoi libri che vorrei chiamare fondamentali sono basati su questa ricostruzione: il primo è L’ebreo narrante, il debutto dello scrittore (1993), l’altro Il prigioniero di Aleppo (1996). Questi due testi sono antitetici e complementari. Il primo è dedicato completamente alla tradizione orale, base e inizio di ogni registrazione e osserva il comandamento biblico di raccontare ai propri figli.3 Il suo carattere è prevalentemente saggistico e storico. Il secondo si presenta come autobiografico e al contempo romanzesco, e rappresenta quindi un passo avanti, quello dal documento all’arte. Ma i libri hanno molto in comune: parte dei personaggi (primo dei quali il signor Zaki, nome che indicherà sia il profeta ebreo Zacharias che il turco Zeki, ‘l’intelligente’), il luogo principale dell’azione (Aleppo), gli argomenti focalizzati (vita ebraica). Anche nei libri di Silvera il mondo ottomano è un elemento di rilievo. Pur essendo tramontato con la fine dell’impero, molti elementi ottomani erano e sono ancora visibili nella Siria moderna. La presenza burocratica francese subentrata all’ottomana ha garantito a lungo la continuità di quel misto di culture, etnie e religioni che aveva caratterizzato il grande impero. Laddove la Turchia moderna si sviluppò in uno stato di turchi al 98 % musulmani, la Siria araba includeva e include molte minoranze: vi si incontrano armeni e curdi, ortodossi e cattolici, alawiti e drusi. La convivenza tra questi gruppi nei tempi in cui c’erano pure gli ebrei, da sempre mediatori tra tutti quanti, è il nucleo del primo libro e il passato in cerca del quale viaggia il giovane protagonista del secondo, Meir ossia Miro, come indica 160 chiaramente il nome, alter ego dell’autore nonché proiezione del suo desiderio di ritorno alla terra d’origine, dove Silvera stesso non ha mai potuto rimettere piede. Meir nel suo viaggio è accompagnato da un bonario autista di nome Muhammad, nome non senza significato nella complessa narrativa del romanzo, un testo che si presta a una lettura a più di un livello, simbolica oltre a intertestuale. Da un lato, si può parlare di una discesa dantesca o virgiliana agli inferi, in cerca di un messaggio che riguarda il passato e futuro della propria stirpe. Dall’altro viene a pensare pure al parallelo tra Miro e miraç (il viaggio celeste del profeta, che sarebbe salito in cielo dalla non lontana Gerusalemme), e il viaggio assume toni diversi anche se sempre rivelatori. Politicamente, il libro si può leggere come manifesto della tolleranza e convivenza, unica forza capace di realizzare una società vivibile per l’umanità e unica soluzione per i mali provocati dal nazionalismo. A portare quest´idea alla sua conseguenza estrema sarebbe il libro Contro di noi, la più profonda riflessione politicoculturale di Silvera. Nella sua opera, questo libro rappresenta il preciso opposto dell’elogio della tolleranza multietnica, la realtà che vince l´ideale tramontato. È l´antisemitismo quel male che corrode la cultura occidentale e mediterranea quasi dalla nascita del cristianesimo e dell’islam fino ad oggi, a fornire il filo rosso del libro, che non intende fornire un discorso strutturato e omogeneo, bensí una serie di analisi, descrizioni, commenti e rimpianti in cui non manca nemmeno qualche brevissimo racconto. Il penultimo romanzo di Silvera non sembra attribuire grande importanza alla tematica ebraica. Il senso del dubbio è un puro romanzo di stampo postmoderno, costruito interamente intorno a caratteri fittizi. Ci sono però tre personaggi di chiara provenienza ebraica. Uno è la misteriosa rock‐star Hedy Sax, nato come Bruno Sachs da padre ebreo. Senza entrare nella trama del romanzo, Sax incarna il complesso dramma d’identità che molti ebrei hanno vissuto e la solitudine che può esserne la conseguenza. Non so se il suo nome sia da leggersi come anagramma di ex hasyd (ex chassid), ma tale interpretazione di ‘ebreo che ha cercato di rompere col suo passato’ offrirebbe un’interesssante chiave di lettura. Il secondo personaggio è la sorella di Hedy, Flora, con cui il protagonista goy ha un breve rapporto erotico. Mi vorrei concentrare qui invece su un personaggio meno importante di questi ultimi, Madame Persia, una cordiale e anziana signora che riceve il protagonista del romanzo, lo scrittore Theodor Burger, al castello abitato dalla rock‐star e sua sorella. Ella è nata nel Vicino Oriente, non in Persia ma in Egitto. Scrive Silvera: Madame raccontò di avere vissuto ad Alessandria d´Egitto, poiché era un’ebrea italiana maritata giovanissima a un levantino. Parlò degli anni di benessere, della vita di società fra inglesi e francesi, del piacere di vivere allora, quando nella incoscienza nessuno si rendeva conto delle grandi tragedie incombenti [...]. Vide lei giovane, la figuretta svelta, l’innocenza degli abiti chiari in un clima caldo, le palme scarmigliate sull’orlo di un mar straniero, la passeggiata verso Ramleh, scorci di cancellate nel quartiere residenziale, con le ville basse circondate di ombra fresca, le carrozze coi cocchieri mustacchiuti, fieri in serpa con in testa il loro tarbòsh. Anche i cavalli erano ornati di fiocchi, 161
consci dei loro ruoli nobili. E poi, gruppi in posa alle feste da ballo, abiti lunghi e scollature, giacche bianche per gli uomini, e lampioni di carta appesi fra gli alberi.4 È l’Egitto di cui parla Madame, ma avrebbe potuto essere anche la Siria, con la stessa società mista, la stessa bella vita, e la stessa miseria dopo che gli europei ebbero lasciato il paese. Più avanti nel libro, Madame parla di una permanenza ad Istanbul, dove ha avuto un figlio, che aveva chiamato prima, alla turca, Selim, poi Shalom e infine egli stesso aveva cambiato il proprio nome in Adon, ‘signore’ (151). È un passo interessante e, direi, rivelante. Il procedimento di scelta e conseguente adattamento di un nome turco è quanto mai insolito per gli ebrei in Turchia, che preferiscono nomi ebraici come Abraham o Esther o nomi europei neutri come Dario, Mario, Harry o Rosa. In ogni modo non è raro incontrare il procedimento nei Paesi Bassi, dove il nome di Mordechai diventa Maurits o Max, o Miriam può condurre a Monique. In Contro di noi, Silvera afferma di scrivere il romanzo che vive ogni giorno sulla sua pelle: “Sovente e a brandelli mi sono fatto romanzo, e storia”.5 Ciò sembra giustificare un’interpretazione se non strettamente autobiografica, certo come documento della storia famigliare, dei suoi libri. Anche il saggio è storia, come la Storia con maiuscola può diventare saggio. Con concisione agghiacciante Silvera racconta gli eventi che hanno condotto al ritorno della famiglia al paese di cui non avevano mai perso la citadinanza: I beni di famiglia erano bloccati, gli affittuari, con una scusa o con l’altra, non pagavano più le pigioni, e coloro che avevano preso in prestito del denaro non lo avevano mai più reso. Molti, come il direttore dell’Alliance di Damasco Jacques Franco, erano stati assassinati, e la grande sinagoga di Aleppo era stata saccheggiata. Mia madre, mio fratello Carlo e io siamo partiti dalla Siria, passando dai nonni che abitavano a Beirut e imbarcandosi poi per l’Italia all’inizio del 1947. Siamo giunti a Genova in primavera. A dicembre di quello stesso anno, in seguito alle sommosse antisemite, i musulmani di Aleppo hanno dato alle fiamme 150 case, 50 negozi, 18 sinagoghe e 5 scuole, uccidendo parecchi ebrei.6 L’EGITTO DI DANIEL FISHMAN E CAROLINA DELBURGO La scelta dell’Egitto come paese di provenienza di Madame Persia ne Il senso del dubbio è interessante anche perché è lo stesso mondo descritto da Daniel Fishman nel suo Chilometro d´oro (2005). Il nonno di Fishman era appartenuto agli italiani d’Egitto, un gruppo piuttosto numeroso e economicamente di gran rilievo. Molti di questi italiani erano, come i loro connazionali istanbuliti, ebrei. Si sa che ad Alessandria nacquero due protagonisti della cultura italiana del Novecento: Marinetti e Ungaretti. Quest´ultimo ha un ruolo importante nel grande romanzo di Maurizio Maggiani, Il coraggio del pettirosso (1995), che si svolge in parte in quella città. Ma questi casi esulano, trattandosi di non‐ebrei, da quest´argomento. Concentriamoci dunque su Fishman. 162 L’autore è nato in Inghilterra da una famiglia egizio‐ebraica fuoruscita e ha tutt’ora la doppia cittadinanza. Suo nonno è il tipico esponente dell’ebraicità mediterranea cui appartenevano anche i Silvera: Sua madre era una Mornaga originaria di Livorno e suo padre Robert un siriano d’Aleppo ma talianin, cioè con passaporto italiano.7 Fishman visitò l’Egitto solo nel 1979 e rimase colpito dal paese, che ricollegò ai racconti del nonno. Il ‘chilometro d’oro’ del titolo è la zona ove vissero i ricchi mercanti caireni durante la prima metà del secolo. Ovviamente è lì che si svolge l’azione del libro, che si può chiamare memoriale di famiglia, romanzo o ricostruzione storica. Preferirei parlare di romanzo storico, non solo perché manca qualsiasi apparato metatestuale o bibliografico od anche un albero genealogico, sussidio non di rado offerto ai lettori di una storia famigliare, ma soprattutto perché l’autore non ci tiene a connettere i personaggi alla sua vita. Hanno una certa loro indipendenza che rende attraente il libro e lo libera dalle costruzioni che spesso rendono pesanti i memoriali. Interessanti sono le tracce del pluralismo linguistico della comunità egiziana, fatto ancora riscontrabile a Istanbul. Oltre ai numerosi prestiti e realia che descrivono la vita al Cairo, si hanno esempi di frasi quali: “Mais non, ma no, don’t worry, chérie, c’est l’Egypte!”8 Che Fishman prediliga la scelta lessicale capace di esprimere l’internazionalità del mondo egiziano, illustra, fra tanti altri, il seguente esempio: La taula, tavola in arabo, un gioco con cinquemila anni di storia e tanti altri nomi: shesh besh per i Turchi e nel Mediterraneo, backgammon nei paesi angloassoni. Emozionante e veloce, ma appassionante anche nella versione lenta, la Mahbousa, ideale per quelli che vogliono giocare d’azzardo.9 In fondo, il principale filone tematico del libro è la lenta discesa social‐economica degli italiani, ebrei e no, in Egitto. Laddove all´inizio del Novecento costituivano una delle comunità estere più attive nel Paese, con l´avvento delle leggi razziali fasciste e poi con le sconfitte militari subite dal regime si compromette la loro posizione. Sono gli inglesi che con la loro maggior esperienza e fortuna risultano vincitori del conflitto bellico, anche se per poco. Con il re Faruk, inizia a predominare sempre di più l´elemento arabo, che seguirà una politica vieppiù radicale finché il colpo di stato di Nasser porterà al potere l’atteggiamento nazionalista, xenofobo e fortemente antisemita. Dopo la crisi di Suez del 1956, per gli stranieri non ci sarà ormai più posto in Egitto. Alla ricostruzione di Fishman si è affiancata ora una recente testimonianza al femminile, Come ladri nella notte di Carolina Delburgo (2006). L’origine della famiglia paterna della scrittrice è romana ‒ Del Burgo ‒ emigrata poi in Egitto, quella materna è romaniota (cioè, rappresenta l’antico ebraismo greco di lingua greca), e nello stesso Paese approdò la nonna Simha al tempo della guerra balcanica del 1913. Interessante la descrizione della società egiziano‐ebraica con delle forti distinzioni di classe. Il 163
matrimonio tra David Del Burgo e Simha Molko fu d’amore e ostacolato dal ricco di lui padre. La coppia ha tre figli fra cui Léon, padre della scrittrice, che farà il rappresentante della Philips in Egitto e poi in Italia. La mamma, Annette Cohen, è figlia di genitori di Salonicco emigrati dopo l’incendio del 1917. La storia famigliare della Delburgo – il cognome cambiò a causa di un errore dell’anagrafe – ha il netto profilo dell’ebraismo cosmopolita sefardita, con frequenti spostamenti e reinserimenti, forte multiculturalità e plurilinguismo e spesso grandi famiglie. Benché le intenzioni della scrittrice non fossero letterarie, riesce a descrivere la propria storia, dagli avi fino ad oggi, con tono caloroso ed abbondanza di dettagli – e di fotografie. La grande differenza tra Fishman e Delburgo è che quest’ultima ha vissuto gli stessi eventi che descrive, e quindi ne è testimone, mentre Fishman interroga e ricostruisce un mondo non conosciuto in prima persona con gli strumenti dei ricordi dei suoi e della letteratura. I due punti di partenza sono, in certo modo, complementari. Evento cruciale è, ovviamente, “l’uscita dall’Egitto”, indicata con una perifrasi dell’esodo biblico. Come Fishman, Delburgo narra i cambiamenti politici degli anni cinquanta, la crisi di Suez e l’estradizione degli ebrei dal Paese nel 1956, quando lei aveva dieci anni. Molta attenzione viene prestata al viaggio stesso, incluse le umiliazioni che dovevano soffrire gli ebrei, costretti a lasciare la casa col saliscendi delle merci, come ladri nella notte, ... di nascosto, ... in silenzio, perché nessuno doveva ‘scoprirci’.10 mentre poi le autorità egiziane li sottoponevano ad ogni sorte di vessazioni: Per prima cosa, ogni famiglia doveva trovare le proprie valigie per poi sottoporle al controllo dei doganieri, che si divertivano a capovolgere valigia per valigia sul pavimento, ‘per controllare il contenuto’. In verità, più che controllare, si divertivano ad agire con provocazione, sorridendo con aria di sfida, per esasperarci. [...] Dopo il controllo, ogni emigrante doveva raccogliere tutti i propri indumenti, gettati per terra, e ricomporre la propria valigia, fra le risatine provocanti dei poliziotti e gli impertinenti sorrisi dei doganieri, che davano loro man forte.11 Dal punto di vista della bambina, è il cambiamento che segnò la sua vita, con la presa di coscienza che non avrebbe mai più rivisto il Paese dove aveva vissuto e, poco dopo. la scoperta che non avevano più niente e il papà una volta benestante non poté regalarle nemmeno una bambola nel porto del Pireo. Molto spazio viene dedicato nel libro alla storia dell’inserimento in Italia, che non tace la calorosa accoglienza fatta agli ebrei in Italia. Un’edizione ampliata del libro è in preparazione. La storia che abbiamo qui riassunto in poche parole non è dissimile dalla sorte della Siria. Scrive infatti Silvera: 164 Dalla Siria di Assad all’Egitto di Nasser, dalla Libia di Gheddafi all’Iraq di Saddam Hussein, dall’Iran e dallo Yemen, almeno un milione di cittadini ebrei sono stati improvvisamente messi alla porta.12 Silvera ricorda anche storie a sfondo egiziano, viste sia dagli occhi di un ebreo che da quelli di un italiano non‐ebreo. E non per niente i due paesi hanno vissuto un breve periodo di fusione politica all’insegna del panarabismo. In tal modo, Silvera e Fishman descrivono da una stessa ottica, quella del fascino per la ricchezza culturale di una pacifica convivenza di religioni e etníe e la preoccupazione per le tendenze nazionaliste che pongono fine a tale periodo di benessere e tolleranza, che ha segnato pure la loro storia famigliare. Inoltre, mettono in guardia contro ciò che Silvera nominò, nel frammento letto qui sopra, ‘l’incoscienza’, un’attitudine sempre in agguato. Un chiaro parallelo con i libri di cui abbiamo appena parlato costituisce E venne la notte, romanzo di Viktor Magiar basato sulla propria storia famigliare. Cambia la scena – ora è la Libia. Ma resta l’antisemitismo arabo, l’odio crescente nei confronti degli ebrei locali e la loro espulsione definitiva. Questi libri italiani, nell’esprimere il dramma dell’esilio, si distinguono da quelli di scrittori come Sammy Michael, che scelse di raccontare, nel suo bellissimo romanzo Victoria (1992) la vita degli ebrei iracheni dell’inizio del Novecento senza raccontare gli eventi che hanno segnato la cesura tra passato e presente.13 Quel particolare romanzo di Michael si svolge pertanto in un passato mitico, mentre gli equivalenti italiani confrontano il lettore con l’ineluttabilità della storia che ha per sempre allontanati gli ebrei sefarditi dalla loro penultima patria. L’avvertimento che possiamo raffigurare nei libri dei predetti, può e forse deve essere applicato alla nostra società odierna. Contro l’esempio ottomano della tolleranza etnico‐religiosa, sorge una conflittualità visibile nella maggior parte dei paesi occidentali, diventati multiculturali ma incapaci di gestire tale pluralità. Il declino della tolleranza e della convivenza positiva in questi paesi può provocare risultati che non sono forse gli stessi che nei casi descritti, ma non per ciò meno pericolosi. NOTE Cfr. il mio ‘Ebrei “ottomani”’ (2005). 1
Ibidem, 6. 2
Devarim/Deuteronomio 4/9: “Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste: non ti sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli […]”. 3
Silvera 2001, 13‐14. 4
Silvera 2003, 1. 5
165
Ibidem, 10. 6
Fishman 2006, 19. 7
Ibidem. 8
Ibidem, 68. 9
Delburgo 2006, 62. 10
Ibidem, 63‐64. 11
Silvera 2003, 15. 12
Invece nel suo più recente Majim nosjekiem le‐majim (L’acqua bacia l’acqua, 2001), il protagonista è appunto un ebreo israeliano proveniente dall’Iraq. 13
BIBLIOGRAFIA Delburgo, Carolina. Come ladri nella notte…. L’uscita dall’Egitto, Barletta: Editrice Rotas, 2006. Fishman, Daniel. Il chilometro d´oro, Milano: Guerini, 2006. Israel, Saul. La leggenda del Re Horkha, Milano: Adelphi, 1984. Magiar, Viktor. E venne la notte, Firenze: Giuntina, 2003. Michael, Sammy. Victoria. S.l., s.e., 1992. Silvera, Miro, Lʹebreo narrante, Milano: Frassinelli, 1993. ‐‐‐. Il prigioniero di Aleppo, Milano: Frassinelli 1996. ‐‐‐. Il senso del dubbio, Milano: Frassinelli, 2001. ‐‐‐. Contro di noi, Milano: Frassinelli, 2003. Speelman, Raniero. ‘Ebrei “ottomani”, scrittori italiani. L’apporto di scrittori immigrati in Italia dai paesi dell’ex impero ottomano’. EJOS VIII (2005) http://www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf8/Speelman‐01‐fin.pdf. 166 D’ANGELO, Carmela. ‘La dimensione transculturale della letteratura in lingua italiana di scrittori afferenti alla cultura ebraica del Novecento postbellico’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 167‐183. RIASSUNTO Gli scrittori appartenenti alla cultura ebraica hanno da sempre dovuto confrontarsi, per motivi storici contingenti, con una o più identità nazionali di provenienza, allo stesso modo come si sono trovati ad elaborare lingue proprie – quali lo yiddish e il ladino –, hanno spesso dovuto scegliere la lingua nella quale scrivere e/o, all’occorrenza, hanno optato per soluzioni espressive linguistiche intermedie. Questa necessità di scelta, più o meno consapevole, si ritrova già da qualche tempo anche in altri scrittori definiti da qualcuno ‘nomadi’ e nella cosiddette letterature ‘migranti’. Il saggio, attraverso la lettura di alcuni autori contemporanei, vuole indagare, anche solo come punto di partenza e spunto di riflessione, in che modo la letteratura in lingua italiana afferente al mondo ebraico possa essere considerata un paradigma di tale situazione, sia a livello di soluzioni incontrate sia come possibili indicazioni per il futuro. PAROLE CHIAVE Identità, poliglossia/creolizzazione, nomadismo, universalità/particolarismo, transculturalità © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 167
LA DIMENSIONE TRANSCULTURALE DELLA LETTERATURA IN LINGUA ITALIANA DI SCRITTORI AFFERENTI ALLA CULTURA EBRAICA DEL NOVECENTO POSTBELLICO Maria Carmela D’Angelo Universiteit Groningen PER INIZIARE: ALCUNE DOMANDE L’occasione per queste riflessioni mi è stata data dalla lettura, talvolta rilettura, della narrativa di autori protagonisti di questo convegno, ai quali ho rivolto un’attenzione più focalizzata sulle loro – intendendo con ‘loro’ sia quelle personali sia quelle dei protagonisti dei loro libri – storie di migrazione, colonizzazione/decolonizzazione e di conseguenza identità. Nella letteratura di scrittori provenienti dalla cultura ebraica, o assai vicina ad essa per svariati motivi, si trovano infatti spesso, sparsi qua e là, a volte quasi in maniera casuale, cenni alla condizione intellettuale, religiosa, linguistica dell’essere ebreo o di appartenenza alla comunità israelitica. In questo momento storico nel quale gli interrogativi sulle identità, parola magica del nuovo millennio, nazionali, linguistiche, letterarie e altre, sono diventati tanto più urgenti quanto più profonda e diffusa si fa la consapevolezza rispetto ad avvenimenti di respiro mondiale, pur non pretendendo in questa sede di dare risposte assolute né tanto meno definitive a tali quesiti, si cercherà in ogni modo di dare un ordine il più possibile consequenziale e coerente ad alcuni nodi essenziali, in grado da un lato di indicare percorsi di riflessione e suggerire ipotesi, dall’altro di avviare un processo di approfondimento di problematiche comuni alle letterature attuali. In particolare, credo che l’esperienza associata alla storia millenaria della condizione ebraica possa essere paradigmatica rispetto a quanti si siano trovati nell’immediato passato ma anche nell’attualità, ad affrontare, sia a livello personale sia in campo letterario, una situazione di migrazione/nomadismo o di esilio determinata da diverse contingenze. Il mio percorso riflessivo è stato ulteriormente sostenuto dalla mia formazione di orientalista e archeologa che mi ha condotta a ‘scavare’ nei testi, come si fa su un campo, alla ricerca di testimonianze dirette, delle parole degli stessi scrittori, trovando poi eventuali conferme in saggi e interpretazioni attuali. Capita a volte, infatti, che talune riflessioni coincidano anche se formulate in diversi contesti testuali. Un esempio lo troviamo subito nel romanzo di Primo Levi, Se non ora, quando?: l'usbeco: Ebrei vero? Per me è lo stesso, ebrei, russi, turchi, tedeschi. - Pausa. - Uno non mangia
più di altro quando è vivo. (Levi 1982, 15) 168
corrisponde, quasi letteralmente all’osservazione dell’antropologo culturale Marco Aime: “Una donna o un uomo che hanno fame non sono prima di tutto islamici o induisti: sono affamati” (Aime 2004, 53). Da un punto di vista metodologico, dunque, è stata la stessa lettura a provocare in me alcune domande, alle quali ho poi cercato delle risposte. QUALE NAZIONALITÀ E/O IDENTITÀ? In un mondo fortemente preoccupato e diviso sull’attuale andamento dell’economia mondiale così come sugli equilibri politici che coinvolgono spesso anche l’ambito religioso (il conflitto Oriente‐Occidente, quello tra Cristianesimo e Islamismo), l’esigenza di appartenere concretamente e visibilmente ad una comunità il più possibile definita sembra essere diventata, per alcuni settori delle società attuali, sempre più urgente e indispensabile. In fondo è la storia di sempre: tanto più ci si sente minacciati da presenze esterne sul proprio territorio nazionale, tanto più si parla, per affermarla e difenderla, di una propria supposta identità solida, compatta e unitaria e soprattutto immutata e immutabile nel tempo. Nel caso specifico degli ebrei, laddove più che la convivenza su un unico territorio nazionale, o il possesso di uno stesso passaporto, la religione sembra essere il fattore principale d’identificazione e appartenenza ad una comunità diffusa in tutto il mondo, ci si chiede come venga ‘risolta’ questa esigenza tenendo presente invece il fatto che, come rileva tra gli altri, Amos Luzzato, presidente delle comunità ebraiche, “ogni identità è suscettibile di mutamenti di generazione in generazione e pertanto è difficile definire anche quella ebraica” (in Aime 2004, 106). A me, in quanto ebreo, hanno spesso chiesto anzi, ‘sono stato richiesto’ di spiegare che cosa significhi essere ebreo, che cosa sia in realtà un ebreo. Durante mesi di notti insonni ho tormentato la mia mente, il mio cuore, la mia anima e ho distillato una dolente risposta che vi propongo: ‘Boh?!’ (Ovadia 2005, 48) Con la consueta ironia, ebraica appunto, Moni Ovadia si esprime in questi termini rispetto al tema dell’identità ebraica. Marco Aime, che dedica un intero paragrafo allo stesso tema, racconta come il rabbino Elio Toaff, alla domanda rivoltagli durante un’intervista televisiva, cosa abbia significato per lui essere ebreo, rispose di essersi sentito per la prima volta veramente ebreo nel 1939, quando vennero emanate le leggi razziali del governo fascista. “Prima” – diceva Toaff – “mi sentivo cittadino italiano di cultura ebraica”. Il suo senso di identità venne pertanto indotto da eventi esterni, conclude lo studioso e aggiunge: “Non è stata solo la fede comune, ma anche l’esclusione da parte degli altri a ‘creare’ non gli ebrei in senso assoluto ma gli ebrei in quanto realtà separata dal resto dei cittadini”. In pratica, da quel momento (dalla promulgazione delle leggi razziali), ad Elio Toaff, come ad altre migliaia di persone, venne tolta la possibilità di scegliere chi e che cosa essere (Aime 2004, 105‐11). 169
Gli ebrei allora, proprio nel momento che rappresenta la minaccia più terribile alla loro stessa esistenza, quello dello sterminio nazista, ma forse anche per difendere il diritto in sé alla vita, si appellano, a volte quasi increduli di fronte a tanta assurdità, alla loro cittadinanza nazionale, travalicando, senza peraltro disconoscerla, la loro appartenenza religiosa, e addirittura marcando, in talune occasioni, ulteriori divisioni all’interno delle stesse comunità nazionali ebraiche. Esistono numerose testimonianze letterarie e documentarie a riguardo. Cito, per l’area francese, Le variazioni Reinach di Filippo Tuena: È proprio con questi ebrei profughi stranieri ‐ ebrei tedeschi, russi, polacchi, belgi che a fiumi hanno invaso la Francia in tempi di pace ‐ che se la prende il nuovo occupante (i primi tedeschi) e con una serie di provvedimenti iniziano a innalzare la barriera che separerà ebrei e francesi. [….] Avvengono così i primi sequestri di beni a famiglie israelite, e ad alcuni ebrei di origine straniera o di recente naturalizzazione viene tolta la nazionalità […] Così facendo la prefettura di Parigi separa in maniera rigorosa gli ebrei stranieri da quelli francesi. (Tuena 2005, 141‐42)1 I Reinach si sentono dunque tranquilli, al punto che non li spaventa il fatto di farsi mettere il timbro rosso di juif/juive sui documenti (Tuena 2005, 146), sentendosi anche protetti dal fatto che la loro famiglia ha contribuito in maniera sostanziosa sia alla salvezza che al patrimonio artistico del proprio Paese, la Francia (Tuena 2005, 139; 155‐58). Non si tratta di rinnegare la propria ebraicità, ma di mettere al primo posto la nazionalità. Situazione quasi identica la troviamo in Egitto, quando leggiamo Il chilometro d’oro di Daniel Fishman: I Mosseri, come tutti, erano fieri dei ‘nostri (gli ebrei di cittadinanza italiana) che ce l’hanno fatta’ ma la comunità ebraica aveva anche un altro volto, molto diverso […] gli ebrei indigeni da secoli vivevano fianco a fianco con gli arabi con i quali condividevano la lingua, le malattie e la povertà. (Fishman 2006, 58) Fino a quel momento (1929) sui registri dell’ufficio civile la confessione poteva equivalere alla nazionalità: un cristiano era di nazionalità cristiana, un ebreo di nazionalità ebraica. Solo i musulmani erano iscritti come egiziani. (74) ma le cose cambiano: Era l’autunno del 1938 e anche i talianin d’Egitto si svegliarono apprendendo che le razze esistevano, e che alcuni erano ‘ariani’ ed altri no. (129) Dal fronte orientale giungono le parole di Primo Levi che, nel suo Se non ora, quando? fa dire a Dov: Tenente, io sono russo. Ebreo ma russo. […] Prima di cominciare il nostro viaggio, abbiamo combattuto da russi prima che da ebrei: da russi e per i russi. (Levi 1982, 178) 170
E ancora: Pavel Jurevic Levinski teneva molto al suo patronimico, e meglio al suo cognome troppo rivelatore: lui era un russo ebreo, non un ebreo russo. (58) In Italia, a Ferrara, Giorgio Bassani riporta ciò che aveva fatto scrivere Moisè Finzi‐
Contini Nella lapide che la Comunità, a eternare i meriti di ‘italiano e di ebreo’, aveva fatto affiggere lungo le scale del Tempio…. (Bassani 1976, 9) separando e di conseguenza evidenziando le due diverse componenti identificative, con l’anteposizione, non si capisce se volontaria o casuale, di quella della nazionalità.2 Rispetto all’ulteriore distinzione tra ebrei di nazionalità diversa, Primo Levi fa dire a uno dei suoi personaggi, che gli ebrei italiani sono diversi: perché? Gli ebrei italiani sono strani come i cattolici. […] – E allora come si distinguono dai cristiani quando passano per la strada? – Appunto, non si distinguono. Non è un paese singolare? Del resto, non sono tanti; i cristiani non si occupano di loro, e loro si curano poco di essere ebrei […]. (Levi 1982, 241‐42) A conferma di quanto appena detto, in tutto e per tutto concorde con quella sopra citata del Rabbino Elio Toaff, riporto la testimonianza di Rossana Rossanda che, ripensando alla sua giovinezza, ricorda: Giorgina Moll non la vidi più [...] Ebrea che voleva dire? Chi era ebreo? Nella nostra miscela triestina, l’ebreo non lo trovo, non si diceva attorno a me il tale è ebreo o non lo è – l’ebreo come ‘altro’ lo decide qualcuno, lo decisero il governo, il regime, i fascisti e sembrò di non dover ascoltare quella prevaricazione. (Rossanda 2005, 44) Fino a tardi fra la gente comune le distinzioni fra ebrei e non ebrei non esistettero né nel bene né nel male. Ma il male doveva essere così sornione e la gente così spossessata che la discriminazione si installò senza un sussulto […] Al Lido eravamo di religioni o riti differenti, cattolici, cattolici di rito armeno, ebrei, e fra ragazzi non faceva alcuna differenza. (31) L’anello di congiunzione di questa miscela lo troviamo, secondo l’interpretazione di Claudio Magris, in una cultura che le supera ambedue, ponendosi ad un livello categoriale più alto. Scrive Magris in Microcosmi: Tuttavia la Mitteleuropea è cattolica ed ebraica e quando manca uno dei due elementi essa è sbilenca […] I Tedeschi senza ebrei sono un corpo carente di una sostanza necessaria all’organismo; gli ebrei sono più autosufficienti, ma in quasi ogni ebreo c’è qualcosa di tedesco. Ogni purezza etnica conduce al rachitismo e al gozzismo. Il nazismo, come ogni barbarie, è stato anche imbecille e autolesionista, sterminando milioni di ebrei, ha mutilato la civiltà tedesca e distrutto, forse per sempre, quella mitteleuropea. (Magris 1998, 197) 171
Ritornando all’importanza o meno dell’appartenere alla comunità ebraica nella società italiana, Giorgio Bassani ci presenta altre due voci, che trovo in qualche modo contraddittorie tra loro, anche se, o forse proprio perché, provengono da due personaggi diversi, un padre e un figlio, e dunque da interpretare, possibilmente come il risultato di due diversi punti di vista generazionali. Dice, infatti, il giovane protagonista del Giardino dei Finzi‐Contini che, nonostante una ‘certa speciale complicità e connivenza’, derivante dal fatto di essere ebrei e quindi di frequentare determinati luoghi in determinate occorrenze, Che fossimo ebrei, tuttavia, e iscritti nei registri della stessa Comunità israelitica, nel caso nostro contava ancora abbastanza poco. Giacché cosa mai significava la parola ‘ebreo’, in fondo? Che senso potevano avere, per noi, espressioni quali ‘Comunità israelitica’ o ‘Università israelitica’, visto che prescindevamo completamente dall’esistenza di un’ulteriore intimità, segreta, apprezzabile nel suo valore soltanto da chi ne era partecipe, derivante dal fatto che le nostre due famiglie, non per scelta, ma in virtù di una tradizione più antica di ogni possibile memoria, appartenevano al medesimo rito religioso, o meglio alla medesima scuola? (Bassani 1976, 25) mentre il padre “con una specie di appassionato rancore” dice: Altro che aristocrazia! Invece di darsi tante arie, avrebbero fatto assai meglio, almeno loro, a non dimenticare chi erano, di dove venivano, se è positivo che gli ebrei – sefarditi e aschenaziti, ponentini e levantini, tunisini, berberi, yemeniti e perfino etiopici – [...]. (25) e non è un caso che qui Bassani citi vari gruppi di ebrei senza fare il minimo accenno alle nazionalità: In qualunque parte della terra, sotto qualsiasi cielo la Storia li abbia dispersi, sono e saranno sempre ebrei, vale a dire parenti stretti. (25) Si ritorna così all’inizio della mia trattazione, quando l’essere ebrei non esclude possibili divisioni, anche interne. QUALE LINGUA? Ci sono a mio parere vari aspetti da esaminare rispetto a quest’ambito, visto che la dimensione linguistica, come tutti sanno, investe numerose problematiche, apparentemente molto distanti tra loro ma in realtà tutte concomitanti e in rapporto di interrelazione. Accennerò per il momento solo ad alcuni di essi: uno è sicuramente quello della creolizzazione delle lingue, non disgiunto da quello della scelta della lingua di scrittura rispetto ad un plurilinguismo diffuso, mentre un terzo aspetto distintivo è quello dell’incursione di altre lingue nella scrittura stessa e/o nel linguaggio parlato. Ed è proprio riallacciandomi al tema dell’esilio e del nomadismo permanenti che per scelta o per necessità caratterizzano molte delle famiglie ebree, riparto con la 172
ricerca sulla lingua: quali lingue parlano gli autori che qui trattiamo e soprattutto quale lingua scelgono come mezzo espressivo per la loro scrittura. Da questo stesso punto riparte Moni Ovadia citando uno dei più grandi scrittori della letteratura europea, Franz Kafka: Nell’esilio si perdono molte cose, prima di tutto la propria lingua. Alla prima generazione già vacilla, alla seconda si sgrana, alla terza verosimilmente, viene inghiottita dal nuovo territorio linguistico. Ciò non accadeva alla lingua che noi vi cantiamo, lo yiddish, che al contrario, dell’esilio e per l’esilio viveva e di esso si alimentava, ribollendo come il mosto a primavera. Incontrando questa lingua sul suo cammino, così ne parlava un grande Saggio di Praga, rivolgendosi ad un pubblico della borghesia ebraica praghese di lingua e cultura tedesche: […] Lo yiddish è la più giovane lingua europea, non ha che quattrocento anni, e in realtà è ancora più recente. Non ha ancora formato strutture linguistiche così nette come ci sono necessarie. Le sue espressioni sono brevi e nervose. Non ha grammatica. Certi amatori tentano di scrivere delle grammatiche, ma lo yiddish viene parlato senza sosta, e non trova pace. Il popolo non lo cede ai grammatici. Esso si compone solo di parole straniere. Queste però non riposano nel suo seno, ma conservano la fretta e la vivacità con cui sono state accolte. Lo yiddish è percorso da un capo all’altro da migrazioni di popoli. Tutto questo tedesco, ebraico, francese, inglese, slavo, olandese, rumeno e perfino latino che vive in esso è preso da curiosità e da leggerezza, ci vuole una certa energia a tenere unite le varie lingue in questa forma. Perciò nessuna persona ragionevole penserà mai a fare dello yiddish una lingua internazionale, benché l’idea si offra quasi da sé […]. (citato in Ovadia 2005, 24) E Primo Levi sottolinea: (Mendel) si stava invece domandando perché Leonid, la cui lingua madre era il russo, si fosse servito del jiddish, che parlava con stento, in quella occasione: ma il jiddish, tutti lo sanno, è un immenso serbatoio di insolenze pittoresche, ridicole o sanguinose, ognuna con la sua sfumatura specifica: poteva essere una spiegazione. (Levi 1982, 30) perché questa è proprio una delle ricchezze dello yiddish, la possibilità di scelta. All’altra lingua parlata dagli ebrei, il ladino, fa cenno Fishman a proposito dei suoi personaggi in Egitto. Victoria, la madre di Mondo, di origine livornese che aveva vissuto diversi anni a Rodi, Aveva la calata particolare di chi parla il ladino, il dialetto giudaico‐spagnolo parlato da molti ebrei nell’area mediterranea. Un pinzimonio linguistico condito anche dall’olio greco e dalle spezie turche. (Fishman 2006, 40‐41) Helga, la moglie di Felice, invece è tedesca askenazita e parla con un accento diverso, differenza più volte sottolineata dagli stessi personaggi del libro: […] ‘(Il gioco degli scacchi) va benissimo per voi vus vus’. Utilizzava volutamente questo termine. Era una storpiatura di vas vas ‘cosa? cosa?’ in tedesco. I sefarditi così volevano sottolineare l’estraneità dei loro ‘fratelli’ di origine est‐europea rispetto al mondo levantino. (98) 173
La sottolineatura di questa differenziazione, così come l’importanza del saper parlare yiddish in quanto identificativa dell’appartenenza alla comunità ebraica, si trova ancora una volta in Primo Levi: Józek, metà per scherzo, metà sul serio, osò addirittura mettere in dubbio che Arié fosse ebreo; chi non parla jiddish non è ebreo, è quasi un assioma, e lo dice anche il proverbio: Redest keyn jiddish, bist nit keyn jid. –Se sei ebreo, parlaci in ebraico: dicci una benedizione in ebraico. Il giovane accettò la sfida, e recitò la benedizione del vino con la pronuncia sefardita, rotonda e solenne, invece che in quella askenazita, sincopata e stretta. Molti risero: – Ih, parli ebraico come lo parlano i cristiani! – No, – rispose Arié nobilmente offeso: – noi parliamo come Abramo nostro padre. Siete voi che parlate sbagliato. (Levi 1982, 145) Il processo di creolizzazione linguistica descritto da Kafka è tipico d’altronde delle società caratterizzate da un diffuso multilinguismo, elemento che, per quanto ci riguarda espressamente in questa sede, si ritrova anche nell’attualità sempre più ampiamente, non solo circoscritto a zone regionali definite – zone di confine o comunità isolate. D’altra parte, e qui passiamo al secondo aspetto delineato all’inizio del paragrafo, la condizione comune a molti autori di origine ebraica, di vivere, per vari motivi, loro stessi o attraverso le loro famiglie una situazione di nomadismo, li porta quasi automaticamente alla poliglossia e quindi a dover poi scegliere una lingua per la scrittura che non coincide sempre o per forza con la lingua madre, né con quella della cittadinanza né, di nuovo, con quella della nazione in cui vivono, insomma non dipende da fattori contingenti ma anzi spesso da una serie di altri fattori a volte così intimi che, se non espressi, sono solo ipotizzabili.3 Quest’ultimo potrebbe essere il caso di Elena Janeczek,4 poetessa e scrittrice di lingua tedesca, nata a Monaco di Baviera da genitori ebrei di origine polacca – pur non essendo il polacco la sua vera lingua madre, dato che non le è stato insegnato – che da molti anni vive in Italia e ha scelto l’italiano come lingua d’elezione ripudiando il tedesco in quanto lingua di chi ha inventato i campi di concentramento, così come Elisa Springer, nata a Vienna nel 1918 che, forse, ha trovato nell’italiano un modo per distanziarsi dalla sua lingua di nascita, anche se è proprio in Italia dove, trasferitasi nel 1940 in seguito alle persecuzioni ebraiche in Austria, era stata denunciata alle SS da una donna italiana, arrestata e deportata ad Auschwitz, da cui sarebbe ritornata per ristabilirsi definitivamente in Italia.5 Che la lingua sia importante proprio perché può ‘tradire’ l’identità di una persona – meglio la sua storia – o attribuirgliene una piuttosto che l’altra, lo vediamo anche nel personaggio di Mendel di Primo Levi: Chi è Mendel figlio di Nachman? Mendel Nachmanovic, alla maniera russa, come era scritto sul ruolino del plotone, o Mendel ben Nachman, come a suo tempo, nel 1915, aveva scritto sul registro di Strelka il rabbino dei due orologi? (Levi 1982, 17) 174
Anche Marina Jarre ha dovuto scegliere una lingua per scrivere, e lo ha fatto con l’italiano, lei nata nel 1925 a Riga da madre italiana valdese e padre lettone di religione ebraica, che in seguito alla separazione dei genitori nel 1935 fuggiva dalla Lettonia con il cognome Gersoni insieme alla madre e alla sorella ritornando in Italia, e stabilendosi a Torre Pellice. Identica scelta hanno fatto, tanto per rimanere nell’Europa nord occidentale, i fratelli Giorgio e Nicola Pressburger nati a Budapest nel 1937, trasferitisi in Italia nel 1956; Edith Bruck nata pure in Ungheria da una famiglia ebraica, vissuta tra l’Ungheria e l’Italia, ove si è stabilita definitivamente nel 1954 dopo aver subito le discriminazioni razziali e la deportazione a soli dodici anni ed essere sopravvissuta ad Auschwitz; Alain Elkann giornalista e scrittore nato a New York da padre francese e madre italiana. E non possiamo certo tralasciare, anche se risale alla metà dell’ottocento , uno dei casi forse più eclatanti, quello di Italo Svevo, all’anagrafe Aron Ettore Schmitz, pseudonimo che mai più abbandonerà in quanto accosta le sue due culture e lingue (gli studi erano stati compiuti in tedesco, in casa parlava triestino). Alcuni critici attribuiscono al suo bilinguismo, che non contempla l’italiano tra le lingue parlate dall’autore, il suo stile mal riuscito. D’altro canto il caso di Svevo non è isolato, dato che quasi tutti gli autori di area triestina sono per forza di cosa bi‐trilingui, come Rossana Rossanda che sceglie l’italiano: Sono nata negli anni venti a Pola con sconcerto delle anagrafi: nata a Pola (Italia), a Pola (Iugoslavia), a Pola (Croazia); […] Papà e mamma parlavano tra di loro in tedesco. Mai con noi, forse volevano fare delle figlie due persone normali invece che gente di due luoghi, due origini e tre lingue. Papà non aveva voluto sostenere in tedesco la tesi a Vienna, e quel tollerante impero gli aveva permesso di discuterla in latino […]. (Rossanda 2005, 5‐6) Nell’Egitto di Fishman circolano così tante lingue che solo negli anni venti il Re dichiarò l’arabo lingua ufficiale, decisione che non fu molto gradita (Fishman 2006, 63). Mentre l’autore osserva che: La Sinagoga di Rav Haim Capussi era dedicata ad un rabbino italiano discepolo del cabalista Luria. Il suo vero nome era Cappucci, ma in Egitto come era successo anche per nonno (da Edmondo a Mondo). […] le storpiature e le traslitterazioni trasformavano rapidamente e per sempre le denominazioni originali. (Fishman 2006, 18; 137)6 La stessa osservazione di poliglossia riguarda anche gli autori – ebrei ‘ottomani’ ma scrittori italiani – esaminati da Raniero Speelman (Speelman 2005, 1‐32). Oltre alla condizione di persone con più lingue a disposizione, a proposito della sensibilità degli ebrei per le lingue si esprime Erri De Luca, lui stesso studioso e traduttore autodidatta di testi biblici, quando descrive Rafaniello, il calzolaio ebreo venuto a Napoli da qualche pizzo d’Europa dopo la guerra, che parla yiddish, canta in una lingua straniera e sa il napoletano, (che) dice che somiglia alla sua 175
lingua. L’italiano gli sembra una stoffa, un vestito sopra il corpo nudo del dialetto. (De Luca 2003, 16‐17) il protagonista bambino si stupisce che […] un calzolaio straniero sa parlare così preciso in italiano che io mi commuovo per babbo che si sforza d’imparare e non sa la metà delle parole di Rafaniello. Avete avuto in sogno pure il vocabolario italiano, gli chiedo. No, dice, l’ho preso dai libri, leggendo molte volte Pinocchio. (67) perché quando si impara una lingua la si sa meglio di altri, spesso anche la grammatica. Anche nel Giardino dei Finzi‐Contini di Bassani, il padre del protagonista‐
narrante afferma con orgoglio, riferendosi ad un articolo scritto da Trotski: Che vivacità, che lingua! Capacissimo di aver steso l’articolo direttamente in francese. Già, gli ebrei russi e polacchi saranno magari poco simpatici, però hanno sempre avuto un vero genio per le lingue. Ce l’hanno nel sangue. (Bassani 1976, 53) In questo stesso romanzo mi sembrano inoltre molto significative le incursioni di altre lingue;7 a parte l’ebraico classico, che viene usato solo per riferirsi ad elementi rituali, quindi senza traduzione – talèd/taletòd, mignan, sefarìm – , Bassani usa volentieri, sparse qua e là, ma in maniera molto naturale soprattutto nelle frasi inserite come discorso diretto, parole francesi – a volte intere frasi o citazioni tedesche – derivate probabilmente dalla nonna materna tedesca: privat, verboten, Hütte, Fraülein, inglesi, o in dialetto veneto. Lo stesso si osserva in tutto il libro di Fishman, dove ci sono molto frequentemente termini francesi, arabi e inglesi. Di questi termini non si dà traduzione, ma la spiegazione di ciò è data nel testo stesso e ci fa riflettere su un altro aspetto linguistico, pure molto importante, quello della traducibilità: (Alfredo) era soddisfatto, mabsut, come dicono qui in Egitto. Effettivamente però, questo era proprio un punto su cui era in difficoltà. Aveva tolto dal suo vocabolario ogni inglesismo, ma in compenso gli capitava, sempre più spesso glielo facevano notare, di utilizzare termini in arabo […] Ma mi si dica come posso spiegare in italiano, al meglio, e con non più di una parola, il concetto di mabsut? L’Egitto gli era entrato in circolo. (Fishman 2006, 112‐13) Queste due ultime caratteristiche si stanno diffondendo sempre di più in altri scrittori di altre
aree culturali, ma con la stessa condizione di nomadismo – culturale in senso lato oltre a
fisico personale: mi riferisco ai vari Luigi Meneghello, Carmine Abate, Laura Pariani, tanto
per fare alcuni nomi tra i più noti. Con questa ultima osservazione voglio sottolineare che ciò
che in altri scrittori è visto come un fenomeno recente da studiare e classificare, per gli
scrittori ebrei, come abbiamo appena visto, sia dal punto di vista della lingua parlata che
scritta è elemento comunemente diffuso e risale a tempi molto più lontani. 176
PER FINIRE: ALCUNE IPOTESI O ALTRE DOMANDE Per arrivare alla conclusione di questo percorso riflessivo, non si può evitare di accennare al tema dell’esilio8 e più in generale del viaggio. Senza di essi, infatti, probabilmente non ci troveremmo ad affrontare questi temi. La storia di Van Straten è al riguardo emblematica: se scorriamo i capitoli del suo libro, a partire dal 1811 fino all’ultima data del 1999, il risultato è un lungo viaggio che parte da Rotterdam per arrivare a Firenze, attraverso città del Nord e Sud America, dell’Est europeo e dell’Italia, dal nord al centro al sud (solo l’Asia e l’Africa non vengono ‘toccate’). Come già era successo dalla fine dell’Ottocento per gli italiani che andavano in Nord e Sud America,9 tocca ora all’Italia accogliere, insieme agli ‘sbarchi’ sempre più frequenti sulle nostre coste, i nuovi scrittori. Siamo di fronte ad un fenomeno come quello della letteratura dei mondi, che comincia a formare una rete planetaria di conoscenze e di riconoscimenti, di traduzioni e di multiple reciprocità, dice Armando Gnisci, e sarà la poetica dell’avvenire.10 Ma quello che per noi può essere considerato un fenomeno relativamente recente, per la comunità ebraica è quasi la storia di sempre. Che gli ebrei siano da sempre esuli e nomadi, con il conseguente risultato di far parte di famiglie multietniche e multilingue, è noto a tutti. Cito ancora una volta Primo Levi: Sono ebreo anch’io, Panie Kondotierze, – disse Gedale con la voce tranquilla. – Queste armi non le abbiamo rubate, e le sappiamo usare piuttosto bene. Voi combattete da cinque anni, e noi da tremila. Voi su due fronti e i nostri fronti non si possono contare […]. (Levi 1982, 144) La domanda, formulata sotto forma di ipotesi conclusiva, che mi pongo è allora questa: può la millenaria esperienza ebraica aiutarci a comprendere meglio questa nuova situazione, alla luce dei concetti di transnazionalizzazione e transculturalizzazione in quanto vanno ‘oltre’ i prefissi multi‐ pluri‐ e inter‐ per i quali la condizione stessa degli ebrei potrebbe essere considerata un precedente ante litteram? A questo proposito, chiarisce Sabrina Brancato: La flessibilità a livello culturale si traduce in mobilità e alterazione continua dei significati e delle identità culturali. Infatti, lungi dal produrre un’omogeneizzazione della cultura, come era stato in un primo momento previsto e temuto, la transnazionalizzazione, con la varietà dei fenomeni che la accompagnano (migrazione, mobilità, circolazione di prodotti, idee, immagini, sapere, ecc.), si sta manifestando in un evidente aumento della diversità culturale, diversità che prende comunque una forma nuova rispetto al passato poiché le fitte interconnessioni e la crescente deterritorializzazione rendono sempre più difficile, se non impossibile, incasellare diverse culture come unità discrete.11 Che ad un certo punto l’incontro tra culture generi una ‘nuova’ identità lo testimonia, riferendosi all’emigrazione italiana in Argentina, molto efficacemente Erri De Luca, un ‘appassionato’ dell’ebraismo, autodidatta, traduttore dei testi sacri pur non essendo ebreo: 177
Da dove imparo, chiede. Dall’Argentina della gioventù, dai vecchi italiani di allora capaci di fare vino negli orti di Buenos Aires. Ora non ci sono più vecchi italiani, né nuovi. Ora lì sono tutti argentini. (De Luca 2004, 60) A sua volta, l’Italia stessa, che proprio per la sua posizione geografica ha da sempre svolto una funzione storica e culturale di ponte tra Occidente e Oriente, potrebbe essere indicata come l’esempio più rappresentativo di incontro tra culture diverse, anche se gli europei e gli stessi italiani se ne sono dimenticati. Guardiamo solo i siciliani: chi sono veramente? Fenici, greci, siculi‐sicani‐enotri, arabi, normanni, angioini, svevi, francesi, spagnoli, o meglio il risultato di tutto questo? Dal canto loro, la condizione stessa dell’appartenere, volenti o nolenti all’ebraismo, senza un territorio fisso, senza ‘patria’, ha portato gli ebrei stessi a rimanere unici e nello stesso tempo individui, pur appartenendo ad una comunità internazionale, questa sì riconoscibile e riconosciuta da tutti; dunque popolo con tradizioni comuni legate alla religione ma nello stesso tempo unico nel senso delle scelte individuali. Il fatto stesso d’essere trasmigranti ha permesso loro di contaminarsi con altre culture accogliendole dentro di sé, pur rimanendo se stessi. Così si esprime il filosofo Cioran a questo proposito: Il più intollerante e il più perseguitato dei popoli, unisce l’universalismo al più stretto particolarismo. (citato in Ovadia 2005: 49) Ricalcando quello che anche Elias Canetti ha detto di sé: “ […] io però porto ancora in me unʹeredità universalmente umana” (7). Questa affermazione, ribaltata all’opposto secondo un movimento biunivoco, coincide quasi del tutto con le due seguenti di Claudio Magris: L’Ebraismo è stato ed è l’esempio di un’estrema diversità, di un’alterità irriducibile, che sembra inaccessibile e straniera nei suoi riti, nelle sue abitudini, nella sua lingua, ma che coincide misteriosamente con l’universale umano. In un mondo che da un lato si disgrega nel delirio dei molti che non s’intendono e dall’altro livella le diversità in un appiattimento anonimo, il problema centrale è quello della diversità che non neghi bensì incarni, nella sua peculiarità, l’universale‐umano. L’Ebraismo è uno dei volti di questa universalità variegata. (Magris 2006, 108, 111) In questo senso, il nomadismo legato all’esilio non deve essere visto necessariamente in senso negativo in quanto ha anche connotazioni positive: L’esiliato non può concedersi il lusso di riposare sulle certezze e i sonni dell’autoctono: deve costantemente riflettere sulla sua condizione esistenziale, e per questo il suo spirito si fa vigile e inquieto. Nasce un’anima dell’esilio mobilissima e ubiqua. (Ovadia 2005, 19) Esso porta infatti per forza di cose verso una dimensione transculturale più che multi/pluriculturale, che ha una dimensione sommativa e quindi orizzontale, nel caso della lingua, l’uso di una lingua base sulla quale vengono innestate espressioni 178
lessicali autoctone, oppure interculturale, cioè che dispone le culture sempre orizzontalmente sotto forma di incontro o scontro. Si può forse invece affermare che sia lo yiddish che il ladino sefardita abbiano connotazioni transculturali proprio perché ‘attraversano’ varie lingue, ebreo‐tedesco nel primo caso ed ebreo‐
portoghese‐spagnolo nel secondo, dando luogo ad una forma di creolizzazione e inventandone così una nuova, affatto avulsa dalla cultura, ovvero artificiale – come nel caso dell’esperanto, in quanto non si rifà propriamente a nessuna cultura – ma comprensiva di tutte le culture di contatto. Si può allora a buon diritto parlare di transculturalismo in quanto queste lingue travalicano la scelta di una sola lingua legata ad un territorio nazionale o ad una nazionalità geografica. Come conclude Sabrina Brancato nel suo interessante articolo elettronico già citato che riprende le idee di Welsch,12 Appadurai, Schulze‐Engler: La transculturalità deve essere intesa, in ambito letterario, come cornice teorica che comprende diversi fenomeni di interazione culturale (dall’intertestualità postcoloniale all’ibridazione e creolizzazione cross‐culturale fino alle modernità multiple del mondo globale) e permette di estrarre le nuove letterature dagli stretti confini del nazionale e del regionale e di rivedere il locale e il diasporico da un punto di vista globale. A un livello più generale, il transculturalismo è l’altra faccia della globalizzazione, una risposta ideologica alla minaccia dell’omogeneizzazione culturale da una parte e a quella degli essenzialismi fondamentalisti dall’altra, una porta che si apre su percorsi molteplici, i nuovi orizzonti dell’identità culturale. Se guardiamo all’esperienza ebraica sotto questa dimensione transculturale, se ne può trarre ispirazione come paradigma rispetto ai nuovi ‘nomadi’ e di conseguenza alle cosiddette nuove letterature che attraversano l’Italia contemporanea per i vari aspetti qui esaminati: per le nazionalità plurime e per la complessità delle composizioni famigliari; per la poliglossia; per la capacità di creare nuove lingue attraverso mescolanze e inserimenti lessicali, in quanto portato delle diverse lingue ‘appartenenti’ all’autore stesso; infine per l’affermazione di una propria origine culturale comune coesistente con un’identità personalizzata, in quanto non esclude, dato che non li disconosce, singoli elementi condivisibili con altri gruppi di persone. Ne consegue che anche la scelta della lingua di scrittura diventa scelta individuale che dipende da varie circostanze. L’appartenenza all’ebraismo non è più quindi l’unico elemento determinante per la propria sopravvivenza espressiva. Proprio per la loro condizione di ‘stranieri perenni’, la loro millenaria esperienza nella rivendicazione di una personalità unica ma solidale, gli ebrei hanno dovuto scegliere tra le diverse identità secondo un’idea di ‘personalizzazione’ che si sta facendo strada nella nostra mentalità europea solo ora, in quanto possibilità di sostenere quale elemento della propria personalità/identità possa essere ‘tirato fuori’ in quale momento a seconda della situazione. Cito le parole poetiche di Amadou Hampâté Bâ a proposito della complessità interiore degli uomini: “Maa ka maaya ka 179
ca a yere kono”. In bambara significa: le persone di una persona sono numerose in ogni persona. “Mia madre, quando voleva vedermi, aveva l’abitudine di chiedere a mia moglie: ‘Quale delle persone di mio figlio abita qui oggi?’” (in Aime 2004, 57). Queste parole sembrano ricalcare queste altre di Primo Levi: La coda procedeva a rilento e Mendel meditava pensieri informi e contrastanti. Mai tanto straniero, anche lui: russo in Italia, ebreo in cospetto del Duomo, orologiaio di villaggio in una grande città, partigiano in tempo di pace: straniero di lingua e d’animo, straniero estraniato da anni di vita selvaggia. (Levi 1982, 246) Perché si può esser ebrei, ma si è anche italiani, scrittori, donne/uomini, e così via e la risposta a tutto è forse proprio nella scelta e nell’avere questa possibilità. E che tale scelta corrisponda ad un grande atto di coraggio, in quanto ne deriva una serie di conseguenze piuttosto rilevanti, ce lo fa capire l’Alfredo di Fishman: Sorry sir, ci deve seguire […] Alfredo non oppose resistenza né fece valere il fatto di avere la madre ebrea, variabile che forse gli avrebbe evitato l’internamento. La sua fede fascista lo aveva convinto da tempo a non porsi problemi di identità: si dichiarava italiano, anzi, un fascista italiano! (Fishman 2006, 149)13 mentre non fa a tempo, o non ne ha la possibilità in quanto non si tratta di una vera scelta, ma di una necessità, l’altro protagonista del libro, Mondo, sulla nave che lo porta in Italia dopo essere stato imbarcato di fretta e di nascosto: Un ritornello di quesiti ritornava circolarmente nella sua testa. In fondo perché sono dovuto partire? Perché sono gli altri e non noi a decidere del nostro destino? Perché devo lasciare questo paese a cui ho dato tutto e a cui devo molto? (222) Ed è proprio, come sottolinea di nuovo Claudio Magris “[…] in questa capacità di essere Ognuno, che consiste la grandezza dell’essere umano” (2006, 162), e è forse da questo particolarismo nell’universalismo umano, che sembra caratterizzare la condizione ebraica, che possiamo trarre insegnamento. Il vero dramma avviene quando si viene privati dalla possibilità di scegliere e ritorniamo a quello che diceva il rabbino capo Elio Toaff all’inizio: “come ad altre migliaia di persone venne tolta la possibilità di scegliere chi e che cosa essere”. Un’altra risposta, ce la offre Edith Bruck,14 sopravvissuta ad Auschwitz, dove ha perso i genitori e alcuni parenti, che ha vissuto tra l’Ungheria e l’Italia, ove si è stabilita definitivamente nel 1954: Amo questo Paese (l’Italia), ma ciò non mi impedisce di denunciare quelle che sono le sue innumerevoli carenze, soprattutto politico‐istituzionali […] l’Ungheria, il Paese natale, mi manca, e cerco di tornarci spesso. Ma non dimentico che è stata proprio l’Ungheria a darmi in pasto ai leoni e a uccidere barbaramente i miei genitori. Credo comunque che la nazione d’appartenenza abbia un’importanza relativa e che ognuno possa rimanere se stesso indipendentemente dal contesto in cui vive. 180
E a questo proposito, rifacendomi all’esperienza italiana dei nostri giorni, esiste ancora un’altra via, quella di ricominciare tutto daccapo. È quello a cui aspira un giovane albanese per sé e suo figlio, nel film LAMERICA di Gianni Amelio: Ora che vengo a Italia, voglio trovare una ragazza di Bari. Mi voglio sposare con quella e fare molti figli. Non voglio parlare mai la lingua albanese con figli miei; voglio parlare solo la lingua italiana, così figli scordano che io sono albanese. Nell’introduzione ad Oylem Goylem, dice Claudio Magris: Leggere, ascoltare, vedere sulla scena Moni, per me, significa inoltre ritrovare, diverse ma simili, molte cose del mio vissuto, per quella strana affinità elettiva che mi ha condotto tante volte a riconoscermi nell’ebraismo e che anni fa, durante un convegno di letteratura yiddish a Eisenstadt, induceva un rabbino viennese a chiedermi se ero ebreo e, alla mia risposta negativa, a protendere le braccia in avanti, quasi per rassicurarmi, dicendo: “Era solo una domanda”. (Ovadia 2005, ix) E se rivolgessimo questa stessa domanda a tutti: non siamo, forse, un po’ tutti ebrei? NOTE 1
Inoltre si precisa: “I tribunali della Senna erano oberati, da qualche mese, da traffici clandestini, i cui responsabili erano quasi sempre ebrei di nazionalità straniera. Così facendo la prefettura di Parigi separa in maniera rigorosa gli ebrei stranieri da quelli francesi, separa anche i ricchi dai poveri” (147).
Rispetto a questo stesso tema dell’identità nazionale anteposta a quella religiosa, ben noti sono i casi documentati proprio nella letteratura tedesca; un esempio fra tutti, Fred Uhlman (1996, 77‐78), tedesco ed ebreo: “Eravamo prima di tutto svevi, poi tedeschi e infine ebrei” afferma Hans, il protagonista della storia, e di seguito “Come osa offendere la memoria dei dodicimila ebrei che hanno dato la vita per questo paese (la Germania). Für unsere Heimat?”. 2
Dalla realtà alla letteratura: per Helga Schneider, tedesca, imparare l’italiano voleva dire dimenticare la madre SS. Per lei è stata una salvezza: “Mi sono rivolta alla lingua italiana con una passione incredibile; poi, essendo di sangue slavo, la nonna boema, il nonno mezzo ucraino, genitori viennesi […] insomma, ho un grande talento per le lingue.” Così Davide Bregola in ‘Mi sembrava che la gente cantasse’ (2004). 3
Davide Bregola riporta queste parole di Helena Janeczek: “mi sono trasferita in Italia nel 1983, mi sono iscritta all’università, ho cominciato a usare l’italiano scritto per lavoro, alla fine – molto ma molto fuori corso – ho fatto la tesi in italiano (incubo). Nel frattempo ho continuato a scrivere poesie in tedesco e nel 1989 sono riuscita a pubblicare la raccolta Ins Freie (Verso l’aperto), con la Suhrkamp di Francoforte. Passano gli anni, e mentre per la necessità di scrivere continuo a coltivare l’orticello poetico tedesco, la mia vita si svolge sempre più in italiano, l’italiano diventa la lingua che parlo con più facilità e ricchezza d’espressione, la lingua in cui comunico con gli altri ed è così che comincio a scrivere qualche pezzo in prosa, semplicemente per condividerlo con gli amici. È da uno di questi pezzi che nasce Lezioni di Tenebra: dalle prime due pagine di cui mi accorgo che potrebbero essere l’inizio di una cosa più lunga, più grande, di un libro intero. Allora mi chiarisco le idee e vado avanti. 4
181
E mentre ci lavoro, sento che sto trovando uno stile e un modo di raccontare che mi appartiene, cosa che, nonostante il contenuto del libro, mi dà energia” (Ibidem). Costa 1998. 5
Altri esempi di storpiature e traslitterazioni: jelati gelati, gazuza gassosa (Fishman 2006: 136) e pasiensa pazienza e lo stesso talianin italiani (Fishman 2006, 81). 6
Cfr. anche Speelman 2004 per la presenza di termini ebraici nei testi di scrittori italiani. 7
Interamente dedicato all’esilio e al cosiddetto mito dell’ebreo errante, il saggio di Magris 1971. 8
Stella 2002 e Bevilacqua 2001. 9
Dalla recensione di Guido Conti, Italia Oggi (1.02.2003) allo stesso libro (Bregola 2002, 147) http://digilander.libero.it/vocidalsilenzio/daquibregola.htm. Armando Gnisci è ritenuto uno dei più autorevoli e appassionati esperti del settore. Tra i suoi ultimi contributi sull’argomento: Gnisci 2006. 10
Brancato 2004. In questo articolo elettronico è possibile trovare tutti i riferimenti bibliografici degli studiosi che vengono citati in quest’ultimo paragrafo. 11
Secondo Wolfgang Welsch i concetti di multiculturalismo e interculturalismo, sia come modelli di interazione culturale che come ideologie, dovrebbero essere superati in favore di un modello analitico ed operativo basato su una nuova concettualizzazione della cultura, che emerge dai diversi dibattiti interdisciplinari sulla transnazionalizzazione, elaborata come “transculturalità” (Schulze‐Engler 2002). 12
Alfredo in questa situazione, cioè quando sta per essere arrestato, sceglie tra le varie identità quella di italiano‐fascista, mentre avrebbe potuto scegliere di dichiararsi di madre ebrea – quale in effetti era – e così salvarsi. In questo sta la grandiosità: nella capacità di scegliere, anche una dimensione sfavorevole. 13
Bruck & Cinanni in ‘Il dovere della testimonianza’. 14
BIBLIOGRAFIA Abate, Carmine. Il muro dei muri. Roma: ARGO, 1993. ‐‐‐. La festa del ritorno. Milano: Mondadori, 2004. Aime, Marco. Eccessi di culture. Torino: Einaudi, 2004. Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: U of Minnesota P, 1996. Bassani, Giorgio. Il giardino dei Finzi‐Contini. Milano: Mondadori, 1976. Bevilacqua, Piero, e.a. Storia dell’emigrazione italiana. Roma: Donzelli, 2001. Brancato, Sabrina. ‘Transculturalità e transculturalismo: i nuovi orizzonti dell’identità culturale’. [2004] ALL – L’Associazione ‒ 25.06.07 http://web.uniud.it/all/simp/num2/articoli/art4.html. Bregola, Davide. Da qui verso casa. Roma: Edizioni Interculturali, 2002. ‐‐‐. ‘Mi sembrava che la gente cantasse’. [2004] http://www.comune.fe.it/vocidalsilenzio/atti04bregola.htm. 182
Voci dal silenzio – 30.05.2007 Bruck Edith & Cinanni Maria Teresa. ‘Il dovere della testimonianza.’ [1999] Caffè Europa – 30.05.2007 http://www.caffeeuropa.it/attualita/98ebraismo‐bruck.html. Costa, E. ‘Recensione a: Springer, Elisa. Il silenzio dei vivi. Allʹombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione. Venezia: Marsilio, 1998’. LʹIndice 8 (1998). Carrozzini, P. Antonio. Grammatica della lingua ebraica. Torino: Marietti, 1960. D’Angelo, M. Carmela. ‘Identidad (transnacional) entre espacio geográfico y espacio interior: escritoras italo‐argentinas’. Mujeres, espacio y poder. S.l.: Editorial ArCiBel Editores, 2006, 178‐179. De Luca, Erri. Montedidio. Milano: Feltrinelli, 2003. ‐‐‐. Tre cavalli. Milano: Feltrinelli, 2004. Fishman, Daniel. Il chilometro d’oro. Milano: Guerini e associati, 2006. Gnisci, Armando. Nuovo Planetario Italiano. Troina: Città aperta, 2006. Janeczek, Helena. Lezioni di Tenebra. Milano: Mondatori, 1997. Jarre, Marina. Un leggero accento straniero. Torino: Einaudi, 1972. Levi, Primo. Se non ora, quando? Torino: Einaudi, 2004. Magris, Claudio. Microcosmi. Milano: Garzanti, 1998. ‐‐‐. L’infinito viaggiare. Milano: Mondadori, 2006. ‐‐‐. Lontano da dove. Torino: Einaudi, 1971. Memmi, Albert. Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur. Paris: Essai Corréa, 1957. Meneghello, Luigi. Libera nos a malo. Milano: Rizzoli, 2000. Ovadia, Moni. Oylem Goylem. Torino: Einaudi, 2005. Rossanda, Rossana. La ragazza del secolo scorso. Torino: Einaudi, 2005. Speelman, Reinier. ‘Ebrei “ottomani” ‐ scrittori italiani. L’apporto di scrittori immigrati in Italia dai paesi dell’ex impero ottomano’. EJOS VIII/2 (2005): 1‐32. http://www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf8/Speelman‐01‐fin.pdf. ‐‐‐. ‘La lingua della letteratura italo‐ebraica contemporanea fra uso di prestiti e traduzione’. La rassegna di Israel. LXX/1 (2004): 47‐78. Schulze‐Engler, Frank. ‘Transnationale Kultur als Herausforderung für die Literaturwissenschaft’. ZAA: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly of Language, Literature and Culture 50/1 (2002): 65‐789. Stella, Gian Antonio. L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi. Milano: Rizzoli, 2002. Van Straaten, Giorgio. Il mio nome a memoria. Milano: Mondadori, 2000. Tuena, Filippo. Le variazioni Reinach. Milano: Rizzoli, 2005. Uhlman, Fred. L’amico ritrovato. Milano: Feltrinelli/Loescher, 1986.
183
RENDA, Marilena. ‘Lo spazio e il linguaggio. Note a margine su ebraismo e scrittura’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 185‐
191. RIASSUNTO L’identità ebraica può essere interrogata solo a partire dai complessi rapporti che essa intrattiene con lo spazio e il linguaggio. In linea con una lunga tradizione del negativo esemplificata dall’esistenza diasporica, ciò che più conta nel testo per un lettore/scrittore ebreo sono gli spazi vuoti piuttosto che gli spazi pieni, la parola assente piuttosto che quella presente. Come l’identità ebraica si definisce in relazione alla sua assenza, possiamo ipotizzare che lo stesso accada per lo spazio e per il linguaggio; anzi, potremmo affermare che il retaggio identitario è tanto più presente quanto più è, o sembra, assente, latente o negato dalla pratica di scrittura. Ne è prova l’opera di Giorgio Bassani e Primo Levi; benché in entrambi il racconto si svolga ‘in chiaro’, ad un livello generalmente esplicito e manifesto, esso occulta delle zone d’ombra e degli angoli di silenzio: zone a margine del discorso centrale in cui la parola arretra di fronte all’incandescenza del vissuto. Bassani e Levi, nel tematizzare esplicitamente la persecuzione, lo sterminio, la riscoperta dell’identità ebraica, mostrano come una parola giunta sull’orlo dell’abisso non possa che ritrarsi nel pudore o nel silenzio, facendo spazio al silenzio dell’indicibile. È forse in questo luogo interstiziale tra nascosto e manifesto, che nasce quella che è stata definita da Blanchot una ‘parola neutra’, una parola “in cui le cose, pur senza mostrarsi, non si nascondono”, “con un singolare modo di nascondere che è tanto più efficace in quanto non si fa notare”. Perché il vissuto ebraico, con il suo fardello di ombre, di attese, di angosce, di mancanze, di silenzi, non può non insediarsi, malgrado l’ebreo stesso, nel cuore della sua scrittura, della sua musica, della sua arte. PAROLE CHIAVE Identità, spazio, linguaggio, assenza, margine © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 185
LO SPAZIO E IL LINGUAGGIO NOTE A MARGINE SU EBRAISMO E SCRITTURA Marilena Renda Università degli studi di Palermo Dissero: “La tua chitarra è blu, tu non suoni le cose come sono”. Rispose: “Le cose come sono sono diverse sulla chitarra blu”. (Wallace Stevens) L’identità ebraica, come aveva intuito Giacomo Debenedetti, è una “bocca d’ombra”1 ripiegata e nascosta come la scrittura ebraica; ed è dall’interrogazione di questa forma cava che occorre cominciare per un’indagine della relazione tra ebraismo e scrittura. L’essere ebraico ruota intorno allo spazio, ed entrambi si configurano come ‘liminari’, inafferrabili, contraddittori. Lo spazio è il vero testimone della complessità dell’esistenza ebraica; a partire da esso sarà forse possibile studiare il portato ebraico nell’opera degli scrittori di origine ebraica, un portato che, a ben vedere, non è che una forma vuota scavata nel dolore dell’esilio e della privazione dell’identità. Tuttavia, è quanto meno curioso che galuth, parola ebraica per ‘esilio’, racchiuda anche il significato di ‘rivelazione’, in virtù di uno di quei rovesciamenti di cui la lingua e la cultura ebraiche sono oltremodo ricche. Di fatto, relativamente poco sappiamo e possiamo dire di questa cosa oscura e intima in cui consiste l’essere ebreo ma, per usare le parole di Derrida, possiamo avanzare l’ipotesi che “questa problematica debba essere ripensata a partire […] dall’abisso nel quale ci trascina”.2 A partire dall’abisso quindi, ancora una volta, da uno spazio vuoto: quello scavato nell’ebreo occidentale dall’assenza di terra e dalla negazione della sua identità. Nel corso del XX secolo sono soprattutto Jean‐Paul Sartre e Hannah Arendt, da prospettive diverse, a tentare di tracciare una direzione nuova dell’ebraicità che non sia declinata esclusivamente in negativo, ma più palesemente e più ‘in chiaro’ di come sia stato fatto fino ai loro giorni. Le loro osservazioni, soprattutto quelle contenute in Riflessioni sulla questione ebraica e Il futuro alle spalle, aiutano a districarci meglio nella vischiosità dell’argomento e a individuare una direzione possibile dell’ebraicità come ‘identità aperta’, complessa, minoritaria, laterale e critica, che continui a fare problema e ad inquietare le coscienze.3 Secondo Levi della Torre, infatti, compito dell’ebreo è incunearsi nelle pieghe della realtà per leggere “la possibilità nascosta” che si apre nello spazio tra gli eventi. Come l’eroe biblico deve leggere la possibilità nascosta degli eventi, allo stesso modo all’esegeta biblico tocca interrogare gli spazi bianchi che si aprono tra le parole e trovare, proprio lì, a margine o tra le righe del testo, il senso non ancora rivelato del 186
discorso. Forse era proprio questo il senso del celebre aforisma di Kafka: “Ci è imposto di compiere il negativo; il positivo è già dato”. Non a caso, il modo in cui l’ebraismo legge, vive e o scrive la Bibbia è basato su una continua proliferazione di sensi, basata sull’esegesi e l’interpretazione continuamente dinamiche del testo, rigorosamente inalterabile in ogni suo minimo dettaglio e però, posto questo rigore, luogo di infinite letture compresenti e proliferanti nel tempo, a seconda delle necessità dei tempi, dei luoghi e delle persone, in una evoluzione dinamica e creativa costanti che, conservando lungo i secoli e i continenti l’importanza, centralità e inalterabilità come il significante stesso della realtà […] ne elabora liberamente e creativamente il significato, sì da renderne sempre attuale il messaggio […].4 L’ebreo legge il Libro praticando un incessante slittamento dal “presente del testo all’assente, dal testo nel suo darsi come evento al suo avvenire”.5 In linea con una lunga tradizione del negativo, ciò che per un lettore‐scrittore ebreo (non a caso, forse, lettura e scrittura condividono in ebraico la stessa radice) più conta nel testo sono gli spazi vuoti piuttosto che gli spazi pieni, i bianchi piuttosto che i neri, la parola assente piuttosto che quella presente. Come l’identità ebraica si definisce in relazione alla sua assenza, possiamo ipotizzare che accada lo stesso per lo spazio e per il linguaggio; anzi, potremmo affermare che tanto più un dato è presente, quanto più è, o sembra, assente, latente o negato dalla pratica di scrittura, come accade nei casi, piuttosto eclatanti, di Svevo o Saba.6 L’ebraicità è un segreto che ripugna di essere manifestato e portato alla luce del sole; ci colpisce e ci intimidisce, costringendo alla cautela o a uno strano timore superstizioso, l’estrema prudenza e riserbo con cui intellettuali e scrittori ebrei si avvicinano sempre al cuore pulsante della loro personale questione ebraica. Come Derrida, che invitato a parlare della propria ebraicità, si risolve a “confidarvi quel che in me, da tanto tempo, si sente allo stesso tempo confidato e confinato al mutismo […] davanti al soggetto così formulato, davanti alla cosa ‘ebraica’”: È un po’ come se un certo modo di tacere o stare zitti, come se un certo segreto avesse rappresentato una sorta di custodia, e ciò da sempre, in riferimento all’ebraismo, all’ebraicità, alla condizione o alla situazione di essere ebreo […], e tuttavia è come se tale riserva ostinata avesse rappresentato, dicevo, una sorta di custodia, di vigilanza, di salvaguardia: un silenzio che si protegge e che protegge, un segreto che forse protegge dall’ebraismo ma allo stesso tempo mantiene una certa ebraicità in sé – qui, dentro di me.7 È stato Harold Bloom ad enucleare una linea negativa della tradizione ebraica che attraversa le figure centrali di Freud, Kafka e Scholem. Leggendo l’operazione di questi scrittori di una nuova ‘Torah eretica’ attraverso la lente del ‘meno’ come condizione del ‘più’, Bloom si imbatte nelle peculiarità più originali non solo del pensiero e della scrittura di questi autori ma anche, più in generale, dell’intera tradizione ebraica, che egli legge all’inverso: quindi nella giusta direzione. Individuando nel procedimento della rimozione il nucleo centrale del pensiero freudiano, nell’elusione dell’interpretazione da parte del lettore il cuore pulsante di 187
quell’’assalto alle frontiere’ che è la scrittura kafkiana, e nel nascondimento della tradizione come unico modo di manifestarla e tenerla viva l’ossessione della ricerca cabalistica di Gerschom Scholem, Bloom infrange i limiti della critica letteraria escogitando un nuovo modo di leggere la tradizione: partire dalle pieghe e dalle forme cave di essa per re‐inventarla. E, nel re‐inventarla, delineare un modo di essere ebrei che, a partire dalla modernità e dai suoi intrecci con l’ebraismo, non può che essere ambiguo, parziale, minoritario,8 anche e soprattutto nell’uso del linguaggio.9 Ci può essere utile per chiarire questo gioco di specchi tra nascosto e manifesto, una notazione del sociologo francese Alain Médam, il quale sottolinea come nella mistica ebraica “monde – qui en hébreu se dit olam – peut être vocalisé de telle manière qu’on puisse le lire elèm qui signifie caché”.10 Dunque ‘mondo’ e ‘nascosto’ in ebraico condividono la stessa radice. Allora, dov’è realmente il mondo?: Se tient‐il où il est à l’endroit: où il est présent, substantiel, peuplé de vie, de chair, de réciprocité entre les êtres? Où réside‐t‐il plutôt là où il est caché, renversé, là où la présence fait défaut, où la substance est louche, où la vie disparaît dans des camps ou des trous de mémoire, où les échanges de coups servent à communiquer, où les injures valent parole et les persécutions tiennent lieu de liens?11 Médam arriva al nocciolo della questione che ci sta a cuore: se da sempre l’ebraicità non è definibile se non in negativo, se l’esperienza atroce, direttamente o indirettamente vissuta, dello sterminio di un intero popolo ha provocato un drastico rovesciamento dei nostri modi tradizionali di concepire cose come l’uomo, la civiltà, il linguaggio, allora in che direzione deve andare il nostro sguardo di lettori di testi, ebraici e non? Esso dovrà di necessità rivolgersi alle pieghe del discorso narrativo, nei luoghi dove il detto si ripiega o si nasconde nel non‐detto, dove la parola si accartoccia nella sua stessa impossibilità, dove il manifesto custodisce una verità, un segreto troppo bruciante per essere esposto alla luce del sole.12 La radice ebraica, allora, dovrà essere letta attraverso la filigrana del linguaggio, e quindi nella relazione composita che esso intrattiene con lo spazio. Nei suoi Dieci aforismi astorici sulla Cabala, Scholem ammonisce che “i segreti sono più protetti dal discorso e dalla scrittura che dal silenzio”.13 Ovvero, la parola e la scrittura nascondono più di quanto sappia farlo il silenzio. Di questo doveva essere ben consapevole Leo Strauss quando elaborò il concetto di “scrivere tra le righe”14 per definire l’operazione letteraria degli scrittori cui è necessaria una consegna di segretezza. Per usare le parole di Trigano: Le discours juif ne peut être qu’une aventure dans la marge d’un texte déjà établi, presque un commentaire, un ensemble de bouts de textes épars qui se feraient vecteurs du transfert de la masse du texte à sa marge, à lui‐même vu de dehors, de “derrière” son apparence.15 Gli spazi bianchi, i silenzi, sono altrettanti rimandi ad un al di là del testo tanto inafferrabile (quasi illeggibile) quanto insostenibile per le sue implicazioni e diramazioni esistenziali: 188
Il silenzio – la morte – che sono il fondo inesplorabile – non possono essere espressi direttamente. Non saprebbero essere – oh paradosso – che tradotti, denunciati insidiosamente, di sbieco, attraverso il loro contrario.16 In due scrittori come Giorgio Bassani e Primo Levi, passati attraverso le prove dell’antifascismo, della Resistenza attiva e del carcere l’uno, per l’orrore di Auschwitz l’altro, il racconto dell’esperienza storica e personale e l’apprendistato ad un ebraismo dimenticato, benché si svolgano ‘in chiaro’, ad un livello generalmente esplicito e manifesto, che vuole tutto mostrare e niente nascondere, tuttavia occulta, come un segreto che è troppo rischioso portare alla luce, delle zone d’ombra e degli angoli di silenzio: zone a margine del discorso centrale in cui, a livelli e con modalità diverse, la parola arretra di fronte all’incandescenza del vissuto. Tra gli altri scrittori di origine ebraica Bassani e Levi, nel tematizzare esplicitamente la persecuzione, lo sterminio, la riscoperta dell’identità ebraica, mostrano al tempo stesso come una parola giunta sull’orlo dell’abisso non possa che ritrarsi nel pudore o nel silenzio, scavando nell’esperienza, e di conseguenza nella scrittura, delle zone di silenzio in cui il dovere di testimonianza o l’esigenza di verosimiglianza vengono sospesi per fare spazio al silenzio dell’indicibile. Mentre Levi è pienamente erede della tradizione culturale ebraica nello scegliere uno stile che, specialmente quando deve testimoniare la tragedia della Shoah, sceglie di sottrarre peso all’insostenibile, il modo bassaniano di affrontare i traumi personali e storici passa invece attraverso l’ambiguità, la sfumatura, l’elusione, il chiaroscuro, i puntini di sospensione: cioè attraverso una parola pudica che oscilla tra detto e non‐detto, “quasi che, pur parlando, non parlasse e lasciasse invece parlare quello che non si può dire in quello che c’è da dire”.17 Da prospettive diverse, di testimone indiretto e sopravvissuto quella di Bassani, di sopravvissuto e testimone diretto quella di Levi, essi affrontano la difficoltà di scrivere dopo il trauma delle leggi razziali e della guerra, e soprattutto dopo Auschwitz, facendo i conti in maniera individuale e con esiti diversi con una questione – lo scrivere dopo la Shoah – che in molti paesi, a partire dal celebre anatema di Adorno sull’impossibilità di fare poesia dopo Auschwitz, è stata ampiamente dibattuta, al contrario di quanto è accaduto in Italia, in cui solo in tempi recenti le questioni relative all’identità, alla pratica della memoria e alla letteratura post‐Shoah hanno trovato spazio e ascolto. È forse in questo luogo interstiziale tra nascosto e manifesto che nasce quella che è stata definita da Blanchot una “parola neutra”, una parola che “non copre né scopre” e “in cui le cose, pur senza mostrarsi, non si nascondono”, in cui certe parole sono messe in risalto non già valorizzandole, bensì ponendole tra virgolette o tra parentesi, “con un singolare modo di nascondere che è tanto più efficace in quanto non si fa notare”.18 La ‘parola neutra’ porta quindi il segno di un nascondimento e di una sottrazione in quanto privilegia la domanda rispetto alla risposta, lo spazio vuoto rispetto allo spazio pieno, il bianco delle ‘vertiginose interlinee’ di Jabès rispetto al nero della scrittura. Perché il vissuto ebraico, con il suo fardello di ombre, 189
di attese, di angosce, di mancanze, di silenzi, non può non insediarsi, malgrado l’ebreo stesso, nel cuore della sua scrittura, della sua musica, della sua arte. NOTE Debenedetti 2001, 69. 1
Derrida 2005, 65. 2
“L’ebraismo, insomma, si presenta nella Storia come l’elaborazione di un punto di vista di minoranza; è un’elaborazione così straordinariamente prolungata nel tempo, e così riccamente declinata secondo le varie circostanze e le varie epoche, da costituire ‘una visione minoritaria del mondo’” (Levi della Torre in Brunazzi & Fubini 1990, 31). 3
Anna Brawer, ‘Introduzione’ a Brunazzi & Fubini 1990, 15. 4
Ibidem. 5
Si veda ad esempio il recente De Angelis 2006. 6
Derrida 2005, 40. 7
Ibidem, 53. 8
Paul Sherwin, ‘Introduzione’ a Bloom 1989, 13. 9
Médam 1991, 168. 10
Ibidem, 169. 11
Derrida 2005, 41: “È noto il legame profondo, e che non è soltanto etimologico, che si può mettere in luce tra la custodia e la verità. Come se, paradosso che non cesserò di sviluppare e che riassume tutto il tormento della mia vita, mi fosse sempre risultato necessario guardarmi dall’ebraismo per mantenere in me qualche cosa che soprannomino provvisoriamente l’ebraicità. La frase, l’ingiunzione contraddittoria che avrebbe così ordinato la mia vita, mi avrebbe detto, in francese: guardati dall’ebraismo – o anche dalla stessa ebraicità. Guardatene per custodirlo, guardatene sempre un po’, guardati dall’essere ebreo per conservare l’Ebreo in te. Custodisci l’ebreo che è in te, prenditene cura. Pensaci bene, sii vigilante, usa riguardo verso il tuo ebraismo, e non essere ebreo a qualunque prezzo”. 12
Gerschom Scholem, ‘Dieci aforismi astorici sulla Cabala’ in Bloom 1989, 66. 13
Strauss 1990. 14
Trigano 1977, 14. 15
Jabès 1986, 193. 16
Blanchot 1977, 43. 17
Ibidem. 18
190
BIBLIOGRAFIA Arendt Hannah. Il futuro alle spalle. 1981. Bologna: il Mulino, 2006. Blanchot Maurice. La scrittura del disastro. Milano: SE, 1990. ‐‐‐. L’infinito intrattenimento: scritti sull’“insensato gioco di scrivere”. Torino: Einaudi, 1977. Bloom Harold. Kafka, Freud, Scholem. Milano: Spirali, 1989. Brunazzi Marco & Fubini Anna Maria, a cura di. Ebraismo e cultura europea del ‘900. Firenze: Giuntina, 1990. De Angelis, Luca. Qualcosa di più intimo. Su Svevo e su altri scrittori ebrei italiani del Novecento. Firenze: Giuntina, 2006. Debenedetti, Giacomo. 16 ottobre 1943. Torino: Einaudi, 2001. Derrida, Jacques. Abramo, l’altro. Macerata: Quodlibet, 2005. Jabès, Edmond. Il libro dei margini. Firenze: Sansoni, 1986. Médam, Edmond. Mondes juifs. L’envers et le droit. Paris: PUF, 1991. Sartre, Jean‐Paul. L’antisemitismo: riflessioni sulla questione ebraica. Milano: Mondadori, 1990. Strauss, Leo. Scrittura e persecuzione. Venezia: Marsilio, 1990. Trigano, Shmuel. Le récit de la disparue. Essai sur l’identité juive. Paris: Gallimard, 1977. 191
NEIGER, Ada. ‘Da Elsa Morante a Elena Loewenthal. Breve viaggio nell’ebraitudine’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 193‐
200. RIASSUNTO È stato uno spettacolo del 1987 di Moni Ovadia, BREVE VIAGGIO NELL’EBRAITUDINE, a suggerire il titolo del presente lavoro, che getta un rapido sguardo su alcune tra le più note narratrici italo‐ebree contemporanee.La ricerca si prefigge di individuare tracce di ebraicità nelle opere delle scrittrici esaminate. La prima autrice che si incontra è Elsa Morante che, figlia di madre ebrea, si è convertita al cattolicesimo. A causa del passaggio ad altra credenza religiosa, il profilo ebraico di Morante risulta sbiadito, eppure ciò non le impedisce di tratteggiare un nitido affresco del ghetto romano. Un folto gruppo di scrittrici, tra cui Giuliana Tedeschi, Liana Millu e Esther Joffe Israel, narra storie di discriminazioni razziali e deportazioni. Tali opere hanno sempre valore documentario e per chi le scrive fungono da valvola di sicurezza, hanno efficacia terapeutica. Scrivono in lingua italiana anche autrici trapiantate in Italia quali Edith Bruck, Elisa Springer, Helena Janeczek. Due scrittrici che vivono la loro ebraicità con naturalezza senza manifestare orgoglio inopportuno perché, come ci insegna Natalia Ginzburg “riguardo all’essere ebrei, è sbagliato esserne avviliti, sbagliato gloriarsene”, sono Clara Sereni e Elena Loewenthal. Clara Sereni e Elena Loewenthal risultano essere tra le nostre più autentiche scrittrici dalle cui pagine traspare la loro neshuma (anima) ebraica. PAROLE CHIAVE Identità, scrittrici italo‐ebree, biculturalismo, transculturazione, Shoah © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 193
DA ELSA MORANTE A ELENA LOEWENTHAL BREVE VIAGGIO NELL’EBRAITUDINE Ada Neiger Università degli studi di Trento Il concetto di identità rimbalza da una tavola rotonda a un dibattito televisivo, è argomento di saggi, materia di ricerca da parte di intellettuali di varia formazione, sopravvive all’usura di un utilizzo spesso indiscriminato e pertanto gode di un’inaspettata attualità. Mai come oggi accanto allo studio dell’identità individuale è sorta l’esigenza di occuparsi anche della cosiddetta identità collettiva condivisa da più soggetti. Di questo termine polisemantico, una concisa definizione presenta l’identità come il nucleo della coscienza di sé di un soggetto, è “il sistema di rappresentazioni in base al quale l’individuo sente di esistere come persona, si sente accettato e riconosciuto come tale dagli altri, dal suo gruppo e dalla sua cultura di appartenenza”.1 va aggiunta al presente asserto una riflessione riguardo alla struttura dell’entità identitaria che per taluni sociologi è stabile, permanente, mentre per altri dispiega una natura aperta, duttile. Ma in questo breve percorso che ci condurrà a individuare tracce impercettibili o vistose di ebraicità nella prosa di scrittrici ebree italiane non c’è spazio per un approccio approfondito della problematica dell’identità per cui, senza pretese sistematiche e senza riferimenti alla prospettiva funzionalista o al pensiero della scuola interazionista o di quella fenomenologia, raccoglieremo episodiche informazioni sulla consapevolezza che gli intellettuali ebrei manifestano della loro identità. Colpisce innanzi tutto l’incessante interrogazione di tanti ebrei sulla propria identità. A conferma di ciò valga l’esempio di Alain Elkann che nell’introduzione alla sua intervista al rabbino Elio Toaff, pubblicata nel 1994 con il titolo Essere ebreo, esordisce chiedendosi “Cosa vuol dire essere ebrei? Me lo sono domandato sovente“. E più avanti così prosegue: “Ma gli ebrei chi sono? Un popolo? Una religione? Una cultura? Una storia? Cos’è la religione degli ebrei? In cosa credono? Cosa si aspettano dopo la morte? Come sentono la fede in Dio? Come cercano perdono? Quali sono le loro feste?”2 Dal canto suo Abraham B. Yehoshua sente l’esigenza di pubblicare uno scritto dal titolo significativo: Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare in cui a proposito dell’ebreo egli presenta quelle che Luca Zevi definisce “istruzioni per il riconoscimento”.3 Nel suo saggio Yehoshua rifiuta la tradizionale definizione religiosa che così recita: “è ebreo chi è figlio di madre ebrea o chi si è convertito secondo le regole”4 e ne propone un’altra che prescinde dall’identificazione religiosa e afferma che “ebreo è chi si identifica come tale” convinto che le motivazioni culturali e familiari non bastano a determinare un’identità se non interviene un atto volontario di scelta. Allo stesso modo la pensa Tzvetan Todorov che reputa ingiusto 194
costringere un individuo a restare legato alla cultura dei suoi avi. Ogni soggetto umano può scegliere di rimanere nell’alveo delle sue tradizioni ma nessuno gli vieta di abbandonare la sua cultura e di acquisirne una nuova. Può cioè compiere un percorso che dalla deculturazione lo conduce all’acculturazione. Un’ulteriore opportunità forse meno lacerante è quella che lo stesso Todorov, immigrato in Francia dalla Bulgaria, ha personalmente sperimentato. Trattasi della transculturazione, un procedimento che permette all’individuo di impossessarsi di un nuovo codice senza peraltro rinunciare a quello precedente. Questa situazione di biculturalismo permette a chi passa da un’appartenenza a un’altra di non considerarsi un traditore. Quest’ultimo appellativo è stato utilizzato per designare Gilad Atzmon, polemico sassofonista e scrittore nato in Israele da genitori ebrei, vivente dimostrazione che l’identità è una corazza, un rivestimento che si può indossare o togliere a piacimento. Atzmon si è spogliato delle sue sembianze giudaiche e ha proclamato di non considerarsi ebreo in quanto non appartenente alla categoria degli ebrei religiosi, né a quella degli ebrei laici. In un’intervista pubblicata su internet così si esprime: “insisto nel non venire mai presentato come israeliano, ma come uno nato in Israele, ex‐israeliano, ex‐ebreo, palestinese di lingua ebraica. Quello che volete, ma non come israeliano o ebreo”.5 E si spinge oltre sino a sostenere che Israele non ha il diritto di esistere, perché rappresenta la più grande minaccia alla pace mondiale. L’anno 1926 pure Freud sentiva il bisogno di esplicitare la sua appartenenza al popolo ebraico trascurando ogni riferimento a elementi religiosi. Si riporta qui di seguito uno stralcio tratto dal Discorso ai membri della Associazione B’nai B’rith pronunciato in occasione del suo settantesimo compleanno: Tante altre cose rimanevano che rendevano irresistibile l’attrazione per l’ebraismo e gli ebrei, molte oscure potenze del sentimento, tanto più possenti quanto meno era possibile tradurle in parole, così come la chiara consapevolezza dell’‘interiore identità’ […] Fu soltanto alla mia natura di ebreo che io dovevo le due qualità che mi erano diventate indispensabili nel lungo e difficile cammino della mia esistenza. Poiché ero ebreo mi ritrovai immune dai molti pregiudizi che limitavano gli altri nell’uso del loro intelletto e, in quanto ebreo, fui sempre pronto a passare all’opposizione e a rinunciare all’accordo con la ‘maggioranza compatta’. Erik Erikson ha messo in evidenza come Freud nei suoi scritti citi il termine identità una sola volta quando si riferisce alla sua identità ebraica. Anche Ben Gurion, interrogato da Gianfranco Tedeschi nel 1967 alla conclusione della guerra dei sei giorni, sul significato che egli attribuiva all’essere ebreo, aveva dato una risposta ‘laica’, perché per lui significava porsi ogni giorno la domanda: cosa significa essere ebrei?)6 In epoca più vicina a noi Amos Luzzatto, dopo essersi chiesto se gli ebrei debbano essere considerati un popolo, una nazione, un’etnia, una razza o un gruppo religioso, riconosce che “in questo crescendo di termini la confusione giunge al suo massimo”.7 Invece quando Moni Ovadia menziona l’identità ebraica non fa riferimento al caos, ma ne sottolinea l’indecifrabilità e ne mette in evidenza l’essenza 195
indefinibile eppure indelebile. E aggiunge che si tratta di un’identità che lo confonde a tal punto da non saperla definire. Interessante nelle parole di Ovadia l’accenno all’indelebilità ovvero a una presunta incancellabilità dell’essenza ebraica. Le riflessioni seriose si alternano a storielle agrodolci: Che cos’è un ebreo corrosivo? Un ebreo corrosivo è un ebreo che arriva in uno sperduto villaggio della Transcaucasia dove non hanno mai visto un ebreo; non sanno che cos’è il giudaismo. Questo villaggio ha duemila abitanti, e l’anno dopo il suo arrivo ci sono duemila antisemiti.8 A giudicare dalla recrudescenza di sentimenti antigiudaici, la società contemporanea è invasa da frotte di ebrei corrosivi! Di questo riaffiorare inarrestabile e impetuoso di pregiudizi razzisti nei confronti dell’ebreo si rende conto Gad Lerner e se ne preoccupa. Egli ci spiega che la parola identità ha la medesima radice della parola identico e designa elementi che accomunano, ma “nella vita di tutti i giorni, al contrario, [l’identità] viene brandita come pretesto per separarci. E i danni rischiano di essere irreparabili”.9 Accanto al timore di un rinascente antisemitismo foriero di nuovi stermini c’è l’allarme per un’insidia che si fa strada all’interno delle comunità ebraiche dove molti soggetti sembrano non voler più sostenere la propria identità etnica. Leslie Fiedler descrive questa tendenza, da taluni considerata una sorta di ‘Olocausto silenzioso’, come una forma di comportamento alimentata non “dall’odio (nemmeno dall’odio per se stessi come a volte lo si chiama) ma dall’amore: un amore per tutta l’umanità, anche per coloro che ci hanno per tanto tempo perseguitati” (147). Queste amare parole pronunciate del critico americano che si considera “un ebreo terminale, l’ultimo di una schiatta durata quattromila anni” (146) figurano in un suo notevole volume che raccoglie saggi su grandi scrittori della tradizione ebraico‐americana preceduti da una prefazione in cui Fiedler sembra dolersi per il fatto di non aver “mai scritto a proposito di scrittrici ebree americane come Grace Paley, Cinthia Ozick, Erica Jong, Esther Broner o Rhoda Lerman, alle quali pure mi ero interessato e che in parte mi avevano anche commosso” (7). Poiché non vorrei trovarmi nella stessa condizione di Fiedler e dolermi a mia volta di non essermi occupata delle scrittrici italo‐ebree, mi accingo ora a parlarne. Preliminarmente vorrei mettere a confronto scrittori e scrittrici italiani contemporanei di origine ebraica. Tra gli uomini troviamo alcuni importanti scrittori che sembrano tener in poco conto la loro eredità culturale e assumono più o meno consciamente i connotati dell’ebreo assimilato. Un esempio ce lo offre Italo Svevo e in tempi più recenti Alberto Moravia. Poi ci sono i romanzieri il cui tema privilegiato è quello della diversità perseguitata, è questo il caso di Giorgio Bassani. Folta è la schiera dei testimoni del genocidio nazista e qui è d’obbligo ricordare Primo Levi. Infine ci sono i narratori come Alessandro Piperno che tracciano la saga di una famiglia ebraica. Diversamente dagli scrittori, le autrici, anche quelle il cui profilo ebraico risulta sbiadito perché non conservano o addirittura non conoscono la tradizione 196
culturale del popolo ebraico, riescono a creare memorabili personaggi ebraici. Si pensi a La Storia con il suo nitido affresco del ghetto romano, un romanzo di Elsa Morante, figlia di madre ebrea ma convertita al cattolicesimo che ha saputo magistralmente tratteggiare il tormentato personaggio di Ida, l’indimenticabile Useppe, e lo studente anarchico Davide Segre. Ma tra le scrittrici ebree il gruppo più numeroso è costituito da narratrici i cui libri prevalentemente narrano vicende di discriminazioni razziali e deportazioni. Le loro opere hanno sempre valore documentario e per chi le scrive fungono da valvola di sicurezza, hanno efficacia terapeutica, talvolta sono opere pregevoli. Giorgio Romano apprezza in modo particolare Edith Bruck, una prolifica scrittrice nata in Ungheria, che ha soggiornato a lungo in Italia e in italiano ha scritto i suoi libri e che “occupa un posto singolarissimo e vorremmo dire unico in questa rassegna, perché […] ci ha dato volumi molto notevoli, in cui la vita ebraica ha radici più profonde e diverse da quelle di tutti i libri di cui abbiamo finora parlato”.10 Pregnante la sua definizione di ebraicità: Essere ebrea già di per sé comporta un destino avverso, ma è un’identità che resiste persino ad Auschwitz, non legata alla fede o ai precetti, ma a qualcos’altro, di indefinibile.11 Edith Bruck non è l’unica ‘straniera’ che si è stabilita in Italia e scrive nella nostra lingua, c’è pure Elisa Springer, viennese, singolare sopravvissuta che dopo aver perso entrambi i genitori, morti nei campi di concentramento, viene anch’essa deportata dapprima ad Auschwitz e successivamente a Bergen Belsen e Terezin. Sopravissuta ai lager, si rifugia in Italia col marito italiano, ma rimuove il suo passato e non ne parla con nessuno. Solo molti anni più tardi, sollecitata dal figlio, si accinge a scrivere la sua sofferta autobiografia (1997). Va menzionata anche Helena Janeczek, figlia di ebrei polacchi, nata a Monaco di Baviera e trasferitasi in Italia all’età di 19 anni. Dopo l’esordio con due raccolte di poesie in lingua tedesca, Janeczek si converte alla prosa e pubblica due opere di narrativa in italiano. Ma in questo caso non ci troviamo al cospetto di una testimone diretta della Shoah. Lo stesso dicasi per Marina Jarre, nata in Lituania da padre ebreo e madre italiana, che è qui ricordata non tanto per i pochi accenni all’ebraicità ma per una sua dichiarazione rilasciata a Piero Bianucci in cui ammetteva di scrivere con molta fatica e di invidiare i suoi colleghi italiani che scrivono nella loro lingua materna. E aggiungeva di dover certe volte consultare il vocabolario e di non essere spesso contenta di come scorre la pagina. Del mondo concentrazionario si sono invece occupate Giuliana Tedeschi, Liana Millu e Esther Joffe Israel. Quest’ultima ha dato alle stampe un volume che è stato tradotto con il titolo di Vagone piombato perché scritto in francese pur essendo l’autrice, nata a Smirne e figlia di padre italiano, vissuta a lungo in Italia dove inoltre si è laureata. Gli ebrei sono portatori di uno stigma sociale che può essere manifesto e allora siamo in presenza di un individuo destinato ad essere screditato, ma se lo stigma non è evidente, ma accuratamente celato, l’individuo è solo virtualmente screditabile. Ho riferito questo concetto desunto dagli scritti del sociologo Erving 197
Goffmann perché apprezzo nelle scrittrici ebree l’ardimento nel rivelare le loro origini pur sapendo che l’affermazione della loro diversità costituisce tutt’altro che un privilegio. Due scrittrici che vivono la loro ebraicità con naturalezza, senza manifestare orgoglio inopportuno perché, come insegna Natalia Ginzburg, “riguardo all’essere ebrei, è sbagliato esserne avviliti, sbagliato gloriarsene”,12 sono Clara Sereni e Elena Loewenthal. Clara Sereni, forse la migliore scrittrice italo‐ebrea vivente, in un articolo apparso su L’Unità del 16 gennaio 2006 lamentava il fatto di essere stata chiamata al palco, durante una pubblica manifestazione, e di essere stata apostrofata “Clara Sereni, ebrea e scrittrice”. In un sito in rete la sua reazione viene descritta così: Clara Sereni, ebrea e scrittrice. L’episodio l’aveva turbata e avrebbe voluto non doversi più giustificare di essere ebrea, non doversi discolpare delle proprie opinioni. Avrebbe voluto che la sua specificità di ebrea, insieme alle altre (donna, comunista, madre handicappata, intellettuale), trovasse un’accoglienza più competente. Forse avevano ragione i genitori di Will Eisner, i quali avevano raccomandato al figlio di star zitto, cioè starsene in disparte rimanere invisibile ‘e non offendere i goyim’.13 perché forse non c’è un altro modo per difendersi dalla più o meno scoperta aggressività di un rinascente antisemitismo che seguita a incoraggiare sotto varie forme l’ostracismo. Ne Il Gioco dei regni, Sereni consegna ai lettori la storia di tre generazioni della sua famiglia e, nonostante la drammaticità che percorre molte pagine, non vien meno la speranza in una società più giusta e meno spietata. Elena Loewenthal è scrittrice versatile, traduttrice, saggista, giornalista, critica militante, romanziera, opinionista. Viene da accostarla a Salcia Landmann, autrice di raccolte di storielle ebraiche, e anche a Vine Deloria junior: Uno dei mezzi migliori per capire un popolo è conoscere quel che lo fa ridere: il riso rivela i confini dell’anima. Nell’umorismo la vita viene nuovamente definita e accettata. L’ironia e la satira forniscono una conoscenza approfondita della psiche collettiva di un gruppo e dei suoi valori, più approfondita di quella che si ottiene in anni di ricerca.14 E in accordo con queste affermazioni dell’indiano d’America Vine Deloria junior, riteniamo meritoria l’antologia di aneddoti che con amara ironia raccontano la società degli ebrei e dei gentili e la raccolta di tradizionali ricette pubblicate da Elena Loewenthal. Sereni e Loewenthal sono le nostre più autentiche scrittrici, quelle dalle cui pagine meglio traspare la loro neshuma (anima) ebrea. NOTE Tessarin 1987, 970. 1
Elkann 1984, 5‐6. 2
Zevi 2001, 10. 3
198
Yehoshua 2001, 30. 4
Atzmon 2007. 5
Tedeschi 2000, 51‐56. 6
Luzzatto 2003, 13. 7
Ovadia 1998, 38. 8
Lerner 2005, 47. 9
Romano 1979, 61. 10
Bruck 1998. 11
Ginzburg 2001, 43. 12
Libri e libri – 7.06.2007 http://www.librielibri.splinder.com. 13
Deloria 1994, 155. 14
BIBLIOGRAFIA Atzmon, Gilas. ‘”Non è detto per niente che sia così”. Intervista’. Kelebek – 7.06.2007 http://www.kelebekler.com/occ/gilad.htm. Bruck, Edith. ‘Il dovere della testimonianza’. [9.09.1998] http://www.caffeeuropa.it/attualita/98ebraismo‐bruck.html. Caffè Europa – 27.06.07 Deloria, Vine jr. Custer è morto per i vostri peccati: Manifesto indiano. Milano: Jaca Book, 1994. Eisner, Will. Verso la tempesta. Bologna: Puntozero, 1998. Elkann, Alain. Essere ebreo. Milano: Bompiani 1984. Erikson, Erik. Gioventù e crisi d’identità. Roma: Armando, 1974. Erlich, Shmuel. ‘Der Mann Moses e l’Uomo Freud: identità psicoanalitica e antisemitismo’. Relazione presentata al Seminario tenuto nei Centri Psicoanalitici Italiani (Milano, Bologna e Firenze). [Maggio 2005] Centro Psicoanalitico di Firenze – 27.06.07 http://www.spi‐firenze.it/Erlich_2005.html. Fiedler, Leslie. Dodici passi sul tetto. Saggi sulla letteratura e l’identità ebraica. Roma: Donzelli, 1999. Freud, Sigmund. ‘Discorso ai membri della Associazione B’nai B’rith’. Opere. Torino: Bollati Boringhieri, 2003. Ginzburg, Natalia. ‘Ragioni d’orgoglio’. Non possiamo saperlo. Saggi 1973‐1990. Torino: Einaudi, 2001. Joffe Israel, Esther. Vagone piombato. Milano: Mondadori, 1949. Lerner, Gad. Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità. Milano: Feltrinelli, 2005. Luzzatto, Amos. Il posto degli ebrei. Torino: Einaudi, 2003. Ovadia, Moni. Perché no? L’ebreo corrosivo. Milano: Bompiani, 1998. Romano, Giorgio. Ebrei nella letteratura. Roma: Carocci, 1979. Sereni, Clara. Il gioco dei regni, Firenze: Giunti, 1993. 199
‐‐‐. ‘La colpa di essere ebrea’. L’Unità (16.01.06). Springer, Elisa. Il silenzio dei vivi. Venezia: Marsilio, 1997. Tedeschi, Gianfranco. ‘L’identità ebraica’. L’ebraismo e la psicologia analitica. Rivelazione teologica e Rivelazione psicologica. Firenze: La Giuntina, 2000. 51‐56. Tessarin, Nicoletta. ‘Identità’. Nuovo Dizionario di Sociologia, a cura di Demarchi Franco, Ellena Aldo, Cattarinussi Bernardo. Milano: Edizioni Paoline, 1987. 970. Todorov, Tzvetan. L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza. Roma: Donzelli, 2000. Yehoshua, Abraham. Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare. Roma: Edizioni e/o, 2001. Zevi, Luca. ‘Introduzione’. Yehoshua 2001. 200
SERKOWSKA, Hanna. ‘La Shoah ha un genere? Il caso di alcune scrittrici ebree di lingua italiana’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐
7. 201‐216. RIASSUNTO Alla lettura dei testi di alcune scrittrici ebree di lingua italiana (dedicati alle tematiche dell’ebraismo e della Shoah) adotto la prospettiva di genere. Partendo dalle statuizioni di Lillian S. Kremer contesto l’universalità dell’esperienza e della testimonianza della Shoah. Il guadagno conoscitivo che ne deriva consiste nell’ampliamento della prospettiva che permette di cogliere lo specifico del vissuto e dello scritto di donne: il razionalismo e le risorse pragmatiche delle donne poste nelle condizioni estreme, il loro spirito gregario manifestantesi nella capacità di creare famiglie putative, l’enfasi sulla ‘biologia’ dell’esperienza dell’internamento e persecuzione, il mondo dei valori ebraici condivisi e seguiti in maniera diversa rispetto al maschio, il protagonismo femminile nelle narrazioni di donne. PAROLE CHIAVE Donna/e, biologia, guerra, Shoah, testimonianza © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il secondo volume della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 201
LA SHOAH HA UN GENERE? IL CASO DI ALCUNE SCRITTRICI EBREE DI LINGUA ITALIANA Hanna Serkowska Università degli studi di Varsavia Nascere per caso nascere donna nascere povera nascere ebrea è troppo in una sola vita (Edith Bruck, Lettera da Francoforte) Il corpus di testi utilizzati per i fini della presente disamina è limitato alle scrittrici nate negli anni venti e trenta, tuttora viventi e attive (Angela Bianchini – nata nel 1921, Marina Jarre – nel 1925, Giacoma Limentani – nel 1927, Lia Levi – nel 1931, Edith Bruck – nel 1932), tutte approdate alla scrittura che tematizza o problematizza la loro esperienza di donne ebree relativamente tardi, alcuni decenni dopo la guerra. Non tutte le scrittrici ebree che considero nella mia relazione hanno vissuto la Shoah, la maggior parte essendo state soggette a persecuzione, deportazione e internamento per motivi razziali. L’ultima di cui parlo è Clara Sereni, classe 1946, che apre un nuovo capitolo nella storia degli scritti di donne ebree; così facendo, mi fermo quindi oltre la generazione che dovrebbe far leva sulla cosiddetta postmemory (figlie e nipoti della Shoah, come la generazione della Loewenthal e della Janeczek). Nel presente articolo unisco la prospettiva di genere alla ricerca che ha per oggetto i testi della cultura scritti da autori ebrei, e in particolare incentrati sulla rappresentazione della Shoah. Perché farlo, perché unire le due prospettive, potremmo domandarci. Quali possibili rischi comporta tale impostazione, di quali debolezze pecca, quali eccezioni è passibile di sollevare? Quali profitti, infine, ne possono derivare? La mia relazione, strutturata come un insieme di osservazioni ancora amorfe attorno a testi di scrittrici ebree contemporanee di lingua italiana, è nata in parte dal bisogno di trovare una risposta a queste domande. Una considerazione importante che in tale prospettiva andrebbe fatta riguarda il canone storico‐letterario e, dato che la costituzione del canone è sempre fondata su determinati valori e criteri (tra cui il carattere nazionale, normativo, l’agire selettivo e discriminatorio), le conseguenze che ne derivano rispettivamente sia per gli scritti di donne che per l’ebraicità e gli scritti sull’Olocausto. Partendo dal presupposto che il canone esclude ogni alterità per costituirsi come tale, le studiose femministe hanno dovuto assolvere al compito di archeologhe per portare alla luce la produzione di 202
donne per vari motivi omessa dal canone, che è stato modificato ed integrato nel suo aspetto; esse hanno pertanto spesso denunciato importanti crepe in quella che si voleva dare come l’estetica esclusiva ed imperante. Nella prospettiva di cui sopra, le testimonianze (di carattere fittizio) che donne ebree hanno rilasciato della loro vita di perseguitate e deportate hanno goduto di un’attenzione notevolmente minore rispetto a quella accordata ai testi tramandati dai loro compagni maschi.1 Critici e studiosi, come afferma la studiosa L. Kremer, hanno avuto fino a poco fa una visione unificata dei testi in oggetto che faceva di quella maschile un’esperienza universale.2 Similmente, solo di recente si è cominciato a pensare che l’Olocausto rappresenti una sfida ancora più grande per la riflessione sulla storia della letteratura, che esso complichi o impedisca la sintesi che ogni canone storico‐
letterario presuppone, e, infine, che ci inviti a ripensare alcune delle premesse fondanti la storia letteraria del Novecento,3 a compiere una revisione del canone d’accordo con quanto ha suggerito Alvin H. Rosenfeld.4 Si propone l’ipotesi che la destrutturazione delle avanguardie, in corso già a partire dagli anni quaranta del Novecento, sia determinata principalmente dal fattore Olocausto (l’indifferenza allo sterminio era manifestazione del pensiero totalitario), e che da tale smontaggio possa ricondursi il pensiero postmoderno che all’affinità preferisce la differenza, all’unità la diversità o la differenza, alla funzionalità la gratuità o la molteplicità di scopi come regola ordinatrice della vita sociale. Si argomenta che sono state le categorie di pensiero totalitario ad aver fondato l’Olocausto, sorto dallo sciovinismo nazionalista (e visto come fondamento fluido del postmoderno, perché pietra tombale della modernità), ma si prova altresì che lo smontaggio del pensiero moderno è avvenuto o almeno iniziato molto prima degli anni sessanta. Gli studi recenti sulla letteratura della Shoah dalla prospettiva di genere compiono quindi un’opera di destrutturazione o destabilizzazione di quel canone ‘storico‐letterario’, modo di pensare e dell’agire sociale che si dava come unico, emulsionato, uniforme al proprio interno, totale e totalitario. Infine, vorrei affrontare di petto le eventuali debolezze e insieme anticipare le accuse degli oppositori dell’approccio di genere, limitandomi alle perplessità maggiori che devono assillare chiunque lo adotti. Gli studi legati alla letteratura femminile sull’Olocausto, sviluppatisi soltanto all’inizio degli anni novanta del Novecento, sono subito stati tacciati di banalizzazione e volgarizzazione di un’esperienza unica come la Shoah, di proiezione sul passato delle preoccupazioni di oggi, consentendo ad un’interpretazione femminista di appropriarsi dell’Olocausto. A ciò potremmo anche aggiungere altre perplessità, come quella legata all’inesistenza di un catalogo di determinanti o di caratteristiche distintive degli scritti di un genere. Non è mio obiettivo sostenere che sia vero il contrario. Ricorrendo alla categoria di genere come ad una categoria che coniuga in qualche modo le narrazioni sulla Shoah, non mi pongo l’obiettivo di compiere una ri‐
ghetizzazione di rimando di chi ha già sofferto le conseguenze dell’emarginazione, bensì quello di aggiungere qualcosa alla nostra conoscenza e comprensione. Quando alla lettura dei testi sulla Shoah applichiamo le tecniche e le prospettive sviluppate nel 203
seno della critica femminista, abbiamo un’ulteriore articolazione dei risultati, non togliamo alcunché, bensì vi aggiungiamo.5 Possiamo occuparci quindi degli scritti di donne ebree come della produzione di una minoranza i cui diritti vanno tutelati, chiedendo agli oppositori dell’approccio di genere alla letteratura dell’Olocausto d’essere consapevoli del rischio che la loro avversione possa essere percepita come volta a monopolizzare, a totalizzare quest’area di studi. Cerchiamo invece di tenere fede all’auspicio, espresso da Theodor Adorno ne La Dialettica negativa, che la letteratura dopo la Shoah necessariamente pensi contro se stessa, ammetta e pratichi la molteplicità e la contraddittorietà, sperimenti diversi e irriducibili modi e forme del raccontare, cambi di prospettiva, di ricerche di lingua.6 Non esiste, credo possiamo essere d’accordo, un modo unico, assoluto, di rappresentare, di raccontare, di scrivere la storia soprattutto perchè questo tipo di racconto, nel più dei casi, si basa sull’esperienza.7 Un racconto legato alla Shoah è destinato a rimanere ellittico, nebuloso, transgenerico, ibrido, anche perché la Shoah non ha un’unica verità da comunicare. Vi sono molte e diverse esperienze, difficilmente esprimibili, e non è ”mai legittimo limitare a una sola le possibili interpretazioni di un evento o di un racconto”, scrive Giacoma Limentani.8 Occorre quindi prestare attenzione a non proporre le proprie risultanze come definitive per preservare la diversità, la molteplicità, la varietà, la differenza. Quanto segue non è che un primo passo sul percorso verso una maggiore conoscenza (rivalutazione, ma soprattutto comprensione) degli scritti di donne ebree appartenenti a quella generazione. Segue in sei punti la discussione dei testi delle scrittrici ebree elencate all’inizio, secondo le premesse e con gli obiettivi tracciati sopra. Lillian S. Kremer – con il cui studio tuttavia mi trovo qualche volta a discordare – sostiene che la consapevolezza della diversità radicale della loro esperienza faceva sì che le donne non si precipitassero a rilasciare la loro testimonianza scritta, impossibile da trasmettere. Incerta della ‘radicale differenza’, sosterrei piuttosto una maggiore complessità della loro esperienza: alla persecuzione dell’ebreo si è aggiunta la persecuzione della donna‐ebrea, dell’ebrea in quanto donna ovvero in quanto potenziale madre, genitrice di altri ebrei eccetera. La biologia, infatti, risulta di principale importanza nell’ideologia nazista del genocidio, in quanto la società nell’universo nazista era strutturata proprio attorno ai poli biologici,9 e da questo fatto scaturisce tutta una serie di differenze e complessità. La razza e il sesso costituivano gli elementi predominanti nella demarcazione sociale del totalitarismo nazista che, come dice Anna Bravo, era “esasperatamente virilista”,10 per cui nelle donne ebree si vedeva, oltre al pericolo della purezza razziale, l’elemento dell’inferiorità e della contaminazione dovuto al loro genere. Come la maternità delle donne ariane era idoleggiata e favorita mediante una legislazione tesa ad incentivare l’incremento del tasso delle nascite, l’ipotesi della maternità delle donne appartenenti a ’razze inferiori’ veniva percepita come pericolo per la purezza della razza ariana, e la razza inferiore era quindi destinata allo sterminio. Se è giusto pensare che le donne ebree erano perseguitate per un motivo in più (contro la loro 204
identità biologica e contro i ruoli sociali determinati dal loro sesso, quello di madri principalmente), non dovrebbe stupire che le donne abbiano dato vita a storie dell’Olocausto diverse, legate e condizionate dal loro genere, che raccontino un tipo di violenza maggiore (o solo diversa?) che includa anche la persecuzione sessuale, il razzismo sessista manifestantesi in stupro, aborto, infanticidio, prostituzione eccetera. IL PROTAGONISMO FEMMINILE Mentre nei memoriali scritti da uomini le donne appaiono come vittime inermi e indifese, figure minori,11 la donna nei testi da me analizzati si racconta e nel farlo si assegna un ruolo centrale. Di conseguenza la figura del maschio ebreo, soprattutto in quanto padre, è ridimensionata, posta sullo sfondo, resa insignificante; egli rimane spesso, semmai, soltanto il maschio antagonista: il nazista. Scrive Edith Bruck: “[...] io potevo parlare solo delle donne, gli uomini erano i nostri aguzzini”.12 Nel romanzo Capo d’Europa, Angela Bianchini traccia una figura di madre forte ed efficace (in confronto al padre muto, inerte e/o assente), una madre che non si è mai arresa anche quando il consolato americano ha nuovamente rifiutato il visto a sua figlia, ha continuato a scrivere in America, a muovere il cielo e la terra, finché è riuscita nel suo intento. Il maschio, padre, fratello, è per lo più debole, irrisolto, inetto, incapace, o del tutto assente.13 Giacoma Limentani, nel romanzo In contumacia (1967), presenta il padre assente (per motivi che non ci vengono nascosti), spesso protetto dalle donne che devono scontarne le conseguenze. Vi si accentua l’appartenenza matrilineare della protagonista, palese nell’orgoglio con cui simile legame viene esaltato dalla piccola protagonista di Una bambina e basta (1994) di Lia Levi. L’atteggiamento della madre della protagonista, sempre composta, intelligente ed elegante, in pieno possesso di sé, resta in netto contrasto con gli atti maldestri e impacciati del padre, segni vistosi della debolezza e dell’irrisolutezza di cui egli, incapace di salvare la famiglia, è protagonista. Non è più mio padre, ma l’eterno uomo ebreo che si ferma smarrito quando quello che da tanto si portava dietro, quello che la sua mente aveva disegnato in ogni più minuta piega, è lì, improvvisamente reale di fronte a lui. Non è capace di vivere la vita, ha già faticato tanto a conoscerla. Il suo cuore ha una stanchezza antica, ogni suo gesto ha il peso di mille anni, non sa battersi per sopravvivere perchè quando suo padre, suo nonno, il suo bisnonno, hanno lottato, hanno via via consumato anche le sue forze. Le madri ebree no, sono tigri, leonesse, contendono alla vita ogni boccone, rubano ogni centimetro. Loro devono difendere i figli: per questo non hanno spazio per libri e sinagoghe. (Levi 1994, 52) La madre rimedia (le s’affianca la direttrice della scuola ebraica, un’altra figura di donna forte e risoluta), trova un convento, un educandato nei pressi di Roma e nasconde le figlie dalle suore cattoliche. Anche quando è chiamato ad intervenire (perché la figlia deve essere dissuasa dalla conversione alla fede cristiana), al padre, 205
capace soltanto di fare un discorso lungo e complesso sul proprio teismo (che la fanciulla di sei anni non può capire), spetta di ufficializzare quanto già stabilito con fermezza dalla madre. Come vediamo, sotto quest‘aspetto, i libri di autori maschi e femmine si presentano non dissimili nella loro diversità, bensì accomunati dallo sforzo di presentare l’altro/a come secondario, marginale. Ma forse, senza lo sguardo femminile, non ci saremmo accorti che la rappresentazione degli atteggiamenti maschili pecca di falso universalismo, tentando, di fatto, di far eclissare le figure femminili. IL RAZIONALISMO PRAGMATICO E LE ENORMI RISORSE DELLE DONNE Un argomento in qualche modo legato al protagonismo femminile in questo tipo di racconti (basati sull’esperienza di chi scrive) è il razionalismo pragmatico, l’ingegnosità e la grande capacità delle donne di far fronte a problemi di vita quotidiana, che sono particolarmente importanti perché determinano la stessa sopravvivenza degli individui. Le donne forniscono quindi prova di enormi risorse (un fatto paradossale se si pensa alla loro vulnerabilità fisica) e di ingegnosità che permette loro di far bastare provviste alimentari limitate, rattoppare abiti consunti, assistere le compagne ammalate. Esse mettono a frutto le doti maturate in una realtà diversa da quella concentrazionaria dimostrando straordinarie abilità di fronte alle loro atroci esperienze. In Chi ti ama così, Edith Bruck afferma che la vita nel campo di sterminio era più dura e più difficile da sostenere per gli uomini perché la cultura patriarcale rende il maschio più debole e in condizioni come quelle essi diventano incapaci anche solo di provvedere a sé. Le donne, secondo le statistiche (che testimoniano un minore tasso di mortalità femminile) sono state invece capaci di sviluppare vere e proprie strategie di sopravvivenza nonostante gli effetti debilitanti della fame e della malnutrizione. Le ebree, poi, che vivevano fuori del lager dovevano nascondere la loro identità e riuscivano nel loro intento grazie alla loro maggiore capacità di mimetizzarsi e alla padronanza delle lingue che permetteva loro la simulazione di un’altra identità.14 LE FORME CHE ASSUMEVANO LE AZIONI DELLE DONNE La vita delle prigioniere è come una maglia, i cui punti sono solidi se intrecciati l’uno all’altro; ma se il filo si recide quel punto invisibile che si snoda sfugge fra gli altri e si perde.15 Uno dei punti più discutibili esposti dalle studiose dei testi di donne ebree è la presunta peculiare propensione delle donne alla convivenza amichevole e pacifica senza regredire alle forme di competizione tipiche dei maschi. Secondo Kremer, per le donne fare amicizia significava il sacrificio personale all’ordine del giorno, mentre per gli uomini la comunicazione aveva spesso lo scopo di condividere interessi e 206
preoccupazioni. Mentre le donne si ritroverebbero e riconoscerebbero nella nuova comunità surrogatoria, negli uomini prevarrebbero, quando non si opta per la solitudine e l’isolamento, le doti di chi è più portato alla competizione, le azioni finalizzate alla sopravvivenza del più forte (figlio rispetto al padre). Simili generalizzazioni si dimostrano abusive leggendo i romanzi di Edith Bruck che cita casi avversi di rivalità, odio tra le donne, invidia e delazione che ne conseguivano. In Se questo è un uomo vediamo inoltre Primo Levi preoccupato dalle relazioni interne, attento alla reciprocità e al riconoscimento dell’amicizia anche nelle condizioni violentemente ostili dell’universo concentrazionario che costantemente divide, mette gli uni contro gli altri senza riguardo se siano uomini o donne. Levi nota che sono stati proprio i legami d’amicizia con gli altri internati ad averlo aiutato a sopravvivere e continuare a nutrire la fede nell’uomo. Non rimane quindi che annotare semplicemente i casi, ove ve ne fossero, di cooperazione, aiuto reciproco, mutua assistenza e disponibilità a condividere le scarse provviste che hanno contribuito ad un maggiore senso di comunità e interdipendenza.16 Per quanto non manchino esempi d’aiuto reciproco, solidarietà e sacrificio maschili, questi rappresenterebbero per le donne un tentativo di ricostruire una vera e propria dimensione familiare, la riproduzione all’interno del campo di ruoli femminili ricoperti già fuori del lager creando ora in più un’ideale, e da tempo sperata, comunità femminile. Un tratto peculiarmente femminile pare quindi formare dei veri e propri gruppi femminili di soccorso, addirittura ‘famiglie putative’ composte di due o più donne che hanno perso la propria famiglia e che quindi tengono in vita una cellula che sostituisca quella. In corrispondenza con le peculiari forme di violenza nascono forme di resistenza e solidarietà (un vero e proprio surrogato del tessuto familiare, composto di sole donne) particolari, tese a proteggere gli anelli più vulnerabili (le donne gravide, i bambini), a nutrirli e allevarli, rischiando spesso la propria vita per assistere gli altri, nascondere il neonato o addirittura ucciderlo per salvare la madre. In alcuni casi tutto ciò poteva, beninteso, consolidare nelle donne il senso di collettività, senza che tuttavia ciò assurgesse ad una caratteristica femminile. CONTINUITÀ DELLO STILE DI VITA FUORI E DENTRO IL LAGER, CON L’ENFASI SULLA BIOLOGIA Mentre lottano per la sopravvivenza, le donne non pongono enfasi sul dissesto dell’esistenza professionale o sulla capacità di mantenere il benessere della famiglia, in altre parole sulla perdita dei loro ruoli sociali come accademici, professionisti, uomini d’affari o leader religiosi, di cui i maschi ebrei erano privati in condizioni di persecuzione, guerra e prigionia. Nei maschi, l’individuo massificato, non più sorretto da quei ruoli e ridotto ad un numero, soffre; egli è chiuso dentro la comunità dell’universo concentrazionario.17 Le donne accentuerebbero invece il dissesto della vita domestica, il venir meno dei mezzi e degli alimenti, l’incapacità di assolvere ai loro compiti di moglie, madre, figlia, sorella. Anche qui, come già al primo comma, l’apparente differenza si riduce alla somiglianza fondamentale, in quanto per 207
entrambi si tratta della privazione della capacità di assolvere i propri compiti e ruoli sociali, diversi prima della guerra per donne e uomini. Una possibile distinzione si nota nel fatto che la sofferenza inflitta generava in entrambi risposte diverse: l’uomo sente e lamenta (nei suoi scritti) la propria identità, autonomia e dignità cancellate, l’umanità schiacciata e la cultura non più capace di salvare, di consolare, dimostratasi anzi ambiguamente imparentata con la barbarie (come afferma George Steiner) le donne descrivono con ossessione il corpo, il sangue, i dettagli più intimi del fisico, gli orrori dell’umiliazione e violenza sessuale che esse subiscono e che insieme formano un quadro della temuta perdita della femminilità. Lo stupro,18 che è al centro della vicenda di In contumacia, da evento personale assurge a metafora di violenza e prevaricazione eterne. Lo stupro, il trauma dell’umiliazione subita, si replica quando alla liberazione un soldato americano ferma la protagonista e le strappa un bacio con la bocca impastata di vino. “Ho terrore perché capisco di essere segnata: i violenti mi vedono e mi riconoscono” (Limentani 1967, 77). E “Non c’è scampo nella liberazione” (139). In una delle biografie romanzate di Edith Bruck, Chi ti ama così, vediamo scene di umiliazione e di molestie sessuali, tra cui quella dei tedeschi che […] si divertivano a punzecchiarci il sedere con le canne dei fucili, oppure sputavano sui nostri capezzoli e chi riusciva a colpire il bersaglio da tre o quattro metri diventava un campione. (1994, 30) mentre le carcerate, portate ad essere disinfettate, attendevano nude per lunghe ore in fila il loro turno, o quando le SS cercavano oggetti di valore che fossero nascosti nelle loro cavità orali, rettali e vaginali. Le SS le malmenavano con urti e pizzichi, commenti e gesti libidinosi, allusioni oscene, la rasatura dei capelli, la violazione della loro pudicizia. Nello stesso racconto troviamo molti riferimenti alla perdita di doti estetiche causata dal deterioramento fisico, da bassissimi standard d’igiene19 e al deterioramento corporeo riducibile all’insegna della defemminizzazione: seni inariditi, perdita delle mestruazioni (amenorrea), paura della sterilizzazione, i ‘crimini’ legati alla gravidanza, al parto, agli aborti forzati. Arrivati a liberarle il 14 aprile 1945 a Bergen Belsen, gli americani non le hanno riconosciute come donne: Ci facevano segno di avvicinarci e di toglierci i vestiti, ci guardavano con pietà e schifo. Chiesero se fossimo tutte donne; ci meravigliammo che dubitassero del nostro sesso. (Bruck 1994, 48) Lo sfruttamento sessuale continua non solo per opera dei tedeschi, ma anche da parte degli americani che offrono alle donne cioccolata e pane bianco in cambio di una ‘passeggiata. Promenade, chocolate – erano le parole più popolari a Bergen Belsen, e molte accettavano e rimanevano incinte in una promenade (50). Anche quando si tratta di rispondere all’imperativo di scrivere per tramandare la memoria, chi racconta fa leva sui termini di fisiologia femminile: ‘gravidanza’, ’gestazione’, ‘sposo’, ‘mostro’, ‘bastardo’, “mostro fedele che non ammette 208
separazione né divorzio […] convivente invisibile” (Bruck 1999, 92). Il ricordo e il dovere di custodirlo, di portare testimonianza, diventano un peso insostenibile. Il mostro le fa male, ma al contempo la lega a sé e non la lascia staccare come una madre da un figlio (19). Alla fine, la protagonista capisce di non potersene mai liberare, di dover spendere la propria vita a testimoniare perché ogni tentativo di abbandonare questo proposito è ancora più estenuante che portarlo avanti. Quel che si può qui osservare è il senso della gratuità della sofferenza femminile, abbinata all’umiliazione sessuale, in confronto alla giustificazione (anche se soltanto agli occhi della protagonista donna)20 che si riusciva a trovare a carico di quella inflitta all’uomo. La protagonista del romanzo di Limentani pensa: Io non so se il mio antifascismo ha valore. Non l’ho scoperto né ragionato. Mi è stato imposto. (Limentani 1967, 14) Quando pensa al padre, forse già arrestato (sa che lo hanno torturato, ma non sa ancora che lo uccideranno sulla soglia della libertà), si domanda che cosa potrebbero fargli: A lui non possono fare quello che fanno a me perché è un uomo. Che cosa fanno agli uomini? (14) Poi il padre può spiegarsi il motivo della persecuzione: “Lui sa perché è antifascista. Io non lo so. Io sento” (22). Le donne si sentono nate ebree per caso; diventano ebree quando viene loro inflitta la sorte di un’ebrea. LA RELIGIOSITÀ RIDIMENSIONATA Un elemento che negli scritti di donne qui analizzati manca, o comunque risulta represso, sottosviluppato, ridimensionato e a volte assente, è la religiosità, il sentimento forte del sacro, il misticismo ebraico, il riferimento ai testi sacri; questo sia perchè le donne non partecipavano attivamente ai riti, o venivano da famiglie di ebrei laici o perchè, dato l’orrore dell’esperienza subita, si arrivava a dubitare dell’esistenza della divinità,21 o ancora – come in Jarre – a causa della […] sua solita fissazione critica contro il ‘cristianesimo storico’, la sua ‘voglia polemica’ di demolire l’immondo sciocchezzaio antigiudaico dei Padri della Chiesa. (Jarre 2003, 28) La fede finisce fortemente scossa, vacillante. Anche nel romanzo In contumacia di Limentani, che nelle altre sue opere (Il grande seduto, Gli uomini del libro, L’ombra allo specchio) ha viceversa dato prova della presenza costante di quell’elemento; i riferimenti a Dio appaiono solo in relazione alla colpa, alla ricerca del senso dell’orribile supplizio che la protagonista Mina non riesce a spiegarsi, concludendo infine di essere stata condannata in contumacia. In chiusura del racconto traumatico, Mina domanda alla nonna presente durante lo stupro: “nonna, tu credi in Dio?”. 209
Risposta: “non mi sono mai posta il problema”. Dio è alef, muto, assente, non solo invisibile, è inerte, impotente di fronte al male. Sefarìm (i sacri testi) galleggiano sconsacrati, il padrone del Nome è stato ucciso. Marina Jarre parla della sua ‘anima d’Arlecchino’ andata in frantumi, come fatta esplodere a causa di una riserva riguardo a una decisa e univoca ‘posizione religiosa’ tramandatale dai genitori che entrambi avevano un atteggiamento ’distante’ verso la fede dei loro avi. (Jarre 2003, 68) La protagonista stessa si definisce in seguito una protocristiana, un’eterodossa, e quando è tenuta a rivelare il suo credo è capace di confessare in che cosa ella non crede (73). Anche dove sembra che vi sia un’eccezione da questa regola (penso alla mai scossa fede della madre nei libri autobiografici di Edith Bruck), l’esagerata religiosità (da prosèlita) serve da una parte per dimostrarne l’inutilità e l’incompatibilità con questa realtà. Alle domande continue e pressanti che mettevano in dubbio i dogmi materni, Edith, in luogo di risposte, riceveva degli schiaffoni. Da adulta la protagonista non si riconcilia, “ce l’ha con Dio, litiga con Dio continuamente, non può fare pace con Lui” (Bruck 1988, 31); la fede materna resta un motivo della ribellione e dell’irritazione della figlia ormai adulta. “Mamma mamma, quanta fede sprecata! E questo non mi dà pace. Quel tuo credo irremovibile così tradito” (91‐92). In Le nostre distanze, Angela Bianchini dà un quadro di religiosità grado zero della sua famiglia: A Roma, ogni tanto, a Pasqua, mia madre aveva l’idea che si dovesse andare al Tempio [...] ma non sapeva quando precisamente cadesse la ‘loro Pasqua’ e cercava di appurarlo con discrezione. Si mischiavano fraudolentemente a quelli che la Pasqua la facevano davvero. […] Come ultimo sforzo di conformismo e di ortodossia, quand’eravamo già esauste dalle emozioni dell’insolita mattina, mia madre proponeva di andare a comprare le azzime nel ghetto. – Sono buone con il caffellatte, – diceva. E le mangiavamo veramente con il caffellatte, per varie mattine, quando, con tutta probabilità, Pasqua era già finita e gli altri non le mangiavano più. Mi sono spesso chiesta se la mia religione, e forse anche la mia vita, non è stata quella delle azzime col caffellatte. (2001, 50) IL MONDO DEI VALORI EBRAICI I valori tradizionalmente importanti per l’eredità ebraica, come la libertà, la compassione e la giustizia,22 anche quando rimanevano al di là di ogni ortodossia religiosa, erano profondamente introiettati e vissuti da famiglie ebraiche in quanto valori morali. La cultura ebraica ha da sempre posto una particolare enfasi soprattutto sul valore della giustizia come principio basilare e costitutivo del tessuto sociale oltre che religioso. Ciò lo si osserva leggendo per esempio La libellula (Panegirico alla libertà) di Amelia Rosselli. Quella giustizia trova negli scritti di donne una certa risonanza, nel più dei casi come un valore caro al maschio assente dal 210
palcoscenico o rimasto sullo sfondo della vicenda, ma non è mai ambita o posta al centro della ricerca e non diventa oggetto degli sforzi della protagonista donna, anche se irraggiungibile, insperabile, presentata come naturalmente auspicabile e genericamente condivisibile. Nelle biografie romanzate di Bruck la giustizia non c’è, e questa sola constatazione dovrebbe bastare per abbattere l’irritante religiosità della madre della protagonista, forse rimasta ferma fino alla fine. Soltanto una volta, la protagonista della Bruck cerca e spera ostinatamente, ma invano, la giustizia: è Linda di Transit, vittima di un pestaggio subito senza un motivo apparente, questa volta non perché ebrea ma perché ungherese. La giustizia che Linda cerca va oltre il riconoscimento della vera versione dell’accaduto e la smentita delle false notizie sul giornale, e richiede un atto di riparazione più generale per tutti i torti che essa ha subito nel passato. Nel romanzo di Limentani la giustizia appartiene al bagaglio di valori‐ideali del partito perso, del padre lontano, già arrestato, torturato e fatto presto morire. In Clara Sereni si esalta invece la compassione, l’essere solidali con gli ‘ultimi’, per cui la narratrice si definisce ‘ultimista’: [...] unico dato certo è che gli ‘ultimi’ restano fuori dalla Storia più che mai, benchè – probabilmente – più che mai numerosi. Il prezzo più alto lo pagano loro, e in cambio di niente. Dicendomi ultimista provo a confrontarmi con la loro espulsione, ad assumere come punto di vista il loro. Stare dalla parte degli ultimi, provare a ragionare con la loro testa la loro pancia e la loro pelle inizialmente mi è capitato per ventura, per un pezzo di me che era ineluttabilmente in gioco più che per cultura o scelta: dichiararmi ultimista significa alla fin fine dirmi che tanto dolore non è inutile, e che a questo mondo finalmente – se non giustizia – può esserci, almeno, una scelta di campo non ambigua. (1998, 14) Mi fermo sulla soglia della nuova generazione di donne ebree, nate nel dopoguerra, di cui trovo la migliore esponente, Clara Sereni, che imbocca altre strade, traccia nuovi orizzonti ai racconti sull’Olocausto, facendoli diventare per così dire intessuti nei testi dedicati ad altro; qui un libro di memorie è mescolato ad un libro di cucina in cui le ricette, i sapori e gli odori della vita domestica familiare diventano una metafora d’altro, del passato proprio e di quello familiare. Sereni, fin dai tempi di Casalinghitudine (1987) cita diverse pietanze e spiega le ricette per esprimere idee, concetti, cose, pareri e sentimenti che riguardano la vita di ciascuno dei suoi familiari e di tutti nell’insieme, il passato della famiglia e le sue radici ebraiche. Ella dice per esempio che il purè è una pietanza diversa come diverso dai goìm è un ebreo. L’ebraismo si può esprimere tramite la scelta di cibo, la metafora che segna la differenza. Anche nel minuscolo racconto della scrittrice, ‘Ebrei’, che svolge la storia di un’amicizia tradita o creduta tale, da parte di un’amica ebrea, il cibo viene a svolgere il ruolo principale, offrendo un eufemismo di altro di cui si preferisce tacere. Un’abissale e insormontabile differenza degli ebrei è rimarcata tramite le pietanze che i personaggi consumano. Nel primo tempo del racconto, la piccola protagonista ariana, a cui non è stato mai spiegato il motivo della scomparsa della sua migliore amica, Zarfati, rimane bloccata nel suo senso di torto e di esclusione, subito per colpa 211
dell’amica. Non l’ha incuriosita né insospettita il fatto che dalla scuola scomparvero altre insegnanti e allieve. Molti anni più tardi, la protagonista lascia che sua nipote inviti per la merenda una sua compagna di banco che però si rifiuta di mangiare il prosciutto dichiarandosi ebrea. La nonna reagisce come se la parola equivalesse a traditrice, trae a sé la nipote, ma di nuovo non le spiega nulla. Le insinua invece la stessa diffidenza, la medesima inimicizia di cui lei è stata corredata da sua madre: Con chi non conosci bene, non sai chi è: magari vai a incrociare abitudini differenti dalle tue, e puoi trovartene male. [...] e se voleva far venire qualche altra compagna lei non avrebbe fatto difficoltà. [...] – Ma non farmi impazzire con merende strane, siamo intesi? (Sereni 1995, 55) CONCLUSIONI Nei libri di donne che ho analizzato non si trovano (anche se non sono rinnegate) le differenze tra le donne (di diversa estrazione sociale e culturale, livello di istruzione, pratica religiosa, orientamento politico), rivendicate a partire dalla seconda ondata del femmismo, del cosiddetto femminismo della differenza (non per niente il caso della Sereni è diverso, con il peso che dà alla sua attività politica). Esiste piuttosto un plurale tantum, Donna con la ‘D’ maiuscola, in virtù di un’implosione sostanzialista delle differenze (pur esistenti al di fuori della realtà del lager) perché le donne sono state spesso ridotte al loro corpo, a questo corpo che è un corpo sessuato. Le donne ebree che si raccontano nei libri di finzione da me esaminati percepiscono il loro ebraismo, l’essere ebree, sostanzialmente come qualcosa loro imposto, può essere questione di destino condiviso, si scoprono perseguitate, sessualmente umiliate senza poter godere della ricompensa o della giustificazione che un maschio trovava nel suo essere attivista antifascista o – tutt’al più – come nel caso della Sereni, ciò è frutto della loro decisione spontanea presa a un certo punto della vita quando si solidarizzava con gli esclusi, gli ‘ultimi’. Dei valori che Amelia Rosselli indica come supremi nella tradizione e cultura ebraica (giustizia, libertà, compassione) le donne dimostrano di sviluppare e coltivare solo la compassione. Per Marina Jarre, ci si riconosce (donne) ebree quando il riconoscimento viene dagli altri, da fuori, o è in ogni modo fatto dipendere da fatti esterni. La protagonista di Ritorno in Lettonia racconta come durante un viaggio in Egitto fu fermata nell’atrio dell’aeroporto da una voce rimbombante che la chiamava per nome: Gersoni Marina, riconosciuto come ebraico. Il panico mi invadeva: avevano notato il mio cognome. Israele era in un periodo di particolare isolamento tra paesi arabi tutti ostili. Unica fra le nostre valigie non si era trovata la mia, che fu poi ricuperata, ma quel terrore istantaneo mi dimostrò ancora una volta che no, non ero affatto in ordine, non avevo la coscienza pulita. (Jarre 2003, 48) Poco più avanti, quando la narratrice si domanda che cosa fa di lei un’ebrea, certamente non la riga sotto la frase di suo padre (miscredente qual’ era, come ebreo) che per irritare la moglie diceva “ricordatevi che anche voi siete ebree” (70‐71). Si 212
sente ebrea, quando si riconosce orfana (di suo padre e) “di quel numero mostruoso che non appartiene al mondo degli umani [...]” (70‐71) ovvero, quando si identifica con i milioni degli scomparsi. NOTE Kremer (2004, 152) afferma che studiando i testi di donne si arriva inevitabilmente a “sfidare il paradigma dell’Olocausto”, a contestare la forma data, “canonica”, del corpus di testi dati come letteratura dell’Olocausto. 1
“Cronaca e storia rappresentano la vicenda ebraica per lo più privilegiando come valore normativo l’esperienza maschile e marginalizzando significativamente quella femminile, secondo il principio che le esperienze di uomini e donne debbano essere identiche. [...] Gli anni dell’immediato dopoguerra non produssero praticamente alcun tipo di ricerca accademica sulle donne e l’Olocausto, se si esclude uno studio sul campo di concentramento femminile di Ravensbrück”, scrive Lillian S. Kremer (Ibidem, 152). 2
Ne parla lo studioso polacco, Przemysław Czapliński (2004). 3
Rosenfeld, 1980. 4
Anette Kolodny (1982, 159) in questo stesso modo difendeva la critica femminista dalle accuse del presunto separatismo, concludendo che la critica femminista non toglie alcunché alla critica preesistente, ma che essa arricchisce. 5
Adorno 1986, 115. Cfr. Czaplinski 2004, 12. 6
Converrebbe qui aprire una lunga parentesi sugli ultimi tentativi di allargare l’orizzonte di studi sull’Olocausto che vertono sulla natura e sui limiti dell’esperienza, sulle nostre capacità di descriverla o di rappresentarla nonchè sull’identità del soggetto che si trova al di qua e al di là dell’esistenza, della conoscenza e della significazione. È proprio il rilancio della categoria dell’esperienza che si attua per il merito della letteratura dell’Olocausto, un’esperienza caratterizzata da un evento traumatico, un’esperienza del mondo in una delle sue manifestazioni più inconcepibili, inimmaginabili, indicibili, insostenibili. Si può descrivere, dunque, un’esperienza che non c’è? Ma l’indicibilità di questa esperienza è solo la metà della verità, l’altra metà dice, d’altro lato, che di quest’esperienza non ci possiamo liberare. (Secondo Lacan il trauma è il nucleo indicibile e irrapresentabile di quello che è reale). L’uomo non dispone purtroppo di uno strumento migliore per raccontare l’esperienza. La rappresentazione discorsiva non si limita alla sola riproduzione o sostituzione dell’oggetto o dell’esperienza. Essa, avendo a che fare con un oggetto che è al di sopra di ogni rappresentazione, deve rendere presente il fatto, comunicare il solo fatto che l’oggetto esista, senza aspirare a dire come quell’oggetto realmente è. Riprodurre, rappresentare è obbligatorio, è un imperativo etico, anche se il solo frutto della rappresentazione dell’esperienza indicibile sia di segnalarne l’esistenza. Quanto al genere di autobiografia sfruttato nei racconti sulla Shoah, anche qui è stato osservato di recente che l’autobiografia è un genere di testo che non riferisce fatti, bensì esperienze, ovvero l’interazione tra l’uomo e gli eventi (Anglani 1996, 29). 7
Limentani 1988, 118. 8
Koontz 1987, 5‐6. Cfr. Kremer 2004, 151. 9
Bravo 1995. 10
Ha ragione Tita Calabrese (2004, 98) nel dire che la donna ebrea da spettatrice, o figura marginale (o da personaggio topico della bella ebrea che rimane un’immagine della seduzione esotica o che perde 11
213
la sua diversità sposando un cristiano) diventa protagonista della stessa sorte che è toccata al maschio ebreo, suo padre o fratello. Accenniamo al saggio di Bożena Umińska (2001), che passa in rassegna le stereotipie che toccarono ai personaggi di donne ebree: da prosèlita, a capro espiatorio, a assimilante ambiziosa (la belle Juive), un personaggio insieme tragico e pericoloso. Bruck 1999, 19. 12
Conviene porre tra parentesi due personaggi forti, positivi, tracciati a tutto tondo nei libri di Angela Bianchini: il “rivoluzionario” Ruben che aiuta ad emigrare in America i profughi ebrei accorsi a Lisbona, o l’affascinante prof. Lowenberg di Le nostre distanze (2001) che fa capire alla protagonista Linda il suo scarso bagaglio spirituale al momento dell’emigrazione e che ne riconosce le doti migliori nella rabbia e irrequietezza, nel non saper essere contenta di essere salvata. 13
Quercioli Mincer (2004, 128) attribuisce la maggiore sopravvivenza di donne ebree nei campi rispetto ai maschi al fatto che esse non portavano “inciso sul corpo il segno del patto con Abramo”, che essendo più portate per le lingue dei loro padri e fratelli, riuscivano a nascondere l’accento yiddish, erano in genere più portate a mimetizzarsi, più abili a non farsi riconoscere e con ciò non irritavano i tedeschi. 14
Tedeschi 1993. 15
Kremer (2004, 168) cita Milton (1984) a sostegno della sua tesi. 16
In simili situazioni, gli uomini si limitavano a parlare del senso dell’impotenza e dell’umiliazione subita all’atto del tatuaggio, scrive Kremer (Ibidem, 160), il massimo di umiliazione e reificazione per il maschio (causati dalla fame, dall’estenuazione, dal lavoro sovrumano, dal terrore) era perdere le caratteristiche distintive di un essere umano, non più homo sapiens, perdita dell’identità personale, riduzione al numero, alla matricola. La perdita della coscienza di appartenere alla razza e alla nazionalità. 17
Nei campi di sterminio invece raramente si trattava di stupro da parte delle SS (ma solo dei funzionari inferiori) perchè le leggi razziali proibivano ai tedeschi rapporti sessuali con le ebree; nel più dei casi le SS le insultavano verbalmente, le punivano o torturavano nel fisico. Le ebree venivano invece incoraggiate a prostituirsi per un pezzo di pane, di stoffa, un paio di scarpe o una medicina, oppure per ricevere un lavoro migliore o per l’esonero da una selezione. Quelle che si prostituivano, in seguito diventavano spesso kapò. 18
Secondo la Kremer gli uomini ebrei danno poco peso al fisico, essendo in essi il vigore fisico tradizionalmente svalutato e non incidendo sul loro senso di mascolinità che loro usano associare non alle virtù atletiche e militari, bensì alla preghiera, cultura, attività professionale. 19
Nella memorialistica maschile ricorre spesso il senso dell’assurdità e della sproporzione oltre che dell’inutilità delle crudeltà inflitta e della sofferenza: basti citare il saggio di Levinas, ‘Useless Suffering’ (1988). 20
Di che fede si può parlare, si domanda Mina de In contumacia, se le fanciulle ammettono di credere perchè costrette dalla fame che urla. Credere in che cosa, poi? “Gli occhi dei ciechi vedranno e i sordi canteranno. Il lupo pascolerà con l’agnello. L’universo sarà un paradiso di pace. Quando nascerà il Messia. Dov’è la pace? Tuoni ad Anzio. Questa pace? Urli a via Tasso? Questa pace? Ceneri nei forni. Questa pace?” (105). 21
La giustizia impone non solo l’obbligo di mantenere una propria integrità (di atto e di parola), di lottare contro il male, di rispettare gli altri, ma di essere onesti e di avere una responsabilità individuale civica, grande peso attribuito alla comunità (l’unione, l’obbligo di non separarsi mai dalla comunità); la compassione si può esercitare tramite la giustizia, la difesa del debole (il rapporto con 22
214
l’altro, la fratellanza). Il concetto della giustizia riguarda una serie di aspetti etici, sociali e religiosi come la salvezza e la libertà. BIBLIOGRAFIA Adorno, Theodor W. Dialektyka negatywna. Traduzione in polacco di K. Krzemieniowa. Warszawa: 1986. Anglani, B. Teorie moderne dell’autobiografia. Bari: Graphis, 1996. Bianchini, Angela. Le nostre distanze. Torino: Einaudi, 2001. Bravo, Anna. ‘Relazione introduttiva’. La deportazione femminile nei lager nazisti, a cura di L. Monaco, Milano: Franco Angeli, 1995. 7‐27. Bruck, Edith. Lettera alla madre. Milano: Garzanti, 1988. ‐‐‐. Chi ti ama così. Marsilio, Venezia, 1994. ‐‐‐. La Signora Auschwitz. Venezia: Marsilio, 1999. Calabrese, Tita. ‘Dalla testimonianza alla letteratura. Memorie tedesche della Shoah negli anni Ottanta’. Oltre la persecuzione. Donne, ebraismo, memoria, a cura di Roberta Ascarelli. Carocci, Roma: 2004. 95‐119. Czapliński, Przemysław. ‘Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze’. Teksty Drugie 5 (2004): 6‐
22. Jarre, Marina. Il ritorno in Lettonia. Torino: Einaudi, 2003. Kolodny, Anette. ‘Turning the Lens on “The Panther Captivity”: A Feminist Exercise in Practical Criticism’. Writing and Sexual Difference, a cura di Elizabeth Abel. Chicago: Chicago UP, 1982. Koontz, Claudia. Mothers in the Fatherland. New York: St.Martin’s Press, 1987. Kremer, Lillian S. ‘Memorie di donne: esperienza e rappresentazione dell’Olocausto in termini di genere’. Oltre la persecuzione. 158‐175. Levi, Lia. Una bambina e basta. Roma: e/o, 1994. Levinas, Emmanuel. ‘Useless Suffering’. Traduzione di R. Cohen. The Provocation of Levinas. R. Bernasconi & D. Wood, eds. London and New York: Routledge & Kegan Paul, 1988. 156‐167. Limentani, Giacoma. In contumacia. Milano: Adelphi, 1967. ‐‐‐. L’ombra dello specchio. Milano: La Tartaruga, 1988. Milton, Sybil. ‘Women and the Holocaust: The Case of German and German‐Jewish Women’. Monthly Review Press (1984): 297‐333. Quercioli Mincer, Laura. ‘Le frontiere della lingua. Memorie ebraiche fra Polonia e Israele’. Oltre la persecuzione. 119‐133. Rosenfeld, Alvin H. A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature. Indiana: Indiana UP, 1980. Sereni, Clara. ‘Ebrei’. Eppure. Milano: Feltrinelli, 1995 ‐‐‐. Taccuino di un’ultimista, Milano: Feltrinelli, 1998. 215
Tedeschi, Giuliana. C’è un punto della terra. Una donna nel lager di Birkenau. Firenze: La Giuntina, 1993. Umińska, Bożena. Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze. Sic: Warsawa, 2001. 216
COSSU, Maria Grazia. ‘Voci di frontiera. il Ritorno in Lettonia di Marina Jarre’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 217‐229. RIASSUNTO Sia nell’impianto narrativo di Ritorno in Lettonia che nei suoi principali nuclei tematici Marina Jarre esibisce una serie di consonanze e suggestioni espresse da altre autrici italiane del Novecento quasi sempre estranee alla cultura ebraica. A titolo esemplificativo, si potrebbe accostare l’opera della Jarre a La penombra che abbiamo attraversato (1964), di Lalla Romano, ad Aracoeli (1982), di Elsa Morante e a Bagheria (1993), di Dacia Maraini. Secondo questa prospettiva, Ritorno in Lettonia presenta un tema ricorrente della scrittura autobiografica al femminile degli ultimi decenni, ossia il ritorno fisico e metaforico al paese dell’infanzia, compiuto da un io narrante che negli anni della maturità affronta finalmente certe lacerazioni profonde e mai risanate del passato, relative alle figure familiari. Nella Jarre, tale discorso si arricchisce di elementi originali, perché la ricerca e il recupero della figura paterna si saldano intimamente sia all’esigenza di comprendere e testimoniare la tragedia dell’antisemitismo consumatasi nell’Europa orientale e sovietica, sia al tentativo di cogliere il volto autentico di un padre volutamente cancellato dalla memoria, a causa di antiche incomprensioni familiari. In questa travagliata ricerca storica e individuale, la voce della bimba fuggita da Riga nel 1935 dialoga incessantemente con quella della scrittrice che tenta di ristabilire la verità su quanto è accaduto in quegli anni, e di ciò vengono sempre fornite opportune e puntuali indicazioni: studi sulle vicende dell’area baltica, ma anche numerose fonti personali (lettere, fotografie, testimonianze di parenti e amici), nonché frequenti autocitazioni che chiamano in causa altre opere della Jarre. Ciò che traspare dall’’opera è soprattutto il desiderio dell’autrice di ristabilire una presenza, quella paterna, da tramandare ai discendenti nel tentativo, forse, di preservare la radice ancestrale di sé e della propria famiglia, ma anche di una cultura e di una fede religiosa in fondo mai abiurata. Inoltre, tale discorso si costruisce attraverso una riflessione ‘laica’ sui valori etici della fede, secondo una coscienza multiculturale che si apre al dialogo fra le religioni: proprio la presenza di duplici radici ebraiche e valdesi – queste ultime ereditate dalla madre – consente alla scrittrice un’elaborazione estremamente originale dei temi della tradizione ebraica. PAROLE CHIAVE Ritorno, Lettonia, infanzia, padre, valdesi © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 217
VOCI DI FRONTIERA IL RITORNO IN LETTONIA DI MARINA JARRE Maria Grazia Cossu Università degli studi di Cagliari Fra le opere di Marina Jarre, Ritorno in Lettonia introduce un’interessante novità perché presenta una serie di motivi e suggestioni espressi, negli ultimi decenni, anche da altre scrittrici italiane estranee alla cultura ebraica. In particolare, l’opera della Jarre si potrebbe accostare a Cortile a Cleopatra (1936) di Fausta Cialente; a La penombra che abbiamo attraversato (1964) di Lalla Romano; ad Aracoeli (1982) di Elsa Morante, e a Bagheria (1993) di Dacia Maraini. Infatti, sul piano tematico, le opere appena citate propongono un ritorno, dalle valenze fortemente simboliche, al paese dell’infanzia nel corso del quale l’io narrante, ormai alle soglie della piena maturità, affronta finalmente certe lacerazioni profonde e mai risanate del passato relative alle figure familiari. Occorre comunque evidenziare che, nel caso della Romano, della Maraini e della Jarre, l’impianto di queste opere risulta assolutamente autobiografico, poiché si tratta della narrazione di un’esperienza reale mentre, nel caso della Cialente e della Morante, tale ritorno risulta fittizio e metaforico, per quanto denso di implicazioni esistenziali, perché il romanzo è comunque percorso da una serie di suggestioni ed esperienze vissute in parte anche dalle autrici. Anche Marina Jarre declina dunque il tema del “guardar dietro”, tema che è poi la riproposizione in chiave moderna del ritorno biblico alla terra dei propri padri. L’autrice, che è nata a Riga nel 1925, descrive infatti il viaggio compiuto in Lettonia nell’autunno del 1999, insieme al figlio Pietro, spinta dall’esigenza di colmare una sensazione di vuoto definita con il termine tedesco Sehnsucht, che qui vuole esprimere: […] una nostalgia di riunione, di ritorno […] la quale diventa nostalgia liturgica di ritorno alla spiaggia luminosa ed immensa dell’infanzia. (Jarre 1981, 81) Con una prosa asciutta e pacata, tesa a registrare attentamente i fatti, ma anche le emozioni che hanno accompagnato un’esperienza respinta per oltre sessant’anni, la Jarre affronta in maniera lucida la vicenda più dolorosa della propria vita, riversandosi senza infingimenti nella scrittura: […] avvertivo un bisogno confuso di parlare di mio padre, fosse pure soltanto ponendo domande e, nel mentre, mi accorgevo di quanto a lungo avessi taciuto. (Jarre 2003, 112) 218
e, al rientro dalla Lettonia, spinta da quel richiamo “fattosi suono vivo a Rumbula” (Jarre 2003, 115), comincia a riannodare i molteplici fili già disseminati in numerose pagine della produzione precedente, soprattutto in Un leggero accento straniero del 1972, e ne I Padri lontani del 1987. Ritorno in Lettonia riproduce i motivi classici della topica del ritorno: quali, ad esempio, l’alternanza dei piani temporali e del punto di vista dell’io narrante, sospeso fra passato e presente; 1 la consapevolezza del perdurare di un tempo interiore e soggettivo che ha cristallizzato certi episodi nella memoria e l’esistenza, invece, di una dimensione temporale indipendente ed esterna all’io narrante che ha scandito gli accadimenti reali; 2 il senso d’irrimediabile estraneità ai luoghi familiari, in cui pure era capace di orientarsi perfettamente, e alle persone, anch’esse ormai naturalmente tutte sconosciute. 3
Tuttavia, il resoconto del nostos compiuto dall’io narrante in Ritorno in Lettonia, si arricchisce di elementi assolutamente originali che scaturiscono, in primo luogo, dalla straordinaria eterogeneità – culturale, religiosa e linguistica – che caratterizza la vicenda personale della nostra scrittrice: per questo, nel titolo, ho voluto definirla una voce di frontiera. Innanzitutto, Marina Jarre non appartiene in maniera esclusiva ad un’unica comunità nazionale e ciò le permette di scrutare la realtà secondo una prospettiva multiculturale che si avvale della perfetta padronanza di numerose lingue apprese sin dall’infanzia (tedesco, francese, italiano), oppure apprese più tardi (inglese, russo), lingue che caratterizzano l’universo idiomatico e culturale entro il quale la nostra autrice riconosce elementi inconfondibili della propria personalità; afferma infatti: “in ogni lingua ero diversa. Ogni lingua ha il suo tempo” (Jarre 1987, 83). Inoltre, occorre sottolineare la sua duplice appartenenza ad ambienti culturali e religiosi tradizionalmente esclusivi, come quelli ebraici e valdesi, da entrambi i quali ha finito col mantenersi distante, pur coltivando una religiosità intesa, da quanto traspare dai suoi libri, soprattutto come esperienza etica e intellettuale e come riflessione laica sui valori di una fede estranea ai dogmatismi delle verità rivelate ma protesa invece a ricercare valori universali e condivisi. Proprio illustrando gli avvenimenti fondamentali della propria esistenza, Marina Jarre pone l’accento sulla mésalliance linguistica con cui ha imparato a convivere sin da bambina: Sono scrittrice italiana ma sono nata in Lettonia e vi ho passato l’infanzia. La Lettonia era allora una repubblica baltica indipendente. Mio padre era un ebreo lettone, mia madre era italiana. La lingua della mia infanzia fu il tedesco. Nella mia città natale, Riga, convivevano etnie, lingue, religioni differenti: luterani, ebrei, ortodossi cattolici. Si parlava lettone, tedesco russo, polacco svedese […] La mia certezza […] era la mia lingua tedesca. A lei, mi riconduce il mio primo consapevole sentimento d’appartenenza. 4
Se la lingua tedesca assicura a Marina Jarre, sin dall’infanzia, l’appartenenza ad un universo culturale circoscritto, le drammatiche vicende familiari dell’autrice e le terribili ferite che la Germania nazista inferse alla storia europea fecero però ben 219
presto vacillare tale certezza. Infatti, nel luglio del 1935, il tormentato divorzio dei genitori riportò Marina e la sorellina Annalisa in Italia dai nonni materni a Torre Pellice, in provincia di Torino, in un ambiente fortemente connotato in senso culturale e religioso: Arrivando in casa della nonna non giunsi propriamente in Italia: mia madre […] apparteneva per origine (se non più per credenza) a un piccolo gruppo di protestanti italiani, i valdesi. Nelle valli valdesi del Piemonte si parlava francese. 5
Benché la madre fosse lettrice d’italiano all’università di Riga, l’apprendimento di questa lingua avviene però solo durante l’adolescenza, a scuola, e finisce per rappresentare “l’esperanto nel quale mi accinsi a scrivere” (Jarre 1987, 85) anche se, ancor oggi l’autrice la percepisce come una “lingua non immediata” (Jarre 2003, 6) e “mai intima” (Jarre 2003, 7), soggetta a infinite revisioni, più importante per il suo valore strumentale che come segno di un’identità culturale e linguistica italiana, in quanto per moltissimi anni il punto di riferimento rimase soltanto “quello religioso – calvinista montanaro – e quello storico valdese”. 6 Sul piano emotivo, Ritorno in Lettonia viene definito da Piera Egidi: “storia straziante di un’assenza”, in quanto l’opera cerca di rimediare all’apparente indifferenza con la quale l’autrice ha sempre circondato l’evento che più di tutti ha segnato la sua esperienza di vita, tanto che per moltissimi anni ha eliminato ogni legame con quel passato. Sin dagli anni Cinquanta, Marina era a conoscenza della scomparsa, avvenuta durante la guerra, del padre Samuel Gersoni, insieme alla figlia illegittima Irene di appena cinque anni – nata dalla relazione con un’infermiera tedesca poi ritornata in Germania – e al resto della famiglia paterna. Da allora, il desiderio di recuperare questa figura sabiana al contempo amata e odiata, i cui affari erano “delle stramberie” (Jarre 1987, 17) e che andava “due volte all’anno a Parigi a divertirsi” (Jarre 1987, 17), si salda intimamente, anche se in modo inconsapevole, sia al tentativo di cogliere il volto autentico di un padre cancellato dalla memoria per le antiche incomprensioni familiari, 7 sia all’esigenza di comprendere e testimoniare la tragedia dell’antisemitismo consumatasi nella piccola repubblica baltica la quale, come mostrano i numerosi documenti presenti in Ritorno in Lettonia, solo dopo la lunga parentesi sovietica ha cominciato ad interrogarsi su una delle pagine più cupe della propria storia recente. DALLA PARTE DEL NAZISTA: IL ROMANZO DI KLAUS Dal punto di vista letterario, Ritorno in Lettonia appare perciò la tappa conclusiva di un percorso esistenziale e narrativo cominciato con Un leggero accento straniero, un romanzo pirandelliano scritto negli anni Sessanta 8 nel quale la Jarre ritrae un personaggio che, come Mattia Pascal, convive con il proprio doppio. L’accento straniero appartiene a Klaus Boehr, un nazista responsabile di molti crimini nell’est 220
europeo e in Lettonia, che dopo la guerra, fingendosi un irreprensibile ingegnere svizzero, si ricostruisce una dignitosa esistenza a Torino. Conducendo un gioco narrativo particolarmente attento ad analizzare dall’interno la parabola esistenziale dei suoi personaggi, la Jarre scava impietosamente nella paradossale ‘verità’ di Klaus il quale, attraverso un accorato apologo al tribunale della coscienza, descrive i sentimenti provati durante quei massacri: Che sentivo? Be’ mi sentivo male ma è così facile ascrivere a una debolezza riprovevole il venir meno della vostra resistenza di fronte a quel che vi ripugna […] I bambini mi facevano sempre più pena dei grandi […] feci una maledetta fatica con i bambini […] E allora, dite voi, […] come fu possibile? […] Fu possibile proprio perché fummo uomini. C’è in noi, in noi tutti, una vitalità feroce che si nutre della morte degli altri […] le nostre scelte sono così prepotenti che cancellano l’esistenza degli altri. (Jarre 1972, 156‐157) Secondo Klaus tali azioni disumane non possono trovare giustificazione “se non in quella lacerazione del tempo nella quale si compirono le nostre azioni” (Jarre 1972, 175), e in tale contesto egli fu solo un esecutore, un soldato fedele che scelse di obbedire alla patria: quei crimini non sono perciò ascrivibili a responsabilità individuali ma solo alla follia collettiva di una nazione che volutamente ha inferto al mondo intero “una ferita che non si cicatrizza” (Jarre 1972, 175). L’unico modo per restare innocenti “era di morire” (Jarre 1972, 194), ma a quale scopo sacrificare inutilmente la propria vita, si chiede infine Klaus con estremo cinismo se, osservando i fatti nel loro complesso, il sacrificio di tanti innocenti in fondo fu permesso anche da Dio? Guardate com’è finita, al di là dei mucchi di vestiti vuoti, al di là della cenere, al di là degli urli e del terrore […] guardate da che parte è stata la fortuna. Da che parte è stato Dio. Che colpa ne ho io, se Dio è stato con me, se Dio è stato con noi? (Jarre 1972, 411) Il romanzo riporta dunque rovesciato tutto il dramma dell’Olocausto: infatti, questo lacerante interrogativo sull’inspiegabile silenzio di Dio che non è intervenuto a salvare il suo popolo, costituisce una delle principali argomentazioni alla base dell’ antisemitismo: “Dio (che esista o meno) non salverà il suo popolo” (Yehoshua 23); mentre, proprio questo atteggiamento divino rappresenterebbe per gli ebrei una conferma della propria condizione di eletti, dal momento che “Dio rimprovera colui che ama” (Prov., 3, 12). Alternando il punto di vista e i piani temporali del racconto, Marina Jarre dà voce anche al gruppo di giovani torinesi, fra i quali è presente una ragazza ebrea, Daria Cohen, i quali rappresentano quella società borghese in cui il nazista cerca di assimilarsi. Accanto alla lucida testimonianza di Klaus, che svela lentamente al lettore la propria terribile verità, si assiste anche alla rievocazione della tragica persecuzione subita dalla famiglia Cohen durante la guerra e alle vicissitudini del gruppo fino all’inspiegabile suicidio di Daria che, quasi per ironia della sorte, muore asfissiata dal 221
gas di scarico dell’automobile mentre Klaus, benché smascherato per caso da una donna come aguzzino nazista, continua a vivere impunito la sua tranquilla vita borghese. Un leggero accento straniero rappresenterebbe dunque la prima tappa del percorso ebraico della Jarre e il suo tentativo di documentarsi a fondo per raccontare gli orrori del nazismo proprio dal punto di vista dell’implacabile nemico tedesco che tuttavia parlava “l’amata lingua dell’infanzia” (Jarre 2003, 135): Lessi per la prima volta la storia dello sterminio del popolo ebraico nei paesi baltici, in Bielorussia, in Ucraina, in Crimea e in Polonia, pochi anni dopo aver avuto conferma della morte di mio padre. Cercavo notizie e testimonianze per […] Un leggero accento straniero […] Il mio doveva essere un libro sui carnefici: gli unici, affermava uno dei miei protagonisti, a poter essere indagati. Le vittime non si potevano rappresentare, poiché inventare le loro vicende sarebbe stato togliergli una seconda volta la vita. Le vittime sono sacre, non si toccano. (Jarre 2003, 26) La dedica posta in exergo al romanzo “per loro veliamoci il viso e piangiamo”, non lascia perciò dubbi sul fatto che l’autrice abbia così avviato la difficilissima rievocazione della pagina inenarrabile della propria esistenza, la ricostruzione della figura paterna e il racconto della sua tragica fine, anche se la cornice romanzesca entro la quale colloca l’intera vicenda le consente di mantenere ancora celato il proprio dramma personale: Ritornavo dunque puntualmente a celebrare nei miei libri il rito funebre per mio padre e i suoi, affidando il compito dell’evocazione alla pura e semplice cronaca della testimonianza altrui […] Ricordavo, sempre, e scrivevo commemorando. (Jarre 2003, 27) Del resto, la Jarre è convinta che la realtà terribile dell’Olocausto renda illegittima e inconsistente qualunque ricostruzione letteraria per cui la rievocazione autobiografica e la ricerca di testimonianze rappresentano l’unica via per raccontare quegli avvenimenti: Di quest’orrore possono raccontare solo i testimoni. E noi, e io non posso scriverne perché questa cosa, questa cosa non si può inventare. Perciò niente romanzi, niente film […] solo loro, solo chi è sopravvissuto ha il diritto di testimoniare. Se ci riesce. La cosa non può essere narrata, non sopporta l’espressione letteraria; lo sterminio non può essere raccontato, le parole si rifiutano, le parole si fanno livide, le parole si rifugiano nel silenzio. Raccontare è tradire. (Jarre 2003, 27) La Jarre non si esime dall’esprimere le proprie considerazioni sulla follia della Shoah e afferma di sentirsi defraudata due volte, sia del padre che di quel numero immenso di persone che seguirono la stessa sorte, mentre il “perverso gioco delle cifre” (Jarre 2003, 219) contribuisce solo a spersonalizzare le vittime e a sbiadire la reale disumanità del crimine. 222
MEMORIA E PERDONO Alla scrittrice pare improprio anche parlare di perdono definito: “frutto di una lunga maturazione interiore […] esito privatissimo di una nostra intima lotta” (Jarre 2003, 227) e questo discorso, che esula da qualunque riferimento alle vicissitudini personali, costituisce invece per l’autrice una misura etica necessaria per discernere le vicende del proprio tempo: La fine dei miei ha nel mio animo un peso tale, una misura così definitiva, che vi rimane conclusa in se stessa. La mia pena sta ferma con i miei morti, fonda, in un abisso in cui il tempo non batte più le sue ore. (Jarre 2003, 247‐48) Al contrario, Marina Jarre tenta di riscattare il senso del proprio e dell’altrui lutto, perpetuandone la memoria attraverso la scrittura e cercando così di testimoniare una verità che deve essere nota a tutti, come prescrive l’antico precetto dello Shema’ Israel nel Deuteronomio. 9 Se per Dario Calimani “la scrittura si propone come alternativa ai vari percorsi dell’oblio, come argine al dissolvimento della memoria storica” (2002, 20), l’autrice mostra di prendere alla lettera tale invito e spiega: Vorrei solo che si sapesse; perciò come potevo, ho fatto raccontare ancora una volta i testimoni, ho posto sassolini, scrivendo. (Jarre 2003, 248‐249) La Jarre immerge il racconto del proprio viaggio in Lettonia in un’atmosfera letteraria di profondo impatto emotivo – la rievocazione immaginaria di alcuni episodi biblici all’origine della storia ebraica e poi della diaspora sembra scaturire, per analogia, dai paesaggi altrettanto selvaggi e senza tempo di una località sarda, Is Aruttas, nella quale la Jarre trascorre le sue vacanze – ma lascia alle fonti storiche 10 e ai vari materiali pubblici e privati (documenti, lettere, verbali), copiosamente presenti nell’opera, il compito di ricostruire la verità storica di quei fatti, per dar voce alle vittime e ai pochi sopravvissuti di quelle stragi. Questa lunga ricerca documentaria le permette di ripercorrere la genealogia paterna a partire da un antenato sefardita Gersoni espulso dalla Spagna nel 1492, quindi, seguendo le tracce della lunga erranza dei suoi discendenti, l’autrice ritrova negli archivi alcune testimonianze relative alla famiglia paterna e a una serie di parenti prossimi superstiti negli Stati Uniti e in Israele. RITORNO AL PADRE Il viaggio si conclude con la toccante visita a Rumbula, luogo in cui avvenne il massacro degli ebrei di Riga del 30 novembre e dell’8 dicembre 1941. A ricordare quei fatti “una pietra nera con incisa, ben visibile, nell’angolo superiore a sinistra, la stella di Davide” (Jarre 2003, 270). Con la sua sacralità, quel monumento riesce finalmente a restituirle nella sua concretezza una presenza che per tanto tempo aveva 223
solo immaginato, un segno che non attesta affatto la tragica morte di suo padre, ma la sua esistenza: “Lo ritrovo vivo” (Jarre 2003, 270). Dedicato a entrambi i genitori, 11 Ritorno in Lettonia propone una serie di elementi che riportano la Jarre nell’orbita di un ebraismo vissuto in primo luogo come retaggio familiare. Innanzitutto l’autrice accenna a una dichiarazione contenuta nell’ultima lettera inviata da Samuel Gersoni alle figlie, nella quale chiede loro aiuto per sfuggire alle persecuzioni, e che assume i contorni di un marchio indelebile sulla coscienza dell’io narrante. Infatti quell’uomo bruno, altissimo e molto bello con “gli occhi splendenti e neri, i ricciolini sulla fronte” (Jarre 2003, 29), soprannominato dalle sue figlie il brigante, che “sembrava un principe arabo” e “viveva come un estraneo” nella sua famiglia, rivolge alle due bambine un monito lapidario: “ricordatevi che anche voi siete ebree” (Jarre 1987, 15), monito con il quale intende coinvolgerle in quel comune destino che la discendenza matrilineare ha potuto scongiurare. Tale dichiarazione non è di scarso rilievo se si considera che, secondo Solomon, l’identità ebraica è costruita sulla base di “una identificazione preadulta con le persone prossime al bambino, con i loro valori e modelli di comportamento” (Solomon 1999, 12). Inoltre, sempre a questo proposito, Yehoshua precisa che, per un ebreo, l’attribuzione dell’identità ebraica è indispensabile per il mantenimento dell’identità stessa e che egli può cambiare paese, lingua, nazionalità e persino religione ma dentro di sé continua a sopravvivere un “principio occulto”, una radice irriducibile che permane a livello inconscio e lo accomuna per sempre ai propri simili. La Jarre si rende conto che la sua appartenenza alla condizione ebraica è parziale, poiché afferma “a noi, ebree, mancava in realtà una madre ebrea” (Jarre 2003, 69), e descrive la propria cosmologia interiore come un’ “anima d’Arlecchino” (Jarre 2003, 68), che con il trascorrere del tempo le ha precluso un’adesione più profonda ad una fede religiosa, valdese o ebraica, anche se questa personale distanza spirituale è in parte il risultato dell’atteggiamento religioso dei suoi familiari: Già dai miei genitori mi veniva una riserva riguardo a una decisa e univoca posizione religiosa: entrambi avevano avuto un atteggiamento (difficile dire se consapevole) in qualche modo distante verso la fede dei loro avi. Mio padre era assolutamente un miscredente e a mia madre la “patria” valdese dava sui nervi. (Jarre 2003, 67) Marina Jarre si mostra molto attratta dal mondo ebraico – svolge la tesi in letteratura cristiana sull’Adversus Judaeos di Tertulliano 12 e manda i propri figli alla scuola ebraica di Torino – come se riconoscesse in quelle “costumanze […] un po’ esotiche […] quasi tutte liete e festose”(Jarre 2003, 68), qualcosa di vagamente familiare che la affascina e che la pone in pace con se stessa perché rappresentano anch’esse “un sassolino rituale” (Jarre 2003, 68). E di sassolini della memoria pare costellata l’intera opera perché Ritorno in Lettonia chiama in causa questa antichissima tradizione funebre ebraica che nella sua umilissima essenzialità riesce a perpetuare il ricordo di qualcuno; anzi, quello stesso 224
invito a conservare la memoria, presente anche in ambito valdese, costituisce per la Jarre il solo anello che riesco a raffigurarmi tra la deliberata incuria cimiteriale dei miei padri valdesi – anch’essi tramandavano ai figli il compito di durare ‐ e la sobrietà funeraria dei miei padri ebrei. (Jarre 2003, 78) ‘Sassolini e pianto rituale’ si intitola, infatti, anche un lungo capitolo di Ritorno in Lettonia, 13 e questa espressione sembra caratterizzare le forme nelle quali per la Jarre è possibile preservare dall’oblio la memoria degli affetti personali, definita dall’autrice “il solo luogo dove si erano svolti i fatti” (Jarre 2003, 16). In particolare, la scrittrice descrive la sua condizione esistenziale attraverso le immagini del pianto e del lutto, esperienze a lungo negate a chi, come lei, è fuggita lontano pur continuando a portare su di sé “il peso di un lutto improprio” (Jarre 2003, 17), al quale teme di “non avere diritto” (Jarre 2003, 18). Il ritorno alla città natale le consente invece di riattraversare quel “muro invalicabile” (Jarre 2003, 16), per ritrovare a Riga, città che secondo l’autrice “non esisteva più al di fuori di me” (Jarre 2003, 16), la sua voce di allora e pochi altri suoni che potrebbero permetterle di “risuscitare la voce” (Jarre 2003, 42) del padre. Nel corso di questa travagliata ricerca storica e individuale, la bambina fuggita da Riga nel 1935 dialoga incessantemente con la scrittrice che vi fa ritorno per ristabilire la verità su quanto è accaduto nel 1941, e anche il suo antico pianto “disperato e lungo” (Jarre 1987, 54), si rinnova in quello della donna ormai matura che, mentre in aereo fa ritorno in Lettonia, piange in silenzio “nel palmo della mano” (Jarre 2003, 15). Un altro elemento che allude al recupero di motivi ebraici è l’uso di imporre soprannomi che ne sanciscano l’appartenenza: da bambina Sisi si era scelta come soprannome “Mosino, l’ebreo errante”(Jarre 2003, 129), e Marina talvolta amava chiamarla così. A questa espressione fa eco la frase pronunciata dalla madre dell’autrice che da vecchia, esitando, come se facesse una scoperta, un giorno disse alla scrittrice: “tu eri […] la valdese e Sisi l’ebrea” (Jarre 1987, 156). L’aspetto che più di tutti qui vorrei sottolineare è che Marina Jarre filtra il discorso ebraico attraverso la dimensione protestante 14 della sua coscienza e, senza avvertire in sé alcuna lacerazione, spesso stabilisce impliciti confronti fra la fede ebraica e quella valdese perché, come spiega Cesare Segre, attraverso la Bibbia la nostra autrice rivive “la continuità tra ebraismo e cristianesimo” (Segre 2003). Marina infatti si interroga a lungo su questa duplice eredità e immagina di aver già vissuto vite precedenti, presentandosi come testimone di episodi biblici ed evangelici o della storia delle prime comunità valdesi; quando però si ritrova al cospetto di quel Dio che rappresenta entrambi i “padri lontani” – l’antico e terribile Dio di Israele, e l’altrettanto minaccioso Dio valdese – si definisce “eterodossa” (Jarre 2003, 73), quasi a ribadire l’incapacità di conciliare in sé le due fedi: 225
Potrei confessare che non credo in un’unica rivelazione, che non credo verrà mai il Messia degli ebrei, e, quanto al giovane Joshua, osso avvicinarmi a lui solo quando lo vedo dormire esausto per la sua affannosa corsa. (Jarre 2003, 73‐74) La scrittrice ricorda di aver percepito tale difficoltà già da bambina quando pensava “nessuno mi spiega la differenza fra gli ebrei e i cristiani” (Jarre 1987, 46). Solo il nonno paterno, un ebreo lettone allevato da un pastore luterano, durante l’infanzia le ha parlato di Dio: “Dio è giusto, dice il nonno, ma noi, la sua giustizia non possiamo comprenderla” (Jarre 1987, 49). L’impossibilità di spiegare razionalmente la presenza di Dio nella storia umana la spinge ad interrogarsi sulla sua imperscrutabile volontà e sul senso di un’elezione che divide cristiani ed ebrei “com’è possibile che Dio tra tutti i popoli della terra abbia privilegiato i cristiani?” (Jarre 1987, 61). L’ANIMA PROTESTANTE DI MARINA JARRE Nemmeno nella lettura della Bibbia, cui si dedica sistematicamente, trova delle risposte anche perché la Jarre si sente attratta più dalle vicende a volte avventurose dei protagonisti che dalle impenetrabili implicazioni dottrinarie. Eppure, vorrebbe comprendere quale mistero si celi dietro l’atteggiamento implacabile di quel Dio venerato nelle valli valdesi che aveva osato abbandonare il proprio figlio sulla croce: Se Iddio non aveva avuto pietà di lui, perché avrebbe dovuto averne di me? Era un Dio tremendo […] Non puoi fare contratti con Lui, il Dio dei barbetti, il Dio degli antenati valdesi di mia madre. (Jarre 1987, 64) La tormentata epopea delle comunità valdesi fa parte della complessa eredità culturale della scrittrice che ne trasmette la memoria in un poderoso romanzo storico, Ascanio e Margherita (1990), in cui racconta le lotte sostenute per la libertà religiosa da un gruppo di valdesi tornati dalla Svizzera – si tratta ancora una volta di un ritorno, il glorioso rimpatrio 15 in Piemonte, nel 1689 – per riconquistare le terre avite. L’opera rivela però quanto sia illusorio poter ricucire la propria appartenenza a quelle origini: “non c’era legame fra me e quel mondo che mi restava esteriore” (Jarre 1987, 148). Infatti, pur immersa in quella comunità di cui conosce perfettamente le vicende storiche e le tradizioni, la Jarre non accetta l’eccesso di rigore che caratterizza la mentalità valdese e che spinge ciascuno ad un gara estenuante con se stessi e con il prossimo nel tentativo estremo di vedere riconosciuti i propri meriti proprio perché, come puntualizza ancora la Jarre, in fondo si ricerca “l’unica approvazione acquietante, quella impossibile del Dio barbetto” (Jarre 1987, 151). Nonostante queste critiche, la nostra autrice non ha dubbi quando afferma: “Io non mi farei cattolica, mai” (Jarre 1987, 150). Profondamente convinta che quello stesso Dio che pure non mostra alcuna pietà per i suoi figli, in fondo non possa rinunciare a nessuna delle sue creature, neppure alla scrittrice la quale un giorno ha compreso che l’astio con cui voleva smascherare le imperscrutabili vie del Signore, 226
celasse invece un’ossessione più profonda per le ombre del proprio passato e per il mistero di quel padre terreno fino ad allora sfuggito ad ogni tentativo di definizione: A Lui acquattato nel mio animo mi lega un patto che contraddice se stesso perché imposto e non sancito; un disaccordo. Un patto d’infedeltà […] che ho sentito raggrumarsi in me via via che scrivevo dei padri […] un diniego che lungi dal riportarmi al loro indomito passato, mi riallaccia piuttosto a qualche cosa di me, remoto non di secoli ma di sconoscimenti.[…] Devo scrivere di me. (Jarre 1987, 153) È questo il senso della “chiamata del Dio barbetto” (Jarre 1987, 154) che la scuote da decenni di torpore spronandola ad aprire finalmente gli archivi polverosi della propria memoria per consegnarsi alla scrittura, anche se continua a chiedersi se è lecito “cercare pace per mezzo del libro” (Jarre 1987, 155), dal momento che esso può solo riferire la cronaca di quella vita, ma non può placarne le angosce. Infatti – e la Jarre lo ha capito perfettamente ‐ il ritorno più autentico alle origini comincia solo con la scrittura: […] temevo nel profondo quell’altro ritorno, che avrei dovuto attuare con la scrittura […] temevo di dover svolgere infine tutto il gomitolo della mia storia personale. (Jarre 2003, 224) Ritorno in Lettonia è dunque il resoconto fedele di questa dolorosa ricerca che si è conclusa a Rumbula di fronte ad una lapide presso la quale, pregando in tedesco, la Jarre si è finalmente riconciliata col proprio padre e con se stessa. Ciò che mi ha colpito in questo magma vischioso della storia dal quale Marina Jarre ha saputo distillare la sua toccante esperienza – strappandola dalle pieghe riposte della sua anima arlecchina – è il desiderio dell’autrice di ristabilire una presenza, quella paterna, come eredità preziosa da tramandare ai discendenti nel tentativo, forse, di preservare la radice ancestrale di sé e della propria famiglia, ma anche di una cultura e di una fede che neppure il battesimo valdese in fondo è riuscito a spegnere. È questo, credo, il senso della riflessione rivolta a Samuele Gersoni ne I Padri lontani e che racchiude, a mio avviso, il senso del mio contributo: La sua morte è rimasta dentro la mia vita come un seme nascosto e via via che vivevo e invecchiavo, essa è cresciuta nel ricordo, non diversamente da un lungo amore […] Da qui è nata, seppure tardi com’è nel mio costume, la mia pietà adulta, come nascono dal gelsomino sarmentoso le radici per ritornare alla terra che le ha generate. Uniche radici che riconosco mie. (Jarre 1987, 110) 227
NOTE Per l’autrice, che osserva il portone dell’antica casa in cui ha vissuto a Riga, la presenza del figlio Pietro assicura il legame fra passato e presente: “Egli era la realtà che mi tratteneva in giusto equilibrio nell’indugio sospeso tra passato e presente”(Jarre 2003, 34). 1
“Non percepivo la distanza che spaziava lungo il percorso di un’intera vita tra la mia partenza da bambina e il mio rientro da vecchia, perché i gradini corrosi che conducevano al portone […] un mio sguardo interiore doveva appunto averli accompagnati mentre si corrodevano anno dopo anno. Ogni mattina avevo continuato a uscire con la cartella, la mia sorellina accanto […] per non tornare indietro”(Jarre 2003, 21‐32). 2
Espressa attraverso la metafora della città disabitata: “[…] non mi era dato di cercare persone ma soltanto luoghi. Nessuno mi avrebbe potuto riconoscere e nessuno avrei potuto riconoscere. Le strade erano vuote”(Jarre 2003, 34). 3
‘Quale patria, per chi non ne ha più nessuna o ne ha più d’una?’ La relazione di Jarre, numerose fotografie e altre notizie biobibliografiche sono disponibili in rete all’indirizzo http://web.tiscalinet.it/marina_jarre. 4
Ibidem. 5
Ibidem. 6
Incomprensioni che per tanti anni la indussero a pensare: “nostro padre non ci amava.”(Jarre 2003, 144). 7
Pubblicato per la prima volta nel 1968 col titolo di Monumento al parallelo, il romanzo contiene una cinquantina di pagine non presenti invece nella versione definitiva di Un leggero accento straniero. 8
“E queste parole che Io ti comando oggi saranno sul tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai […] le legherai come segno sulla tua mano e saranno come frontali tra i tuoi occhi. E le scriverai agli stipiti della tua casa e sui portali della tua città” (Deut. 6, 4‐9). 9
In particolare il libro di Max Kaufmann (1947) (Jarre 2003, 47). 10
La dedica così recita: “Riuniti infine in questa dedica, mio padre e mia madre che per pochi anni si amarono a Riga, dove sono nata”. 11
Così si spiega perché ha scelto Tertulliano: “Più che un senso d’appartenenza alla stirpe […] a spingermi era […] la mia voglia polemica di demolire l’immondo sciocchezzaio antigiudaico dei Padri della Chiesa” (Jarre 2003, 28). 12
Si vedano i seguenti capitoli: ‘Palestina’ (Jarre 2003, 3‐14), ‘Sassolini e pianto rituale’ (Jarre 2003, 15‐
30), ‘Il cuscino di Gesù’ (Jarre 2003, 60‐74). 13
Sulla figura del protestante nella letteratura italiana del Novecento si rimanda a Egidi 2004, 6. 14
Sulla storia della Comunità Valdese e sull’episodio del ‘Glorioso rimpatrio’ si rimanda a De Lange 1990, 1998 e Tourn 2003. 15
228
BIBLIOGRAFIA Cavaglion, Alberto. ‘Guardare contro’. L’Indice 11 (2003): 10. Cialente, Fausta. Cortile e Cleopatra. Milano: Baldini & Castoldi, 2006. De Lange, Albert, a cura di. Dall’Europa alle valli valdesi. Torino: Claudiana, 1990. ‐‐‐. Dreihundert Jahre Waldenser in Deutschland, 1699‐1999: Herkunft und Geschichte. Karlsruhe: Evangelische Presseverband für Baden, 1998. Egidi Bouchard, Piera. ‘La storia straziante di un’assenza’. Riforma 12/ 5 (2003): 5. ‐‐‐. ‘Il protestante nella letteratura italiana’. Riforma 11/ 5 (2004): 6. Caimani, Dario. ‘L’esilio e la ferita della memoria’. L’ombra lunga dell’esilio. Ebraismo e memoria, a cura di Maria Sechi e.a. Firenze: Giuntina, 2002. Jarre, Marina. Monumento al parallelo. Roma: Samonà e Savelli, 1968. ‐‐‐. Un leggero accento straniero. Torino: Einaudi, 1972. ‐‐‐. I padri lontani. Torino: Einaudi, 1987. ‐‐‐. Ascanio e Margherita. Torino: Bollati Boringhieri, 1990. ‐‐‐. Ritorno in Lettonia. Torino: Einaudi, 2003. ‐‐‐. Marina Jarre: home page. [16.09.03] ‒ 25.06.07 http://web.tiscalinet.it/marina_jarre. Kaufmann, Max. Die Vernichtung der Juden Lettlands. Monaco: Im Selbstverlag, 1947. Maraini, Dacia. Bagheria. Milano: BUR, 1997. Morante, Elsa. Aracoeli. Torino: Einaudi, 1997. Romano, Lalla. La penombra che abbiamo attraversato. 2a ed. Torino: Einaudi, 1994. Segre, Cesare. ‘Viaggio in Lettonia alla ricerca della verità’. Corriere della Sera (30.09.2003). Solomon, Norman. Ebraismo. Torino: Einaudi, 1999. Tourn, Giorgio. I Valdesi: identità e storia. Torino: Claudiana, 2003. Yehoshua, Abraham B. Antisemitismo e sionismo. Torino: Einaudi, 2004. 229
DE ANGELIS, Gabriella. ‘Clara Sereni: la sfida della differenza’. Scrittori italiani di
origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica
Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht
Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978-90-6701-017-7. 231-242.
RIASSUNTO
L’opera di Clara Sereni appare contraddistinta dalla valorizzazione di tutte le differenze, a partire da
quelle di genere, passando attraverso quelle etniche, religiose, politiche, fino a quelle che nascono
dalla malattia, fisica o mentale. Sia nella narrativa che negli scritti di vario genere, raccolti in parte nel
Taccuino di un’ultimista, la Sereni, a partire dalla sua molteplice identità, di donna, ebrea, comunista e
madre ‘handicappata’, propone una sfida: non cancellare la diversità, ma accettarla e farne una risorsa
utile ai fini della conoscenza degli altri e di se stessi, lo strumento per impedire che ogni singola
persona e il mondo tutto vadano in pezzi.
PAROLE CHIAVE
Clara Sereni, diversità, donna, ebrea, comunista
© Gli autori
Gli atti del convegno ‘Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale’ (Utrecht-Amsterdam, 5-7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata
da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
231
CLARA SERENI: LA SFIDA DELLA DIFFERENZA
Gabriella de Angelis
Université de Provence
Lo spaesamento, la memoria e il desiderio di un altrove mitico o mitizzato, può essere
considerato uno dei tratti distintivi dell’ebraismo, in tutte le epoche e in ogni
latitudine: la diaspora come destino di tragedia ma anche come fattore forte di
identità che connota di sé ogni membro della comunità. Nostalgia, speranza, paura,
impegno a lavorare per un domani migliore: questo è il lascito che l’ebraismo
consegna a ciascuno dei suoi figli. Con accezioni e accensioni diverse, talvolta –
apparentemente – in forte contrasto le une con le altre, ma con un denominatore che
resta comune, al di là delle condizioni di vita dei singoli, e della loro stessa volontà.
(Rose Zwi, Un altro anno in Africa)
Nelle parole del brano in esergo, che Clara Sereni scrive presentando un libro poco
conosciuto, 1 possiamo leggere, in filigrana, una sorta di autoritratto della scrittrice:
spaesamento, memoria, desiderio di un altrove mitico, nostalgia, speranza, paura, 2
sono tratti caratteristici di coloro che, di persona o attraverso la loro famiglia, hanno
vissuto l’esperienza della diaspora. A questi connotati psicologici si accompagna la
tensione ad impegnarsi per un futuro migliore, rafforzata dall’incertezza sull’aldilà,
la cui aspettativa ha indotto la tradizione cristiana a svalutare la vita terrena.
Sereni è nota per il suo impegno politico e civile, 3 un impegno che si esplica in
campi diversi, ma è sempre caratterizzato da una forte carica utopica e da
un’attenzione particolare per gli ultimi, i diversi.
Oltre alle radici culturali e familiari, all’origine di quest’attenzione sta
l’esperienza personale della scrittrice che, donna, ebrea, comunista, 4 intellettuale,
madre di un ragazzo handicappato, 5 ha sperimentato sulla propria pelle diversità
tutte ugualmente scomode e spesso difficilmente conciliabili tra loro.
La prima sfida dunque è quella di riuscire a tenerle insieme: perché
annullarne o anche solo ignorarne una significherebbe tagliar via una parte di sé, ma
anche perché ciascuna differenza è portatrice di ricchezza.
Tuttavia ciò non basta. Perché la diversità, per quanto scomoda, offre quasi
sempre il conforto di poterla condividere con altri, e quindi, se essa da una parte è
fonte di esclusione, dall’altra consente di riconoscersi in un gruppo più o meno
numeroso, mentre Sereni sperimenta continuamente (e racconta) l’impossibilità di
acquietarsi, di scegliere una volta per tutte, di schierarsi, di fare dell’identità ‘un
angolino caldo’ in cui rifugiarsi: per dirla in breve, si scopre diversa anche tra i
diversi.
In particolare, scegliendo una consapevole appartenenza all’ebraismo, come
altri della sua generazione, figli o nipoti di quanti vissero la Shoah, la scrittrice si
232
trova a fare i conti da una parte con quella memoria, dall’altra con le richieste, più o
meno esplicite, che il mondo circostante le rivolge di schierarsi, di prendere
posizione rispetto alla politica dello stato d’Israele, cui chiunque oggi si dica ebreo,
non può non sentirsi in qualche modo legato:
Israele non è – e probabilmente non potrà mai essere – un paese totalmente uguale agli altri.
Non solo per la sua storia, non solo per la delicatezza strategica della sua collocazione, ma
perché quel fazzoletto di terra […] e i suoi poco più di tre milioni di abitanti sono nel cuore e
nei pensieri di un numero ben più grande di persone sparse nei cinque continenti, ma a quella
terra e ai suoi abitanti legate da affetto, parentela, cultura, interessi, talvolta religiosità. (Sereni
1998, 32)
Nelle pagine che seguono cercherò di illustrare meglio il senso della sfida che Sereni
propone a se stessa e a noi, attraverso due delle sue opere più significative.
IL GIOCO DEI REGNI E LA STORIA DI UN’IDENTITÀ CONTROVERSA
Nell’ultimo capitolo de Il Gioco dei Regni, 6 la scrittrice racconta le tappe del percorso
che, con la frequentazione delle lezioni di Giacoma Limentani prima e un viaggio in
Israele poi, la porta a riappropriarsi pienamente della cultura ebraica e insieme a
riconoscersi parte di una grande famiglia, divisa dalla storia tra Italia e Palestina.
L’adesione più matura e consapevole all’ebraismo, che tuttavia esclude fermamente
la dimensione religiosa, si compie, dunque, da una parte attraverso lo studio dei
testi, ma si completa solo con il recupero di un passato personale di cui prima, dice la
scrittrice, aveva posseduto soltanto brandelli (Sereni 1993, 435).
Importante diventa così rintracciare le testimonianze, volutamente cancellate
dalla memoria consegnatale, del matrimonio al tempio dei genitori e della
conversione della madre, che le consentono di definirsi ebrea non solo per cultura,
ma “anche da un punto di vista giurisprudenziale” (Sereni 1993, 441); ed illuminante
è la scoperta della giovanile adesione del padre al sionismo e addirittura
all’ortodossia religiosa.
I libri e il viaggio insieme, dunque, memoria ed esperienza, mente e cuore ma
anche corpo coinvolti in un’avventura che comporta dislocazioni continue nel tempo
e nello spazio e soprattutto il rischio di riaprire ferite che apparivano sanate o di
provocare nuove lacerazioni. Perché la storia raccontata ne il Gioco dei Regni si dipana
tra l’inizio del secolo scorso e i primi anni del dopoguerra, sullo sfondo di quegli
eventi che hanno fatto ripetutamente a pezzi l’Europa, le sue nazioni e le diverse
comunità che la abitavano.
Clara Sereni sembra fare il percorso inverso rispetto a quello compiuto dal
nonno paterno Samuele, detto Lello che, agli inizi del secolo scorso, aveva
consapevolmente interrotto la tradizione di annotare le nascite e le morti della sua
famiglia in ebraico, su una vecchia bibbia ereditata dal padre rabbino, per inaugurare
la nuova “genealogia cui intendeva dar corpo […] fatta non di ebrei, ma di uomini”
(Sereni 1993, 30).
233
Samuele Sereni, medico della Real Casa, godeva di un prestigio sociale indiscusso e,
sentendosi a pieno titolo membro dello stato unitario, aveva creduto che i suoi figli
avrebbero trovato ad accoglierli un mondo in cui la differenza, che aveva
dolorosamente segnato gli antenati, sarebbe stata ignorata, sancendone la compiuta
integrazione nella collettività nazionale. Pur senza uscire dalla Comunità romana,
decide di attenuare i segni di quell’appartenenza, evitando, per esempio, la
tradizionale cerimonia per la circoncisione dei figli maschi. Quando essi saranno più
grandi resiste alle pressioni della cognata Ermelinda che, non avendo figli suoi,
sogna per uno dei nipoti la carica di rabbino e sceglie, d’accordo con la moglie
Alfonsa, di dar loro un’educazione laica:
Per l’ebraico cosa pensate di fare? – chiese Ermelinda […] Alfonsa sospirò: non restava che
impegnarsi, la nuova carica di suo cognato alla presidenza delle Comunità israelitiche non
consentiva rinvii, né espedienti.
– Enrico andrà al Talmud Torà come tutti quanti – disse Alfonsa […]
– Un po’ pochino, non credi? […] il mio Angelo pensava ad un rabbino giovane, qualcuno che
possa occuparsi di tutti e quattro i ragazzi qui in casa, con tutta la serietà che ci vuole […]
– Lello ed io pensiamo che vada bene così – precisò Alfonsa.
[…] Come molti Enrico studiò l’ebraico e la Torà lo stretto necessario, la celebrazione del barmitzvà sembrandogli non altro che un passaggio obbligato, un adempimento formale da
superare in fretta per dedicarsi poi ad occupazioni più laiche e interessanti. (Sereni 1993, 7779)
In seguito, allo scoppio della prima guerra mondiale Enrico, coerentemente con le
scelte del padre, consapevole che anche quel prezzo è da pagare per essere
riconosciuti definitivamente italiani, deciderà di parteciparvi. Ne tornerà segnato da
inquietudini e angosce che lo spingono a lungo in fuga per l’Europa, alla ricerca di
un’unità sempre sfuggente e in quella ricerca
[…] perfino l’identità ebraica, addormentata sotto coltri consolidate, gli si risvegliò. Però non
fece fatica a tenerla a bada, anzi quasi ne rise e rimase immune dal bacillo del sionismo.
(Sereni 1993, 129)
Poco più tardi, Enrico fu tra i primi a prendere contatto con gli esponenti
dell’antifascismo militante, mentre il fratello più giovane, Enzo, sperimentava già da
studente liceale le botte e l’olio di ricino. Ma quest’ultimo, diversamente da lui e
insieme ad Emilio, detto Mimmo, di poco più giovane, comincerà a frequentare i
circoli degli studenti sionisti e ambedue saranno immediatamente conquistati da
quel progetto che sembrava incarnare al meglio il sogno di un mondo ispirato ai
valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della giustizia.
Partito Enzo per la Palestina insieme alla moglie e alla figlia piccolissima,
Mimmo si preparava a raggiungerlo e portava avanti gli studi di agraria che aveva
intrapreso proprio per contribuire alla rinascita di quella terra. Ma il progetto viene
bruscamente troncato dall’adesione al partito comunista che ne orienta in senso
234
completamente diverso l’impegno e le speranze e lo induce a interrompere ogni
rapporto col fratello.
In seguito Emilio, lungamente prigioniero nelle carceri fasciste e più volte
condannato a morte, riuscirà a salvarsi e diventerà esponente di punta del PCI e poi
ministro nel primo governo dell’Italia repubblicana; mentre Enzo, che insieme alla
moglie Ada era al centro di una rete di attività clandestine destinate a salvare dallo
sterminio migliaia di ebrei, verrà catturato dai nazisti e finirà i suoi giorni a Dachau.
Duramente provato dalla morte del fratello, il padre di Clara assiste con
emozioni contraddittorie alla nascita dello Stato d’Israele, ma
quando Anna, la figlia maggiore di Enzo, decide di sposarsi, Mimmo chiede di essere lui ad
accompagnarla al Tempio, ad esserle padre. La sacralità del rito, fra i superstiti dei
rastrellamenti e dei lager, lo restituisce a un mondo che non ha smesso di appartenergli.
(Sereni 1993, 372)
Sarà la Guerra dei Sei Giorni a determinare l’interruzione definitiva dei rapporti con
quanti, dei suoi, avevano scelto Israele. E Clara, allora troppo giovane per pensare di
frapporsi fra il padre e la famiglia di lui, dovrà attendere vent’anni per ritrovarsi, con
il viaggio a Gerusalemme, in una rete di rapporti affettivi assai vasta e
inaspettatamente disponibile a riaccoglierla nel suo seno.
Così sarà lei, con il suo libro, a ricomporre almeno idealmente quella frattura
che si era consumata tra i due fratelli Enzo ed Emilio, riconoscendoli identici nel
perseguire gli ideali nobilissimi e non poi così discordanti cui avevano deciso di
consacrare la loro vita:
Sionismo, comunismo. Parole che hanno assunto significati e sfumature diversi e per chi oggi
ha vent’anni il sionismo s’identifica nell’espansionismo dello Stato d’Israele, e il comunismo
nelle bandiere ammainate sulle cupole d’oro del Cremlino.
I vent’anni di Enzo e di Mimmo, i febbrili vent’anni di chi era nato con il secolo che ora sta
finendo, trovavano in quelle e in altre parole un denominatore comune: la speranza di un
mondo diverso, più giusto ed umano. (Sereni 1993, 205)
IL TACCUINO DI UN’ULTIMISTA, OVVERO DELL’UTOPIA
Il Taccuino è una raccolta di pezzi, apparsi su riviste e giornali, o anche inediti, che
coprono un arco di circa dieci anni, dai quali emerge con chiarezza, anche teorica,
insieme alla rivendicazione di un’identità fatta come un “mosaico di tessere mal
tagliate”, 7 l’affermazione forte del valore della diversità, che da sofferenza può
trasformarsi in ricchezza:
[…] l’ordine assegnato ai diversi brani segue una logica che attiene più che altro alla ricerca di
un filo interno a me. Non fingo alle quattro partizioni di questo libro un’oggettività esterna,
ma le dichiaro come i quattro spicchi dei quali, con continui sconfinamenti, mi sembra di
compormi: ebrea per scelta più che per destino, donna non solo per l’anagrafe, esperta di
handicap e debolezze come chiunque ne faccia l’esperienza, utopista come chi, radicandosi in
235
quanto esiste qui e oggi, senza esimersi dall’intervenire sulla realtà quotidiana coltiva il
bisogno di darsi un respiro e una passione agganciati al domani. La fatica di dare coerenza a
queste parti, e gli sconfinamenti dall’una all’altra, sono peraltro la rappresentazione più fedele
di una fase diversa da quella di “scrittrice pura” che vantavo fino a pochi anni fa […]. (Sereni
1998,11-12)
I brani sono organizzati dunque in quattro sezioni, corrispondenti ai quattro spicchi
che corrispondono ciascuno a una forma di differenza. 8
Esaminerò qui la prima sezione, intitolata Shalom, quella che ci parla della
condizione di chi, dichiaratasi “ebrea per scelta, più che per destino” affronta le
difficoltà e le lacerazioni continue cui tale scelta la espone. Si tratta di dieci
capitoletti, più o meno brevi, scritti dal 1991 al 31 luglio 1997 e non cronologicamente
disposti, ma accostati l’uno all’altro in modo da costituire un vero e proprio racconto.
Il libro del resto è già da altri stato riconosciuto come un vero e proprio capolavoro di
narrativa immerso nel nostro sociale.
A prima vista ogni pezzo appare concluso in se stesso, legato com’è a un
episodio, un fatto di cronaca, un’emozione. Ma alla fine scopriamo il duplice filo
rosso che lega un brano all’altro e che è fatto di due parole chiave, due immagini:
‘smarrirsi’ (o perdersi e perdere la vita) ed ‘esplodere’ (o andare in pezzi).
Ed ecco, nel primo brano, la storia del soldato israeliano che si è smarrito a
Ramallah,
armato di mitra ma non di fortuna, dentro una manifestazione di integralisti: perduto per
sempre, preda di una violenza senza appello ma anche senza più ragioni che dalla ragione
possano farsi comprendere. (Sereni 1998, 15)
L’immagine che la scrittrice usa, paragonandolo a un “Pollicino del Duemila”, riesce
appena ad attenuare lo sgomento, suggerendo l’idea che potrebbe trattarsi di una
fiaba e che, dunque, la speranza in un lieto fine è possibile.
Nel secondo brano, il più lungo, inedito, del 1991, è invece centrale l’idea della
deflagrazione.
Il racconto comincia con un sogno in cui sono riconoscibili gli elementi dello
scenario cui ci hanno abituato le rappresentazioni della Shoah. Siamo nel marzo ’91, è
scoppiata la cosiddetta prima guerra del Golfo e dall’inconscio riemerge quella
memoria che non le appartiene e che pure è dentro di lei come un male inevitabile:
Agguati, fughe a perdifiato. Filo spinato, torrette, riflettori puntati. Controlli occhiuti, i miei
documenti sono falsi e comunque insufficienti. Rastrellamenti, torture […] Sui sogni
dell’orrore ho lavorato a lungo, pensavo di essermene liberata. Invece al primo
bombardamento su Baghdad eccoli qua, pronti e verdi e virulenti:gli ultimi vent’anni – i
tentativi di costruirmi un equilibrio – spazzati via da un telegiornale. (Sereni 1998, 16)
Ma peggiore del sogno è la realtà: in un breve giro per la sua città, tra luoghi familiari
e persone note, Clara scopre che quelle bombe hanno cambiato in modo forse
irreversibile il mondo, e insieme tutti i rapporti, la percezione che gli altri hanno di
236
lei e che lei ha degli altri: sospettosi o imbarazzati, vagamente ostili o preoccupati di
consolarla, tutti la vedono non come una persona qualunque, con cui condividere
inquietudini e riflessioni, ma in primo luogo come ebrea: “La memoria ripesca chissà
dove una citazione, chissà di chi: ‘Alcuni mi rinfacciano di essere ebreo, altri me lo
perdonano, altri ancora addirittura mi lodano per questo, ma tutti ci pensano’”
(Sereni 1998, 17). E lei stessa sente un tono di minaccia nella voce in arabo che esce dal
transistor del fioraio maghrebino, da cui si è fermata col figlio a comprare un
tulipano. L’effetto è letteralmente dilacerante:
Una deflagrazione: i pezzi di me non riescono più a tenersi insieme, il concerto di clacson del
perenne ingorgo romano non copre minimamente il frastuono che mi esplode nella testa.
Ho bisogno di dire almeno la confusione grandissima, il dolore: è come se mi si fossero slogate
tutte le giunture, una dislocazione integrale e ininterrotta di tutte le connessioni che mi
impedisce ogni riflessione, ogni aggiustamento. Sull’ascolto possibile, però, ho fin d’ora molte
incertezze. (Sereni 1998, 17)
La narratrice dubita della possibilità di “dichiarare tutta la confusione, la sofferenza
di non potersi schierare con niente e con nessuno”: gli ebrei cui si unisce in piazza
San Pietro per chiedere il riconoscimento dello stato d’Israele, con cui sarebbe facile
scoprire legami di sangue più o meno stretti, le appaiono compatti e più lontani del
papa polacco che ha tante volte criticato.
Le persone con cui in altri tempi ha condiviso la fine delle certezze politiche e
il bisogno di adattarsi a trasformazioni e incertezze, le appaiono, soprattutto gli
uomini, “straripanti di aggressività primordiali” e implacabili nel sottolineare
ostilmente ogni differenza. Ma anche tra le donne sono poche quelle che non si
rassegnano “a ridursi sui binomi bianco/nero, buono/ cattivo”, poiché l’irrazionalità e
la paura facilitano prese di posizione schematiche, inadatte a descrivere le
contraddizioni nuove che la situazione impone. Dovunque
un vuoto pervaso di ostilità e insofferenza, chiuso a ogni parola che sia riconoscimento di
differenza e problematicità. (Sereni 1998, 19)
Persino l’8 marzo è capace solo di suscitare la rabbia
per gli alberi di mimosa scerpati dal consumismo […] non ho niente da festeggiare, non la
guerra finita solo virtualmente, non vincitori che mi fanno orrore: quand’è che troverò una
comunità cui appartenere. (19)
Ma l’incontro casuale con un gruppo di coinquiline (casalinghe e borghesi, dunque
diversissime da lei), che per la prima volta si regalano una cena da sole, la contagia
brevemente di euforia e la riscalda:
Provo a dirmi – ma con quanta fatica di ottimismo!- che forse è possibile ripartire da qui, da
questi legami minimali ma indistruttibili, da questo filo esile, per tentare di ritrovare parole di
donna, quelle che mi interessano per ricominciare a definire il mondo, e per tentar di ricucirmi
237
[…] L’ordito non cessa dunque di lacerarsi, di aggrovigliarsi ma Penelope non è morta, e –
voglio crederlo- prima o poi ricomincerà a tesserla, la sua tela. (Sereni 1998, 20)
Attraverso i brevi capitoli si alternano la registrazione dei momenti di speranza
(l’accordo di pace siglato da Arafat, Rabin e Clinton) e dei giorni di tragica
disillusione (la morte di Rabin), ma anche quella di fatti meno eclatanti che pure
risultano significativi a illuminare un mondo in cui la diversità, qualunque essa sia,
non viene riconosciuta e rispettata, è anzi annullata o ignorata e diventa, magari per
noncuranza, occasione o pretesto di esclusione.
Particolarmente amare, per esempio, le parole con cui la scrittrice commenta la
leggerezza con cui il governo di Carlo Azeglio Ciampi fissò la data per lo
svolgimento delle elezioni politiche del 1994, senza tener conto della coincidenza con
Pesach, la Pasqua ebraica. Nulla a che vedere, certo, con la pervicacia che
contraddistinse i Romani, all’epoca dell’occupazione della Palestina, nel cercare
consapevolmente di “strappare gli ebrei alla loro religione e alla loro diversità, di
assimilarli e renderli indistinguibili e privi di identità specifica”, abili ad utilizzare
persino la conoscenza dei testi sacri, per obbligare le autorità religiose a consentire la
trasgressione delle regole. In questo caso “tutt’al più un peccato di omissione, di
distrazione, di superficialità”. Peccato grave però, se provoca una lacerazione anche
in una come lei, che pur non essendo religiosa, è profondamente legata alle sue
radici, e la obbliga a una scelta che esclude ogni mediazione:
[…] dichiararsi ebrea oppure italiana. Così come agli altri, a tutti gli altri elettori, richiederà di
scegliere fra essere solidali con gli ebrei oppure cittadini rispettosi delle esigenze dello Stato.
(Sereni 1998, 21-22)
Ogni episodio risuona nell’animo della scrittrice con una nota personale, ed è così
che lei ce lo consegna, segnato da una soggettività che lo sottrae alla nuda cronaca e
lo integra in quel discorso unitario, sempre in bilico fra testimonianza, riflessione e
letteratura, che è la sua caratteristica.
C’è la visita a un kibutz, “l’unica forma di convivenza collettiva che non abbia
ancora dichiarato fallimento”, come le dice orgogliosamente la sua accompagnatrice,
consapevole che quella diversità è legata a un filo fragilissimo; e il filo rischia
continuamente di spezzarsi, sotto l’attacco della crisi economica che mina alla radice
tutta l’organizzazione e soprattutto per l’affievolirsi della spinta ideale:
[…] i giovani nati qui ora vogliono essere uguali a tutti gli altri di ogni parte del mondo e per
questo fuggono via, a sciami, ed è molto difficile trovarne di nuovi che chiedano di essere
ammessi a far parte permanente della comunità. (Sereni 1998, 26)
Un altro brano, scritto dopo uno dei tanti attentati, nel 1996, lamenta l’impossibilità
di trovare parole nuove per descrivere e riflettere sull’ennesima tragedia; e
soprattutto la crescente difficoltà di distinguere tra lo Stato d’Israele e il popolo
ebraico:
238
So benissimo che non sono la stessa cosa e io per prima ho combattuto tante volte, su fronti
diversi, la tendenza a un’omologazione che non può essere che dannosa. Eppure anch’io mi
ritrovo a pensare che chi vive in Israele è uno scampato, o figlio o nipote di scampati:
scampati ai pogrom, ai lager, agli stermini grandi o minuti, alle guerre e agli attentati.
A questi scampati è capitato di farsi carnefici di altre vittime; a questi scampati si chiede ora di
affrontare la pace, una pace che non deve affogare nel sangue ma che dal sangue e dai morti è
certamente messa a repentaglio. (Sereni 1998, 28)
Ancora le immagini di un attentato nell’ultimo brano, che porta la data del 31 luglio
1997: il mercato di Gerusalemme insanguinato da un’esplosione. Vi si sente lo
sgomento di chi sa che le analisi politiche più raffinate, da qualunque parte
provengano, non bastano a capire, che la razionalità è insufficiente, che le parole
stesse sono sempre più impotenti, anzi sono diventate rischiose:
So di fare un discorso rischioso, dicendo che l’ebraismo è una rete di rapporti che abbraccia il
mondo intero […] in un’epoca che sta facendo dell’appartenenza un’arma assai contundente,
non è strano che rivendicarne una produca, in se stessi e negli altri, effetti perversi.
Ma è proprio la capacità di tenersi uniti attraverso i quattro punti cardinali che ha definito nei
secoli gli ebrei, più in termini di popolo che non di religione in senso stretto. Un senso di
appartenenza che li ha costruiti irriducibilmente “altri”, strutturalmente diversi da tutte le
popolazioni con le quali sono via via venuti in contatto. Una diversità per molti aspetti
rivendicata, ma soprattutto una diversità pesantemente subita: la scia di sangue ha
attraversato i secoli con tracce ripetute e appariscenti. (Sereni 1998, 32)
Ma, se è evidente che “con questa diversità fatica a misurarsi e convivere il mondo
arabo” e che “rispetto a questa diversità non sono sciolte le ambiguità che hanno
attraversato e attraversano il resto del mondo, e in particolare il mondo occidentale”
(Sereni 1998, 32), la scrittrice è certa che la sfida della diversità va affrontata e vinta
perché “all’utopia della pace non c'è alternativa”. 9 Del resto “abbiamo cominciato ad
imparare che si può confliggere, che ci si può contare, confrontare e scontrare senza
che questo significhi (o almeno, non necessariamente) uccidersi, annientarsi a
vicenda”. 10
Il che significa accettare ogni differenza e non cercare di annullarla, né negare
i conflitti che essa provoca, ma saperli attraversare, con la possibilità di scoprire
finalmente che in ciascuna si nasconde un tesoro, che tutte insieme danno sapore al
mondo:
È come la ragazza ammantata nel chador che vediamo attraversare una strada di Milano o di
Dublino: la sua presenza stessa ci interroga e pensare che accettarla possa significare renderla
uguale a noi equivarrebbe a cancellarla, a cancellare un tratto di quella diversità che – per
quanto scomoda – è il sale della terra. (Sereni 1998, 32-33)
Ed è proprio l’immagine della ragazza in chador che richiama per contrasto, con la
sua leggerezza, quella del soldato israeliano del brano iniziale, che conclude, in una
composizione ad anello, la prima sezione del Taccuino. Se la differenza ne è il
leitmotiv dal punto di vista tematico, la frammentazione ne è la cifra stilistica: 11
239
perché i pezzi di cui siamo fatti sono a continuo rischio di dispersione (o diaspora!),
esposti come sono alle esplosioni che riempiono di urla e sangue le strade delle città
del mondo e, attraverso i media, bombardano le nostre case.
CONSONANZE
Mi piace segnalare qui, a conclusione di questo breve studio, le consonanze non
superficiali con i temi e i problemi proposti da Sereni che ho ritrovato nei testi di
alcuni autori israeliani contemporanei e che affrontano la realtà contemporanea. Mi
limito a citarne due, convinta tuttavia della grande ricchezza di spunti che
potrebbero venire da una ricerca più approfondita.
Il primo è il romanzo di Shifra Horn, intitolato Inno alla Gioia. In esso si
racconta di Yael, giovane antropologa sposata e madre di un bambino, la cui vita va
in pezzi in seguito ad un attentato di cui ha rischiato di essere vittima: la donna si
trovava nella sua utilitaria bloccata nel traffico cittadino, incolonnata dietro a un
autobus, e per ingannare l’attesa si era messa a giocare a nascondino con un bimbo
affacciato al vetro posteriore dell’automezzo, quando all’improvviso si era scatenato
il finimondo. Salva per miracolo e illesa nel corpo, Yael non riesce a riprendere una
vita di cui ha smarrito il senso. Gli altri, tutti quelli con cui ha condiviso fino a quel
momento la quotidianità, il marito, la madre, le amiche, i colleghi, sono incapaci di
comprenderla: l’episodio l’ha resa irrimediabilmente diversa. Istintivamente sente il
bisogno di ritornare sul luogo dell’esplosione, incredula che il mondo possa
continuare ad esistere, finché incontra l’unica persona nella quale forse potrà
riconoscersi, il padre del bambino morto: con lui poco a poco trova la forza per
ricominciare a vivere.
Prende le mosse da un attentato (che, come quello reale, del luglio 1997, ha
luogo nel mercato ortofrutticolo di Gerusalemme) anche la vicenda narrata nel
romanzo di Abraham B. Yehoshua, Il responsabile delle risorse umane. In esso stavolta
ha trovato la morte una donna non più giovane, dipendente di un grosso e famoso
panificio. Per motivi di immagine, il proprietario dell’azienda dà al suo capo del
personale (ovvero responsabile delle risorse umane) l’incarico di occuparsi dei
funerali della donna e non si tira indietro neppure quando quello scopre che si tratta
di una straniera, da poco arrivata a Gerusalemme, originaria di un lontano paese
asiatico e forse neppure ebrea. Il responsabile è dunque incaricato di scortare la
salma in quella terra, quasi ai confini del mondo, dove ancora vivono la madre e il
figlio di lei. Il viaggio, lungo, accidentato, si trasforma in un percorso di purificazione
per il protagonista, tormentato da sensi di colpa di cui non sa darsi ragione. Infine,
proprio quando si crede finalmente arrivato a destinazione, dovrà confrontarsi con
un problema inatteso: l’anziana madre della defunta esige che la salma sia riportata a
Gerusalemme, dove la figlia aveva scelto di vivere, perché, dice, quella città
“appartiene a lei come a chiunque altro.”(Yehoshua 2004, 250). In un primo tempo il
responsabile respinge nettamente la richiesta, che tra l’altro comporterebbe difficoltà
economiche e burocratiche al limite dell’insuperabile. Ma a poco a poco si fa strada in
240
lui la convinzione che le ragioni della donna abbiano qualche fondamento e tenta di
persuaderne il suo stesso capo; infatti, dice, il ritorno potrebbe “rafforzare la città che
negli ultimi tempi ci sta facendo disperare tutti quanti”:
– Rafforzarla con che cosa, strano uomo, con una nuova tomba?
– Con una nuova tomba, un’anziana madre e un bel ragazzo che si uniranno a noi.
– Vuole portare anche loro.
– Perché no? Non hanno il diritto di venire?
– Il diritto? Il diritto? – L’urlo angosciato del proprietario della fabbrica di Gerusalemme
sovrasta ora il frastuono dei macchinari. – Ma che dice? Tutto questo non ha senso.
– Un senso, signore, lo troveremo insieme. Io, come sempre, l’aiuterò. (Yehoshua 2004, 257258)
NOTE
Si tratta di Un altro anno in Africa di Rose Zwi: vi si raccontano le storie di una piccola città abitata, tra
gli altri, da ebrei che, arrivati in tempi diversi in fuga dai pogrom dell’Europa orientale, si trovano a
vivere nel paese dell’apartheid razzista.
1
2
Per questa dimensione ‘intima’ dell’identità ebraica si veda il libro di Luca De Angelis (2006).
Nel decennio scorso Sereni, dubitando che la scrittura fosse sufficiente a cambiare il mondo, decise di
misurarsi anche con la politica istituzionale e accettò la carica di vicesindaco di Perugia, la città in cui
si era trasferita, abbandonando Roma. Di quell’esperienza, caratterizzata dalla caparbia volontà di non
rinunciare ad essere diversa e di non omologarsi alle logiche dei partiti, racconta in Passami il sale. In
seguito, costretta alle dimissioni, perseguirà il suo impegno contribuendo, tra l’altro, alla creazione
della Città del sole, una fondazione il cui obiettivo principale è la promozione di progetti mirati alle
persone che hanno problemi mentali e psichici.
3
Particolarmente difficile rivendicare insieme l’appartenenza all’ebraismo e alla schiera di coloro che
si definiscono ancora, nonostante tutto, comunisti. Si veda a tale proposito l’articolo della Sereni
apparso sul quotidiano l’Unità il 16 gennaio 2006 col titolo ‘La colpa di essere ebrea’, che ha suscitato
molte polemiche; come del resto è accaduto alla recente autobiografia di Bice Foà Chiaromonte, che
s’intitola proprio Donna, ebrea, comunista e che per di più è uscita con una prefazione di Massimo
D’Alema, esponente di spicco dei DS.
4
A questa particolare esperienza e alla riflessione sulla malattia mentale e su altre dolorose diversità
sono dedicate due raccolte di racconti brevi, Manicomio Primavera ed Eppure. Si vedano però anche i
molti interventi della scrittrice sulla stampa quotidiana e periodica e le due opere collettive, Mi
riguarda (che contiene ‘Diario’, la testimonianza della sua vicenda personale) e Si può.
5
Mi limiterò qui a pochi cenni sul romanzo, che è già stato oggetto di un mio studio: ‘Storia, memoria
e costruzione dell’identità nel “Gioco dei regni” di Clara Sereni’, Atti del Convegno dell’AIPI, Ascoli
Piceno 2006, (in corso di pubblicazione).
6
La metafora, che ritorna più volte nella Sereni, con numerose varianti, si trova per la prima volta in
Casalinghitudine (1987, 165), il libro forse più noto della scrittrice che, uscito tredici anni dopo quello
d’esordio, Sigma Epsilon, pubblicato nel 1974 e mai ristampato, la rese nota al grande pubblico.
7
Per il tema della differenza, coniugata in tutte le sue forme, che è centrale nell’opera della Sereni, si
veda un altro mio breve saggio: ‘Clara Sereni, ovvero l’indecente differenza’, in Images et formes de la
8
241
différence dans la littérature narrative italienne des années 1970 à nos jours, Atti del Colloque du CERCIC,
Université Stendhal, Grenoble, 2005 (in corso di pubblicazione).
Da un articolo pubblicato sul quotidiano l’Unità col titolo ‘I ragazzi c’insegnano il realismo di
un’utopia’ (2002).
9
Da un articolo pubblicato sul quotidiano l’Unità col titolo ‘La vera sfida: rendere la diversità una
ricchezza’ (2002). L’articolo contiene riflessioni in margine al congresso dei DS, il partito erede del
vecchio PCI cui, pur in modo molto diverso dal padre, la scrittrice continua a fare riferimento.
10
Ritengo che il frammento, il racconto breve, sia davvero la forma che più si addice alla scrittrice. Del
resto anche l’ultimo libro, Le merendanze, il più vicino alla forma del romanzo tradizionale, la
contraddice per molteplici aspetti. Si veda comunque il breve saggio di Stefano Giovanardi (1997).
11
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Mi riguarda, Roma: Edizioni e/o, 1994.
AA.VV., Si può, a cura di Clara Sereni, Roma: Edizioni e/o, 1996.
De Angelis Luca. Qualcosa di più intimo. Firenze: Giuntina 2006.
Foà Chiaromonte, Bice. Donna, ebrea, comunista. Roma: Memori, 2006.
Giovanardi, Stefano. ‘Verso la forma romanzo: prospettive narrative di Clara Sereni’. Accademia degli
Scrausi. Parola di scrittore. Roma: Edizioni minimum fax, 1997.
Horn, Shifra. Inno alla gioia. Traduzione di E. Carandina. Roma: Fazi, 2004.
Sereni, Clara. Sigma Epsilon. Padova: Marsilio, 1974.
---. Casalinghitudine. Torino: Einaudi, 1987.
---. Manicomio primavera. Firenze: Giunti, 1989.
---. Il gioco dei regni. Firenze: Giunti, 1993.
---. Eppure. Milano: Feltrinelli, 1995.
---. ‘Introduzione a Rose Zwi’. Un altro anno in Africa. Roma: Edizioni Lavoro, 1995. vii-ix.
---. Taccuino di un’ultimista. Milano: Feltrinelli, 1998.
---. Passami il sale. Milano: Rizzoli, 2002.
---. ‘La vera sfida: rendere la diversità una ricchezza’. l’Unità (18.11.2002).
---. ‘I ragazzi c’insegnano il realismo di un’utopia’. l’Unità (12.02.2002).
---. Le Merendanze. Milano: Rizzoli, 2004.
---. ‘La colpa di essere ebrea’. l’Unità (16.01.2006).
Yehoshua, Abraham B. Il responsabile delle risorse umane. Torino: Einaudi, 2004.
242
ANDERLINI D’ONOFRIO, Serena. ‘Utopias, Metabolized: Queering Communism and
Zionism in Clara Sereni’s Testimonial Narratives’. Contemporary Jewish Writers in
Italy: a Generational Approach. Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds.
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving
Services, 2007. ISBN 978-90-6701-017-7. 243 – 259.
SUMMARY
This article proposes an analysis of the narrative ecologies of Sereni’s autobiographical novels,
Casalinghitudine and Il gioco dei regni. It includes a discussion of the utopian discourses present in her
family and childhood, of her relationships with the maternal figures in her life, and of her take on the
cultural concept of mothering – with its connotations related to origin, desire, and genealogy. In the
context of assessing the bio-politics of Sereni’s testimonial writing, the article teases out, perhaps
against the grain of the author’s intention, the queer aspects of Sereni’s autobiographical accounts,
and it places these aspects in the context of today’s global ecological concerns – especially those
related to fertility and water. The utopian discourses brought to bear on the analysis include those
focused on modern science, revolutionary socialism, communism, and Zionism.
KEYWORDS
Queer utopias, narrative ecologies, mothers, waters, the matrixial
© The authors
The proceedings of the international conference Contemporary Jewish Writers in Italy: a
Generational Approach (Utrecht-Amsterdam, 5-7 October 2006) are volume 2 of the
series ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE,
published by Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
243
UTOPIAS, METABOLIZED
QUEERING COMMUNISM AND ZIONISM IN CLARA SERENI’S
TESTIMONIAL NARRATIVES
Serena Anderlini D’Onofrio
University of Puerto Rico, Mayaguez (USA)
NARRATIVE ECOLOGIES AND THEIR UTOPIAN PATHS
Clara Sereni’s work is at the intersection of three current personal and professional
interests of mine, which include the interconnections of ecology and culture; the
study and production of testimonial narratives that involve tropes like memory,
outness, and trauma; and the elaboration of, as well as participation in utopian
visions, families, and laboratories. There is also an important similarity in our lives:
both of our fathers were politicians who genuinely believed in their calling to
contribute to a better future for the planet, and both of our biological mothers died
from cancer when we were quite young. 1 This, I submit, involves a preoccupation
with the mother, both as a conventional – and often anti-feminist – social construct,
and as a lost – or imagined – utopian space of amniotic liquidity and prenatal
hospitality. My reflection on this contrast has been further stimulated by the
theoretical work presented by Bracha Ettinger, based in Israel and England. She
focuses on the matrixial as a border space modeled on prenatal life where identities
collapse and singularities co-emerge in the transubjective sharing of memories and
traumas. In the context of my preoccupation with waters, health, wombs, and
mothers, this concept enables interesting readings of the ecology of Sereni’s
narratives, where the seduction of interrupted female genealogies often seems to
compete with the instinct to survive via lateral moves that leave Oedipal origins
aside. 2
Much as this study is inspired by shared preoccupations and multiple
alignments, it focuses on the two books by Sereni that reverberate with memories
related to her family, Casalinghitudine (1987), and Il gioco dei regni (1993). The former
is the book that established her reputation as a writer, calling the attention of secondwave Italian women and feminists to her gender-inflected themes and style. The
latter is a family saga that confirms and expands this reputation with a wider
perspective on the intricacies of twentieth-century history and culture. Both can be
viewed as testimonial narratives where the author figures as a witness of personal
and family experiences that are significant in the writing of what I have elsewhere
called the ‘her/stories’ of the disempowered and the marginalized. 3
Here I propose to read these two books in the context of Sereni’s ambivalent
relationship to Israel, Judaism, and the utopian discourses therein implied, an
244
ambivalence which, as I claim, comes from her experience of growing up in a highly
utopian early- and mid-twentieth century family where a number of utopian
discourses intersected, including Socialism, modernism, Communism, and Zionism.
At this early stage of the new millennium, most of the enthusiasm for these utopias
has subsided. On the other hand, other utopian discourses have arisen, including
those embedded in queer and LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) lifestyles
and studies, in ecofeminist theory and activism, and in sustainability and gender
studies. We live in a time of what ecofeminist Vandana Shiva calls ‘water wars’, a
time of increasing scarcity, privatization, and lack of access to the fresh water all
humans need to stay alive. Sea water and its salinity produce increasing
desertification in a global-warming climate. Israel, with its evocative power of a land
‘promised’ as hospitable and fertile, is inevitably inscribed in a wider ecological
narrative, as are other utopian gardens built in the desert, including the city of Los
Angeles and its surrounding irrigation-based agriculture. 4 At this junction, the arts
loving humans need most are not reproductive, and the scarcity of life-giving liquids
needs to be thought, as I propose, through cultural metaphors about pre-natal life
and mothers and their related narrative and theoretical deconstructions. 5
Indeed, if one reads Il gioco dei regni with Vandana Shiva’s Water Wars in
mind, one realizes that the early Jewish kibbutz founded in pre-World War II
Palestine were part of a utopian vision designed to bring fertility and abundance
back to the Middle East, an area that had once been the ‘fertile crescent’ that
functioned as the proverbial ‘cradle’ of western culture. But if one looks at the
satellite map of today’s Israel and its neighboring countries, as well as at the map of
its Integrated National Water Distribution System in the highly documented study
by historian Howard Sachar, it becomes apparent that the transformation of Israel’s
territory into a garden is partly responsible for the expansion of the human-made
deserts that surround it. 6 The former shows scorching deserts east, north-east, and
south of Israel’s green area; the latter an aqueduct plan, implemented around 1957,
designed to pump the fresh water of Lake Galilee, at the border with Syria – and near
the area often contended with Lebanon – into Israel’s southern irrigated agricultural
valley.
I have lived near the border between Southern California and Northern
Mexico long enough to know how precarious the lives of migrant Mexicans are –
especially when they manpower California’s agricultural production – and to
empathize with their fellow country people who resent the damming and pumping
systems that hoard most usable water out of the Colorado and turn this powerful
river into a trickling stream as it reaches the other side. The dystopian character of
this contrast is persuasively argued in Cadillac Desert, a study of the American West
and its disappearing water. As I became involved in this study, I picked up on the
similarities between the two situations. As one reads Sereni with these coordinates in
mind, the possibility occurs that in both Israel and California some form of utopian
modernism was not relinquished on time. This is not meant to imply that either
Sereni or I accuse Israel of intending to cause desertification in surrounding areas,
245
nor of deliberately or intentionally stealing other people’s water. Rather, the utopian
modernity that inspired Israel and Southern California’s development styles was
deluded to assume that, if scientifically made to irrigate and fertilize, available water
would multiply, just like the amniotic liquid in the uteri of mothers constructed as a
culture’s natural bodies of reproduction rather than subjects in their own right. The
dystopian effects of this presumption can be easily imagined.
To come back to the utopian discourses at play in Clara Sereni’s family,
predictably we find Zionism. According to historian Walter Laqueur, this utopian
discourse was based in forms of secular Jewish nationalism tinged with socialist
communitarianism. Its claim to a homeland was founded on nineteenth century
romantic sense of patriotism. Historically, the desire to found Israel results from the
combined effects of the progressive emancipation of Jews in European countries
following the French Revolution, and its resulting successes and backlash – all of
which were compounded with post World War II gentile and Jewish survivor guilt
about the horrors of the Shoah. 7 However, in Israel the Zionist utopia did not become
actualized. According to political and economical scientists Ilan Peppé and Daniel
McGowan, dystopian effects manifested early enough: with the end of the British
mandate on the region of Palestine in 1948, they note the beginning of what
Palestinians call Nakba, or ‘disaster’, which in that culture’s historical memory is
associated with the massacre of the Arab population in the village of Deir Yassin,
near Jerusalem, in the same year of 1948. 8 In 1967, the Six-Day War allowed the
expansion of Israel almost all the way to Egypt – an expansion later on contained, but
nonetheless understandably threatening to its neighbors at the time. 9 Today, the
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) has acquired a reputation as one
of the strongest conservative lobbies in Washington, and Israel is often seen as a
proxy of the ‘good empire’. Many speak of a de facto Israeli-Palestinian apartheid.
Sereni’s narratives are testimonial to the need to create more alignment between
culture and ecology in view of assuaging these violent contrasts.
Despite or perhaps because of the early and idealistic supporters of Zionism,
today’s Israel is oddly positioned at the intersecting nodes of major global and local
ecologies. Cultural ethnographer Jared Diamond has good reasons to claim that
‘fertile crescent’ is a cruel misnomer for the desert between two rivers called
Mesopotamia. 10 Sadly enough, in ecological terms this largely human-made
degradation reads as a measure of the long-term effects on nature of the
unsustainable Western predatory mentalities. By the same token, the establishment
of Israel in the aftermath of World War II can be read as the military-industrial
complex’s strategy to put a new Danzig corridor on the world’s map – a time bomb
predisposed to make military and violent solutions to cultural and environmental
conflicts appear necessary enough. Why would otherwise the same militaryindustrial complex that had produced the anti-Semitism that lead to the Shoah now
want to send all surviving Jews to Palestine? Military build-up feeds on the same
fuels as industrial production, and a foot in the Middle-East keeps an eye on its
blood supply.
246
Considerable environmental risks are inherent in this course of action at any time.
But today’s climatologists agree that if global temperatures go further up by more
than just two Fahrenheit degrees, the oceans will rise by an estimated 80 feet. 11 This,
as Al Gore’s documentary AN INCONVENIENT TRUTH demonstrates very graphically,
places most of Manhattan, Haifa, Tel Aviv, Beirut, LA, and many other shoreline
cities positively under water. Ironically enough, in the perspective of these
cataclysms, the military ideology that constructs war as the ‘world hygiene’ that
resolves overpopulation problems and its ensuing impact, might prove just as
unnecessary as it is otherwise known to be highly cruel and impractical.
This global ecological perspective, I claim, puts a new spin on Clara Sereni’s
testimonial narratives – and their stories of survival from utopias-turned-dystopian.
Due to their cultural, religious, racial, and political affiliations, Sereni’s parents and
grandparents had an uncanny affinity for, and familiarity with, utopian discourses.
Sereni’s father Emilio, aka Mimmo, aka Uriello, was born to highly educated Jewish
parents in the significantly integrated Jewish middle-class of pre-Fascist Italy. He
lived beyond the Shoah that killed his two brothers thanks to the shelter offered by
the utopian networks of clandestine communist activism – only to bury his comrade
wife Xeniuška, aka Marina, aka Loletta, shortly after. Xeniuška was born to a biracial
couple of Jewish-Gentile revolutionary socialists in pre-revolutionary Russia. Her
father participated in the insurrections of 1905. After his execution, her gentile
mother Xenia took Xeniuška to Italy to escape persecution from the Czars. She was a
writer, an intellectual, and a stateless single mother who eked a living by running a
boarding house.
The various names Sereni’s parents used in life are reflected in their
daughter’s family narratives, and they testify to the multiple yet coexisting
personalities they developed to survive. Emilio, the father’s given name, shorts to
Mimmo for the family. Uriello is the coded love name he used with his comrade
wife. Xeniuška has the same given name as her mother, since, as Clara suggests,
when she was born her parents imagined that, as political insurgents, they would die
young. Marina is the name of her integration into Italian society by way of marrying
Emilio, while Loletta is Uriello’s counterpart. These lateral moves denote in-flux
identities that theorize as highly Deleuzian and rhizomatic survival strategies. Their
youngest daughter Clara became a writer in the context of second-wave feminism
and the radical transformations it effected in Italian families and society. The lifewriting work of this feminine/feminist family bard must imply an appreciation for
these strategies. Yet, while Regni acknowledges this gratitude more than
Casalinghitudine does, both narratives also fiercely denounce the dangers of not
giving up one’s utopias on time.
I now turn to this work to facilitate the interlocking reflections it invites. Il
gioco dei regni, or The game of the kingdoms, appeared in 1993, as the Cold-War order
was about to subside. In a political commentary designed to address her audience at
that time, Clara Sereni observes:
247
Sionismo, comunismo. Parole che hanno assunto negli anni significati e sfumature diversi: e
per chi ha oggi vent’anni il sionismo si identifica nell’espansionismo dello Stato di Israele, e il
comunismo nelle bandiere ammainate sulle cupole d’oro del Cremlino. (Sereni 1993, 205) 12
In the next paragraph, her voice shifts back to the mid-century reality of the two
secular Jewish brothers, Emilio Sereni (Clara’s father) and Enzo (her uncle), who are
young adults during Italian Fascism and the European political climate that
anticipated the Holocaust. Sereni claims that “In quelle e in altre parole [trovavano]
un denominatore comune: la speranza di un mondo diverso, più giusto ed umano”
(205). 13
Here communism and Zionism enter the testimonial narrative of Sereni’s
family saga as parallel utopian spaces and discursive laboratories. Each one is ‘queer’
in the sense that Judith Butler, as a Jew who speaks against Israel’s current
expansionism, recuperates to this word in Precarious Life. It is closeted, clandestine,
yet meaningful and necessary, in a world that, in the aftermath of 9/11 and the
ensuing propaganda – as in Fascist Italy – is too disappointing to be accepted as it is.
In these pages, Butler’s ‘we’ is a generic queer population that includes herself and
hides its diversities for the sake of claiming equal rights, yet is often grieving from
loss and internally divided. The recognition of this pattern is key, I claim, for Butler,
and for Sereni, to the acceptance of one’s precariousness in life, and hence one’s
inevitable bondage with those ‘others’ political polarizations often represent as
irreducible enemies. 14 Sereni, possibly even more than Butler, is highly aware of the
self-defeating contradictions inherent to each utopian discourse:
Lotte feroci dilaniavano i due gruppi, e non soltanto sul piano verbale: fra i sionisti, il
rapporto con le popolazioni arabe era già una discriminante; fra i comunisti, la cultura del
silenzio e del sospetto già mieteva le prime vittime. (205) 15
Yet, in the wider cycle of what might be seen as a Marxian, Deleuzian, and perhaps
slightly Hegelian, historical becoming, Sereni insists that both discourses were, each
in its way, necessary. As she explains:
Per chi cercava un sogno da vivere, per chi voleva essere parte attiva della forza che porta
avanti il mondo, una scelta si imponeva comunque. (205) 16
In the discursive context the narrative outlines, one is invited to ask what ‘game’ the
title of Sereni’s family saga alludes to. With what ‘kingdoms’ are characters playing
around? The answer I propose is that the game is the interplay of the four utopian
discourses, or ‘kingdoms’, at the crossroads of which Clara Sereni’s life is founded.
The testimonial experience that emerges from Casalinghitudine is that, to a young
second-wave feminist, one’s family utopias are both inevitable and crushing. In this
book Sereni resents her father, whose involvement in politics, she claims, made him a
permanent absentee from his own and his daughter’s emotional life. The revisitation
thereof Sereni offers in the family saga points to the mature person who recognizes
248
that these utopias are also necessary. Indeed, in Il gioco dei regni Sereni comes across
as a daughter who has metabolized the utopias of her childhood, and she now
admires her ancestors for their eccentricity and courage. Predictably, in the current
discursive regime about ecologies and mothers, the only one who is not fully
redeemed by the narrative is Sereni’s biological mother, Xeniuška/Marina/Loletta, to
whom I will return later. For now let me just say that what makes her attractive to
Clara’s father is the foreigness and courage she has inherited from her mother – a fact
her character never acknowledges.
In an appendix to Regni Sereni describes how and why she chose this project,
thus indicating that healing from Oedipal resentments was part of the process of
writing about them. From the rift between Sereni’s voice in Casalinghitudine and in
Regni a lesson can be gauged about the role of utopias in one’s life. Utopias are like
umbilical chords that must be severed on time. Much as they are necessary, Sereni’s
narrative ecologies imply, it is also necessary to surrender them before they become
dystopian, and therefore destructive and self-destructive. Utopias, I learn from Clara
Sereni, are stored with remarkable socially and spiritually transformative powers, yet
surrendering them on time is a gendered strategy designed to avoid heartconsuming conflicts and extreme rivalries.
And indeed the writer is an expert in utopian discourses from her experience
of family life. The combined analysis of Casalinghitudine and Regni manifests four
intersecting utopian paths in Clara Sereni’s early life. They include the revolutionary
socialism of her gentile grandmother Xenia and her Jewish partner Lev in prerevolutionary Russia. Lev was a leader in the early uprisings against the Czar. After
Lev’s execution in 1905, Xenia was left alone with their child, yet she never
completely sacrificed her intellectual aspirations. Xeniuška, cut off from the cultural
context in which her mother’s utopian discourse was alive, grew up resenting her
and the inevitable bond that tied them to one another. Xeniuška is presented as child
who never forgives Xenia for being different from more conventional mothers, and
only acknowledges her debt to her in extreme circumstances.
The next utopian path is the one pursued by Sereni’s Jewish grandfather Lello
and his oldest son Enrico Sereni. Lello was a physician who believed in the
objectivity of modern science and in the professional excellence that, in the early
twentieth century, made way for gradual integrations of Jews in secular western
societies. His son Enrico followed in this path, as did, to a large extent, his wife
Alfonsa and her sister Ermelinda. Lello turned up to be such a model in his path that
in the early twentieth century the Italian royal family chose him as their doctor. Yet
Lello and Enrico’s delusions of a seamless integration were obviously shattered by
the Shoah. The ecology of Sereni’s narrative shows modernity as it bites its tail when
Enrico dies of a power accident while in the bathtub. His accidental electrocution
from a boiler gone awry certainly smacks of suicide. Yet one wonders if Enrico’s act
of exiting life via electricity is not an uncanny message to symbolize the failure of
utopias, modern style.
249
The utopian path pursued by Sereni’s parents is that of communism, in the
democratic centralist version proposed by Stalin for the USSR. During the twentysomething years of Italian Fascism, the moral imperative that governs this path is
that men be either political prisoners or exiles/clandestine activists, with their
spouses completely devoted to helping them and their shared cause. Accordingly,
Emilio Sereni, Clara’s father and the second of the two bothers, is imprisoned twice.
Xeniuška, his comrade wife, becomes Loletta in the secret code they use to
communicate through the prison censorship system. Their passion is augmented by
their utopian understanding of their separation and suffering, and their daughters
are spaced out based on his releases. When Emilio’s father Lello pulls the strings left
in his power to get his child out, the young family sneaks out to France, where their
activism resumes, with both partners now involved as peers. Their first child, Clara’s
older sister Lea, becomes French by taste and culture. By understatement, Stalinist
utopianism comes across as powerful – for all its aberrations – as it is the hidden
network of complicity and activism that protects the family and keeps its members
alive. It is the force that later, after the armistice, Xeniuška/Loletta celebrated in her
memoir I giorni della nostra vita (the days of our life). The book is authored as Marina
Sereni, Xeniuška’s Italian name by which she was known in the Party. 17 Clara was
also conceived at this time, which is why, she explains, her parents used to call her
child of peace, figlia della pace. She also, of course, owes her existence to Stalinist
utopianism and its party line.
The fourth utopian path is the one chosen by Enzo Sereni, the middle bother,
who in the early days of Italian Fascism marries Ada, an Italian woman from a
Jewish family, and moves to Palestine to live in a Kibbutz. Initially he believes that his
younger brother Emilio, aka Mimmo, will follow him, as the two correspond
passionately about which utopian path will most effectively offset and counter the
obscurantism and bone-headedness of fascism. Yet Enzo slowly realizes that Mimmo
has found another path. The rift between the two bothers as well as the bond that ties
them is registered in their correspondence, published in 2000. However, as the racial
laws go into effect in Italy, both Lello and his wife Alfonsa join Enzo in Palestine.
This new life brings out the best in Alfonsa, who is simple, without vanity, and easy
to adapt to rustic Kibbutz life. Shunned by her daughter and alone in life, Xenia also
moves to Palestine and is welcomed by the new, utopian society. However, Zionism
ends up not protecting Enzo from the Shoah well enough. During a trip to Germany
as the war has already started, he is caught and sent to a camp where he is executed.
In both books Sereni also of course describes her two older full sisters, Lea,
“the daughter of war”, and Marinella, “the daughter of clandestine life” (Sereni 1987,
66), as well as her younger half sister, born to Emilio’s second wife, whom he marries
after Xeniuška’s death from cancer. (In Casalinghitudine Marinella’s and Lea’s
fictionalized names are, respectively, Ada and Giulia.) Yet while in Casalinghitudine
one gets the sense that Clara suffers from her being born at these intersecting paths –
she’d rather be ‘normal’ – in Il gioco dei regni one realizes her growing awareness of
the privilege of her position, and its inherent responsibility for exploring why, which
250
is, admittedly, the inspiration for her work. So Casalinghitudine presents Clara at the
crux of an un-scrutable, unusual past, whose conflicting narratives appear as
phantasms, while Il gioco dei regni explores this past, discovers its utopias as separate,
conflicting narratives, and also integrates them in a wider narrative ecology that
allows Clara to fulfill her mission as the family bard.
A QUEER, GENDERED, AND UTOPIAN SPACE FOR THE MOTHER
My proposal in this study is to claim that, in the context of the utopian discourses
and laboratories at play in Sereni’s two ecological narratives, this pattern is both
queer and gendered, and, more precisely, that it is queer because it is gendered, and
it is gendered because it is queer. I will also submit that this reciprocity is uncannily
related to the question of the mother, and to how that question becomes
reformulated as the matrixial in the context of a narrative ecology that reaches back
for lost female genealogies even as it moves laterally in rhizomatic anti-Oedipal
fashions. In her study of utopian spaces, feminist Deleuzian theorist Elizabeth Grosz
argues that in classical philosophy utopia is associated with ‘no place’, as per its
Greek roots, u/no and topos/place (Grosz 2001, 134). As she explains, in a discursive
arena traversed by the force fields of gender and queer awareness, the utopic is
cradled in-between a “past (which) [...] is the virtuality of the present”, and a “future
[...] (which is) prefigured, rendered potential, through and by the past [...] (and
therefore) overwrites and restructures the virtual which is the past” (141). Therefore,
Grosz proposes, a utopian that is queer and gendered is indeed enfleshed rather than
abstract.
Much in the fashion Grosz describes, in Clara Sereni’s narrative ecologies,
utopia is ‘written on the body’, as UK lesbian novelist Jeannette Winterson would
put it. It is the anorexia that clasps Clara’s stomach when she eats with her
hypercritical father; the queerness of her grandmother Alfonsa’s men’s shoes and her
cross-dressing at Purim family parties; the food as body of inexpressible emotions in
Casalinghitudine’s recipes; and the association of women and animals in that book’s
narrative as David Del Principe aptly argues. In Il gioco dei regni, this overhauling
utopia is the narrator’s deep-seated awareness of how Bateson’s schismogenesis, or
the desire to be different from those in one’s group, assuages ancestral fears of
inbreeding and excessive similarity between the three Sereni brothers, and ultimately
functions as a homophobic divider for then and the women in their lives.
The characters sketched out in Casalinghitudine reappear enfleshed and fully
rounded in Il gioco dei regni. This, one might say, is Sereni’s way of “going at [her
own family] history backwards”, Irigaray style (1985), namely turning around from
the forward path of life, and going inward to follow a pre-Oedipal desire to reenter
one’s birth channel and get a taste of one’s prenatal life. Thus nonna Alfonsa, who, in
Casalinghitudine is sketched out as a woman who wears men’s shoes and raises
chicken in Palestine, becomes enfleshed in the novel as a woman who understands
her role, has a quiet intelligence and a staunch commitment to life, believes in strict
251
parenting, demonstrates resilience in the most challenging circumstances, is
accustomed to concealing her emotions and to transferring her ambitions on her
sons, and is very adaptable. Emilio starts as the absentee father intent in being ”il
primo firmatario di un’interpellanza parlamentare contro lo Stato d’Israele” (Sereni
1987, 76) 18 whose comments at the dinner table kill Clara’s appetite. In Il gioco dei
regni he features as the devoted partner who sits at Loletta’s death bed as she is
dying of cancer. He is capable of complete presence as he sends his beloved a coded
“messaggio senza più parole [che] passa fra le mani di Uriello e Loletta, tre colpi col
dito sul palmo per dirsi l’amore” (Sereni 1993, 414). 19
In Casalinghitudine, nonno Lello is described as a man shorter than the
notoriously short King Umberto I, who was so diminutive that the government had
to lower the minimum height for enrollment in the military. The implication is that
the royal family liked him for he made the king look tall by comparison, rather than
for his competence as a physician. In Il gioco dei regni, however, Lello is described as a
man proud of his dearly earned upward mobility, good humored, and dedicated to
his job. Finally, Clara herself, sketched out as “la figlia della pace” (“the daughter of
peace”) in the early narrative, becomes enfleshed in the book as a sickly infant and
child to whom Emilio acts a bit like a mother as they are in Russia for Loletta’s
illness. Clara’s fragility makes her mother Marina/Xeniuška (the comrade) feel guilty
about the special care necessary for her.
With this context outlined, let me come back to Xeniuška, the biological
mother whose daughter’s resentment is, I claim, not fully metabolized in the
ecological narrative of the family saga. In 1952, when Clara is six, Xeniuška/Marina
Sereni/Loletta dies from cancer in a private Swiss hospital, after a medical trip to the
USSR that has been duly approved by the party and turned out to be to no avail. Like
a healthy post-modern Deleuzian schizo, she is three characters in one. 20 She
represents the narrative’s anti-Oedipal impulses, as she is neither unified nor central.
Indeed, Clara represents herself as a child who has two mothers, her defunct
biological parent, and Emilio’s second wife, with whom she grows up and whom she
calls mamma. Yet I claim that some un-metabolized resentment lurks behind this
image. It transpires in the seams between Xeniuška’s different personalities. In
Clara’s narrative saga, Xeniuška is the part-Jewish daughter of Xenia, her stateless
single mother from Russia, who grows up in Rome and wants to integrate into
western modernity and repudiate her past, including her mother. Marina Sereni is
Emilio’s happy wife; the ‘new blood’ in the Sereni family who, by marrying Jewish
finds her new Italian nationality; the faithful comrade whose popular post-war
memoir testifies to Emilio’s commitment to the cause and their clandestine antiFascist activism from France. Loletta is the lover with whom Emilio shares his closet
utopian personality of Uriello, and the secret code that enables them to feel happy,
united, and proud during his prison years under Fascism. Il gioco dei regni also in
some ways denies the integrity of Loletta/Marina’s narrative as that of one who was
not a feminist because she did not claim an identity of her own distinct from her
partner.
252
However, in a self-contradictory mode that testifies to her own integrity as a
testimonial writer, Clara also outlines the discursive space of Uriello and Loletta’s
love, whose utopian character places them outside the narrowly defined erotic
normativity of modern western culture. No adversarial force can divide them, since
their coded language turns any clandestine or closeted situation into a reason for
them to feel more united. While still lucid and aware of her impending agony,
Loletta writes Uriello a letter, to be opened only post-mortem, which encourages him
to find a new comrade/wife. In a daring move, Clara publishes this very personal
family document. Hence, the queer aspect of Loletta’s personality, which is,
arguably, what ultimately made her attractive to Uriello, is left to be revealed in her
own voice. Loletta urges Uriello to remarry, in a letter that fully embraces the
polyamorous principle that humans are capable of loving more than one. As she
explains:
Tutto l’amore che hai avuto e che sempre avrai per me non sarà in nulla intaccato da un
nuovo affetto che domani potresti avere per un’altra donna. (Sereni 1993, 216) 21
As if she was writing a proto-manifesto for ‘polyamory’, Loletta proceeds to
recommend what kind of new partner: “E come moglie che consigliarti? […] Una
ragazza […] che non abbia paura del nostro amore” (417). 22 I hear Clara’s mother
willing herself included in the new love, not forgotten, in a non-normative, queer,
non-exclusive manner. Yet I don’t know how aware her daughter is of the radicalism
this implies, a radicalism impossible, at least in Loletta’s time, outside the bounds of
the communist utopias her parents inhabited.
Further in the document, we learn that Loletta thinks of their love as a
transforming energy in the utopian space of communism, Stalin style, where all
possible gender and sexuality conflicts are resolved. Uriello’s new partner is
imagined as a comrade as self effacing as Loletta has been, and as capable as Uriello
of becoming just a speck of life in the wider body of the living party. As Loletta
writes,
Il Partito invece si è fuso per me con la mia vita privata, così strettamente e completamente, da
darmi sempre la certezza di essere una particella di quella immensa forza che porta il mondo
in avanti. (417) 23
So Loletta wants posterity to remember her as perfectly content with her role of
comrade/wife and speck in the wider life of the Party. Yet in her effort to reach back
through past utopias for a usable legacy from her Russian grandmother, her
daughter Clara undermines this construction and exposes its misogyny and
patriarchy. Emilio Sereni became a minister in the popular-front government that
wrote the new Italian constitution after the fall of Fascism, in 1946-48. Marina got
cancer. Would Uriello be prepared to accept Loletta’s role in their couple? Is there
any connection between the two destinies? Why is the woman (who also happens to
be Clara’s mother) expendable and what does that say about the utopian discourse
253
she inhabited? These, I claim, are the thorny questions the child can’t answer. (And
they are, not coincidentally, also central questions in Eros, my own self-writing
narrative).
Clara’s trajectory teases out the glitch in her mother’s construction: in
becoming part of Uriello’s life, Loletta has chosen to imitate her mother, who had
also fully embraced the utopia of her revolutionary socialist lover Lev. Yet she has
forgotten her body in the meanwhile just as she never acknowledged the matrixial
embodiedness of her mother. Her utopia had become dangerously masculine and
abstract. In Il gioco dei regni, Clara also chooses to publish a 1937 letter by her mother,
written from her French exile to her own mother Xenia in Palestine, a testimonial to
her mother’s utopianism comrade Marina Sereni was eager to hide. The letter
acknowledges Xeniuška’s debt to Xenia, even as it is ever so cruelly designed to
interrupt any communication between mother and daughter, due to the need for
security for the clandestine party and the alleged deviance of Xenia’s utopian past.
As Xeniuška transforms into Loletta, she repudiates the petit-bourgeois
aspirations she displayed while growing up, and claims she has come to a fuller
appreciation of her mother. She writes her: “Io ti amo come prima, e forse di più
perché ora amo rispetto in te non solo la madre ma anche la persona” (Sereni 1993,
316). 24 Loletta goes as far as admitting that without her mother’s utopian model, she
could not be what she is now because “la tua fiducia assoluta di allora […] ha
lasciato in me un segno profondo” (317). 25 Yet, with the iron-fist logic of the party,
she concludes that by way of superior necessity: “Non ti scriverò, non mi scriverai”
(317). 26
Clara wonders if by virtue of being homonymous, by having the same name,
Xenia and Xeniuška are incapable of inhabiting the same planet. When utopias are
still coded as masculine, heterosexist, and abstract, fears of the body are too powerful
and women’s names cannot form genealogies. Yet Xenia comes back in her
daughter’s life when, via Alfonsa, she finds out that her daughter is dying of cancer
in a private Swiss hospital, just a few years after the utopian dreams she and Uriello
shared have partly become actualized. But this return of the mother is tangled with
suffering because it implies that she will bury her child. And there is no redemption
of the emotional aspects. Xenia is only called to help Loletta in practical matters,
while Uriello continues to be the only participant in her utopian love. As Clara
explains:
Quando Mimmo era lì sua figlia non la voleva nella stanza: solo quando lui si assentava […]
Xenia entrava per piccoli gesti utili, muta. (411) 27
Yet, in the crux of precarious life inhabited by the multiple utopias that Clara has
resulted from, and which her narrative ecologies explore in her attempt to make
sense of her life, the body works its magic, as maternal knowledge proves necessary
to the dying child, and Uriello learns from Xenia how to get Loletta’s consumed body
to take in some water:
254
Mimmo […] mise il braccio sotto il cuscino per tirare su Loletta […] Xenia […] gli porgeva un
tubicino flessibile […] Loletta s’innervosiva […] con gli occhi [Mimmo] pregò Xenia di
provvedere, pochi gesti precisi e Xeniuška riuscì a succhiare. (411) 28
The rivulet of water that seeps up through the straw is the body of the mother
morphed as lymph for the dying child. Perhaps in the space of this fleeting matrixial
encounter, Mimmo understands what Loletta’s love for him has cost her mother.
Perhaps Loletta/Xeniuška imagines how he could have loved Xenia, how she, too,
could have been included in their diad. Perhaps Xenia imagines how she could stay
and help Mimmo raise her granddaughters instead of returning to Palestine. In the
matrixial encounter, identities break down and water becomes the vehicle for the
exchange of transubjective energies in the female genealogy. Utopia becomes matter.
The water from the mother’s straw into the dying daughter’s mouth is like the rivulet
trickling down to Mexico from the river Colorado. The ecology of the narrative
brings down all the utopias-turned-dystopias at once. Modern medicine cannot save
Clara’s mother, because modernity itself causes cancer. Neither can Stalin because
his utopia too is abstract. Zionism, like the revolutionary socialism of Lev’s time, is a
distraction that attracts Xenia away from her granddaughters.
But the fleeting moment quickly fades out as Clara proceeds to narrate how
Loletta still remained unforgiving to her mother. Loletta’s voice has been lost to her
cancer, yet, as accidentally Xenia mentions Russia, Loletta grabs a pencil and writes:
“Abituati a dire Urss, una buona volta” (Sereni 1993, 412). 29 Until the day she dies,
Xeniuška blames her mother for being bereft of a male partner able to grant her
utopia value. Until the day she buries her child, Xenia feels rejected by her child for
the very reason that her choice of being single defines her as a parent prior to being a
party member or spouse. In the tragedy of interrupted female genealogies, Clara
shows the divisive results of not giving up one’s utopias on time.
In her testimonial effort, Clara Sereni is clearly reaching behind her lost
mother for a female genealogy Loletta and her legacy denied her. This agrees with
Sereni’s project of warning her audience that utopias are as transforming and
empowering as is the imperative to give them up on time. But, as I would like to
argue, what really stands between Xenia and her dying daughter Xeniuška is the
impossibility to imagine utopian love beyond the narrow confines of exclusive twogender couples, the modern normativity which in itself bespeaks its own
monogamous, sexist, and heterosexist tyranny. How can female genealogies be
traced when a woman cannot even pass her family name to her child? Xeniuška’s
first name was after her mother, yet she never saw their bond as an equal
partnership. Each woman found her utopian space in becoming part of the body of
the man who embodied that imagined reality, and so could not embrace or recognize
the other woman as a utopian space in and of herself. This traps the feminine into its
role of provider for the house that a masculine utopian thought will inhabit, and also
traps this thought into separate houses that will, eventually, divide it. Thus the game
of the kingdoms that casts the three Sereni brothers into different utopias, is also,
255
ultimately, the game that kills two of the brothers, Enzo, the Zionist, and Enrico, the
scientist. Emilio is left alone to age in a solitude that becomes increasingly dogmatic,
even as his daughter Clara belatedly acknowledges her gratitude for this survival
that has made her birth possible.
CONCLUSION
Clara Sereni’s Il gioco dei regni, together with her Casalinghitudine, can be seen as
testimonial narratives that revolve around the tropes of memory, outness, and
trauma, and invite a reflection on ecology and culture. In Casalinghitudine, Clara’s
memories of her traumatic past at the crux of her family’s four utopian narratives is
the impulse to out her ancestors as different, unaligned with prevalent ideologies
and their conventions. The process of healing from these traumas distills into Regni, a
family saga that outs Clara as one of them, as she revisits this past in a narrative
ecology that weaves the utopian discourses together. The narrative testifies to their
value in helping humans imagine the other possible world we need, even as it
remains highly aware of the dangers of not giving up one’s utopias on time. Like
communism and Zionism, Western modernity proves to be one such necessary yet
failed utopian narrative.
What further transpires in the seams between the two testimonial works is the
unprocessed trauma of being inscribed in a utopian discourse that still conflates
utopias with heterosexist masculine abstractions. Sereni’s writing is clearly antiOedipal in its non-linear, rhizomatic style. Yet in Regni her search for female
genealogies is evident in her gesture towards her maternal grandmother, and in her
emphasis on her mother’s identity as divided and in-flux. Sereni rescues Xenia from
the indifference of her child, and this opens the narrative to Xeniuška’s queer and
polyamorous desire to play an active part in helping Emilio choose a new wife and
thus feel included in their love. That this desire is post mortem does not count,
because when she wrote the letter Loletta was alive. Yet Xeniuška was unable to
teach Loletta how to love her mother, Xenia disappears from her granddaughter’s
life, and Clara is still the orphaned child of a woman who paid for the diseases of
modernity with her life. The writing of Il gioco dei regni was clearly a therapeutic
process for Clara, yet some residual grief transpires as resentment towards the
Loletta/Xeniuška who never became self-possessed and unified enough to survive,
and admiration for Xenia’s long and poignant life. As Marina dies, Emilio’s new wife
takes her place in Clara’s life. In Casalinghitudine Clara calls her mamma. The
oscillation between Oedipal and anti-Oedipal tropes outlines the trajectory of
Sereni’s trip back into the fluidity of pre-natal life in search for utopias of the flesh
that intertwine metaphors about mothers, ecologies, fluidity, and survival without
conflating them into one another. With respect to today’s pressing global political
questions about energy, peace, ecology, and survival, Sereni’s work invites new ways
of thinking about problems too often considered intractable. Sereni’s family, and its
female bard, offer models of utopians with an awareness of the necessity of giving
256
up one’s dreams when one’s utopias turn dystopian. This can only auspicate a
similar outcome from today’s political leaders, who share with us the responsibility
of giving up one’s utopias while there is still time.
NOTES
1
For my own biographical circumstances, I refer to Anderlini 2007, 131-42.
Ettinger’s matrixial borderspace is both pre-oedipal and anti-oedipal. It is a transubjective space of
fluidity where identity dissolves and where the co-emergence of different singularities is made
possible by co-poietic access to memories and traumas (2006).
2
3
Anderlini 1997, 101-03 and 155-58.
4
Reisner 2003.
Besides Ettinger, another inspiring theorist about mothers as cultural metaphors and their necessary
deconstruction is Rosi Braidotti (2002).
5
6
Sachar 2006, 521.
7
Laqueur 1972, 3-8; 270-337;505-63.
8
Prior 2005, 71-103.
9
Sachar 2006, 615-66.
10
Diamond 2005, 48.
11
Hansen 2006, 13.
“Zionism and communism: over the years these words have acquired different meanings and
nuances. For today’s twenty year olds Zionism is identified with the expansionism of the State of
Israel, communism with the flags hauled down on the golden domes of the Kremlin”. Unfortunately
no English translation of Regni has been published yet. Throughout the essay, this and other
translations from this text are mine. Parenthetic page numbers refer to the established Italian text.
12
“in those and other words [the brothers found] a common denominator: the hope for a different
world, more human and just”.
13
14
Butler 2004, 22-26.
“Ferocious disputes tore both groups apart, and they weren’t just verbal squabbles. Among the
Zionists, the style of relating to the Arab populations was already cause for divisiveness; among the
communists, the culture of suspicion and silence was already harvesting its first victims”.
15
“[F]or those who were looking for a dream to be lived out, for those who wanted to be an active part
in the force that moves the world forward, choosing, one way or another, was inevitable”.
16
This book promises to be a valuable historical document which is unfortunately out of print. It is my
hope that my inquiries with Clara Sereni as to how to locate a copy of the text will yield some results.
17
18
“the first to sign a parliamentary petition against the state of Israel”.
“message with no more words [that] passes between Uriello and Loletta’s hands, three knocks of his
finger on her palm that tell their love”.
19
257
For the concept of the post-modern schizo I refer to Deleuze and Guattari’s work on capitalism and
schizophrenia, where they claim that a certain dosage of schizophrenia is not only typical of people
who live under capitalism but also necessary to navigate post-modern cultural landscapes in a
somewhat healthy way (1983, 1987).
20
“All the love you’ve had and always will have for me won’t be even remotely injured by a new
affection that in the future you could have for another woman”.
21
22
“And for a wife, how to advise you? […] A young woman [...] who won’t be afraid of our love”.
“On the other hand, the Party has become fused with my private life as closely and completely as to
give me the certitude that I am at all times a particle of that immense force that moves the world
forward”.
23
“I love you as I did before, and maybe more because now I also love and respect in you not just the
mother but also the person”.
24
25
“the absolute trust you had at that time […] has left a deep mark within me”.
26
“I won’t write you, you won’t write me”.
“When Mimmo was there, her daughter did not want her in the room. Only when he went out […]
Xenia got in for small, useful acts, silent”.
27
“Mimmo […] placed his arm under the pillow to pull Loletta up […] Xenia was handling him a thin
flexible pipe […] Loletta got nervous […] with his eyes [Mimmo] begged Xenia to help out, a few
precise gestures and Xeniuška managed to suck”.
28
29
“Get used to call it USSR, for once!”
WORKS CITED
Anderlini, Serena. The "Weak" Subject. On Modernity, Eros, and Women's Playwriting. Madison: Farleigh
Dickinson UP, 1998.
---. Eros: A Journey of Multiple Loves. Binghamton, N.Y.: Harrington Park Press, 2007.
Avishai, Bernard. The Tragedy of Zionism. New York: Helios Press, 2002.
Braidotti, Rosi. Metamorphosis: Towards a Materialist Theory of Becoming. London: Polity Press, 2002.
Butler, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso, 2004.
Deleuze, Gilles, & Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Translation by
Brian Massumi. Minneapolis: U of Minnesota P, 1987.
---. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Translation by Robert Hurley. Minneapolis: U of
Minnesota P, 1983.
Del Principe, David. ‘Consuming Women and Animals in Clara Sereni’s Casalinghitudine’. Italica 76/2
(Summer 1999): 205-219.
Diamond, Jared. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Penguin, 2005.
Ettinger, Bracha. The Matrixial Borderspace. Minnesota: U of Minnesota P, 2006.
258
Finkelstein, Norman. Beyond Chutzpah. Berkeley: U of California P, 2005.
Hansen, Jim. ‘The Threat to the Planet’. The New York Review of Books 52/12 (July 13, 2006): 12-16.
Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Translation by Catherine Porter. Cornell: Cornell UP, 1985.
Grosz, Elizabeth. Architecture from the Outside. New York: MIT Press, 2001.
Laqueur, Walter. A History of Zionism. New York: Schocken, 1972.
Menozzi, Giuliana. ‘Food and Subjectivity in Clara Sereni’s Casalinghitudine’. Italica 71/2 (Summer
1994): 217-227.
Prior, Michael ed. Speaking the Truth: Zionism, Israel, and Occupation. Northampton, MA: Olive Branch
Press, 2005.
Reisner, Marc. Cadillac Desert: The American West and its Disappearing Water. New York: Penguin, 2003.
Sachar, Howard. A History of Israel. New York: Knopf, 2006.
Sereni, Clara. Casalinghitudine. Torino: Einaudi, 1987. (Keeping House: A Novel in Recipes. Translation by
Susan Briziarelli & Giovanna Miceli-Jeffries. New York: SUNY Press, 2005).
---. Il gioco dei regni. Firenze: Giunti, 1993.
Sereni, Emilio & Enzo Sereni. Politica e utopia, Lettere 1926-1943. Torino: La Nuova Italia, 2000.
Shiva, Vandana. Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit. Cambridge MA: South End Press, 2002.
259
CICIONI, Mirna. ‘Speaking “as a” and Speaking “for”: Multiple Appartenenze in the
Autobiographical Macrotexts of Aldo Zargani and Clara Sereni’. Contemporary Jewish
Writers in Italy: a Generational Approach. Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia
Gaiga, eds. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing &
Archiving Services, 2007. ISBN 978-90-6701-017-7. 261 – 275.
SUMMARY
Clara Sereni (Rome, 1946) and Aldo Zargani (Turin, 1933) share a number of appartenenze, the word
used in contemporary Italian discourses on ‘identity’ to denote conscious belonging to one or more
ethnic groups, religious faiths, regional origins, political allegiances. Both are non-practicing Jews and
left-wing public intellectuals. Both have written autobiographical books, essays, articles, lectures and
stories: cumulatively, they constitute two macrotexts, where each text positions itself against the
background of the previous texts and is linked to them by numerous cross-references. Zargani, who
lived through the Shoah as a child, writes mainly in order to explain to his – mostly non-Jewish –
readers issues connected with the problmatic notion of ‘Jewish identity’. Sereni, whose formative
years were the late Sixties and early Seventies, places herself at the intersection of four appartenenze: as
a Jew, a woman, a ‘handicapped mother’ and a political utopian. Drawing on Nancy K. Miller’s
distinction between ‘speaking as a ...’ (as an individual who identifies specifically as one thing in a
specific context) and ‘speaking for’ (representing a group and speaking on its behalf), I examine
aspects of both macrotexts with a particular focus on the connections between self-representation,
public contexts and Jewishness. I also, drawing mainly on Linda Hutcheon (1994), look at the way
Sereni and Zargani use irony – particularly self-deprecating irony – to emphasize their unfulfilled
political expectations and their status as insiders or outsiders according to whom and in which public
situations they speak ‘as’ and ‘for’.
KEYWORDS
Sereni, Zargani, appartenenze, autobiography, irony
© The authors
The proceedings of the international conference Contemporary Jewish Writers in Italy: a
Generational Approach (Utrecht-Amsterdam, 5-7 October 2006) are volume 2 of the
series ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE,
published by Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
261
SPEAKING “AS A” AND “SPEAKING FOR”
MULTIPLE APPARTENENZE IN THE AUTOBIOGRAPHICAL MACROTEXTS
OF ALDO ZARGANI AND CLARA SERENI
Mirna Cicioni
Monash University
Clara Sereni (born in Rome in 1946) and Aldo Zargani (born in Turin in 1933) share a
number of appartenenze, the word used in contemporary Italian discourses on
‘identity’ to denote conscious belonging to one or more ethnic groups, religious
faiths, regional origins, political allegiances. Both are non-practicing Jews who have
written autobiographical texts, and both have occupied a variety of positions on the
left of the continuum of Italian politics. The major aim of this essay is to analyze their
autobiographical self-representations in the context of their roles, and of their
writings, as public intellectuals.
Zargani and Sereni came to the notice of the Italian reading public between
the late 1980s and the mid-1990s, a period in which the traditional Left disintegrated
and Italians grew increasingly disenchanted with all-embracing ideologies. 1 For each
of them, recognition came late. Sereni was over forty years old in 1987 when she
published her best-selling Casalinghitudine, a fragmented account of the intersections
between political and personal relations in her family and in her own life. Zargani
was a sixty-two-year-old retiree in 1995 when he published Per violino solo, the first of
his two autobiographical books, where he traces how the 1938 Race Laws and their
consequences deprived him of his childhood. Both have expanded their
autobiographical constructs in subsequent texts. Sereni described the complex
history of her family from 1900 to the 1990s in Il gioco dei Regni (1993) and thinly
disguised her experiences as deputy mayor of Perugia between 1994 and 1997 in
Passami il sale (2002). Zargani represented his generation’s attraction to socialism and
Zionism in the years following World War II and its gradual disillusionment with
both in Certe promesse d’amore (1997). Both of them have been, and are, participants in
progressive political activities. Sereni, after being a member of the far-left movement
Lotta Continua, has been connected in various ways to the Democratici di Sinistra (DS)
ever since the Italian Communist Party dissolved in 1991. 2 The mother of a son with
a mental illness, she has also been an advocate for mental health issues and a very
visible member of associations lobbying on behalf of people with psychoses. Zargani
was a long-time member of a left faction of the Italian Socialist Party and is now an
active member of the Gruppo Martin Buber – Ebrei per la Pace, which recognizes the
right of the Israeli and Palestinian peoples to independent national states. He is also –
as someone who spent his childhood hiding from fascists and Nazis between 1938
and April 1945 – frequently asked to speak on the Italian Day of Memory or to
262
commemorate anniversaries of the Resistance. Zargani and Sereni are also known as
writers of opinion articles for political and cultural publications which are read by
the members of what the historian Paul Ginsborg calls the ceti medi riflessivi, the
reflexive middle class. 3 Both, therefore, fit the definition, widespread and widelydiscussed in English-speaking countries, 4 of ‘public intellectuals’.
It is clearly impossible to give an overall definition that encompasses all
varieties of ‘public intellectuals’ and the ‘publics’ they address. However, behind the
term there are some basic assumptions: that public intellectuals “use the media to
express views on a number of subjects on which they are not necessarily expert” 5 and
“address a non-specialist public on matters of general concern” 6 which relate to
history, society and culture. Sereni writes mainly in order to contribute to
discussions of politics and social justice in Italy; Zargani mainly in order to explain to
his – mostly non-Jewish – implied readers issues connected with notions of ‘Jewish
identity’ and with the historical and political uses of Holocaust memory. For both of
them, their Jewish appartenenza is inseparable from their innate sense of being Italian,
shaped by the developments of Italian history and society for many generations.
Most of the production of each writer (essays, articles written for periodicals,
stories and fragments as well as books) constitutes an autobiographical macrotext:
each text positions itself against the background of the previous ones, and there is
constant interplay through autobiographical cross-references. I look at the two
macrotexts concentrating on Zargani’s and Sereni’s writings as public intellectuals
rather than on the specifically autobiographical works. I examine their
representations of their experiences with various forms of political and social power,
and look at the way they use irony to foreground the precarious position of the two
narrated selves vis-à-vis their appartenenze.
Zargani’s public intellectual persona is first and foremost that of a Jew who
has lived through the Shoah in Italy, and who traces every aspect of his life back to
this appartenenza. The second chapter of Per violino solo opens with the
acknowledgement of this fact and the explanation that public (historical and
political) events are to blame for the disproportion in his personal recollections:
L’infanzia di tutti è una specie di cannocchiale collegato a un microscopio, ma il mio
strumento esplora la notte della Shoah […] Ho piú di sessant’anni e la mia vita è spezzata in
due frammenti ineguali: il tempo dei sette anni di persecuzione si è moltiplicato a dismisura
ed è divenuto un’escrescenza dell’anima che schiaccia le stagioni normali, mezzo secolo, e le
confina, con tutte le loro vicende alterne ma comuni, in uno spazio angusto. (Zargani 1995,
13) 7
Sereni – whose formative years were the late 60s and early 70s, when the
private/public dichotomy was challenged – represents herself in a more diverse way.
She positions herself at the interconnection of four appartenenze, and stresses that in
each case her personal experiences are inseparable from political choices and linked
to political discourses:
263
[Questi sono] i quattro spicchi dei quali, con continui sconfinamenti, mi sembra di compormi:
ebrea per scelta più che per destino, donna non solo per l’anagrafe, esperta di handicap e
debolezze come chiunque ne faccia l’esperienza, utopista come chi, radicandosi in quanto
esiste qui e oggi, senza esimersi dall’intervenire sulla realtà quotidiana, coltiva il bisogno di
darsi un respiro e una passione agganciati al domani. (Sereni 1998, 12) 8
Like Zargani, Sereni also refers to her life as fragmented, but, unlike him, she makes
an explicit connection between her fragmented self and her gendered self: “nella mia
vita costruita a tessere mal tagliate, nella mia vita a mosaico (come quella di tutti, e
piú delle donne)” (Sereni, 1987, 165). 9
The two macrotexts construct ‘Jewish experience’ and ‘Jewish voice’
cumulatively, with different contradictions and ambiguities deriving from different
gender, generation, historical and political positions. A useful starting point for an
analysis is the problem of representativity raised by the American theorist of
autobiography Nancy K. Miller in her collection of essays Getting Personal. Miller
distinguishes between “speaking as a” (as an individual who has a specific
appartenenza, and whose statements are inevitably accompanied by specific
expectations from the audience) and “speaking for” (an individual who takes on, or is
given, the burden of representing a group and speaking on its behalf). 10 Sereni
primarily speaks as a Jew (as an individual positioned within a culture, which she
consciously chooses to claim for herself). Zargani, although with occasional
qualifications, speaks for Jews (as someone who is asked to, or wants to, explain
‘Jewishness’ and ‘Jewish culture’ to non-Jews, and speak on behalf of the survivors of
persecution).
Positioning the narrated self as “speaking as a” or “speaking for” also makes a
connection between the private and the public dimensions within both macrotexts.
Both have a similar narrative feature: frequently, a public event triggers
autobiographical recollections, which are then placed in the context of the author’s
wider political and ethical perspectives. The public event which inspires Sereni’s
article “Al voto con furore” (Going to Vote in Anger), written in June 2005, is her
forthcoming participation in a television panel on the attempt to abolish a law which
restricts choice on reproductive technologies through a nation-wide referendum. She
makes a (gendered) acknowledgement of her growing anger with the law:
[I]l mio corpo di donna torna ad essere considerato […] un contenitore che può essere usato
violentemente, contro la mia volontà e contro i miei desideri, per produrre una vita difficile
che ricadrà sulle mie spalle. (Sereni 2005, 27) 11
She then connects her personal stake in the issue of the right to choose to two of her
appartenenze. First she speaks as a mother: “io ce l’ho, sulle spalle e nel cuore, il peso
di un figlio difficile”. 12 Then she speaks as a Jew, with Jewishness as a marker of
differentiation from the ethics of a part of Catholic Italians: “l’Italia si ferma,
inchiodata da diktat religiosi pervasivi che molti cattolici non condividono, e che
tanto più offendono me, che sono di cultura e di radici ebraiche” (Sereni 2005, 27). 13
264
She concludes speaking for all Italians, with the hope – unmarked by any
appartenenze – for policies which will give the country secular perspectives on the
developments of bio-technologies:
Con la speranza, sempre più disperata, che ci sia un momento in cui i grandi temi del vivere e
del morire […] del diritto alla felicità e della sofferenza, siano al centro di un dibattito politico
finalmente serio, di alto profilo, capace di costruire risposte di cui, al momento, non si vede
neanche l’ombra. (27) 14
Sereni’s oxymoron “speranze disperate” emphasizes the contrast between her desires
and her awareness that they have hardly any connection with real-world politics.
The gap between expectations and actual events is in fact one of the main recurring
themes in both autobiographical macrotexts: the narrated selves often feel displaced,
falling between their multiple appartenenze and uncertain as to whether they can
speak as or for someone. Therefore in their accounts of their political experiences
they are sometimes surprised, often disappointed, and on several occasions – from
the perspective of the narrating selves, who have the benefit of hindsight – they
‘should have known better’. To foreground their unfulfilled expectations, the
narrating selves often use irony.
Although irony eludes classifications and categorizations, most of its theorists
agree that it is a strategy to make interlocutors – or, in the case of writers, implied
readers – aware of the different dimensions that coexist in each act of communication
and of the contradictions and ambiguities within narratives. 15 Therefore it redefines
what is ‘known’, encouraging multiple perspectives. A particularly complex kind of
irony is self-disparaging irony: apparently self-critical, it can be seen as a selfprotective strategy 16 and, in the specific context of Jewish humour, as a defense
mechanism which mocks the prejudices of the dominant group and builds bonds of
solidarity. 17 Another useful critical tool is the notion of reframing, developed by the
psychologists Juni and Katz: self-disparaging humour is one of the strategies
whereby a difficult situation is rethought and redefined so that it is bearable. 18
Zargani’s 2001 essay ‘Mi hanno tradotto!’ (I Have Been Translated!) starts with
an argument between the narrated self and a friend on the way mistranslations
sometimes make the target texts richer in meanings. Then the narration shifts from
the general to the particular. In the same sentence the narrating self speaks first as a
survivor and a writer, then connects his first book to Holocaust testimony and,
through the quotation of a Jewish witticism, ends up speaking for Jews:
Vengo ora alla mia personale vicenda di autore che, con Per violino solo, ha aggiunto il suo
mattoncino all’enorme muraglia di scritture sulla Shoah: ‘Hitler ce ne ha fatte tante, ma noi
ebrei poi gliene abbiamo dette […]’. (Zargani 2001, 9) 19
The self-disparaging quip reframes Holocaust testimony as an inevitably inadequate
yet necessary response to genocide, and includes the narrating voice in the first
person plural ‘we Jews’: Jewishness, testimony and humour belong to him. The focus
265
then shifts again to the personal dimension: Zargani’s lecture tour in Berlin after the
success of the German translation of Per violino solo 20 and his relationship with the
interpreter provided by the German publishers. This movement along the personal/
public continuum is based on a sequence of clichés:
Non era biondo, meno male, ma i capelli neri e lisci, con la discriminatura e rasati alti sulla
nuca, generavano ugualmente parecchia apprensione. Tuttavia quel che mi suscitava i
peggiori sospetti era il suo modo di vestire, patologicamente ordinato, con un completo grigio
con le maniche troppo lunghe, i pantaloni troppo stirati, una camicia di qualità ma con il
colletto troppo largo e una cravatta troppo scura per quell’abito. Quell’uomo era tutto in
bianco e nero come un documentario sul processo di Norimberga. Non ne sono sicuro, ma
nella mia allucinazione vedevo sul bavero di quella giacca un distintivo che, senza entrare nei
dettagli, mi appariva il simbolo della decorazione pour le mérite, la massima onorificenza della
terribile Wehrmacht. (Zargani 1995, 9) 21
The passage is constructed as a crescendo of tension between two frames of
reference: that of the narrated self, who, in public situations, projects his wariness of
Germany onto an individual, and that of the narrating self, who – with hindsight –
mocks the narrated self’s apprensione and allucinazione. The narrated self reads in
political terms (specifically, in Nazi terms) every personal detail about his
interpreter, even colour-coding him in an explicit simile, “in bianco e nero come un
documentario sul processo di Norimberga”. Two paragraphs later he progresses to
speaking for the interpreter, ironically praising him for his faithful translations
“nonostante l’abisso incolmabile che ci separava a causa delle sue atroci, intime e
inconfessate, convinzioni” (Zargani 1995, 10). 22 When the narrated self meets the
interpreter for the last time, the interaction is private instead of public: the interpreter
– no longer in black and white, but wearing blue jeans, a yellow shoulder bag and an
orange helmet – visits the narrated self in his hotel and gives him a guidebook,
published by a small left-wing publisher, to the ‘topography of Nazi terror’ in Berlin.
The narrated self finally realizes the extent to which he has ‘mistranslated’ someone
who never was an enemy, and with whom there never was any real political
difference.
In Sereni’s case, self-disparaging irony tends to arise from the fact that she
represents herself as being constantly at the intersection of two or more appartenenze
and trying, without much success, to make connections between them. One of the
fragments of Casalinghitudine relates an experience that the narrated self had in 1973,
when feminism and different ‘countercultures’ were thriving in Italian cities. The
narrated self – politically very distant from the Communist Party, but eager for
adventure – agrees to sing in a ‘festa dell’Unità’ 23 in a remote village in Calabria. She
arrives with a programme of challenging songs on oppressive institutions and
women’s estate, and finds herself in a square full of rowdy Party members, all men.
She resorts to a desperate measure:
Attaccai a pieni polmoni Bandiera rossa. Il sindaco, continuando a distribuire urtoni, cominciò
a farmi coro, seguito quasi immediatamente dai più anziani, che l’inno richiamava a un ordine
266
non suscettibile di discussione. Prima che la canzone finisse la piazza era calma, anche i
giovani cantavano. Benedicevo per la prima volta la “disciplina rivoluzionaria” contro cui mi
ero più volte battuta. L’applauso finale fu compatto.
Snocciolai l’intero repertorio degli inni più popolari e alla fine potei permettermi qualche
canzone più “difficile”: evitai accuratamente tutte quelle sulla condizione femminile. (Sereni
1987, 97) 24
The outcome, and the irony, are ambiguous: an example of what the humour theorist
Christie Davies has defined as “comic images that are at once self-praise and selfdeprecation”. 25 Sereni mocks the “ordine non suscettibile di discussione” and the
“disciplina rivoluzionaria” of the old Party, which, however, are what allow the
narrated self (who ‘should have known better’) to reframe her role and her
performance in order to win over the crowd. However, the narrated self – at the
same time an outsider who would like to speak for the new Left and an insider who
needs to speak as a Party ‘faithful’ – does not escape consequences: the bitterness of
“potei permettermi” and “evitai accuratamente” stress that cost of survival is her
erasure of some of her own appartenenze.
A song is also the starting-point for political reflections in the article
‘Spaesamento’ (Displacement), published in 2005. The narrated self has begun to sing
again after thirty years, and finds herself recalling a song of the 1960s, based on the
well-known passage from Pavese’s La luna e i falò: “Un paese vuol dire non essere soli
[…]” (A country means that you’re not alone). The quotation becomes a metaphor,
which in turn expands into other ironic metaphors: like an illegal migrant with no
papers or expired IDs, the narrated self no longer has a political appartenenza, either
as a member of the Left or as a feminist. Shifting from the first person singular to the
first person plural, Sereni identifies as a gendered member of a generation which
may slide into despair unless it urgently rethinks politics. The hyperbolic opposition
between “un paese” and “una cabina balneare” ironically emphasizes what a
difficult challenge this has become in Italy in the past thirty years.
È che io un paese proprio non ce l’ho più, e credo che siamo in tanti a trovarci nelle stesse
condizioni.
Non ho più un paese politico, un progetto una teoria e un’utopia in cui riconoscermi. Sono
una sans-papier, i documenti che avevo sono scaduti e inutilizzabili e non c’è anagrafe al
mondo che possa farmene di nuovi […] Perfino l’età, gli anni che ho, non sono più un paese
riconoscibile: diverse dalle nostre madri, differenti dalle figlie che verranno, noi – generazione
degli zoccoli e delle gonne a fiori – non riusciamo ad essere né giovani né vecchie, né dentro
né fuori dal gioco dei sessi e delle differenze, insomma viviamo in un terrain-vague esposto a
venti, maree, conchiglie e distruzioni, in cui appare follia costruire non dico un paese, ma
perfino una cabina balneare. (Sereni 2005, 11) 26
The conclusion of the article reiterates Sereni’s “speranze disperate” as a public
intellectual. She hopes, warily yet stubbornly, that the Italian people may establish
connections in the public sphere and formulate alternatives to old ideologies which
may become viable answers to cynicism and displacement:
267
[…] creare con altri e altre una rete, qualcosa che permetta di non affogare e anzi di alzarsi un
po’ più su del pelo dell’acqua. Qualcosa che prefiguri un paese nuovo, un orizzonte di
possibilità, una comunità in cui sia possibile tornare a riconoscersi. (Sereni 2005, 1) 27
The need for new ways of thinking politically is also at the centre of a controversial
article Sereni wrote for L’Unità on 16 January 2006. The ironic title, ‘La colpa di essere
ebrea’ (The Crime of Being a Jew), foregrounds her anger at explicit or implicit
racism forcing her to speak for Jews rather than as a Jew. The starting point are two
incidents, one in the private sphere and one in the public sphere. The private incident
takes place at a birthday dinner among representatives of the left-wing “ceti medi
riflessivi” (“tutta gente di sinistra e per bene” (all left-wing, respectable people)).
When the conversation shifts to the Middle East, the narrated self – the only Jew
present – is the only person who feels the need to speak out when someone rattles off
a series of negative stereotypes about Jews before stating that the Palestinians are
‘the oppressed’ and the Israelis are ‘the oppressors’: “ho dovuto, da ebrea, fare il mio
‘Radames discolpati’“ (Sereni 2005, 24). 28 The ironic cultural reference to both Verdi’s
Aida and a well-known article published by the journalist Rosellina Balbi in 1982, at
the time of the massacres of Sabra and Chatila, 29 highlights the ambiguities of the
narrated self’s position: she feels simultaneously a part of the group of left-wing
friends, angry at being pushed to answer for Israel because of her Jewishness,
determined to distance herself from the aggressive policies of the Sharon
government, and offended by the racist generalizations. The second incident occurs
at the beginning of a panel discussion on peace and war organized by the left-wing
union CGIL, 30 where Sereni is introduced as “Clara Sereni, ebrea e scrittrice” (Clara
Sereni, a Jew and a writer). She interprets this as an appropriation of her subjectivity
by the public representatives, who reduce her to two appartenenze, both of which she
has claimed for herself, but which, in that sequence and in that political context,
implicitly amount to another demand for Jewish self-justification. On both occasions,
although offended, Sereni explains that all simplifications and sweeping
generalizations about the Middle East are dangerous, and stresses “la richiesta di più
politica e meno ‘tifo’ rispetto alla questione due popoli/due Stati” (Sereni 2005, 24). 31
She concludes with a repeated reference to self-justification (“Vorrei non dovermi
discolpare delle mie opinioni” (I wish I did not have to defend myself and my
views)) and the wish that the Left, instead of locking her into one definition that
forces her to speak for Jews, would fully acknowledge her Jewishness as one of her
many appartenenze (as well as “donna, comunista, madre handicappata e
intellettuale” (a woman, a communist, a handicapped mother and an intellectual)). 32
Unlike Sereni, Zargani implicitly considers his role as mediator between Jews
and non-Jews the central one in his life. In fact, in his 1999 essay ‘La caldaia spenta
del sabato’ (The Boiler Switched Off On the Sabbath) he represents all Jews, starting
from Josephus Flavius, as cultural mediators. The essay starts from a conversation
with a non-Jewish friend who, on a winter Saturday in New York, was asked to turn
on the heating for a small synagogue. ‘La caldaia spenta riguarda anche me’ (The
268
switched-off boiler is about me too) Zargani states, thinking generally of Jewish/ nonJewish cultural relations (Zargani 1999, 37). He goes on to describe the cultures of
Diaspora Jews as being complementary to the other cultures within which they live,
constantly explaining Jewishness to ‘the others’ and constantly redefining it in the
process. In the lecture ‘La mia identità ebraica en amateur’ (My Amateurish Jewish
Identity) – given in September 2002 at Monash University, Melbourne, and which
takes up and expands some of the reflections of “Mi hanno tradotto!” – he paints a
positive, if ironic, picture of this relationship between Jewish writers and non-Jewish
readers. Two literary references add ironic ambiguity. The impossibility of giving
one, clear-cut definition (historical, social, political, literary) of what it means to
speak as a Jew is emphasized through an extended comparison to the semi-serious
poem The Naming of Cats by T.S. Eliot: ‘Jewish identity’ is the secret third name of
cats,
the name that you never will guess; / The name that no human research can discover – / But
THE CAT HIMSELF KNOWS, and will never confess. (Eliot 1986, 11)
La gente ha perduto l’ubi consistam, i gentili, denudati a rate anch’essi, con le buone o con le
cattive, della propria identità, diventano talvolta accaniti lettori delle ricerche a tentoni che gli
ebrei fanno, nella speranza forse di trarne per sé una qualche utilità. (Zargani 2002, 10) 33
[…] I nostri lettori […] ascoltano con attenzione le ripetizioni di quanto già sanno, nell’attesa
inappagata, perennemente inappagata, che venga alla fine svelato […] il terzo nome del gatto,
in che consista cioè la famosa identità ebraica. Ma poiché questa identità è ignota anche a noi
stessi – animula vagula blandula, hospes comesque mei – e di essa viene alla luce in definitiva
solo l’affanno di raccontarla, in questo travaglio è racchiuso il fascino della narratività ebraica
che, in tutti i continenti, crea le fortune di così tanti scrittori. I lettori continuano ad ascoltarci,
sperando e non sperando che giunga la parola FINE che invece è rimandata alle fiabe della
notte successiva. (10-11) 34
The second literary reference is less accessible, but just as significant. Referring to
‘Jewish identity’ through the series of diminutives used by the dying Emperor
Hadrian in his final poem to address his departing soul can be read as ironic in two
ways: as an apparently self-deprecating mocking of the notion of ‘Jews as Other’
(“my guest and companion”) or as mocking all reductive attempts to conceptualize
one Jewish ‘soul’. Furthermore, the Latin quotation implicitly points out that in the
case of Italian Jews, Jewish cultural appartenenza is inextricably linked to the classical
heritage they absorbed in the Italian secondary school system.
Relations between Jews and non-Jews in Italy are also at the centre of the
essay ‘Il posto degli ebrei del posto’ (The Place of the Local Jews) written at the end
of 2003 as a response to the monograph Il posto degli ebrei, by the then-President of the
Union of Italian Jewish Communities, Amos Luzzatto. 35 Luzzatto’s thesis is that
Diaspora Jews, integrated yet different, represent a challenge to racism wherever
they live, and that Jews are bound to find an equal ‘place’ in a unified Europe.
Zargani agrees, but argues that at the beginning of the twenty-first century even
269
integrated Diaspora Jews are feeling increasingly uneasy as a consequence of the
growth not only of various kinds of anti-Semitism, but also of some problematic
varieties of pro-Semitism. The essay begins with some ‘personal and public’ good
news. The first item is a conversation between the narrated self and his twelve-yearold grandson, then a student at a Rome state school:
‘De … degli ebrei pa … parlate qualche volta?’ ‘Mai.’ ‘E di … di Israele?’ ‘No, anzi sí. Solo
quando leggiamo Repubblica’. (lungo silenzio, anche mio). ‘Ehm … e di te che sei un ebreuccio
cosa dicono i tuoi compagni? Eh! eh!’ ‘Niente.’ ‘Ma tu, dí la verità, lo tieni un po’ nascosto, il
fatto di essere ebreo, no?’ ‘Ma che dici? a nonno! e perché dovrei tenello nascosto? Mah!’
(Zargani 2003, 2) 36
The narrated self’s insecurities and fears – self-disparagingly highlighted by the
reproduction of a stammer – are unfavourably compared to the laconic, matter-offact integration of the representative of the survivors’ grandchildren. However, as
the essay moves from the private to the public sphere (namely to the complex Italian
responses to Israeli policies after 2001), self-disparaging humour is replaced by
sarcastic parody. The narrating voice parodies two different voices, which express
opposite, equally problematic perspectives on Jews and Israel. The first is the far
Right, which is constructed, with grotesque exaggeration, as pro-Israel and proSemitic for the wrong reason (“the enemy of our enemies is our friend”):
Cosí ci piacete, voi ebrei, non come all’epoca di quando vi scardellavamo noi, cosí ci piacete,
siete diventati camerati, soldati, guerrieri, certo per merito nostro – che, se non altro, vi
abbiamo irrobustito! – sentinelle di scorta al mondo di Cristo, di Odino, di Wothan, contro la
barbarie orientale e, in particolare, quella degli arabi, che hanno dimenticato, quegli
irriconoscenti, le Crociate. (6) 37
The second voice, also reduced to grotesque stereotypes, is that of the part of the Left
which strongly opposes most Israeli policies. Like the first parody, this also
culminates in the word irriconoscenti, which in both fictitious discourses is used to
refer to the oppressors’ view of the minorities they have oppressed.
Ecco, ecco, basta criticare qualche aspetto dell’operato del governo Sharon, e viene subito
usata contro di noi, democratici, progressisti, internazionalisti, pacifisti, l’accusa di
antisemitismo che ci offende profondamente. Tanto piú ci offende l’uso di quest’arma
impropria, che ad adoperarla siano gli ebrei di oggi, che, loro sí, sono diventati antisemiti,
perché hanno dimenticato, irriconoscenti, la tragica lezione di Auschwitz. (13) 38
The sarcastic reframing – speaking for two threatening Others – allows the narrating
voice to speak for Diaspora Jews and to express their uncertainty and fears.
Primo Levi wrote that “chi sta al margine del gruppo […] può andarsene
quando vuole e vede meglio il paesaggio” (Anyone who is on the margins of a group
[...] can leave whenever he wants to and can get a better view of the landscape). 39
Zargani’s and Sereni’s autobiographical macrotexts show that both are deeply rooted
270
in their cultural and political Italianness, yet are on the margins of several Italian
groups, simultaneously insiders and outsiders according to whom, and in which
public situations, they speak as and for. Irony – which in Linda Hutcheon’s words
“can only ‘complexify’; it can never ‘disambiguate’“ – allows both of them to
problematize all monolithic notions of ‘identity’. 40 Sereni does that by pointing out
her multiple appartenenze and the conflicts between them, Zargani by exposing the
complexities and contradictions inherent in being Jewish. Their major contribution as
public intellectuals arises from this constant questioning and renegotiation of
‘meanings’ in public discourses and in their own personal discourses.
NOTES
The philosopher Giacomo Marramao talks in terms of “una separazione progressiva della politica
[...] dalla mappa dei saperi” (a progressive separation of politics [. . .] from the map of knowledges)
(82). See also Chapters 3 and 8 of Ginsborg.
1
She was never a member of the Italian Communist Party; she joined the then PDS (Partito dei
Democratici di Sinistra, now DS) after becoming deputy mayor of Perugia, and left it around 2004.
2
3
See Ginsborg 2001, 42-44 and 96 and Andrews 2005, 104-106 and 170-171.
4
See, for instance, Altman 1997, Daniel 1997, Ozick 2000, Collini 2002.
5
Altman 1997, 20.
6
Collini 2002, 210.
7
“Childhood is like a telescope attached to a microscope; in my case, when I peer through it I see the
dark night of the Shoah [. . .] I am now more than sixty years old, and my life is divided into two
unequal parts; those seven years of persecution have expanded out of all proportion and become an
excrescence of my soul, pushing aside half a century filled with the normal stages of life, confining
them and all of the various ordinary trials of a life into a tiny space” (For Solo Violin, 14).
“I think of myself as being made up of four segments whose boundaries constantly blur: a Jew
because I chose rather than happened to be; a woman not only because my birth certificate says so; an
expert on disabilities and shortcomings, like anyone who has direct experience of them; a utopian like
anyone who is firmly rooted in the here and now, and who, without refusing to get involved in dayto-day issues, cultivates the need to have a vision and a passion which draws them towards the
future”. Translations of quotes are mine unless otherwise specified.
8
“[…] in my life, pieced together with ill-fitting bits, in the mosaic of my life (as in everyone’s, but
more so women’s” (Keeping House, 142).
9
10
Miller 1991, XIV, 20, 97.
“My woman’s body is considered once again [...] a container which can be used violently, against
my will and against my wishes, to create a difficult life whose responsibility will fall back on my
shoulders”.
11
12
“I do have, on my shoulders and in my heart, the weight of a difficult child”.
“Italy is at a standstill, shackled by intrusive religious prescriptions which are not shared by many
Catholics, and which offend me even more, since I have Jewish roots and culture”.
13
271
“With the increasingly desperate hope that there may come a time when the big issues of living and
dying [...] of the right to happiness and of pain may be central to a political discussion; and that this
discussion may at long last be substantial, high quality, able to produce answers which, right now, are
nowhere to be found”.
14
15
See Hutcheon 1995, 60-64, Mizzau 1984, 21, 35-40, and Anolli e.a. 2002, 137-139.
16
See Hutcheon 1995, 47-50 and Muecke 1970, 56-57.
17
See ‘Introduction’, in Ziv 1998, 54-55.
18
See Juni & Katz 2001, 122-130.
“And now I come to my own experiences as an author who, with For Solo Violin, has added his small
brick to the huge wall of writings on the Holocaust: ‘Hitler did so many things to us, but now we Jews
have had so much to say about him […]’”.
19
The German translation (Für Violine Solo: Meine Kindheit im Diesseits 1938-1945) was published by
Fischer Verlag in 1998 (translation by Ruth Mader).
20
“Luckily he was not blond, but his smooth black hair, parted and shaved high on the nape of his
neck, nevertheless produced considerable apprehension. However, what aroused my worst suspicions
was the way he dressed – pathologically neat, with a grey suit with sleeves that were too long and
exceedingly well-ironed trousers, a shirt of good quality but with too wide a collar, and a tie which
was too dark for that suit. The man was all in black and white, like a documentary on the Nuremberg
trials. I am not sure, but in my hallucination I saw on the lapels of that jacket a badge which – without
going into details – seemed to me the symbol of a decoration pour le mérite, the highest decoration of
the terrible Wehrmacht”.
21
22 “in spite of the unbridgeable chasm which separated us due to his awful, deep and unconfessed,
convictions”.
The ‘feste dell’Unità’ were Communist Party festivals, with food, speeches by Party leaders, and
various cultural and community activities.
23
“I started singing Bandiera Rossa (Red Flag) at the top of my lungs. The mayor, still shoving people
around, joined me in singing along with the elderly men, who were brought about by the Communist
hymn to a nonnegotiable order. Before the song was over the square was already calm; even the
young people were singing. For the first time I praised the ‘revolutionary discipline’ against which I
had fought so many times. The final applause was solid.
24
I went through the entire repertory of the most popular hymns, and at the end I could afford to sing
some of the more involved songs: I carefully avoided all those about women’s issues” (Keeping House,
92).
25
Davies 1993, 43, n. 3.
“The fact is that I no longer have a country, and I think there are many of us in the same position.
I no longer have a political country, a project a theory and a utopia with which I could identify. I am
without an ID, the identity papers I had have expired and cannot be used, and there is no registry
office in the world which can provide me with new ones [. . .] Even my age, my years, are no longer a
recognisable country. Different from our mothers, different from the daughters who will follow us, we
– the generation who wore wooden clogs and flowered skirts – cannot manage to be either young or
old, either inside or outside the games between sexes and differences. In short, we are in an inbetween land exposed to winds, tides, shells and destruction, where it appears insane to build even a
bathing hut, let alone a country”.
26
272
“[...] creating with other men and women a net, something that may allow us not to drown, in fact to
rise a little above the water line. Something which may evoke a new country, a horizon of possibilities,
a community in which we may once again recognise ourselves”.
27
28
“As a Jew, I had to act out my ‘Radames, defend yourself’”.
29
Balbi 1982.
30
Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
“[…] the call for more politics and less side-taking when it comes to the question ‘two peoples, two
States’”.
31
The responses to the article were strong (see, as examples, the articles by Fait and by Israel). The
irony of the title was apparently not perceived, since Sereni was accused of being ashamed of her
Jewishness and of not being aware of the incompatibility between being a Jew and being a
Communist.
32
“People have lost their ubi consistam (their resting place). Non-Jews, who have also been – more or
less gently – gradually divested of their identity, sometimes become passionate readers of the
fumbling searches of the Jews, possibly hoping to gain something for themselves from them”.
33
“Our readers [...] listen carefully to the repetitions of what they already know, in the unfulfilled,
ever unfulfilled, expectation that [...] the third name of the cat, that is to say, the nature of the muchdebated Jewish identity, may eventually be revealed. But this identity is unknown to ourselves –
animula vagula blandula, hospes comesque mei – and the part that emerges is only our anxious attempts to
tell its story. In this labour lies the attraction of Jewish storytelling, which, in all continents, has made
the fortune of so many writers. Readers keep listening to us, hoping and not hoping to get to the
words THE END – which, however, are postponed to the following night’s tales”.
34
The essay – originally a lecture given on 30 October 2003 at the World Conference on Religion and
Peace in Rome on the topic ‘Religious Identities’ – is to be republished in a collection of essays and
sketches with the provisional title Cocci rotti.
35
“‘D … do you ever t … talk about Jews?’ ‘Never.’ ‘And about … about Israel?’ ‘No, I mean yes. Only
when we read Repubblica’. (A long silence, mine as well). ‘Er … and what do your friends say about
you, who are a little Jew? Heh, heh!’ ‘Nothing’. ‘But you, tell the truth, you keep it secret, the fact that
you’re a Jew, don’t you?’ ‘What are you talking about? Come on, grandpa! Why should I keep it
secret? Who knows!’”
36
“That’s the way we like you, you Jews – not like the times when we were bashing you up. That’s the
way we like you, you have become comrades, soldiers, warriors, definitely thanks to us – if nothing
else, we made you strong! You’re sentries and escorts to the world of Christ, Odin, Wotan, against
Eastern barbarism – particularly that of Arabs, who (thankless people that they are) have forgotten
about the Crusades”.
37
“Look, look, all we do is criticize some aspect of the actions of the Sharon government, and
immediately you accuse us – democratic, progressive, internationalist pacifists – of anti-Semitism,
which deeply hurts us. We are even more hurt by this weapon because the ones wielding it are
today’s Jews: it is they who have become anti-Semitic, because they (thankless people that they are)
have forgotten the tragic lesson of Auschwitz”.
38
39
Preface to L’altrui mestiere. Opere, II, 631.
40
Hutcheon 1995, 13.
273
WORKS CITED
Altman, Dennis. ‘The Public Intellectual and Reviewing’. Bartoloni 1997: 19-32.
Andrews, Geoff. Not a Normal Country. Italy After Berlusconi. London and Ann Arbor: Pluto Press,
2005.
Anolli, Luigi e.a. ‘‘You’re a Real Genius!’ Irony as a Miscommunicative Design. Say Not To Say. New
Perspectives on Miscommunication’. Amsterdam: IOS Press, 2002, 135-159.
Balbi, Rosellina. ‘Davide, discolpati’. La Repubblica (6.06.1982).
Bartoloni, Paolo e.a. Intellectuals and Publics: Essays on Cultural Theory and Practice. Melbourne: School
of English, La Trobe University, 1997.
Collini, Stefan. ‘Every Fruit-juice Drinker, Nudist, Sandal-wearer ...: Intellectuals as Other People’. The
Public Intellectual. Helen Small, ed. Oxford: Oxford UP, 2002. 203-223.
Daniel, Helen. ‘The Public Intellectual: Mavericks and Chameleons’. Bartoloni 1997, 33-39.
Davies, Christie. ‘Exploring the Thesis of the Self-Deprecating Jewish Sense of Humor’. Semites and
Stereotypes. Characteristics of Jewish Humor. Avner Ziv and Anat Zajdman, eds. London & Westport,
Connecticut: Greenwood Press, 1993. 29-46.
Eliot, T. S. Old Possum’s Book of Practical Cats. 1339. London and Boston: Faber & Faber, 1986.
Fait, Deborah. ‘Da ebrea israeliana a ebrea italiana’. Informazione Corretta (21.01.2006).
Ginsborg, Paul. Italy and Its Discontents. Family, Civil Society, State 1980-2001. London: Allen Lane/ The
Penguin Press, 2001.
Hutcheon, Linda. Irony’s Edge. The Theory and Politics of Irony. London: Routledge, 1995.
Israel, Giorgio. ‘È ora che si discolpi Golia’. Il Foglio (20.01. 2006).
Juni, Samuel & Bernard Katz. ‘Self-Effacing Wit as a response to Oppression: Dynamics in Ethnic
Humor’. The Journal of General Psychology 128/2 (2001): 119-142.
Levi, Primo. ‘Preface’ to L’altrui mestiere. Opere, II. Marco Belpoliti, ed. Torino: Einaudi, 1997. 631-32.
Luzzatto, Amos. Il posto degli ebrei. Torino: Einaudi, 2003.
Marramao, Giacomo. ‘Si prega di disturbare il manovratore’. La fatica di pensare. Gli intellettuali
nell’Italia di Berlusconi. Roma: con nuovi tempi, 2003. 81-87.
Miller, Nancy K. Getting Personal. Feminist Occasions and Other Autobiographical Acts. New York &
London: Routledge, 1991.
Mizzau, Marina. L’ironia. La contraddizione consentita. Milano: Feltrinelli, 1984.
Muecke, D.C. Irony. London: Methuen & Co., 1970.
Ozick, Cynthia. Public Intellectuals. Quarrel and Quandary. New York: Alfred A. Knopf, 2000. 120-126.
Sereni, Clara. Casalinghitudine. Torino: Einaudi, 1987. Keeping House. Translation by Giovanna Miceli
Jeffries & Susan Briziarelli. New York: SUNY Press, 2005.
---. Il gioco dei Regni. Firenze: Giunti, 1993.
---. Taccuino di un’ultimista. Milano: Feltrinelli, 1998.
---. Passami il sale. Milano: Rizzoli, 2002.
274
---. ‘Spaesamento’. Leggere (bulletin of the Culture Division of the Florence City Council) Jan.-March
(2005).
---. ‘Al voto con furore’. L’Unità (2.06.2005).
---. ‘La colpa di essere ebrea’. L’Unità (16.01.2006).
Zargani, Aldo. Per violino solo. La mia infanzia nell’aldiquà, 1938-45. Bologna: Il Mulino, 1995. For Solo
Violin. Translation by Marina Harss. Philadelphia: Paul Dry, 2002.
---. Certe promesse d’amore. Bologna: Il Mulino, 1997.
---. ‘La caldaia spenta del sabato’. Lettera internazionale 61 (1999): 37-39.
---. ‘Mi hanno tradotto!’ L’informazione bibliografica Il Mulino (2001): 7-13.
---. ‘La mia identità ebraica en amateur’. Unpublished lecture. Monash University, Melbourne. Sept.
2002.
---. ‘Il posto degli ebrei del posto’. Lecture. World Conference on Religion and Peace. Rome, 30 Oct.
2003.
Ziv, Avner, ed. Jewish Humor. New Brunswick & London: Transaction, 1998.
275
PELLIZZI, Federico. ‘Casalinghitudini tra identità e storia: La scrittura pluristratificata
di Clara Sereni’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a
cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA
ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN
978-90-6701-017-7. 277 – 292.
RIASSUNTO
La scrittura di Clara Sereni si è sempre caratterizzata per la capacità di connettere, senza annullare le
distanze e le differenze, la storia personale e la storia di una generazione, la dimensione domestica e il
mondo esterno, la memoria privata e la memoria storica. L’intervento esamina i personaggi e i
cronotopi sereniani, partendo dalla teoria delle rappresentazioni dell’identità di Amélie Rorty, e cerca
di mettere in luce quali siano le modalità stilistiche e tematiche attraverso le quali Clara Sereni riesce,
spesso con grande originalità, a intersecare questi diversi piani. Importante in tutti i suoi libri è la
ricerca dell’identità, che non è mai affermazione di valori precostituiti bensì esercizio di esperienza,
esplorazione ai confini, curiosità creativa, lotta per l’autonomia. La memoria si innesta sulla vita
quotidiana, sugli oggetti e sulle pratiche familiari, si misura negli spazi della casa. Il cibo, la cucina
hanno un ruolo fondamentale e costante in tutte le sue opere, divengono quasi il motore simbolico
dell’immaginario. L’intervento si sofferma soprattutto su due opere di Clara Sereni: Casalinghitudine
(1987) e Le merendanze (2004), anche se si fa riferimento alle tappe fondamentali di Manicomio primavera
(1989), Il gioco dei regni (1993), Eppure (1995), Passami il sale (2002), e ad altri scritti. Si vuole mostrare da
un lato da quali generi è influenzata la scrittura sereniana, con particolare riferimento al diario,
dall’altro come il radicarsi di questa scrittura in un tempo vissuto, individuale e collettivo, apra un
dialogo con altre memorie e con altre scritture. Così le opere della Sereni si misurano anche con la
generazione che ha vissuto la Shoah, con le proprie appartenenze, con altri scrittori (alcune
considerazioni sono dedicate al rapporto con Primo Levi). Non si tratta di un avvicinamento
convenzionale o partigiano, ma di una presa di coscienza che è al tempo stesso percorso autonomo e
mantenimento di distanza critica. Lo stesso vale per il dolore presente, per la vita vista con assoluto
realismo, cui fa fronte una lingua tersa, la conquista della parola e della narrazione. Un percorso che,
tra femminilità, ebraismo e politica, è anche la ricerca di un ordine della memoria, un dialogo con
figure famigliari e storiche appartenenti a generazioni diverse, una presa in carico da parte della
scrittura della quotidianità e della storia, e insieme itinerario intellettuale.
PAROLE CHIAVE
Clara Sereni, generi letterari, diario, quotidianità, identità
© Gli autori
Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale (Utrecht-Amsterdam, 5-7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata
da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
277
CASALINGHITUDINI TRA IDENTITA E STORIA
LA SCRITTURA PLURISTRATIFICATA DI CLARA SERENI
Federico Pellizzi
Università degli studi di Bologna
Indubbiamente Clara Sereni ha molte voci, di donna, di madre, di figlia, di “ebrea
per scelta più che per destino”, come lei dice in una nota autobiografica, 1 di persona
impegnata politicamente e professionalmente; e molti sono i registri attraverso i quali
queste personae, nel senso latino, si esprimono e vengono rappresentate: ironico,
tragico, memorialistico-descrittivo, schiettamente narrativo. Anche i generi coinvolti
in questa resa del sé nella scrittura sono molteplici, dal libro di cucina alle “bandelle
per la casa editrice” come scrive in un’altra nota autobiografica, 2 dal saggio alla
ricostruzione documentale, dalla biografia al racconto breve coordinato. Un
contrappunto di generi, prima ancora che una contaminazione di generi, che fa della
scrittura di Clara Sereni un terreno sperimentale assai interessante e originale.
Memoria e appartenenze generazionali svolgono senza dubbio un ruolo
notevole nelle sue opere. Nata nel 1946, Clara Sereni appartiene alla prima
generazione nata dopo Auschwitz; pertanto, quando si volge indietro, o
semplicemente decide di fare i conti con le proprie origini ebraiche, ricorre alla
ricostruzione e alla reinvenzione; o, per usare le due categorie introdotte da Elrud
Ibsch, si muove tra la remembered history e la imagined history. Categorie che possono
riferirsi non solo alla Shoah, ma diventano traslabili anche ad altri traumi atavici,
dolori profondi ed essenziali, come chiarirò più avanti, o alle tappe di una vita e di
una generazione. E indubbiamente la matrice fondamentale della sua scrittura, in cui
comunque sull’esperienza e sul ricordo agiscono sempre l’invenzione e
l’immaginazione, è in generale quella della ‘fiction autobiografica’ o biografica, volta
a rintracciare, come recita la seconda di copertina del suo libro del 1993, Il gioco dei
Regni, “i fili sfuggenti di alcune eccezionali esistenze individuali”. 3
Eppure credo che occorra circostanziare meglio questa matrice. Innanzitutto
mi sembra che nella scrittura di Clara Sereni, tra i tanti generi che vengono impiegati,
ne prevalga in particolare uno, il diario. Il diario, a volte in forma implicita e
sotterranea, a volte in forma esplicita, è in qualche modo sempre presente in tutte le
sue opere, da Sigma epsilon (1974) a Passami il sale (2002), da Le merendanze (2004) a Il
lupo mercante (2007). Va ricordato che il diario è la forma che Sereni ha impiegato per
una straordinaria testimonianza, sul piano umano e sul piano della scrittura,
dedicata al rapporto con il figlio psichicamente sofferente, e intitolata
significativamente Diario. 4 Spesso il diario è un modello nascosto, nondimeno
influenza la scrittura, come vedremo, sia sul piano stilistico e discorsivo, sia sul piano
strutturale e compositivo.
278
Premetto che mi occuperò qui brevemente non dell’intero macrotesto sereniano,
come lo chiama Mirna Cicioni, 5 ma principalmente di due opere, Casalinghitudine
(1987) e Le merendanze (2004). Alcuni riferimenti tuttavia riguarderanno
necessariamente altre opere intermedie, come Manicomio primavera (1989), Eppure
(1995), Passami il sale (2002), e altri testi.
Mi sembra infatti che il tratto – stilistico e di senso – che unisce
Casalinghitudine e Le merendanze, all’insegna di questa presenza sfuggente del diario
come genere, sia particolarmente illuminante per guidarci nella lettura anche di altri
suoi testi, come i racconti o lo stesso Il gioco dei Regni. A proposito di quest’opera
Asor Rosa ha richiamato giustamente il genere tre-cinquecentesco del “libro di
famiglia”, 6 mi sembra tuttavia che il ritmo e la tonalità, come in altri testi sereniani,
siano quelli dell’acquisizione quotidiana, dell’intimità vissuta, di ciò che si potrebbe
chiamare scrittura della frequentazione, sia sul piano compositivo, sia sul piano della
costruzione della frase, a livello macrosintattico e microsintattico. Ne Il gioco dei regni
la scrittura non va mai verso la cronaca, verso la genealogia, o verso la massima, e
nemmeno verso la mera registrazione o documentazione di eventi, ma verso la
presenza e la compartecipazione. Anche la scelta e la collocazione dei documenti
inseriti – diari, epistole, ecc. – contribuiscono a questa logica quasi woolfiana della
percezione e della cattura di momenti e di pensieri. Ogni enunciazione, in tutta
l’opera sereniana, è sempre una testimonianza, un passaggio attraverso l’esperienza,
il pensiero, e le cose della vita quotidiana.
Casalinghitudine è un’opera assai originale, che trasforma un libro di cucina in
uno scandaglio nella memoria personale e storica, in un’analisi della vita domestica e
famigliare e dei rapporti interpersonali. Il passaggio tra cibo e memoria, tra ricette e
persone non è mai artefatto o meccanico, perché il libro è propriamente un diario di
cucina, più che un libro di ricette. Sereni usa la prima persona per raccontare la
preparazione di ogni piatto, come registrando un evento che si sta compiendo o si è
appena compiuto: “Cuocio gli gnocchi come al solito” (Sereni 1987, 32), “faccio
scaldare il latte con il sale, quando bolle aggiungo – a pioggia – il semolino” (27).
Casalinghitudine
rappresenta
certamente
una
rivitalizzazione
e
7
rifunzionalizzazione del genere “libro di cucina”, come scriveva Stephen Kolsky, ma
a me sembra che la sua maggiore originalità e incisività stia nel rivitalizzare e
rifunzionalizzare il genere ‘diario’.
Innanzitutto le ricette non sono una cornice vuota, bensì ordinano in una
semantica vissuta la narrazione. Non sono un pretesto, ma sono esse stesse radicate
nel tessuto della memoria personale. Appartengono alla vita quotidiana, ma hanno
una risonanza più profonda, individuale e collettiva: sia come dato antropologico – la
cucina e il cibo come prisma delle relazioni sociali e private –, sia come evento
concreto, storico, legato a certi episodi traumatici o terapeutici, felici o dolenti, sia
come risorsa personale, riconquista del tempo, modo di reimparare e reinventare il
quotidiano. 8 Le ricette sostituiscono le date, creano la giusta scansione per evocare,
registrare e ordinare eventi, situazioni e persone, ma divengono strumento di
ricognizione non solo del vissuto, ma dei rapporti umani in generale.
279
Nonostante la prossimità diaristica ai fatti ricordati, siano essi insanabili o risolti, o
forse grazie ad essa, la loro rappresentazione è sempre sintomo o manifestazione di
una distanza, emotiva e intellettuale, della narratrice, anche quando prelude a uno
scioglimento positivo. Giuliana Menozzi ha mostrato come in Casalinghitudine si
manifesti una discrepanza tra l’io che descrive le ricette, sicuro e assertivo, e l’io che
narra, emotivamente coinvolto, alla ricerca di un proprio posto:
For the narrator, cooking is a form of action that allows her to reach some degree of
autonomy. The emphasis on action is remarkably clear if one looks at the discrepancy
between the “I” that speaks in the recipes and the “I” of the narrative fragments. The latter is
painfully and tentatively engaged in finding its space, in negotiating it, whereas the former
shows security, assertiveness, self-confidence. For example, in the recipe for the pea soup, we
read: “Trito la cipolla, faccio imbiondire [...] aggiungo i piselli. Lascio cuocere [...] aggiungo
[...] Ottengo una minestra che passo [...]” This is a very cut and dry sequence of verbs in the
first person, and all the recipes are consistently described in the same way. 9
In realtà questo spazio è anche più mosso e frammentato, abitato da una molteplicità
di rappresentazioni del sé alla ricerca di radici e di identità. 10 Ma anche da una
molteplicità di rappresentazioni degli altri, dal figlio che apre il volume al padre che
lo chiude, il quale è al tempo stesso avversario, estraneo, figura di riferimento e
complice. Lo stesso io che ricorda e narra assume registri differenti, a volte nella
stessa frase, e cerca di interpretare una “vita a mosaico” (Sereni 1987, 165) che
richiede necessariamente ruoli e appartenenze diverse ma anche induce umori e
capacità di resistenza differenti.
L’io narrante fa spesso uso di una sorta di paratassi avversativa che rende
bene l’idea di una pluridimensionalità di intenzioni, pulsioni, azioni e
rappresentazioni. Ne faccio solo due esempi, anche se sarebbe facile trovarne molti:
“Cerco di radicarmi in me, dipendo puntigliosamente dall’esterno” (Sereni 1987:
164); oppure quest’altra affermazione sulla quale tornerò tra un istante:
“Discutevamo di cibo, e sempre i fantasmi di molte altre cose dietro e dentro di noi”
(101).
Credo che per rendere conto di questa molteplicità di piani si attagli bene la
costellazione di modalità di rappresentazione dell’individualità messa a punto da
Amélie Rorty, la quale distingue tra caratteri, figure, persone, io, individui e
presenze. 11 Mi limito a citare le distinzioni principali, anche se dovrò aggiungere
qualche osservazione e essere piuttosto circostanziato. Come Rorty ammette si tratta
di distinzioni forzate, giacché i confini tra i concetti sono tutt’altro che netti e le
diverse modalità spesso si sovrappongono e si contaminano; tuttavia il tentativo di
distinguere alcune tipologie è utile in quanto mostra gli ‘strati archeologici’ della
nostra concezione dell’identità. Rorty ne fornisce una ricostruzione diacronica, che è
anche uno schizzo di storia del personaggio da Omero al Novecento, ma offre anche
un repertorio sincronico utile per il tempo presente, un quadro sinottico delle matrici
fondamentali del nostro immaginario riguardo alla soggettività, alla persona e
all’identità.
280
I ‘caratteri’ (Characters) derivano dagli eroi greci: la loro consistenza è determinata
quindi dal destino di appartenere a una qualificata discendenza e la loro fama è
affidata alle gesta compiute sul campo. Chi è rappresentato in questo modo tende a
essere personaggio pubblico, in qualche modo prevedibile, immune da crisi di
identità, tutt’uno con la propria corporeità e temperamento, fedele a se stesso fino ad
eventuali esiti tragici, ma in fin dei conti ‘tipo’, e non individuo: tendenzialmente
dominante, ma in qualche modo intercambiabile e astorico.
Le ‘figure’ (Figures) si distinguono dai caratteri perché sono definite invece dal
ruolo che svolgono in un contesto, in una situazione, in una narrazione. Derivano dal
mito e dalle sacre scritture, e si presentano come esemplari. Sono ancora ‘tipi’, e non
individui, perché le loro caratteristiche (il loro mestiere, la loro fisicità) sono sì
concrete, incarnate (“vivid, experienced” (Rorty 1976, 307)), ma non derivano
dall’esperienza, non sono frutto di una storia posseduta e riconosciuta: hanno
piuttosto carattere allegorico, archetipico.
Tuttavia il dover interpretare la propria vita attraverso il modello cui essa
corrisponde introduce la dimensione della rappresentazione di sé, che costituisce il
germe della distinzione tra interiorità ed esteriorità, introspezione e vita pubblica.
Quando all’interno di questa distinzione, che prelude in fondo alla scoperta della
propria identità – ossia dello spazio tra sé e sé, tra il sé e l’altro –, si fa strada la
possibilità di scegliere, si giunge al concetto di persona (309). Le ‘persone’ (Persons) si
collocano alla confluenza di due matrici: il teatro e il diritto. Conta molto anche in
questo caso il ruolo, più che il temperamento, ma è un ruolo scelto, interpretato,
difeso. La scelta implica un’azione, in senso teatrale ma anche in senso legale: l’attore
indossa maschere che sceglie di interpretare, e la sua interpretazione viene giudicata
dalla collettività. La persona, quindi, è vista come agente responsabile, fuori dal clan,
dalla famiglia, o da altre appartenenze. Costituisce un centro di scelta e di azione che
influisce sugli altri. È dotata, a differenza dei caratteri e delle figure, di libero arbitrio,
e quindi di possibilità di sbagliare (e non tanto di fallire, come i caratteri e le figure
nella loro potenzialità tragica). La responsabilità porta a pensare al soggetto in
termini di unicità e unitarietà, concetti che hanno matrice al tempo stesso legale e
teologica: il giudizio si esercita sul legame storico, eventuale, individuale (e non più
riconducibile a tratti caratteriali o a ruoli intercambiabili) che la persona istituisce tra
scelta e azione, e al tempo stesso è universale, uguale per tutti, in un certo senso
‘dall’alto’.
Rappresentare ‘persone’ implica perciò, oltre all’idea di unitarietà, l’idea di
uguaglianza (di fronte a Dio e di fronte agli uomini), che conduce nuovamente alla
costruzione di ‘tipi ideali’ a cui ciascuno dovrebbe corrispondere: ciò però apre una
discrepanza tra essere e dover-essere, tra dovere e prudenza, tra moralità e vita
pratica, tra obbligazioni sociali e obbligazioni morali, e, in ultima analisi, tra
interiorità ed esteriorità, che predispone di fatto la persona alla “crisi di identità”
(311), e introduce nuove scissioni. In fondo già l’idea di ‘persona giuridica’ porta a
una separazione del corpo fisico dal ‘corpo’ legale, a una non-coincidenza del
rappresentante e dell’ente: conduce a una sorta di “disembodiment” (312), a una
281
rappresentazione della ‘persona’ come res cogitans, come entità che sopravvive alla
morte. L’illuminismo ha accettato di buon grado questa riduzione del coefficiente
individuale della persona, in nome dell’universalità del discorso razionale, ma dietro
a questa unilateralità si nasconde un conflitto di cui proprio l’io razionale (o l’anima,
nella versione teologica) e l’io sensibile si rendono acuti ed implacabili scopritori e
critici. Jane Austen si colloca, secondo Rorty, nel mezzo di questa trasformazione che
conduce dalla persona all’io.
Il concetto di io (Self) nasce proprio da un’interpretazione energetica (e
borghese) di questa sublimazione e sovrastima di anima e intelletto, e dall’emergere
di una dimensione economico-politica della soggettività: l’io diviene principio
detentore di diritti e di potere. Non è più un’entità che sceglie, bensì che decide. L’io
emerge quando in una società “gli individui ottengono diritti in virtù del loro potere,
piuttosto che ricevere poteri definiti dai diritti” (313). L’io è caratterizzato dal
possesso: di beni, di denari, ma anche di esperienza, di memoria, di cultura. Ciò
costituisce la sua identità, che rimane tuttavia un’identità problematica, soprattutto
se permane più o meno latente la concezione della persona come esercizio di scelta in
una società di uguali. L’io è in grado di costruire la propria storia, ma al tempo stesso
comincia a fare i conti con la storia, può entrare in conflitto con essa, può esserne
condizionato o oppresso, può esserne corrotto. Può nascere un contrasto tra
immagine di sé e prassi.
Il concetto di individuo (Individual) è un tentativo di risposta a queste tensioni.
L’individuo tenta di conciliare la nozione di proprietà (intesa anche come possesso di
uno spazio personale) e i principi della scelta responsabile, cercando di crearsi
un’autonomia. L’individuo diviene un’entità indivisibile, unica, non tipizzabile, che
si definisce in contrapposizione alla società corrotta e corrompente. I suoi diritti sono
inalienabili, e la sua integrità è differenza. Anche in questo caso, come per le persone
e per gli io, nascono contraddizioni specifiche per questo tipo di rappresentazione
dell’identità.
Le presenze (Presences), infine, derivano dal romanzo russo e attraversano
tutta la letteratura moderna e contemporanea: sono esistenze gettate nel mondo che
rappresentano l’antitesi della versione volontaristica ed energetica dell’identità. Le
presenze sono personalità complesse, magnetiche; sono presenti in primo luogo alla
propria esperienza, anche se non sono in grado di dominarla e di dirigerla; ne sono
partecipi con grande serietà e intensità, ma la loro personalità si definisce al di là
della determinazione individuale e delle conquiste agognate.
In Clara Sereni l’io narrante si misura con tutti questi strati della
rappresentazione identitaria, creando la distanza a cui accennavo. Le figure paterne e
maschili hanno spesso qualcosa dei caratteri e delle figure, sono tratteggiate per il
loro temperamento e per il loro ruolo, tendono ad avere dei caratteri esemplari, nel
bene e nel male. Gli avi in generale sembrano muoversi nel mondo degli io, sono
possessori di beni e di cultura, garanti di storia e di memoria, produttori di scrittura,
dotati di sensibilità, di affetti e di percezioni sottili. Ma sono anche ‘individui’, perché
coltivano la propria differenza, e anche ‘persone’ perché, come Enrico Sereni, sono
282
consapevoli della molteplicità di personalità di cui ognuno è composto, e della
necessità di scegliere la personalità che conduce a “quell’unità spirituale” al
raggiungimento della quale “ogni uomo deve dedicare tutte le sue forze”,
rinunciando a ciò che non è “consono al resto” (Sereni 1993, 199): 12
Tagliar via una parte di sé [qui è Clara che parla] per realizzarsi integralmente, darsi legami e
limiti per essere davvero liberi, optare esclusivamente per scelte in sintonia con la propria
personalità: quasi un compendio delle idee che sottendono l’intera cultura ebraica. (199)
Considerazioni che illuminano retrospettivamente anche le osservazioni sulla “vita a
mosaico”, sulla “vita costruita a tessere maltagliate” (Sereni 1987, 165), di cui si parla
nel finale di Casalinghitudine e a cui si è già accennato.
I personaggi sereniani, invece, ad esempio le co-protagoniste de Le merendanze,
hanno tendenzialmente lo spessore di persone e di individui, in quanto
sperimentano le maschere, le scelte, le azioni, riflettono sulle proprie dotazioni,
peculiarità e differenze. Sono consapevoli della propria solitudine, del proprio
dolore, ma si muovono comunque in una comunità. E spesso lottano per la propria
autonomia, difendono e perseguono la propria unicità, la propria separatezza di
esseri individuali, con razionalità o con ironia.
In Casalinghitudine sembrano affacciarsi tutte queste modalità di
rappresentazione, in modo problematico e aperto. Sono tutte evocate e filtrate da un
io narrante a sua volta molteplice, come si è detto, ma le cui tonalità dominanti
sembrano essere la presenza e la persona: presenza alla propria esperienza, e
all’esperienza altrui, e ricerca all’interno di una memoria e di una conoscenza mobili,
creazione di uno spazio dove immaginare e ricostruire il proprio passato e il proprio
presente. Come dice Sereni nella prefazione alla traduzione americana di
Casalinghitudine, il cucinare è il luogo dell’inesattezza, l’unico veramente creativo
della casalinghitudine, “with its gray area that allows space for invention,
modification, appropriation”. 13 Non si ha mai la rappresentazione di un’identità
acquisita, posseduta: l’io di Casalinghitudine è caratterizzato dal non-possesso, non è
un io compiuto e ridotto, come il Self della Rorty, ma incompiuto e molteplice come
una persona e una presenza. La memoria non è un dato, un bene, un patrimonio, ma
qualcosa di cui appropriarsi, qualcosa da rivivere ed esperire, magari attraverso la
scrittura, conservando una sorta di rispetto e di distanza.
L’area dell’io narrante di Casalinghitudine è quindi caratterizzata dalla
responsabilità, dalla scelta, dal giudizio, e al tempo stesso dalla riconquista del corpo,
del presente, del futuro, della narrabilità delle cose. Distanza e presenza si nutrono
reciprocamente.
Il commento della narratrice può essere allora una critica diretta a certe
illusioni o ingenuità di una fase personale e storica, come nel caso della rievocazione
di momenti degli anni Settanta, o una rapida evocazione di frammenti di situazioni
in cui si affacciano personaggi emblematici, o si mostrano tratti di esistenze
individuali, o si evocano presenze fugaci. Ma al tempo stesso può essere anche
283
l’espressione del ‘farsi radice’, del trovare agio e ricchezza in piccoli gesti di cura, nel
manipolare e trasformare il cibo.
Sotto la ricetta della “Parmigiana bianca di melanzane”, ad esempio, sette
donne preparano il piatto per un compleanno. Hanno portato ciascuna un chilo di
melanzane, bianche e nere:
le teglie che entravano e che uscivano dal forno formavano un rapporto, la capacità di essere
insieme e amalgamare le differenze. Fino a tardi le canzoni di lotta: tutto nel ‘75 era senza
ombre e a portata di mano. (Sereni 1987, 125)
Oppure il commento viene espresso direttamente, senza ironia:
La pignatta quasi piena giaceva al centro del tavolo. Si discuteva di politica, avremmo dovuto
parlare di noi. (23)
O, infine, sopravvenuta la crisi, la discussione su un menù di Capodanno è
l’emblema, la ‘figura’ si potrebbe dire citando in questo caso il Barthes dei Frammenti
di un discorso amoroso, 14 di un cambio di anima e di epoca:
Discutevamo di cibo, e sempre i fantasmi di molte altre cose dietro e dentro di noi. (Sereni
1987, 101)
La distanza, lo scarto, possono essere espressi anche attraverso forme di
rappresentazione dello straniamento:
Durante il mese vennero per una giornata mio padre e mia madre, Micol nel porte-enfant
aveva pochi mesi. Avendo sempre amato i gadgets tecnici mio padre si era comprato una
cinepresa; come spesso gli accadeva un amore non ricambiato, sbagliò completamente
l’esposizione e venne fuori un filmino tutto virato e bellissimo: Micol accucciata sulla mia
spalla, un rapporto sospeso in tonalità dall’arancione al rosso, reale perché falsato. (87)
La presenza, invece, si esprime spesso attraverso il cibo. Il cibo è un regolatore dei
rapporti tra le persone, può esprimere un’ampia gamma di rapporti possibili, dal
dono alla violenza. E non riguarda solo i rapporti verticali, tra genitori e figli, ma
anche tra donne, tra sorelle. In Casalinghitudine, la sorella di Clara, Giulia, fa l’arrosto
con le cipolle per la festa di compleanno della sorella. Clara le chiede di farlo un po’
bruciacchiato, come piace a lei. Al momento decisivo:
Non restava che da affettare l’arrosto. Alzai il coperchio e mi trovai di fronte ad una sorta di
tronchetto carbonizzato: per affetto, per insicurezza, per quel diaframma che sempre ci divide,
Giulia aveva preso molto sul serio quella mia voglia di bruciaticcio. Il sugo era salvabile:
Francone tagliò grosse fette di pane casereccio, fu un bellissimo compleanno. (89)
Questo tagliare, distribuire, è il momento iterativo, frequentativo del diario, che
riguarda anche altri atti ricorrenti, elementari, che trovano espressione in frasi non
284
banali reiterate, come “taglio grossolanamente le cipolle” (35; 86), o “Friggo le
melanzane tagliate nel senso della lunghezza” (54; 65), e a volte le operazioni
elementari sono registrate con l’aggiunta di commenti personali e connotativi. In
ogni caso questa registrazione di gesti costituisce la base, che non è mai rituale, bensì
direi ritmica, per ordinare la materia. Il diario di cucina ordina la vita per tipi di cibi,
ma su quest’ordine, su questo sistema si innesta un susseguirsi di atti creativi, una
ricerca di sviluppo e di futuro.
La forma diario, nascostamente, compare anche nell’altro libro che vorrei
esaminare qui, Le merendanze. E a consolidare un nesso tra i due libri c’è anche un
rilievo tematico, ossia la presenza, pagina per pagina, del cibo, che qui è perfino più
ossessiva, come vedremo tra breve. Molto diverso è tuttavia il modo in cui compare il
modello nascosto del diario, e il suo ruolo, perché qui si tratta di un libro che si
presenta esplicitamente, anche se sono fitti i riferimenti autobiografici, come fiction.
Quindi la percezione diaristica interessa direttamente la narrazione: il modo di
registrare gli eventi – anche qui giorno per giorno, momento per momento – e
l’impiego dell’indicativo presente, nonostante l’uso della terza persona, ci
introducono in un susseguirsi di narrazioni brevi, occasionali, scandite, che ci
ricordano quelle del diario. E il diario qui si innesta più esplicitamente in un altro
genere, il racconto breve, perché Le merendanze è un romanzo, ma costruito di fatto
attraverso racconti brevi.
Da questo punto di vista (di genere, ma anche stilistico e ritmico-percettivo),
Le merendanze è accostabile, in parte, a Manicomio primavera e a Eppure, e anche
all’ultimo Il lupo mercante (2007), 15 che offrono raccolte di racconti brevi e brevissimi,
tematicamente affini tra loro, anche se meno consequenziali sul piano narrativo.
In generale gli elementi diaristici che vediamo filtrare nella prosa sereniana
sono:
1) l’uso preferenziale dei tempi del discorso (commentativi) rispetto ai tempi
del racconto (narrativi), per dirla con Weinrich 16 (presente o passato prossimo invece
di passato remoto o imperfetto;
2) la struttura discreta della narrazione (unità narrative brevi e indipendenti,
occasionali, interrotte, frammentarie);
3) la forma ellittica e reticente della descrizione (per momenti significativi e
per scorci inusuali e parziali piuttosto che in forma estesa e compiuta);
4) la rappresentazione di una situazione in fieri che il narratore condivide con
il lettore (il narratore sembra seguire le vicende man mano che si svolgono, come il
lettore, anche quando si tratta di ricordi, che vengono per così dire esperiti nella
scrittura);
5) la prospettiva da cui si osserva legata al vissuto, al presente storico (c’è
sempre un legame alla vita, alle sue urgenze, al momento in cui la scrittura ha luogo);
6) la rappresentazione preferenziale di situazioni domestiche, famigliari,
quotidiane (che diviene anche una modalità di percezione, prettamente femminile –
come Sereni scrive nel Taccuino 17 – attraverso la quale è possibile leggere anche in
modo inconsueto il mondo, l’esterno, la storia);
285
7) il finale aperto.
Naturalmente in ogni opera tali elementi assumono ruoli e forme differenti,
ma particolarmente significativa è la loro evoluzione tra Casalinghitudine e Le
merendanze. In Casalinghitudine la tensione tra tempi commentativi e tempi narrativi è
evidente, e si potrebbe distinguere tra un ‘tempo delle ricette’ e un ‘tempo del
ricordo’. In Le merendanze la tensione si risolve invece a favore di una possibilità di
narrare ormai acquisita: i tempi del ‘mondo commentato’ sono piegati alla facoltà di
narrare, affidati alla terza persona, anche se conservano quell’equilibrio di distanza e
di presenza, tipica dei tempi commentativi, che già caratterizzava – come ho
mostrato – Casalinghitudine. Questa origine, questa metamorfosi sofferta, questa
conquista della narrabilità costituisce secondo me la particolare declinazione
sereniana, nell’ambito della narrativa contemporanea, dell’uso del presente.
Weinrich notava, parlando dei finali delle fiabe iberiche, che il mangiare e il cibo
appartengono a pieno titolo al mondo commentato. 18 E ciò è un indizio della matrice
non certo intellettualistica del ‘commentare’:
Il passato che commento è sempre una parte di me stesso, e proprio perché esso mi riguarda
ancora, lo commento. 19
Inoltre, se in Casalinghitudine del diario era sovvertita la progressione (la
sequenzialità temporale era destrutturata dall’ordine delle ricette e dalla rapsodicità
dei ricordi), in Le merendanze essa è recuperata sul piano narrativo, e la prima persona
è sostituita dalla terza.
In Le merendanze la terza persona ci induce a leggere questa prosa come una
sorta di diario altrui, di ‘autobiografia dell’altro’, non nel senso iper-letterario di
Antonio Tabucchi, 20 ma ad un livello semmai pre-letterario, di intersezione tra la
percezione, il ricordo e la scrittura. E ci viene in mente una definizione di Mario
Lavagetto, 21 che ha chiamato appunto “diario altrui” il diario che il fratello di Svevo,
Elio, teneva sulla vita, le opere e le intenzioni di Ettore. Documento importantissimo,
tra l’altro, per registrare i rapporti del giovane Svevo con la cultura ebraica,
altrimenti passati sotto silenzio. È una modalità di scrittura che si vede all’opera,
proprio per il ritmo e, per così dire, per il respiro della narrazione, anche nel già
citato Il gioco dei regni. In Le merendanze assume la forma di una scrittura diaristica
applicata all’invenzione narrativa, che si sviluppa come diario altrui sulle vite di un
gruppo di co-protagoniste.
In Le merendanze la narrazione si avvale dei deittici temporali e spaziali tipici
del diario, precisi e al tempo stesso reticenti, anticipatori e in medias res, legati per la
massima parte a situazioni e luoghi delle case dei personaggi, a momenti della
giornata, ma anche a luoghi e tempi ‘esterni’. Le parole ‘casa’ e ‘cucina’ (e ‘tavola’,
‘cena’, ‘cibo’, ‘mangiare’, ‘corridoio’) sono preponderanti, ma compare
frequentemente e in passi significativi anche il termine ‘città’ (intensificato con le sue
specificazioni del ‘Duomo’, del ‘Corso’, e di altri luoghi ed emblemi urbani come
vicoli, portoni, scale, o figure simboliche come parroci, sindaci, vescovi, ecc.). Allo
286
stesso modo ‘notte’ e ‘mattina/o’ ‘mezzogiorno’, ‘sera’, le ‘otto’, o altri indicatori di
tempo rendono ancor più evidente l’ancoraggio delle percezioni, delle azioni e dei
pensieri di ciascun personaggio ai momenti della giornata.
Le merendanze si costruisce intorno a un cronotopo comunale, urbano: un
cronotopo che tradizionalmente favorisce la scoperta e la raffigurazione artistica
dell’interiorità, articola e rende più complesso quello che Bachtin chiama il “tempo
biografico”, 22 e pone le basi per la concezione della ‘persona’ in un senso vicino a
quello esposto da Amélie Rorty. È un cronotopo che appartiene al patrimonio della
tradizione letteraria italiana, dantesca, petrarchesca. Ma qui c’è un elemento nuovo:
Laura e Beatrice divengono molteplici, divengono una collettività: Giulia, Laura,
Lucilla, Valeria, Francesca, Caterina, Liuba, Marta, ma si potrebbero aggiungere i
molti altri nomi, quasi sempre femminili, degli ultimi racconti (dopo ‘l’anonimato’
sperimentale di Manicomio primavera) da Eppure a Il lupo mercante. Questo proliferare
di nomi è – questa volta sì – una sorta di genealogia, di genesi, di proiezione del sé,
ma anche un tentativo di lettura dell’altro, di enciclopedia di profili umani. Si tratta
della trasformazione di un modello che ha comunque la funzione di far vivere
frammenti, frammenti che, cercando un loro spazio esistenziale, creano personaggi.
Del diario è assunta una modalità dialogica fondamentale, il suo essere a
ridosso del reale, il suo avere almeno un interlocutore a distanza (il diario stesso, un
altro se stesso, o anche coloro di cui si parla, o, come nelle epistole, coloro a cui il
diario è destinato, più reali e intimi di un astratto ‘lettore’). È un interlocutore a volte
occulto, fittizio o mascherato, ma sempre concreto e storico, ancorato ai giorni. Il
diario diviene quindi strumento di percezione del mondo, di appropriazione dello
spazio-tempo, anche se ne viene sovvertito l’impianto e trasfigurata la forma. Infatti,
sia in Casalinghitudine, sia in Le merendanze, sono abolite le date nella loro funzione
strutturante, e ciò trasgredisce la prima regola del diario secondo Maurice Blanchot:
la necessità di “rispettare il calendario”, 23 di dispiegare la scrittura secondo le sue
scansioni e le sue regole. Se in Casalinghitudine questo ruolo – di organizzazione
dell’ordine del discorso, di dispositio – è assunto dalle ricette, ne Le merendanze è
mutuato non tanto dalla successione numerica dei capitoli, di importanza secondaria
(in quanto non marcata né sul piano semantico né su quello formale), quanto dalla
presenza di motivi ossessivi ricorrenti e dal succedersi delle storie delle coprotagoniste, che suddividono la materia in blocchi narrativi individuali.
Sereni ricorre a un dispositivo narrativo ed espositivo – una forma di
dispositio – che permette di aggiungere un’ulteriore notazione sui generi. In Le
merendanze, come in Casalinghitudine, oltre alla presenza generativa del diario e del
racconto breve, vediamo all’opera un altro modello, di tipo enciclopedico,
determinato dalla necessità di destrutturare la narrazione, l’ideologia, il mito,
l’identità stessa e la favola della ‘storia’ in una serie di tratti parziali, di illuminazioni
e di piste indipendenti. Il modello del diario è sempre contaminato dal modello
enciclopedico, da un ordinamento che sostituisce o affianca a una progressione
crono-logica un criterio di altro tipo, alogico o tematico.
287
In Le merendanze l’incipit è, come in Casalinghitudine, culinario, e solo apparentemente
pulp:
Il grosso coltello cala con regolarità sulla fetta di filetto, spessa e sanguinolenta. Tanti colpi
fitti, netti, prima in orizzontale, poi in verticale. Arrivata al margine, lì dove una minuscola
scaglia di grasso macchia appena di bianco il rosso compatto della carne, Giulia fa ruotare di
quarantacinque gradi quasi esatti il tagliere, in modo che anche i colpi sulle diagonali cadano
precisi, e nessuna fibra sfugga al suo destino. (Sereni 2004, 9)
È un brano che mostra subito, in apertura di libro, qual è il modo di descrivere e di
narrare, la qualità dello sguardo su azioni meticolose e ossessive, uno sguardo che
non vuole perdere nulla di una sorta di sapere del corpo e del keeping house. 24 Qui
tuttavia, a differenza che in Casalinghitudine, la narrazione si impossessa sempre della
descrizione, o la descrizione è di per sé narrazione: non sono mai momenti separati, e
questo è anche un indizio dell’evoluzione della scrittura sereniana.
I cibi rimangono il criterio ordinatore anche di questo tipo di diario altrui, ma
si accompagnano a una serie di altri elementi che destrutturano ulteriormente la
linearità apparente della narrazione. Mi riferisco alla comparsa di motivi ricorrenti e
ben delineati che svolgono il ruolo che la scansione per ricette svolgeva in
Casalinghitudine. Qui però la modalità di funzionamento è anche più elaborata e
complessa. In Casalinghitudine la composizione era affidata a una suddivisione per
categorie, dalle pappe ai dolci, che stabiliva una connessione analogica tra
progressione del giorno e ontogenesi dell’individuo. In Le merendanze la modalità del
funzionamento del testo è affidata alla ricorrenza e alla combinazione di alcuni
motivi che un’analisi dei campi semantici può suffragare (oltre al cibo, il potere,
l’ordine, il pulito, il dono, la cura, il senso di vuoto, il senso di frantumazione, il
disagio, la paura, la coscienza di genere, i genitori, i figli, la casa, eccetera). Tali
motivi costellano ossessivamente la narrazione, disponendosi in successione e
collassando a tratti, costituendo dei veri e propri addensamenti tematici: connessi tra
loro, il cibo, l’ordine, il pulito, il potere, ecc., divengono messa in scena, “campo di
battaglia” (Sereni 2004, 82) di rapporti con i figli, i genitori, altre donne, altri
uomini). 25 Quando questi addensamenti tematici hanno luogo si crea una sorta di
emergenza narrativa che rivela una tensione profonda, a volte irrisolvibile, a volte
generatrice di uno slancio vitale verso una situazione nuova.
La loro risonanza profonda è data dal fatto che si tratta in realtà della
rappresentazione di universali antropologici, anche nei loro legami reciproci, come
ad esempio quello tra la sporcizia e la paura messo in luce da Mary Douglas. 26 Ma se
vogliamo trovare una delle peculiarità della presenza ricorrente di tali universali
antropologici in Clara Sereni ci dobbiamo scostare dall’analisi della Douglas. Le
pratiche e i saperi legati alla casa, alla cura, all’ordine e alla pulizia non sono mai in
Sereni forme rituali. In Le merendanze la loro funzione emerge con chiarezza: non è
rituale, ma – come ho già detto – ritmica ed euristica. I gesti ricorrenti hanno solo in
minima parte un ruolo di autoriconoscimento di tipo sedativo. Sono invece atti molto
più dispendiosi, che mettono in gioco il corpo, più che risparmiarlo. Hanno a che fare
288
con il dono e la creatività, implicano una perdita nel momento stesso in cui creano
valore aggiunto. 27
Questa contiguità con il corpo – che accomuna secondo me Clara Sereni e
Primo Levi – è un elemento fondamentale della scrittura sereniana, e influenza anche
la visione della storia, il legame tra le generazioni e il rapporto con le proprie radici.
La storia che si affaccia nei libri di Clara Sereni è sempre a misura umana, riguarda
sempre tre o quattro generazioni, ossia le generazioni effettivamente conoscibili da
un singolo individuo. E la sua attingibilità, la sua narrabilità richiede sempre la
mediazione dell’immaginazione:
Il prima, quel nucleo nascosto che pure esiste da qualche parte dentro di me, posso solo
immaginarmelo, raccontarmelo come una fiaba. (Sereni 1987, 49)
La forma diario in fin dei conti cerca di ricostruire un discorso frammentario, di dare
narrabilità a nuclei profondi che altrimenti sarebbero inesprimibili. E a questo fine
concorrono anche il ricorso alle forme brevi e alle forme enciclopediche: sono un
tentativo (riuscito) di conquistare il racconto. In fondo questa è la strada che ha
percorso anche Primo Levi. Penso all’importanza del racconto breve, dalle Storie
naturali in poi, e a una forma esemplarmente ‘enciclopedica’ come Il sistema periodico.
Ma a ben guardare entrambe le forme interessano il tessuto stesso di Se questo è un
uomo, composto di racconti autonomi, e rubricati per temi.
Gli universali antropologici scavano nel profondo dell’animo umano,
assumono valore di cronotopi assoluti, nel bene e nel male. La cucina, la casa,
divengono i luoghi dove si combatte la battaglia tra l’entropia e il racconto, la
distruzione e la vita. Anche il ben più atroce Lager è un cronotopo della
contemporaneità; anche l’olocausto diviene un universale umano.
C’è un aspetto terapeutico della scrittura, che accomuna Levi e Sereni. Ma è un
aspetto che costituisce la negazione – o l’attenuazione – dell’affermazione di Michel
de Certeau, secondo cui “bisogna morire nel corpo [come presenza] perché nasca la
scrittura”. 28 Qui il corpo è l’unità di misura, il punto di partenza (il corpo
sopravvissuto) della ‘storia’, in tutti i sensi. Anche il passato non è allontanato e
separato dal presente, non è freudianamente denegato e riemergente, ma cercato e
frequentato nella scrittura per una necessità interna. Anche questo è un elemento di
contatto tra Sereni e Levi (che era come noto refrattario alla psicoanalisi perché in
qualche modo troppo contiguo al grado zero della sofferenza, all’inconscio reso
mostruosa realtà). Proprio su questa linea terapeutica della scrittura, nella
consapevolezza della sofferenza, di un dolore ai confini dell’umano, che impedisce
ogni relazione con l’altro, 29 si innesta il rapporto di Clara Sereni con le proprie radici
e con la generazione che ha vissuto l’olocausto, con gli appartenenti a quella che
Stuart Hughes chiamava “età d’argento” dell’ebraismo italiano (“Silver Age”). 30 Si
tratta di fare i conti con la narrabilità. È un dialogo esistenziale ma anche letterario,
che riporta quelle esistenze nel presente. Levi è tolto dalla Auschwitz-Literatur e
riportato a noi. Mettere le mani nella materia (mater), con la chimica o con la cucina, 31
289
diviene metafora generativa della scrittura e fattore di sperimentazione. E in un certo
senso Sereni va oltre Levi, perché la terapia è in qualche modo consapevole
dell’incurabilità. Non in senso ontologico (di questo tipo di incurabilità era convinto
anche Levi), ma in un senso più aderente alla vita, alla molteplicità e multiformità del
presente, irto di impossibilità e di mondi ‘altri’. Nonostante questo, la scrittura
sereniana è in grado di restituire la gioia e la risata, e ciò rende più forte – ma anche
più allegra – la coscienza della necessità di una resistenza continua, che inventa
sempre nuovi modi di narrare e di comprendere.
NOTE
Sereni 1998a, 12. Ringrazio Marina Hassan e il Centro di Documentazione Ebraica di Milano per
l’assistenza durante la stesura di questo saggio.
1
2
Sereni 1998b, 22.
3
Sereni 1993, seconda di copertina.
4
Sereni 1994, 101-125.
5
Cicioni 2004, 86-99.
6
Asor Rosa 2007, iii.
7
Kolsky, 1997, 47.
In Passami il sale, opera strettamente legata a Casalinghitudine, di cui costituisce quasi un
completamento, l’immersione nella cucina (in particolare “la preparazione del sartù di riso: una delle
elaborazioni più lunghe, articolate e rare di tutta la mia cucina”) è il momento “per ricominciare a
imparare il tempo, i gesti, la cura” (Sereni 2002, 246).
8
9
Menozzi 1994, 220.
Sulla frammentazione come strumento di auto-rappresentazione di genere e di messa in discussione
dell’identità si sono soffermate Cicioni & Walker 2000.
10
11
Rorty 1976, 301-323.
12
È un brano di Enrico Sereni (Sereni 1932) del 30 maggio 1927.
13
Miceli 2005, vii.
14
Barthes 1979, 5.
15
Sereni 2007, 190.
16
Weinrich, 2004.
17
Sereni 1998a, 40.
18
Weinrich 2004, 72.
19
Ibidem, 123-124.
20
Tabucchi 2003.
21
Lavagetto 2004, xiv.
22
Bachtin 1979, 277.
290
Blanchot 1969, 187. Regola che per Blanchot mette lo scrivente e la scrittura “sotto la protezione dei
giorni comuni”, permette di affidarsi alla “regolarità felice” del giornaliero, proteggendosi anche dalla
scrittura stessa (187; 189). In Sereni, anche se non manca la funzione protettiva di certe scansioni
(ricette, luoghi, persone), le funzioni prevalenti sembrano quella terapeutica, quella euristica e quella
creativa. Come scrive Sereni “La casalinghitudine è anche un angolino caldo”, e quell’anche è
estremamente significativo (Sereni 1987, 165).
23
24
È il titolo della già citata traduzione americana di Casalinghitudine.
Si vedano questi esempi, per limitarsi ai passi in cui la convergenza ha luogo nella stessa
proposizione, anche se a ogni pagina se ne possono trovare: per il binomio cibo-figli (10, 31, 67, 83);
per quello ordine-genitori, o potere-genitori (29, 56, 66, 82); per quello ordine-figli, o potere-figli (81,
181); per quello ordine-cibo-potere-colpa-spreco-altri uomini-altre donne (143, 153, 198).
25
26
Douglas 1975.
27
Pellizzi 2008.
28
De Certeau 2006.
“Può darsi che lo abbia fatto soffrire: come altre volte ero troppo impegnata nella mia sofferenza per
essere capace di occuparmene” (Sereni 1987, 88).
29
30
Hughes 1983.
31
Già su alcune affinità e differenze tra Levi e Sereni si era soffermato Kolsky 1997, 53 e ss.
BIBLIOGRAFIA
Asor Rosa, Alberto. Prefazione alla nuova edizione de Il gioco dei regni. Milano: BUR, 2007. iii-ix.
Bachtin, Michail. ‘La forma del tempo e del cronotopo nel romanzo’. Estetica e romanzo. Traduzione di
Clara Strada Janovič. Torino: Einaudi, 1979.
Barthes, Roland. Frammenti di un discorso amoroso. Traduzione di Remo Guidieri. Torino: Einaudi, 1979.
Blanchot, Maurice. ‘Diario intimo e racconto’. Il libro a venire. Traduzione di Guido Ceronetti & Guido
Neri. Torino: Einaudi, 1969.
Cicioni, Mirna. ‘Better Losers than Lost: Self, Other and Irony in Clara Sereni’s Autobiographical
Macrotext’. Reconfiguring Italian Identity: Women Writing Lives, a cura di Susanna Scarparo and Rita
Wilson. Newark: U of Delaware P, 2004. 86-99.
Cicioni, Mirna & Susan Walker. ‘Picking Up the Pieces: Clara Sereni’s Recipes for Survival’. Novel
Turns Towards 2000. Critical Perspectives on Contemporary Narrative Writing from Western Europe, a cura
di John Gatt-Rutter. Voz Hispanica (2000): 35-47.
De Certeau, Michel. La scrittura della storia. Traduzione di Anna Jeronimidis. Milano: Jaca Book, 2006.
Douglas, Mary. Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù. Traduzione di Alida
Vatta. Bologna: Il Mulino, 1975.
Hughes, Henry Stuart. Prigionieri della speranza. Alla ricerca dell’identità ebraica nella letteratura italiana
contemporanea. Traduzione di Valeria Lalli. Bologna: Il Mulino, 1983.
291
Kolsky, Stephen. ‘Clara Sereni’s “Casalinghitudine”: The Politics of Writing. Structure and
Intertextuality’. Italian Quarterly 133-134 (1997): 47-58.
Lavagetto, Mario. ‘Il romanzo oltre la fine del mondo’. Introduzione a Italo Svevo, Romanzi e
“continuazioni”. Milano: Mondadori, 2004. xi-xc.
Menozzi, Giuliana. ‘Food and Subjectivity in Clara Sereni’s “Casalinghitudine”‘. Italica, 71 (1994): 217227.
Miceli Jeffries, Giovanna, e.a. ‘Preface’. Keeping House: A Novel in Recipes. Traduzione di Giovanna
Miceli Jeffries & Susan Briziarelli. Albany: State U of New York P, 2005. 1-19.
Pellizzi, Federico. ‘Il dono e il racconto. Per una lettura bachtiniana dello scambio simbolico’.
L’immagine riflessa, 2008.
Rorty, Amélie Oksenberg. ‘A Literary Postscript: Characters, Persons, Selves, Individuals’. The
Identities of Persons, a cura di Amélie Oksenberg Rorty. Berkeley-Los Angeles-London: U of California
P, 1976. 301-323.
Sereni, Clara. Sigma Epsilon. Venezia: Marsilio, 1974.
---. Casalinghitudine. Torino: Einaudi, 1987. Keeping House: A Novel in Recipes. Traduzione di Giovanna
Miceli Jeffries & Susan Briziarelli. Albany: SUNY Press, 2005.
---. Manicomio primavera. 1989. Firenze: Giunti, 1993.
---. Il gioco dei Regni, Firenze: Giunti, 1993; Milano: BUR, 2007.
---. ‘Diario’. Bossi Fedrigotti, Isabella e.a. Mi riguarda. Roma: e/o, 1994. 101-125.
---. Eppure. Milano: Feltrinelli, 1995.
---. Da un grigio all’altro. Roma: Di Renzo, 1998a.
---. Taccuino di un’ultimista. Milano: Feltrinelli, 1998b.
---. Passami il sale. Milano: Rizzoli, 2002.
---. Le merendanze. Milano: Rizzoli, 2004.
Sereni, Enrico. Dai diari e dalle lettere di Enrico Sereni (1914-1930). Roma: Casa Editrice Alberto Stock,
1932.
Tabucchi, Antonio. Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori. Milano: Feltrinelli, 2003.
Weinrich, Harald. Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo. Traduzione di Maria Provvidenza La Valva e
Paolo Rubini. Bologna: Il Mulino, 2004.
292
NEZRI-DUFOUR, Sophie. ‘Alessandro Piperno: una visione iconoclasta dell’ebraicità’.
Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero
Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht:
Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978-90-6701-017-7. 293302.
RIASSUNTO
Uno degli eventi letterari italiani del 2005 fu l’uscita del romanzo Con le peggiori intenzioni di
Alessandro Piperno. Questo romanzo, che narra la saga di una ricca famiglia ebrea romana, è
esemplare della nuova stagione della letteratura ebraica italiana: evidenzia un rapporto esplicito e
liberato, senza complessi, dello scrittore ebreo con l’universo ancestrale. Con l’irriverente Piperno,
siamo ben lontani dai pudici Svevo, Bassani e Primo Levi, la cui scrittura dell’identità era piena di
ritegno e di sottintesi, cioè intimista, confidenziale; con il nostro, l’‘ebraicità’ ‒ più che l’ebraismo ‒
diventa una realtà culturale e sociologica che egli si riappropria, analizzandola e criticandola con una
libertà di tono e un’ironia talvolta sarcastica che si riscontra solo nella letteratura ebraica americana a
cui si ispira abbondantemente. Piperno ‒ secondo taluni il nuovo Philip Roth italiano ‒ ci offre difatti
una riflessione iconoclasta sulla realtà e l’identità ebraica italiana odierna (la Shoà, la memoria, Israele,
l’assimilazione) sulle quali costruisce il suo personalissimo edificio identitario. Pur affermandosi in
quanto ebreo ‒ benché non lo sia secondo la legge mosaica ‒ e dando voce con fierezza alla sua
ebraicità, dissacra l’universo dei padri, magari nell’intento di inserirvisi più facilmente e anche di
integrarlo meglio alla realtà italiana di oggi: se i suoi ebrei sono umani, troppo umani, è anche perché
devono uscire dal ghetto e rivelare la loro dimensione universale: gli ebrei italiani sono cittadini come
gli altri, parlarne con ritegno non ha più senso. È perciò interessante studiare la posizione di Piperno
tra fedeltà e trasgressione, considerare la natura della sua ebraicità, che certi hanno ritenuto
superficiale, poco interiorizzata, anzi caricaturale e ‘commerciale’ ‒ forse è vero? ‒ ma che ha almeno il
merito di affermarsi senza vergogna.
PAROLE CHIAVE
Ebraicità, dissacrazione, liberazione, costruzione identitaria, affermazione culturale
© Gli autori
Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio
generazionale (Utrecht-Amsterdam, 5-7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana
ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata
da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. ISSN 1874-9577
(http://www.italianisticaultraiectina.org).
293
ALESSANDRO PIPERNO
UNA VISIONE ICONOCLASTA DELL’EBRAICITÀ
Sophie Nezri-Dufour
Université de Provence
Il clamoroso romanzo di Piperno, Con le peggiori intenzioni (2005), presenta una
visione dell’ebraismo e dell’ebreità 1 che non può essere ignorata da chi si interessa
allo stato attuale della letteratura ebraica italiana. Al di là delle sue qualità letterarie,
reali o no, o della sua volontà di fare scandalo, c’è, nel suo romanzo, un trattamento
dell’ebraitudine invadente e per questo centrale, che non può lasciare indifferente.
Il registro che sceglie Alessandro Piperno per proporre indirettamente la sua
riflessione su un’identità ebraica problematica, vissuta attraverso tre generazioni, e
soprattutto dal suo alter ego Daniel Sonnino, giovane Woody Allen italiano, è
decisamente umoristico, anzi sarcastico.
Per sottoporre al lettore interrogazioni che gli stanno a cuore, come si indovina
in filigrana senza che mai lo confessi, l’autore sceglie l’autoderisione,
l’autoflagellazione. Il suo è un racconto che, per molti aspetti, è una vera
tragicommedia, molto lontano dal buonismo, ispirandosi piuttosto a un umorismo
crudele, feroce.
La sua visione dell’ebraismo del dopo-Shoah si iscrive in una linea di
trasgressione anticonformista voluta, sistematica. Apparentemente, Piperno rifiuta
ogni pathos e tratta i suoi personaggi con umorismo demistificante, anche se dietro la
sua causticità si nasconde, come vedremo, un reale affetto per le sue radici mosaiche.
Rapidamente ci si rende conto difatti che l’argomento dell’identità ebraica è
tanto più importante per l’autore quanto più egli cerca di ostentare nei suoi confronti
un notevole distanziamento, un’oggettività estrema al limite della crudeltà. Non è un
caso che i suoi numi tutelari siano Saul Bellow e Philip Roth. Quest’ultimo diventa
per il giovane scrittore un vero modello che non esita a plagiare ostensibilmente.
Il protagonista somiglia stranamente a quello del Lamento di Portnoy: antieroe
erotomane, il suo onanismo (Piperno 2005, 72-73) e i suoi rapporti problematici con la
sua identità ebraica sono riferimenti diretti allo scrittore ebreo americano, senza
dimenticare la dilettazione con la quale Piperno diventa il cantore iconoclasta della
borghesia ebraica di Roma. La sua vena ironica e autoironica, caustica e tagliente,
comporta una palese impronta ebraico-americana.
Con Piperno la provocazione, l’irriverenza, la spudoratezza sono quasi delle
condizioni sine qua non per spettacolarizzare e mettere a nudo, senza alcun rispetto,
un universo ebraico che egli offre in pasto al lettore poco abituato, in Italia, a vedere
negli scrittori ebrei una tale disinvoltura, una tale assenza di rispetto, di pietas e di
interiorità.
294
Fin dall’epigrafe al testo c’è la presenza di un umorismo nero usato abitualmente
dagli ebrei americani e askenaziti. Un umorismo totalmente assente dalle pagine di
un Bassani o di un Primo Levi, che annuncia al lettore la piega che Piperno desidera
dare al suo racconto e alla sua riflessione:
Céline raccomanda di sterminare gli ebrei come batteri. E’ il dottore che c’è in lui, suppongo
[…]. (Piperno 2005, 7)
scrive egli, ispirandosi a un motto di Bellow. Fin dall’inizio, l’intonazione del
racconto è data. La riflessione sull’identità ebraica sarà centrale ma il lettore deve
capire che l’autore non userà un tono grave, tanto meno disperato.
Nello stesso senso, si può dire che il suo eroe, o piuttosto antieroe, sperimenta
una vera Bildung mancata: con la sua identità sfuggente – non è né completamente
ebreo, né tanto meno cristiano – il protagonista-narratore si rivela vittimista,
narcisista, affetto da enormi complessi d’inferiorità. Egli ha una vita fatta d’invidia,
di rimorsi e di presunte vendette e si nota in lui un’assenza totale di dignità, di valori
saldi e d’integrità: incapace di farsi responsabilmente adulto è inetto, perdente,
totalmente immaturo. Si definisce perfino una “screditante pubblicità al popolo
ebraico” (Piperno 2005, 210).
Il suo rapporto con l’identità ebraica è per lo meno problematica e Piperno non
esita a mettere in scena il famoso odio di sé, tipico di certi ebrei, che il lettore non
riesce a capire se sia sincero o no. La descrizione del padre del protagonista per
esempio è realizzata in modo tale che, se non ci fosse ironia, quell’autoironia
caratteristica dell’umorismo ebraico, incanterebbe un antisemita:
La barba bianco-bionda toccava quasi il petto sporgente, mentre il naso aveva l’ebraica
spudoratezza che faceva pensare agli askenaziti sterminati quarant’anni prima dai nazisti o a
certi dandy ebrei che infestavano i salotti viennesi ai tempi della Felix Austria. (Piperno 2005,
95)
Come vediamo, è per mezzo della provocazione e soprattutto dell’umorismo di
secondo grado che Piperno ricrea un universo ebraico di cui si sente però l’erede
diretto. Evocando la grande epoca ‘alla Grande Gatsby’ del nonno Bepy, confessa di
sentirsi
parte di qualcosa di più grande di [lui], una sorta di ultimo discendente di questa famigliatribù, di questi nani, rancidi bizantini alla mercé della loro ultima stagione, questi gagà
semiebrei scampati allo sterminio. (Piperno 2005, 42-43)
Piperno si sente perciò, nei loro confronti,
un bilioso curatore testamentario […] uno di quegli etilisti pellerossa che bivaccano nelle
sempre più anguste riserve americane nel culto e nel vagheggiamento di tempi che non possono
più tornare. (42-43)
295
In Piperno, il sarcasmo non è dunque mai privo di tenerezza, o di nostalgia, come se
l’autore usasse l’ironia per non intenerirsi troppo. Del resto, egli riesce a creare una
pittoresca galleria di personaggi ebrei che, malgrado le loro debolezze e tare, sono
piuttosto simpatici. Ma è vero che essi hanno atteggiamenti criticabili: sono
totalmente amorali, pieni di vizi, frivoli, dissoluti, ossessi sessuali e cupidi, il che
lascia talvolta un certo malessere perché l’autore sembra ridurre spesso, anche se si
tratta ancora di ironia, l’essere ebreo all’essere ricco e sessuomane. Piperno è sempre
sul filo del rasoio, e questa situazione ambigua, che smarrisce il lettore, è da lui
voluta.
Lo scopo del giovane scrittore ebreo è quello di affermare la sua indipendenza
nei confronti di una letteratura ebraica italiana tradizionale, che tendeva a creare
personaggi ebrei globalmente positivi. Qui, tutt’al contrario; il nonno Bepy
rappresenta l’antitesi dell’etica ebraica: disinvolto
pazzo, eccessivo, asso nell’arte dello scherno e della dissimulazione. Una creatura forgiata dal
ventennio fascista addolcita da un’overdose di causticità e humour repubblicano. (Piperno 2005,
21)
Del resto, la tonalità generale si ispira spesso alla farsa e al grottesco che ritroviamo
in certe storielle ebraiche: molti brani si ricollegano difatti a quell’umorismo fatto di
autoironia e di derisione insieme eccessiva e surrealista. Basta pensare a certe pagine
in cui sotto la dimensione comica si nascondono interrogativi e problemi sociologici
che riguardano l’ebraismo.
Il lettore non potrà difatti dimenticare il nonno Sonnino, per nulla praticante,
ma che si offende perché ha visto il rabbino comprare due panettoni durante il
periodo di Natale:
’Dove sta scritto che un rabbino non possa comprare il panettone?’
‘Un rabbino deve dare l’esempio…’
‘Non ti ha sfiorato che potesse essere un panettone kasher?’
‘Ada, sto parlando seriamente…’
‘Trovami una sola interdizione – una!- che vieti a un ebreo d’acquistare un panettone.’
‘E allora perché non il presepe? È scritto da qualche parte che un ebreo non possa fare il
presepe?‘
‘E allora tu dimmi chi ti dà la certezza che volesse mangiarlo?’
‘Pensi lo abbia preso per soprammobile?‘. (Piperno 2005, 4)
E l’io narrante aggiunge, con ironia affettuosa, in cui si nasconde male un certo
orgoglio:
Da notarsi come i Sonnino ebraicamente prediligessero la dimensione interrogativa rispetto a
quella asseverativa tipicamente cristiana. (14)
Non manca nemmeno il brano farsesco legato alla tematica della presunta cupidità
ebraica, in cui il nonno chiede alla moglie cosa chiederebbe a Picasso se lo
296
incontrasse:
Bah, probabilmente gli chiederei un prestito! (15)
Il romanzo è pervaso di brani in cui l’umorismo tipicamente ebraico, che rasenta il
grottesco, sottolinea lo stato ambiguo e tavolta poco comodo dell’ebreo diasporico.
Una scena centrale del romanzo è difatti quella del funerale del nonno in cui, benché
ci sia tanta gente, non ci si riesce a riunire dieci adulti ebrei per costituire un minian,
indispensabile alla cerimonia:
Solo alle soglie del kaddish ci si accorge che tra i convenuti ci sono soltanto nove ebrei adulti. Ne
manca uno per comporre il minian, numero minimo di dieci maschi adulti per poter eseguire le
funzioni. Mio fratello e io siamo esclusi, non essendo ebrei. Mio padre e mio zio sono costernati,
mentre il rabbino Perugia […] torna a fare la conta nella speranza di trovare qualcuno che abbia
i requisiti. Ma lo spettacolo è […] all’occhio d’un vero ebreo, avvilente: una banda di marrani,
convertiti, sangue misto a iosa, atei d’estrazione marxista […]. (43)
Piperno evoca allora, sempre con tono sarcastico, che l’indegno Bepy è stato vittima
del proprio desiderio d’assimilazione e della sua volontà di allontanarsi dai suoi
“austeri patriarchi ebrei”. Non è sorprendente, e qui la farsa continua, che il vecchio
Debenedetti, che sta arrivando nel cimitero, rifiuti di unirsi al gruppo degli ebrei per
formare lo sperato minian (44).
La farsa prosegue quando lo stesso Daniel, la cui madre è cristiana, il che gli
impedisce secondo la legge ebraica di essere ebreo, propone la sua partecipazione al
minian:
È ora di farsi avanti! Mi intima imperiosamente una voce interna. ‘Ci sono io!’ azzardo, e lo dico
con un insorgente orgoglio.
Quale il risultato? Suo padre si piega letteralmente in due, sghignazzando come un matto. (45)
Attraverso questa scena, innegabilmente comica, Piperno sottolinea l’esistenza di una
vera realtà sociologica, oggi in Europa, per cui numerosissimi giovani, figli di padre
ebreo e di madre cristiana, non sono riconosciuti dalla loro comunità come ebrei,
vivendo un micro-dramma identitario, da cui è difficile uscire indenni:
Mio padre è stato chiaro. Tu non sei ebreo! Non è la prima volta che se ne esce così […] che mi
insulta in questo modo […]. Un’esecrabile corruzione nel DNA stava sfrattando un povero
bambino di dieci anni dal suo spicchio di eternità! […] devo ingoiare questo rospo assurdo:
semplice cruda verità storica: Tu non sei ebreo! […] Questa è semplicemente la tua condanna:
essere ebreo per i gentili e gentile per gli ebrei! Né c’è da stupirsi che qualcuno, benché ancora
adolescente, desideri ardentemente essere ebreo. Non c’è da sbalordirsi che un bambino voglia
essere come suo padre. Un ebreo come tanti altri. (46-47)
aggiunge con ironia.
Ma lo sappiamo, Piperno rifugge da ogni sentimentalismo e pathos e circonda
questa scena da una dimensione insieme grottesca e spietata. Del resto, l’umorismo
297
diventa lo strumento privilegiato di Piperno per sottolineare situazioni incontrate
dagli ebrei di oggi che possono rivelarsi talvolta surrealiste o assurde. Basta pensare
al brano ancora qui farsesco in cui i fratelli Sonnino, Daniel e suo fratello, sono
attratti da due giovani tedesche: una è la sosia di Eva Braun, l’altra è una vera
transfuga della gioventù hitleriana. (118).
I contatti tra l’universo ebraico e quello cristiano sono difatti, in Piperno, fonte
di problemi, come se l’assimilazione, che Piperno è proprio l’ultimo a denunciare,
provocasse problemi insuperabili. Pensiamo a questo proposito al brano insieme
patetico e comico del padre di David Ruben, Amos, soggetto improvvisamente a
coliche renali quando la moglie, pure ebrea anche lei, festeggia Natale con un enorme
tacchino:
Giace, come Marat, nella grande vasca del bagno […] nudo, sofferente, la testa reclinata
all’indietro. [Però] lo spettacolo deve continuare. Né bisogna vanificare il sacrificio mortale del
tacchino. (176-177)
aggiunge Piperno, con un’ironia tinta di pietà.
Allo stesso modo, quando finisce la tragicommedia di Daniel con l’amata Gaia,
che egli minaccia pateticamente di morte, l’io narrante usa un tono tanto più
sarcastico che si tratta ancora qui di un appuntamento mancato tra l’universo ebraico
e quello cristiano, in fin dei conti molto antagonisti nelle pagine piperniane:
Questa è la storia del secondo ebreo giustamente crocifisso da un’oligarchia di romani […] dopo
la quale non sarei potuto risorgere. (Piperno 2005, 223)
Il lettore abituato alla misura, alla dignità e all’interiorità che caratterizza una gran
parte della letteratura ebraica italiana capisce bene che, con il suo romanzo, Piperno
tenta di realizzare una svolta profonda. Vuole saltare il simbolico fosso del passato e
far uscire la letteratura ebraica italiana dalla sua dignitosa roccaforte, dai suoi
sottintesi codificati e intimisti, e dal suo rifugio nella memoria e nel ricordo
mitizzante.
Le sue pagine sono un tentativo di segnare la fine del trauma della Shoah e della
mitificazione degli anni neri della comunità ebraica della Penisola. Con Piperno, si
assiste alla fine della cristallizzazione di un passato tragico. Egli vuole opporsi, come
dice, ai presunti ‘mausolei della memoria’, alleggerire la letteratura ebraica dalla
carica del pathos. Provocatore, parla perfino della tradizione ‘paludata’ della
letteratura ebraica italiana. 2
Quali sono le sue peggiori intenzioni? Sembra voglia umanizzare gli ebrei,
sottrarli a quella retorica che li ha resi martiri sacrificali. Per quale ragione? Forse per
dare una nuova vitalità e un avvenire alla letteratura italoebraica contemporanea che
non può indefinitamente parlare della Shoah. Evidentemente, Piperno è stato molto
malaccorto nel parlare di “cultura di piagnistei”, ispirandosi alla dichiarazione di
Amos Oz e alla necessità di arrivare “alla liberazione dall’eterna umiliazione degli
ebrei della Diaspora”, ripetendo le parole di un altro israeliano, David Grossman. 3
298
Lia Levi, con ragione, gli ha chiesto indirettamente ma in modo molto pertinente se
“i libri di Primo Levi e di Jean Amery sono forse umilianti e umiliati?” La cultura dei
piagnistei sarebbe forse quella che ha affrontato i più specifici temi della Shoah? 4
Ciò che ha voluto dire Piperno maldestramente o piuttosto provocatoriamente è
forse che è necessario metter fine alla figura dell’ebreo italiano vittima. Nelle sue
pagine si sente il bisogno di affermare un’identità ebraica ottimistica che si svela
qual’è, senza vergogna, senza tabù né falsi pudori: forse il suo scopo segreto è, in
qualche modo, quello di mettere un po’ di disordine in una tradizione per
mantenerla viva, come pensa abbiano fatto gli scrittori israeliani ai quali ha reso, sui
giornali, un ardente omaggio, apprezzando in loro la volontà di creare “donne e
uomini che non siano stereotipi di maniera ma persone in carne e ossa dotati di istinti
forti, di debolezze tragiche” (Piperno 2006).
Il suo rifiuto del registro memoriale ancorato nella tragedia sbocca perciò in un
nuovo rapporto con i lettori italiani, un rapporto forse più fiducioso, più
banalizzante: l’ebreo non è un mito storico o biblico ma un italiano particolare,
interessante da conoscere, ma come tutti gli altri, umano, talvolta troppo umano. Si
potrebbe dire che Piperno si situi all’opposto di un criptoebreo intimista e discreto
come Svevo. L’ebreità piperniana è ostentata, largamente divulgata. Con il giovane
scrittore romano, l’universo ebraico italiano perde perciò la sua dimensione finora un
po’ mitica e i suoi temi storici privilegiati per inserirsi meglio nella realtà sociologica
italiana globale, anche se la riflessione sulla Shoah rimane presente, anzi ricorrente.
Ma non si tratta più di una resa dei conti storica, bensì di un’analisi sociologica.
Il nonno Bepy ha difatti vissuto la Shoah e fa parte dei salvati, come spiega l’io
narrante, riferendosi a Primo Levi. Ma non è un salvato tradizionale. È, si potrebbe
dire, un anti Primo Levi; non si sente colpevole di essere sopravvissuto, al contrario,
è convinto di essere in perenne credito con la vita, cerca di dimenticare gli anni neri
e, peggio, i parenti deportati:
Era come se quella spaventosa clownesca coppia di dittatori fascisti [Mussolini e Hitler] non
fosse mai esistita, come se […] essa fosse stata sepolta insieme alle carcasse indistinte delle
centinaia di parenti deportati […] di cui era severamente vietato parlare e della cui fine
nascostamente si vergognava. Cancellati […] dalla memoria dei congiunti sopravvissuti: come
se i loro stracci e le loro magrezze infernali, le loro morti senza identità […] fossero inadatte allo
scintillio delle argenterie o al brio euforizzante dei cocktail di quegli anni fantastici. (Piperno
2005, 16)
Con ironia sarcastica e dura il narratore ci svela questa realtà raramente evocata:
spiega che l’inferno della Shoah aveva provocato nella sua famiglia una vera
rimozione del passato. Malgrado la tenerezza di Piperno per i suoi personaggi, qui la
sua denuncia è evidente: parla al loro proposito di “frivolezza […] imprudenza […]
disinteresse per l’altrui punto di vista […] ottimismo che sconfina
nell’irresponsabilità” (17).
Vediamo bene che Piperno desidera evocare una realtà sociologica tabù ma
reale e ben comprensibile, senza pure giustificarla. Questa realtà è tanto più tabù che
299
la rimozione del passato da parte del nonno del narratore e di altri salvati è
all’origine di un vero decalogo iconoclasta e edonista, una nuova religione, blasfema:
“I nazisti volevano accopparmi per ragioni che a tutt’oggi ignoro”, dichiara il nonno.
L’ho sfangata. E [sono] abbastanza giovane per ricominciare daccapo. Non chiedetemi come
né perché. Non sono un tipo con le riposte in tasca. Griderò la mia felicità. Santificherò la
mia buonafede. Gratificherò materialmente la mia prole. (22)
La necessità che hanno provato certi superstiti di dimenticare per sopravvivere è
illustrata qui da Piperno che propone allora una riflessione sfumata e abbastanza
oggettiva, senza giudizi rigidi, pur svelando i diversi motivi di tale atteggiamento.
La questione del dopo-Shoah non è difatti evitata da Piperno, come certi critici
gli hanno rimproverato. Evoca a lungo il destino dei nonni di David Ruben,
sterminati a Buchenwald, analizza la vergogna “ispirata dal nulla dietro di sé” che
prova la madre del ragazzo che cerca disperatamente di “sbarazzarsi dei suoi morti.
Possibile che lei arrivasse a considerare inelegante il modo in cui i suoi genitori e i
suoi nonni e tutti gli altri s’erano fatti ammazzare” (Piperno 2005, 168-170), si chiede
il narratore, rivelandoci così la riflessione di Piperno stesso sull’argomento. L’autore
sembra difatti voler trovare un nuovo modo di evocare la Shoah senza edificare nuovi
mausolei della memoria pur senza occultare il trauma che provocò questa tragedia
nella comunità ebraica.
È del resto a partire da questo profondo problema della Shoah e, più
globalmente, dall’antisemitismo, che Piperno svolge una riflessione abbastanza
interessante sull’ebraismo italiano odierno. Tutti i temi legati all’identità ebraica vi
sono presenti, perfino quello di Israele nei cui confronti Piperno ha uno sguardo
critico ma molto tenero. Pur fustigando la presenza di fanatici ebrei, egli non riesce a
nascondere la sua profonda empatia per questo paese
[…] in cui i giovani sono drogati di Coca Cola e i cui vecchi stentano a disintossicarsi di tutta la
rabbia accumulata fin dai tempi delle persecuzioni faraoniche; sì, questa strana lingua desertica,
veemente inverdita, che gli ebrei di tutto il mondo chiamano ‘nazione’: questo Paese che sembra
composto di atomi di terrore. Tutto qui è ammutolente. Anche i tramonti incredibili hanno il
colore del sangue. (70)
Sono anche evocate diverse situazioni in cui la solidarietà del narratore e, si
indovina, anche di Piperno, nei confronti di Israele è palese: l’emozione e la
solidarietà degli ebrei italiani – perfino del nonno – durante la Guerra dei Sei Giorni
(66),
[…] ci siamo commossi, abbiamo sofferto, perso il sonno, tifato, temuto realmente che Israele
potesse smettere di esistere, scomparisse dalla faccia della terra, un nuovo genocidio ebraico e
l’ennesimo sogno tramutato in tragedia […]. (102)
o durante i tragici attentati in Israele (69-70).
In modo generale, Piperno evoca le situazioni in cui l’antisemitismo riemerge,
300
come nel caso del suo stesso personaggio, il cui nonno materno è nientemeno che
antisemita. Nel caso piperniano, il paradosso dell’ebreo diasporico è difatti al suo
parossismo: “credo di essere il primo ebreo della storia dell’umanità”, spiega il suo
personaggio, “ad aver subito discriminazioni dal proprio stesso nonno. Il primo
ebreo della storia con un nonno antisemita” (107-108).
Al di là della farsa, la riflessione di Piperno è più profonda di quanto non si
creda. Attraverso questa situazione schizofrenica, il protagonista tenta di costruirsi
un’identità tanto più difficile da chiarire per chi vive un’epoca di transizione,
ambigua: da un lato, è un prodotto dell’assimilazione e non è possibile per lui
sentirsi totalmente ebreo, e da un altro, è vittima dell’antisemitismo. Un
antisemitismo che analizza sotto tutte le sue sfaccettature, attraverso numerosi
personaggi simbolici di diverse forme dell’odio antiebraico: i nonni cristiani per
esempio, confrontati tramite il loro genero con un universo verso il quale nutriscono i
più triti stereotipi antisemiti, fanno un discorso che si ricollega alla più pura
tradizione antisemita:
Chi sono gli ebrei? Loro non ne hanno mai conosciuti. È la prima volta che vi entrano in
contatto […] Gente ricca e maliziosa. Gente avara e scaltra […] Gente furba che ti frega. Ecco chi
sono: strozzini e pezzivendoli, banchieri e gioiellieri. Se la sono cercata. Che senso ha rimanere
ebrei in un mondo di cattolici […] essere tanto snob e vittimisti? (98)
Attraverso numerosi personaggi e varie scene, Piperno analizza così diversi aspetti
dell’antisemitismo che compongono oggi una parte della realtà ebraica: quello
tradizionale, come vediamo, ancorato nell’Europa cristiana da secoli, oppure quello
di Nanni, più contemporaneo, che per nascondere meglio il suo antisemitismo
latente, esibisce il suo amico ebreo, Bepy (Piperno 2005, 136-137), e il suo pseudofiloebraismo. Oppure quello più attuale, di un’attualità bruciante: quello dell’examico Giorgio: “Ne conoscono di tipi come te”, dichiara con odio Giorgio, portavoce
di un antisemitismo odierno sempre più frequente:
Questa città è piena di tipi come te. Ti somigliano persino fisicamente. Hanno tutti il tuo profilo
da formichiere […] sempre pronti a mandare in avanscoperta i vostri libri, la vostra sensibilità, e
gli ebrei e l’Olocausto e tutte queste altre puttanate. (197)
Sono senza dubbio pagine così realistiche ma anche molto crude e violente, nel
trattamento dell’ebraicità, che hanno provocato reazioni negative nei confronti di un
Piperno che, rispetto alla sua origine odiosamata, ha saputo sì sottolineare senza
trucchi la realtà ebraica italiana odierna, ma in modo così spudorato che certi hanno
temuto che il suo romanzo diventasse uno strumento prezioso per certe persone
malintenzionate… Ma queste non hanno bisogno di Piperno!
301
NOTE
Cfr. De Angelis 2006, 16, dove l’ebraicità viene definita come “la condizione psicologica e fisiologica
dell’ebreo”.
1
2
Baudino 2005.
3
Piperno 2006.
4
Levi 2006.
BIBLIOGRAFIA
Baudino, Mario. ‘Mantova, Mihaileanu e la sua storia dedicata ai falasha’. La Stampa (10.09.2005).
De Angelis, Luca. Qualcosa di più intimo. Firenze: Giuntina, 2006.
Levi, Lia. ‘Nessun piagnisteo, questa è memoria’. Il Corriere della Sera (28.01.2006).
Piperno, Alessandro.Con le peggiori intenzioni. Milano: Mondadori, 2005.
---. ‘Sono ostile al Giorno della Memoria’. Il Corriere della Sera (21.01.2006).
302
RICCIARDI, Stefania. ‘Filippo Tuena, Le variazioni Reinach: l’inferno del lager dalla musica del niente’. Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 2. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. ISBN 978‐90‐6701‐017‐7. 303‐314. RIASSUNTO Romanzo, saggio, diario, biografia: Le variazioni Reinach (Rizzoli, 2005) sfuggono alle classificazioni di genere per collocarsi all’incrocio tra fiction e non‐fiction, territorio particolarmente fertile della narrativa contemporanea. Premio Bagutta, Vittorini e Comisso, questo mirabile affresco della prima metà del Novecento parigino percorre la storia di tre generazioni di banchieri ebrei appartenenti alle famiglie Reinach e Camondo, unite dal matrimonio dei rispettivi rampolli Léon, compositeur de musique, e Béatrice. Tuena ricostruisce i percorsi e le stigmate di una decadenza sociale e affettiva che culmina con l’incubo di Auschwitz. Egli conduce due indagini parallele, due vortici che risucchiano il lettore, due cerchi concentrici che si avvitano su di sé: nell’uno, il lento scivolare di questa famiglia dell’alta borghesia avvezza ai salotti proustiani, all’arte e ai passatempi nobili come l’equitazione, il gioco delle carte, fino alla deportazione; nell’altro, i movimenti interni alla stesura, gli interventi di Tuena stesso che parla di sé in terza persona presentandosi come ‘lo scrittore’. L’originalità dell’opera rispetto alla celebrata letteratura dell’Olocausto, la peculiarità che ci proponiamo di mettere in luce, risiede nell’approccio estetico alla Shoah. Il documento si fa racconto, il racconto sommessa e irrinunciabile testimonianza dell’inferno del lager impresso nella ‘musica del niente’, pallida evocazione della Sonata per violino e pianoforte composta da Léon Reinach e che solo la tenacia di Tuena è riuscita a riesumare dagli archivi di un’università americana per darci “la voce di un sommerso che torna a vibrare come un ultimo omaggio”. PAROLE CHIAVE Filippo Tuena, Léon Reinach, Musée Camondo, Auschwitz, Shoah © Gli autori Gli atti del convegno Scrittori italiani di origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale (Utrecht‐Amsterdam, 5‐7 ottobre 2006) sono il volume 2 della collana ITALIANISTICA ULTRAIECTINA. STUDIES IN ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE, pubblicata da Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISSN 1874‐9577 (http://www.italianisticaultraiectina.org). 303
FILIPPO TUENA, LE VARIAZIONI REINACH L’INFERNO DEL LAGER DALLA ‘MUSICA DEL NIENTE’ Stefania Ricciardi Université Michel de Montaigne‐Bordeaux 3 Aux même temps je voudrais écrire un livre sur le RIEN. Sur les choses de famille qui passent et sur les gens qui sont englouties par le passé.1 Così, in una lingua non sua, in un francese “più che zoppicante” (Tuena 2005, 80) per sua stessa ammissione, Filippo Tuena, nato a Roma nel 1953, svela il cuore del suo libro innestandolo nella corrispondenza con una discendente acquisita di casa Reinach. Queste righe racchiudono l’essenza di una delle opere più incredibilmente trascurate degli ultimi anni, malgrado i premi Bagutta, Vittorini e Comisso e il secondo posto all’Adei‐Wizo, dove Tuena figurava come unico autore non ebreo tra i finalisti di questo riconoscimento riservato alla letteratura ebraica. “Un libro importante di cui si è parlato troppo poco”, ha notato Alberto Cavaglion, aggiungendo che Tuena “avrebbe agevolmente superato il rivale, da cui, purtroppo, è stato oscurato, se soltanto non si fosse lasciato prendere la mano dall’estetismo”.2 Il rivale in questione è Alessandro Piperno,3 romano di origine ebrea, classe 1972, autore del best‐seller Con le peggiori intenzioni, uno dei casi letterari più eclatanti degli ultimi anni (ottantamila copie vendute in soli quindici giorni), ma anche più controversi, perché osannato e lapidato dalla critica. Se Pietro Cheli lo considera “un libro da non perdere” e Franco Cordelli “uno dei più brillanti esordi della nostra letteratura recente”, Giovanni Pacchiano ne lamenta le “lungaggini insopportabili”, mentre i toni di Giuseppe Bonura sono decisamente aspri: “Piperno ha costruito il suo romanzo attingendo a piene mani nel sacco della farina altrui. Il suo è uno stile di riporto, e chi ha orecchio lo sente”.4 Al di là di ogni giudizio di valore, l’estetismo cui allude Cavaglion inscrive Le variazioni Reinach in quella branca della letteratura che, se non proprio elitaria, si situa comunque su un piano di singolare raffinatezza, dunque di dubbia fruizione per il pubblico di massa. In realtà, l’approccio estetico segna davvero il discrimine tra queste due opere che, pur narrando la saga di una famiglia ebrea nell’ottica di autori che non hanno vissuto l’Olocausto, non sembrano condividere granché eccetto la consapevolezza che, come ha scritto Tuena: C’è una generazione che raggiunge il culmine economico, c’è una generazione che raggiunge il culmine culturale e c’è una generazione che dissipa patrimonio e cultura. (Tuena 2005, 30) 304
La lettura delle Variazioni Reinach si presta a diversi spunti di riflessione, ed è lo stesso autore a suggerirli nel corso del testo. Allo spiazzante “libro sul NIENTE” della citazione posta in epigrafe, si aggiungono: […] questo è un libro sulla nostalgia e sul conflitto con il passato che giace e che però fortemente desidera ritornare in vita. (41) […] questo è un libro sul peso dell’eredità. (65) […] questa che racconto è anche una storia di precauzioni inutili, d’incapacità a essere padri. (133) Parlerò di libri in questo libro, e della felicità che sanno dare a chi li possiede. (176) Malgrado l’indubbio interesse, la nostra riflessione ignora o sfiora appena queste piste per concentrarsi su un nodo cruciale: cosa si può desumere dalla tragedia della Shoah e come si pone dinanzi ad essa uno scrittore non testimone e soprattutto non ebreo qual’è Tuena? Va da sé che l’osservazione di Cavaglion fungerà da causa scatenante per comprendere un effetto: fino a che punto il taglio estetizzante penalizza Le variazioni Reinach e non ne rappresenta invece un pregio? Ma in primo luogo conviene risalire alla genesi e alla sinossi del testo. L’opera si presenta come un affresco della prima metà del Novecento parigino attraverso la storia di tre generazioni di banchieri ebrei appartenenti alle famiglie dei Reinach – originari di Francoforte – e dei Camondo – provenienti da Costantinopoli – famiglie unite dal vincolo matrimoniale dei rispettivi rampolli Léon e Béatrice, da cui nasceranno due figli, Fanny e Bertrand. Tuena si sofferma su questo nucleo familiare, su queste quattro persone osservate in fotografia al museo Camondo a Parigi durante una visita privata. È tra le sale semideserte della casa di Béatrice che il conte Moïse suo padre preferì donare alla Francia, omaggiando la memoria del figlio Nissim, aviatore caduto in guerra nel 1917, è esattamente lì che scatta nell’autore il desiderio di riportare in vita “des gens englouties par le passé”, nella fattispecie queste quattro persone morte ad Auschwitz, come recita la lapide all’ingresso. Tuena ricostruisce i percorsi e le stigmate della loro decadenza, sociale e affettiva, culminata nei campi di sterminio. La sua è una ricostruzione originale sia come modalità narrativa – perché fonde biografia, autobiografia, diario, romanzo e documenti autentici (fotografie, copie anastatiche, verbali) collocandosi all’incrocio tra fiction e non‐fiction, territorio tra i più fecondi della letteratura contemporanea – sia come progressione del racconto, che comprende due indagini parallele, due vortici che risucchiano il lettore, due cerchi concentrici che si avvitano su se stessi. Uno riproduce il lento scivolare, fino alla deportazione, di questa famiglia dell’alta borghesia avvezza ai salotti proustiani,5 all’arte, ai passatempi nobili come l’equitazione e il gioco delle carte. L’altro, svela i movimenti di Tuena stesso, che parla di sé alla terza persona presentandosi come ‘lo scrittore’. Per quanto concerne la struttura, si tratta di un testo di oltre quattrocento pagine diviso in cinque parti progressivamente sfoltite, se pensiamo che la prima conta pressappoco centoventi pagine e l’ultima appena una quindicina, come se il 305
flusso del racconto si andasse prosciugando con l’approssimarsi del congedo dei Reinach da questo mondo. Coincidenza bizzarra per chi si è proposto di scrivere un libro sul NIENTE, per chi, dovendo eleggere un personaggio come perno dell’impianto narrativo, ha scelto Léon, un compositeur de musique autore di una Sonata per violino e pianoforte in re minore che solo la tenacia di Tuena è riuscita a riesumare dall’archivio di un’università americana.6 E il re minore è la tonalità dell’assenza, del vuoto, del niente, una tonalità che “conduce sempre al silenzio” (Tuena 2005, 82), precisa l’autore. Egli modula la narrazione concependola come uno spartito, un insieme di variazioni tematiche e stilistiche dagli accordi ora lenti e cupi, ora sfuggenti e palpitanti resi tali da una punteggiatura praticamente inesistente. Entriamo allora nel vivo dell’analisi attraverso due approcci decisivi: uno con il lettore e con i personaggi (Léon in special modo), l’altro con la Shoah. LO SCRITTORE, IL LETTORE E I PERSONAGGI Il rapporto tra lo scrittore e il lettore si definisce essenzialmente nella prima parte. Oltre ad essere la più corposa, è anche quella che gode di maggiore autonomia ed equilibrio stilistico: una pregevole miniatura dell’opera, in cui Tuena traccia il perimetro della storia e ne abbozza l’arredo su scala ridottissima. Il lettore prende conoscenza degli ambienti e dei propositi dello scrittore, acquisisce dimestichezza con i personaggi, dei quali fissa fisionomia e postura grazie alle istantanee riprodotte nel testo atte a sancire la soggettività delle descrizioni con l’oggettività fotografica e del documento autentico. In particolare, dall’album di famiglia spicca il contrasto interno‐esterno che oppone il solitario Léon ritratto al chiuso, intento a leggere libri, a Béatrice, Fanny e Bertrand “ripresi quasi sempre all’aria aperta a cavallo, nel bosco” (Tuena 2005, 95), a conferma dell’indole umbratile del capofamiglia, “un uomo silenzioso, almeno fino a questo momento della storia” (72), stando all’immagine che lo scrittore ha di Léon dopo una settantina di pagine. Questo frammento evidenzia un dato importante: a circa un sesto del libro, pur conoscendo la storia del suo personaggio principale (o almeno credendo di conoscerla, considerando la scoperta della sopravvivenza ad Auschwitz più lunga del previsto, sopraggiunta a stesura quasi ultimata), Tuena ne intravede una silhouette ancora floue e questo vale anche per le altre figure. Difatti, se il loro raggio d’azione risulta circoscritto, sono i movimenti interni ad apparire sfocati, sintomo del loro divenire nella mente dell’autore. Significativo, allora, il colloquio con Madame Suzanne Reinach, moglie separata di un nipote di Léon, durante il quale egli rileva che è la prima volta nella sua storia di scrittore che incontra qualcuno che conosce i suoi personaggi meglio di lui. (Tuena 2005, 90) Perché prima di esistere nella sua mente, questi personaggi erano persone. E sono esattamente quelle persone che lui vuol riportare in vita, pertanto il suo interesse 306
deve convergere sulle singole identità più che sulle comuni appartenenze, il che significa trattare le testimonianze, i documenti, le ricerche carpendo dall’orizzontalità dei fatti il contrassegno dell’individuo, il suo moto ascensionale. La narrazione rispecchia l’atteggiamento dell’autore. Dopo appena cinque pagine apprendiamo che i Reinach sono morti deportati ad Auschwitz; conosceremo presto le rispettive attività artistiche, sociali e professionali, il che cosa sono, per porre la questione sotto un’ottica filosofica, ma ignoreremo a lungo il percorso umano di queste creature, il chi sono, quel loro essere nel quotidiano che Tuena si sforza di ricompattare in presa diretta visitando luoghi, incontrando persone, sfogliando libri. È così che, come ha osservato Antonio Debenedetti, “Il documento si fa racconto, il racconto sommessa e irrinunciabile testimonianza”.7 Ora, secondo la filosofa della politica Adriana Cavarero, ogni volta che parliamo del che cosa, noi parliamo di qualità comuni, che non definiscono un’identità singolare.8 Al contrario, Tuena vuol andare al di là del semplicistico compositeur de musique che qualifica il deportato Léon al campo di Drancy, a nord di Parigi. Tuena vuol andare al chi è dei suoi personaggi, alla loro identità narrata da intendersi come “senso compiuto di una vita” che Adriana Cavarero identifica non in qualcosa di ‘dato’, ma in qualcosa di ‘desiderato’, ponendo l’accento sul desiderio di Tuena di dare una storia a quattro esseri umani.9 Perché in esso, in questo desiderio, è sotteso quello di narrare la propria identità, il senso compiuto della propria vita: “Sono sempre io, è la mia storia quella che vado raccontando, non te ne accorgi?” (Tuena 2005, 48). Con ogni evidenza, lo scrittore ha colto una serie di affinità con la famiglia Reinach, particolarmente con Léon. AFFINITÀ E POSTURE Il libro si apre su un ‘lui’ che osserva una ‘lei’: lui è lo scrittore, lei Béatrice de Camondo “perfetta padrona di casa” (Tuena 2005, 9). Ancora non sappiamo che quella casa è il museo che lui sta visitando insieme a sua moglie e a suo figlio in un assolato pomeriggio di marzo, e che la donna intravista è frutto della sua immaginazione, essendo morta da oltre mezzo secolo. Come pure non sappiamo che lo scrittore è l’autore del libro che stiamo leggendo. Lo scopriremo una decina di pagine dopo, quando leggeremo: “lo scrittore che sta scrivendo questo libro”. L’impatto con questa storia dai falsi antecedenti è decisamente intrigante: l’identità dei soggetti è un’incognita celata dietro due pronomi che non rinviano a nessun nome. Si resta nel vago, sebbene s’intuisca la presenza di soggetti precisi che vanno definendosi nel corso della narrazione in una trama incrociata dove il che cos’è e il chi è dei personaggi s’intreccia con il che cos’è e il chi è dello scrittore. In tale prospettiva, la scelta di solcare l’opera non nella prima persona autobiografica, ma nella terza esprime una duplice ricerca: da un lato i Reinach, dall’altro se stesso 307
percepito come personaggio e in quanto tale veicolato al lettore. Un personaggio che lotta sovente contro il ritrarsi della scrittura, che cerca il conforto della parola nella conversazione con se stesso – “Sogna davvero di suo padre […] o immagina di sognarlo?” (64) – e nel dialogo con l’amico di turno, come accade nei momenti critici, quando il racconto è giunto a una svolta e bisogna scegliere in fretta la direzione da imprimergli. Si ricorderà che l’elezione di Léon Édouard Reinach a personaggio‐
chiave, nonché a propria controfigura, nasce dall’esortazione dell’amico che gli propone: […] raccontare di te; scegli uno dei tuoi personaggi e prestagli i tuoi pensieri i tuoi sogni dirà la verità che ti riguarda e ti racconterà le cose che ha veramente sognato. […] Scelgo Léon […] risponde. (67) Questa risposta perentoria argina il flusso emotivo dell’autore che diluisce l’invito dell’amico in una trascrizione scevra di punteggiatura, frenata solo in parte dalla paratassi. D’ora innanzi l’identificazione è dichiarata, al lettore come a se stesso. Perché la scelta ricade su Léon? Certamente non solo perché porta il nome che lo scrittore pensava di dare al figlio e un cognome altrettanto familiare, data la presenza di un volume a firma di Salomon Reinach, zio di Léon, nella biblioteca paterna. Al di là delle reminiscenze onomastiche, esistono affinità emerse dopo uno slalom elettivo tra i Reinach e il loro mondo rispetto ai quali Léon rappresenta il culmine. Una di queste associazioni si produce durante la visita al museo Camondo: le voci francesi di bambini si sovrappongono a quelle ascoltate a Roma almeno trent’anni prima in una stazione della metropolitana. La seconda, sempre al museo, proviene da una fotografia di Fanny e Bertrand ragazzini, seduti in poltrona, camicia bianca per entrambi, cravatta per lui. Dal transfert immediato con il figlio – “Ils ont presque le même âge que mon fils” (77) – si passa a quello più diretto: Ils m’ont aussi rappelé quand, enfants, ma mère habillait moi et ma soeur avec les même vêtements! (77) Si noti, per inciso, un’altra confessione in un francese “incerto”, sul quale ci soffermeremo più avanti. Al momento, seguiamo ancora l’autore nel processo di empatia con i suoi personaggi. Un altro episodio significativo riguarda l’incontro con Monsieur Fabrice, nipote di Léon, che riceve lo scrittore nella propria abitazione. È lui che gli mostra le fotografie più intense, quelle che appariranno in prima e in quarta di copertina. È lui che gli parla dello zio come “la memoria di casa” (105), ma soprattutto è in casa di questo anziano ed elegante signore, davanti al ritratto della madre di Léon, che Tuena riconosce all’istante, è lì che lo scrittore “si sente quasi in famiglia” (103), tanto da permettersi un’incursione personale nel sogno che Monsieur Fabrice gli racconterà. Dettaglio, questo, non trascurabile, se si considera l’importanza attribuita al bozzolo familiare, testimoniata da questo omaggio in chiusura dell’opera: 308
Il libro è dedicato alle mie due famiglie, quella che mi ha generato e quella che ho formato. Tra di esse continuo a sentirmi un cardine incerto ma tenace. Una precisazione è tuttavia opportuna: prima ancora che con Léon compositeur de musique, Tuena ha familiarizzato con il destino di una coppia di giovani sposi privata dai genitori di alcuni beni di famiglia: se Moïse de Camondo ha fatto della casa in cui Béatrice è cresciuta un museo, Théodore Reinach, padre di Léon, ha donato all’Institut de France villa Kérylos a Beaulieu in Costa Azzurra, dove Léon ha trascorso le vacanze estive con i suoi fratelli. Scrive Tuena: Orfani dei padri e delle splendide case che avevano abitato Léon e Béatrice si sentono forse sottovalutati. (100) Un senso d’inadeguatezza analogo pervade lo scrittore dinanzi ai propri beni ereditati. “Ogni cosa che gli hanno lasciato i suoi morti gli sembra immeritata” (64): è solo il principio di una litania delirante lunga sette righe senza nessun segno di punteggiatura. La varietà di rimandi insiti in questo libro risiede appunto nel ventaglio di quesiti di natura estetica, fisica, metafisica che lo scrittore si pone: Il faut conserver les héritages ou ils faut que chaque génération change son histoire? (77) La storia dei Reinach s’intreccia con la propria perché anche lui è, per certi versi, vittima dell’eredità, non sul piano materiale come Léon e Béatrice, ma su quello morale, che continua ad attanagliarlo: Sente il peso dell’eredità che ha ricevuto sente il peso dell’eredità che lascerà perché questo è un libro sul peso dell’eredità. (65) Il rovello estetico è azionato da una duplice pulsione: il godimento che l’eredità gli procura e la diffidenza verso se stesso e verso i propri eredi. Ma non solo. Integrandolo nella stesura, l’ingranaggio narrativo non gli risparmia né personaggi né eventi. L’APPROCCIO CON IL PERSONAGGIO Prima guerra mondiale: Léon è arruolato nel contingente francese a Salonicco, città degli ebrei di Grecia. Questo giovane solitamente “severo, poco disponibile” (Tuena 2005, 53), secondo la testimonianza di chi lo ha conosciuto, si mostra d’un tratto sensibile all’aspetto fisico scegliendo un fotografo d’arte per farsi ritrarre in divisa di allievo ufficiale. Quando lo scrittore si reca all’indirizzo del celebre Henri Manuel nota che non solo dello studio fotografico non c’è traccia, ma pure che “il bell’ascensore di fine secolo” (53) vantato in un inserto pubblicitario è stato sostituito da 309
un ascensore moderno, elettrico, di metallo laccato bianco Isabella con la porta scorrevole, sporco come il palazzo. (53) La perizia descrittiva di Tuena, la sua attenzione ai rilievi estetici, non stupisce: figlio di un antiquario, cresciuto tra oggetti antichi di valore, lo scrittore è uno storico dell’arte, un collezionista, una persona che ha affinato lo sguardo sulla bellezza e l’eleganza, uno sguardo che scruta e stima al tempo stesso con estrema naturalezza. La mole documentaria su cui si erge questo libro (basta scorrere l’apparato bibliografico per sincerarsene) persegue un fine estetico oltre che veridico: non c’è fotografia di cui non sia colto il supporto dei personaggi, lo sfondo, l’arredo, l’architettura di interni ed esterni mediante un commento minuzioso ma mai pomposo. In questi frangenti, il tono è sobriamente didascalico perché Tuena è attratto dall’eleganza senza sfarzo, come dote innata, si tratti di persone o di ambienti. Esemplare è la descrizione della fotografia che immortala Léon in un salotto dell’appartamento di Neuilly: […] seduto su una bergère stile Luigi XV […]; sullo sfondo una boiserie moderna, due dipinti, uno è molto scuro, indistinguibile, l’altro più piccolo, proprio sopra Léon raffigura una natura morta […]. (94) L’occhio indugia ancora sugli oggetti, quindi si focalizza gradualmente sul personaggio: Léon legge, ha un libro sulla gamba accavallata, la mano destra tiene un sigaro o una penna, ed è posata su un tavolino tondo ricoperto di una tovaglia bianca […]. (94) Dapprima ne coglie l’atteggiamento e il rapporto con l’ambiente, in seguito si fissa sull’aspetto esteriore: Léon ha i capelli imbrillantinati, legge senza occhiali, ha la carnagione chiara, indossa una giacca di lana, dunque è inverno; i pantaloni hanno una piega impeccabile e il risvolto piuttosto alto, almeno tre centimetri e mezzo, è questa la misura minima per un risvolto come si deve. (94) Si noti tuttavia come la figura di Léon assuma presto connotati intimi: dalla minuzia dell’abbigliamento si traggono conseguenze indicative dell’indole e dello stato d’animo: Léon indossa un paio di ghette color grigio, alte quattro bottoni, nota ancora una volta altri particolari, la brillantina, la piega dei pantaloni, il risvolto, la giacca sostenuta e rigida, il fazzoletto bianco: Léon è un preciso, Léon è silenzioso, Léon legge, Léon è solo. (95) Lungi dall’essere gratuito, l’estetismo rappresenta una chiave di accesso alle latèbre umane, conducendo direttamente al chi è. Osserviamo ora come si traduce questo atteggiamento dello scrittore nell’impatto con gli eventi. 310
L’APPROCCIO CON LA SHOAH Se il tema della deportazione è annunciato sin dall’inizio, anche il relativo sconvolgimento nella vita dei personaggi è anticipato al lettore, come dimostrano questi cenni su Béatrice: “Verranno i giorni in cui dovrà gestire la pensione dei suoi guardiani” (Tuena 2005, 25). Il giro di boa che segna l’esistenza dei Reinach entra nel corpo dell’opera dopo un centinaio di pagine, nella seconda parte che si apre con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e prosegue con le ordinanze antiebraiche e i sequestri dei beni di famiglia. Il 13 giugno 1940 Parigi è proclamata città aperta, e di lì a poco sarà eretta la barriera tra francesi ed ebrei. Intanto, anche le relazioni familiari subiscono una metamorfosi: Léon e Béatrice si separano, quest’ultima si converte al cattolicesimo e rimane sola con Fanny nell’appartamento di Neuilly fino al loro arresto, il 5 dicembre del 1942. Dal suo canto, Léon opta per la fuga a sud, dove tenterà di valicare i Pirenei insieme a Bertrand, ma il loro progetto non sortirà buon esito. Difatti, i Reinach si ritrovano al campo di sterminio di Drancy, evento che segna la fine della seconda parte e introduce la terza, incentrata sulla loro permanenza in questo luogo che precede Auschwitz. Per un ragguaglio completo della ripartizione del testo, osserviamo che nelle ultime due sezioni i Reinach sono già morti e il racconto verte sulla difficoltà di narrare Auschwitz (quarta parte) e sulla ricerca dello spartito di Léon (quinta parte). Nell’ottica di Tuena, affrontare la questione ebraica significa anzitutto evidenziare le ripercussioni materiali e morali che affliggono i Reinach: il divieto di presentarsi in società e nei luoghi di svago di cui erano habitués, l’isolamento tra le mura domestiche. Béatrice e Fanny trasgrediscono sovente alle regole: appuntano la stella gialla solo su alcuni dei loro capi d’abbigliamento e non rinunciano alle passeggiate al Bois de Boulogne. Esistono tuttavia privazioni alle quali si cerca invano di rimediare: Léon, l’inerte e trasognato Léon, si attiva scrivendo lettere alle autorità competenti ora in soccorso del fratello Julien, cui è stata sottratta la biblioteca, ora a sostegno di Béatrice, perché le sia restituito il ritratto della madre opera di Renoir e perché possa disporre del proprio patrimonio senza le restrizioni impostele. Il dramma dei Reinach si consuma dinanzi ai rifiuti che ricevono, indizio del pericolo che incombe anche su di loro che si stimavano intoccabili grazie ai meriti collezionati dai genitori, ai morti di famiglia immolati alla causa francese che però non valgono la protezione auspicata della patria adottiva, una Francia ingrata pronta ad avallare lo scempio nazista. Una volta di più, si noti la vena estetica che emerge dall’indugiare dell’autore su questo presunto tradimento e sul conseguente contraccolpo, fatale all’intera famiglia estranea al “privilegio dei poveri”, ossia alla capacità di staccarsi agevolmente da quel poco che si possiede, allorché “è difficile per i ricchi abbandonare i propri averi” (139). 311
L’organizzazione del campo di Drancy, per quanto dettagliata, si perde nell’abbaglio della salvezza prima e della feroce decadenza poi. Uno dei primi a presagire il precipitare degli eventi è proprio Léon, la figura apparentemente più lontana dal concreto, immersa nel suo mondo di letteratura e musica. Come scrive al nipote Fabrice, in una cartolina dal campo di Mérignac, nei pressi di Bordeaux, quando il tentativo di fuga suo e di Bertrand è stato sventato: “Bisogna provare tutto. Essere i primi e gli ultimi”.10 L’ordine si sovverte anche a Drancy: è Bertrand, il meno intellettivamente dotato della famiglia che, con la sua qualifica di falegname, consente ai suoi cari di migliorare la vita al campo. È dunque l’attività manuale, l’applicazione concreta del sapere che prolunga la sopravvivenza, come ha appurato anche Primo Levi: la sua fortuna – è lui a dirlo nella prefazione a Se questo è un uomo – fu di trovarsi a Auschwitz in un periodo di scarsità di manodopera che indusse i nazisti a protrarre la vita dei prigionieri. La laurea in chimica fece il resto.11 Da quanto risulta dalle schede di Drancy, i Reinach sono tutti impegnati in attività produttive o socialmente utili: Bertrand è falegname, Fanny e Béatrice infermiere, Léon è chef d’escalier. Non a caso, ritorna il che cos’è dei personaggi nel luogo di annientamento per antonomasia del chi è, laddove l’essenza umana è ridotta a una cifra impressa sull’avambraccio. Sarà la dimensione sociale e professionale a reintegrare l’individuo nel proprio essere e, nel caso specifico di Léon, a elargirgli sei mesi di vita supplementare. Complice l’amico, lo scrittore realizza che se Léon, provato nel corpo e nello spirito, è sopravvissuto fino al 12 maggio 1944, deve aver beneficiato di un privilegio facile da concedere a un compositeur de musique, deve aver fatto parte dell’orchestra di Auschwitz. Questo privilegio sconvolge il progetto narrativo: quando la vicenda sembrava conclusa, una ricerca su internet contrasta con le fonti di riferimento dell’autore, costringendolo ad una revisione del racconto. Léon e Bertrand non sono morti gassati immediatamente dopo l’arrivo ad Auschwitz, il 24 novembre 1943, e prima di Fanny e Béatrice. Tuena, che si vedeva in dirittura d’arrivo, è colto da un comprensibile smarrimento “per le molte settimane da aggiungere alla loro vicenda, settimane che non conosco, settimane buie” (364). Cerca di fare luce attingendo alle testimonianze più autorevoli su Auschwitz: quelle di Primo Levi e Jean Amery tra le altre. Ma il racconto non decolla. Perché Tuena è lontano dagli intenti di Levi; egli non vuole “fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano”,12 né documentare un’esperienza estrema, mostrare le peggiori conseguenze della xenofobia, meditare sul comportamento umano in condizioni eccezionali o liberarsi da un’ossessione, secondo le quattro peculiarità individuate da Cesare Segre nella sua analisi di Se questo è un uomo.13 Riesumando le vicende uniche e irripetibili di persone diventate personaggi, Tuena riesce a narrare la propria identità e a eternare le identità collettive. Nel primo caso, l’esperienza di Auschwitz è paragonata a un profondissimo pozzo oscuro alla 312
cui sommità egli si affaccia trovando se stesso (Tuena 2005, 377). Comprende allora che “il cercatore di storie” (365), come si definisce, e il compositeur de musique cessano di procedere in parallelo. I loro destini s’incrociano e tendono a sovrapporsi anche tipograficamente, con queste due definizioni riportate in successione ma non di seguito: ognuna è sola sul rigo della pagina, divisa dall’altra da un capoverso. In merito al secondo aspetto, è eloquente la percezione dei morti di Auschwitz: (Essi) sono ancora nascosti nelle profondità della terra in attesa d’esser svelati; così è convinzione dello scrittore che la parola scritta non possa venir cancellata e ogni forma di pensiero scritto produca una scossa nella convinzione della mortalità dell’essere umano. (376) Da Le Variazioni Reinach si leva un singolare inno alla vita composto sul pentagramma della memoria storica e umana. Se i documenti hanno fissato sprazzi di esistenze, la rielaborazione dell’uomo li ha clonati nell’atto della scrittura. Scrivendo, Tuena ha riportato in superficie persone inghiottite dal passato. Nel farlo, è ricorso spesso a un francese sintatticamente e ortograficamente inesatto. Ma non diremmo che è incappato in una pecca, del resto troppo eclatante per essere tale. Piuttosto, ci chiediamo perché mai uno scrittore arcicolto, che dispensa citazioni erudite (Anna de Noailles, Villon, Racine e Shakespeare tra gli altri) e allusioni al mito (Laocoonte, padre inascoltato), uno scrittore che si è documentato con dovizia di mezzi, spaziando dai luoghi abitati dai Reinach al Centre de documentation juive e al campo di Drancy, senza contare le ricerche effettuate via internet, perché mai una persona così precisa, attenta e attendibile si sarebbe smentita dinanzi all’impiego di una lingua straniera tra le più diffuse e dunque facilmente riproducibile in forma corretta. La nostra idea è che non si tratti di negligenza, di mancanza di rispetto per il lettore, ma al contrario di un atto sincero nei confronti di quest’ultimo e della letteratura. Automatismo psichico puro di bretoniana memoria o meditata strategia narrativa atta ad esprimere gli intenti principali del libro in francese, estrapolandoli da documenti autentici peraltro tradotti alla pagina seguente, o ancora, perché no, puro vezzo esterofilo, ognuno di questi casi suggella il desiderio di identificazione con “la voce di un sommerso che torna a vibrare come un ultimo omaggio” (risvolto di copertina). Ognuno di questi casi attesta che Tuena si presenta senza maschere. Lungi dall’ostentare competenze fittizie, l’autore confessa che “Avrebbe voluto conoscere meglio il francese, e avrebbe voluto conoscersi meglio”. Il francese è la lingua di Léon: nel loro periplo di identità narrate, il cercatore di storie e il compositeur de musique animano un libro che ha innegabilmente almeno un pregio, quello di essere autentico, e l’autenticità è dote sempre più rara in letteratura, laddove il timbro della voce narrante emana spesso toni densamente seduttivi quanto capziosamente personali. 313
NOTE Tuena 2005, 77‐79. “Allo stesso tempo volevo scrivere un libro sul NIENTE. Sulle cose di famiglia che passano e sulle persone che sono inghiottite dal passato” (traduzione in Tuena 2005, 105). 1
Cavaglion 2005, 8. 2
Piperno 2005. 3
Questi ed altri estratti di recensioni al libro di Piperno sono riportati nella rivista Origine (2006). 4
Citato come frequentatore di casa Cahen d’Anvers, da cui proviene Irène, madre di Béatrice, Proust compare anche in una lettera a sua firma inviata a Moïse de Camondo e riportata a p. 58. 5
La Sonata in re minore per violino e pianoforte di Léon Reinach. 6
Debenedetti 2005. 7
Cavarero 2005. Per un approfondimento dei concetti qui esposti, si veda il saggio della Cavarero 1997. 8
Ibidem. 9
Léon Reinach, cit. in quarta di copertina. L’originale francese (“Il faut tout essayer. Être le premier et le dernier”) è citato da Tuena a p. 105. 10
Levi 2005, 9. 11
Segre in Levi 2005, 9. 12
Ibidem. 13
BIBLIOGRAFIA Cavaglion, Alberto. ‘Lo spartito ritrovato’. L’Indice dei libri del mese 12 (2005): 8. Cavarero, Adriana. ‘Identità narrate’, conferenza dell’11.04.2005. Snodi: Circolo Interviste – 19.06.2007 http://www.snodi.org/circolo/interviste.asp?id=2&a=o&ct=16. ‐‐‐. Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione. Milano: Feltrinelli, 1997. Debenedetti, Antonio. ‘Variazioni dall’inferno’. Corriere della Sera (11.02.2005). Levi, Primo. Se questo è un uomo. 1947. Postfazione di Cesare Segre. Torino: Einaudi, 2005. Origine, rivista letteraria 14 (2006): 40‐43. Piperno, Alessandro. Con le peggiori intenzioni. Milano: Mondadori, 2005. Sonata in re minore per violino e pianoforte di Léon Reinach (Parigi, 1893 ‐ Auschwitz, 1944) è stata incisa in occasione dell’uscita del libro di Tuena, interpretata da Ruggero Fededegni e Maria Pia Carola (RCA). Tuena, Filippo. Le variazioni Reinach. Milano: Rizzoli, 2005. 314
GLI AUTORI/ THE AUTHORS
SERENA ANDERLINI-D’ONOFRIO, Ph.D., is a writer, scholar, activist, translator, and public
speaker. She is also a Professor of Humanities and Italian at the University of Puerto Rico at
Mayagüez. Her current interests include human and global ecology, erotic expression, and emotional
sustainability. The “Weak” Subject: On Modernity, Eros, and Women’s Playwriting (1998) is a comparative
study of women’s authorship in the modern theater (Italian translation by the title of Due in una
(2004)). The edited volumes she has contributed to include Natalia Ginzburg: A Voice of the Twentieth
Century, Feminine Feminists: Cultural Practices in Italy, and Franca Rame: A Woman Onstage. For the
community based Journal of Bisexuality she has guest edited two special-topics issues, Women and
Bisexuality: A Global Perspective (2003); and Plural Loves: Designs for Bi and Poly Living (2005), both of
which are also available as books from Haworth Press. Her book of applied cultural theory on the
politics of love and the globe’s future is in preparation with an academic press. She is the co-translator
of In Spite of Plato (1995), a book of feminist theory by Italian philosopher Adriana Cavarero.
PHILIP BALMA is a PhD candidate in Italian Literature at Indiana University in Bloomington, and a
visiting member of the Italian faculty in the Department of Romance Languages and Literatures at the
University of Notre Dame (2007). His research interests include literary and cinematic representations
of the shoah, Jewish studies, Women’s studies, literary translation, and modern Italian slang. His work
has appeared (and is also forthcoming) in Italica, Translation Review, and Lettere Italiane. He is the coauthor of Streetwise Italian: the User-Friendly Guide to Italian Slang and Idioms (2005).
DOMINIQUE BUDOR è professore ordinario nell’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III
(Dipartimento d’Italianistica). I suoi contributi critici — di orientamento semiologico, con particolare
attenzione alla portata storica delle forme — vertono sul Novecento: studi di narrativa, da Pirandello
fino agli scrittori contemporanei ; argomenti di teatro (dai Futuristi a Dario Fo); analisi dell’immagine
(con interventi dedicati al western italiano, a diversi registi italiani e ad autori di fumetti). Ultimo
volume personale è il suo Mattia Pascal, tra parola e immagine. Dal romanzo di Pirandello a Dylan Dog
(2004). Autrice di numerosi articoli e saggi pubblicati in riviste o volumi collettivi in Francia, in Italia e
negli Stati Uniti, ha organizzato convegni e curato Atti su diversi argomenti di teoria letteraria, tra i
quali si segnalano: Dire la Création (1994), Le Texte: genèse, variantes, édition (2000), Les objets inachevés de
l'écriture (2001), Les lyrismes interdits (2002), Le texte hybride (2004), Vincenzo Consolo. Éthique et écriture
(2007).
GANDOLFO CASCIO ha studiato presso le università di Palermo e di Amsterdam dove si è
soprattutto dedicato all’indagine sulle tecniche e la prassi delle traduzioni poetiche. Dal 2006 è
docente a contratto di lingua italiana e traduzione presso il dipartimento di italianistica dell’Università
di Utrecht, ed è impegnato in una ricerca sulla ricezione delle Rime di Michelangelo. Collabora a varie
riviste e si occupa di critica, in modo particolare di traduttologia e poesia contemporanea, rivolgendo
una costante attenzione alle questioni e alle voci escluse dal canone del secondo Novecento e, quindi,
all’opera di Cesare Pavese, Sandro Penna e Elsa Morante. Ha pubblicato il volume di liriche Admeto.
Poesie dell’amore perfetto (2005) e sta lavorando al suo nuovo libro a tematica religiosa: La costruzione del
bianco, di cui alcuni testi sono già apparsi su Poeti e poesia.
315
MIRNA CICIONI was born in Rome and has degrees from the universities of Bologna, Leeds (UK)
and La Trobe (Melbourne). She taught Italian language, culture and linguistics for over thirty years in
the United Kingdom and Australia. She is the author of an introductory monograph on Primo Levi
(Primo Levi – Bridges of Knowledge, 1995) and several articles on the Italian women’s movements and on
post-World War II Italian Jewish writers (Levi, Bassani, Ginzburg, Sereni nd Zargani). With Nicoletta
DiCiolla from Manchester Metropolitan University she is editing a collection of essays on Italian crime
fiction, entitled Deceptions, Deceits and Desires. She is working on a book on autobiography and
humour in the autobiographical macrotexts of Levi, Ginzburg, Sereni and Zargani.
MARIA GRAZIA COSSU si è laureata in Pedagogia (1989) e in Lettere moderne (2000), ed è docente di
lettere nella scuola superiore. Nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Letterature
comparate (tesi sulla figura della madre nella scrittura autobiografica di Marguerite Yourcenar e Lalla
Romano), e di Cultrice della materia di Letteratura italiana contemporanea. Attualmente collabora
nell’ambito del corso di Letteratura italiana contemporanea della facoltà di Lettere dell’Università
degli Studi di Cagliari e si occupa di scrittura femminile. Fra le sue pubblicazioni, alcuni articoli sulla
peste nella letteratura del Novecento, in particolare in Camus, in Raoul Maria de Angelis, nel teatro di
Artaud e in alcuni spettacoli della scena contemporanea. Si occupa inoltre di letteratura ebraica
italiana.
MARIA CARMELA D’ANGELO, impegnata da anni in attività di insegnamento e diffusione della
lingua e cultura italiane in diverse realtà scolastiche oltre confine per conto del Ministero degli Affari
Esteri italiano, attualmente svolge la funzione di Lettore MAE presso la Facoltà di Lettere,
Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze, nella Rijksuniversiteit Groningen. In quanto tale, oltre
all’insegnamento, si dedica all’organizzazione di eventi culturali e seminari di aggiornamento, non
disgiunti dalla ricerca scientifica in diversi campi: dalla didattica e formazione docenti a tematiche
legate a diverse forme espressive di comunicazione tra culture, in particolare cinema e letteratura.
GABRIELLA DE ANGELIS ha insegnato a lungo Letteratura Italiana e poi Lingua e Letteratura Latina
e Greca nei Licei Classici di Roma. In seguito ha lavorato presso l’Università di Rabat dove,
nell’ambito di un progetto in collaborazione con l’Università di Bologna, ha curato la nascita e
l’organizzazione del Dipartimento di Italianistica e si è occupata della formazione dei futuri docenti.
Ha insegnato infine Lingua e Letteratura italiana all’Université de Provence, dove attualmente sta
lavorando a una ricerca su Clara Sereni. Tra i suoi interessi principali la rappresentazione della
condizione femminile nelle letterature e la scrittura delle donne.
LUCA DE ANGELIS, dopo essersi laureato a Ferrara, è stato borsista per un corso di perfezionamento
presso l’EHESS di Parigi. Insegna Letterature Comparate all’Università di Trento e tiene dei seminari
di Letteratura Italiana all’Università di Münster. In modo particolare si è dedicato allo studio socioletterario della condizione ebraica degli scrittori ebrei italiani ed europei del Novecento. Ha curato tra
l’altro il volume L'ebraismo nella letteratura italiana del Novecento (1995); E. Schmitz, Diario (1997). Di
recente ha pubblicato il saggio Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica del Novecento italiano
(2006).
ELRUD IBSCH is professor emerita of General and Comparative Literature, Vrije Universiteit
Amsterdam. She published on theory of literature, literary history of the twentieth century, and
Holocaust literature. With Douwe Fokkema she wrote Theories of Literature in the Twentieth Century
(1977, 1995, Italian translation: Teorie della letteratura del XX secolo, 1981), Modernist Conjectures (1988),
and Knowledge and Commitment (2000). She is editor of several volumes, among others The Conscience of
Humankind (2000). Her book Die Shoah erzählt: Zeugnis und Experiment in der Literatur has been
316
published in 2004. ‘La scrittura contro il silenzio: autori ebrei del dopoguerra in Olanda, Germania,
Francia e Austria’ appeared in Sessant’anni dopo. L’ombra della seconda guerra mondiale sulla letteratura del
dopoguerra (2006).
INGE LANSLOTS si è laureata in filologia romanza all’Università di Anversa. Sotto gli auspici di
Walter Geerts ha iniziato una ricerca di dottorato sulla nozione del tempo nella letteratura
contemporanea, dal titolo Gli orologi molli. La narrativa italiana contemporanea e la conoscenza del tempo,
ricerca conclusasi nel 1998. Specializzatasi nella narrativa italiana contemporanea, ha scritto vari
contributi su più autori (quali Baricco, Buzzati, Calvino, Camilleri, De Luca, Eco, Ortese, Tabucchi),
ma anche sul giallo e sui (cant)autori. Ora è docente d’italiano presso la Lessius Hogeschool, un
Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori ad Anversa (che dipende dall’Università di Lovanio), e
l’Università di Anversa.
STEFANIA LUCAMANTE è professore associato di letteratura italiana e comparata presso la Catholic
University of America a Washington D.C. dove dirige il programma d’Italiano. Fra le sue
pubblicazioni si segnalano Elsa Morante e l'eredità proustiana (1998); Italian Pulp Fiction: The New
Narrative of the Giovani Cannibali Writers (a cura di; 2001) [in ordine cronologico?]; Isabella Santacroce
(2002). Con Sharon Wood ha curato ‘Under Arturo’s Star’: The Cultural Legacies of Elsa Morante (2005).
Di prossima pubblicazione: A Multitude of Women: The Challenges of the Contemporary Italian Novel
(University of Toronto Press).
ALFREDO LUZI è ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea all'Università di Macerata.
Insegna anche Sociologia della letteratura, Letterature Comparate, Storia della lingua italiana,
Didattica della letteratura del Novecento. Ha dedicato studi alla poesia italiana contemporanea, in
particolare a Mario Luzi e a Vittorio Sereni, alla letteratura d’emigrazione, alla sociologia letteraria,
alla narrativa del Novecento, pubblicando volumi e saggi su Slataper, Bigiaretti, Volponi, Tomizza. È
stato professore invitato in numerose università europee, americane ed australiane.
STEFANO MAGNI ha terminato nell’ottobre 2006 un dottorato in letteratura italiana contemporanea
con una tesi in cotutela tra l’Université Paris 8 e l’Università degli Studi di Trieste dal titolo
Détournement des genres dans la production narrative postmoderne en Italie sotto la direzione di Marina
Fratnik e di Elvio Guagnini. Ha insegnato nelle università Stendhal-Grenoble 3 e Paris 1 e 4. Ha
pubblicato numerosi articoli di letteratura contemporanea, occupandosi principalmente delle nuove
tendenze della letteratura italiana (e di diversi autori contemporanei tra cui Ammaniti, Benni, Busi,
Macchiavelli, Manganelli, Tondelli, Vassalli) e delle memorie e delle fiction riguardanti le due guerre
mondiali (analizzando, tra gli altri, i testi di Frescura, Gadda, Jahier, Lussu, Marinetti, Monelli,
Meneghello, Revelli, Salsa, Soffici).
LAURA QUERCIOLI MINCER insegna Storia e cultura ebraica nei paesi slavi all’Università di Roma
‘La Sapienza’. È traduttrice dal polacco e autrice di numerosi articoli e saggi sulla cultura ebraica
moderna in Europa Centro-Orientale. Fra le sue pubblicazioni più recenti, il volume Cafè Savoy. Teatro
yiddish in Europa, curato con Paola Bertolone (2006), la cura di Per amore della lingua. Incontri con
scrittori ebrei (2005) e il capitolo sulla Letteratura yiddish ed ebraico-polacca nella Storia della letteratura
polacca curata da Luigi Marinelli (2004). Sta scrivendo un libro sulla letteratura ebraica del dopoguerra
in Italia e in Polonia.
317
ADA NEIGER ha insegnato, in qualità di professore incaricato di Letteratura italiana, all’Università
italiana per stranieri di Perugia (1978-1985). È docente di Sociologia della Letteratura e Letterature
comparate presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento a partire
dall’anno accademico 1985-86. Fa parte del Comitato di Redazione della Rivista Annali di
Sociologia/Soziologisches Jahrbuch. Partecipa, in qualità di docente, al Dottorato di Ricerca in Italianistica,
‘Problemi relativi alla nascita formazione e sviluppo della letteratura di massa’ con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste. Tra le sue pubblicazioni più recenti di
argomento ebraico si segnalano: ‘Campo di concentramento’ in Dizionario dei temi letterari (2007);
‘Bassani noir’ in Linee d'ombra. Letture del fantastico in onore di Romolo Runcini (2004); ‘Storie di “vite
nascoste” in Thomas Mann e Giorgio Bassani’ in Omaggio ad un amico - Miscellanea di studi critici in
memoria di Pompeo Giannantonio (2002).
SOPHIE NEZRI è professore associato all’Université de Provence dove insegna la letteratura italiana
contemporanea. Ha scritto una tesi di dottorato, un libro (Primo Levi: una memoria ebraica del Novecento
(2002)) e numerosi articoli su Primo Levi (sullo stile, le poesie, le immagini, il riso o il teatro leviano); si
interessa alla letteratura e alla cultura italoebraica, alle specificità dell’ebraismo peninsulare (storia,
periodo chiave del Risorgimento, memoria, conservazione del passato), alla letteratura
concentrazionaria (testimonianze letterarie e non di deportati ebrei), nonché al rapporto tra Storia e
letteratura nelle testimonianze e nei libri degli ebrei italiani. Studia anche la rappresentazione e
l’immagine dell’Altro in letteratura. Ha partecipato a numerosi convegni in Europa su Primo Levi e la
letteratura italoebraica.
FEDERICO PELLIZZI è Professeur invité di Letteratura italiana contemporanea presso l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux III (2007). Dal 2002 è professore a contratto di Letteratura italiana
presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna (sede di Ravenna) e
collabora con la cattedra di Letterature comparate presso la Facoltà di Lingue, letterature e culture
moderne dell’Università IULM di Milano. Nel 1995 ha fondato, presso l’Università di Bologna, la
prima rivista di letteratura italiana e critica letteraria online, Bollettino ’900, che tuttora dirige. Ha
tradotto per Il Mulino e per Adelphi. Collabora a Synapsis - European School for Comparative Studies
(Università di Siena e di Bologna) e a ICoN - Italian Culture on the Net (Università di Pisa e
consorziate). Ha pubblicato saggi sulla letteratura e la critica del Novecento in numerose riviste. Ha
curato recentemente il fascicolo monografico de il verri dedicato a Le forme del racconto (2006) e il
volume Letterature biblioteche ipertesti (2005), e sta ora per pubblicare un volume su Michail Bachtin.
GIORGIO PRESSBURGER lasciò il proprio paese all’indomani dell’invasione sovietica dell’Ungheria
nel 1956 insieme al fratello gemello Nicola (poi morto nel 1985), con cui scrisse i primi libri.
Protagonista della cultura italiana, organizzò festival e altre manifestazioni culturale, fra l’altro a
Spoleto e Udine. È autore di testi teatrali, regista teatrale e cinematografico e ha svolto attività di
docente. Fra la sua opera narrativa, si ricordano Storie dell’Ottavo Distretto (1986), L’elefante verde (1986),
La legge degli spazi bianchi (1989), Il sussurro della grande voce (1990), Denti e spie (1993), I due gemelli
(1996), La neve e la colpa (1998), Di vento e di fuoco (2000) e L’orologio di Monaco (2003). Vive tra Roma e
Trieste.
MARILENA RENDA si è laureata nel 2000 a Palermo con una tesi su Amelia Rosselli e Sylvia Plath.
Ha conseguito un dottorato in Italianistica a Palermo con la tesi Una questione a margine. Ebraicità e
scrittura in Giorgio Bassani e Primo Levi. Ha scritto saggi su Bassani, Levi, Rosselli. Insegna e traduce.
Collabora a Stilos.
318
STEFANIA RICCIARDI lavora come docente a contratto all’ISTI-HEB (Institut supérieur de
traducteurs et interprètes de la Haute école de Bruxelles) ed è traduttrice e dottore in Etudes italiennes
all’Università di Bordeaux 3, dove è stata lettrice e ricercatrice. Ha curato, insieme a Martine BovoRomoeuf, il volume Frammenti d’Italia. Le forme narrative della non-fiction (2006). Ha firmato la
postfazione alla riedizione di Occhio per occhio (2006) di Sandro Veronesi, autore del quale sta
preparando una monografia per le edizioni Cadmo. Di prossima pubblicazione: Gli artifici della nonfiction. La messinscena narrativa in Albinati, Franchini, Tondelli, Veronesi (2008).
HANNA SERKOWSKA è professore associato all’università di Varsavia, dove insegna lingua e
letteratura italiana. Ha pubblicato tre monografie e ha curato un volume (tutti sulla letteratura italiana
contemporanea), tra cui si ricordano Le radici medioevali di Federigo Tozzi (1994) e Uscire da una camera
delle favole. I romanzi di Elsa Morante (2002). Si occupa soprattutto di letteratura contemporanea, scrive
recensioni per la rivista Nowe Ksiazki, collabora alle riviste letterarie dell’Accademia Polacca delle
Scienze: Teksty Drugie, Pamietnik Literacki. Il suo progetto di ricerca attuale concerne l’analisi critica di
approcci recenti alla ricerca storica in generale e di rappresentazioni finzionali del passato nel
Novecento in particolare.
MIRO SILVERA immigrò in Italia nel 1947 quando gli ebrei furono espulsi dalla Siria. È stato
consulente editoriale e traduttore ed ha collaborato con numerose riviste. Debuttò come poeta con
Liber singularis (1979), cui fecero seguito vari libri di poesia. Negli ultimi decenni è attivo soprattutto
come narratore e saggista. Fra le sue opere, si ricordano L’ebreo narrante (1993), Margini d’amore (1994),
Il prigioniero di Aleppo (1996), Il senso del dubbio (2001) e Contro di noi (2003). Dal suo romanzo I giardini
dell’Eden (1998), dedicato alla gioventù di Yeshua ossia Gesù, è stato tratto un film di Alessandro
D’Alatri, con sceneggiatura dello stesso autore.
RANIERO SPEELMAN studiò italianistica e storia dell’arte a Leida e insegna lingua e letteratura
italiana e studi del Rinascimento all’Università di Utrecht. Si è specializzato in studi italoebraici, sui
quali ha pubblicato numerosi articoli, ma si è dedicato anche alle relazioni fra gli stati italiani e
l’Impero Ottomano (da menzionare, le edizioni di un canzoniere di Pietro Della Valle e delle Lettere
sulle cose dei turchi di Pietro Businello, entrambi sulla rivista elettronica EJOS) e a studi di
traduttologia. Ha curato varie antologie di racconti italiani contemporanei ed ha tradotto fra l’altro
cinque libri di racconti, saggi e poesie di Primo Levi in neerlandese.
SARA VANDEWAETERE si è laureata in lingue romanze nel 2001 presso l’università di Anversa. Nel
2002 ha svolto un anno di specializzazione in italiano (DEA) all'università di Paris X, con una tesi
sull'intertestualità dantesca nell’opera di Primo Levi. Nel 2002, ha conseguito una borsa di studio del
collegio dei Fiamminghi a Bologna, svolgendo attività di ricerca. Nel luglio del 2003 è tornata
all’università di Anversa, dove attualmente lavora a una tesi di dottorato sugli aspetti sensoriali nella
vita, nella filosofia e nell’opera di Primo Levi. Ha pubblicato diversi articoli su aspetti dell’opera
leviana, tra cui l’intertestualità dantesca, l’influenza di Chagall sull’opera di Levi e l’influenza di Levi
sul regista ebreo-americano Woody Allen.
PAOLO VANELLI, bolognese d’origine, vive da lungo tempo a Ferrara (Italia), dove insegna
Letteratura Italiana e Storia negli Istituti Superiori. La sua attività di conferenziere e saggista lo vede
impegnato soprattutto sull’Ottocento e sul Novecento letterario italiano. Consigliere della Società
Dante Alighieri, si impegna nella diffusione della cultura italiana in Italia e all’estero. Come saggista
ha pubblicato vari saggi letterari su riviste italiane e straniere. Suoi saggi sono presenti nei volumi:
Corrado Covoni e l’ambiente letterario ferrarese del primo Novecento (1984); I tempi del rinnovamento - Atti del
Convegno internazionale (1995); I segni incrociati - Letteratura Italiana del Novecento e Arte figurativa (1998);
Quaderni della Dante (dal 2000 al 2007). Ha curato l’antologia degli scritti di Mario Tobino, uscita in due
319
edizioni (1994 e 2001), col titolo Ecco Tobino. Recentemente è uscito il suo volume Le icone del testo –
Saggi sulla narrativa italiana contemporanea (2006) dove ha fatto il punto sugli autori che hanno
maggiormente sollecitato il suo interesse di lettore e di critico – Bassani, Buzzati, Mancinelli, Pardini,
Pazzi e Tobino.
CRISTINA VILLA è lettrice di italiano presso la University of Southern California a Los Angeles. Ha
ottenuto il dottorato in italiano presso la University of California Los Angeles e il masters presso
l’University of Wisconsin, Madison. Si occupa principalmente di cinema italiano e tedesco, studi sulla
shoah e di letteratura ebraica. In aggiunta lavora anche come traduttrice. Tra le sue pubblicazioni si
ricordano: Crescendo (Workbook and Labmanual) (coautore; 2007); ‘Il silenzio dei vivi. La letteratura della
deportazione razziale nell’Italia del boogie-boogie, della rivolta studentesca e del terrorismo’ in Italian
Fiction of the Sixties and the Seventies (2007); ‘The Moon and the Bonfires by Cesare Pavese’. in World
Literature and its Times 7: Italian Literature and its Times (2005); ‘Alla ricerca del midollo del leone e
l’Ariosto geometrico di Calvino’ in Romance Studies (2004); ‘La bambola di pietra: Il dolore del ricordo,
il ritorno del rimosso, l’incomunicabilità e il silenzio nell’Attrice di Edith Bruck’ in Carte Italiane (2003).
320