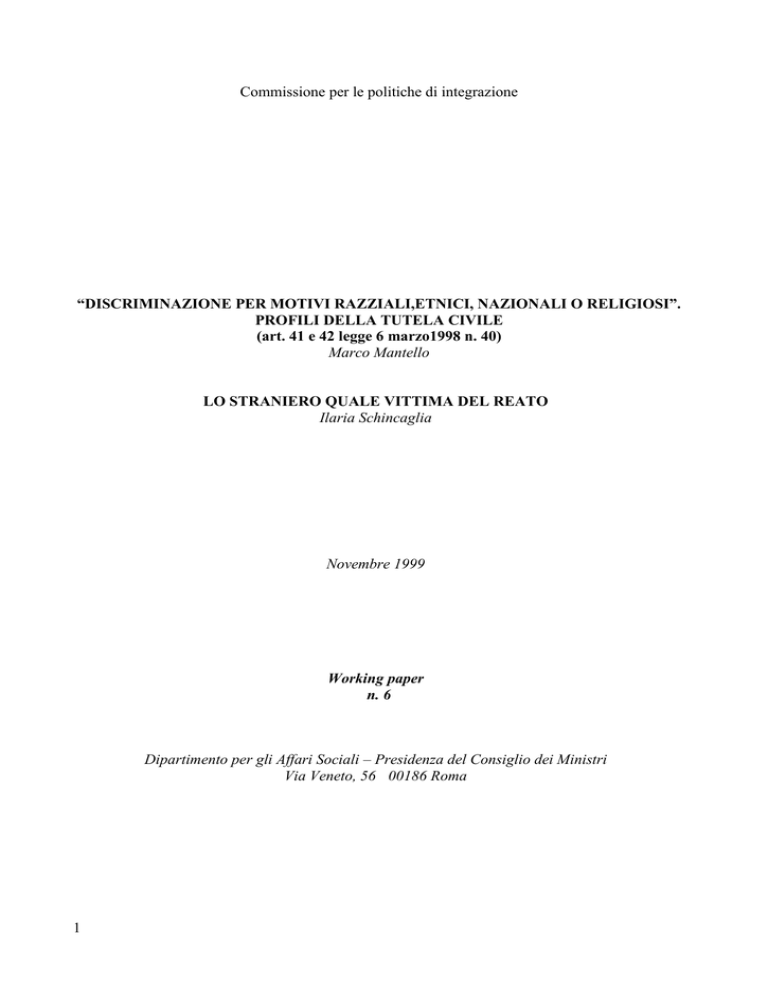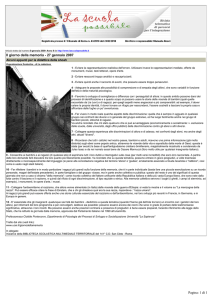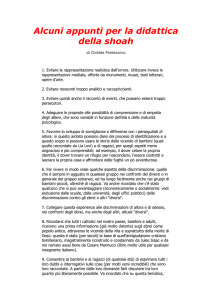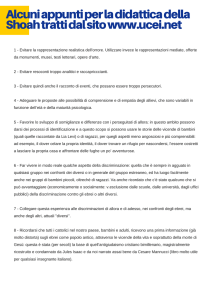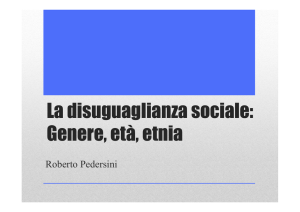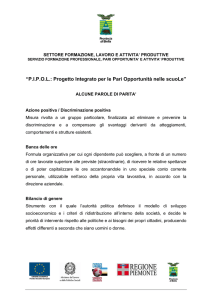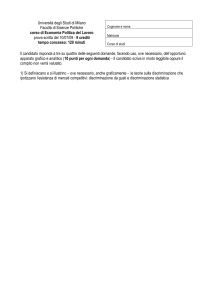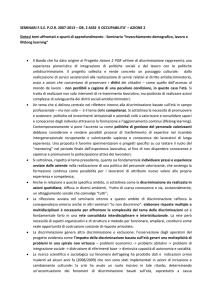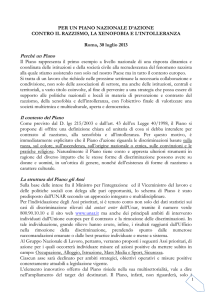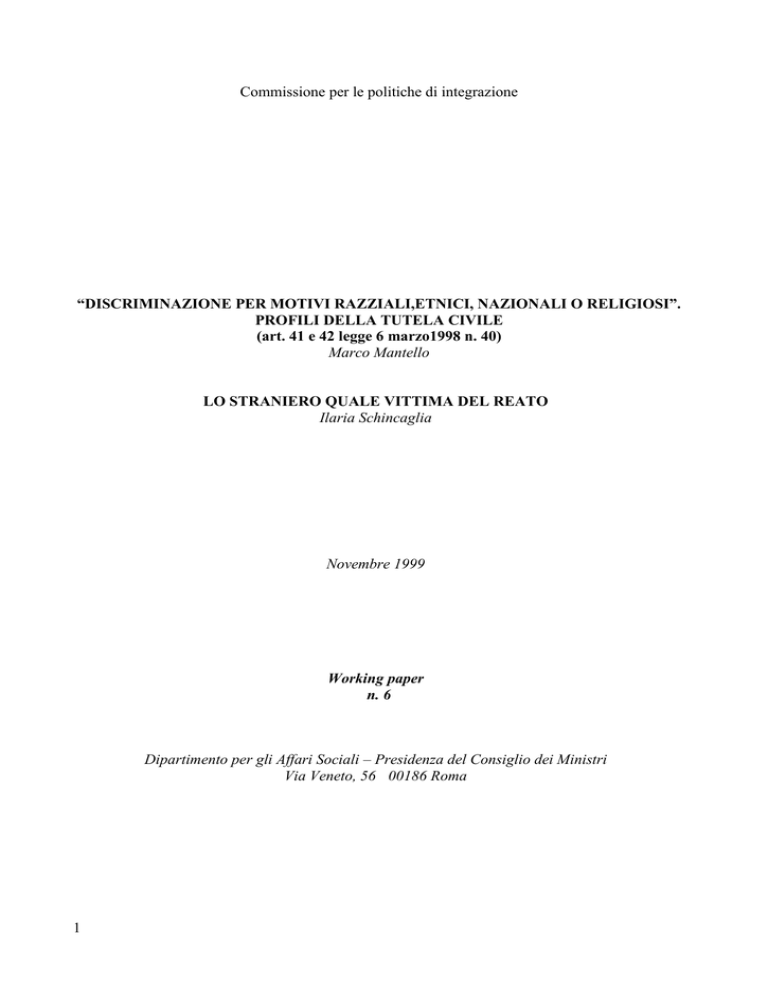
Commissione per le politiche di integrazione
“DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI,ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI”.
PROFILI DELLA TUTELA CIVILE
(art. 41 e 42 legge 6 marzo1998 n. 40)
Marco Mantello
LO STRANIERO QUALE VITTIMA DEL REATO
Ilaria Schincaglia
Novembre 1999
Working paper
n. 6
Dipartimento per gli Affari Sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Veneto, 56 00186 Roma
1
INDICE
DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI
RAZZIALI,ETNICI, NAZIONALI O
RELIGIOSI. PROFILI DELLA
TUTELA CIVILE
(art. 41 e 42 legge 6 marzo1998 n. 40)
Marco Mantello
pag. .3
LO STRANIERO QUALE VITTIMA ………….pag. 17
DEL REATO
Ilaria Schincaglia
Le ricerche di Marco Mantello e Ilaria Schincaglia sono state realizzate su proposta e con
contributo della Commissione.
2
“DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI,ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI”.
PROFILI DELLA TUTELA CIVILE
(art. 41 e 42 legge 6 marzo1998 n. 40)
Marco Mantello
“Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi”. Profili della tutela civile
(art. 41 e 42 legge 6 marzo 1998 n. 40)
L’analisi letterale dell’art. 41in relazione ai rimedi civilistici previsti dall’art. 42. L’ambito di
applicazione oggettivo della clausola generale di discriminatorietà; le singole ipotesi di
“comportamento discriminatorio” previste dal secondo comma dell’art. 41. In particolare:
impossibilità di rinvenire un regime di presunzioni iuris et deiure di “discriminatorietà”.
L’analisi sostanziale del concetto di “discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi”. In particolare: estensibilità dell’ambito di applicazione oggettivo dell’art. 41
comma 1 alle discriminazioni legate agli orientamenti sessuali della persona. La tutela civile
contro le discriminazioni.
L’articolo 41 comma I legge n. 40/1998, stabilisce attraverso una clausola generale 1 cosa debba
intendersi per “discriminazione” dovuta a “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, ai fini del
Capo IV della legge medesima. Lo stretto legame instaurato dal legislatore fra il ricorrere di una
“discriminazione” e l’applicabilità dei rimedi previsti dall’art. 42, richiede un’indagine
preliminare sul senso e la portata della clausola di “discriminatorietà”.
In particolare, l’art. 41 comma 1 si riferisce ad “ogni comportamento che direttamente o
indirettamente, comporti (sic!) una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e
che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
Il significato del termine “comportamento” non pone particolari problemi interpretativi, dovendosi
comprendere in esso tanto le “azioni” quanto le “omissioni”. Queste ultime, salvo il caso previsto
alla lettera (a) del secondo comma della norma in esame, si risolvono in un dovere generico di
“non impedire mediante astensione”.
L’azione o l’omissione è in rapporto di causalità, diretta o indiretta, con una serie di “fatti
discriminatori”(“distinzione, esclusione, restrizione, preferenza”, basate tutte su “razza, colore,
ascendenza ecc.”).
La causalità diretta, a parte le ipotesi in cui assume rilevanza il criterio della prognosi postuma 2,si
spiega attraverso il richiamo alla teoria della condicio sine qua non, che sul piano linguistico
postula un condizionale congiuntivo, nell’ambito di un periodo ipotetico in cui il fatto ipotizzato
1 Su questa tecnica di normazione cfr. Di Majo, Obbligazioni in generale, Bologna, 1995, pp. 296 ss.
L’indeterminatezza fisiologica della “clausola generale”, che non individua la fattispecie mediante la descrizione di un
“fatto”, ma sottende la necessità di valutare un “comportamento”, impone all’interprete di ricercare una serie di indici
normativi attraverso cui possa correttamente esplicarsi, nel caso concreto, la discrezionalità applicativa del giudice
adito.
2 Mi riferisco alla c.d. teoria della causalità adeguata ,di regola riconnessa agli illeciti aggravati dall’evento.
3
nella protasi è contrario a un fatto conosciuto come vero3; su quello della “realtà sensibile” si
ricollega invece alla c.d. sussunzione sotto leggi scientifiche, e nella maggior parte dei casi
garantisce solo un grado variabile di probabilità alla connessione causale ipotizzata.
Il termine “causalità indiretta” sembra rinviare non tanto a comportamenti che, pur non
costituendo in senso proprio un logicamente “ineliminabile” e temporalmente “contestualizzato”
antecedente del fatto, si pongano in funzione “ausiliaria” o “complementare” rispetto alle condotte
causalmente rilevanti, né tantomeno alla formale inerenza della condotta considerata a un evento
diverso rispetto a quello della “distinzione, esclusione, restrizione, ecc.”, evento che costituisce a
sua volta la causa prossima del fatto discriminatorio. Piuttosto il comportamento che
indirettamente determini una distinzione, restrizione, ecc., basata sulla razza, il colore, ecc., è dato
dall’applicazione formalmente indifferenziata, da parte dell’agente o dell’omittente, dello stesso
criterio selettivo ai fini dell’accesso di qualsiasi terzo all’utilità da lui offerta, criterio che di fatto
consenta l’accesso a quella utilità ovvero lo escluda solo per un certo gruppo “razziale”,
“religioso”, ecc., rispetto al resto della “collettività”.
In termini generali, è opportuno distinguere un lato passivo e un lato attivo del “fatto
discriminatorio”. Si riferiscono al lato passivo i termini “distinzione” ed “esclusione”, al lato
attivo i termini “restrizione” e “preferenza”.
In particolare, vi sarà una “distinzione” in quanto, dati due “soggetti” B e C, i quali richiedano
entrambi di accedere a una certa “utilità” X, il titolare di quella “utilità” consenta a B di accedere a
X , ma a condizioni più sfavorevoli rispetto a C. Vi sarà una “esclusione” qualora a B, e solo a B,
sia impedito l’accesso all’utilità X. La distinzione o l’esclusione di B rispetto a C da parte del
titolare di X deve essere fondata su una determinata “proprietà” di B, non rinvenibile in C (razza,
colore, ascendenza ecc.)
Quanto invece al lato attivo, la “restrizione” indica il caso in cui l’accesso alla utilità X sia
consentito a B e solo a B, a causa di una determinata “proprietà” (razza, colore, ascendenza ecc.)
del medesimo, con esclusione di C. La “preferenza” indica invece qualsiasi modalità di accesso
alla utilità X, riservata a B e solo a B, a causa di una determinata “proprietà”(razza, colore,
ascendenza ecc.) del medesimo, con trattamento di sfavore verso C. In quest’ultimo caso, si badi
bene, anche C può formalmente accedere all’utilità.
L’accertamento del fatto discriminatorio sottende un giudizio di tipo “comparativo” fra
“trattamenti differenziati”: dati due soggetti B e C, che richiedano a D una certa utilità X, il fatto
che D applichi un trattamento differenziato a B rispetto a C deve essere imputabile all’esistenza in
B di un elemento (razza, colore, ecc.) che di fatto assuma rilevanza migliorativa o peggiorativa
della condizione di B rispetto a C.
Il comportamento determinativo del fatto discriminatorio si risolve in una “discriminazione” solo
in quanto abbia come “scopo” o come “effetto” la “lesione” di un “diritto umano” o di una “libertà
fondamentale”, nei termini precisati dall’ultima parte dell’art. 41 comma 1. L’alternativa tra
“scopo” ed “effetto” sembra rinviare, attraverso l’uso della congiunzione “e”, ad una ulteriore
connessione causale dell’uno o dell’altro con il “comportamento”, nel senso che non ogni azione
od omissione produttiva di una distinzione, esclusione, ecc., dovuta alla razza, al colore, ecc., sia
di per sé solo una “discriminazione”. Ai fini del perfezionamento della fattispecie assume
rilevanza il ricorrere di uno “scopo” o di un “effetto” discriminatorio. L’alternativa
“scopo”/“effetto” è stata prevista dal legislatore non solo per svincolare l’operatività del rimedio
ex art. 42 comma I dalla rilevanza degli stati soggettivi dell’agente o dell’omittente, ma anche per
consentire al giudice adito di inibire ogni comportamento direttamente o indirettamente finalizzato
a una “discriminazione”, a prescindere dall’esistenza di una concreta lesione di un diritto umano o
di una libertà fondamentale ovvero dalla potenziale separabilità di questa dal “fatto”
discriminatorio. Così, senza il vincolo di una prova circa il ricorrere dell’elemento “soggettivo”, il
3 Per tutti Stella, Rapporto di causalità, in “Enc. giur. Treccani”,Roma, 1988, pp. 3 ss.
4
giudice che riscontri, anche a mezzo di presunzioni semplici, una condotta avente l’effetto di
“discriminare”, ordinerà , se necessario, una restitutio in integrum e in ogni caso la cessazione del
comportamento pregiudizievole. Senza il vincolo di una lesione in atto al momento della
proposizione del ricorso, il giudice che riscontri in un dato comportamento uno scopo
discriminatorio ne ordinerà per ciò solo la cessazione.
In molti casi è ragionevolmente presumibile che “fatto” e “scopo” od “effetto” non siano così
distanti l’uno dall’altro. Sono le ipotesi in cui la lesione o l’intento di ledere una libertà
fondamentale o un diritto umano, anche se logicamente separabili rispetto al fatto discriminatorio
della “distinzione, esclusione, restrizione o preferenza” basate sulla razza, il colore, ecc., appaiano,
in base a una valutazione sociale tipica, sostanzialmente connaturati al “fatto”.
Un esempio, seppure stilizzato, può forse chiarire come operi la “valutazione sociale” nel
ricondurre presuntivamente l’“effetto” al “fatto” discriminatorio: un ragazzino rom, sui tredici
anni, entra in un noto self-service di Largo Argentina e domanda un bicchiere d’acqua, confortato
dal fatto che, poco prima di lui, tre ragazzi sulla ventina, con un ottimo accento toscano, avessero
ottenuto un bicchiere ciascuno da un ligio e rispettoso barista. Il medesimo inserviente risponde di
no alla domanda del ragazzino, senza altro specificare ed ignorando accuratamente ogni sua
richiesta di spiegazione. Il ragazzino esce sconsolato dal noto self-sevice di Largo Argentina.
La stretta connessione tra il fatto e lo scopo o l’effetto discriminatori assume particolare rilevanza
nelle ipotesi di “discriminazione indiretta”. Così, una scuola privata esige, per espressa
disposizione statutaria, che tutti gli allievi indossino un certo abbigliamento nelle ore scolastiche
(nelle ore di lezione in classe: gonne a righe blu per le ragazze, bermuda e berretto blu per i
ragazzi. Nelle ore di educazione fisica: divieto per tutti di portare cappelli e obbligo per le ragazze
di indossare pantaloncini corti di un certo tipo). La previsione statutaria di questi obblighi produce
l’effetto di escludere da alcune attività scolastiche, come ad esempio l’educazione fisica, gli alunni
e le alunne che, per motivi religiosi, debbano necessariamente indossare un turbante, nonché le
alunne di religione musulmana, cui è preclusa, per ragioni di fede, la possibilità di presentarsi in
pubblico con le gambe scoperte . In una simile eventualità il giudice adito ax art. 42comma 1
dovrà valutare, su basi rigorosamente oggettive, se la norma dello statuto sia giustificata da cause
di per sé non “discriminatorie”, per esempio da specifiche finalità educative della scuola privata in
questione, di per sé meritevoli di tutela o comunque non incompatibili con le norme e i principi,
specie quelli costituzionali, cui aderisce l’ordinamento italiano in materia di “educazione” e
“formazione” del minore. In caso contrario, egli potrà adottare, per il solo fatto della “esclusione”,
ogni provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti discriminatori ad essa
conseguenti4.
In termini più generali, l’oggettiva riscontrabilità di un trattamento differenziato e ingiustificato,
che si risolva in una presunzione iuris tantum di discriminatorietà, potrebbe essere facilitata
attraverso opportuni rilievi statistici5, in ordine ai “comportamenti” usuali di un certo “soggetto”,
considerato uti singulus o come parte di un “gruppo”, rispetto a una data categoria di persone. In
questa prospettiva deve essere letto il disposto dell’art. 42 comma 12,ai sensi del quale “le regioni,
4 Questi esempi sono “liberamente” tratti dal Code of Practice for the elimination of racial discrimination
ineducation, del dicembre 1989, a cura della Commission for Racial Equality, istituita in Gran Bretagna con il Race
Relations Act 1976.Si rinvia in particolare alle pp. 10, 15 s., 18.
5 In questa prospettiva assumerà notevole rilevanza l’impegno di tutti coloro che si occupino attivamente di
“immigrazione” nel promuovere le opportune indagini statistiche circa il trattamento abitualmente riservato a
determinati soggetti. La carenza di “informazioni” circa il diffondersi o l’esistenza di pratiche discriminatorie in
determinati settori della vita economica, politica, sociale, ecc. si traduce in una maggiore debolezza, sul piano
“probatorio”, del ricorrente ex art.41.
5
in collaborazione con le province e coni comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri”, dovendosi ritenere il richiamo all’ “informazione” come comprensivo di attività di
raccolta dati. Peraltro, il richiamo operato dalla norma ai soli “stranieri vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” non può essere inteso in chiave
limitativa, al fine di dispensare le regioni dal predisporre i mezzi economici necessari allo
svolgimento, continuativo o periodico, di indagini statistiche dirette ad accertare eventuali ed
usuali“disparità di trattamento” nei più rilevanti settori della vita pubblica, a danno non solo di
stranieri, ma di qualsiasi gruppo razziale, etnico o religioso considerato “a rischio”, senza che
assuma rilevanza a tal fine la nazionalità dei suoi membri (si argomenti ex art. 41 comma 3).
Di regola lo scopo o l’effetto discriminatori costituiscono un quid pluris rispetto al “fatto” della
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, ecc. Ciò significa che
dovrebbero intendersi come “non discriminazioni” quei comportamenti determinativi di un
trattamento differenziato basato su razza, colore ecc., posti in essere al fine ovvero produttivi
dell’effetto di(...) tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali di un certo individuo, inteso uti
singulus o come parte di un “gruppo”. Ma una argomentazione a contrario di questo tipo dovrà
fare i conti con la reale possibilità che una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza, basate
sulla razza o sul colore, risultino essere ad adiuvandum rispetto al soggetto passivo.
Piuttosto, un comportamento determinativo di un trattamento differenziato non si traduce in una
“discriminazione”, e dunque può distinguersi tra un “fatto” e uno “scopo” ovvero un “effetto”,
qualora si richiedano determinate caratteristiche, per esempio somatiche, per lo svolgimento di
una certa attività, in ragione delle specifiche esigenze “tecniche” ad essa inerenti. Si pensi al caso
di un provino cinematografico in cui la parte da assegnare agli aspiranti attori sia quella di un
gangster anni trenta, di origine polacca, biondo e con gli occhi azzurri, ovvero quella di un
bambino coreano.
È ovvio che, fra tutti gli aspiranti attori, saranno “preferiti” soggetti in possesso dei tratti somatici
espressamente richiesti dal copione. E ancora, un fotografo ritiene indispensabile, in
considerazione del tipo di servizio a lui commissionato e della particolarità dei giochi di luce che
egli intenda realizzare, che la modella o il modello siano neri e dunque esclude dalle selezioni tutti
quelli che non hanno il colore della pelle specificamente richiesto; un’impresa con sede a Torino
assume una persona di nazionalità giapponese residente da alcuni anni in Italia per occuparsi
dietro corrispettivo di “procacciamento di affari” nelle città di Tokyo, preferendolo a un italiano
laureato in lingue orientali, in base alla presunzione di una migliore padronanza di usi e di
tradizioni culturali di quel paese da parte del primo, ciò che era stato ritenuto rilevante ai fini di un
proficuo espletamento dell’attività lavorativa richiesta.
Quanto osservato finora vale senza dubbio per gli strumenti di tutela di cui all’art. 42 comma 1.
Diverse sono invece le condizioni di risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ex art. 42
comma 7: ai fini dell’applicabilità di questo rimedio è sempre necessaria una concreta “lesione” di
un diritto umano o di una libertà fondamentale. In particolare, possono darsi almeno tre
alternative:
1) Il giudice adito ritiene che la riscontrabilità, nel caso di specie, di un “effetto” discriminatorio
non escluda la necessità di provare quantomeno la “colpa” dell’agente o dell’omittente, sempre
ammesso che sia configurabile una fattispecie “colposa” di “discriminazione per motivi razziali,
etnici, ecc.”. In tal modo si ricollega tout court il settimo comma dell’art. 42ai criteri di
imputazione soggettiva previsti dall’art. 2043,giustificando la risarcibilità “anche del danno non
6
patrimoniale”, inteso come “danno morale subiettivo” 6 , attraverso il richiamo ai “casi previsti
dalla legge” operato dall’art. 2059.
2) Se invece, con il termine “effetto discriminatorio” si intenda la mera rilevanza del nesso causale
fra “comportamento” e “lesione” anche agli effetti dell’ingiustizia del danno, l’art. 41 comma 1
fonderebbe un’ipotesi di responsabilità per mera “causalità”7. Il richiamo all’art.2043 sarebbe in
tal caso limitato alla “clausola generale” di “ingiustizia del danno” in esso contenuta mentre il
criterio di imputazione della responsabilità sarebbe già rinvenibile nell’“effetto” di cui parla la
norma in esame. Questa soluzione potrebbe avere un fondamento dogmatico, alla luce di quegli
orientamenti dottrinari 8 che ritengono che l’art. 2043 esprima una “clausola generale” solo
rispetto alla “lesione di un interesse giuridicamente rilevante”, non anche ai criteri di imputazione
ivi contenuti (dolo o colpa)9. Sorgerebbe peraltro la necessità di individuare la specifica ratio di
una responsabilità senza colpa, laddove le ipotesi normative conosciute dal diritto civile in cui sia
rinvenibile o una svalutazione, sul piano probatorio, dell’elemento soggettivo (responsabilità
cosiddetta semi-oggettiva) o addirittura un criterio di imputabilità per mera causalità dell’evento
lesivo all’agente od omittente, sono ricollegate ora alla natura dell’attività esercitata, ora alla
individuazione di un risk bearer, ora a una situazione “lato sensu” dominicale.
3) L’alternativa tra “scopo” ed “effetto” di cui all’art. 41 comma 1 consente al massimo di
rinvenire una attenuazione delle regole ordinarie di cui al punto 1) , nei casi in cui il giudice possa
ragionevolmente presumere, in base a una valutazione sociale tipica, che la “distinzione,
esclusione, restrizione, preferenza”, in sé e per sé considerata, sia già determinativa della lesione.
Questi principi potrebbero valere per i fornitori di beni o servizi offerti al pubblico di cui all’art.
41 comma2 lettera b), i quali adottino pratiche discriminatorie “individuali” ovvero rientranti negli
“usi” di un più ampio settore “commerciale” e, più in generale, in tutti i casi in cui il
comportamento del convenuto determini un trattamento socialmente valutabile come
“ingiustificato” nei confronti di un certo individuo o di un certo gruppo di soggetti, rispetto a
quello normalmente riservato a un tertium comparationis (costituito da altro gruppo di individui se
non dall’intera collettività) ovvero al valore della “persona”, intesa come entità ideale. In tutte
queste ipotesi, difficilmente delimitabili a priori, graverà sul convenuto l’onere della prova che il
suo “comportamento”, determinativo di una “distinzione, esclusione, ecc.”, sia basato su elementi
diversi da quelli indicati dalla prima parte dell’art. 41 comma1 (razza, colore, ecc.). In tal modo,
l’assenza ovvero la mancata dimostrazione, da parte del convenuto, della non inerenza alla razza,
al colore, ecc. del “trattamento differenziato”, si traduce tout court nell’accertamento
dell’esistenza di un effetto discriminatorio. La responsabilità del convenuto è semi-oggettiva in
quanto la prova liberatoria non ha per oggetto l’assenza di dolo o di colpa, ma l’oggettiva non
6 Per una prima indagine sul disposto dell’art. 2059 e sui criteri di liquidazione del “danno morale subiettivo” cfr.
quanto meno Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in “Riv. dir. civ.”,
1957,I, pp. 292 ss.; Franzoni, Danno morale, in“Contr. e impresa”, 1990, I, pp. 307 ss. Sulla distinzione fra danno
morale e danno c.d. punitivo cfr. Busnelli, Pena privata, in Busnelli/Patti, Danno e responsabilità civile, Torino, 1997,
pp. 196ss.
7 In tal caso il regime probatorio per “rilievi statistici e presunzioni semplici ex art. 2729 comma 1”,così come
disciplinato dall’art. 42 comma X, assumerebbe rilevanza generale ai fini della prova dell’effetto discriminatorio, in sé
e per sé considerato.
8In questo senso: Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, pp. 89 ss. Per una rivalutazione del
ruolo della “colpa” e della necessità di un sistema evolutivo di “illeciti tipici”, tale da assicurare che l’“ingiustizia del
danno” ex art. 2043 non si risolva nella risarcibilità tout court della mera diminuzione patrimoniale cfr. Castronovo,
La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, pp. 80 ss.
9 In molte disposizioni di legge il ruolo della “colpa” è svalutato o sostituito da differenti criteri di imputazione delle
conseguenze dannose di un evento a una determinato soggetto. Si possono menzionare, a titolo di esempio, gli artt.
2051, 2052 e 2053 (i quali fondano l’imputabilità quantomeno su basi semi-oggettive, anche a seguire l’indirizzo
“calmieratore” di Busnelli, La parabola della responsabilità civile, in Patti/Busnelli, Danno e responsabilità civile,
Torino, 1997, pp. 152ss.) o l’art 15 legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che prevede una vera e propria responsabilità
senza colpa.
7
inerenza del “trattamento differenziato” alla razza, al colore, ecc. Se ciò non dovesse avvenire il
danno risarcibile consisterà nelle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali della lesione del
diritto umano o della libertà fondamentale. Così, e per adesso molto genericamente: qualora il
ricorrente, senegalese, dimostri che la controparte, in ragione della sua attività d’impresa, offra un
certo bene o servizio a certe condizioni; che nel contratto stipulato in conformità degli art.1341
comma 2 e 1469-bis commi I e II n. 7, l’imprenditore abbia regolato la facoltà di recesso per
entrambe la parti, prevedendo, a carico del ricorrente, una caparra penitenziale di ammontare più
elevato rispetto a quella uniformemente richiesta ad un altro gruppo di utenti (italiani, spagnoli,
americani, ecc.), l’esistenza di una deviazione dalle condizioni generali di contratto normalmente
praticate dal fornitore, se opportunamente “circostanziata”, potrebbe costituire elemento indiziario
univoco e concludente per presumere una discriminazione. Il fornitore non sarà condannabile al
risarcimento del danno ex art. 41 comma 7 se dimostri, per esempio, che il fatto discriminatorio
coinvolge indistintamente tutti i consumatori stanziati in un certo ambito territoriale e dipende dai
maggiori costi di trasporto del bene offerto al pubblico in quella zona. Nei casi in cui non sia
ravvisabile, in base a una valutazione sociale tipica, una stretta correlazione tra il “fatto” e
l’“effetto” discriminatorio, dovrebbe riespandersi il criterio generale di imputabilità previsto
dall’art. 2043. Questa soluzione ricostruttiva è a mio avviso da preferire alle altre.
Il secondo comma dell’art. 41 elenca una serie di comportamenti costituenti “in ogni caso un atto
discriminatorio”. Qui l’interpretazione del testo legislativo è problematica. Infatti, il termine “in
ogni caso ”sembra annunciare la descrizione circostanziata di una serie di “fatti” costituenti
“discriminazione”, con la conseguente instaurazione di un regime probatorio caratterizzato da
presunzioni iuris et de iure di discriminatorietà al ricorrere delle fattispecie specificamente
individuate dalla norma. Tuttavia il legislatore incentra ancora una volta la nozione di
discriminazione sul “comportamento” dell’agente o dell’omittente. Non vi è, in altre parole, un
passaggio netto dal profilo della “valutazione del comportamento” (tipico delle “clausole generali”
e caratterizzante il disposto del primo comma della norma in esame) al profilo della “descrizione
del fatto”, passaggio da considerarsi logicamente necessario ai fini della configurabilità di un
regime probatorio “speciale” . Di qui la possibile deduzione che le cinque lettere di cui si compone
il secondo comma dell’art. 41contengano ognuna una mera “esemplificazione” di atti
“discriminatori” ai sensi della clausola generale di cui al primo comma, ribadendo la sufficienza di
un accertamento oggettivo, anche per presunzioni semplici, della “discriminazione” ai fini della
tutela inibitoria e indicando altresì alcune delle ipotesi in cui si potrebbe ricorrere a presunzioni
iuris tantum anche ai fini della risarcibilità del danno. Verifichiamo la fondatezza di questo
assunto attraverso l’esame particolareggiato dei comportamenti elencati dall’art. 41 comma II.
Ai sensi della lettera a), compie in ogni caso un atto di discriminazione “il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità10
che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero
che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente”. La disposizione in esame rinvia ad
un soggetto attivo qualificato e all’inerenza:
–nel caso di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio”, del compimento o
dell’omissione dell’“atto” a quella “attività” che, se oggettivamente esercitata, faccia rientrare
l’agente all’interno dell’una o dell’altra qualifica soggettiva, a prescindere dall’esistenza di un
rapporto d impiego con la p.a. (c.d. esercizio di fatto di una pubblica funzione o di un pubblico
servizio);
– nel caso di “esercenti un servizio di pubblica necessità”, del compimento o dell’omissione
10Le tre qualifiche soggettive sono definite dagli artt. 357, 358 e 359 c.p. Sull’argomento, con particolare riguardo alla
c.d. “teoria funzionale oggettiva”, si rinvia a Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 1997, pp.
165-180 (con un’ampia bibliografia alla nota n.14 di p. 165).
8
dell’“atto” a una attività privata “svincolata da ogni rapporto soggettivo con la pubblica
amministrazione ma oggettivamente caratterizzata da un rilievo, da un bisogno e da un interesse
pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato”11.
La disposizione, nel suo tenore letterale, è tutta incentrata sul profilo soggettivo del
“comportamento” e dell’“atto” discriminatorio. Sembrerebbe una “tautologia” il fatto che
compimento o l’omissione dell’atto discriminatorio da parte del soggetto qualificato debbano
determinare, solo a causa della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata
razza, etnia o nazionalità una “ingiusta discriminazione” del ricorrente. Se così fosse, sarebbe
necessario rinviare al contenuto della clausola generale di “discriminatorietà”, ai fini della
individuazione e del “fatto” e “dell’effetto discriminatorio”. Inoltre il regime probatorio ordinario
non muterebbe e, sul piano ricostruttivo, non sarebbe necessario precisare l’ambito di applicazione
della fattispecie in esame (ad esempio: cosa debba intendersi per “inerenza” dell’atto all’attività e
in particolare se nella lettera a) dell’art. 41 comma 2 si ricomprendano anche quelle attività
discriminatorie concretantesi in “atti” caratterizzati da un nesso di “occasionalità necessaria ”con
l’attività determinativa della qualifica soggettiva)12.
La lettera b) dell’art. 41 comma 2 si riferisce a “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o
si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.
Il caso in esame costituisce una possibile esemplificazione del regime probatorio che si è ritenuto
generalmente applicabile, ex art. 41 comma 1, ad ogni fenomeno di “discriminazione” socialmente
e tipicamente valutabile come tale.
Quanto alle lettere c) e d) dell’art. 41 comma 2 , esse pongono i medesimi problemi di cui alla
lettera b). Occorre precisare che, dal lato attivo l’atto discriminatorio ha carattere “comune” e non
“proprio”, dal lato passivo esso può riguardare solo gli “stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia”. Pertanto l’esame delle fattispecie ivi previste sarà ripreso in sede di analisi dell’ambito di
applicazione “soggettivo” dell’art. 41 e dei rimedi civilistici di cui all’art. 42. Ciò vale anche per il
contenuto della lettera e), salvo evidenziare in questa sede come la possibilità di uno stretto
collegamento dell’“effetto” al “fatto” discriminatorio sia stata avvertita dal legislatore nel
collegare al concetto di discriminazione “indiretta” il regime probatorio di cui al comma 9dell’art.
42. Così, se sul piano formale si distingue tra l’adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore determinati soggetti e che non riguardino requisiti essenziali allo
svolgimento dell’attività lavorativa (profilo del “fatto”) e il conseguente “trattamento
pregiudizievole” subito dal lavoratore (profilo dell’“effetto”), sul piano sostanziale si ammette la
possibilità che la prova della discriminazione possa essere raggiunta secondo le modalità previste
dall’art. 2729: dal fatto oggettivamente accertato in base a rilievi statistici, il giudice ha la
possibilità di risalire all’effetto.
11Fiandaca-Musco, op. cit., p.179.
12 Tuttavia, se riconnessa all’art. 42 commi 1-6, la fattispecie di cui alla lettera A) dell’art. 41 comma 2 potrebbe
acquisire una sua autonoma rilevanza in ordine a un differente profilo: quello della competenza giurisdizionale del
pretore che, se ammessa, sarebbe “esclusiva”, nell’ipotesi in cui l’atto compiuto od omesso dal soggetto qualificato
nell’esercizio delle sue funzioni sia propriamente un “atto amministrativo”. Infatti, poiché il primo comma dell’art.42
attribuisce al pretore il potere di “ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole” e di “adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”, l’applicabilità o meno
dell’art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, dipende dalla possibilità o meno di qualificare come “comportamento
pregiudizievole” il compimento o l’omissione dell’atto che “discrimini ingiustamente” il ricorrente. Specie nelle
fattispecie omissive, l’illegittimo rifiuto di compiere un atto amministrativo da parte del soggetto qualificato potrebbe
costituire, di per sé, un “comportamento da far cessare” ex art. 42 comma1.
9
L’ambito di applicazione “oggettivo” della clausola generale di discriminatorietà è delimitato
innanzitutto dalla lettera dell’art. 41 comma 1, sia in sede di qualificazione del “fatto
discriminatorio”, sia in sede di determinazione dello scopo o dell’effetto discriminatori. In tal
senso assumono rilevanza da un lato la razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, dall’altro la “distruzione” o “compromissione” del
“riconoscimento”, del “godimento” o dell’“esercizio”, in condizioni di parità dei “diritti umani” e
delle “libertà fondamentali” in ogni (...)settore della “vita pubblica”. Occorre osservare
innanzitutto che il legislatore tace sulle distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze basate sugli
orientamenti sessuali (omosessualità, transessualismo)13 della persona.
Menziona invece le discriminazioni riconnesse alla appartenenza a un dato gruppo “linguistico”
non all’interno della clausola generale, ma alla lettera e) dell’art. 41 comma 2.
Il problema della rilevanza ex art. 41comma 1 delle “preferenze sessuali” della persona si risolve
nella possibilità di un’interpretazione analogica14 ovvero, per chi distingue, di una interpretazione
c.d. adeguatrice, di carattere logico-sistematico15,della norma in questione.
In termini molto semplificati, lo schema formale della c.d. analogia giuridica è il seguente: dati
due termini A, per il quale la legge prevede la norma X, e B, non espressamente disciplinato, se
essi presentano una “somiglianza rilevante” C, la norma X sottesa ad A può essere applicata anche
a B. Si intende per “somiglianza rilevante” C il fatto che il termine B, al quale inerisce
l’estensione, abbia in comune con il termine A un elemento di per sé sufficiente a giustificare
l’attribuzione ad A di X. “Somiglianza rilevante” non significa nient’altro che identità di ratio
legis 16 , identità da valutarsi sul piano sostanziale, alla luce del principio di
“uguaglianza-razionalità” di cui all’art. 3 comma 1cost.17.
Nel caso in esame occorre giustificare tecnicamente che:
– la razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose di un individuo sono dati irrilevanti ai fini dell’accesso a una certa utilità in condizioni
13 È importante sottolineare fin da ora come il richiamo alla “sexual orientation” sia espressamente ricollegato al
concetto di “discriminazione” dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato dall’Italia il 4 luglio
1998.
14 Su questo concetto e sulla problematicità di una distinzione tra “analogia” e “interpretazione estensiva” in diritto
civile cfr. quantomeno Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, pp. 350 ss.; Giannini, L’analogia
giuridica, in “Jus”, 1941, pp. 516 ss.; Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938, pp. 87 ss.; Id.,
Analogia, in “Noviss. Dig.it.”, Torino, 1968, pp. 601 ss.; Id., Intorno al fondamento del procedimento per analogia, in
“Giur.it.”, 1951, I, p. 229 s.; Id., Ancora intorno alla distinzione fra interpretazione estensiva e analogia;
Gianformaggio, Analogia, in “Digesto disc. priv., Sez. civ.”, Torino, 1987, pp. 320 ss. (con ampi richiami
bibliografici); Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, in “Trattato di diritto
privato”,diretto da Rescigno, I, Torino,1982, pp. 218 ss.; Guastini, Produzione e applicazione del diritto, Lezioni sulle
“Preleggi”, Torino, 1989,pp. 89 ss. e 97 ss.; Id., Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, pp. 370 ss. e
429 ss. (con relativa bibliografia).
15 Alpa, Il ricorso all’analogia nella giurisprudenza. Esempi, tecniche e stili, in “Nuova giur. civ. comm.”, 1998, II,
pp. 45 ss., 59, il quale richiama il disposto dell’art. 3 cost.
16 Lo schema di ragionamento del c.d. “paradigma” (Aristotele, Primi analitici, II, 24, in Aristotele, Opere,1, Bari,
1991, pp. 247ss.), così come inteso da Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, cit. pp. 90 ss. e 100 ss., è qui
utilizzato solo sul piano formale: la “ratio legis” non si identifica, in altre parole, con il principio ricavato dalla
norma.
17 Sul punto si rinvia alle incisive osservazioni di Tarello, L’interpretazione della legge, cit., pp. 352 ss.,
sostanzialmente condivise dalla Gianformaggio in Analogia, cit., p. 324.In particolare, secondo il primo autore “ (...)
la forza persuasiva dell’argomento analogico dipende dalla propensione dell’uditorio ad accettare la rilevanza della
somiglianza o analogia di p e q (leggi A e B)al fine di disciplinarli ugualmente”. Sul problema della rilevanza
interpretativa della norma costituzionale in diritto civile si rinvia a Perlingieri, Il diritto civile nella legalità
costituzionale, Napoli, 1991, pp. 189 ss.
10
paritetiche rispetto al resto della collettività;
– anche le preferenze sessuali di un individuo sono irrilevanti a tal fine.
Il legislatore, attraverso la clausola generale di “discriminatorietà”, ha individuato una serie di
“qualità” della persona in presenza delle quali non sono ammissibili trattamenti differenziati se
non siano giustificati da criteri di discriminazione riconosciuti dall’ordinamento (è il caso, già
esaminato, del “fatto discriminatorio” di per sé non lesivo di un diritto umano o di una libertà
fondamentale).
– La ratio legis dell’art. 41 comma 1 è data da una regola di “indifferenza” di certe “qualità”
soggettive ai fini dell’accesso a una certa utilità. Il comune denominatore delle suddette qualità è
dato dal riscontro, in base a una valutazione sociale tipica, di una possibile rilevanza discriminante
delle medesime all’interno di certi settori della società: la razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale, ecc., sono “qualità personali” a rischio-discriminazione.
– Il principio di “uguaglianza/razionalità” di cui all’art. 3 comma1 cost. richiede all’interprete di
trattare in modo uguale situazioni uguali, in modo diverso situazioni diverse.
– L’omosessualità e la transessualità, alla luce di una valutazione sociale tipica, possono senza
dubbio considerarsi qualità personali a rischio di discriminazione, al pari della razza o del colore,
poiché in molti settori della società esse appaiono ancora oggi come deformazioni o malattie, o in
ogni caso sono socialmente valutate con disfavore.
– Di conseguenza, l’art. 41 comma 1 si applica anche alle discriminazioni dovute alle preferenze
sessuali della persona.
Il terzo comma dell’art. 41 precisa che esso, in uno con l’art. 42, si applica anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea presenti in Italia. La disposizione è importante,
poiché conferisce carattere generale al concetto di “discriminazione” ex art. 41 comma 1, a
prescindere dalla nazionalità del soggetto passivo. In particolare, le lettere (c), (d),(e) dell’art. 41
comma 2 sono applicabili a tutti gli individui, salvo gli stranieri non regolarmente soggiornanti in
Italia.Ciò si spiega, per le fattispecie contemplate alle lettere (c) e (d),alla luce dei commi 1 e 2
dell’art 2 legge 40/1998; per quella di cui alla lettera (e), in base al terzo comma della stessa
disposizione.
Il primo comma dell’art. 42 consente al giudice adito di ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione 18 . Mi limiterò ad evidenziare i possibili limiti di
applicazione, nel campo del diritto civile, del rimedio in esame, considerando in termini generali
la dialettica tra “parità di trattamento” e “libertà contrattuale” nei rapporti inter-soggettivi19; in
termini specifici alcune fattispecie ricomprese nell’ambito di previsione delle lettere(b), (c), (e)
dell’art. 41 comma II.
18 Sul problema della tutela inibitoria, del suo accedere a lesioni già in atto e della inconfigurabilità nel nostro
ordinamento di un illecito di pericolo, si rinvia integralmente a Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, pp.
140 ss. Nel senso della ammissibilità di una tutela inibitoria atipica, e per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali
cfr. invece D’Adda, Orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela civile inibitoria definitiva, in “Nuova giur. civ.
comm.”, II, 1999, pp.59 ss.
19 Rescigno, Il principio di uguaglianza nel diritto privato, in“Riv. trim. dir. proc. civ.”, 1959, pp. 1515 ss.; Id.,
Ancora sul principio di uguaglianza nel diritto privato, in “Foro it.”, 1960, I, pp. 660 ss.; Id., Riassunzione dei
lavoratori licenziati e parità di trattamento, in “Diritto dell’economia”, 1960, pp. 719 ss. (i tre saggi di Rescigno sono
ora raccolti in “Persona e Comunità”, Padova 1987, I, pp. 335 ss., 362 ss. e 426 ss.); Pasetti, Parità di trattamento e
autonomia privata, Padova, 1970; Buoncristiano, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova,1986;
Dell’Utri, Poteri privati e situazioni giuridiche soggettive (Riflessioni sulla nozione di interesse legittimo in diritto
privato), in “Riv. dir. civ.”,1993, II, pp.303 ss.; Id., Poteri privati, interessi legittimi e forme di tutela, in “Riv. dir.
civ.”, 1997, II, pp. 47 ss.; Carusi, Principio di uguaglianza, diritto singolare e privilegio, Napoli, 1998.
11
L’espressione “parità di trattamento” assume in diritto civile una connotazione tecnica ben precisa.
Essa indica infatti tutte quelle ipotesi, previste da una norma di diritto privato, in cui sia prescritto
che due o più persone debbano essere trattate “alla pari”. Secondo la migliore dottrina, il
presupposto di applicabilità della regola di giustizia distributiva, diretta a dividere la “scarsità
relativa” dei beni nelle ipotesi di “crisi della libera concorrenza”, è dato dall’esistenza di una
“comunità” già costituita e giuridicamente qualificata. Ciò che avviene, ad esempio, nel settore
delle associazioni e delle società di capitali e in quello del lavoro subordinato che, sebbene
sottenda, sul piano negoziale, un rapporto di scambio, è in ogni caso caratterizzato dalla presenza
di “comunità” quali i sindacati, il personale e la c.d. comunità aziendale, sicché il principio di
parità di trattamento assume rilevanza quantomeno nell’ambito degli atti a carattere
aziendale-collettivo posti in essere dal datore di lavoro. In tutte le ipotesi in cui sussista un vincolo
comunitario, volontario o legale, l’ordinamento tenderà a presumere ingiustificato ed arbitrario, e
dunque a vietare, rispetto a una pluralità di soggetti che si trovino nella situazione supposta, un
trattamento differenziato. Viceversa, nei settori in cui vige il principio di “autonomia privata” o
“libertà contrattuale”, ed è il caso dei c.d. rapporti di scambio, opera una regola di giustizia
commutativa: le discriminazioni di fatto non necessitano, in altre parole, di essere giustificate 20. In
tale prospettiva, se si considera la parità di trattamento come il risultato della appartenenza di più
persone ad una “comunità” e la libertà contrattuale come il risultato dell’operare del singolo
all’interno di un rapporto di scambio, si deve escludere che il primo concetto possa direttamente
ricollegarsi al disposto dell’art. 3comma 1 cost. e risolvere il “conflitto tra principi” attraverso la
precisa individuazione del rispettivo ambito di competenza. Così, se A intende vendere un
immobile e preferisce di fatto C a D per motivi razziali o religiosi, la fattispecie rientra nell’area di
competenza dell’autonomia negoziale21. Ne consegue la non necessità di giustificare il trattamento
differenziato e l’irrilevanza del motivo che abbia indotto l’alienante a trasferire l’immobile a C
anziché a D. Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui il proprietario di un immobile ad
uso abitativo preferisca concederlo in locazione a una coppia eterosessuale, a scapito di una coppia
gay, nonostante un simile comportamento possa potenzialmente rientrare tra quelli menzionati alla
lettera (c) dell’art. 41 comma 2(diniego di accesso all’abitazione). Ne consegue, più ingenerale,
l’impossibilità per il giudice adito di intervenire ex art.42 comma 1 in tutte le ipotesi in cui la
disparità di trattamento dovuta alla razza, al colore, ecc., coinvolga una situazione di “libertà
contrattuale” riconosciuta dall’ordinamento. In tutte le ipotesi esaminate, in cui assume rilevanza
predominante il principio di “autonomia privata”, il soggetto discriminato potrebbe richiedere
soltanto l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle comuni regole in materia di
responsabilità pre-contrattuale, salva in ogni caso la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art.
42 comma7.
Peraltro, la nuova disciplina pone notevoli problemi anche nei casi in cui, ad avviso della dottrina
in esame, si possa invocare il principio di “parità di trattamento” in diritto privato. Così, nei
rapporti associativi 22 , la rilevanza di un vincolo comunitario non riguarda la costituzione del
20 In questi termini, sulla scia della dottrina tedesca si esprime Rescigno, Il principio di uguaglianza nel diritto
privato, in “Persona e Comunità”, cit., pp. 339 ss. e 354 ss.; Id., Ancora sul principio di uguaglianza nel diritto
privato, in “Persona e Comunità”, cit., pp. 369 ss. Analogamente Carusi, Principio di uguaglianza, diritto singolare e
privilegio, cit., pp. 34 ss.
21Carusi, op. cit., p. 34.
22 Sul principio di uguaglianza nei rapporti associativi e sulle eventuali conseguenze, meramente “interne” alla
associazione e dunque insindacabili dall’autorità giudiziaria, di una ingiustificata reiezione, da parte degli
amministratori, della domanda di ammissione proposta da chi integri le condizioni richieste dall’atto costitutivo cfr.
quantomeno Galgano, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 1993, pp. 226 ss. (in particolare: p. 230). Sul problema
della parità di trattamento nei rapporti di lavoro subordinato e per l’analisi del predominante indirizzo
giurisprudenziale, che nega l’esistenza di un siffatto principio in diritto privato, infra, pp. 15 ss.
12
gruppo: “la nostra giurisprudenza tende ad escludere un diritto di accedere all’associazione
anche in capo a chi presenti tutti i requisiti eventualmente previsti dallo statuto; tutt’al più alle
clausole statutarie riguardanti l’adesione di nuovi soci potrà applicarsi, ricorrendone gli estremi,
il regime della proposta contrattuale”23. Seguendo una simile impostazione, il giudice adito ex
art. 42 comma 1 non potrebbe stabilire coattivamente l’accesso di Tizio, avente i medesimi
requisiti di Caio, ma non ammesso solo a causa del colore della sua pelle, all’interno della
associazione X e tuttavia la norma in esame attribuisce al pretore il potere di “rimuovere gli effetti
della discriminazione”, il che sembra rinviare, nel caso di specie, non solo e non tanto alla
dichiarazione di“inefficacia” dell’atto di esclusione, ma anche e soprattutto alla possibilità di una
pronuncia costitutiva della qualità di associato, ovvero di un ordine giudiziale rivolto agli organi
dell’associazione, affinché il ricorrente sia ammesso a farne parte. Sorge allora il problema di un
opportuno inquadramento sistematico di simili poteri giudiziali, che sembrano riconnettersi ad un
“facere” normalmente considerato nei sistemi di Civil Law come “infungibile” e “incoercibile”.
Minori difficoltà sono riscontrabili nel caso in cui la discriminazione coinvolga chi sia già
membro di una data “comunità”. Per esempio: qualora una associazione con finalità educative, nel
fornire alloggio agli iscritti, discrimini ingiustamente determinati membri ex art. 41 comma
2lettera (c), il giudice adito potrà rimuovere d’autorità gli effetti della discriminazione.
Come vedremo tra breve, il problema dei rapporti fra “parità di trattamento” e “libertà
contrattuale” e il peso di una consolidata tradizione giuridica, di stampo marcatamente liberale,
non sembrano idonei a costituire un limite rilevante alla rimozione giudiziale degli effetti di una
discriminazione per motivi razziali, etnici, ecc.. Questo perché esiste una netta differenza,
riconosciuta dallo stesso “diritto vivente”, tra l’inammissibilità, tendenzialmente affermata dalla
Corte di Cassazione, di un principio di parità di trattamento in diritto privato, e l’ingiustificabilità
di un trattamento differenziato ex art. 41 comma 1.
Ferma restando la nostra adesione alla dottrina del “vincolo comunitario”, ai fini dell’indagine in
corso è necessario che l’area di incidenza della “libertà contrattuale”, e penso soprattutto ai casi
del monopolio naturale e delle condizioni generali di contratto, sia opportunamente relativizzata in
via interpretativa. Questo perché la lettera (b) dell’art. 41 comma 2 si riferisce espressamente alla
imposizione, da parte di “chiunque”, di condizioni più svantaggiose nel fornire beni o servizi
offerti al pubblico a un determinato soggetto, solo a causa della sua condizione di“appartenente ad
una determinata razza, religione, ecc.”. In particolare, qualora il giudice adito accerti che un
imprenditore applichi costantemente e uniformemente una data regolamentazione per il deposito
cauzionale di somme da parte del cliente, derogandovi in senso peggiorativo solo nei confronti di
cittadini extracomunitari residenti in Italia, l’accertamento della discriminazione può condurre non
solo a una dichiarazione di nullità parziale del contratto ex art.1419 comma 1 cod. civ., ma anche a
una rimozione dell’effetto ex art. 42comma 1. Ciò che, nel caso di specie, non sembra nettamente
incompatibile con il dogma della “libertà contrattuale”. Infatti, la riduzione d’autorità
dell’ammontare della somma depositata dal cittadino extracomunitario a quanto normalmente
praticato dall’imprenditore nei confronti della generalità della clientela, a cui consegue la
ripetibilità dell’eccedenza ex art. 2033 cod. civ., riconduce la pattuizione nell’ambito di un valore
che in ogni caso era stato predeterminato, in via uniforme e generalizzata, dall’imprenditore
medesimo. Il legislatore, predisponendo una clausola generale di discriminatorietà, ha inteso
23 Carusi, op. cit., p. 24. Il principio di parità di trattamento “si lega alla comunità già costituita”. Sul punto cfr.
Rescigno, Il principio di uguaglianza in diritto privato, in “Persona e comunità”, cit., p. 339, nel senso della
inesistenza di un interesse giuridicamente rilevante del singolo richiedente ad essere ammesso a far parte di una data
associazione; Id., Riassunzione dei lavoratori licenziati e parità di trattamento, cit., p. 441 ss., nel senso della
inconfigurabilità, ad avviso della dottrina tedesca esaminata dall’autore, di un dovere giuridico di parità di trattamento
con riguardo alla costituzione del rapporto di lavoro, nella valutazione delle attitudini e delle capacità degli aspiranti
alla assunzione.
13
attribuire rilevanza a determinate qualità della persona, ai fini dell’accesso a una certa utilità, in
condizioni di “parità” con il resto della collettività. Ciò significa che, se un imprenditore disciplina
in modo uniforme, ad esempio per aree territoriali e presumibilmente in base ai costi di fornitura
del bene, i suoi rapporti contrattuali con la clientela, derogandovi solo nei confronti di alcune
persone di colore odi religione protestante, la prova della discriminazione, anche per presunzioni
semplici, esclude la “pattuizione” dall’area di incidenza dell’autonomia negoziale. Qui non si
pone, a ben vedere, un problema di violazione della libertà contrattuale o di irrilevanza dei motivi
del trattamento differenziato, essendovi una espressa disposizione di legge, avente carattere
imperativo, che qualifica come atto costituente in ogni caso una discriminazione la imposizione di
condizioni più svantaggiose per motivi razziali, etnici, ecc., nella fornitura di un bene o di un
servizio. L’autonomia negoziale è dunque sottoposta a un limite di liceità.
Si è anticipato come il problema della configurabilità o meno, nell’ordinamento italiano, di un
principio di parità di trattamento in diritto privato non incida sull’area di incidenza del concetto di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Nel quadro dei comportamenti discriminatori sanzionabili ex art. 42 comma 1 assume particolare
rilevanza la connessione con la lettera (e) dell’art. 41 comma 2 24 . Quest’ultima disposizione
richiama a sua volta l ’art. 15 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) che all’ultimo comma
sancisce la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa, razziale, di
lingua o di sesso. Il problema che si pone all’interprete è di stabilire se e in quali ipotesi la
rimozione degli effetti della discriminazione ex art. 42comma 1 possa estendersi a misure di
carattere “positivo”, attraverso il riconoscimento al soggetto discriminato del medesimo
trattamento applicato al resto della “comunità” di appartenenza.
È noto come e perché la Corte di Cassazione, in una serie di pronunce del1993 25, abbia escluso
che, nonostante la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale,
sia desumibile nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento fra privati, non
potendosi esso desumere dagli art. 3, 36, 37 e 41 cost. né dagli art. 1175 e 1375 cod. civ.26. Non
24 La norma vale per le “discriminazioni” di carattere individuale a soggetto determinato, poste in essere dal datore di
lavoro o dai suoi preposti. Per le discriminazioni di carattere collettivo a soggetto indeterminato o non
immediatamente individuabili, poste in essere dal datore di lavoro, la legittimazione ad agire è attribuita ex art. 42
comma 10 alle rappresentanze locali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice,
nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina al datore di lavoro un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
25 È doveroso menzionare quantomeno Cass. sez. un. 29 maggio 1993 n. 6030, in “Corriere giur.”, 1993, 9,p. 1057
ss., con nota di Pera, Le sezioni unite sulla parità di trattamento nel diritto del lavoro; Cass. 29 maggio 1993 n. 6031,
in “Foro it.”, 1993, I, p. 1794, con nota di Mazzotta: La resistibile ascesa della parità di trattamento nel rapporto di
lavoro. Sull’argomento cfr. la nota di SCARPELLI: Parità di trattamento e valutazioni “discrezionali” in relazione
ad erogazioni decise unilateralmente dall’imprenditore, in “Riv. it. dir. lav.”, 1991, II, p. 777 ss. Successivamente, in
senso conforme: Cass. sez. lav. 2 dicembre 1996 n. 10738, in “Mass. giur. lav.”, 1997, p.32 e in “Rep. Foro it.”, 1997,
v. “Lavoro”, p. 788. Per l’esame della giurisprudenza anteriore e del senso dei richiami ivi operati al principio di parità
di trattamento si rinvia integralmente a Cerri, L’uguaglianza giuridica nei rapporti interprivati: spunti e riflessioni a
partire dalla giurisprudenza in materia di lavoro, in “Foro it.”, 1992, I, p. 1523.
26 Per una valorizzazione del canone di buona fede oggettiva, nel senso che la totale assenza di apprezzabili e
giustificati motivi di eventuali differenze retributive, previste in sede di contrattazione collettiva ovvero individuale,
determini una violazione dell’obbligo di correttezza, con conseguente risarcibilità del danno subìto dai lavoratori
esclusi dal trattamento economico privilegiato, cfr. Cass. sez. lav. 8 luglio 1994 n. 6448, in “Foro it.”, 1995, I, pp. 186
ss. connota di Amoroso: Retribuzione e mansioni del lavoratore: l’obbligo di parità di trattamento come
specificazione del dovere di correttezza e buona fede (Osservazioni critiche in Dell’Utri, Poteri privati, interessi
legittimi e forme di tutela, cit., pp. 50 ss.). Un ulteriore e opportuno ridimensionamento della negazione, in sede di law
inaction, del principio di parità di trattamento è rinvenibile in Trib. Napoli 8 ottobre 1997, in “Giur. it.”, gennaio1999,
pp. 64 ss., con nota di Santucci: Controllo “occulto” del lavoratore, sanzioni disciplinari e parità di trattamento. La
14
intendo soffermarmi su questo problema, in verità assai complesso. Mi preme solo evidenziare
come secondo l’orientamento in esame (anche) in sede di contrattazione c.d. individuale siano
insindacabili, sotto il profilo della razionalità, le circostanze determinative di:
– diversificazioni ai fini della qualifica spettante a lavoratori addetti a identiche mansioni;
– trattamenti preferenziali a titolo di liberalità in sede di accoglimento della domanda di
pensionamento;
– condizioni retributive più favorevoli rispetto a quelle contrattualmente previste come
obbligatorie;
– differenziazioni della retribuzione pur a parità di categoria o di mansioni.
Secondo il “diritto vivente”, la discrezionalità del datore di lavoro trova un limite negativo nel
trattamento discriminatorio: una eventuale diversità di retribuzione o di inquadramento a parità di
mansioni è sanzionabile dal giudice adito se il lavoratore dimostri che ciò sia avvenuto per i fini
elencati dall’art. 15 ultimo comma(discriminazione politica o religiosa, razziale, di lingua o di
sesso).Nelle già citate Cass. 6030/1993 e 6031/1993 si distingue nettamente tra un principio
generale di parità, non invocabile in presenza di un trattamento puramente differenziato, e il
divieto di discriminazioni. Peraltro, ed è questo ciò che più interessa ai fini della presente
indagine, si afferma che dagli art. 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori non sia desumibile la
possibilità di estendere a tutti i lavoratori il trattamento determinativo della disparità
discriminatoria. Ora, salvo ritenere che la lettera (e) dell’art. 41 comma 2 legge 40/1998
costituisca un duplicato della tutela accordata ex art. 15legge 330/1970 (nullità dell’atto
discriminatorio), la sua connessione con il rimedio della rimozione degli effetti di cui al
successivo art. 42 comma 1 dovrebbe consentire al pretore di estendere al soggetto discriminato il
trattamento preferenziale. La sanzione pecuniaria ex art. 16 non può costituire più, alla luce della
nuova disciplina, l’unico rimedio previsto dalla legge in favore del soggetto discriminato
A fronte di un atto discriminatorio è possibile distinguere la sanzione della nullità, che incide sul
contenuto negoziale del rapporto di lavoro subordinato, dalla rimozione degli effetti della
discriminazione, che incide, come è ovvio, sulla c.d. fattispecie effettuale. Il disposto dell’ultimo
comma dell’art. 41 conferisce al rimedio in esame il carattere della generalità.
Quanto da ultimo osservato deve tuttavia coordinarsi con l’art. 3 legge 108/1990, che prevede,
indipendentemente dalla motivazione addotta dal datore di lavoro, il ricorso all’art. 18legge
300/1970 in tutte le ipotesi di licenziamento individuale determinato da ragioni discriminatorie ai
sensi (...) dell’art.15 legge 300/1970, svincolando l’applicabilità del rimedio della reintegrazione
dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.
Ai fini dell’accertamento della discriminazione di cui all’art. 41 comma 1assume rilevanza, sul
piano probatorio, un giudizio di tipo comparativo secondo i criteri indicati dall’art. 42 comma 9 27.
Qualora non fosse raggiunta la prova della discriminazione, ma la disparità di trattamento sia
valutata come “ingiustificata” o “irragionevole”, l’unico rimedio esperibile sarà quello risarcitorio
sentenza si segnala in quanto afferma la rilevanza, ai fini di una valutazione oggettiva della proporzione della sanzione
espulsiva rispetto all’infrazione, di un giudizio comparativo tra una data sanzione disciplinare irrogata dal datore di
lavoro per un certo fatto del dipendente, e le sanzioni irrogate dal medesimo per casi identici: l’interesse
dell’organizzazione del lavoro alla prosecuzione dell’attività lavorativa deve essere determinato alla luce del fatto che,
per le stesse infrazioni, il datore di lavoro avesse in precedenza adottato o meno provvedimenti conservativi.
27 È singolare come questa norma menzioni, tra i “fatti” oggetto di comparazione ai fini dell’accertamento dell’atto o
del comportamento discriminatori ex art. 2729 comma 1 cod. civ., anche il “regime delle assunzioni”. Quanto da
ultimo osservato può costituire un argomento, di per sé non risolutivo, in favore della applicabilità dell’art. 42 comma
1 anche alle mancate assunzioni per motivi “razziali, nazionali, etnici o religiosi”. Come già si è avuto modo di
rilevare, ammettere l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di non discriminare nelle assunzioni in tanto è
possibile in quanto si ridiscuta, anche alla luce della normativa in esame, il concetto di “autonomia privata”.
15
ex art. 1175 e 1375 cc.
Fin qui la disciplina dettata dagli art. 41e 42 legge 40/1998 in materia di lavoro subordinato
sembrerebbe potenzialmente compatibile con l’affermazione giurisprudenziale circa l’inesistenza
di un principio di parità di trattamento in diritto privato. Maggiori problemi sorgono tuttavia dalla
lettura dell’art. 2 comma 3, collocato nel titolo relativo ai “principi generali”, ai sensi del quale la
Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori soggiornanti regolarmente in Italia (...) parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. È probabile che la Corte
di Cassazione, alfine di mantenere fede all’indirizzo che distingue tra disparità di trattamento e
discriminazioni, tenderà ad attribuire carattere programmatico alla norma da ultimo menzionata. In
caso contrario, l’interprete potrebbe argomentare a fortiori, nel senso che la parità di trattamento,
se riconosciuta agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, dovrebbe valere anche per i
cittadini italiani, in quanto la legge 40/1998 tende ad equiparare la condizione dei primi alla
condizione dei secondi.
Peraltro, affermare tout court la compatibilità fra quanto disposto nella legge 40/1998 in materia di
atti o comportamenti discriminatori con la negazione del principio di parità di trattamento in
diritto privato significa negare che il concetto di “discriminazione per motivi razziali, etnici, ecc.”
di cui all’art. 41 comma1 esprima un fattispecie oggettivamente riscontrabile dal giudice adito, a
prescindere dalle intenzioni dell’agente o dell’omittente. In molti casi i concetti di
“discriminazione per motivi razziali, etnici, ecc.”. e di “disparità di trattamento” a discrezione del
datore di lavoro non sembrano affatto così lontani: il fatto che una disparità di trattamento sia
ingiustificata o irragionevole può essere sufficiente, alla luce di una valutazione sociale tipica, a
qualificare come discriminatoria la condotta del datore di lavoro o dei suoi preposti. A una simile
osservazione è probabile si obietti come l’effetto discriminatorio di cui all’art. 41 comma 1 si
riferisca a una lesione di un diritto umano o di una libertà fondamentale e dunque, specie nelle
ipotesi di trattamenti retributivi differenziati a parità di mansioni, non assume rilevanza il profilo
della comparazione tra quanto percepito da Tizio, senegalese, e quanto percepito in più da Caio,
torinese, addetti entrambi ai servizi igienici di un ristorante, ma il profilo della “sufficienza” della
retribuzione di Tizio ai sensi dell’art. 36 cost. Si potrebbe rilevare come l’art. 41 comma 1 legge
40/1998 si riferisca (...)all’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo (...) economico. Non tanto all’art. 36 cost., quanto alla pari dignità sociale
ex art. 3comma 1 cost. dovrebbe aversi riguardo.
Sembra che l’art. 42 comma 2lettera (e) l. 40/1998 riproponga, sul piano strettamente probatorio,
il problema della ammissibilità di una distinzione fra disparità di trattamento ingiustificate ovvero
che non necessitino, di per sé, di una giustificazione e disparità di trattamento “discriminanti”. Ciò
che assume rilevanza in tutti i casi in cui ’effetto discriminatorio sia connaturato al “fatto” della
distinzione, esclusione ecc., in base a una valutazione sociale tipica28.
28 Supra, pp 3ss.
16
LO STRANIERO QUALE VITTIMA DEL REATO
Ilaria Schincaglia
Una ricerca sulla condizione dello straniero in Italia non può prescindere dall’indagine di una
realtà poco studiata, ma non per questo meno importante, come quella della discriminazione
basata sulla razza, sulla lingua o sulla religione di cui i cittadini extracomunitari sono vittime, e
che trova la propria manifestazione più eclatante nella criminalità a danno degli immigrati.
I profili alla luce dei quali si può intraprendere un’analisi sulla vittimizzazione degli immigrati
stranieri sono almeno tre:
a) sociologico;
b) giuridico-sostanziale;
c) giuridico-processuale.
Dal punto di vista sociologico, il ruolo dello straniero quale persona offesa rispecchia una
condizione di inferiorizzazione e di emarginazione che rientra nell’ambito generale della tutela
dei diritti della persona umana, e che incide negativamente sulla possibilità di un’integrazione
degli immigrati nella società italiana29.
La tutela dei diritti della persona e in particolare dello straniero assume un’importanza
fondamentale nel quadro delle garanzie giurisdizionali, che dovrebbero rappresentare la premessa
indispensabile per una pacifica convivenza tra immigrati extracomunitari e cittadini italiani.
Dal punto di vista giuridico-sostanziale, le norme poste a tutela dello straniero da ogni forma di
discriminazione sono alquanto numerose.
In primo luogo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede, all’art.
14, che il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato senza alcuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Tale definizione normativa preclude ogni discriminazione suscettibile di ripercuotersi
negativamente sui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione e di alterarne, in maniera
sostanziale, il godimento30, ma la sua applicazione pratica si è rivelata piuttosto problematica
riguardo alla tutela del soggetto straniero.
Il principio di non-discriminazione nei confronti dello straniero è venuto all’attenzione della
Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente al godimento di diritti quali il rispetto della vita
famigliare e privata (art. 8), l’equo processo (art.6), il divieto di tortura e di trattamenti inumani
(art. 3), ma non è stata praticamente mai riscontrata una violazione degli stessi da parte degli
Stati aderenti alla Convenzione, nonostante le segnalazioni siano state numerose (si veda caso
Abdulaziz, Cabales andBalkandalj/GB, 28/05/85, A/94; Moustaquim/Belgio,18/02/91, A/193;
C/Belgio, 7/08/96; Gaysgusuz/Austria, 16/09/96).
A livello comunitario, soprattutto dopo le innovazioni apportate ai trattati istitutivi con il trattato
di Amsterdam, si è provveduto alla fondazione di una nuova politica in materia di visti, asilo e
immigrazione(tit. IV del Trattato di Roma) e a rafforzare il ruolo della Corte di giustizia, nelle
materie di sua competenza, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo (art. 6 del Trattato
29 S. Palidda, La devianza e la vittimizzazione, in Terzo Rapporto sulle migrazioni, Milano, Fondazione
Cariplo-ISMU, 1997.
30 G. Sperduti, Il principio di non-discriminazione e una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo,
in “Riv. dir. int.”, 1976, p.246.
17
UE)31.
Tuttavia è bene tenere presente che la protezione assicurata dalla Corte di giustizia non coincide
con quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché essa non accoglie automaticamente
gli standard elaborati da quest’ultima, ma garantisce la tutela delle libertà fondamentali tenendo
conto dei valori essenziali e del campo di applicazione dell’ordinamento comunitario.
Il trattato di Amsterdam ha influito sensibilmente sulle competenze della Corte di giustizia in
materia di diritti umani, soprattutto nell’ambito della tutela dei diritti “sociali”, quali la parità di
trattamento, la lotta a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sul colore della
pelle, sulle opinioni e sulle credenze, e in quello della solidarietà contro l’emarginazione sociale
(artt. 3-137)32.
In assenza di un catalogo di diritti fondamentali propri della Comunità europea o di una sua
adesione formale alla CEDU, il trattato di Amsterdam ha cercato di svincolare la Corte di
giustizia dalla questione relativa al carattere vincolante o meno della CEDU, soprattutto per la
sua inidoneità ad offrire soluzioni praticabili33, ma esso ha accentuato la diversità dei parametri
assunti dalle due Corti con riferimento sia agli stranieri comunitari che a quelli extracomunitari.
Dopo questa breve disamina della normativa sovranazionale a tutela dello straniero da ogni forma
di discriminazione, occorre esaminare i fondamenti del principio di uguaglianza all’interno del
sistema giuridico italiano.
Il riferimento normativo principale è l’art. 3 cost., il quale statuisce che “tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, ove il termine “cittadino”
non preclude che soggetto giuridico siano anche gli stranieri e gli apolidi34.
La Corte costituzionale ha costantemente affermato il principio di uguaglianza dello straniero
rispetto al cittadino nella sfera dei diritti fondamentali, anche se in alcuni casi è sembrata
contraddirsi, quando ha assunto che, nelle situazioni concrete, possono presentarsi differenze di
fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità(sentenze costituzionali
n. 54/1979 e n. 144/1976).
Sul piano della legislazione ordinaria non si riscontrano iniziative particolarmente significative
atte a rendere effettivo il principio di non discriminazione nei confronti dello straniero e,
comunque, il pregiudizio razziale non è stato certamente contrastato mediante politiche per
l’immigrazione adeguate, nonostante la recente legge n. 40/1998 abbia introdotto agli artt.
40-41istituti volti a combattere le manifestazioni di razzismo e xenofobia. Essa prevede infatti
l’istituzione presso il CNEL di un organismo nazionale di coordinamento e di informazione,
nonché l’obbligo per il datore di lavoro e i suoi preposti di rispondere di discriminazioni dirette e
indirette nei confronti dei cittadini extracomunitari.
Questo quadro normativo rappresenta la premessa indispensabile per affrontare il tema cardine
dell’indagine incorso, quello dello straniero nella veste di persona offesa dal reato. Gli strumenti
finalizzati a contrastare la criminalità fondata sul pregiudizio razziale sono alquanto ridotti e, non
31M. Balboni, Diritto comunitario ed europeo, note a margine delle sentenze in rassegna, in “Diritto, immigrazione e
cittadinanza”, n. 1/99, p. 78.
32 P. Magno, Diritti sociali nell’ordinamento dell’unione europea dopo Amsterdam, in “Il diritto del lavoro”,1998, p.
17.
33G. Arrigo, La politica sociale nel trattato di Amsterdam, in “Il diritto del lavoro”, 1998, p.43.
34 T. Martines, Diritto costituzionale, 1994, p.631.
18
a caso, l’unica soluzione ipotizzabile e praticata dalla giurisprudenza è stata quella di applicare
l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p., cioè l’aver agito per motivi abietti o futili oppure di
escludere l’applicabilità delle circostanze attenuanti in ragione del comportamento criminoso
manifestamente razzista.
Tuttavia l’art. 61 n. 1 c.p. non sembra soddisfare le esigenze che caratterizzano un fenomeno così
complesso.
Una ragione di tale inadeguatezza nasce dalla constatazione che i criteri fondamentali per la
valutazione dei motivi che spingono a delinquere nel sistema penale possono essere diversi, ossia
uno“reale-generale”, l’altro “sintomatico-particolare”. Nel primo caso si considera il motivo in se
stesso, per quello che vale nella generalità dei casi umani, indipendentemente dal modo di
operare nella personalità del reo, dunque più coerente con un diritto penale “del fatto costituente
reato”. Nel secondo caso si prescinde dalla considerazione del valore che il motivo ha nella
generalità dei casi e lo si assume come indice della particolare personalità del soggetto,
richiamando i presupposti di un diritto penale “dell’autore”, scelta certamente da non
condividere35.
In particolare l’espressione “motivi abietti o futili” presuppone un giudizio di carattere
spiccatamente etico, la cui validità e opportunità potrebbero essere contestati; infatti, prendere
atto che diversi comportamenti repressi dalla norma penale siano anche riprovati dalla morale
non basta ad avvicinare quest’ultima alla norma penale o addirittura legare l’una all’altra
indissolubilmente36 . Quanto affermato vuole sostanzialmente evidenziare che il diritto penale
non sembra lo strumento più adatto per contrastare il pregiudizio razziale, proprio in ragione del
fatto che non è assolutamente suo compito reprimere comportamenti umani dissonanti dalla
morale corrente laddove non vi sia effettivamente un fatto costituente reato concretamente
offensivo di beni giuridici meritevoli di tutela.
Nonostante ciò, n senso contrario alla predetta necessità di “depurare” il diritto penale da
valutazioni puramente etiche, è stata approvata nel1993 la legge n. 205, la quale ha cercato di
potenziare la tutela contro comportamenti suscettibili di condurre a forme di discriminazione non
tollerabili alla luce dei valori su cui si fonda l’attuale convivenza civile37.
Gli aspetti innovativi di tale legge sono molteplici: innanzitutto ha determinato la trasposizione a
livello di “motivi” o moventi dell’azione criminosa, siano essi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, di quel profilo del fatto tipico che in precedenza veniva costruito mediante il
riferimento all’offesa rivolta contro persone “perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico
o razziale”.
In tal modo la rilevanza penale della condotta si integrerà con la semplice “motivazione” del
comportamento discriminatorio qualificato da un atteggiamento di intolleranza nei confronti di
razze, culture o religioni diverse dalla propria38.
Un altro aspetto meritevole di approfondimento è quello relativo alla condizione dello straniero
quale vittima del reato.
Lo status di vittima assume connotati diversi a seconda del rapporto che esiste tra la persona
offesa e l’autore del reato; le ipotesi che si possono verificare sono almeno tre:
35 A. Malinverni,Voce Motivi, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIV, 1977, p.295.
36S. Messina, Considerazioni “de iure condendo” sulle circostanze di cui agli artt. 61, n. 1 e 62, n. 1 del codice
penale, in “Riv. pen.”, 1973, p. 438.
37 G. De Francesco, Commento all’art. 3 della legge n. 205/93, in “Leg. pen.”, 1994, p. 175.
38 DeFrancesco, op. cit., p. 177.
19
a) il colpevole e la vittima hanno una “personalità di base” comune, dunque si tratta di soggetti
dotati di una personalità condivisa dalla maggioranza dei membri della società;
b) tra colpevole e vittima intercorrono rapporti di partecipazione emotiva o empatici, quindi la
dinamicità del movente raggiunge la sua massima intensità;
c) tra colpevole e vittima, il processo di riconoscimento non avviene in quanto il codice di
comunicazione costituito dai modelli culturali non è lo stesso per i due soggetti.
In quest’ultimo caso l’incomunicabilità tra i due soggetti può essere dovuta a differenze di
linguaggio, di origine socio-culturale, di razza, le quali possono dar luogo ad una “reificazione”
reciproca per cui, mentre la vittima si costituisce come un frammento di realtà di cui ci si può
servire, il colpevole non percepisce alcun segnale o messaggio che non sia di natura istintuale da
parte di questa39. Senza dubbio questa ipotesi è quella che più si addice al fenomeno criminoso di
cui è vittima lo straniero e raggiunge un indice di pericolosità altissimo, poiché il delinquente,
prescindendo in genere da uno scopo egoistico, non reagisce ad un’offesa o non vuol procurarsi
denaro da chi ne ha, ma solo ferire, uccidere, sequestrare chi la pensa diversamente da lui o è di
razza diversa40.
Al fine di rendere più chiaro il quadro vittimologico riguardante lo straniero, è opportuno
riportare alcuni esempi giurisprudenziali particolarmente significativi per comprendere la realtà
nella quale l’immigrato assume le vesti di persona offesa dal reato.
In assenza di studi o ricerche su questo tema, si propongono in questa sede sentenze pronunciate
dalla Pretura circondariale, dal Tribunale e dalla Corte d’assise di Bologna.
Bologna attualmente può considerarsi una delle città più rappresentative delle problematiche
relative alla criminalità legata alla presenza di immigrati extracomunitari sul territorio italiano e
l’aspetto maggiormente conosciuto è certamente quello dei reati commessi dagli stranieri grazie
ai numerosissimi procedimenti giudiziari a loro carico e alle cronache giornalistiche che hanno
evidenziato il sentimento di insicurezza maturato dai cittadini.
Tuttavia in questo contesto non si intende tracciare un quadro esaustivo della situazione in cui
versano gli stranieri in Italia sotto il profilo della vittimizzazione, bensì aspira semplicemente a
disegnare un breve “spaccato” esemplificativo delle condizioni favorevoli all’insorgenza di
fenomeni criminosi di cui siano vittime gli immigrati extracomunitari.
L’analisi delle pronunce giurisprudenziali raccolte viene suddivisa in quattro grandi aree, relative
alla tipologia di reati nell’ambito dei quali gli stranieri sono parti lese:
1) vittime di condizioni di lavoro insicure e irregolari, legate soprattutto alla violazione della
normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2) vittime di violenze, racket e minacce da parte di altri connazionali e/o italiani;
3) vittime dello sfruttamento della prostituzione e di violenze;
4) vittime di violenze razzista.
Per quanto riguarda il primo campo d’indagine, le sentenze n. 58/99, n. 427/99, n. 507/99,n.
1932/99, n. 2002/98 emesse dalla Pretura circondariale mostrano quanto sia frequente che
giungano all’attenzione dell’autorità giudiziaria situazioni lavorative estremamente disagiate e
insicure a danno degli operai extracomunitari.
Nel primo caso l’immigrato veniva adibito alla sostituzione di guarnizioni all’interno di un
impianto di sollevamento di un ascensore, senza l’attrezzatura necessaria per operare in
condizioni di assoluta sicurezza per la sua incolumità; tra l’altro nella descrizione dei fatti emerge
un contesto nel quale lo straniero sembra essere vittima di minacce da parte del datore di lavoro o
quantomeno del tentativo di occultare l’accaduto attraverso la prospettazione di una sua futura
espulsione dall’Italia, anche se bisogna precisare che l’autorità giudiziaria competente ha ritenuto
39F. Guerrini, Il motivo a delinquere nella prospettiva del rapporto tra colpevole e offeso, in “Arch. pen.”, 1976, p.
341.
40 P. Nuvolone, La vittima nella genesi del delitto, in “Indice penale”, 1973, p.643.
20
che il fatto non sussistesse.
Il secondo esempio vede l’immigrato vittima di lesioni personali gravissime a causa
dell’imprudenza dei datori di lavoro e dell’inosservanza di normative antinfortunistiche
nell’ambito di un’attività di lavorazione della carta; lo stesso accadeva all’interno di un cantiere
edile, in cui non si era provveduto ad adottare le prescritte precauzioni idonee ad evitare la caduta
di materiali sollevati dal suolo e che in conseguenza della loro caduta si cagionava la morte al
dipendente extracomunitario (sent. n. 507/99).
Il quarto esempio riporta l’ipotesi di un infortunio avvenuto in un panificio, in cui l’immigrato
rimane vittima di lesioni personali a causa della mancata dotazione della macchine spezzatrice di
protezioni idonee a evitare il contatto della mano con l’organo lavoratore.
Infine la sentenza n. 2002/98 si occupa di un incidente sul lavoro a danno di un immigrato
durante il funzionamento della macchina accoppiatrice di pannelli fibrolegnosi con fogli di carta,
che presentava una fessura per l’alimentazione molto più ampia rispetto ai parametri stabiliti
dalla legge e che ha reso possibile lo schiacciamento della mano.
Da quanto illustrato si può desumere che gli extracomunitari lavoratori, oltre ad essere assunti
irregolarmente dal punto di vista contributivo, sono costretti ad operare in condizioni lavorative
assolutamente prive di alcuna garanzia di sicurezza, segno della precaria situazione in cui vivono
solo aldi fuori dell’ambiente di lavoro. Tuttavia è doveroso precisare che adibire dipendenti
stranieri a mansioni lavorative prive di adeguata protezione, non può interpretarsi come la
volontà dei datori di lavoro di discriminarli, in quanto gli infortuni e la mancanza di sicurezza sul
lavoro costituiscono un fenomeno che tocca indifferentemente lavoratori italiani e stranieri.
Dunque tali esempi giurisprudenziali sono la manifestazione di un sintomo particolarmente
preoccupante e che vede inevitabilmente coinvolti quegli immigrati che sono giunti in Italia
proprio per trovare nuove opportunità di sostentamento personale e della propria famiglia.
Passando ora all’analisi del secondo quadro di indagine, si può evidenziare quanto gli stranieri
spesso siano vittime di violenze da parte degli stessi connazionali o comunque da parte di altri
cittadini extracomunitari: le quattro sentenze emesse dalla Pretura (n. 408/99, n. 405/99, n.11/99,
n. 1984/98) mostrano la frequenza delle aggressioni tra stranieri in occasione di risse o di veri e
propri agguati sferrati al fine dirivendicare il controllo sul territorio o per derubare la vittima dei
valori posseduti attraverso la minaccia o l’uso di armi da taglio.
Le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bologna (n. 824/98, n. 809/98, n. 660/98, n.590/98) si
incentrano su forme di aggressione tra immigrati per mezzo di atti incendiari, accoltellamenti e
uso di armi da fuoco. I moventi addotti sono per lo più ricollegabili al mondo dello spaccio di
sostanze stupefacenti e quindi alla riaffermazione della propria autorità all’interno del mercato
della droga; inoltre l’evento dannoso può sorgere anche a causa di liti insorte all’interno di
tradizioni culturali come quella nomade, che nel caso di specie vede coinvolti due soggetti in
contrasto per questioni legate al danaro e al rapimento di una figlia quale riscatto del debito
rivendicato.
In un altro caso lo straniero è vittima di quegli stessi reati predatori che tanto allarmano la
sicurezza pubblica: infatti, sotto la minaccia di una pistola giocattolo, egli è costretto a
consegnare danaro e portafogli, a dimostrazione che tali comportamenti vengono indirizzati
indifferentemente verso cittadini italiani ed extracomunitari da parte di autori sia italiani che
stranieri.
La terza area di indagine giurisprudenziale pone l’attenzione sul fenomeno dello sfruttamento
della prostituzione (n. 725/98, n. 604/98, n. 55/98). Questo è un tema particolarmente complesso
da trattare poiché lo sfruttamento di immigrate straniere, in questi casi di origine est-europea, ai
fini della prostituzione, mostra quanto tali vittime siano costrette a subire soprusi di ogni genere
proprio da parte di coloro che le hanno aiutate ed esortate a venire in Italia per trovare nuove
occasioni di lavoro; gli autori di questi reati sono il più delle volte connazionali delle vittime,
amici o addirittura parenti stretti.
Tali prostitute immigrate, oltre a essere vittime della realtà in cui sono costrette a vivere,
21
vengono spesso maltrattate e derubate dagli stessi clienti: si riporta l’ipotesi di un cliente che
pretendeva la prestazione sessuale dopo essersi accordato sul pagamento e sulle modalità, ma di
fronte al rifiuto successivo della donna, egli la minacciava con una pistola e le sottraeva la
borsetta e il denaro ivi contenuto; nell’altra ipotesi, invece, il cliente pretendeva di non pagare la
prostituta e fruire gratuitamente delle sue prestazioni sessuali, ma l’atteggiamento di protesta
della donna scatenava la sua reazione violenta, che degenerava in lesioni personali e rapina nei
confronti della donna.
In quest’ultimo caso è interessante notare che la parte lesa aveva denunciato di aver subito
violenza sessuale a opera del cliente, che l’avrebbe costretta al rapporto sessuale sotto la
minaccia di un coltello, ma il Tribunale non ha ravvisato gli elementi necessari per la
configurazione di tale reato, a riprova di quanto sia arduo dimostrare quale sia il confine tra
prestazione sessuale consenziente della prostituta e prestazione imposta con la violenza, tenendo
conto di tutti i dubbi nutriti dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria intorno alla
credibilità delle vittime in questione.
L’ultima parte della ricerca è dedicato all’esposizione di quelle sentenze, emesse dalla Corte
d’Assise, che hanno punito comportamenti criminosi dettati da motivazioni direttamente o
indirettamente razziste (n. 6/93, n. 7/95, n. 3/96, n. 2/98).
Le due pronunce meno recenti riportano il caso di un immigrato deceduto a causa
dell’immissione di un compressore ad aria all’interno della zona anale ad opera di compagni di
lavoro di nazionalità italiana: la Corte non ha ravvisato motivazioni di stampo razzista nel gesto
degli imputati, bensì l’esito di un tragico scherzo; tuttavia bisogna rilevare che vi sono stati
notevoli problemi nello stabilire la qualificazione giuridica del reato e, per tal motivo, è stata
interpellata più volte la Corte di Cassazione per valutare i profili di legittimità delle sentenze
emesse dalle Corti d’Assise.
Un esempio particolarmente significativo di violenza razzista viene illustrato nella sentenza n.
2/98, che mostra il coinvolgimento di stranieri e italiani inattività criminose come lo spaccio di
droga, ambito particolarmente favorevole all’insorgenza di contrasti dettati da motivazioni
apparentemente futili come la sottrazione di un cellulare o di un orologio e che spesso sfociano in
avvenimenti ben più cruenti come gli omicidi o i tentati omicidi.
Nel caso di specie l’evento pare essere maturato proprio alla luce di atteggiamenti razzisti
dell’imputato italiano nei confronti della vittima straniera: la Corte non ha applicato l’aggravante
di cui all’art. 61 n. 1 c.p., facendo rientrare il movente razzista nell’alveo dei motivi abietti o
futili, bensì ha preferito non concedere le attenuanti generiche in considerazione della gravità del
crimine commesso e delle odiose motivazioni razziste che lo hanno sotteso.
La sentenza più interessante da analizzare, permettere in luce la gravità dei delitti di stampo
xenofobo, è quella pronunciata a carico dei fratelli Savi, i cosiddetti assassini della “Uno bianca”.
Nella varietà dei reati loro ascritti, numerosi risultano a danno di stranieri: in un primo caso essi
si resero responsabili di un tentato omicidio nei confronti di un cittadino maghrebino, verso il
quale vennero indirizzati diversi colpi; in un’altra occasione la banda criminale sparò
indiscriminatamente contro le roulotte di un campo nomadi, causando numerosi feriti; i cittadini
maghrebini sono state vittime una seconda volta, quando i Savi esplosero colpi di pistola contro
di loro semplicemente per “spaventarli” o perché irritati dal fatto che ad ogni semaforo essi
pretendessero di pulire il vetro della macchina; l’ultimo episodio in cui rimasero vittime i nomadi
si consumò con un assalto diretto al campo zingaro con armi munite di pallottole dotate di una
particolare potenza devastatrice.
Emerge con evidenza quanto i reati commessi dalla “banda della Uno bianca” siano fondati da
motivazioni apertamente razziste, nonostante gli imputati abbiano addotto quali moventi l’intento
di depistare le indagini o di mettere alla prova il coraggio di uno dei propri compagni.
La Corte d’Assise ha punito le condotte criminose menzionate applicando la circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 1c.p., cioè l’aver agito per motivi abietti o futili, definendo i reati
commessi delitti di stampo razzista.
22
Si tenga presente che la giurisprudenza ha interpretato i “motivi abietti o futili” come quei motivi
che rivelano nell’agente un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e
di disprezzo in ogni persona di moralità media (Cass.pen., sez. I, 8/10/93); in particolare
costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve,
quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della
condotta antigiuridica (Cass. pen., sez. I,30/01/1996 n. 7034).
Nel caso dei fratelli Savi l’aggravante doveva essere applicata proprio in ragione dell’oggettiva
sproporzione esistente tra movente e azione delittuosa, che deve essere individuata onde rendere
possibili scelte razionali, non arbitrarie e astratte, concretamente ancorate ai fatti e alla
personalità dell’individuo, nella quale la futilità, quale espressione di malvagità, trova ragione di
aggravamento della pena(Cass. pen., sez. V, 27/06/97 n. 8450).
In conclusione di questa breve disamina giurisprudenziale, si può affermare che in un lasso di
tempo relativamente limitato(1997,1998,1999) sono emersi numerosi episodi nei quali, nella sola
città di Bologna, gli stranieri sono stati vittime di reati commessi da datori di lavoro negligenti
sotto il profilo dell’adozione di protezioni anti infortunistiche e di violenze da parte di altri
cittadini extracomunitari, a dimostrazione di quanto le forme di disagio presenti nella comunità
immigrata in Italia possano diventare fattori determinanti per la nascita di ulteriore criminalità.
Inoltre l’attenzione va posta anche sulla condizione della donna extracomunitaria costretta a
prostituirsi e priva di qualsiasi tutela sia all’interno della propria comunità, che nell’ambito dei
contatti esterni con la clientela.
I reati di stampo razzista, invece, vengono perseguiti dall’autorità giudiziaria più raramente. E la
ragione non è certo che questi episodi si verificano raramente, ma che gli stranieri sono soliti
tollerare tali comportamenti a loro danno per non incorrere essi stessi in controlli delle forze
dell’ordine che potrebbero far emergere situazioni di irregolarità o clandestinità col rischio di
espulsione.
Questa è una delle ragioni per cui i reati perseguibili a querela, di cui sono vittime gli immigrati,
non vengono praticamente conosciuti dall’autorità giudiziaria, ne tanto meno dai mass media; lo
straniero quale parte lesa è conoscibile solo quando il reato è perseguibile d’ufficio e viene reso
noto dai mezzi di informazione solo se si tratta di un episodio particolarmente violento e cruento,
che possa attirare l’attenzione dei lettori e colpire la loro immaginazione.
Dal punto di vista processuale non bisogna dimenticare che l’istituto della querela è uno
strumento che può essere attivato tanto per offese a interessi privati quanto per offese a interessi
pubblici; tuttavia è previsto dal legislatore quale condizione di procedibilità nei casi di tenuità
dell’interesse pubblico, rimettendo alla volontà della persona offesa la decisione circa
l’opportunità di rendere nota all’autorità giudiziaria la lesione di un proprio interesse privato41.
Difficilmente verrà manifestata dallo straniero la volontà di invocare la tutela di un proprio
interesse, poiché la precarietà della condizione dell’immigrato, la diversità di linguaggio, di
culture, di tradizioni ostacolano fortemente un dialogo costruttivo con gli operatori giudiziari.
Si tenga presente che l’immigrato incontra un’estrema difficoltà all’utilizzazione degli strumenti
processuali a tutela dei propri interessi non solo quando è vittima di condotte penalmente
rilevanti, ma anche, quale presunto autore del reato, nella fase di custodia cautelare o di pendenza
dei successivi gradi di giudizio.
L’extracomunitario subisce una discriminazione poiché come soggetto economicamente debole
non può assicurarsi una difesa forte all’interno del processo accusatorio. Infatti vivono la realtà
carceraria in completo isolamento, non solo dal mondo esterno, ma dagli stessi detenuti
compresenti a causa delle differenze linguistiche e delle difficoltà di integrazione; inoltre i
contatti con gli avvocati, per lo più assegnati d’ufficio, sono rarissimi e questo incide fortemente
sul loro diritto di difesa garantito ex art. 24 Cost.
Le forze di polizia mostrano nei confronti degli stranieri una tendenza a operare arresti di
41 A. Santoro,Voce Querela, in “N. Dig. it.”, vol.XIV, 1967, p. 642.
23
“gruppo”, senza sottilizzare sulle singole responsabilità; in fase di valutazione da parte del
giudice sulla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle misure cautelari, l’immigrato
extracomunitario si presenta in posizione estremamente svantaggiata, specie se privo di
documenti o di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, quindi la custodia cautelare diviene
praticamente automatica42.
L’uso dei riti alternativi al dibattimento è limitatissimo a causa dello scarso interesse dimostrato
dagli avvocati e dall’impossibilità per gli stranieri di essere pienamente informati dei diritti loro
riconosciuti.
In conclusione si può affermare che le occasioni nelle quali lo straniero diviene vittima di
discriminazioni e, nella forma più grave, di crimini di stampo razzista sono molteplici; tuttavia
tali episodi non sono né conosciuti, né studiati, probabilmente per lo scarso interesse che essi
susciterebbero nell’opinione pubblica.
La ripercussione più grave è che questa “lacuna” non consente un approfondimento completo
delle implicazioni legate al fenomeno immigratorio, che troppo spesso viene associato
all’aumento della criminalità nelle grandi città, senza tenere conto dell’altra faccia della
medaglia, cioè lo straniero non solo autore, ma anche vittima del reato.
42 M. Pastore, Lo straniero e la legge penale, in “Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e
criminalità degli immigrati”, “Quaderni ISMU”, n. 9, 1995, p. 51.
24
Bibliografia
Arrigo G., La politica sociale nel trattato di Amsterdam, in “Il diritto del lavoro”, 1998.
Balconi M., Diritto comunitario ed europeo, note a margine delle sentenze in rassegna,
in“Diritto, immigrazione e cittadinanza”, n. 1/99.
De Francesco G., Commento all’arte. 3 della legge n. 205/93, in “Leg.en.”, 1994.
Guerrini F., Il motivo a delinquere nella prospettiva de lrapporto tra colpevole e offeso, in
“Arch. en.”, 1976.
Magno P., Diritti sociali nell’ordinamento dell’unione europea dopo Amsterdam, in “Il diritto
del lavoro”, 1998.
Malinverni A., Voce Motivi, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XXIV, 1977.
Martines T., Diritto costituzionale, 1994.
Messina S., Considerazioni “de iure condendo” sulle circostanze dicui agli artt. 61, n. 1 e 62, n.
1 del codice penale, in “Riv.pen.”,1973.
Nuvolone P., La vittima nella genesi del delitto,“Indice penale”, 1973.
PaliddaS., La devianza e la vittimizzazione, in Terzo Rapporto sulle migrazioni, Milano,
Fondazione Cariplo-ISMU,1997.
Pastore M., Lo straniero e la legge penale, in “Produzione normativa e costruzione sociale della
devianza e criminalità degli immigrati”, in “Quaderni ISMU”, 1995.
Santoro A., Voce Querela, in“N. Dig. it.”, vol. XIV, 1967, p. 642.
Sperduti G., Il principio di non-discriminazione e una recente sentenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo, in “Riv. dir. int.”, 1976.
25
26