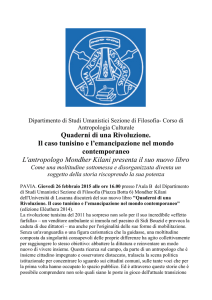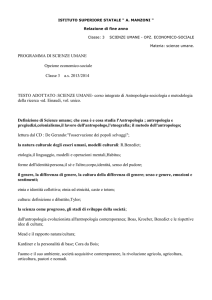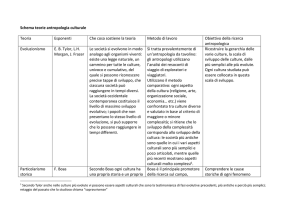Che cos’è il lavoro antropologico di M. Kilani
Mondher Kilani è professore di antropologia nell’Università di Losanna, ha svolto lunghe ricerche sul campo e ha scritto
molti libri di analisi critica del linguaggio specifico dell’antropologia e della teoria antropologica. Il brano che segue, tratto
da un libro del 1997 intitolato L’invenzione dell’altro, è una spiegazione molto chiara, almeno nella prima parte, del
lavoro di un antropologo, delle diverse fasi in cui si articola e degli obiettivi che ne sono alla base. Nelle prime righe
Kilani espone in modo semplice e condivisibile ciò che fanno gli antropologi. La seconda parte del brano mostra, invece,
che non tutto è così chiaro, che non tutto è così ben delineato, e che il lavoro antropologico nasconde numerosi ostacoli
logici ed epistemologici, oltre che pratici. Il primo fra tutti, che ha del resto animato molte discussioni fra gli antropologi a
partire dalla seconda metà del Novecento, riguarda il fondamento empirico dell’antropologia: il sapere, le conoscenze
che l’antropologia costruisce su particolari gruppi umani (società, tribù, comunità ecc.) attraverso le ricerche sul campo e
secondo le modalità così bene ricordate da Kilani hanno un aggancio reale con quegli uomini e con l’Uomo in generale?
È una riflessione ovviamente non facile, che il brano qui riportato sintetizza nei suoi termini principali.
In che cosa consiste il lavoro dell’antropologo e come lo si può
rappresentare? Possiamo rispondere dicendo che l’antropologo ha in
primo luogo un campo di ricerca che sceglie per ragioni sia
scientifiche sia personali e nel quale soggiorna per un certo numero di
mesi o anni. Sul campo egli fa l’apprendistato di una cultura e di un
modo di pensare, interagisce con delle donne e degli uomini, fa delle
scoperte, sperimenta errori, raccoglie dati, elabora le prime sintesi,
formula delle ipotesi. A conclusione del lavoro sul campo, torna a
casa con diversi “oggetti”, disponibili per essere pensati e trattati
mediante concetti, termini tecnici e modelli teorici, nel quadro di un
testo monografico. Insomma, al tempo del campo segue il tempo della
scrittura. La finalità del lavoro dell’antropologo è, infatti, offrire un
testo elaborato, attraverso il quale comunicare a un lettore potenziale –
generalmente un collega, ma non solo – la propria visione
dell’esperienza dei membri della società presso la quale ha
soggiornato.
Quanto detto rappresenta una schematizzazione del lavoro
dell’antropologo, lavoro che in verità è assai più complesso. Anzitutto
va respinta l’idea che vi sia una realtà – il campo – che esiste
indipendentemente dal lavoro antropologico e che preesiste ad esso. Il
campo non è un’entità già data che attende d’essere scoperta ed
esplorata dal solitario e intrepido antropologo. L’immagine
dell’antropologo che giunge sul posto, armato del suo solo sguardo,
per raccogliere dei dati, suscettibili di essere trattati poi teoricamente,
appartiene a una visione ingenua del lavoro sul campo, che si fonda su
una duplice illusione.
La prima illusione è credere che l’esteriorità dell’oggetto implichi di
per sé l’oggettività. Questa concezione dimentica che la postulata
differenza dell’oggetto dal soggetto che l’osserva non è una qualità
intrinseca dell’oggetto, un’essenza, ma il prodotto di una storia
differenziale che li costituisce entrambi – soggetto e oggetto – come
differenti. La seconda illusione è credere nella simultaneità fra
l’oggetto da vedere e l’atto di vedere, il che equivale ad assimilare la
presenza dell’antropologo sul campo al presente dell’oggetto
etnografico. Tale confusione, che annulla ogni distanza storica, è il
risultato dell’idea oggettivistica secondo la quale l’oggetto
dell’antropologo sarebbe un dato pronto da essere osservato e il
discorso dell’antropologo sarebbe identificabile con il linguaggio
dell’osservatore neutro.
Ma, se il rapporto con il campo non è un rapporto tecnico neutro,
ancor meno è un rapporto di fusione simpatetica con l’oggetto di
studio: l’antropologo non deve confondersi con l’altro al punto da
diventare egli stesso l’altro. Se procede in tal modo, se parla lo stesso
linguaggio dell’indigeno, non è più in una situazione dialogica, non ha
la possibilità di tradurre nel proprio codice e ancor meno di riferirci la
sua esperienza.
Insomma, la conoscenza antropologica è un lavoro di mediazione con
la distanza e la differenza, lavoro che comincia già sul campo. In altri
termini, il campo si definisce subito ed essenzialmente come un lavoro
simbolico di costruzione di senso, nel quadro di un’interazione
discorsiva, di una negoziazione di punti di vista fra l’antropologo e i
suoi informatori.
M. Kilani, L’invenzione dell’altro, Dedalo, Bari 1997, 51-52