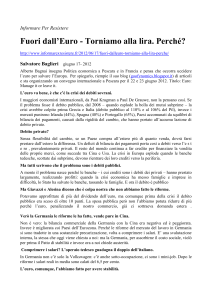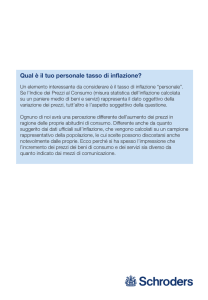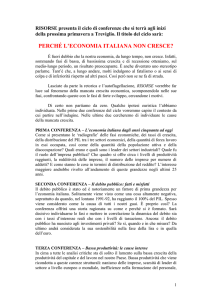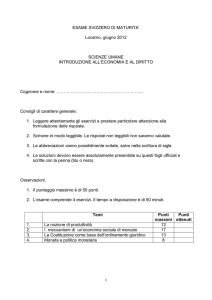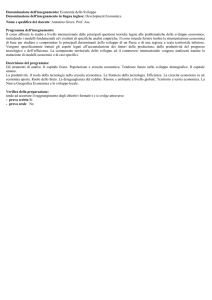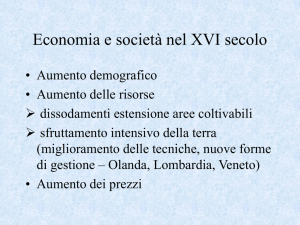Sistemi Economici Comparati
Anno accademico 2014-2015
Prof.sa Renata Targetti Lenti
Le caratteristiche dello sviluppo economico
italiano: dal miracolo economico all’entrata
nell’euro
Lezione 15 4/12/2014
Il declino dell’economia italiana
Nel maggio 2005 l’Economist in un breve articolo sottolineava
«Italy's economy is stagnant, its businesses depressed—and its
reforms moribund».
Nel 2003 Carlo d’Adda si chiedeva se il «modestissimo ritmo
di crescita» dell’economia italiana potesse considerarsi «un
fenomeno malgrado tutto di natura transitoria e destinato a
riassorbirsi una volta che la congiuntura internazionale» o
invece una tendenza di segno negativo, con radici lontane e
destinata ad accentuarsi nei prossimi anni, almeno in
mancanza di vigorose trasformazioni dell’apparato produttivo
e delle istituzioni che lo reggono».
Nel 2010, Mario Draghi governatore della Banca d’Italia
sintetizzava così le fasi dello sviluppo e del declino italiano
«Negli anni Ottanta l'economia italiana è cresciuta del 27 per
cento; negli anni Novanta del 17 per cento; tra il 2000 e il
2007 - prima della crisi - è cresciuta dell'8 per cento, mentre
gli altri paesi dell'area dell'euro crescevano del 14. …
Il divario fra l'Italia e gli altri paesi perdura nella fase di
ripresa. Questi dati esprimono sinteticamente la difficoltà delle
imprese italiane a essere competitive, dei responsabili della
politica economica ad attuare strategie di modernizzazione del
Paese, degli stessi economisti a orientare le proprie ricerche e a
comunicarne al pubblico i risultati».
Nel 2011, Monti in un articolo sul Corriere della Sera, indicava
insintesi la ricetta per tornare a crescere «Meno barriere
all'entrata, meno privilegi e rendite per gli inclusi, più
possibilità di ingresso per gli esclusi e per i giovani, più spazio
al merito e alla concorrenza: questi gli ingredienti di
un'economia più competitiva, di una maggiore crescita, di una
società più aperta, più inclusiva, più equa. Purtroppo, questo
impegnativo disegno non è stato voluto con continuità; ancor
meno è stato realizzato».
Nel “XV Rapporto” della Fondazione Einaudi il capitolo
dedicato all’Italia è intitolato “L’Italia della crisi”:
Tabella1
I fattori del declino hanno radici lontane
Numerosi sono i fattori, tra di loro strettamente interconnessi,
che spiegano il rallentamento della crescita a partire dagli anni
90 e dalla metà del 2000 un sentiero di vero “declino”.
Non si sono sapute cogliere le opportunità di crescita offerte
dall’«età dell’oro» nel periodo 1945-1975 da un modello di
produzione fordista, dall’integrazione internazionale e da una
sostenuta crescita delle esportazioni.
Convenzionalmente si fissa la fine di questa fase nel 1975, e
cioè nell’anno della prima seria recessione post-bellica,
conseguente alla “crisi petrolifera”.
Nel 1975 vennero adottate misure di restrizione della domanda
adottate,
contemporaneamente
nei
principali
paesi
industrializzati, misure per contrastare i disavanzi commerciali
consguenti alla quadruplicazione del prezzo del petrolio.
Secondo altri, invece, la fine dell’età dell’oro potrebbe essere
anticipata e collocata già nei primi anni ’70 in corrispondenza
al forte rallentamento nella crescita della produttività
nell’economia americana, alla crescita dell’inflazione, alla
dichiarazione di inconvertibilità del dollaro ed alla sua
conseguente svalutazione, al crollo del sistema di Bretton
Woods con il passaggio a cambi flessibili.
Questo crollo rappresentò un vero cambio di regime di politica
economica a livello internazionale.
Il contesto politico istituzionale
Alcuni autori hanno sottolineato le variabili, endogene al
sistema, che hanno operato nel lungo periodo come il contesto
politico e istituzionale:
1) Una classe dirigente rivolta a conseguire obiettivi di breve
anziché di lungo periodo è stata incapace di intraprendere le
necessarie riforme strutturali. Non è stata in grado di
perseguire lo“State and Nation building”
2) le inefficienze della pubblica amministrazione
3) il prevalere dei legami di natura familiare e/o di “clan”.
I fattori economici più recenti
Altri autori hanno evidenziato i fattori economici che negli anni
più recenti hanno influenzato negativamente il livello della
produttività e conseguentemente della competitività del nostro
sistema:
i) il basso tasso d’accumulazione, e la riduzione delle spese di
ricerca e sviluppo.
ii) un flusso di esportazioni troppo concentrato nei settori
tradizionali.
iii) la dimensione delle imprese e la struttura proprietaria, hanno
frenato e ancora frenano il progresso tecnologico e la capacità di
conquistare nuovi mercati.
iv) il processo di privatizzazione di molte imprese pubbliche,
dagli anni 90, poi, si è tradotto nella formazione di nuovi
monopoli ed in rendite per pochi.
La globalizzazione ed i vincoli di policy
La reazione delle imprese italiane alle sfide della globalizzazione
è stata in larga misura quella di delocalizzare nei paesi in cui il
costo del lavoro era inferiore.
Il tasso di risparmio e di investimento si è progressivamente
ridotto nel tempo.
Le misure di politica economica, anche recenti, sono state
orientate prevalentemente alla stabilità, che è certamente
condizione necessaria, ma non sufficiente per la crescita.
L’elevato debito pubblico, insieme alla rigidità della spesa
pubblica, ha rappresentato un grosso ostacolo all’avvio di
politiche virtuose.
Dal «miracolo economico» all’«autunno caldo».
Gli anni del primo dopoguerra, fra il 1951 e il 1963, sono stati
definiti gli anni del “miracolo economico”, in cui cioè “la società
italiana realizzò la più profonda trasformazione della sua storia
contemporanea”.
La crescita del prodotto interno lordo si mantenne sostenuta, anche
se inferiore a quella del periodo della ricostruzione, e cioè pari al
5,8% medio annuo, risultato attribuibile in larga misura all’elevato
tasso di accumulazione, pari al 9,4% medio annuo.
Bassi salari ed elevata produttività favorirono la formazione di
profitti che vennero reinvestiti. Gli investimenti fissi lordi
crebbero quasi ininterrottamente.
La progressiva apertura si rivelò infatti un fattore di crescita della
domanda e del reddito grazie alla dinamica delle esportazioni. Si
tradusse anche in un potente stimolo alla concorrenza,
contribuendo ad accrescere competitività ed efficienza del sistema
industriale.
Fattori esterni e interni
La scelta di un elevato grado di apertura e del conseguente tipo di
specializzazione si trasformò in un “vincolo” negli anni
successivi.
La specializzazione si era infatti concentrata in settori tradizionali
quali tessile, mobili, beni strumentali, beni alimentari ed
elettrodomestici.
In questi settori l’economia italiana godeva di un elevato grado di
competitività grazie ad un minor costo del lavoro. Tale
specializzazione era funzionale anche alla domanda interna
trainata da consumi che aumentavano con il reddito e l’
occupazione.
Secondo altri autori, invece, i fattori che avrebbero condizionato i
futuri sviluppi erano principalmente di natura interna.
Il dualismo della crescita, l’arretratezza dell’economia
meridionale, una unificazione economica e sociale ancora
incompiuta, la scarsità di capitale umano apparivano come i
principali fattori di criticità.
L’arresto del processo di accumulazione
Il processo di accumulazione di capitale, stabile fino al 1963,
improvvisamente subì un’ inversione.
i) La prima ipotesi è stata formulata da Kindleberger il quale,
basandosi sulla tesi che l’Italia, così come altri paesi europei,
fosse un’economia dualistica caratterizzata da un eccesso di
offerta di lavoro nel settore agricolo, considerava l’arresto
del processo di accumulazione nel settore industriale come
l’inevitabile conseguenza dell’esaurimento dei fattori
produttivi che, in precedenza, avevano favorito la crescita
(modello di Lewis).
ii) In realtà una situazione di piena occupazione era stata
raggiunta solo nel triangolo industriale. Tuttavia era cresciuto
un certo numero numero di lavoratori “scoraggiati”. Inoltre
erano iniziati i primi flussi migratori verso i paesi della CEE.
Al dualismo territoriale si erano aggiunti quello settoriale e
quello salariale.
La redistribuzione del reddito dai profitti ai salari
ii)Una seconda spiegazione della contrazione degli investimenti
fa riferimento alla redistribuzione dei redditi dai profitti ai salari
come conseguenza di aumenti salariali superiori a quelli della
produttività. La crescita dei salari era stata parzialmente scaricata
sui prezzi.
Questa traslazione non era stata tuttavia sufficiente a mantenere
invariati i margini di profitto, e quindi a sostenere il processo di
accumulazione mediante l’autofinanziamento.
Proprio per mantenere elevato il tasso di crescita degli
investimenti vennero adottate, dalla Banca d’Italia politiche
espansive.
L’attività di programmazione, adottata con la Nota aggiuntiva di
La Malfa alla Relazione generale sulla situazione economica del
paese, doveva costituire lo strumento per coordinare le diverse
misure di policy. In realtà allarmò gli imprenditori con lo spettro
della “pianificazione socialista”.
Un secondo effetto fu quello di accentrare le decisioni di
investimento
pubblico
nel
cosiddetto
“tavolo
della
programmazione”.
Proprio le grandi imprese a partecipazione statale, non vincolate
all’obiettivo del profitto di breve periodo, avevano infatti dato
vita a strutture produttive di “capitalismo manageriale”,
prioritariamente orientate alla crescita ed alla innovazione più di
quanto non lo fosse stato il capitalismo familiare del grande
capitale privato.
Con la programmazione le decisioni d’investimento vengono
subordinate a criteri di natura politica.
Sempre nel 1962, al fine di mettere sotto controllo
l’evasione fiscale, era stata varata la legge che istituiva
l’imposta cedolare di acconto.
La manovra monetaria espansiva contribuì a rafforzare
le spinte inflazionistiche. Quella fiscale restrittiva finì
con l’alimentare la fuoruscita di capitali verso l’estero
da parte di imprenditori e capitalisti allarmati dalla
manovra.
Il disavanzo dei movimenti di capitale finì con il
sovrapporsi a quello delle partite correnti conseguente
alla riduzione delle esportazioni divenute più costose a
causa dell’inflazione.
La nazionalizzazione dell’energia elettrica
La
nazionalizzazione
dell’industria
produttrice
dell’energia elettrica avrebbe dovuto immettere capitali
nel sistema produttivo privato attraverso i risarcimenti
concessi agli azionisti delle società ex-elettriche,
trasformando le azioni in obbligazioni a carico dello
Stato. Le imprese nazionalizzate avrebbero potuto così
disporre di nuovi capitali da investire.
Invece il flusso di capitali derivante dagli indennizzi
andò disperso in “iniziative inconcludenti”.
La nazionalizzazione provocò inoltre ulteriore allarme
nel mondo imprenditoriale, che temette una eccessiva
espansione dello Stato nelle attività produttive.
I divari di produttività
iii) Una terza interpretazione individua nella composizione della
domanda interna e di quella esterna il principale fattore di crescita
del costo del lavoro, e quindi della crisi del 1962-63.
La produzione, inizialmente rivolta ad alimentare il flusso delle
esportazioni, aveva finito con il condizionare anche la domanda
interna determinando una vera e propria distorsione nei consumi
ed in particolare dei beni durevoli come gli elettrodomestici..
Si era così generato un dualismo settoriale tra industrie che
producevano per l’estero, caratterizzate da livelli di produttività
più elevati, ed altre che producevano essenzialmente per il
mercato interno.
La prima e più grave conseguenza degli aumenti di produttività
all’interno dei settori più dinamici, collocati prevalentemente
nelle regioni settentrionali, fu quella di alimentare rivendicazioni
intese ad ottenere aumenti salariali superiori a quelli della
produttività stessa.
Nello stesso tempo la crescita della domanda di beni di consumo,
più elevata di quanto sarebbe stato compatibile con l’aumento del
reddito, aveva finito con l’alimentare tensioni inflazionistiche e
con il rallentare lo stesso sviluppo.
L’aumento dei prezzi era stato considerato dagli imprenditori
come uno strumento per mantenere elevati i margini di profitto.
Tuttavia, nonostante la stabilità dei profitti gli investimenti,
privati e pubblici, si mantenevano bassi.
Le imprese, che in passato avevano contribuito al
“miracolo economico”, non erano state in grado di
investire in nuovi settori e nuovi mercati.
Continuava, quindi, il deflusso dei capitali, alimentato
anche dai risparmi delle famiglie in conseguenza della
limitata gamma di attività finanziarie offerta dal mercato
interno. La bilancia dei pagamenti continuò quindi a
presentare saldi passivi.
L’esigenza di contenere l’inflazione e di riequilibrare la
bilancia dei pagamenti, intervenendo per
ridurre
domanda interna e importazioni, ”costrinse” ben presto
la Banca d’Italia, nell’autunno del 1963, a far seguire
alla stretta fiscale quella monetaria.
Le caratteristiche della struttura produttiva
Nella seconda metà degli anni ’60 si era verificato un mutamento
nella sua composizione, con una riduzione di quella operaia ed un
aumento di quella assorbita dalla Pubblica Amministrazione e dal
terziario privato. Questo ridusse “la produttività totale del
sistema ed il suo potenziale di sviluppo”.
I livelli di produttività erano inferiori a quelli dei paesi
concorrenti (imprese di dimensione medio-piccola, una modesta
presenza di produzioni tecnologicamente avanzate).
Questi fattori strutturali, combinandosi con quelli congiunturali
come l’aumento del costo del lavoro e le misure deflazionistiche
decise dalla Banca Centrale nel 1963, avevano indotto le imprese
ad adottare processi di ristrutturazione e di riorganizzazione
produttiva, ad aumentare i ritmi di lavoro, ad adottare tecniche a
più elevata intensità di capitale.
Tra il 1963 ed il 1969 le numerose contraddizioni che avevano
caratterizzato il precedente processo di sviluppo finirono con
l’alimentare tensioni inflazionistiche di lunga durata.
Il modello di sviluppo italiano si rivelò fragile e soggetto a fattori
ciclici, inadeguato a sostenere la crescita di un settore industriale
moderno in grado di assorbire la sottoccupazione agricola e di
ridurre le numerose forme di dualismo e di bloccare l’inflazione.
La crescita della produzione era stata solo parzialmente stimolata
dalla domanda interna. Una determinante importante era sempre
stata, infatti, la domanda estera, che alla fine rivelò un fattore di
rigidità.
Nel settembre del 1969 ebbe inizio la trattativa per il rinnovo del
contratto dei metalmeccanici.
Nel 1970 l’andamento dell’economia era stato condizionato
dall’eccezionale aumento dei costi non compensato dall’ aumento
della produttività.
Sindacato e sinistra al governo ritenevano che dall’aumento dei
salari sarebbe derivato un aumento della domanda interna,
maggiori investimenti e quindi un’accresciuta produttività, che
avrebbe compensato l’aumento dei costi conseguente agli
aumenti salariali.
Guido Carli invece nelle Considerazioni finali della Relazione
annuale per il 1971, aveva affermato che il circuito virtuoso dagli
aumenti salariali alla domanda per consumi non si sarebbe
verificato.
•
Gli anni 70. Dall’«autunno caldo» alla crisi energetica.
La flessione della crescita di produzione e produttività, la stasi
degli investimenti, l’inflazione, il pronunciato squilibrio dei
conti pubblici e di quelli esteri sono stati i fenomeni più
significativi degli anni della stagflazione successivi al 1974.
L’indicizzazione salariale, conseguente all’aumento dei prezzi
derivanti dai due shock petroliferi aveva contribuito a
determinare un’inflazione a due cifre, superiore a quella di
tutti gli altri paesi europei.
I livelli di profitto venivano mantenuti ad un livello
soddisfacente solamente grazie alle variazioni del tasso cambio
e cioè alla svalutazione.
Gli effetti dell’austerità
La caduta degli investimenti veniva attribuita anche
alla contrazione dei consumi, la quale era a sua volta
da ascrivere alle misure restrittive adottate nel 197374 ed alla successiva stretta creditizia del 1977-78
operata per fare fronte alla crisi energetica prima e
alla nuova crisi valutaria poi.
La successiva politica espansiva del 1979-80 non era
stata in grado di determinare una effettiva ripresa,
avendo coinciso con la seconda crisi energetica e con
un processo inflazionistico e di deterioramento dei
conti con l’estero di rilevanti dimensioni.
La manovra restrittiva del 1980, infine, aveva
determinato una nuova, prolungata contrazione.
Le riforme del mercato del lavoro
Le rivendicazioni salariali ed il complesso di riforme del
mercato del lavoro aveva provocato, nei primi cinque anni del
decennio ’70, un significativo aumento del costo del lavoro per
unità di prodotto nonché un generale appiattimento salariale.
Nel 1969 erano state abolite le cosiddette “gabbie salariali”
introdotte per tenere conto delle differenze nel costo della vita
nelle diverse regioni del paese. I salari, di conseguenza, erano
stati uniformati verso l’alto.
Nel 1970 era stato inoltre adottato lo Statuto dei Lavoratori.
Furono quindi numerose le misure che finirono con il
determinare aumento dei costi e vincoli alla gestione del
personale. Paolo Baffi, governatore della Banca d’Italia, nelle
Considerazioni finali alla Relazione del 1976 sottolineava
infatti come si fosse venuto a determinare un incremento dei
costi superiore a quello degli altri paesi industrializzati.
La scala mobile
Una spinta alla crescita dei costi proveniva inoltre dal
meccanismo della scala mobile, che adeguava i salari al costo
della vita attraverso il cosiddetto “punto di contingenza”.
Questo strumento era nato per attenuare la conflittualità
salariale, garantendo il potere d’acquisto al lavoratore ed
all’imprenditore prospettive più stabili di programmazione
aziendale.
Inizialmente il punto di contingenza era parametrato al livello
del salario di riferimento differenziato per settori.
Nel 1975 il punto venne unificato per tutti i settori,
indipendentemente dai divari settoriali di retribuzione e di
produttività, dando così origine, nei settori a minore
produttività, ad una spinta verso l’alto dei costi.
Si sviluppò un intenso dibattito circa l’opportunità di “sterilizzare” la scala
mobile, ovvero di escludere dal computo del punto di contingenza gli aumenti
dei prezzi di origine esogena (materie, prime, aumento dell’imposta indiretta)
al fine di spezzare il nesso tra deprezzamento del cambio e inflazione interna.
Agli aumenti salariali si erano inoltre aggiunti ulteriori fattori che avevano
contribuito all’incremento dei costi. In particolare si erano ridotti i livelli di
produttività, e di conseguenza era aumentato il costo del lavoro per unità di
prodotto.
L’inasprirsi della conflittualità colpì in particolare le grandi imprese
concentrate verticalmente e operanti in settori a elevato intensità di energia.
Si modificò il modello di impresa verso una maggiore specializzazione
produttiva all’interno di imprese di dimensioni più piccole.
Questa scelta consentiva una maggiore flessibilità grazie anche al ricorso all’
outsourcing di alcune funzioni. In parallelo si espanse anche il cosiddetto
“terziario avanzato” che forniva servizi alle imprese.
La “piccola” dimensione diventerà una delle
caratteristiche peculiari, ma anche un elemento di
debolezza, dell’industria italiana.
In particolare, in questo periodo si consolidò la
specializzazione nei settori tradizionali più esposti
alla concorrenza dei paesi emergenti e caratterizzati
da un basso livello di ricerca e di innovazione.
Le svalutazioni degli anni ‘70, reiterate nel ’92, non
potevano che orientare il sistema produttivo verso
settori in cui la competizione fra imprese era fondata
sui prezzi o che erano caratterizzati da estrema
flessibilità organizzativa e produttiva.
Il primo shock petrolifero
Nel corso degli anni ‘70 altri tre eventi contribuirono all’aumento dei costi di
produzione ed alla riduzione dei margini di profitto:
i) A seguito del Kennedy Round si verificò innanzitutto un’espansione del
grado di apertura e di internazionalizzazione delle economie, con
progressiva riduzione delle barriere protezionistiche fra la CEE e il resto
del mondo.
ii) Nel febbraio del 1973 fu deciso di passare dai cambi fissi a quelli flessibili,
consentendo che la lira si svalutasse rispetto al dollaro ed alle altre valute
forti come il marco. Si determinò così un aumento dei prezzi (in lire) dei
prodotti importati, ed in particolare delle materie prime. La svalutazione
accelerò l’inflazione che, a sua volta, indusse un’ulteriore svalutazione al
fine di recuperare competitività, generando inoltre instabilità ed incertezza
per le imprese.
iii) nell’ottobre del 1973, la guerra del Kippur provocò una crisi energetica
che quadruplicò i prezzi del petrolio. In Italia gli effetti sui costi degli
aumenti dei prezzi delle materie prime e della svalutazione furono
amplificati dall’operare della scala mobile. Si determinarono ulteriori spinte
inflazionistiche alimentate, in un circuito perverso, dalle aspettative.
In seguito all’aumento dei tassi di interesse, trainati dall’
inflazione aumentò il costo del capitale per le imprese che si
erano indebitate a breve termine.
Anche se il tasso di interesse reale corrisposto dalle imprese
restava basso, quando non negativo, l’aumento del costo del
capitale determinò una grave crisi finanziaria a carico dei gruppi
industriali più deboli che non riuscivano, per carenza di domanda
e per la concorrenza internazionale, a trasferire per intero l’
aumento dei costi sui prezzi di vendita. Con la caduta dei margini
di profitto si era ridotta una importante fonte di
autofinanziamento,
La legislazione imponeva la separazione tra banche commerciali
e istituti di credito industriale, rendendo di fatto molto debole il
monitoraggio dell’ efficienza delle imprese da parte delle banche.
Per lungo tempo il governo delle grandi società private italiane
era rimasto nelle mani di una proprietà stabile, ma che non subiva
gli stimoli della concorrenza.
Gli anni ’70 sono stati caratterizzati anche da significativi
aumenti nel peso della Pubblica Amministrazione.
L’introduzione di un sistema di protezione sociale universale, e
l'istituzione della pensione sociale fecero lievitare la spesa
corrente.
Il carico contributivo era limitato ai soli lavoratori (in
particolare quelli dipendenti) mentre i benefici si estendevano
a tutta la popolazione.
La spesa pubblica si espanse anche in altre direzioni per fare
fronte ad alcuni fra gli effetti più gravi della crisi Trasferimenti
a famiglie e imprese).
Nacque in quegli anni una sorta di «capitalismo assistito».
L’indennità di contingenza venne adeguata a quella del settore
privato e furono varate norme per l’esodo volontario, che di
fatto aumentarono la spesa pubblica.
Le riforme fiscali
Anche le entrate pubbliche subirono le conseguenze di riforme
che determinarono un aumento del gettito. Nel 1972, per
ottemperare ad un impegno con la CEE, l’Imposta generale sull’
entrata (IGE) venne sostituita dall’Imposta sul valore aggiunto
(IVA).
Con la riforma delle imposte dirette, attuata da Bruno Visentini
nel 1973-74, vennero introdotti l’IRPEF ed il sostituto d’imposta.
Con il prelievo alla fonte sui redditi da lavoro dipendente venne
ridotta drasticamente l’evasione fiscale, con conseguente forte
incremento delle entrate. Visentini introdusse anche una nuova
disciplina del diritto societario, contribuendo a ridurre
ulteriormente l’evasione.
Grazie alle riforme fiscali le entrate pubbliche passarono da un
valore inferiore al 30% del Pil all’inizio del decennio al 34% nel
1980. Si trattò di un aumento significativo al quale contribuirono
l’inflazione ed il fenomeno del fiscal drag.
L’aumento delle imposte, tuttavia, non bastò a compensare quello
della spesa pubblica, tanto più che, contemporaneamente,
cresceva anche la spesa per interessi a causa della lievitazione del
debito pubblico.
Anche il ridotto tasso di sviluppo dell’economia, a partire dal
1974, aveva influito negativamente sull’andamento delle entrate
pubbliche.
Nonostante la crisi diffusa di diversi grandi gruppi, il sistema
produttivo italiano ha manifestato, in questi anni, una notevole
capacità di resistenza.
Proprio nel periodo 1974-83 e con riferimento a squilibri come
l’inflazione, il deficit pubblico, il disavanzo della bilancia dei
pagamenti, l’indebitamento estero, l’ inquinamento e il degrado
ambientale si è ampliato il divario tra il nostro sistema economico
e gli altri paesi industrializzati.
Dalla seconda crisi petrolifera alla caduta del muro di
Berlino.
Nel 1979 si verificò la «seconda» crisi petrolifera che, tuttavia
non generò tensioni inflazionistiche comparabili a quelle prodotte
dalla «prima» grazie alla riduzione della dipendenza dal petrolio.
Nel periodo successivo al 1979 uno degli obiettivi centrali, sia a
livello internazionale che a livello nazionale, fu quello di frenare
l’inflazione con una politica monetaria restrittiva che fece
aumentare i tassi d’interesse.
Nello stesso anno divenne operativa l’adesione dell’Italia allo
SME (Sistema Monetario Europeo). Ebbe così fine quel processo
di «protezionismo monetario» che attraverso la svalutazione della
moneta aveva consentito alle imprese italiane un recupero di
competitività.
L’adesione allo SME, che aveva obiettivi essenzialmente
macroeconomici, finì quindi per determinare conseguenze di
politica industriale, favorendo di fatto un’accelerazione degli
interventi di ristrutturazione.
Fra gli altri la sostituzione di capitale di debito con capitale
proprio, il passaggio da sistemi di produzione fordisti a sistemi
a rete e la progressiva sostituzione del capitale al lavoro per
accelerare il processo di innovazione tecnologica mediante
l’introduzione dell’elettronica e dell’informatica.
Con i distretti industriali vennero favoriti insediamenti in aree
meno congestionate dell’Italia centrale. Queste tendenze,
accompagnate da fusioni e nuove concentrazioni, furono
favorite anche dalla formazione del mercato unico europeo e
dall’accelerazione del processo di internazionalizzazione.
Gli anni 80
A partire dall’inizio degli anni ’80 si era modificata la scala mobile
“sterilizzando” gli aumenti dei prezzi di origine esogena. Venne ricalcolato il
punto di contingenza e fu emanata una legge per predeterminare l’andamento
della scala mobile sulla base dell’inflazione attesa e non di quella passata.
Come conseguenza delle ristrutturazioni aziendali, il prodotto per addetto
aumentò con un recupero, sia pure parziale, dei margini di profitto che in
precedenza erano scesi a livelli decisamente inferiori alla norma.
Il costo del lavoro permaneva elevato a causa dell’indicizzazione dei salari ai
prezzi crescenti e ad un ritmo superiore a quello della produttività.
L’inflazione, pure diminuita, restava più elevata rispetto agli altri paesi
industrializzati.
La politica monetaria restrittiva non fu sufficiente ad evitare un deprezzamento
strisciante della lira, superiore al differenziale inflazionistico con gli altri paesi:
ne conseguì un incremento del vantaggio competitivo delle imprese italiane.
Il “divorzio della Banca d’Italia dal Tesoro
Per rendere la manovra monetaria restrittiva più efficace venne
introdotta anche una modifica istituzionale. Nella seconda
metà del 1980 il ministro Andreatta abolì infatti l’obbligo, per
la Banca d’Italia, di sottoscrivere i titoli pubblici non collocati
sul mercato (“divorzio” fra Banca d’Italia e Tesoro)
La decisione favorì il rientro dall’inflazione ed indusse ad una
maggiore prudenza nelle decisioni di spesa pubblica: comportò
altresì un aggravamento del servizio del debito, che diventerà
uno dei principali fattori di crescita del disavanzo.
In seguito al riconoscimento della piena autonomia della Banca
centrale rispetto alle esigenze di finanziamento del Tesoro, ed
anche della crescente dipendenza dello Stato dal risparmio delle
famiglie, i tassi di interesse reali divennero positivi e crescenti.
La svolta del Tesoro divenne anche un segnale per le imprese. Per
far fronte ai crescenti tassi d’interesse le imprese avviarono un
processo di ristrutturazione sostituendo il capitale a debito con
quello proprio.
I processi di ristrutturazione, accompagnati da fusioni e nuove
concentrazioni, furono favoriti anche dalla formazione del
mercato unico europeo e dall’accelerazione del processo di
internazionalizzazione.
Nel corso degli anni 80 si verificò, come conseguenza di queste
ristrutturazioni, un aumento del prodotto per addetto, ed un
recupero, sia pure parziale, dei margini di profitto.
La crescita del debito pubblico
La politica monetaria restrittiva non era stata per altro
accompagnata da una politica fiscale altrettanto
severa. In particolare non era stata colta l’occasione
di stabilizzare il gravame del debito pubblico con
manovre correttive del disavanzo al netto degli
interessi.
Nel corso degli anni ’80 e fino al 1994, si è verificato
uno straordinario accumulo di debito in un contesto di
forte espansione delle entrate tributarie.
Dell’aumento complessivo del debito (salito dal 65%
al 108% del Pil fra il 1982 e il 1992) circa la metà è
attribuibile al differenziale positivo fra costo del
debito pubblico e tasso di crescita reale.
L’aumento dei tassi di interesse aveva, d’altra parte,
contribuito a rendere più oneroso l’onere del servizio
del debito, alimentando l’ulteriore crescita del
disavanzo e quindi dell’indebitamento, in un circolo
vizioso assai difficile da spezzare.
Ne è derivata una crescente accumulazione di debito
pubblico, sotto controllo solo grazie ai tassi di
interesse reali negativi.
Se quindi l’inflazione era stata posta sotto controllo,
si era determinato, con la crescita del debito pubblico,
un ulteriore fattore di instabilità, le cui conseguenze
permangono a tutt’oggi.
La crescita del debito pubblico, d’altra parte, trovava
spiegazione anche nel forte aumento della spesa sociale sia
per gli sviluppi del Welfare State sia per fare fronte alla
disoccupazione conseguente alle ristrutturazioni aziendali.
E poiché in Italia non esisteva un sistema di ammortizzatori
sociali adeguato (quali l’indennità di disoccupazione e le
procedure di avviamento al lavoro), si era finito per fare
ricorso alla batteria di strumenti esistente, “piegata” a fini
sociali.
Il differenziale di produttività tra settore privato e settore
pubblico ha così trasformato uno “Stato di diritto in uno
assistenziale”.
L’intervento dello Stato si manifestava anche
attraverso l’azione diretta nella sfera produttiva ad
opera delle imprese pubbliche e a partecipazione
statale.
Queste avevano contribuito alla ripresa postbellica,
ma col tempo il loro ruolo mutò progressivamente ed
esse si trasformarono in ”strumenti di clientela
politica anziché di rafforzamento infrastrutturale
dell’economia nazionale”.
Le imprese pubbliche cercarono di trasferire le
perdite al bilancio dello Stato attraverso l’aumento
dei fondi di dotazione e l’ottenimento di crediti
agevolati.
Gli anni della “concertazione” e della nascita dell’EURO.
I primi anni ’90 sono stati molto turbolenti. Prima la sterlina
inglese e poi la lira italiana si svalutarono in modo
consistente contribuendo ad accrescere la competitività delle
imprese ancora una volta grazie al protezionismo monetario.
La svalutazione non provocò una accelerazione
dell’inflazione.
In seguito alla crisi valutaria del 1991-92 inizia quel
processo di stabilizzazione dell’economia, che nel giro di
pochi anni avrebbe consentito di riequilibrare rapidamente i
conti pubblici, ponendo le premesse per l’ adesione all’euro.
Il Governo italiano fu «costretto» a collocare sul mercato i
propri titoli a tassi di interesse elevatissimi aggravando, così, il
peso del debito pubblico.
Il pagamento degli interessi rappresentava ancora nel 1993 il
12% del Pil. Il debito pubblico aveva raggiunto, alla fine del
1994, il picco più alto pari a ben il 123% del Pil.
In un clima di forti tensioni interne ed internazionali con il
rischio di dover affrontare un’altra svalutazione vennero
introdotte alcune misure di carattere congiunturale.
Venne varata una manovra fiscale molto restrittiva con:
- tagli alla spesa pubblica,
- introduzione di nuove imposte,
- blocco delle pensioni di anzianità
I primi anni 90 sono stati caratterizzati anche dall’introduzione
di importanti riforme strutturali:
- venne definitivamente abolita la scala mobile per eliminare
una importante componente dell’inflazione
- vennero attuate alcune importanti privatizzazioni di imprese
pubbliche.
- vennero ridotte in modo permanente alcune voci di spesa
pubblica come quella relative al sistema pensionistico
Carlo Azeglio Ciampi, succeduto ad Amato
nell’aprile del 1993, riuscì a concludere un patto con
le parti sociali per stabilire nuove relazioni industriali
e confermare la fine della scala mobile.
Questo accordo permise di avviare una nuova politica
dei redditi basata sulla «concertazione». Il cosiddetto
«patto per il lavoro» contribuì a modificare la
distribuzione funzionale del reddito a favore dei
profitti.
Gli investimenti ricominciarono ad essere una delle
componenti importanti della crescita. Questi, tuttavia,
furono diretti più a ricostituire la capacità produttiva
che a stimolare spese in innovazione, ricerca e
sviluppo.
Già a partire dal 1994 l’andamento dell’economia risultò
migliore di quello sperimentato in molti altri paesi europei.
Come conseguenza degli effetti positivi della svalutazione, la
bilancia dei pagamenti registrò un avanzo delle partite correnti
di circa il 2 per cento del Pil.
Nel periodo successivo, invece, si verificò un rallentamento
nella crescita sia del PIL sia del Pil pro capite. Il rallentamento
divenne particolarmente significativo verso la fine del
decennio con la lira ormai nell’euro.
La crescita del risparmio, la riduzione dei consumi, l’elevata
concentrazione nella distribuzione personale del reddito,
crescente a partire dal 1993, aveva certamente contribuito al
rallentamento della crescita.
L’entrata della lira nell’euro nel 1999 e le politiche
preparatorie rese necessarie per il conseguimento di questo
risultato hanno prodotto effetti positivi dal punto di vista degli
equilibri macroeconomici.
Un vincolo istituzionale come il «patto di stabilità»
dell’Europa post-Maastricht e le regole di finanza pubblica che
vi si accompagnano aveva sostituito, nella seconda metà degli
anni 90, il vincolo di mercato dei primi anni 90, e cioè il
rischio incombente di una crisi monetaria.
Molto meno positivi sono stati invece gli effetti di lungo
periodo in termini di dinamica della produzione. Le imprese
italiane, dall’inizio degli anni ‘90, avevano perso
progressivamente quote di mercato a livello internazionale a
causa dei prezzi elevati e delle caratteristiche della
composizione merceologica delle esportazioni. La crescita dei
prezzi delle esportazioni era continuata anche dopo la
rivalutazione della lira verificatesi a partire dal 1995.
La politica di privatizzazione delle imprese pubbliche avviata
negli anni ’80 non aveva prodotto risultati apprezzabili in
termini di rafforzamento delle strutture portanti del nostro
sistema produttivo.
Nel 1992 venne quindi predisposto un ulteriore piano di
privatizzazioni. Da una parte si intendeva aumentare efficienza
e redditività delle imprese, dall’altra incrementare le entrate
per ridurre l’indebitamento dello Stato.
I risultati in termini di efficienza, di stimolo alla concorrenza e
di diversificazione dei titoli scambiati sul mercato finanziario
furono tuttavia inferiori alle aspettative.
Posizioni
oligopolistiche
(quando
non
addirittura
monopolistiche) pubbliche vennero sostituite da posizioni di
natura privatistica, ma altrettanto protette. Molte imprese
privatizzate operavano, infatti, nei settori bancario, delle
telecomunicazioni e dell’energia, settori tutti al riparo dalla
concorrenza internazionale.