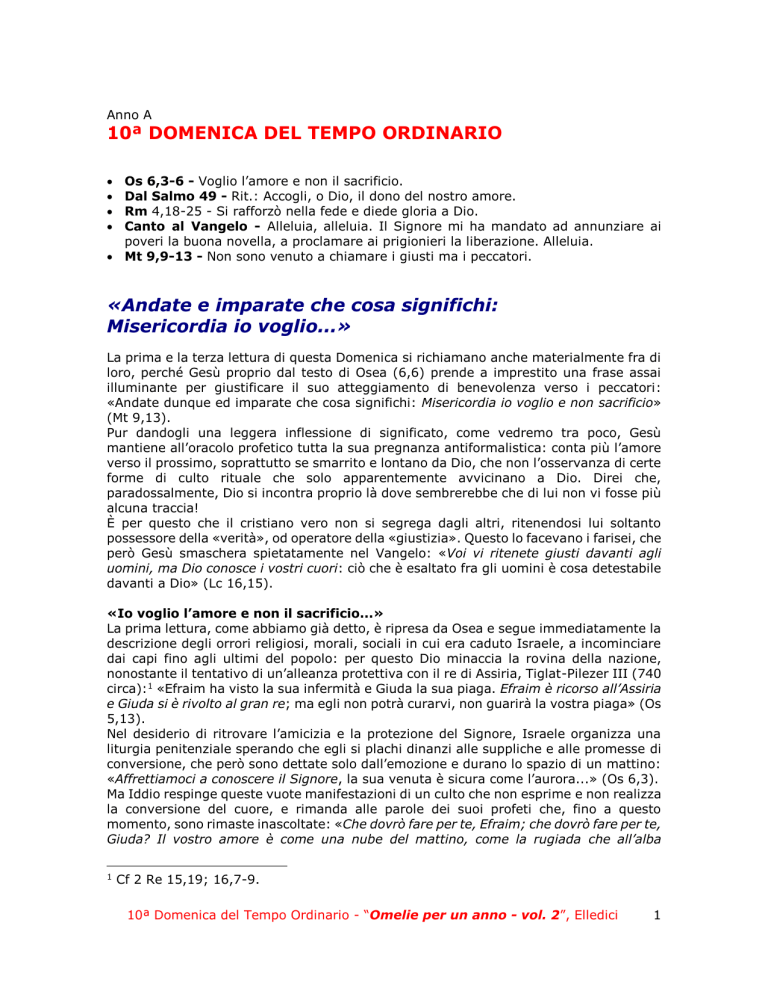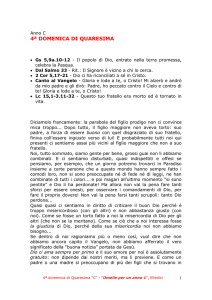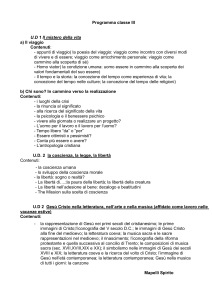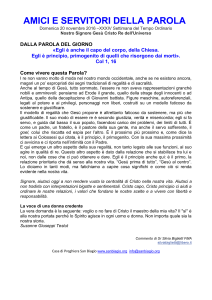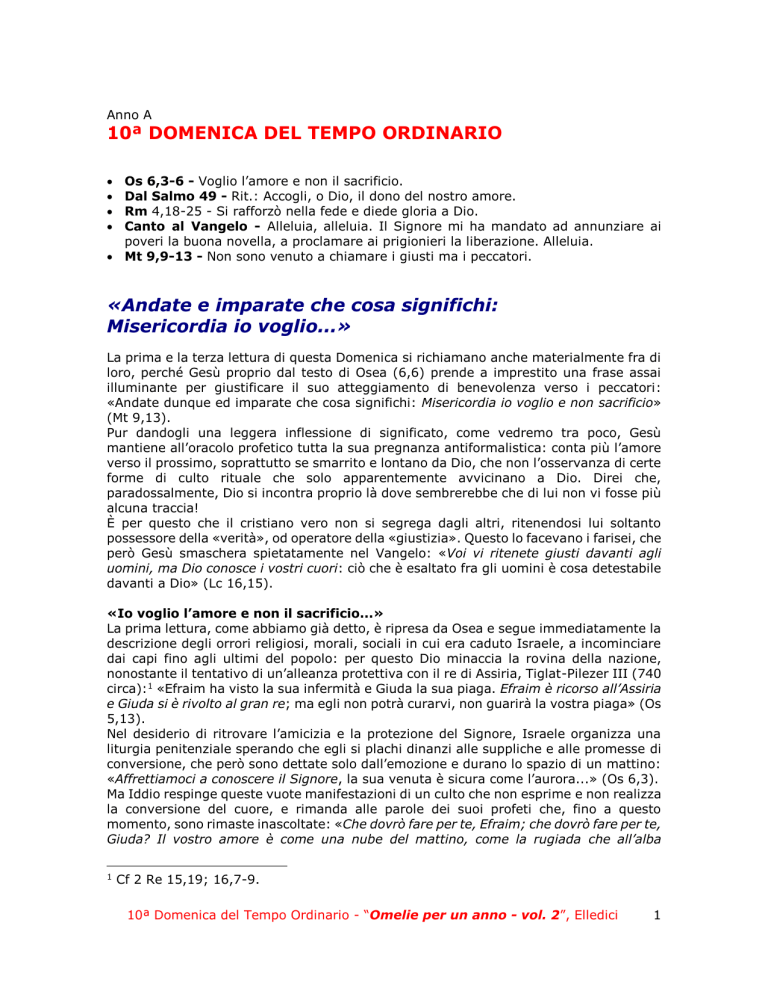
Anno A
10ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Os 6,3-6 - Voglio l’amore e non il sacrificio.
Dal Salmo 49 - Rit.: Accogli, o Dio, il dono del nostro amore.
Rm 4,18-25 - Si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio.
Canto al Vangelo - Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato ad annunziare ai
poveri la buona novella, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia.
Mt 9,9-13 - Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori.
«Andate e imparate che cosa significhi:
Misericordia io voglio...»
La prima e la terza lettura di questa Domenica si richiamano anche materialmente fra di
loro, perché Gesù proprio dal testo di Osea (6,6) prende a imprestito una frase assai
illuminante per giustificare il suo atteggiamento di benevolenza verso i peccatori:
«Andate dunque ed imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio»
(Mt 9,13).
Pur dandogli una leggera inflessione di significato, come vedremo tra poco, Gesù
mantiene all’oracolo profetico tutta la sua pregnanza antiformalistica: conta più l’amore
verso il prossimo, soprattutto se smarrito e lontano da Dio, che non l’osservanza di certe
forme di culto rituale che solo apparentemente avvicinano a Dio. Direi che,
paradossalmente, Dio si incontra proprio là dove sembrerebbe che di lui non vi fosse più
alcuna traccia!
È per questo che il cristiano vero non si segrega dagli altri, ritenendosi lui soltanto
possessore della «verità», od operatore della «giustizia». Questo lo facevano i farisei, che
però Gesù smaschera spietatamente nel Vangelo: «Voi vi ritenete giusti davanti agli
uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile
davanti a Dio» (Lc 16,15).
«Io voglio l’amore e non il sacrificio...»
La prima lettura, come abbiamo già detto, è ripresa da Osea e segue immediatamente la
descrizione degli orrori religiosi, morali, sociali in cui era caduto Israele, a incominciare
dai capi fino agli ultimi del popolo: per questo Dio minaccia la rovina della nazione,
nonostante il tentativo di un’alleanza protettiva con il re di Assiria, Tiglat-Pilezer III (740
circa):1 «Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso all’Assiria
e Giuda si è rivolto al gran re; ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga» (Os
5,13).
Nel desiderio di ritrovare l’amicizia e la protezione del Signore, Israele organizza una
liturgia penitenziale sperando che egli si plachi dinanzi alle suppliche e alle promesse di
conversione, che però sono dettate solo dall’emozione e durano lo spazio di un mattino:
«Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora...» (Os 6,3).
Ma Iddio respinge queste vuote manifestazioni di un culto che non esprime e non realizza
la conversione del cuore, e rimanda alle parole dei suoi profeti che, fino a questo
momento, sono rimaste inascoltate: «Che dovrò fare per te, Efraim; che dovrò fare per te,
Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba
1
Cf 2 Re 15,19; 16,7-9.
10ª Domenica del Tempo Ordinario - “Omelie per un anno - vol. 2”, Elledici
1
svanisce. Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia
bocca e il mio giudizio sorge come la luce» (vv. 4-5). Continuerà dunque la punizione e lo
sfacelo nazionale si aggraverà, fino a che Israele non avrà compreso che quello che conta
è la «fedeltà» all’alleanza, espressa nell’obbedienza alla parola di Dio trasmessa dai
profeti e nell’amore ai fratelli. Questo è il «culto» vero che rende accetti al Signore (cf Os
14,3).
È quanto viene detto nell’ultimo versetto del breve oracolo, che rappresenta una delle
vette più alte della spiritualità e dell’interiorità dell’Antico Testamento: «Poiché io voglio
l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti» (v. 6). Al culto
meramente esteriore, espresso nei «sacrifici» e negli «olocausti», si oppone dunque
l’«amore» e la «conoscenza di Dio» da parte degli uomini.
Al termine «amore» corrisponde la parola ebraica khèsed, dall’ampia risonanza
semantica. Fondamentalmente essa esprime un «atteggiamento conforme all’alleanza»,
cioè una forma di «solidarietà» alla quale si sono obbligate le parti che hanno stipulato un
patto. Riferito a Dio, il termine esprime la fedeltà alla sua alleanza contratta con Israele
e anche il particolare affetto che ne deriva nei riguardi del popolo eletto (cf Es 34,6).
Infatti il termine verrà adoperato di preferenza per descrivere il rapporto di «nuzialità» di
Dio con il suo popolo: «Ti farò mia sposa per sempre... nella benevolenza e nell’amore»
(Os 2,21).
Di riflesso, però, l’«amore» di Dio esige anche nell’uomo un atteggiamento di khèsed,
cioè l’amicizia fiduciosa, l’abbandono, la tenerezza, la «pietà», in una parola l’amore, che
si traduce in una sottomissione gioiosa alla volontà di Dio e nella carità verso il prossimo.
«...la conoscenza di Dio più degli olocausti»
All’amore si congiunge la «conoscenza di Dio», che non è mera conoscenza intellettuale,
ma una specie di «esperienza» di Dio fatta «affidandosi» a lui. Come Dio «si fa
conoscere» all’uomo legandosi a lui per mezzo dell’alleanza, così l’uomo «conosce» Dio
per mezzo di un atteggiamento che implica la fedeltà alla sua alleanza, il riconoscimento
dei suoi benefici, l’amore. Perciò, sempre in Osea, la «conoscenza di Dio» è rapportata
ancora all’immagine nuziale, di cui abbiamo appena parlato: «Ti fidanzerò con me nella
fedeltà e tu conoscerai il Signore» (Os 2,22).
«Amore» e «conoscenza» perciò si intrecciano, per aprirci la strada all’unica possibilità di
incontro in Dio. Fuori di questa prospettiva Dio rimarrà sempre un «oggetto», che magari
ci teniamo caro, per timore o per certi possibili momenti di emergenza, dandogli anche
qualche grano d’incenso o qualche bisbiglio di preghiere, ma non l’essere «più intimo a
noi di noi stessi» (sant’Agostino), colui che deve diventare l’unico «soggetto» della nostra
vita.
In questo testo Osea non rettifica soltanto la religiosità degli Ebrei del suo tempo, ma
anche la religiosità di quei «giudei» in ritardo che siamo rimasti un po’ tutti noi cristiani,
più pronti a «parlare» di Dio che a «vivere» di Dio, più pronti a cantare le sue lodi che a
«essere noi la sua lode» (sant’Agostino).
In questo senso è molto significativo il Salmo responsoriale, che è tutto una polemica
contro l’esteriorità del culto: «Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici; / i tuoi olocausti mi
stanno sempre davanti. / Se avessi fame, a te non lo direi: / mio è il mondo e quanto
contiene... / Offri a Dio un sacrificio di lode / e sciogli all’Altissimo i tuoi voti; / invocami
nel giorno della sventura: / ti salverò e tu mi darai gloria» (Sal 49,8.12.14-15).
«Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”»
Il breve tratto evangelico (Mt 9,9-13) è una composizione letteraria molto ben
organizzata, che tende a far vedere come Cristo soltanto può «convertire» i cuori degli
uomini, chinandosi con amore sulle loro pene e i loro peccati. Ed è proprio questa
10ª Domenica del Tempo Ordinario - “Omelie per un anno - vol. 2”, Elledici
2
«celebrazione» della misericordia e del perdono che vale più di qualsiasi osservanza
rituale: questo è il «culto» vero che Dio riceve in Cristo ed esige dai credenti!
Dapprima c’è la scena della chiamata di Matteo, che Marco (2,13-14) e Luca (5,27-28)
chiamano invece Levi. Passando per la «sua città» (9,1), cioè Cafarnao, «Gesù vide un
uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si
alzò e lo seguì» (v. 9). Luca aggiunge un breve inciso: «Egli, lasciando tutto, si alzò e lo
seguì» (5,28), che è il tratto caratteristico della «sequela» anche degli altri Apostoli (cf Mt
4,20-22, ecc.).
Se ben ci pensiamo, siamo davvero davanti a qualcosa che è miracoloso quanto e più di
tutti gli altri miracoli narrati in questa sezione (cc. 8-9): sono ben nove i miracoli qui
descritti e molto ben coordinati fra di loro. Basta una sola «parola» di Cristo a cambiare
non soltanto il destino di un uomo, ma a dare alla sua vita un significato e un contenuto
del tutto diversi!
Ma che cosa ha questa «parola» per essere così «potente»? È la stessa domanda che si
ponevano i discepoli, spaventati, dopo che Gesù aveva «sgridato» i venti e il mare in
tempesta: «Chi è mai costui, al quale i venti e il mare obbediscono?» (Mt 8,27). Il mistero
non sta nella parola, ma in «chi» dice quella parola: la parola di Gesù ha potere
«creativo» di situazioni nuove, «illuminativo» di itinerari non ancora esplorati, perché lui
è il «Figlio di Dio», come lo proclamano i due indemoniati di Gadara (Mt 8,29).
Tutto il problema è di porsi liberi e nudi davanti a quella «parola», completamente
disarmati, senza progetti e senza calcoli, non amando niente più di quella parola, neppure
il denaro e la posizione sociale, sia pure prestigiosa, quale Matteo possedeva; perché, se
amiamo qualcosa «più» di quella parola, vuol dire che non amiamo Cristo, o l’amiamo
poco, perché quella «parola» è «lui».
In questo senso si può vedere il tradimento che ciascuno di noi consuma, o rischia di
consumare, tutte le volte non prende sul serio il problema della propria «chiamata»: essa
non è solo quella alla fede, ma anche ai molteplici «ministeri» nella Chiesa, che trovano
il loro vertice, non solo di ricchezza ma anche di unificazione, in quello «apostolico». Se
Matteo non avesse risposto, non è che qualche altro avrebbe potuto sostituirlo: nessun
altro avrebbe potuto scrivere il suo Vangelo. Se Dante fosse mancato, nessun altro
avrebbe potuto essere Dante e scrivere la Divina Commedia. Neppure Dio può, o vuole,
plagiare gli uomini, facendo sì che uno possa essere un altro!
«Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?»
Matteo però non solo «seguì» immediatamente Cristo, ma volle esprimere la sua «gioia»
e la sua gratitudine imbandendo per Gesù, i suoi discepoli e tanti altri amici un festoso
banchetto, come risulta in maniera anche più evidente dagli altri Sinottici. Però «vedendo
ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: “Perché il vostro maestro mangia insieme ai
pubblicani e ai peccatori?”» (v. 11). I «pubblicani», in quanto appaltatori di imposte,
avevano cattiva fama e venivano assimilati automaticamente ai «peccatori»: di qui il
frequente interscambio fra i due termini nel Vangelo. Ora, con tale gente, secondo la
tradizione giudaica, così come con i pagani, non si poteva mangiare insieme: 2 di qui lo
scandalo dei farisei nei riguardi di Gesù.
È evidente che, se si fosse comportato in tal modo, Gesù avrebbe potuto al massimo
creare un movimento di «spirituali», o di cosiddetti «puri», più per certi aspetti esteriori
che interiori: infatti, il «cuore» dell’uomo chi lo può conoscere? E così per la quasi totalità
degli uomini non ci sarebbe stata speranza di salvezza: il cristianesimo si sarebbe ridotto
a una setta, che per di più si discrimina e discrimina solo in base a certi fatti «esteriori»,
2
Cf Mc 7,3-4.14-23 e parall.; At 10,15; 15,20; ecc.
10ª Domenica del Tempo Ordinario - “Omelie per un anno - vol. 2”, Elledici
3
più strumento di oppressione che di liberazione degli uomini da tutti i pesi, ivi compreso
quello più schiacciante di tutti che è il peccato.
È per questo che Gesù reagisce, scandalizzando anche di più i farisei, in quanto infrange
tutte le barriere di tradizioni, di formalismi, di pretesi privilegi davanti a Dio: «Non sono
i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i
giusti ma i peccatori» (vv. 12-13).
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico»
Con queste parole, che sono le più rivoluzionarie di tutto il Vangelo, Gesù capovolge la
prospettiva dei farisei: se una preferenza c’è presso Dio, questa è solo per quelli che
hanno più bisogno di lui, cioè per i «malati» e per i «peccatori». I «giusti», se qualcuno ce
n’è al mondo, non interessano a Dio: essi infatti, proprio perché si ritengono tali, non
hanno bisogno di lui, si costruiscono da sé, si fanno con le loro mani! I farisei, e la gente
come loro, in pratica, sono «atei», perché impediscono a Dio di entrare nella loro vita e di
renderli «giusti» secondo la sua misura, secondo il suo dono: essi cercano invece la
«giustizia» dalle loro opere, come Paolo dirà dei Giudei del suo tempo (cf Rm 10,3).
Dicendo che «non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati» (v. 12), Gesù
si riferisce non solo a tutti i malati fisici da lui guariti nello sfondo dei capitoli 8-9
(lebbrosi, ciechi, ecc.), ma anche ai «malati» spirituali, cioè a tutti coloro che hanno
bisogno del perdono di Dio (cf 9,2.6): ognuno di noi, perciò, è incluso in questa premura
del «medico» celeste che è Cristo. Anche se non abbiamo nessun merito davanti a lui,
come pretendevano di averne i farisei, già questo basta perché egli si chini con più amore
verso di noi!
E questo ci renderà comprensivi verso tutti i fratelli, credenti e non credenti, ai quali ci
accomuna questa situazione di peccato.
Le parole, aggiunte qui dal solo Matteo: «Andate dunque e imparate che cosa significhi:
Misericordia io voglio e non sacrificio» (v. 13), sono l’esaltazione dell’amore perdonante di
Dio, che i farisei invece mettono sotto accusa, contestando l’atteggiamento di
«esagerata» benevolenza di Cristo, che oltre tutto portava con sé la violazione delle
norme di segregazione conviviale con i «peccatori». Però nell’intenzione di Matteo sono
certamente anche un invito a tutti i credenti a imitare l’atteggiamento di Cristo verso i
lontani, o i fratelli traviati: l’amore, il perdono, lo sforzo di avvicinare e di comprendere
chi ha mancato verso Dio, verso di noi o verso la società, sono la «liturgia» e il «sacrificio»
più veri che possiamo offrire al Signore.
Abramo «ebbe fede sperando contro ogni speranza»
Il tratto della Lettera ai Romani, in cui san Paolo porta l’esempio di Abramo come tipo
ideale della giustificazione «per la fede», può fare da contrapposizione all’atteggiamento
dei farisei, che Gesù smaschera spietatamente, come abbiamo visto, nel Vangelo.
Abramo «ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli,
come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur
vedendo già come morto il proprio corpo – aveva circa cento anni – e morto il seno di
Sara... Ecco perché gli fu accreditato a giustizia» (Rm 4,18-19.22). Tutto era contro di lui
e contro la più elementare «ragionevolezza», quando Dio gli promise di dargli una
«discendenza» numerosa al pari delle stelle del cielo (cf Gn 15,5). Eppure egli credette,
«sperando contro ogni speranza» (v. 18): Abramo ha avuto il coraggio di farsi «costruire»
tutto da Dio, di suo non portando nulla, neppure quello che, in fin dei conti, non è merito
alcuno perché tutti normalmente lo possiedono, e cioè la potenza generativa: lui, invece,
era vecchio e Sara sterile. Ha offerto a Dio la «disponibilità» di tutto se stesso, perché
ogni «vanto» gli venisse dall’alto.
10ª Domenica del Tempo Ordinario - “Omelie per un anno - vol. 2”, Elledici
4
Abramo ha preceduto Matteo nel lasciarsi guidare esclusivamente dalla «parola» di Dio, e
ha preceduto tutti noi in un atteggiamento paradossale di fede, che dobbiamo fare
nostro; proprio «noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro
Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la
nostra giustificazione» (Rm 4,24-25). Cristo ha fatto molto di più che «mangiare insieme
ai pubblicani e ai peccatori» (Mt 9,11): egli è «morto» sulla croce per i peccatori!
10ª Domenica del Tempo Ordinario - “Omelie per un anno - vol. 2”, Elledici
5