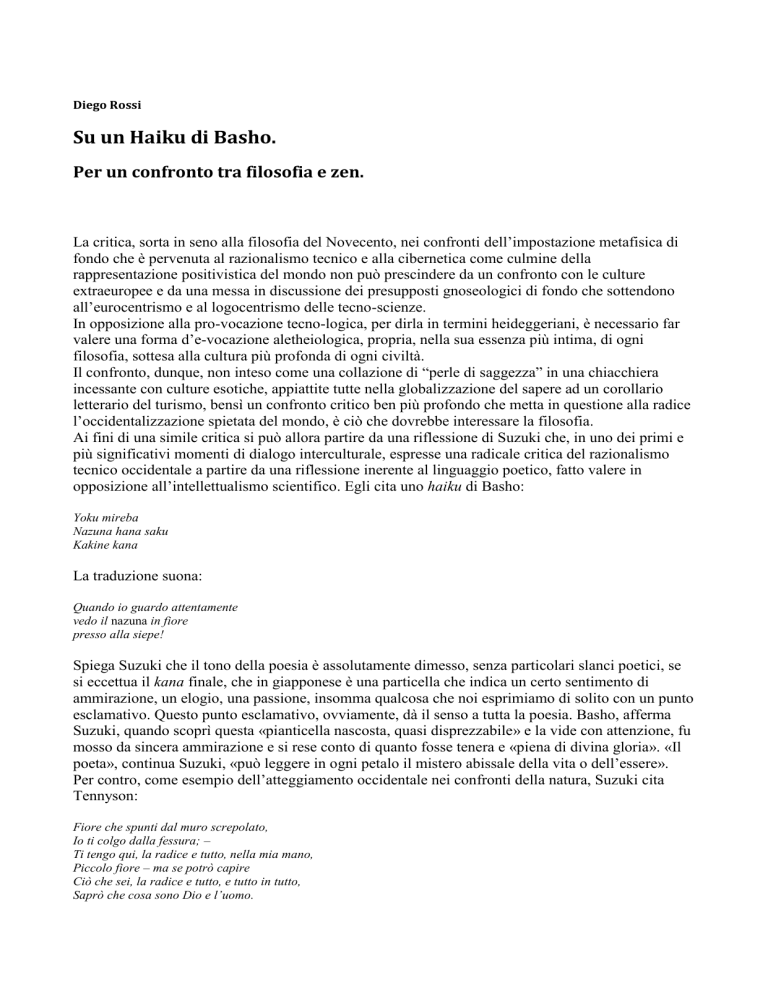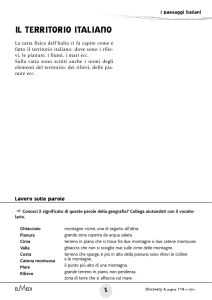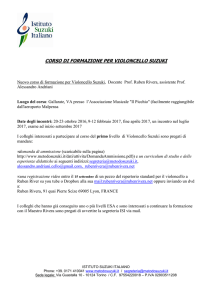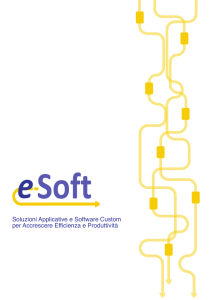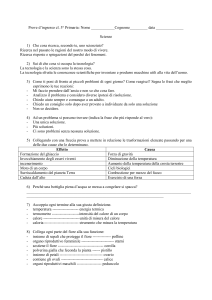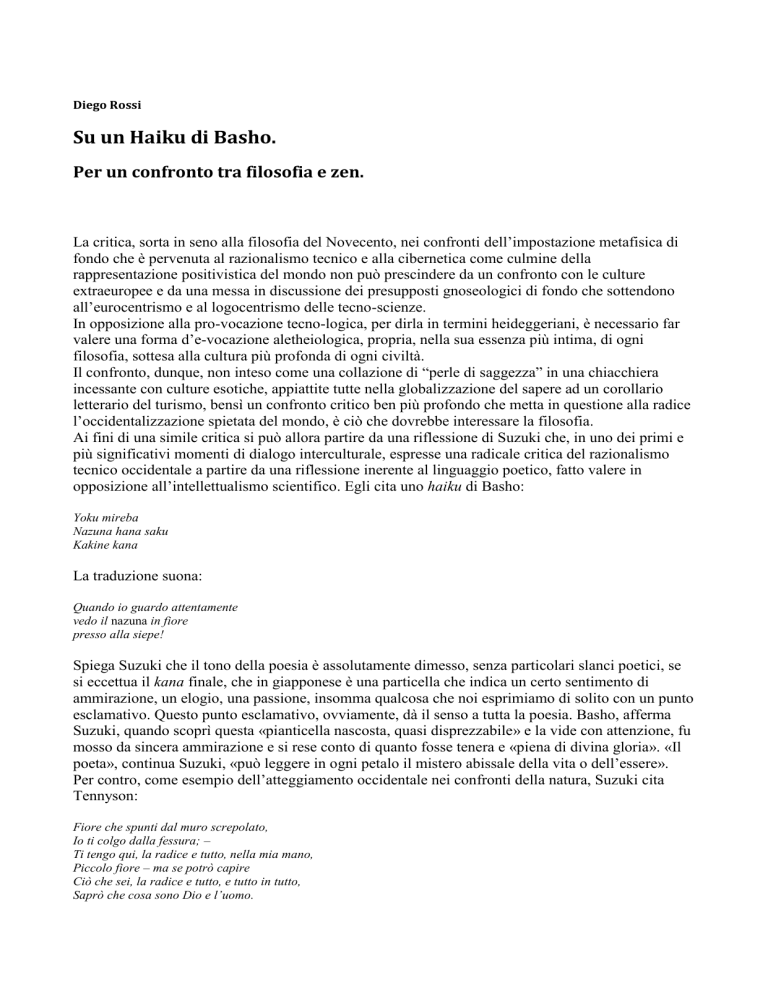
Diego Rossi
Su un Haiku di Basho.
Per un confronto tra filosofia e zen.
La critica, sorta in seno alla filosofia del Novecento, nei confronti dell’impostazione metafisica di
fondo che è pervenuta al razionalismo tecnico e alla cibernetica come culmine della
rappresentazione positivistica del mondo non può prescindere da un confronto con le culture
extraeuropee e da una messa in discussione dei presupposti gnoseologici di fondo che sottendono
all’eurocentrismo e al logocentrismo delle tecno-scienze.
In opposizione alla pro-vocazione tecno-logica, per dirla in termini heideggeriani, è necessario far
valere una forma d’e-vocazione aletheiologica, propria, nella sua essenza più intima, di ogni
filosofia, sottesa alla cultura più profonda di ogni civiltà.
Il confronto, dunque, non inteso come una collazione di “perle di saggezza” in una chiacchiera
incessante con culture esotiche, appiattite tutte nella globalizzazione del sapere ad un corollario
letterario del turismo, bensì un confronto critico ben più profondo che metta in questione alla radice
l’occidentalizzazione spietata del mondo, è ciò che dovrebbe interessare la filosofia.
Ai fini di una simile critica si può allora partire da una riflessione di Suzuki che, in uno dei primi e
più significativi momenti di dialogo interculturale, espresse una radicale critica del razionalismo
tecnico occidentale a partire da una riflessione inerente al linguaggio poetico, fatto valere in
opposizione all’intellettualismo scientifico. Egli cita uno haiku di Basho:
Yoku mireba
Nazuna hana saku
Kakine kana
La traduzione suona:
Quando io guardo attentamente
vedo il nazuna in fiore
presso alla siepe!
Spiega Suzuki che il tono della poesia è assolutamente dimesso, senza particolari slanci poetici, se
si eccettua il kana finale, che in giapponese è una particella che indica un certo sentimento di
ammirazione, un elogio, una passione, insomma qualcosa che noi esprimiamo di solito con un punto
esclamativo. Questo punto esclamativo, ovviamente, dà il senso a tutta la poesia. Basho, afferma
Suzuki, quando scoprì questa «pianticella nascosta, quasi disprezzabile» e la vide con attenzione, fu
mosso da sincera ammirazione e si rese conto di quanto fosse tenera e «piena di divina gloria». «Il
poeta», continua Suzuki, «può leggere in ogni petalo il mistero abissale della vita o dell’essere».
Per contro, come esempio dell’atteggiamento occidentale nei confronti della natura, Suzuki cita
Tennyson:
Fiore che spunti dal muro screpolato,
Io ti colgo dalla fessura; –
Ti tengo qui, la radice e tutto, nella mia mano,
Piccolo fiore – ma se potrò capire
Ciò che sei, la radice e tutto, e tutto in tutto,
Saprò che cosa sono Dio e l’uomo.
Le differenze tra le due poesie sono abbastanza evidenti. Suzuki sottolinea come Tennyson,
innanzitutto, abbia sradicato la pianticella dal suo luogo, «la radice e tutto», incurante quindi della
vita del fiore stesso: egli è mosso unicamente da un desiderio di curiosità, completamente assente in
Basho, che si limita alla contemplazione, nella quale tutto il mistero del nazuna si rivela per quello
che è, senza alcun bisogno di verbalizzazioni o spiegazioni. La vita si dà, così, interamente, nell’atto
stesso dello stare in essa. Al contrario Tennyson, dice Suzuki, «è tutto intelletto, tipico della
mentalità occidentale; è un avvocato della dottrina del Logos. Deve dire qualcosa, deve astrarre o
intellettualizzare la sua concreta esperienza. Deve procedere oltre il dominio del sentimento in
quello dell’intelletto e assoggettare la vita e la passione ad una serie di analisi per dar soddisfazione
allo spirito indagatore dell’Occidente».
Ciò che, nelle parole di Suzuki, viene rimproverato agli Occidentali, è di voler ricostruire
nell’astrazione ciò che l’astrazione stessa ha già ucciso e dissezionato.
In verità, dietro l’opposizione tra Oriente e Occidente si può scorgere ciò che, in altri termini, lo
stesso Occidente ha preso a criticare, almeno da Nietzsche in poi, nei riguardi dell’impostazione
logocentrica dell’approccio conoscitivo.
Non si può pretendere di tradurre lo Zen nei termini di un’intellettualizzazione – sarebbe come
strappare un fiore alla radice per studiarlo in laboratorio. Per scorgere ciò che lo Zen può indicarci
si deve necessariamente coglierlo nel modo in cui esso stesso si lascia vedere: solo più attraverso
aneddoti, parabole, koan e tentare di trarre spunti per una riflessione e un’autocritica. In uno di tali
aneddoti è proposto un dialogo tra un maestro e un monaco:
«Hai tu mai fatto un qualche sforzo per disciplinarti alla verità?».
«Sì».
«E come ti eserciti?».
«Quando ho fame, mangio, quando sono stanco, dormo».
«Questo è ciò che fanno tutti, ma si potrebbe dire mai che si esercitino al tuo stesso modo?».
«No».
«Perché no?».
«Perché, quando mangiano, non mangiano invero, bensì pensano a tante altre cose, con ciò lasciandosi disturbare;
quando dormono, non dormono, ma sognano mille cose. Per questo non sono come me».
In queste parole è possibile scorgere la condizione dell’uomo medio, che Fromm definisce come
«costantemente irretito in un mondo di fantasie»; e tanto più oggi, «quando quasi ognuno vede,
sente, prova e gusta piuttosto con atti di pensiero che con quelle facoltà interiori, che possono
vedere, sentire, provare, gustare». La condizione dell’uomo moderno, proprio in quanto interamente
condizionata dall’intellezione, lungi dall’essere pienamente cosciente, è la condizione di un
sognatore che vive nelle sue proiezioni ed elucubrazioni, scambiandole per la realtà dei “fatti”.
Così, un maestro Zen racconta: «Prima che io fossi illuminato, i fiumi erano fiumi e le montagne
erano montagne. Quando ebbe inizio per me l’illuminazione, i fiumi non erano più fiumi e le
montagne non erano più montagne. Ora, dopo l’illuminazione, i fiumi tornarono di nuovo ad esser
fiumi e le montagne montagne». In altre parole, scopo dello Zen è quel processo di consapevolezza
che Fromm individua al cuore della psicanalisi e che mira ad «esser consapevole della propria
realtà, come di quella del mondo, nella più profonda pienezza e senza veli».
Attraverso questi, pur esigui, esempi, lo Zen si mostra subito come una dottrina sorprendentemente
“nietzscheana”, e proprio in questo suo appello ad essere «buoni amici delle cose prossime», in
questo superamento del dualismo e della frattura tra mondo vero e mondo apparente. L’intelletto,
quando voglia cogliere il reale, non fa altro che incatenare l’uomo a questa platonica caverna di
ombre astratte, che rinviano solo, ma non coincidono, alla realtà delle cose.
Al cuore dello Zen, in fondo, non vi è che questa esigenza, espressa in altre parole e in altri tempi in
Occidente. Il satori, l’illuminazione Zen, non esprime altro che questo: «vedere la realtà così
com’è». Tornare alle cose stesse, si direbbe.
Non è un caso che tra le correnti di pensiero europee del Novecento, la fenomenologia husserliana
sia tra quelle che maggiormente hanno suscitato interesse in Oriente, particolarmente per quella
riflessione che sulla scorta dell’impostazione fenomenologica è possibile avviare in senso critico nei
riguardi dell’approccio conoscitivo occidentale. Ancor più significativo è che il fondatore della
scuola di Kyoto, Nishida, muovesse a Husserl critiche che, nella sostanza, sono molto vicine a
quelle di Heidegger.
Nishida metteva in questione tre punti, in particolare, della fenomenologia husserliana: il
soggettivismo (ed in particolare il fatto che l’esperienza fosse sempre riferibile ad una persona
individuale); la differenza, indiscussa in Husserl, tra soggetto e oggetto; ed il fatto che sentimento,
desiderio e volere sono considerati solo come diversi gradi di complessità della noesi. Allo stesso
modo Heidegger (il quale, come è noto, pur mantenendo la sua riflessione sempre ancorata alla
tradizione filosofica europea, non fu tuttavia estraneo a dei classici orientali come il Lao-zi) sin da
Essere e tempo aveva maturato una critica nei confronti della fenomenologia husserliana che lo
avrebbe portato ad interrogarsi direttamente sulla questione fondamentale della metafisica: la
Seinsfrage. Ciò a cui pure perviene Nishida, con la domanda circa il Jitsuzai (Vero Essere,
Esistenza Effettiva).
Sotto questo riguardo si vede bene che le differenze tra Oriente e Occidente sono spesso solo ciò
che vi vede lo sguardo del curioso, laddove una riflessione anche solo meno superficiale vi
scorgerebbe non già un’intima uguaglianza, come pure si rischierebbe facilmente di concludere, ma
differenze di tutt’altra natura, che riguardano piuttosto la diversa struttura del domandare.
Anne Chang, nella sua introduzione alla Storia del pensiero cinese, sottolinea come tale pensiero
non avverta mai «l’esigenza di esplicitare né il problema, né il soggetto, né l’oggetto», dal momento
che «non si preoccupa di scoprire una qualsivoglia verità di ordine teoretico»: piuttosto, «in virtù
della peculiare essenza della sua scrittura, il pensiero cinese si inscrive nella realtà invece di
sovrapporsi».
Ecco, allora, il senso più profondo che può avere, per l’Occidente, un confronto critico con il
pensiero extraeuropeo, e nella fattispecie con quello orientale: la ricerca di un’indicazione per
ripensare le proprie fondamenta e tentare un domandare che non pro-vochi solo la realtà per
dominarla ma che piuttosto in essa vi si reinscriva come nella propria casa.