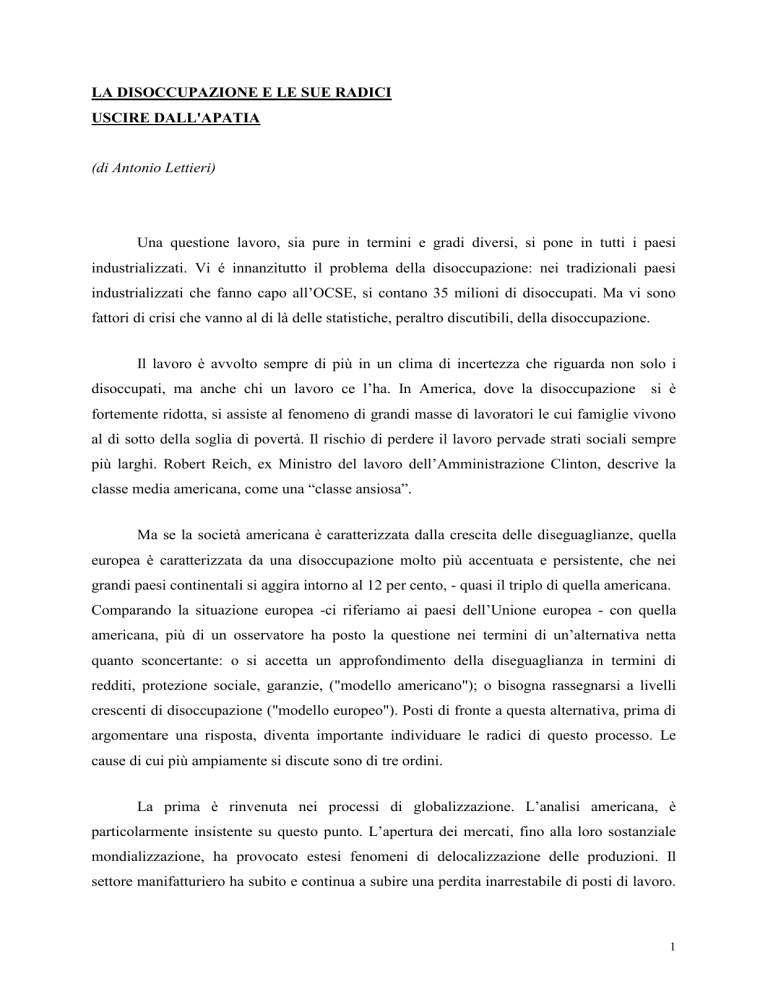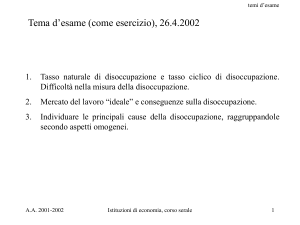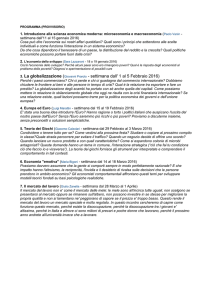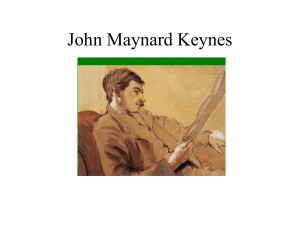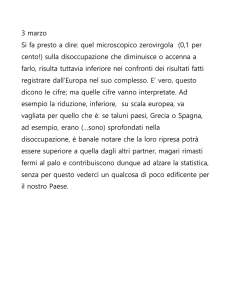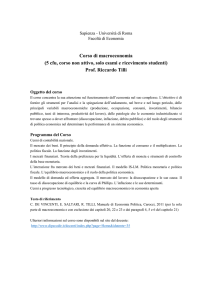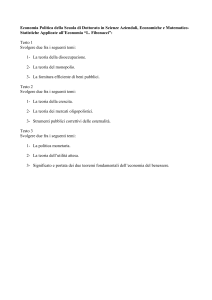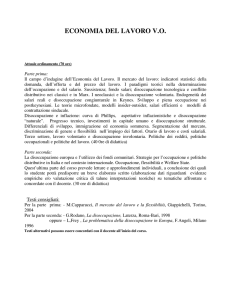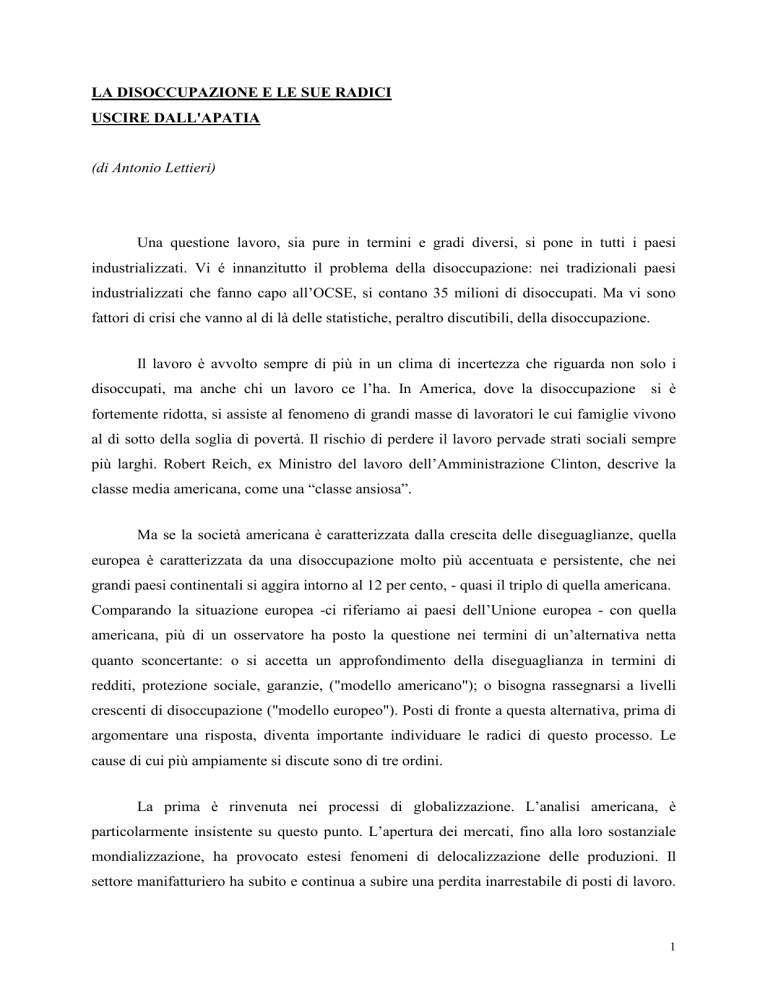
LA DISOCCUPAZIONE E LE SUE RADICI
USCIRE DALL'APATIA
(di Antonio Lettieri)
Una questione lavoro, sia pure in termini e gradi diversi, si pone in tutti i paesi
industrializzati. Vi é innanzitutto il problema della disoccupazione: nei tradizionali paesi
industrializzati che fanno capo all’OCSE, si contano 35 milioni di disoccupati. Ma vi sono
fattori di crisi che vanno al di là delle statistiche, peraltro discutibili, della disoccupazione.
Il lavoro è avvolto sempre di più in un clima di incertezza che riguarda non solo i
disoccupati, ma anche chi un lavoro ce l’ha. In America, dove la disoccupazione si è
fortemente ridotta, si assiste al fenomeno di grandi masse di lavoratori le cui famiglie vivono
al di sotto della soglia di povertà. Il rischio di perdere il lavoro pervade strati sociali sempre
più larghi. Robert Reich, ex Ministro del lavoro dell’Amministrazione Clinton, descrive la
classe media americana, come una “classe ansiosa”.
Ma se la società americana è caratterizzata dalla crescita delle diseguaglianze, quella
europea è caratterizzata da una disoccupazione molto più accentuata e persistente, che nei
grandi paesi continentali si aggira intorno al 12 per cento, - quasi il triplo di quella americana.
Comparando la situazione europea -ci riferiamo ai paesi dell’Unione europea - con quella
americana, più di un osservatore ha posto la questione nei termini di un’alternativa netta
quanto sconcertante: o si accetta un approfondimento della diseguaglianza in termini di
redditi, protezione sociale, garanzie, ("modello americano"); o bisogna rassegnarsi a livelli
crescenti di disoccupazione ("modello europeo"). Posti di fronte a questa alternativa, prima di
argomentare una risposta, diventa importante individuare le radici di questo processo. Le
cause di cui più ampiamente si discute sono di tre ordini.
La prima è rinvenuta nei processi di globalizzazione. L’analisi americana, è
particolarmente insistente su questo punto. L’apertura dei mercati, fino alla loro sostanziale
mondializzazione, ha provocato estesi fenomeni di delocalizzazione delle produzioni. Il
settore manifatturiero ha subito e continua a subire una perdita inarrestabile di posti di lavoro.
1
Le conseguenze sono diverse. Nelle aree a bassa crescita, aumenta la disoccupazione. In
quelle invece dove l’occupazione complessiva aumenta, i nuovi lavori collocati nei settori dei
servizi sono meno stabili e con salari più bassi. Disoccupazione e crescita delle diseguaglianze
sono in questa analisi fenomeni che hanno la stessa origine: un processo di globalizzazione
che per la sua dimensione e accelerazione ha messo in crisi le istituzioni e i meccanismi di
controllo politico e sociale.
Una seconda tesi si contrappone nettamente a quest’analisi. Essa sostiene che
l’apertura dei mercati, per quanto intensa, ha effetti assolutamente secondari sulle grandi
economie industriali. Paul Krugman, economista di Harvard, che ha raccolto una serie di saggi
dedicati a questo dibattito sotto il titolo, tutt’altro che allusivo, di “Pop internationalism”,
respinge senza mezze misure la tesi della globalizzazione come causa dei nuovi squilibri
sociali. Consideriamo pure -è il suo ragionamento- la perdita di un milione di posti di lavoro
nell’industria manifatturiera americana: essa deve essere letta in rapporto a una forza lavoro di
130 milioni di americani. Calcolando una perdita di reddito da lavoro dell’ordine del 30 per
cento medio nel passaggio ai servizi, il gap salariale medio sarebbe pari a una frazione di
decimali. Disoccupazione e crescita delle diseguaglianze -conclude Krugman- hanno origine
non nell’economia globale, ma nella rivoluzione tecnologica che tende a polarizzare i redditi
da lavoro, in rapporto alle competenze e alle dinamiche professionali come non era più
accaduto nell’era della produzione di massa.
Una terza tesi, che ha nell’OCSE un forte ancoraggio e che ispira una parte dominante
delle analisi europee, fa invece risalire la crisi alle disfunzioni del mercato del lavoro. Mentre
il lavoro è cambiato profondamente, il mercato del lavoro rimane regolato secondo i modelli
rigidi del paradigma fordista. Ne discende un problema strutturale dell’offerta la cui soluzione
sta
in
un
processo
di
adattabilità,
mobilità,
flessibilità,
deregolazione,
tanto
dell'organizzazione del lavoro come dei salari.
Queste tre analisi puntano ciascuna a una spiegazione
per così dire oggettiva e
onnicomprensiva. A ciascuna di esse si collega una terapia specifica. Ma, in effetti, nessuna di
queste tesi appare autosufficiente, pur contenendo ognuna di esse elementi di verità. La
globalizzazione dei mercati non va misurata solo nei termini quantitativi criticamente
analizzati da Krugman. La riorganizzazione industriale con i processi di delocalizzazione,
2
ristrutturazione, "downsizing" non ha solo effetti quantitativi diretti, ma esercita una forza
dirompente sui tradizionali rapporti di lavoro. Colpisce le organizzazioni sindacali nel punto
di maggior forza, la grande fabbrica. Il sindacalismo americano copre ormai solo delle isole
tradizionali. Il lavoro stabile si riduce drasticamente. E quello che più conta è la minaccia
incombente di chiusura, migrazione verso altre aree (fuori, ma anche all’interno dello stesso
paese) con un continuo ridimensionamento degli organici. Nel corso dei processi di
ristrutturazione la forza lavoro della General Motors si è ridotta da oltre 500.000 a poco più di
200.000.
D’altra parte, questi processi non sarebbero possibili senza la rivoluzione tecnologica
che consente di organizzare la produzione e la distribuzione su scala planetaria, creando nel
campo dei servizi più sofisticati -come quelli finanziari- aree di privilegio professionale e di
reddito che si distanziano in termini crescenti dalle aree professionali tradizionali - non solo
gli operai, ma i tecnici della produzione, il management intermedio tagliato fuori
dall’accorciamento delle scale gerarchiche, i settori amministrativi, e così via.
E’ in questa combinazione di cambiamenti fra loro profondamente intrecciati che
acquista senso la problematica di modelli più flessibili dell’organizzazione del lavoro. (Senza
dimenticare, in ogni caso, che ci riferiamo alla flessibilità del lavoro umano, che non può non
incontrare limiti di accettabilità etica e sociale).
In sostanza, siamo di fronte a fattori di cambiamento che si intrecciano e si potenziano
reciprocamente. Un primo errore sta proprio nell’isolamento delle diverse cause e nella
pretesa di una soluzione onnivalente, a partire dall’uno o dall’altro dei fattori di crisi. Ma vi è
un secondo errore che a me pare decisivo, e che nel dibattito corrente viene del tutto messo in
ombra o trattato con molto pudore. Mi riferisco ai diversi contesti politici in cui i diversi
fattori di crisi si collocano. Su una tela di fondo comune, si delineano approcci culturali, scelte
politiche che, a partire dalle stesse cause, generano dinamiche diverse.
Osserviamo più da vicino i dati dell’occupazione in Europa e negli Stati Uniti. Oggi la
disoccupazione americana è meno della metà di quella media dell’Unione europea. E’
addirittura poco più di un terzo di quella dei grandi paesi continentali dell’Unione (Germania,
3
Francia, Italia). Perché questo enorme divario? Possiamo identificare la causa in qualcuno dei
tre fattori di crisi che abbiamo esaminato? O anche in tutt’e tre insieme? La risposta è
difficilmente positiva. Basti considerare che all’inizio del decennio, fra il ‘90 e il ‘92, in
relazione al diverso andamento del ciclo, la disoccupazione nell’Unione europea era dello
stesso ordine di grandezza degli Stati Uniti, vale a dire compreso fra il 7 e l’8 per cento. A che
cosa dobbiamo la divaricazione esplosiva verificatasi in un così breve giro di anni?
Nessuno dei fattori esaminati (globalizzazione, tecnologie, rigidità) può spiegare un
aumento del 50 per cento della disoccupazione europea nel giro di un quinquennio. La
spiegazione diventa ancora più improbabile se si considerano due circostanze. La prima è che
nella seconda parte degli anni 80, la disoccupazione era costantemente diminuita nella
Comunità, e l’occupazione era cresciuta di 9 milioni di unità fra l’85 e il ‘90. La seconda
circostanza sta nel fatto che il crollo dell’occupazione in Europa ha un carattere, per così dire,
'istantaneo', verificandosi tutto nel giro di 2-3 anni, fra il ‘91 e il ‘93.
Che cosa c'è all'origine di questa rottura? Globalizzazione dei mercati e
ristrutturazione degli apparati produttivi, rivoluzione informatica, pressione destabilizzante
sui mercati del lavoro, sono tutti fattori interattivi che sarebbe sbagliato offuscare. Ma da soli
non possono spiegare il collasso. Vi è qualcosa di più e al di sopra. Vi è un contesto di
orientamenti e di scelte politiche che innesca in quei fattori un processo esplosivo con una
reazione a catena che va fuori controllo.
La seconda parte degli anni 80 era stato un periodo di crescita non eccezionale ma
sostenuta e soprattutto costante. In tutta la Comunità questa crescita aveva consentito di
assorbire le nuove leve e di ridurre gradualmente la disoccupazione. Il punto di rottura si
verifica con l’unificazione tedesca. L’accelerazione impressa da Kohl al processo di
unificazione economica con la parificazione del marco portò al collasso l’economia dei
Länder orientali, imponendo trasferimenti di bilancio dell’ordine di 150.000 miliardi di lire
l’anno. Come sappiamo, queste scelte di carattere eminentemente politico avvennero nel pieno
dissenso della Bundesbank che mise in atto le contromanovre di cui disponeva, aumentando i
tassi di interesse che peraltro erano già in crescita. Fra l’ '89 e il ‘92 si assistette a un aumento
di circa 4-5 punti, vale a dire un aumento del 100 per cento.
4
L’effetto di deflazione di questo drastico irrigidimento monetario fu il crollo del PIL e della
produzione industriale in Germania, con un conseguente aumento della disoccupazione ma
anche col rafforzamento del marco, dovuto agli alti tassi e all’afflusso dei capitali esteri.
E’ in questo quadro che i paesi della Comunità perdono il controllo delle variabili
macroeconomiche. I fatti che ne seguirono sono diventati successivamente chiari e perfino
elementari. Le monete nazionali legate al marco nel quadro dello SME non erano più in grado
di reggere le parità centrali prefissate. Le difficoltà del cambio erano accentuate dal
deprezzamento del dollaro. Si sarebbe dovuto procedere a un riallineamento, ma l’accordo
mancò. Le valute più esposte furono travolte, dalla lira alla peseta alla sterlina. Il franco
francese resse all’attacco dei mercati finanziari per l’appoggio ricevuto in extremis dalla
Bundesbank. I paesi della Comunità avevano in altri termini subito uno shock asimmetrico
che una catena di avvenimenti fiscali, salariali, monetari riconduceva all’unificazione tedesca.
Nonostante il reciproco collegamento nella Comunità e nello SME e l’obiettivo dell’Unione
monetaria appena sanzionato dal trattato di Maastricht, i governi nazionali non riuscirono a
concordare una politica comune basata su un riassestamento dei cambi. Lo shock si risolse in
una deflazione generalizzata.
Ne seguì un aumento verticale della disoccupazione. Tra il ‘91 e il ‘93 la
disoccupazione aumentò del 50 per cento in Germania, Francia, Gran Bretagna. In Italia, dove
i primi effetti della recessione erano stati attutiti dal forte deprezzamento della lira, la
disoccupazione raggiunse il 12 per cento nel ‘94. La correlazione fra politiche di deflazione,
recessione e crollo dell’occupazione fu tutt’uno.
Un’inversione del ciclo si era verificata tra il ‘90 e il ‘91 anche negli Stati Uniti, e la
disoccupazione era cresciuta portandosi sul livello europeo del ‘90, intorno al 7 per cento e al
di sopra di quello della Germania pre-unificazione. Ma la Federal Reserve aveva adottato una
politica monetaria 'dolce', lasciando deprezzare il dollaro e frenando la caduta della domanda
interna. Clinton aveva attaccato il predecessore Bush per l’aumento della disoccupazione,
giovandosene nella campagna elettorale, ma prima ancora della sua elezione alla presidenza,
l’economia americana era già in ripresa. Una ripresa che non si è mai fermata nei sette anni
successivi.
5
Nell’Unione europea, al contrario, dopo la stretta monetaria guidata dalla Germania
entrò in campo la stretta fiscale. Dappertutto i deficit erano in crescita sia per la caduta
produttiva che per l’aumento dei tassi che si rifletteva sul servizio del debito. In queste
condizioni la disoccupazione non poteva che stabilizzarsi o crescere. E quella ciclica, derivata
dallo shock monetario, tendeva a diventare strutturale. Certo, nella Comunità europea, nei
suoi vertici, nei documenti ufficiali, si affermò l’uso di porre la lotta alla disoccupazione come
obiettivo prioritario. Ma nella realtà, tutta la politica economica comunitaria era in contrasto
con l’obiettivo conclamato. Il tentativo di Jacques Delors col Libro bianco su “Crescita,
competitività e occupazione” fu rapidamente seppellito. Sulla scena rimasero i parametri
finanziari di Maastricht, la cui funzione a un certo punto sembrò più quella di far saltare
l’Unione monetaria che non di avvicinarla.
La disoccupazione come ogni altro accadimento sociale ha a che vedere con la politica
in generale e con le scelte di politica economica in particolare. Federico Caffè insegnava che
la politica economica non poteva prescindere da un’etica sociale i cui principi fondamentali
egli vedeva nella lotta alla disoccupazione e alle diseguaglianze. Oggi la globalizzazione, o
meglio l’idea della globalizzazione - la sua ideologia - è adoperata come una clava contro la
politica come strumento di programmazione economica e mediazione sociale.
In questo senso, hanno ragione quanti temono che l’ideologia neoliberista di cui viene
circondata la globalizzazione possa gettare una pesante ombra sui regimi democratici. I
francesi hanno denunciato per primi la dittatura intellettuale e politica di una sorta di
“pensiero unico”. Ralf Dahrendorf è solito ammonire sui rischi che corre la democrazia. John
Gray, professore di politica di Oxford, vede nella rinata ideologia della sovranità dei mercati
un "fattore di frantumazione sociale e di instabilità economica e politica su vasta scala".
La sinistra europea deve ripartire da qui, dalla riscoperta della politica come quadro di
riferimento dei processi economici e sociali. La strategia per l’occupazione che dovrebbe
ispirare la nuova UEM rischia di essere la continuazione della stessa politica che ha fatto
esplodere la disoccupazione nei primi anni del dopo Maastricht. Le tesi affermate nel vertice
dei capi di stato e di governo di Lussemburgo dell'autunno '97 dedicato ai problemi della
disoccupazione, ripropongono testardamente la stessa scissione. Le istituzioni comunitarie BCE e i ministri economici riuniti nell’Ecofin - hanno come obiettivo la lotta all’inflazione
6
(che non c’è) e il pareggio/surplus dei bilanci pubblici (i cui saldi già sono al di sotto del
parametro di Maastricht), mentre il problema della disoccupazione viene rimesso
all’iniziativa dei singoli stati. Così la politica macroeconomica di stabilità - l’unica con un
carattere federale - è scissa dalla politica dell’occupazione confinata agli interventi
microeconomici dal lato dell’offerta. In sostanza, se c’è disoccupazione è perché non si lascia
agire liberamente i mercati del lavoro a livello territoriale. L’Unione se ne lava le mani, salvo
raccomandare adattabilità e flessibilità.
In realtà, quella che appare una scissione fra politica economica e politica del lavoro è
il riflesso della ben radicata ideologia che affida alla sovranità dei mercati l’automatica
ricomposizione
degli equilibri economici e sociali. Se nella politica di ispirazione
thatcheriana e reaganiana questa filosofia splendeva alla luce del sole, nella politica
comunitaria si confrontano linee più sfumate che rendono il quadro più mosso e suscettibile di
letture diverse a seconda degli attori. Ma la sostanza non cambia. La ripresa dell’occupazione
non può prescindere da una condizione preliminare: una crescita sostenuta e prolungata per
molti anni come si verificò nella seconda parte degli anni ‘80 in Europa e negli Stati Uniti in
questi anni ‘90.
Il libro bianco di Delors puntava su una crescita media del 3-5,5 per cento stabile. Con
un aumento della produttività dell’ordine del 2 per cento - che è pure il doppio di quella
americana - si sarebbero creati gli spazi per un incremento regolare e prolungato
dell’occupazione (secondo quel piano il dimezzamento della disoccupazione nella Comunità
entro la fine del decennio).
L’espansione, al tempo della moneta unica e del Patto di stabilità, non può fare a meno
di una politica concordata e convergente a livello comunitario il cui obiettivo centrale sia
appunto una crescita generale, sostenuta e a lungo termine. La pretesa sintomatica di De
Silguy, commissario per gli affari monetari, di comprimere i bilanci nazionali per accelerare
l’obiettivo del pareggio e del surplus fa parte di una linea masochista, che fa dell’Unione
monetaria una camicia di forza, invece che un potente strumento di rilancio dell’Unione e di
riequilibrio dell’economia internazionale in una fase in cui si attenua la spinta americana e si
aggrava la crisi asiatica.
7
Il rilancio della crescita in Europa ha bisogno di investimenti pubblici e privati, di
sviluppo tecnologico, di ricerca, formazione. Economisti di tutte le scuole concordano almeno
su questo punto: la spesa per investimenti pubblici (e di sostegno a quelli privati) deve essere
distinta dal contenimento della spesa corrente. Non si tratta, aggiungiamo, di una politica della
domanda in deficit, ma di sostegno a una crescita a sua volta generatrice di occupazione. Nè
questo significa lasciare andare l’inflazione. Il riconoscimento di un ruolo centrale al
sindacalismo europeo per una politica dei redditi in un quadro di sviluppo e crescita
dell’occupazione ha precedenti in un gran numero di paesi dell’Unione, non ultimo l’Italia.
Certo, il rapporto crescita-occupazione si pone in termini profondamente diversi
rispetto al passato. La flessibilità nell’organizzazione del lavoro e i nuovi modelli di lavoro
sono una sfida reale. L’apertura dei mercati, la dislocazione delle produzioni, lo slittamento
dell’occupazione verso i settori dei servizi hanno messo in crisi il diritto del lavoro elaborato
nel corso di questo secolo e i modelli contrattuali fondati sull’organizzazione fordista. Fare
appello alla crescita e quindi a una politica macroeconomica che ne sia la levatrice non può
significare offuscare la sfida delle riforme nel mondo del lavoro. Ma questo è diverso
dall’invocazione di una flessibilità sregolata, di una precarietà generalizzata, di quel 'modello
americano' che produce insieme ricchezza, diseguaglianza, frantumazione sociale. Lo stesso
modello che l’ala democratica, “liberal” e progressista, sta sottoponendo a una critica serrata.
Soprattutto i nuovi stili di lavoro domandano una rielaborazione dei modelli di
protezione sociale: uno stato sociale rinnovato per equità ed efficienza, non ridimensionato. Il
Presidente Clinton, nonostante il pareggio del bilancio, non riesce a fare la riforma sanitaria
nel paese più ricco del pianeta, dove 40 milioni di cittadini sono privi di assistenza. Robert
Reich ha lasciato l’Amministrazione nell’impossibilità di fare una politica per l’educazione e
la formazione. Tony Blair, al contrario, generando una certa sorpresa, ha annunciato un
aumento della spesa statale di 120.000 miliardi in 3 anni dedicata a sanità e istruzione. La
Gran Bretagna, pur segnata profondamente dalla politica thatcheriana, conserva le tracce
fondamentali dello stato sociale universalistico ridisegnato dal liberale Beveridge negli anni
‘40. In questo senso anche il modello anglosassone presenta variabili diverse sulle due sponde
dell'Atlantico.
8
Un’analisi ravvicinata dei processi in corso dimostra che la “globalizzazione” è un
fatto, ma anche un alibi e che la “fine del lavoro” è un travisamento ideologico della
rivoluzione tecnologica. La disoccupazione è un male complesso, ma non fatale. Il governo di
centro sinistra, una volta portato a compimento il progetto di condurre l’Italia nell’Unione
monetaria, ha il dovere di fare politica europea. Jospin ci ha provato, ma senza esiti concreti,
essendo rimasto solo a chiedere un governo economico dell’Unione. Probabilmente la
scadenza elettorale tedesca non poteva non avere un effetto paralizzante. Il dopo elezioni in
Germania può essere l’avvio di una nuova fase della politica europea. Alle sinistre spetta il
compito di aprire un discorso nuovo, culturale, programmatico e politico entro il quale i
mutamenti del lavoro, l’obbiettivo dell’occupazione, e quindi delle condizioni concrete per
realizzarlo, siano riproposti al centro della scena, uscendo dall’incertezza e dall’abulia di
questi anni ‘
Roma, luglio ‘98
9
10