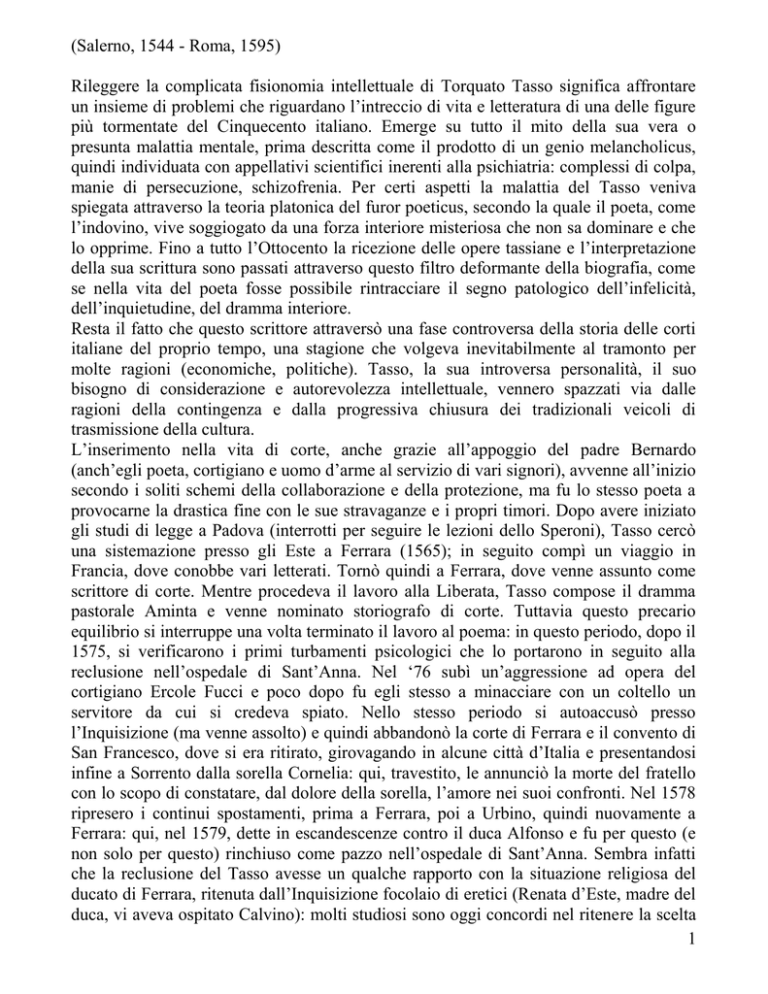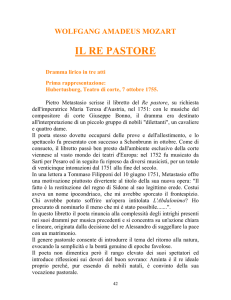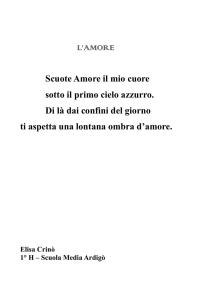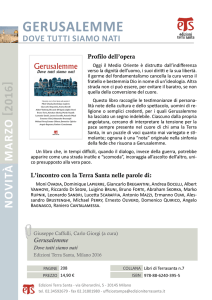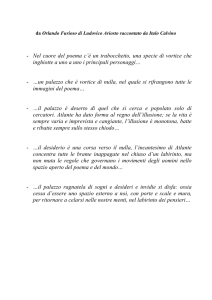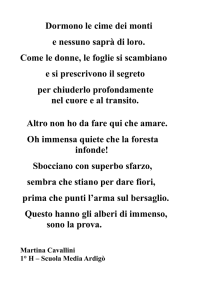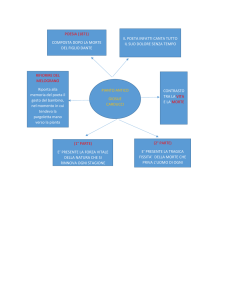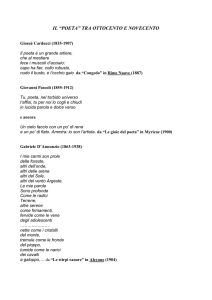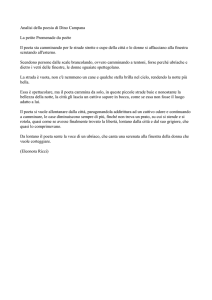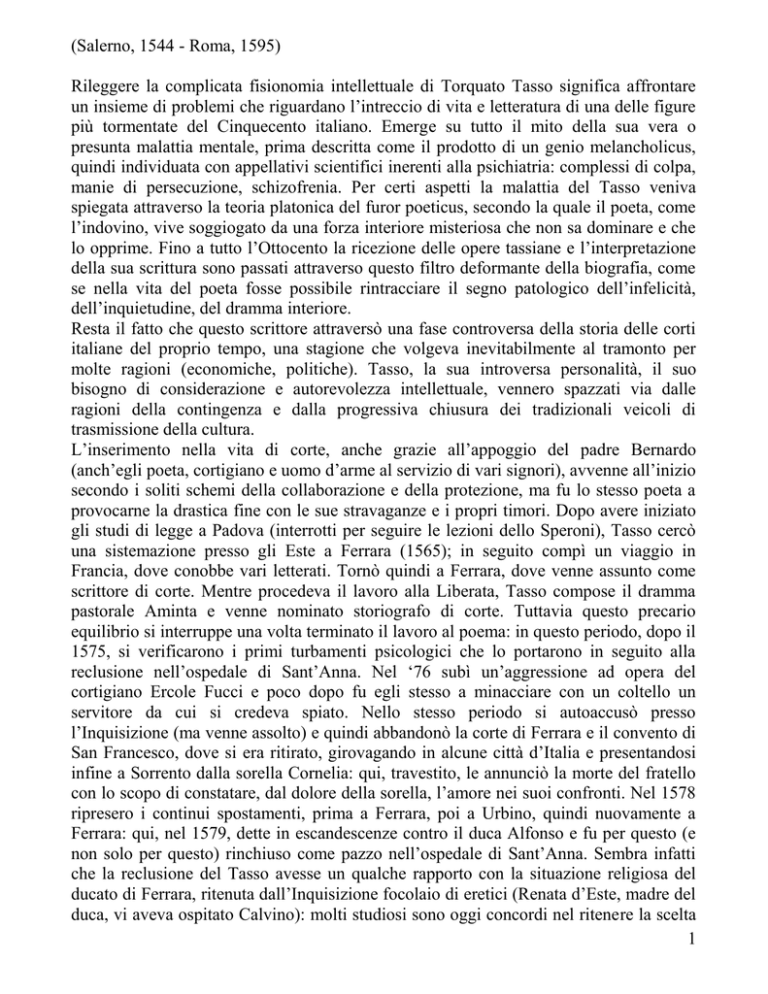
(Salerno, 1544 - Roma, 1595)
Rileggere la complicata fisionomia intellettuale di Torquato Tasso significa affrontare
un insieme di problemi che riguardano l’intreccio di vita e letteratura di una delle figure
più tormentate del Cinquecento italiano. Emerge su tutto il mito della sua vera o
presunta malattia mentale, prima descritta come il prodotto di un genio melancholicus,
quindi individuata con appellativi scientifici inerenti alla psichiatria: complessi di colpa,
manie di persecuzione, schizofrenia. Per certi aspetti la malattia del Tasso veniva
spiegata attraverso la teoria platonica del furor poeticus, secondo la quale il poeta, come
l’indovino, vive soggiogato da una forza interiore misteriosa che non sa dominare e che
lo opprime. Fino a tutto l’Ottocento la ricezione delle opere tassiane e l’interpretazione
della sua scrittura sono passati attraverso questo filtro deformante della biografia, come
se nella vita del poeta fosse possibile rintracciare il segno patologico dell’infelicità,
dell’inquietudine, del dramma interiore.
Resta il fatto che questo scrittore attraversò una fase controversa della storia delle corti
italiane del proprio tempo, una stagione che volgeva inevitabilmente al tramonto per
molte ragioni (economiche, politiche). Tasso, la sua introversa personalità, il suo
bisogno di considerazione e autorevolezza intellettuale, vennero spazzati via dalle
ragioni della contingenza e dalla progressiva chiusura dei tradizionali veicoli di
trasmissione della cultura.
L’inserimento nella vita di corte, anche grazie all’appoggio del padre Bernardo
(anch’egli poeta, cortigiano e uomo d’arme al servizio di vari signori), avvenne all’inizio
secondo i soliti schemi della collaborazione e della protezione, ma fu lo stesso poeta a
provocarne la drastica fine con le sue stravaganze e i propri timori. Dopo avere iniziato
gli studi di legge a Padova (interrotti per seguire le lezioni dello Speroni), Tasso cercò
una sistemazione presso gli Este a Ferrara (1565); in seguito compì un viaggio in
Francia, dove conobbe vari letterati. Tornò quindi a Ferrara, dove venne assunto come
scrittore di corte. Mentre procedeva il lavoro alla Liberata, Tasso compose il dramma
pastorale Aminta e venne nominato storiografo di corte. Tuttavia questo precario
equilibrio si interruppe una volta terminato il lavoro al poema: in questo periodo, dopo il
1575, si verificarono i primi turbamenti psicologici che lo portarono in seguito alla
reclusione nell’ospedale di Sant’Anna. Nel ‘76 subì un’aggressione ad opera del
cortigiano Ercole Fucci e poco dopo fu egli stesso a minacciare con un coltello un
servitore da cui si credeva spiato. Nello stesso periodo si autoaccusò presso
l’Inquisizione (ma venne assolto) e quindi abbandonò la corte di Ferrara e il convento di
San Francesco, dove si era ritirato, girovagando in alcune città d’Italia e presentandosi
infine a Sorrento dalla sorella Cornelia: qui, travestito, le annunciò la morte del fratello
con lo scopo di constatare, dal dolore della sorella, l’amore nei suoi confronti. Nel 1578
ripresero i continui spostamenti, prima a Ferrara, poi a Urbino, quindi nuovamente a
Ferrara: qui, nel 1579, dette in escandescenze contro il duca Alfonso e fu per questo (e
non solo per questo) rinchiuso come pazzo nell’ospedale di Sant’Anna. Sembra infatti
che la reclusione del Tasso avesse un qualche rapporto con la situazione religiosa del
ducato di Ferrara, ritenuta dall’Inquisizione focolaio di eretici (Renata d’Este, madre del
duca, vi aveva ospitato Calvino): molti studiosi sono oggi concordi nel ritenere la scelta
1
di rinchiudere il Tasso come un segnale di efficienza nel controllo degli elementi
“devianti”, voluto da Alfonso II e indirizzato al confinante Stato della Chiesa.
La prigionia durò sette anni, durante i quali lo scrittore poté spesso dedicarsi ai propri
studi, alla composizione della maggior parte dei Dialoghi e alle Rime e a un interessante
epistolario. Durante la reclusione la Gerusalemme liberata venne pubblicata più volte, in
edizioni non complete e senza il consenso e la revisione del poeta. Nel 1584 usciva
intanto il libro di uno studioso napoletano Camillo Pellegrino dal titolo Il Carrafa o vero
dell’epica poesia, con cui prendeva il via la lunga polemica che vide al centro i poemi
dell’Ariosto e del Tasso e la presunta superiorità dell’uno sull’altro (il dibattito
coinvolse subito l’Accademia della Crusca e il suo rappresentante più illustre Leonardo
Salviati in difesa del poema di Ariosto).
Con l’aiuto di Vincenzo Gonzaga, figlio del duca di Mantova, il Tasso venne liberato: a
Mantova compose il Re Torrismondo, ma da qui riprese le sue peregrinazioni. Sostò a
Roma, a Firenze, poi di nuovo a Mantova, Roma e Napoli. Nel frattempo preparava
un’edizione delle Rime (pubblicata in due parti nel 1591 e ‘92), attendeva alla revisione
del poema con il nuovo titolo di Gerusalemme Conquistata (pubblicato nel 1593 ma con
uno scarso successo di pubblico), dava alle stampe i Discorsi del poema eroico (1594).
Oltre alla follia, il dato più interessante della biografia tassiana è indubbiamente il senso
di sradicamento, il continuo peregrinare da una città all’altra, da una corte all’altra,
senza tuttavia trovare un punto di equilibrio e una stabilità interiore e materiale in grado
di consentire al poeta un lavoro continuativo sui propri studi: e tuttavia Tasso ripose
nella idealizzazione dello spazio sociale della corte le nutrite speranze di una
sistemazione personale e di un prestigio professionale. La realtà fu ben diversa: in questa
frizione che si venne a creare tra aspettazione e risultato, tra domanda e offerta,
possiamo intravedere il disagio interiore e l’insoddisfazione, la delusione e la rabbia, che
poi sfociarono nella malattia mentale.
Con il dramma pastorale Aminta, che cade in una fase di densa e importante vena
creativa, quella appunto che vede il poeta impegnato alla coeva costruzione del ricco
dettato della Liberata, Tasso sperimenta la scrittura teatrale in una zona di confluenza di
molti generi, dal teatro all’elegia e alla lirica, ponendo a confronto l’azione drammatica
con il pathos sentimentale.
La novità strutturale dell’Aminta, ora portata alla luce da studi più recenti e specifici,
andrà cercata semmai nella sua valenza teatrale e drammaturgica, nell’autonomia di un
impianto costruito appositamente per il palcoscenico. Questo non significa
assolutamente limitarne la pregnanza lirica, che è stata invece il prevalente versante
della ricognizione operata dalla critica: tuttavia nell’Aminta gli elementi che
costituiscono il dettato bucolico e l’ispirazione pastorale vengono complicati da una più
schietta consapevolezza del mondo cittadino. Così le “ville seguon l’essempio de le gran
cittadi!”, e non vi è più distinzione tra un’Arcadia rappresentata come lontano paesaggio
naturale e la realtà cittadina, quella cortigiana ed estense, che diviene quindi la
condizione per eccellenza del letterato. La stessa rappresentazione, dietro i personaggi
dell’Aminta, di corrispondenze dirette con il mondo della corte ferrarese, è forse la cifra
della piena coincidenza tra corte e teatro, tra città e scenografia. Dunque non l’Arcadia,
2
territorio ideale e idillico, che già aveva fatto da sfondo all’Egle del Giraldi Cinzio, ma
la “gran cittade in ripa al fiume” (v. 570), dove si trova il “felice albergo” di Alfonso II.
Alla fortuna e al successo di pubblico del teatro tragico cinquecentesco hanno
contribuito elementi di natura diversa:
- la ancor viva dimensione della corte, con la sua classe dominante e i suoi riti legati
alla festa; il dibattito, anch’esso fiorente, intorno alle regole aristoteliche;
- la capacità di essere specchio inquieto di quelle tensioni proprio all’interno della
corte, e di Ferrara in particolare.
Il mondo arcadico dei pastori e lo struggente intreccio di amore e passione d’amore, si
congiungono dentro la forma teatrale non senza debiti espliciti verso alcune esperienze
tra le più significative della stagione umanistica. La poesia bucolica latina, l’Arcadia di
Sannazzaro e il consolidato petrarchismo si innestano nel tronco di una vivace ripresa,
anzi vera e propria fondazione moderna, della favola pastorale. Centro specifico di
questo fenomeno è la corte estense, in cui aveva trovato spazio una larga fioritura di testi
teatrali, dalla commedia alla tragedia moderne.
Il giovane pastore Aminta è invaghito di Silvia, bellissima ninfa che sdegna
l’amore, sebbene la matura Dafne la inviti a gustarne la dolcezza. Consigliato dalla
stessa Dafne e dal vecchio pastore Tirsi, Aminta segue Silvia al fiume dov’è solita
bagnarsi, e la salva dalle grinfie di un satiro, ma la giovane, ingrata, fugge. Alla
falsa notizia che Silvia è stata divorata dai lupi, Aminta disperato si getta da una
rupe cercando la morte, ma un cespuglio attutisce la caduta ed egli resta solo ferito
e svenuto. Silvia, che lo crede morto, dapprima si impietosisce per una tale prova
d’amore, poi si rende conto di essersene innamorata e corre a baciarlo. Aminta
rinviene e l’amore trionfa.
Il motivo centrale dell’opera è l’esaltazione dell’amore, o, meglio, dell’innamoramento;
il Tasso infatti indugia ad analizzare il modo in cui il sentimento nasce, vitale, potente e
indomabile, “non so da qual radice / com’erba suol che per se stessa germini”, e quali
riflessi psicologici esso abbia sull’animo dei protagonisti. L’aspetto passionale non è
trascurato, ma quasi filtrato e alleggerito attraverso le nostalgiche rievocazioni di Dafne
e Tirsi, e nei commenti attribuiti ai cori.
Aminta, indeciso e trepidante, si strugge nella malinconia; Silvia dapprima resiste, ma
non riesce a ostacolare l’amore che si insinua in lei sottilmente e quasi contro la sua
volontà. La ninfa sembra insensibile e ritrosa, ma dentro di sé è consapevole della
propria bellezza e se ne compiace; il Tasso sottolinea questi motivi apparentemente
contrastanti, che anticipano l’ambivalenza psicologica di alcuni personaggi della
Gerusalemme liberata. Ai due giovani protagonisti fanno da contrappunto Tirsi e Dafne,
più anziani e saggi, che conoscono le gioie dell’amore e le pene che derivano dalla sua
mancanza.
Da tutta la favola si sprigiona un anelito al piacere, che richiama l’edonismo proprio del
mondo rinascimentale; il paesaggio agreste, con la sua bellezza delicata e serena, dai
colori tenui e sfumati, crea un’atmosfera incantata, ideale per il trionfo dell’amore, forza
naturale e spontanea. L’ambiente pastorale, collocato in un luogo immaginario, fuori
dello spazio e del tempo, contiene tuttavia allusioni a personaggi e costumi della corte,
3
celebrata come mondo eletto, chiuso nella sua raffinata e preziosa eleganza. Gli accenni
sono velati ma riconoscibilissimi; l’autore stesso si cela sotto le vesti di Tirsi.
L’esaltazione della vita cortigiana è coerente alla personalità del Tasso, sempre
fortemente attratta dal fascino di quella società esclusiva, ma corrisponde anche al
desiderio di compiacere e dilettare il proprio pubblico, che vedeva rivivere nelle figure
del mondo arcadico i propri costumi e ideali. Il paesaggio idillico rispecchia inoltre il
sogno, mai espresso a chiare lettere ma latente in tutte le opere del poeta, della
campagna come luogo libero, privo di artifici e condizionamenti, dove è possibile
condurre un’esistenza serena e non essere travolti dagli affanni della realtà e dalle
inquietudini dovute all’ambizione e al desiderio di gloria. La corte, proiettata in una
sfera mitica e ideale, diventa così lo strumento per rappresentare e insieme cristallizzare
il proprio mondo interiore, sottraendolo al tormento delle contraddizioni che il poeta non
riesce a risolvere nella realtà e che tanto influiscono sulla sua stessa ispirazione poetica.
Lo stile dell’Aminta si impernia su una sapiente costruzione del verso, che si vale di
molteplici espedienti retorici, usati in modo da ottenere un effetto di scorrevolezza e di
naturalezza. Sono frequenti le rime finali e al mezzo, le assonanze, le consonanze, le
allitterazioni e molte altre figure retoriche, che producono una accentuata musicalità,
tanto che, come rileva il critico Mario Fubini, lo stile dell’Aminta prelude a quello dei
libretti d’opera, che spesso gli si ispireranno. Il linguaggio, in prevalenza di derivazione
petrarchesca, è ricco di rimandi alla tradizione classica (si trovano intere citazioni dei
poeti elegiaci latini) e volgare.
Ancora non del tutto risolto è l’inserimento dell’Aminta nelle categorie del teatro
cinquecentesco: divisa tra elementi tragici e comici, il dramma tassiano sembra fare di
questa incertezza la sua autentica forza specifica. Gli elementi comici, come ad esempio
lo scioglimento della vicenda, sono estremamente rari nell’Aminta, e anzi il finale è
tutt’altro che risolto in senso favorevole ai due amanti. È vero, nell’ultimo atto, Tasso
lascia intravedere l’unione prossima di Aminta e Silvia dopo la reiterata ritrosia della
ragazza e le voci sulle loro presunte morti: ma lo scioglimento dell’intreccio è troppo
debole per essere considerato un lieto fine, e manca di quella necessaria idealizzazione
dell’amore che si addice all’esito comico. L’Aminta, ha scritto il Guglielminetti, “pur
muovendosi, come tutta la produzione teatrale pastorale, fra commedia e tragedia,
propende piuttosto verso quest’ultima e non conosce che poche situazioni comiche”.
Nell’atto terzo Tirsi espone infatti i timori che Aminta si sia suicidato perché rifiutato da
Silvia, mentre Nerina racconta la morte di costei, sbranata dai lupi: è l’elemento della
tragedia che Aristotele definisce con il termine di peripezia, come mutamento
improvviso dell’azione, ma in questo caso la catastrofe è come rimandata e sospesa. Più
opportuna ci pare allora la ricapitolazione offerta dallo stesso Guglielminetti che ha
assunto per l’Aminta la soluzione del masque inglese, sulla scorta degli studi di
Northrop Frye.
Nel 1573 il Tasso inizia la stesura di Galealto re di Norvegia, una tragedia rimasta
interrotta alla scena seconda del secondo atto; essa viene ripresa e portata a termine tra il
1586 e il 1587, con il nuovo titolo Il Re Torrismondo. L’intenzione dell’autore nel
comporre il Torrismondo è quella di dar vita ad una tragedia rispettosa delle regole
4
aristoteliche, e difatti egli si ispira alle tragedie greche, in particolare all’Edipo Re di
Sofocle, ma è visibilmente influenzato dal gusto per le atmosfere cupe e passionali care
alla drammaturgia del tardo Cinquecento.
Gerusalemme liberata
È il 1099: la Crociata per la riconquista del Santo Sepolcro è in corso
ormai da sei anni senza alcun esito (in realtà la Crociata, iniziata nel 1096,
durava da tre anni). L’arcangelo Gabriele, inviato da Dio, si reca al campo
cristiano e ispira il nobile condottiero Goffredo di Buglione a radunare i
suoi e a concludere l’impresa espugnando Gerusalemme. Nella città santa
il re Aladino si dispone a subire l’assedio e caccia gli abitanti cristiani per
affrontare più facilmente l’attacco nemico; il re d’Egitto invia ambasciatori
alle tende dei crociati per cercare invano di dissuaderli dal combattere.
Intanto giunge a Gerusalemme la guerriera saracena Clorinda, giusto in
tempo per salvare dal rogo due cristiani, il giovinetto Olindo e la donna di
cui è segretamente innamorato, Sofronia, che Aladino ha condannato a
morte per aver rubato una sacra immagine della Vergine.
Nel frattempo Satana raduna i suoi demoni, che dovranno correre in
appoggio degli infedeli con l’aiuto del potente mago Ismeno e della
bellissima Armida. A lei viene affidato l’incarico di affascinare i guerrieri
cristiani distraendoli dalla guerra, opera che ella compie tanto bene da
sedurne quaranta, tra i quali il prode Rinaldo, capostipite degli Estensi, e il
valoroso Tancredi. Quest’ultimo spasima per Clorinda, dalla cui bellezza è
stato rapito per averla vista una sola volta, ed è vanamente amato dalla
dolce fanciulla pagana Erminia. Dagli spalti di Gerusalemme ella assiste
trepida al duello fra Tancredi e il fiero Argante e si precipita poi a
soccorrere l’eroe cristiano, indossando le armi di Clorinda; sorpresa da
una pattuglia cristiana, si rifugia tra i pastori. Tancredi, ingannato
dall’armatura, la insegue ma viene catturato da Armida.
Intanto i demoni ostacolano in tutti i modi i cristiani, in soccorso dei quali
vengono Dio e gli angeli. Rinaldo, prigioniero del fascino di Armida, viene
liberato dall’incanto grazie all’intervento di due compagni dotati dei
talismani del vecchio saggio di Ascalona; fa penitenza sul monte Oliveto,
libera gli altri guerrieri affascinati dalla maga e distrugge i potenti
incantesimi di Ismeno.
Argante e Clorinda tentano invano di fermare i crociati. La guerriera,
ferita a morte durante un duello con Tancredi, che non l’ha riconosciuta,
gli chiede e ottiene di essere battezzata. Tancredi, pur disperato, torna a
5
combattere e in un aspro scontro uccide Argante. Ferito a sua volta, viene
curato da Erminia, ma non la riconosce. Tutta Gerusalemme è sconvolta
da furiosi duelli che sfociano in una grandiosa e spietata battaglia, nel
corso della quale l’eroico sultano turco Solimano si getta nella mischia e
muore sotto i colpi di Rinaldo. Aladino viene ucciso da Raimondo di
Tolosa. Alla fine della tremenda battaglia, Goffredo vittorioso entra nel
tempio, s’inginocchia e prega.
Il soggetto della Gerusalemme liberata è la prima Crociata, un evento realmente
accaduto e non fantastico; in tal modo viene rispettato il principio che la poesia debba
fondarsi sul vero storico, che per il Tasso coincide con gli elementi religiosi della storia
stessa; d’altronde è bene ricordare che la scelta dell’argomento non è solo l’espressione
di un ossequio formale ai precetti della Controriforma, ma trova fondamento
nell’attualità della minaccia turca e in una convinta adesione alla fede cattolica.
Gli episodi di fantasia inseriti all’interno della materia storico-religiosa sono calcolati in
modo che restino nell’ambito di un’equilibrata verosimiglianza con il reale, secondo i
criteri già espressi nei Discorsi dell’arte poetica. Il Tasso infatti ritiene che il poema
epico non debba escludere del tutto la finzione, ma renderla verosimile, raccontando fatti
che non sono accaduti, ma sarebbero potuti o potrebbero accadere. L’uso della finzione
è giustificato dal desiderio di procurare diletto al lettore, una prerogativa che il Tasso
riconosce alla poesia, purché sia piegata ad elevate finalità etiche.
All’inizio del poema tutti i crociati, per quanto nobili e coraggiosi, hanno perduto di
vista il loro sacro obiettivo, sono “erranti” fisicamente e spiritualmente. Questa parola,
così strettamente connessa alla sensibilità del Tasso, è la chiave per interpretare le loro
avventure e capire il senso stesso del poema, che indica nella riconquista dell’integrità
morale e religiosa l’unica strada per superare le varie e vane seduzioni terrene. Così non
solo l’esercito cristiano può vincere la guerra, ma si arricchisce di una nuova e più alta
moralità; tra le righe della vicenda storica della Crociata possiamo leggere quella
metaforica di una crisi spirituale, e nella liberazione del Sepolcro, il riscatto simbolico
dell’anima. La materia è varia, poiché il Tasso giudica la varietà indispensabile al
“diletto”, ma unica è l’azione, la riconquista del Sepolcro, e unico è il personaggio,
Goffredo, anche se attorno a lui agiscono molte altre figure. Alla pluralità di eroi e di
azioni tipica del poema cavalleresco si sostituisce la ricerca di quella rigorosa unità
teorizzata dagli aristotelici del secondo Cinquecento (e sostenuta dal Tasso medesimo
nei Discorsi).
D’altronde, la scelta del tema impone un preciso ordine della struttura. Per questo, prima
di tutto, il numero dei canti è limitato, in modo da facilitare la compattezza del racconto.
Inoltre, alla struttura “aperta” dell’Orlando furioso se ne sostituisce una “chiusa”, basata
su una rigorosa geometria e simmetria delle parti. Alla divisione “orizzontale” tra
l’esercito cristiano e quello pagano in lotta sulla Terra ne corrisponde una analoga, ma
“verticale”, che vede fronteggiarsi i due “campi” ultraterreni, il Cielo (il Bene) e
l’Inferno (il Male). E se la dimensione terrena è contingente e variabile, quella celeste è
eterna e immutabile.
6
Quasi tutti gli avvenimenti accadono in uno spazio ridotto, tra la città assediata e il
campo cristiano, e il racconto scorre lineare anche nel tempo. Ogni azione ha un inizio,
uno svolgimento e una fine. Il Tasso non interrompe mai i suoi episodi; al massimo
introduce qualche rapida scena retrospettiva per chiarire l’antefatto di ciò che sta
succedendo in quel momento. Inoltre, sul modello dei poemi classici come l’Iliade, non
narra tutta la Crociata, ma si concentra sulle sue fasi finali e sull’episodio decisivo della
battaglia.
Anche gli elementi che sembrano ricondurre al poema cavalleresco tradizionale, come la
presenza di personaggi d’invenzione e il gusto per l’esotico e l’avventuroso, sono
fortemente modificati dall’autore. La guerra perde il suo carattere di epopea e si
trasforma in una necessità e in un dovere; d’altro canto, il mondo fantastico si trasferisce
dall’ambiente pagano a quello cristiano. Il “meraviglioso” che il Tasso ci descrive
rientra infatti nel quadro di una lotta perenne tra la potenza benefica di Dio e la
malvagità demoniaca di Satana; i talismani del vegliardo di Ascalona, che permettono a
Rinaldo di sottrarsi al fascino di Armida, sono uno strumento religioso, così come le
subdole arti di Ismeno e della stessa Armida sono al servizio del demonio.
La dimensione narrativa della Gerusalemme liberata è apparentemente lineare, ma al suo
interno si fronteggiano, in un difficile tentativo di conciliazione, due ideali di vita e di
civiltà in contrasto. L’autore ha una concezione pedagogica dell’arte, e forti
sollecitazioni morali e religiose lo spingono a seguire i precetti della Controriforma;
inoltre il gusto e la preparazione classica lo portano al rispetto consapevole della
tradizione epica e delle norme retoriche e letterarie dell’accademia. D’altro canto su di
lui agiscono prepotentemente il fascino della corte e l’ammirazione per un ideale
“codice d’onore” cavalleresco.
L’educazione letteraria e il sogno di una vita elegante e raffinata si innestano quindi
sulla già complessa materia religiosa, si integrano e interagiscono con essa. I duelli,
descritti con minuzia scientifica, rispettano scrupolosamente i regolamenti della scherma
e il codice della cavalleria; gli assalti e le battaglie hanno la precisione tecnica di un
manuale; il fasto rituale delle parate militari e delle processioni religiose, la grandiosità
degli sfondi, e persino la sontuosità regale delle vesti rimandano alla magnificenza e
all’ostentazione di ricchezza del mondo cortigiano. Anche la potenza visiva degli
episodi richiama una struttura drammatica più teatrale che narrativa; spesso la Liberata
appare come un grande palcoscenico che riflette il gusto scenografico, il senso dello
spettacolo e l’abitudine alla rappresentazione nelle corti.
A questo si aggiunge l’aspetto encomiastico, come il solenne e ripetuto ossequio agli
Estensi, e il compiacimento per le discussioni morali, politiche e strategiche proprio
della trattatistica dell’epoca. Analogamente, le orazioni e i discorsi sono costruiti
seguendo precisi schemi retorici di sostenuta eleganza.
Tuttavia, non di rado lo sforzo compiuto dal Tasso per ordinare la sua materia narrativa
entro schemi teorici e poetici perfettamente organizzati determina mancanza di pathos o
di scorrevolezza. La vera poesia della Liberata scatta allorché inconsciamente l’autore si
libera delle costrizioni impostegli dall’apparato esterno e rifiuta le regole accademiche e
i rituali cortigiani. Egli si discosta allora dal soggetto e dallo scopo che si è prefissi e
7
lascia parlare il suo ricco e inquieto mondo interiore, nel quale l’impulso che lo induce a
disciplinare e soffocare le passioni è in costante opposizione con la libertà del suo
spirito.
Nasce così un inestricabile intreccio di motivi eterogenei e complessi, che convergono e
interagiscono nel poema, manifestandosi in un ansioso e ininterrotto fluire di sentimenti
contrastanti, e che ha le sue radici in quello che Lanfranco Caretti definisce il
“bifrontismo” tassiano. Il termine sta ad indicare quella profonda ambivalenza interiore
che è prima di tutto una caratteristica psicologica e spirituale della personalità del poeta,
ma che trova un fertile terreno di sviluppo nella crisi storica e culturale del suo tempo,
della quale egli è insieme espressione e sintesi.
Lo scontro tra i limiti che l’autore stesso si è posto e le passioni che continuano tuttavia
a palpitare dentro di lui determina una delle caratteristiche più evidenti del poema, la
sensualità, che talora sfocia in vera e propria morbosità e nel compiacimento per
situazioni torbide.
I tanti amori vagheggiati e non corrisposti, costruiti come in una catena alla quale manca
l’anello di chiusura, testimoniano l’angosciosa consapevolezza che è impossibile
raggiungere l’appagamento dei propri desideri e, più ancora, ne denunciano la
sostanziale vanità. Erminia ama non ricambiata Tancredi, che a sua volta ama Clorinda;
Rinaldo ama Armida per un incantesimo, ma quando vi si sottrae, è Armida che
s’innamora di lui (e poco importa sapere che forse alla fine Rinaldo la ricambierà).
Inoltre, un ambiguo rapporto unisce l’amore e la morte; una tragica ironia vuole, ad
esempio, che Olindo, innamorato di Sofronia, si trovi unito a lei solo quando Aladino li
fa legare schiena contro schiena al palo del rogo, o che proprio la mano dell’ignaro
Tancredi immerga la spada nel seno dell’amata Clorinda.
L’intrinseca instabilità dello spirito tassiano determina la frantumazione d’ogni certezza
e incrina l’immagine fiduciosa di un mondo dove sia possibile segnare, con una linea
netta e decisa, la divisione tra il Bene e il Male, insinuandovi la coscienza accorata che
nella vita umana tutto è multiforme, contraddittorio e relativo. Un esempio chiarissimo
si ha nell’episodio della battaglia finale. Si è detto che la figura di Goffredo regge le fila
del poema, poiché incarna la “giusta causa” dando senso e valore morale alla guerra; ma
proprio quando quel senso e quel valore sembrano realizzarsi pienamente, il Tasso ne
rovescia la prospettiva. Nel furore della battaglia, tra l’incalzare degli eserciti e i suoni
cupi dei duelli, Solimano, il glorioso re turco, sale in cima alla torre di Davide e da
lontano, attonito, stupefatto, “mirò, quasi in teatro od in agone / l’aspra tragedia de lo
stato umano: / i vari assalti e ’l fero orror di morte, / e i gran giochi del caso e de la
sorte”. La giustizia della guerra santa scompare, resta l’immagine della vita umana che
appare come un angoscioso mistero al quale non si trova risposta; il dominatore
dell’esistenza torna ad essere, come per l’Ariosto, il caso. Ma il Tasso non vi guarda col
sorridente distacco della saggezza ariostesca e ne vede soltanto gli oscuri “gran giochi”,
che lo rendono una potenza cupa e minacciosa.
Il tema conduttore della Gerusalemme liberata è il sentimento della caducità che
incombe su tutte le cose, dell’implacabile destino di morte che attende ogni uomo. Il
Tasso sente con partecipazione intensa il motivo della morte, e in esso riesce a
concentrare le diverse passioni e a conciliarle senza forzature. L’angoscia della morte
8
non si cancella, ma la percezione acerba e lacerante della vanità dell’esistenza si
stempera nella fede religiosa, il dolore acquista un senso, la vita umana uno scopo. Ne è
un esempio la morte di Clorinda, annunciata da versi solenni e rivelatori (“Ma ecco omai
l’ora fatale è giunta, / che ’l viver di Clorinda al suo fin deve”). La morte spezza una vita
giovane e fiera e interrompe bruscamente ogni sogno e illusione, ma segna anche il
passaggio ad uno stato di sublime quiete: “passa [muore] la bella donna, e par che
dorma”. Nella contemplazione stupita e commossa dell’ora “fatale” la poesia del Tasso
raggiunge le sue vette più alte e suggestive.
Non di rado, infine, riaffiora nella Gerusalemme la vena elegiaca e idillica, già espressa
nell’Aminta, con il sogno fuggevole di una società semplice e incontaminata, come nel
celebre episodio di Erminia che trova conforto e alimento al suo sogno d’amore tra i
pastori, nella pace della natura e nell’armonia del paesaggio accogliente e sereno.
E il paesaggio non è mai un semplice sfondo o una cornice; al contrario, scandisce le
variazioni tematiche ed ha sempre una funzione essenziale al racconto, in perfetta
coerenza con la psicologia e lo stato d’animo dei personaggi; spesso deserto e immerso
in un assoluto silenzio, sottolinea la solitudine interiore o favorisce il raccoglimento;
talora la sua calma fa da contrasto al fragore delle battaglie e sembra riflettere l’anelito
alla pace, che subentra al desiderio di gloria; talvolta è spazzato dal vento e dalla bufera
e appare come una manifestazione di potenza sovrumana, che rende ineluttabile la sorte
dei protagonisti.
9