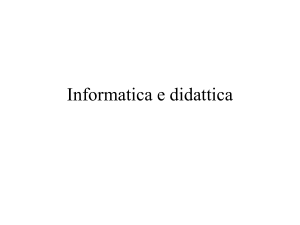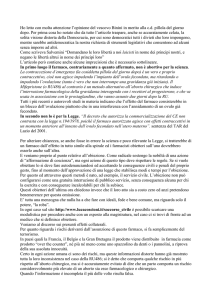BOLLETTINO U.C.F.I. (UNIONE CATTOLICA FARMACISTI ITALIANI) – SEZIONE DI VERONA
LUNGADIGE SAMMICHELI, 3 C.A.P. 37129 VERONA TEL. 045/8034396
E-MAIL: ethical@brembenet .it
SITI INTERNET: www.ucfi.it e www.farmacieverona.it
N. 4/06
Obbedire alla legge positiva o alla legge morale?
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
L’obiezione di coscienza è il rifiuto, da parte di un singolo o di un gruppo, di un
dovere di diritto pubblico, come il servizio militare obbligatorio, ma è insieme la
testimonianza di un valore ritenuto superiore. Si pone la questione se si debba
obbedire alla legge positiva o alla legge morale. Già per San Tommaso la fonte
del diritto non è l’autorità, ma la coscienza individuale o collettiva. Questo è
generalmente riconosciuto dalle legislazioni moderne, che autorizzano in
determinati casi l’obiezione di coscienza.
L’obiezione di coscienza consiste essenzialmente nel fatto che un cittadino, per motivi interiori, ossia «di
coscienza», si rifiuti di adempiere a un obbligo espressamente previsto dalla legge positiva. Si può discutere
se l’obiezione sia un fenomeno necessariamente soltanto individuale, ovvero se si possa parlare anche di
un’obiezione posta in atto da gruppi di consociati; si distingue inoltre tra un’obiezione «assoluta», che
riguarda sic et simpliciter ogni e qualunque comportamento che rientri nel genere al quale si obietta (ad
esempio, alla guerra comunque e dovunque), e un’obiezione «relativa», capace di ammettere eccezioni (ad
esempio, uno obietta a questa guerra). È vasta poi la gamma di motivi per i quali si obietta.
Storicamente l’obiezione di coscienza nasce per motivi religiosi: dal rifiuto di Antigone di obbedire
all’ordine del tiranno Creonte, che le proibiva di seppellire il fratello, in nome degli agrapha dogmata, delle
leggi non scritte della giustizia e della pietà, al rifiuto dei martiri cristiani di prestare culto al genio
dell’imperatore, fino al rifiuto del giuramento in un processo o delle trasfusioni di sangue da parte di alcune
sètte. È indubbio però che, nel secolarismo proprio della cultura occidentale, essa si sia estesa anche a motivi
morali prima, come il rifiuto della violenza, specie quella delle armi, e a convincimenti filosofici poi, che
riguardano in senso ampio la concezione del mondo, dell’uomo e della storia, fatta propria dall’obiettore.
Com’è certo che essa si estenda anche a motivi politici, come l’anarchia o l’internazionalismo: da un lato,
infatti, questi appartengono certamente a quella sfera dei liberi convincimenti interiori che potremmo
chiamare «filosofici», dall’altro pare che in tal modo l’obiettore si sottragga al dibattito politico e al gioco
democratico, il quale prevede che la maggioranza approvi leggi, e quindi dia indirizzi politici vincolanti
anche per la minoranza o i dissenzienti.
Vale ancora la pena di rilevare che, mediante l’obiezione di coscienza, il singolo non pone in essere un
atto negativo, ossia un semplice rifiuto: egli, etimologicamente, pro-testa, ossia rende testimonianza a favore
di una verità da lui ritenuta più grande, più vincolante, più alta dei comportamenti contingenti e fallibili
previsti dalle leggi umane. In questo senso, specialmente quando ne sono subite le conseguenze negative,
che a volte sono o sono state assai pesanti - Tommaso Moro pagò con la vita la ribellione a Enrico VIII, ma
anche molti altri hanno eroicamente subìto la morte, il carcere o altre pene per testimoniare la verità in cui
credevano -, l’obiezione può assumere il significato profano di una proclamazione di libertà, della
incomprimibilità della persona umana a semplice «esecutore» di ordini statali, ovvero quello religioso della
profezia, la proclamazione solenne che «bisogna obbedire a Dio piuttosto cha agli uomini» ( At 5,29).
I motivi per i quali si obietta possono essere condivisi, o quantomeno compresi come tali, dalla generalità
dei consociati, ovvero non trovare un ampio riscontro o approvazione, e questo non può non rivelarsi anche
1
nella disciplina normativa: così in molti Paesi, come l’Italia, l’obiezione all’aborto è prevista senza che la
legge indichi particolari motivi fondanti, è cioè concessa senza distinguerne i motivi o fissarne un «elenco»,
mentre per altre forme di obiezione la concessione di questo beneficio è subordinata a particolari motivi,
previsti «a numero chiuso»: così in passato non fu accolta la richiesta di obiezione di coscienza al servizio
militare presentata per motivi politici, poiché la legge 15 dicembre 1972 n. 772, che disciplinava la materia,
faceva riferimento soltanto a convincimenti «religiosi o filosofici o morali». Nel caso poi della cosiddetta
«obiezione fiscale», il rifiuto cioè di versare quella parte delle tasse che andrebbe a sostenere, ad esempio, le
spese militari, il legislatore appare molto più «chiuso», escludendola del tutto.
Sarebbe interessante ripercorrere l’itinerario legislativo e soprattutto giurisprudenziale che nel nostro
Paese ha interessato l’obiezione di coscienza per antonomasia, quella al servizio militare: la giurisprudenza,
il cosiddetto «diritto vivente», ha operato molto profondamente sul dettato legislativo, o «diritto vigente»,
concepito originariamente in termini abbastanza sfavorevoli ad essa, sia nella valutazione dei motivi previsti,
sia per la durata del «servizio sostitutivo», sia anche per altri aspetti, penali e amministrativi. La
giurisprudenza ha recepito, e anche, al tempo stesso, favorito, un cambiamento della valutazione etica di
alcune condotte rilevanti per la vita di tutti. In questo senso, potremmo dire che l’argomento che trattiamo è
di estremo interesse come «ponte» tra lo Stato e l’individuo, fondendosi con considerazioni più propriamente
filosofico-giuridiche sul ruolo dei convincimenti diffusi in una società per la formazione dell’ordinamento
giuridico, e sulla natura stesa del «dovere» giuridico: si tratta di un argomento estremamente vario, perché
molte sono le fattispecie che rientrano in considerazione (obiezione al servizio militare, all’aborto, al
giuramento, ai trattamenti sanitari obbligatori, a prestazioni lavorative contrarie a convinzioni ideologiche o
religiose e così via) e anche perché, per propria natura, è diacronico, in continua evoluzione storica. Questo
nostro contributo non vuole essere, e non potrebbe essere, una completa disamina del problema: ci
accontenteremo di svolgere alcune considerazioni di ordine filosofico per aiutare a elaborare una valutazione
serena e critica di alcuni presupposti della nostra cultura giuridica.
Considerazioni preliminari
È di fondamentale importanza osservare che, nonostante la pluralità di forme che assume l’obiezione di
coscienza e nonostante anche le incertezze della dottrina, un dato rimane comunque fermo: l’obiezione di
coscienza si pone come rifiuto di un dovere di diritto pubblico, ossia promanante dall’autorità statale. Non è
pensabile cioè un’obiezione a un dovere che nasce da un contratto privato, ossia da relazioni «private». In
questo senso, essa si dà, o si può dare, solamente nei rapporti tra il cittadino e il potere pubblico, che impone
determinati comportamenti. La dualità esasperata tra pubblico e privato è l’alveo naturale nel quale sorge il
problema: poiché il diritto è tout court pensato come legge, e con essa confuso, e poiché la legge, per sua
natura, non può che essere pubblica, comportamento imposto dall’alto a una massa di individui concepiti
come incapaci di essere regola a se stessi, irregolari e asociali, ne deriva che l’obiezione di coscienza non
può che essere ammessa se non nei limiti previsti dalla legge, sotto pena di stravolgere quella pace sociale
che la legge, attraverso i propri imperativi, vuole costituire. In altri termini, in una concezione positivista
come quella giuridica dominante, non può legittimamente darsi alcuna obiezione alla legge, a meno che la
legge non lo preveda: ma in questo caso in fondo non si può nemmeno parlare di obiezione vera e propria,
ma solamente di un diverso comportamento che può essere assunto, ossia di una facoltà concessa dalla legge,
come appunto quella di non prestare la propria opera professionale all’esecuzione di un intervento abortivo,
ovvero - quando esisteva, fino a tempi recentissimi, la leva obbligatoria - la facoltà di svolgere il cosiddetto
«servizio civile» in strutture non militari. In breve, per un positivista «di stretta osservanza», l’obiezione di
coscienza non esiste: tutt’al più esiste, ma come dato di fatto, non come fattispecie contemplata, il rifiuto di
obbedire alla legge, per il quale la legge stessa prevederà eventualmente sanzioni, magari anche non
necessariamente penali.
Ma, in fondo, anche nel caso opposto, ossia per il giusnaturalista «puro», la situazione è la stessa: per lui
la «vera» legge non è umana, ma superiore, morale se non divina, e, se la legge positiva ne differisce, non va
osservata, proprio perché non è (più) legge. Per lui la legge umana stessa non esiste, ma esiste soltanto il
dettame della propria coscienza. In fondo, un certo tipo di giusnaturalismo - non certo quello di San
Tommaso, ma quello di una certa manualistica, oppure quello di S. Pufendorf o di C. Thomasius - pensa di
poter prescindere dalla legge positiva, non riconoscendole una reale autonomia.
È evidente a questo punto che bisogna sfuggire entrambi i corni del dilemma: il problema dell’obiezione
di coscienza è destinato a rimanere inevitabilmente nei termini sopra delineati, a meno che non si compia una
critica alle premesse sulle quali si fondano tanto i giusnaturalisti quanto i positivisti. Tutto questo sarà
2
possibile soltanto ridefinendo il concetto di diritto, contestando la dicotomia tra pubblico e privato, passando
da una legge concepita come imposizione a una legge intesa come osservanza.
Alcune premesse
Per noi moderni, la legge nasce come ordine imposto da un superiore, che dispone di sufficiente forza
fisica per costringere all’esecuzione: il legislatore, cioè semplicemente lo Stato, elabora, produce
proposizioni normative conformemente a quanto dispone una norma fondamentale, o Costituzione, e,
mediante l’Esecutivo, ne esige l’adempimento. Diciamo che un ordinamento «valido», cioè le norme
prodotte in conformità a norme superiori che disciplinano la formazione delle leggi, diviene così «efficace»,
vale a dire capace di farsi valere ed effettivamente obbedito. Possiamo osservare, in questa sommaria
descrizione, l’apporto della teoria di H. Kelsen, certamente la più coerente enunciazione della fenomenologia
dello Stato moderno. Essa si impernia, come appare evidente, sul principio della divisione dei poteri, già
elaborato da Montesquieu: nondimeno, anche se tale aspetto è più implicito, questa concezione si fonda su
una valutazione sostanzialmente negativa, quella elaborata da T. Hobbes, del ruolo del singolo consociato,
del privato cittadino concepito come individuo egoista e incapace di regolarsi, e dunque come esposto, in
mancanza dello Stato, alla guerra civile perenne, frutto degli appetiti disordinati e degli egoismi di tutti.
L’ordine del sovrano, la violenza del legale esercitata in suo nome e con la sua autorità, è l’unica scappatoia
al disordine e al caos, cioè alla violenza inevitabile. La legge non può che essere un ordine, e agli ordini non
si può (legalmente) che obbedire: la disobbedienza non esiste giuridicamente, se non come dato di fatto, non
legale, al quale lo stesso ordinamento ricondurrà precise conseguenze. L’ordine giuridico significa il
comando dello Stato: ma bisogna osservare che «ordine» non significa soltanto «comando», com’è evidente.
È da addebitare a quel grande movimento filosofico, chiamato «seconda scolastica», una sorta di shifting,
di slittamento di significato di questo termine così decisivo nella storia e nella filosofia del diritto: da F.
Suarez in poi ordo, l’ordo iuris medievale, cioè la realtà intrinsecamente ordinata, capace come tale di
esprimere un’autoregolamentazione secondo esigenze oggettive, percepite e tradotte dalla dottrina giuridica,
significa semplicemente l’ordine inteso come comando, il precetto autoritario del potere. Tecniche
particolari, come la generalità, l’astrattezza, il sillogismo giuridico, ne costituiranno lo strumentario
concettuale: ma ormai il diritto si è identificato con la legge e si è ancorato definitivamente allo Stato, e non
più, come nel mondo romano e medievale, alla società. All’opera dei tribunali rimane l’applicazione del
diritto, la sua concretizzazione da previsione generale e astratta a comando vincolante le parti in causa, non
più la sua individuazione e creazione, come accade ancora oggi nel sistema anglosassone di common law.
È questo il motivo per cui, storicamente, l’obiezione di coscienza non era prevista nei sistemi codicistici,
ossia negli Stati liberali sviluppatisi nell’Ottocento: non si tratta di un semplice dato di fatto che vogliamo
osservare, né il motivo è una semplice esigenza di sopravvivenza, nel senso che, al contrario, lo Stato ne
sarebbe rimasto vulnerato nel momento del suo stesso sorgere, ma di una vera e propria esigenza logica,
intrinseca alle ragioni costitutive dell’ordinamento stesso. Implicitamente, veniva affermata l’irrilevanza
delle motivazioni personali e, più radicalmente, della dimensione del «privato» nei confronti del «pubblico».
Soltanto successivamente, nello sviluppo dello Stato liberale classico secondo linee più marcatamente
personalistiche e dopo le esperienze dei regimi militari totalitari, tale posizione di esclusione andò
attenuandosi. Non a caso, del resto, l’obiezione era generalmente vietata anche dagli ordinamenti giuridici
dei Paesi socialisti: tanto la prospettiva individualistico-liberale quanto quella socialista hanno infatti come
matrice comune la prospettiva hobbesiana del diritto e dello Stato. Al contrario, nel Regno Unito, cioè nel
dominio della common law alla quale abbiamo accennato, la legislazione, perlomeno sull’obiezione al
servizio militare, è stata molto generosa, forse la più favorevole di tutti gli Stati liberal-democratici anche in
tempo di guerra. Non si tratta soltanto di un fenomeno, di un dato empirico da osservare e da spiegare con
dati ancora empirici, come la presenza sociologicamente rilevante di varie sètte religiose: dobbiamo appunto
coglierne anche le ragioni più profonde, che attengono a un diverso modo di concepire il diritto e la legge,
nonché i rapporti tra privato e pubblico, tra cittadino e Stato.
Un diverso modo di concepire l’esperienza giuridica
Tutto cambia ponendosi in un’altra prospettiva. Se non identifichiamo il diritto con la legge, ossia con il
comando del superiore, e se concepiamo il singolo come capace di auto-organizzazione, ossia come capace
di essere legge a se stesso e di trovare ciò che è giusto per sé e per gli altri anche al di fuori della legge, in un
discernimento concepito come giusto giudizio sulle situazioni di fatto nelle quali egli può trovarsi, è ben
3
possibile scoprire spazi ben più ampi per l’obiezione di coscienza alla legge positiva in nome di esigenze
superiori di giustizia, senza che per questo l’ordinamento perda la propria giuridicità a la sua stessa
positività. In questo contesto, che storicamente è proprio dell’esperienza giuridica romana e medievale, e
oggi di quella anglosassone e, in un certo senso, di quelle canonica, la legge positiva non è più l’unica fonte
del diritto:l’esperienza giuridica è imperniata, in questa diversa dimensione, non sull’obbedienza a un
comando, ma sul trovare, nella mutevole varietà delle cose umane, cio che è giusto. Fulcro del sistema
appare così non la costruzione teorica del diritto soggettivo, secondo la prospettiva moderna, ma la res, la
cosa stessa con la quale il soggetto si incontra, che richiede di essere valutata e compresa nel suo valore e
significato: così il diritto è una realtà preesistente che il potere non crea, non pretende di creare, non sarebbe
in grado di creare; che può invece soltanto dire, dichiarare.
Questo non significa misconoscere il ruolo delle leggi positive umane, che costituiscono una dimensione
necessaria e fondamentale del discernimento di ciò che è giusto: non a caso, anche nella stessa esperienza
anglosassone, la massa degli Statutes, le leggi approvate dal Parlamento, è imponente. Ma significa
riconoscere che il diritto non coincide con la legge, ossia con il potere, se non in parte, in una sua
estrinsecazione, anche se storicamente determinante: significa riconoscere che fondamento del diritto non è
l’obbedienza a un comando, ma un comune sentire, un assenso, un’osservanza comune. Tale è il significato
più profondo di un ordinamento che vive non tanto di leggi, quanto di sentenze giudiziali, vincolanti come
precedenti, ancorate al sentire diffuso di una comunità. Il diritto nasce dunque non dallo Stato, da un
apparato di governo, ma dalla società, dai valori che essa esprime e che percepisce come tali. Accade per il
diritto come per la lingua parlata: tutti usano il congiuntivo non perché è «ordine», ma perché lo «sentono»
necessario, come tale. In questo senso, il diritto appare ancorato ad alcuni valori: e il valore è un principio o
un comportamento che la coscienza collettiva ritiene di sottolineare isolandolo e selezionandolo dal fascio
indistinto dei tanti principii e comportamenti. Ed ecco perché esso si àncora inevitabilmente alla dimensione
interiore, soggettiva, all’assenso del singolo al valore espresso dalla legge.
Questo è il motivo per cui nell’esperienza giuridica medievale, della quale San Tommaso è ottimo
testimone, il ruolo della coscienza individuale è così sottolineato, perfino nella consapevolezza che di fatto
uno può oggettivamente sbagliarsi. Così per l’Aquinate sarà meglio affrontare l’immeritata scomunica della
Chiesa disobbedendo a un ordine superiore che si reputa ingiusto, e fuggire, per non farsi prendere, dove non
giunge il braccio secolare: «Deve piuttosto affrontare la scomunica […] oppure deve esulare in terre lontane
(Summa Theol,, Suppl., q. 45, a. 4, ad 3). Ancora: «Anche se ciò che la nostra ragione ci impone non sia per
se stesso secondo la legge di Dio […], in quanto però la nostra ragione lo conosce come secondo la legge di
Dio, e cosa buona, ne segue che la coscienza, pure quando sbaglia, ci obbliga» (In II Sent., d. 39, q.3, a.3, ad
1). In questa prospettiva, la giustificazione «abbiamo solo obbedito agli ordini», tanto sentita nella storia del
XX secolo, perde moltissimo del suo valore.
Scompaiono dunque, nella loro assolutezza, i riferimenti alla validità e all’effettività dell’ordinamento
giuridico, mentre l’«ordine» viene riportato al suo significato vero e proprio, quello originario. Il diritto,
riportato alla società e non solo allo Stato, viene epurato da prospettive autoritarie fuorvianti. Soprattutto,
viene riportato alla sua piena importanza il ruolo dei singoli consociati nello svolgimento dell’esperienza
giuridica, mentre il «pubblico» è riportato alle sue giuste dimensioni. Questo è precisamente l’alveo nel
quale sorge la possibilità dell’obiezione di coscienza, sulla quale giova però svolgere ulteriori
puntualizzazioni.
Considerazioni ulteriori
Come abbiamo già osservato, le Costituzioni moderne non si limitano ad essere semplici «macchine
legislatorie», a fornire cioè le semplici «regole del gioco» in base alle quali formare le leggi statali: in termini
kelseniani, le Costituzioni non attengono solamente alla dimensione formale degli ordinamenti giuridici,
fissandone i criteri per la loro validità, come «norme sulla produzione» degli atti normativi statali. Nelle
Costituzioni moderne sono presenti veri e propri valori diffusi, nei quali la generalità dei consociati si
ritrova, e che, come valori condivisi, fondano l’intelaiatura normativa, come una ragnatela si poggia su puntiforza esterni ad essa. In questo senso, è interessante osservare che, a norma dell’art. 2 della nostra
Costituzione, la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili» dell’uomo, come singolo e come
associato nelle varie formazioni intermedie. Riconosce ,non concede: l’ordinamento giuridico italiano è così,
dalla nostra massima fonte di diritto, concepito come basato su valori previ a ogni riconoscimento legale, ma
non per questo non giuridici, proprio perché la Carta costituzionale non vede necessariamente coincidenti il
diritto e la legge.
4
Questo principio fondamentale, al quale se ne collegano altri, come l’inderogabile principio di
uguaglianza fra tutti, la libertà religiosa e di coscienza, nonché gli altri diritti di libertà (politica, civile ed
economica) con i connessi doveri di solidarietà sociale enunciati nella nostra Costituzione, è di fatto il plesso
teoretico a partire dal quale si spiegano e giustificano gli interventi della giurisprudenza, costituzionale e no,
volti ad ammettere sempre più ampiamente la possibilità dell’obiezione di coscienza: ciò è visibile nella
storia della disciplina normativa specie dell’obiezione di coscienza al servizio militare, via via resa sempre
più ampia nonostante le originarie previsioni della legge. In questo senso, è vero che il diritto alla libertà di
coscienza non è formalmente riconosciuto, in maniera esplicita, nella nostra Carta Costituzionale. Ma di esso
manca solo il nome, non l’ammissione e la tutela, essendoci infatti riconoscimenti costituzionali impliciti,
non meno validi di quelli espressamente formulati, e tra questi proprio la libertà di coscienza, che è la
primordiale e basilare tra tutte le libertà.
Potremmo dire che la più grande estensione dell’applicabilità di questi princìpi sia propria di uno Stato
veramente democratico, di uno Stato cioè che voglia essere, come si dice, la casa comune di tutti, anche di
coloro che non si sentono di condividere scelte legali e politiche vigenti. Naturalmente, questo non può
legittimare l’anarchia, né svellere alla radice quel dovere massimale di obbedienza che promana dalle leggi
statali.
In questo senso, non qualsiasi motivazione di dissenso può meritare l’appellativo di «obiezione di
coscienza», ma solamente quelle che mettono in causa, da un lato, i valori religiosi e, dall’altro, i valori
fondamentali di convivenza sociale pacifica e ordinata che lo Stato tutela. Probabilmente non si può invocare
l’obiezione di coscienza per protestare contro certi tipi di spese statali, ad esempio quelle sugli armamenti,
per quanto nobili ne siano le motivazioni: il dibattito politico, cioè le regole fondamentali di convivenza di
uno Stato democratico, dovrebbe essere sufficiente per manifestare nelle sedi opportune il proprio dissenso,
fermo restando l’obbligo di tutti al prelievo fiscale e alla manifestazione del proprio libero pensiero.
Diversamente potrebbe darsi in altri casi, come nel caso in cui la legge dovesse imporre a un funzionario
statale atti che, se pur legali, sovvertono la stessa antropologia: ad esempio, celebrare un «matrimonio» tra
persone dello stesso sesso, ovvero quando si dovesse imporre a un medico di procedere all’eutanasia, anche
se su richiesta del paziente. Si tratta infatti di atti che, a prescindere dalla loro valutazione religiosa e dal
loro significato morale obiettivamente diverso, manifestano l’implosione degli ordinamenti giuridici
contemporanei ad essere puri strumentari della volontà individuale, ossia la rinuncia da parte dello Stato ad
essere strumento di coesistenza pacifica: non si tratta infatti, nonostante quanto pretestuosamente si dice, di
atti che si esauriscono tra i richiedenti, quasi loro affare privato. Il diritto è relazionalità tutelata e garantita, e
la legge è strumento di essa: la soppressione di una persona è negazione di questo, e un rapporto mimetico
non è, per natura, un rapporto reale, che, proprio in quanto rapporto, è basato sulla differenza, anche
sessuale (a tacere del diritto dei figli ad avere una vera coppia di genitori, basato sul principio antropologico
fondamentale della differenziazione e della complementarità, per lo sviluppo della loro identità personale,
che nasce dal sapere «chi è mio padre», e della loro correlata identità sessuale).
Conclusioni
In questi casi, e in altri che potrebbero profilarsi, l’ammissibilità dell’obiezione di coscienza, anche se non
fosse prevista dal legislatore, e si dovesse dunque configurare come illecita, deriva dal fatto che la
legislazione alla quale si obietta è in contrasto non con il diritto di natura - che certamente esiste, ma sul
quale bisogna comunque intendersi, non costituendo un facile terreno d’incontro con la maggior parte della
cultura giuridica attuale -, ma con la natura del diritto, ossia con le finalità proprie di ogni ordinamento
giuridico, finalità e princìpi precipitati, positivamente, nelle nostre Costituzioni, particolarmente nei princìpi
di uguaglianza e libertà individuali, e i correlati doveri di solidarietà sociale. In altri termini: poiché i nostri
ordinamenti democratici si fondono su alcuni valori, riconosciuti e tutelati dalle Costituzioni, il semplice
dettato normativo non può costituire un limite invalicabile e un dovere assoluto di obbedienza. In particolare,
quando di fatto l’applicazione del dettato legale sovverte i princìpi giuridici basilari dell’ordinamento, è da
riconoscersi un vero e proprio diritto all’obiezione. Concretamente, questo significherà non un farsi giustizia
da sé, che è comunque la negazione dello Stato di diritto, ma un rinvio alle Corti giudicanti che attueranno
così i valori impliciti nel nostro costituzionalismo.
In questo senso, l’ambito proprio dello sviluppo degli spazi di libertà in nome dei princìpi personalistici
indicati dalla nostra Costituzione, e dunque dell’ampiezza dei diritti della coscienza, è il diritto vivente dei
Tribunali, specie della Corte Costituzionale, cioè il concreto darsi dei problemi, più che non la loro teorica e
astratta previsione normativa o diritto vigente. Questo è già accaduto, anche nel recente passato della nostra
5
storia repubblicana, come dimostra la storia della normativa riguardo all’obiezione di coscienza al servizio
militare, e succederà ancora. Ma questo richiede anche un cambiamento della cultura giuridica, un suo
svincolarsi da pastoie formalistiche e positivistiche, al quale c’è da augurarsi che ci conducano proprio le
aberrazioni a cui si può giungere in vista di una più concreta e piena attuazione dei diritti della persona.
Prof. OTTAVIO DE BERTOLIS
Facoltà di Diritto canonico dell’Università Gregoriana
Roma
(© La Civiltà Cattolica 2005 IV 145-156)
6


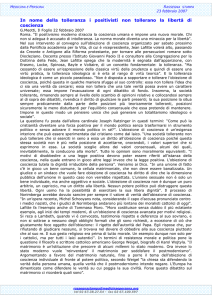
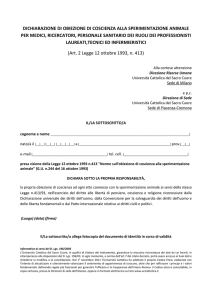

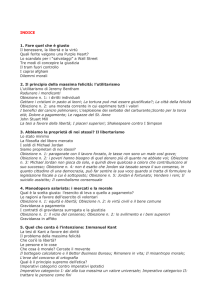
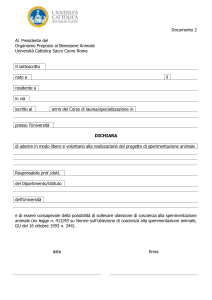

![Legge 194 [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/001044929_1-3725e6d4a7a52850e059e79e50807730-300x300.png)