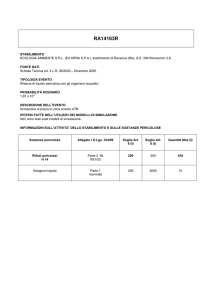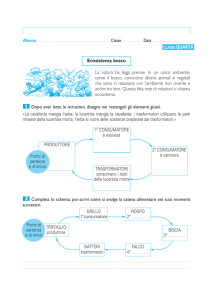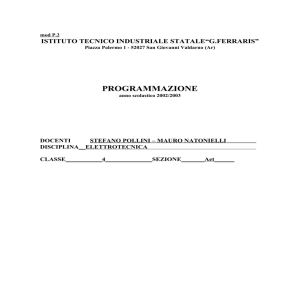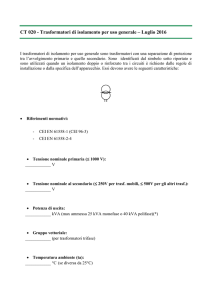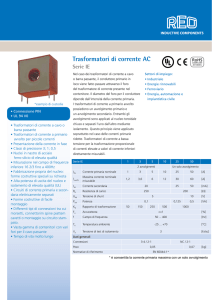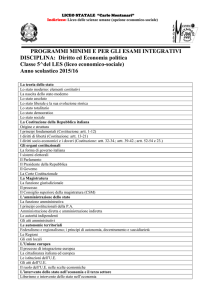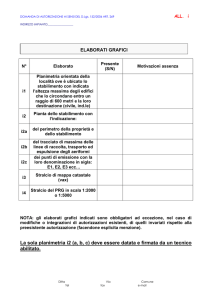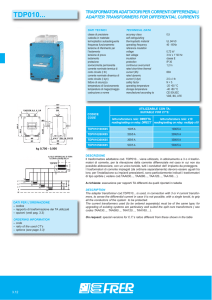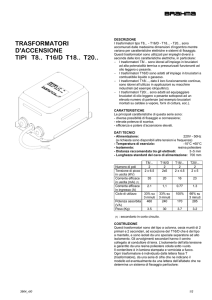TRIBUNALE DI TARANTO
GIUDICE MONOCRATICO
2° SEZ. PEN.
SENTENZA
(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott DR. M. ROSATI alla pubblica udienza del 5/7/2004 ha pronunziato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
l) CAPOGROSSO LUIGI
2) DEL VECCHIO SALVATORE
3) LESTO ANTONIO
4) COLUCCI MICHELE
IMPUTATI
Dei reati di cui agli artt.
a) 437 c.p. perché nelle rispettiva qualità di Direttore di Stabilim ento il Capogrosso, di
responsabile della produzione del reparto PLA/2 il Del Vecchio, di responsabile della
manutenzione per l'area laminazione il Lesto, di responsabile della manutenzione del
reparto PLA/2 il Colucci, omettevano in tutto o in parte i con trolli e le verifiche previste
dal DPR 216/88 e dalla normativa CEI per il corretto esercizio delle apparecchiature
contenti fluidi a base N. di PCB (policlorobifenili) ovvero violavano costantemente le
norme in materia di sicurezza e di prevenzione infort uni sul lavoro di cui ai successivi
capi nonostante le ripetute disposizioni e segnalazioni impartite dalla ASL di Taranto
così determinando in una situazione di concreto pericolo per la salute dei lavoratori e
della intera collettività e per l'ambiente in seguito allo scoppio di un trasformatore
elettrico contenente fluido elettrico costituito da PCB sito all'interno del reparto PLA/2
dello Stabilimento ILVA dì Taranto.
b) del reato di cui agli artt. 267, 389 DPR 547/55 perché nelle rispettiva qualità sopr a
indicate non provvedevano al corretto esercizio ed alla dovuta manutenzione dei
trasformatori elettrici ad apirolio presenti nello stabilimento ILVA di Taranto al fine di
prevenire il pericolo di scoppio.
c)del reato di cui agli artt. 4, 58 DPR 303/56 pe rché nelle rispettive qualità sopra indicata
non informavano adeguatamente il personale addetto al reparto PLA/2 in merito ai rischi
cui erano esposti né fornivano loro i necessari mezzi di protezione;
d) del reato di cui agli artt. 43. co.4, 89 DPR 626/94 perché nelle rispettive qualità sopra
indicate non provvedevano ad una adeguata manutenzione dei dispositivi di protezione
individuale.
In Taranto fino al 16/8/1997
Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. MAURIZIO CARBONE
del difensore dì fiducia avv. C. Mattesi per il 1° presente e acc. F. Mucciarelli assente;
Avv. Albanese per 2°, 3° e 4° di fiducia assente sost. con delega dall'avv. F. Nevoli.
SI COSTITUISCE PARTE CIVILE
- COMUNE DI TARANTO ASS. B. DECORATO
- LA UIL NELLA PERSONA DI FRANCO SORRENTINO ASSENTE ASS. DALL'AVV. S.
TORSELLA DIFENSORI PRESENTI
Le parti hanno concluso come segue:
MOTIVAZIONE
1
l. - IL PROCESSO E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI. - Il processo si è svolto
secondo il rito ordinario.
**** OMSSIS ****
2. - RITENUTO IN FATTO. - Nella loro consistenza materiale i fatti rilevanti per la
decisione sono sostanzialmente incontroversi e possono sintetizzarsi nei termini che
seguono.
Il 16 agosto 1997, alle ore 1, 16 della notte, all'interno del reparto "produzione lamIere n°2
(d'ora in poi "PLA 2") dello stabilimento «I.L.V.A.» di Taranto, esplodeva un trasformatore
elettrico con isolante in olio dielettrico a base di policlorobifenili (comunemente
denominato “askarel” od “apirolio”). Il trasformatore, identificato con il n ° matr. "T24",
era situato, al pari di altri 28 apparecchi simili, all'interno dello scantinato del capannone
adibito a sala motori del reparto.
L'esplosione determinava lo sversamento di un gran quantità di apirolio all'interno della
sottostante vasca di cemento, la dispersione di tale liquido anche su altre parti del
pavimento dello scantinato, nonché la diffusione dei vapori anche all'este rno del locale.
Non soltanto, infatti, Capuano Vincenzo, ovvero l'operaio precipitatosi nello scantinato al
momento dello scoppio e costretto, a causa della precaria visibilità dovuta ai fumi dell'olio
dispersosi, a dismettere il dispositivo autorespiratore di cui si era munito, ma anche altri
tecnici ed operai accusavano malori conseguenti all'inalazione de i vapori, benchè costoro al
momento si trovassero in altri locali del reparto, separati dallo scantinato e distanti anche
varie decine di metri dal trasformatore.
La causa dell'incidente veniva individuata verosimil mente in un corto circuito, successivo
alla riattivazione degli impianti, resasi necessaria in conseguenza di un'interruzione
dell'erogazione di energia elettrica da parte dell’E.N.E.L., protrattasi sino alle ore 15.00 del
giorno precedente.
Quanto allo stato dei luoghi e delle strutture, i rilievi effettuati da l dr. Giua nei giorni
seguenti all'accaduto e, successivamente, dai consulenti tecnici del P.M. permettevano di
accertare che: allo scantinato sì accedeva attraverso tre scale metalliche a gradini, "con
pedata piuttosto piccola e spigolo irregolarmente ero so"; l'illuminazione all'interno dello
stesso era "insufficiente"; esso permetteva una dispersione aerea di fumi e vapori nocivi
verso l'esterno e non era provvisto di un idoneo sistema artificiale di aerazione, con
dispositivi di arresto e chiusura delle bocche di ventilazione e con filtri adeguati;
mancavano cartelli od altri segnali che prescrivessero ai lavoratori il divieto assoluto, in
caso di esplosione effettiva o sospetta di un trasformatore, di entrare nello scantinato privi
dei necessari mezzi di protezione individuali; mancava qualsiasi dispositivo tecnologico di
controllo visivo a distanza del locale di allocazione dei trasformatori, così che gli operai ed
i tecnici addetti, in caso di disfunzioni, erano costretti necessariamente a portarsi nell o
scantinato per verificarne l'effettiva esistenza, la natura e quant'altro.
I dispositivi di protezione individuale (maschere, respiratori, guanti, tute, etc.) erano
presenti; essi, tuttavia, non risultavano assegnati in dotazione personale ai singoli
lavoratori, bensì riposti a loro disposizione nei magazzini del reparto ed in alcuni pulpiti
dislocati nell'area interessata.
In ogni caso, essi erano istituiti in misura assolutamente insufficiente rispetto al numero
degli addetti al reparto, che, in caso d i esplosione, sarebbero risultati esposti al rischio di
inalazione di esalazioni di apirolio.
Al riguardo, basti rilevare che, in occasione dell'incidente del 16 agosto, Palumbo
Giuseppe, addetto alla sala motori del reparto, ha operato senza autorespirat ore, perché
quello posto a sua disposizione era stato già prelevato da altra persona; mentre Giacobelli
Leonardo, che prestava il proprio servizio all'interno della sala computer, non ha potuto
munirsi di alcun respiratore, perché nessun dispositivo di pro tezione di tal specie era ivi
installato: eppure anche gli, come Palumbo, Capuano ed altri addetti al reparto, ha inalato
vapori di apirolio, tanto da essere costretto a ricorrere alle cure dell'infermeria dello
stabilimento.
***
Quello dell'agosto '97 non era il primo incidente riguardante un trasformatore ad apirolio
avvenuto all'interno dello stabilimento "ITALSIDER", e poi "I.L.V.A.", di Taranto.
A partire dal 1982, infatti, per lo meno altri tre apparecchi di quel tipo erano esplosi
(18.9.1982, 19.4.1992, 31.1.1996), altri tre avevano subito rotture (29.7.1982, 10.12.1995 e
9.2.1996) ed almeno in un altro paio di occasioni si erano verificati fenomeni di corto
circuito (30.11.1983 e 6.9.1996). Gli estremi essenziali dì ciascun episodio sono indicati
nella relazione depositata il 22.6.1998 nella segreteria del P.M. dal c.t. dr.ssa Spartera,
acquisita all'udienza del 9.6.2003, e non sono stati contestati dalle avverse difese.
2
E' pure pacifico tra le parti, tuttavia, che, ancora nell'agosto del '97, ope ravano all'interno
dello stabilimento oltre 900 trasformatori di tal specie, peraltro in larghissima parte
costruiti oltre vent'anni addietro. Si trattava secondo un'affermazione della dr.ssa Spartera,
anche questa non contestata, di una concentrazione di simili apparecchiature con pochi
eguali in ambito europeo.
Tali circostanze, con la progressiva presa di coscienza dell’estrema lesività dei
policlorobifenili (cc.dd. 'pcb") per la salute umana e per l'ambiente, avevano portato la
"questione apirolio" all'attenzione dei vertici aziendali: lo ha riferito il sindacalista
Calcante; lo dimostrano i documenti tecnici ed i ritagli di stampa da lui raccolti e prodotti
dal P.M. all'udienza del 7.4.2003; lo ha confermato in dibattimento l'imputato Capogrosso,
che ne ha parlato come di un problema "all'ordine del giorno" dell'azienda ed a lui ben
noto; ha contribuito a dimostrarlo la documentazione a pi ù riprese prodotta dalla difesa di
costui (verbali di deliberazioni aziendali e di incontri con le rappresentanze sin dacali e
degli enti territoriali, relazioni di organi di controllo, etc.), allo scopo di provare
l'accelerazione da quegli impressa al processo di progressivo smaltimento di quelle
apparecchiature.
E'un dato anche questo incontroverso, infatti, che, dal l' dicembre del 1996, data in cui
Capogrosso è divenuto direttore dello stabilimento, sono stati dismessi circa 700
trasformatori ad apirolio.
Per quel che riguarda, invece, le procedure di controllo sulle condizioni strutturali di
codesti apparecchi, lo stesso Capogrosso ha precisato che, consapevolmente discostandosi
dalle indicazioni ricevute dai competenti organi della A.S.L., che disponevano dì eseguire
periodicamente analisi chimico-fisiche e controlli dell'apirolio in relazione a tredici
parametri, l'azienda si limitava a controlli periodici di soltanto cinque di quegli indici
(colore, aspetto, umidità, tensione di scarica, fattore di dissipazione), salvo estende re
l'indagine agli altri significativi qualora le prime avessero offerto risultati non confo rmi ai
valori normali. Tanto era stato deciso di fare - ha spiegato apertis verbis l'imputato in
dibattimento - nella convinzione che neppure mediante il costante controllo di tutti i
parametri individuati dalla A.S.L. sarebbe stato possibile prevenire con certezza esplosioni
od altri simili accidenti, e che l'unico rimedio atto a prevenire quei rischi era la dismissione
di quei trasformatori.
********
In punto di fatto, soltanto un accenno va riservato, da ultimo, all'organizzazione aziendale,
nonché alle qualifiche rivestite ed alle funzioni svolte dai vari imputati nell'ambito di
questa, poiché anche questo profilo non ha formato materia di discussione tra le parti.
Secondo il racconto - per il vero sorprendentemente approssimativo - di Capogrosso, lo
stabilimento da lui diretto era, in generale, suddiviso in "aree", ciascuna guidata da un
"capo area" e con una ripartizione interna tra il settore della “produzione” e quello della
“manutenzione”, a capo di ognuno dei quali v'erano ulteriori dirigenti; nell' ambito di
ciascuna area, poi, vi erano vari “reparti”, ciascuno retto da un “capo reparto”; all’interno
dei vari reparti, quindi, vi era un'ulteriore suddivisione per “squadre” operative, ognuna
facente capo ad un "capo turno".
*****************
3. - CONSIDERATO IN DIRITTO. - Gestione di apparecchiature ed art. 437, cod. pen.. L'ipotesi accusatoria di cui al capo A) dell'imputazione si fonda essenzialmente su due
rilievi: la pluralità degli incidenti verificatisi negli anni su quel tipo di trasformatori nello
stabilimento I.L.V.A.; la scelta dell'azienda, consapevole e volontaria, di non adeguarsi alle
indicazioni impartitele dalla A.S.L. circa i controlli delle condizioni strutturali di quelle
apparecchiature.
Una siffatta impostazione, però, non può es sere condivisa, se non per quel che concerne la
non conformità a legge della procedura di gestione degli impianti seguita dall'azienda. Un
rapido panorama delle fonti normative di riferimento può giovare alla comprensione di tale
giudizio.
Il D.P.R. 24.5.1998, n' 216, vietando l'ulteriore immissione nel mercato e l'uso dei
policlorobifenili e degli impianti, apparecchi e fluidi che li contenessero, ne consentiva
l'uso di quelli già in esercizio a quella data, "sino all'eliminazione o fino al termine della
loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli
apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche
generalmente adottate dagli operatori del settor e» (art. 4, co. 2).
Tali norme del CEI (che sta per "Comitato elettrotecnico italiano", struttura collegata al più
noto "C.N.R.") sono contrassegnate dall'identificativo "10 -6" e sono state pubblicate nel
novembre del 1981.
Al punto 3 dell’”allegato D”, esse individuano i 13 parametri da esaminare per "verificare
se le proprietà dell'askarel sono sempre adatte alla ulteriore utilizzazione o se sia
opportuno prevedere qualche misura correttiv a“.
3
Quindi, al successivo punto 4, dopo la previsione di una frequenza almeno quinquennale dei
controlli sui trasformatori con tensione non superiore a 35 kv, si afferma: " I
trasformatori……….. a tensione più elevata possono richiedere verifiche più frequenti. Una
frequenza maggiore è pure consigliabile quando una qualunque delle proprietà
significative si avvicina al limite raccomandato per l'utilizzazione".
Dopo di che, al punto 7, dopo aver previsto che luogo, numero e tipi di prove sui campioni
di askarel 'possono variare in funzione delle circostanze locali', ed altresì che il giudizio
sullo stato degli askarel "dovrà preferibilmente essere basato sulla valutazione combinata
delle più importanti caratteristiche", il C.E.I. stabilisce: “Un programma completo di
verifiche comprende tutte le prove indicate all'art. 3. Contemporaneamente alla valutazione
delle condizioni generali del fluido, queste prove permettono sovente di riconoscere la
causa della degradazione o l'origine della contaminazione e di prendere le misure
opportune per ridare al fluido caratteristiche soddisfacenti ”.
Ed infine, al punto 8, si statuis ce che le proprietà relative ad aspetto, umidità, tensione di
scarica e fattore di dissipazione (le sole, ossia, annualmente controllate dall'I.L.V.A.) "sono
considerate come soddisfacenti per un'apparecchiatura funzionante ad una tensione
inferiore od uguale a 35 kv”.
Se questi sono i dati normativi di riferimento, e se si pensa, da un canto, al fatto che il
trasformatore "T24", come la maggior parte di quelli presenti nello stabilimento, funzionava
ad una tensione assai superiore a 35 kv (nello specifico, 640 kv), e, dall'altro, alla s volta in
senso fortemente restrittivo impressa dal cìt. D.P.R. n' 216 nell'uso e nella gestione dei
p.c.b. (con la generale previsione dì controlli almeno annuali, anche, ossia, per quegli
apparecchi per i quali le norme C.E. I. del 1981 si accontentavano di controlli
quinquennali), se ne deve coerentemente desumere che il dovere di diligenza imposto
all'azienda, e che - secondo la costante esegesi dell'art. 43, cod. pen. dev'essere calibrato
sulla «migliore scienza ed esperienza del settore", le imponesse di eseguire con cadenza
almeno annuale le analisi relative a tutti e tredici i parametri di cui s'è detto (sull'obbligo
dell'imprenditore di informare la sua condotta alla migliore scienza ed esperienza, derivante
già dall'art. 2087, cod. civ., si legga, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 24.6.2000, n' 7402).
Ma la non corretta gestione di tali apparecchiature, se certamente è tale da realizzare la
contravvenzione contestata al capo B) della rubrica (poiché è evidente che, se tut te quelle
analisi fossero state eseguite, verosimilmente si sarebbe potuto ottenere un quadro più
preciso delle condizioni di 'durata operativa» della macchina, e se ne sarebbe, così, potuta
prevenire l'esplosione, adottando le maggiori cautele necessarie nello specifico), non può
invece essere sufficiente, di per sé sola, ad integrare la condotta penalmente sanzionata
dall'art. 437 del codice penale.
In effetti, la rubrica di tale articolo potrebbe trarre in inganno, laddove si parla
genericamente di "cautele contro infortuni sul lavoro". Ma rubrica legis non est lex, ed
invece il dato testuale della norma è assolutamente perspicuo.
Rilevano unicamente, infatti, condotte di omessa collocazione, rimozione o
danneggiamento.
Inoltre, l'oggetto materiale di tali condotte non è rappresentato da qualsiasi macchinario
impiegato nel ciclo della lavorazione, bensì esclusivamente dagli «impiantì, apparecchi o
segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro". E'necessario, ossia, che si
tratti di dispositivi di qualsiasi natura, ma comunque qualificati da una propria consistenza
morfologica (tale da poterli far "collocare", "rimuovere" o "danneggiare") e, soprattutto, da
una specifica ed immediata destinazione antinfortunistica o di prevenzione dei rischi
derivanti dalle attività lavorative, tanto per la collettività (si rammenti la allogazione della
norma nel titolo relativo ai "delitti contro l'incolumità pubblica"), quanto per i singoli (sul
punto, infatti, i problemi er meneutici connessi alla appena ricordata posizione sistematica
della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza).
Appare, dunque, di solare evidenza che la negligente gestione dei trasformatori ad apirolio
da parte dell'I.L.V.A., limitatamente alla omessa esecuzione di tut ti i controlli necessari per
la migliore conoscenza possibile dello stato di salute di ciascuno di essi, non può farsi
rientrare nella fattispecie astratta sanzionata dalla norma in rassegna (nel senso del testo, si
può leggere la nota sentenza del Trib. V enezia, sez. 1, 22.10.200 1, emessa nel processo
contro Cefis ed altri e relativa ai fatti dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera,
la quale - a dire il vero - si spinge ancora oltre, escludendo dal novero delle condotte
rilevanti ex art. 437 anche alcune - a parere dell'odierno invece pienamente riconducibili a
quella fattispecie astratta: in giudicante Cassaz. pen., 1/2003, 106, in part. pagg. 296 s.).
Ne può condividersi la tesi - tuttavia, per il vero, non priva di una certa efficacia suggest iva
-sostenuta dalla difesa della parte civile "U.I.L. secondo cui il delitto in argomento sarebbe
stato realizzato dai vertici dell'azienda mediante l'omessa predisposizione delle
apparecchiature necessarie per eseguire codeste analisi ulteriori.
Accedendo ad una simile lettura, infatti, si f inirebbe per far ricadere nell'a mbito della
previsione sanzionatoria la totalità, o quasi, dei beni aziendali, che, in quanto inseriti nel
ciclo produttivo, sono, per tal via, anche soltanto indirettamente funzionali a lla migliore e
più sicura gestione dei diversi impianti immediatamente produttivi di rischi per l'incolumità
4
personale dei lavoratori. La conseguenza, allora, sarebbe quella di far entrare dalla finestra
ciò che il legislatore ha ritenuto di metter fuori dalla porta, dilatando oltre misura la
norma, fino al punto di esporla - a ben vedere - anche a dubbi di sufficiente tassatività.
Certo, balza agli occhi - suscitando non poca amarezza e, perciò, rendendo comprensibili
anche simili forzature ermeneutiche - la evidente iniquità di un sistema normativo che
sanziona con la reclusione sino a cinque anni, appunto ex art. 437, cit., la mancata
apposizione di un cartello di pericolo, spesso soltanto ipotetico in concreto, mentre affida
ad una contravvenzione, peral tro punita con pena pecuniaria alternativa fino ad un massimo
di 1.032,00 € (artt. 267 e 389, lett. c, D.P.R. n" 547/1955), la repressione penale della
gestione incauta di un impianto elettrico, come quello in esame, suscettivo di creare con
elevata probabilità rischi gravissimi per la salute di un gran numero di lavoratori e pe r la
salubrità di vastissime aree territoriali.
E' altrettanto evidente, però, che una simile contraddizione logica interna del sistema, tanto
più stridente perché in conflitto con la sempre maggiore tutela riconosciuta alle esigenze di
sicurezza dei lavoratori dalla pletora di leggi speciali successive al codice, non può essere
sanata che dal legislatore, e non certo dal giudice mediante una dilatazione della norma
oltre quanto consentito dal testo.
***
Configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 451, cod. pen.. -La
contestazione del delitto di cui all'art. 437, c.p., è stata elevata dalla Pubblica Accusa
altresì con riferimento, tra l'altro, alla mancata predisposizione ed alla inadeguata
manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (cc.dd. «d.p.i."). Ed ínvero - come si
è avuto modo di osservare dianzi in parte narrativa - nel caso di specie codesti disposìtivi
erano assolutamente insufficienti e non correttamente dislocati.
Ma non basta. Anche altri impianti, apparecchi o segnali a specifica destinazione
antinfortunistica - come s'è visto - non risultavano collocati in «PLA/2" ove erano situati i
trasformatori ad askarel: e ciò in ispregio a specifiche discipline normative od a canoni di
normale prudenza e diligenza.
Degli autorespiratori s'è già detto: e l'obbligo per l'azienda di provvedere ad una dotazione
personale in favore dei singoli lavoratori, o comunque in misura sufficiente alla protezione
di tutti coloro prevedibilmente esposti al rischio di inalazioni nocive, si ricava, oltre che
dalle norme generali di cui agli artt. 4 del D.P.R. n° 303 del 1956 e 4, com. 5, lett. d), e 40
- 43 del D. L.vo n° 626 del 1994, anche dalla disposizione specifica contenuta all'art. 369
del D.P.R. n' 547 del 1955 (della necessità di "mettere questi strumenti a portata d i mano
del lavoratore" parla, tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 3.6.1995, n' 6486).
Mancava un cartello di divieto assoluto d'accesso al locale scantinato senza la protezione di
autorespiratori, in caso di scoppio, anc he soltanto sospetto; la sua presenza, invece,
considerando l'estrema lesività delle esalazioni dell'apirolio, sarebbe stata obbligatoria,
quanto meno in base alle norme generali degli artt. 3, co m. 1, lett. q), 4, com. 5, lett. e), h)
ed i), del cit. D. L.vo n° 626, e dell'art. 2, com. 1, D. L.vo n° 493 del 1996, nonché quale
cautela immediatamente prodromica e funzionale all'assolvimento degli obblighi previsti
dal combinato disposto degli artt. 236 e 372, D.P.R. n' 547, cit..
La rilevata insufficienza dell'impianto di illuminazione, poi, viola, se non altro, le norme di
cui al capo V del titolo II del medesimo D.P.R. n ° 547, nonché il precetto contenuto all'art.
10, com. 1, seconda parte, D.P.R. n° 303, cit., laddove impone dì munire tutti i luoghi di
lavoro, anche quelli situati in locali sotterranei o seminterrati, di dispositivi di
“illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza... dei lavorator” .
Le scale a pedata piccola ed a spigoli erosi, invece, non paiono osservanti, per lo meno ,
degli obblighi previsti, rispettivamente, dagli artt. 16, co m. 1, e 374, D.P.R. n" 547, cit..
Quanto, inoltre, all'assenza, nello scantinato in questione, di un idoneo impianto di
aerazione, tale da aver consentito la formazione di una spessa coltre di f umo, che ha
costretto il malcapitato Capuano a togliersi la maschera per poter meglio vedere ed operare,
essa è censurabile ai sensi, se non altro, delle norme generali di cui agli artt. 8 e 9, D.P.R.
n° 303, cit., ed agli artt. 3, 4 e 30 -32 del D. L.vo n° 626, cit..
E parimenti illegale é l'assenza di dispositivi atti ad evitare l'avvenuta dispersione aerea al
di fuori del locale dei gas sprigionatisi a sèguito dell'e splosione. L'art. 370, D.P.R. n° 547,
cit., prevede, infatti, che i locali nei quali posso no svilupparsi emanazioni tossiche debbano
essere isolati da altri luoghi di lavoro o di passaggio (mentre Giacobellí, Palumbo ed altri,
che si trovavano in locali distinti e distanti da quello scantinato, hanno anch ’essi respirato i
vapori di askarel). Inoltre, l'art. 20 del cit. D.P.R. n ° 303 impone che un'attrezzatura da
lavoro che comporti pericoli dovuti, tra l'altro, ad emanazione di gas o vapori debba essere
munita di "appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte" di
pericolo. Ma, soprattutto, sono le norme C.E.I. "ll - 19" dell'1.11.1984, al cap. 2 .4, a
disporre che "nella installazione di trasformatori all'interno di fabbricati occorre
provvedere a che i fumi che si possono sviluppare in caso di guasto interno non interessino
5
luoghi di abituale passaggio o frequentati da persone", così imponendo l'adozione di ogni
possibile cautela strumentale a tal fine.
Infine, anche il difetto di strumenti di controllo visivo a distanza dei trasformatori può
ritenersi in contrasto, se non con una norma specifica, comunque con la disciplina generale
contenuta nel cit. D. L.vo n° 626, laddove impone la eliminazione o la riduzione al minimo
dei rischi "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", facendo
carico al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione "in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione" (artt. 3, com. 1, lett. a, e 4,
com. 5, lett. b).
Tuttavia, com'è noto, affinché simili comportamenti omissivi possano rilevare ex art. 437,
c.p., è necessario che essi siano stati dolosamente serbati dai soggetti obbligati alla
corrispondente condotta attiva.
Ebbene, nello specifico, non può ritenersi raggiunta una prova rassicurante del fatto che gli
odierni imputati ……………………………………………………………………
……………
…………………………….., attesa la loro qualità apicale all'interno dell'organigramma di
uno stabilimento con oltre 10.000 dipendenti, avessero precisa ed effettiva contezza delle
condizioni di illuminazione e di aerazione di quello scantinato, ovvero della presenza e
della dislocazione di cartelli e d.p.i.: anzi, è ragionevole ipotizzare, soprattutto per
Capogrosso, che una conoscenza dettagliata dello stato dei luoghi non vi fosse, così da far
venire meno il presupposto logico per l'adozione della condotta attiva richiesta dalla legge.
Ma, se può escludersi che costoro fossero in concreto consapevoli delle segnalate carenze, è
tuttavia innegabile che essi avessero comunque il dovere di tenersene informati, onde
provvedere consequenzialmente ed assolvere, per l'effetto, agli obblighi di tutela dei
lavoratori loro commessi dalla legge. Tutta la normativa antinfortunistica, infatti, è
caratterizzata - si potrebbe dire - da un vis actractiva verso l'alto delle relative
responsabilità, delle quali investe direttamente e principalmente il datore di lavoro, e di
sèguito, nelle organizzazioni imprenditoriali più complesse, i vertici aziendali, scendendo
per li rami.
Pertanto, da un lato, l'omessa collocazione di quei dispositivi può ricondursi alla condotta
non diligente dei funzionari tecnici responsabili all'interno dell'organizzazione aziendale
dell'I.L.V.A. (tra un attimo vedremo nello specifico quali): una negligenza tanto più grave,
in quanto massimo era ìl dovere di attenzione e di vigilanza nella fattispecie concreta,
trattandosi di trasformatori allocati in uno scantinato, e quind i di una delle situazioni più
pericolose.
Dall'altro, tutti gli anzidetti dispositivi mancanti possono indiscutibilmente ricondursi
anche alla nozione di "apparecchi od altri mezzi destinati al salvataggio o al soccorso
contro... infortuni sul lavoro» (benché questa non sia evidentemente sovrapponibile a quella
adottata nell'art. 437, c.p., per descrivere l'oggetto materiale della condotta).
Ne consegue la sicura configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie delittuosa colposa
prevista e punita dall'art. 451, cod. pen.. Non v'è dubbio, infatti, e la dottrina e la
giurisprudenza sono assolutamente unanimi in questo senso, quanto meno quelle più
recenti, che la sussistenza di tale reato prescinda dalla già avvenuta verificazione di un
disastro o di un infortunio sul lavoro (si veda, ad es., Cass. pen., sez. VI, 14.3.1996, n °
2720; nel caso oggetto di giudizio, peraltro, è ravv isabile un infortunio nei malesseri patiti
dai tecnici ed operai già nominati).
Va da sé, poi, che una simile ricostruzione gi uridica degli accadimenti non integri una
mutatio libelli, per la quale - secondo l'oramai costante lettura giurisprudenziale - sarebbe
necessaria la "sostanziale immutazione del fatto contestato», ovverosia la «trasformazione
radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenzial i”, tale da "precludere in
concreto» all'imputato la possibilità di difesa. Nell'ipotesi in discorso, invece, non soltanto
le due fattispecie astratte tipizzate dagli artt. 437 e 451, c.p., sono contigue sotto il profilo
dogmatico, ma altresì, nel caso specifico, la seconda è stata evocata ed esaminata dalle
difese degli imputati nelle loro discussioni.
****************
OMISSIS
6